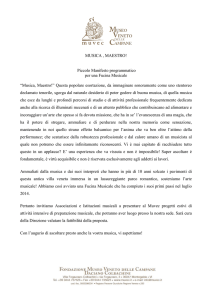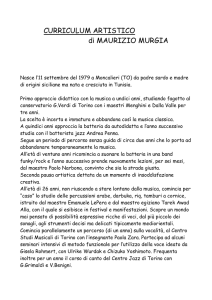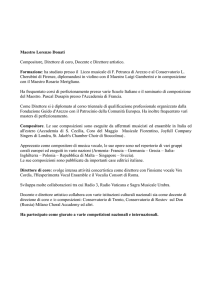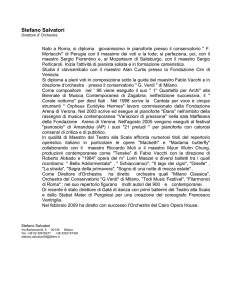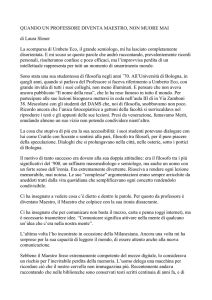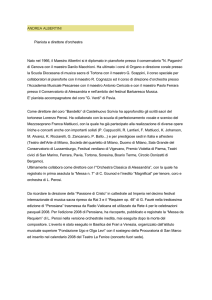I racconti
dei “Battuti”
FERRUCCIO
MARONESE
L’ORGANISTA
DEL DUOMO
di Fabio Metz
a cura del CENTRONOVE
Circolo Aziendale Ospedaliero
di San Vito al Tagliamento
n. 5 - Dicembre 2012
El picolo nio
Pare, xe ora,
tira a bordo le sime:
za s'alza la buora
e vien le luse prime.
Bisogna salpâ:
vol tenpo per la traversada;
arivemo in rada
a la fin de l'istà.
Ninte ne dà sto porto,
marsise el bastimento
se no l'ha vele al vento
e mar sul bocaporto.
Za le stele svanisse
e l'alba se vissina,
soto le refolade fisse
la barca s'incamina.
(B. Marin, 1969)
Ferruccio Maronese, l'organista del duomo di
San Vito, ha lasciato il suo «piccolo nio», la mattina del 25 giugno 2001. Anche lui quasi di certo
in accordo con il poeta: «Niente ne dà sto porto,
/ Marsise el bastimento / se no l'ha vele al vento
/ e mar sul bocaporto». Da quell'addio, che ancora mi (ci) pesa sul cuore, muove questa nota che
biografia assolutamente non vuole e non può
essere. Ma solo ricordo, rimpianto, omaggio
devoto, prima che il tempo, inesorabile e feroce,
tutto abbia a trascolorare ed a confondere.
Il difficile xe scuminsiar. Se te scuminsi benon,
il resto te vien più fasile. Mi diceva il maestro. Ora
che non c'è più, giusto per farmi coraggio per
cominciare, mi sono fatto accompagnare dal
"sussurro" di Biagio Marin e cullare, nelle lunghe
ore del dopo cena e fino a notte, dal Requiem di
W. A. Mozart e però anche dalla melodia gregoriana della Missa defunctorum, proprio quella che
un giovanissimo Ferruccio quasi tutte le mattine
accompagnava con l'organo nella sua parrocchiale di Pravisdomini. Le righe che seguono sono il
risultato di un dialogo paragonabile, se la proposta non apparisse blasfema, a quello che Nicolò
Machiavelli intesseva, alla sera, con i suoi autori
classici a San Casciano (1513). Un dialogo protratto per più anni, poi che incominciato, e poi
garantito alla committenza e poi più volte interrotto. A motivo del fatto che la scrittura ben spesso si interrompeva di fronte agli occhi ed al sorriso ironici del maestro. E perciò tutto si faceva
faticoso, lentissimo, alla rincorsa, alle volte affannata, di un personaggio complesso, costruitosi
juxta modum che è come a dire fatto a modo suo.
Era fisicamente fragile il maestro. La fragilità,
pare almeno a me, essere la qualità che meglio
viene a definirne l'aspetto esteriore tanto egli era
mingherlino. Eppure su tutta quella ridotta struttura corporea da subito colpiva il volto incorniciato da abbondante capigliatura - a seconda del
trascorrere del tempo nera e quindi brizzolata ed
alla fine bianca - ed avvivato da due pupille scure,
mobilissime, puntute, in qualche caso di una
inquisitorialità attenta e persino spietata, ed in
altro di una attenzione al problema in esame concentratissima, ed in altro ancora di un abbandono gioioso, totale e coinvolgente al discorrere tra
amici, ma pure tra personaggi occasionalmente
incontrati. Al di sotto degli occhi si apriva la
bocca. Una sorta di taglio che si distendeva di tra
le due piccole rilevanze delle guance. Mobilissima
e, di volta in volta, chiamata a commentare - sino
ad atteggiarsi in una sorta di piccola smorfia o
con lo sporgere del labbro inferiore - quanto egli
andasse discutendo onde la formulazione del suo
pensiero, oltre che con le orecchie, si riusciva a
leggere da subito negli occhi e nella piega delle
labbra.
E debbo confessare come, nel mentre vengo
scrivendo queste righe, mi accada di inseguirlo
con lo sguardo intanto che scendeva lungo via
Panteleoni da casa oppure quella strada ripercorreva per rientrare in famiglia, con quel suo andare dinoccolato il cui ritmo era assicurato da un
piede puntato ad oriente e l'altro ad occidente. Le
braccia penzoloni. E poi anche alzate, o l'una o
l'altra o tutte e due, nel gesto del saluto. A doman.
Sì, a domani, maestro.
Con l'aspetto esteriore, mi pare, in maniera
imprescindibile si debba coniugare la pressoché
costante rinuncia, da parte del maestro, al pronome personale di prima persona singolare: «io»
(mi, nel dialetto in cui costantemente amava
esprimersi). Sapeva di esserci, ma la vita gli aveva
insegnato quanto fosse pericoloso schierarsi in
prima fila. Non per vigliaccheria, ma per l'aver
compreso, credo, ben presto, quanto complesso
fosse il tessuto sociale all'interno del quale gli era
toccato in sorte di vivere. E quanto difficile fosse
il convivere. Per cui l'impancarsi a tribuni oppure a giudici voleva dire prendere atto di quante
fossero le teste con cui venire a confronto. Ma,
nel contempo, pure dubitare delle proprie.
Siccome, credo, confermatogli dalla frequentazione musicale, in veste di esecutore, con i grandi musicisti, in primis, J. S. Bach, che egli ha sempre sentiti quali indiscussi maestri di cui farsi
fedelissimo esecutore. Il rapporto con la partitura
dei grandi, annullava o comunque di molto riduceva, in qualche misura, il terreno della propria
autonomia che poteva trovare spazio nello sforzo
interpretativo. Ma che era e rimaneva pur sempre
un'operazione strettamente personale e chiusa nel
perimetro del respiro individuale. Un respiro che
il suo silenziosissimo «io» custodiva gelosamente.
Un uomo - ancora una volta - juxta modum,
per dire non facile. E perciò, per me, fascinoso. Al
quale non sono mai riuscito a dare, se non per
sbaglio, del «tu»; siccome invece; e da subito, o
quasi, mi era riuscito con la Marilù (mi perdoni,
signora maestra Maria Luisa Dean in Maronese,
se mi permetto di chiamarti a questo modo?). E
non riesco a spiegare questa mia scelta se non
ripensando al fatto che il maestro mai mi ha sollecitato, come altri invece tra i molti che ho
incontrato sui miei passi, ad usare nei suoi confronti questo pronome confidenziale, ma soprattutto era a me che tornava naturale stabilire questa sorta di rispettosa distanza con un uomo che
aveva la possibilità di accedere a quelle stanze
della musica che a me, man mano che il tempo
passava, diventavano sempre più di difficile accesso. E che pertanto, non potevo che guardare da
lontano.
Veniva da lontano, il maestro e credo abbia
sempre mantenuta questa sua lontananza che va
al di là del perimetro delle fosse cittadine di San
Vito al Tagliamento. Si deve necessariamente
muovere dalla piccola Pravisdomini, da poco
uscita dalla Prima Grande Guerra nella quale da
Sante e Pigat Teresa nasceva il 15 aprile 1927, e
quindici giorni dopo veniva battezzato dal parroco don Silvio Bomben, Ferruccio. Già altri otto
fratelli e sorelle lo avevano preceduto e lui era il
nono venuto, per ultimo, a godere della luce di
questo mondo.
Erano tempi e luoghi difficili, annate magre,
avara la terra che il padre coltivava. Stagionalmente Sante emigrava in Germania per assicurare il necessario a quelli di casa. Onde in quinta
elementare, il giovanissimo Ferruccio, si vantava
coi condiscepoli di contare fino a cinque in tedesco. E intanto le sorelle, tra un funerale e l'altro,
si ingegnavano a servire presso famiglie private
onde garantirsi una dote per il giorno del matri-
monio. Anni difficili, si diceva. Durante i quali,
inopinatamente incompresa dal fratello maggiore
- tranne che da papà Sante che ne avrebbe difeso
la scelta "musicale" sino alla fine - veniva maturando in quel ragazzino quella sua strana passione: travolgente e, proprio perché tale, ai più
incomprensibile, per la musica.
È un adolescente Ferruccio che, dopo la frequenza alle scuolucce musicali ceciliane istituite
in ambito diocesano, nel 1942 si iscriverà al
Conservatorio Musicale Benedetto Marcello di
Venezia: un quindicenne, con la sola licenza elementare, che dal piccolo suo borgo, si affacciava,
con intuibile timidezza, alla città lagunare. Pochi
o con pochissimi spiccioli, quelli guadagnati suonando le messe da morto la mattina presto nella
parrocchiale di Pravisdomini e qualche cos'altro
allungatogli da papà Sante, da un lato; un'Italia
che era appena entrata in guerra dall'altro. In
mezzo un adolescente armato di una volontà di
ferro. Mi raccontava un collega che ha fatto scuola con me, e che aveva frequentato, in quegli anni
contemporaneamente al maestro, l'Accademia
delle Belle Arti in Venezia (oggi purtroppo passato lui pure a miglior vita), di come il giovane
Ferruccio si adattasse a lavare i piatti per un piatto di minestra nel mentre lui, per ottenere analogo trattamento, andasse schizzando su certi suoi
fogli paesaggi lagunari e gondoline e ponti e
palazzetti della Dominante.
Si diplomerà il maestro con lusinghieri risultati, dopo aver superato, alle soglie del nono anno
di frequenza al conservatorio un'infezione gravissima e lunghissima motivata dalla febbre maltese,
nella sessione estiva dell'anno scolastico 19531954. Nel corso dello stesso anno approderà in
San Vito al Tagliamento con il titolo di maestro
d'organo del duomo cittadino. Questo trasferimento, in termini spaziali piuttosto ridotto, ma
in una prospettiva psicologica, prima che professionale, di una valenza tutta particolare, sarebbe
stato vissuto dal maestro quale un nuovo inizio
della propria vita, la fine di una difficile battaglia
per la sopravvivenza. Lo ripeteva, pur di raro, con
una disarmante semplicità. Ma ecco: la sopravvivenza era per lui non un fatto di natura fisiologica: ad accontentarsi di poco era avvezzo. Per il
giovane maestro invece sopravvivere era finalmente poter far musica, a tempo pieno.
Nonostante condizioni logistiche, professionali
ed economiche non ottimali. Quasi di fortuna:
un letto in una sorta di ridotto ricettacolo ricavato nel sottotetto dell'oratorio parrocchiale (che la
domenica pomeriggio doveva condividere con
l'arbitro chiamato a regolare la partita della squadra dell'oratorio, la mitica "Astra"), pressoché
contigua a quella in cui la Tunina, zia del cappellano dell'epoca, don Angelo Pandin, alllevava
alquante rumorose gallinelle; l'obbligo di suonare in duomo tutte le domeniche e feste ed accompagnare, per giunta, i vespri delle solennità anche
presso la chiesa del Monastero della Visitazione e
la cappella dell'ospedale; darsi da fare per istruire,
con prove multiple e faticate, la corale della parrocchia. In cambio poteva contare su lire 20.000
mensili e sulla garanzia di un pranzo e di una
cena quotidiani presso la locale Casa di Riposo.
Durante quei giorni, galeotti furono gli scacchi di
cui era appassionato Dean, fratello di Marilù e
che piacevano pure alla mentalità fortemente
razionale del maestro. Da cosa, si sà, nasce cosa.
Il maestro cominciava a frequentare casa Dean.
In quelle stanze, caratterizzate da una costante e
cordiale accoglienza, incontrava una ventiduenne
Marilù dagli strordinari occhi verdi. Nel settembre del 1956 si sposano con la benedizione di
monsignor Pietro Corazza e con l'accompagnamento musicale di don Gianni Lavaroni e la presenza della corale diretta da Piero Fogolin.
Dall'incontro prenderà l'avvio quella che il maestro considererà sempre la sua gloria e la sua corona costituita dai propri figli e figlie: Piero (1957),
Fabrizia (1958), Flavia (1960), Luciana (1961),
Cristiana (1964).
Nel 1957, con un piazzamento di straordinaria eccezionalità (il primo fra i dieci di una marea
di concorrenti) vinceva una cattedra per l'insegnamento di Educazione Musicale nelle scuole
medie di grado inferiore. Era la sistemazione definitiva che metteva fine, per lui, ad una prospettiva precaria quale poteva essere quella di organista
della parrocchiale sanvitese. Fu così che dal 1957
al 1960 veniva incaricato di insegnare all'Istituto
Pacifico Valussi di Udine, dal 1961 al 1968 presso la Scuola Media Statale di Codroipo e dal
1969 alla Scuola Media Statale di San Vito al
Tagliamento: cattedra quest'ultima che lascerà
nel 1983 al momento di andare in meritata quiescenza.
Era davvero cominciata la vita per un uomo
che si sapeva accontentare e sapeva prendere dalla
vita il meglio che potesse venirne. Con un disarmante ottimismo. E la vita per il maestro era la
tranquillità economica, con l'appoggio della straordinaria capacità amministrativa di Marilù, la
frequentazione del suo organo in duomo, il piacere dell'insegnamento.
Veniva da lontano, il maestro. Nonostante
una apparente e certamente facilmente percepibile cordialità e colloquialità e straordinaria capacità di mettersi in immediata comunicazione con
chiunque egli avesse ad incontrare, sono profondamente convinto che si sia riservato, con tutti, o
comunque con quasi tutti, un territorio suo. Una
sorta di hortus conclausus, di riserva personale, di
piccola prateria all'interno della quale egli solo
poteva e sapeva come entrare. Che proteggeva
con lunghi silenzi. Un'area che confinava direttamente con quella che nell'animo suo occupava la
musica, ma alla quale nemmeno la musica, credo,
potesse avere totale accesso. Un'area che egli tutelava con estrema gelosia assicurandola da una
corona di barzellette e della quale potevano essere spia una rapida battuta, uno sguardo fuggitivo,
una piega della bocca, un gesto rapido della
mano. Solo chi aveva avuto modo di frequentarlo a lungo poteva non certamente penetrare in
quell'hortus, ma capire qualche cosa di quanto vi
si muovesse. Che era cosa sua poi che il maestro
si portava dietro - sino alla tomba - un suo
mondo faticato e faticoso di cui di volta in volta
era gelosamente pudico e fin vergognoso, ma
anche orgoglioso, e però anche forzatamente
dimentico sino a trasfigurarne i confini in una
sorta di limbo dal quale era una volta per sempre
riuscito ad uscire. Poi però, magari alla fine di un
lungo argomentare da parte mia, se ne usciva con
una o due frasi lapidarie che a tutto il questionare egli offriva quale soluzione. Erano, di norma,
frasi che venivano da una saggezza antica, se si
vuole anche sostanziata di una costante attenzione alla legittima difesa personale ereditata da lontane epoche in cui era pressoché obbligatorio
guardarsi sempre alle spalle, ma anche aliene da
inutili eroismi destinati a lasciare il tempo che
trovavano. Aveva, sulla sua pelle, imparata la virtù
del silenzio quando il combattere si rivelava
immediatamente inutile. Per poi rifugiarsi, con
l'amico Mansueto Frozza nei boschi alla ricerca di
funghi, accompagnando la passeggiata con un
ottimo coniglio in umido annaffiato da un sorso
di vino. Oppure tutto intento a coltivare un suo
piccolo appezzamento messo ad orto da cui,
orgoglioso, ricavava ortaggi da esibire, con la collaborazione della Rosi, sulla mensa di casa. O
ancora, con gesti di una solennità quasi liturgia,
tutto impegnato a gestire quella cantina di casa di
cui andava orgoglioso e dei cui prodotti gratificava quanti, me compreso, di volta in volta venissero frequentando la sua casa sempre aperta agli
amici.
Amava per altro stare tra la gente e con la
gente. Ovviamente, juxta modum. Convinto di
come i santi stessero solamente in paradiso e come
sulla terra, assieme ad un eventuale qualche santo
- della cui esistenza per altro dubitava - bisognasse fare i conti sempre con chi santo non solo non
era, ma era pure cattivo. E convinto, egli stesso,
di non essere un santo. Dall'approdo in San Vito,
il maestro non si muoverà più, diradando di anno
in anno le assenze per ferie ai monti od al mare
sino ad annullarle totalmente in concomitanza
all'allentamento progressivo delle proprie prestazioni musicali quale organista del duomo di cui,
per altro, fino all'ultimo volle conservare quello
che era il momento essenziale: la messa grande.
Non sono mai risucito a comprendere questa
sua scelta di seppellirsi in San Vito, nonostante le
richieste, per citarne alcune, le reiterate da parte
di don Albino Perosa, onde avesse ad accettare
una cattedra d'organo presso il Conservatorio
Musicale di Udine. Marilù mi viene suggerendo
che, raggiunta la sede di San Vito, il maestro vi si
fosse talmente ben accomodato, da non richiedere diverse sistemazioni. Forse aveva bisogno di
sentirsi accolto, amato, apprezzato. E molti, in
San Vito, ebbero ad accoglierlo, amarlo, apprezzarlo. E da parte sua, egli molti accolse, amò,
apprezzò.
Soprattutto non dimenticava facilmente chi
gli aveva fatto del bene e lo aveva aiutato, anche
alle volte, facendogli pesare questa mano tesagli.
Tra questi, don Tullio Tesolin. Aveva retto questi
la parrocchia natale di Pravisdomini, nelle vesti di
economo spirituale tra la partenza di don
Umberto Missana e l'arrivo del nuovo pievano. A
quell'adolescente che, finito di suonare l'officio
funebre mattutino si apprestava a percorrere, di
buon mattino i due chilometri che lo avrebbero
portato alla propria abitazione, ma pronto a
rimettersi in strada per ritornare in chiesa sul suo
organo per studiare, don Tullio Tesolin insisteva
per offrire una tazza di pane e latte. Ben accetta.
E ricordo come fosse oggi, una sera di almeno
cinquant'anni or sono. Avevo accompagnato il
maestro, dietro sua richiesta, con la sua Seicento
fino alla Casa dello Studente di Pordenone dove
aveva tenuto una lezione-concerto sulle composizioni di J. S. Bach. Ritornando a casa, verso le
ventitre e trenta, al momento di imboccare,
uscendo da Pordenone, la strada verso
Borgomeduna, ebbe ad incrociare casualmente
l'automobile in cui viaggiava don Tullio. Ricordo
ancora la frenata al centro dell'incrocio di norma
fortemente trafficato e che a quell'ora, per fortuna, risultava piuttosto tranquillo. Ho negli occhi
la portiera dell'automobile pericolsamente spalancata ed il maestro che, d'un balzo, raggiungeva la vettura di don Tullio. Non credo gli abbia
detto nulla, ma si sia limitato a stampargli un
bacio sulla guancia di sinistra. Poi siamo ripartiti
verso San Vito. Per più di mezz'ora non disse una
parola. Né io dissi nulla. Ero ben cosciente che
non dovevo parlare.
Allo stesso modo trovava stabile ospitalità nel
suo cuore la Rosi (all'anagrafe Rosina Simonato
di Braida Bottari) che, dalla dipartita, oggi con il
maestro riposa, dal 1996, nell'accoglientissima
sepoltura dei Dean nel cimitetro urbano di San
Vito al Tagliamento. Una figura esile e silenziosa,
che si muoveva felpata, con un sorriso di una
straordinaria dolcezza, e che il maestro aveva
incontrato fin dal primo giorno che aveva posto
piede in casa Dean. Ne stimava - e me lo disse
l'unica volta che, con il suo modo estremamente
colorito, siamo entrati in argomento - la discrezione, la sobrietà, l'instancabile laboriosità, la
capacità di stare al proprio posto, di tacere, di
sparire quando la sua presenza non fosse necessaria. Non so se mi sbaglio, ma penso che ritrovasse nella Rosi le doti delle donne (o di alcune di
esse) della casa natale o della piccola
Pravisdomini. Perché, in fondo in fondo, e si
ritorna a questo modo ad una delle componenti
più sostanziose della personalità del maestro, a lui
era rimasto fortissimo in bocca il sapore ed il
gusto per le persone semplici e genuine, dal
discorre e dal comportamento lineare e soprattutto sincero. Diretto. Fino a dubitare che potessero
davvero esistere per modo che se gli era dato di
incontrarne qualcuna dubitava che si potesse trattare di pose o di convenienze. In confronto con la
Rosi, io gli riuscivo ben spesso un pochino troppo complicato. Te son ingropà come el spago in
scarsela, commentava, senza sarcasmo, ma con
una disperata lucidità, certo mio argomentare. Ed
era un giudizio che, al di là della singola tematica, oggetto occasionale, del discorrere si estendeva ad una valutazione globale del mio modo di
vedere e di valutare le cose che non riusciva a condividere e, alle volte, persino a sopportare.
In parallelo, odiava profondamente la chiacchiera vana, il pressapochismo verboso, la falsità,
il bigottismo. L'ipocrisia, soprattutto. Ad evitare
la quale, era pronto a presentarsi sempre così
com’era di fronte a tutti. A costo di non essere
capito o di essere preso in giro o di non essere
preso in troppa considerazione per il fatto che lui
era «musico». Non abbassava perciò mai quel suo
sguardo acutamente puntuto di fronte a nessuno,
guardava diritto negli occhi l’interlocutore, esprimeva sino in fondo la sua opinione pur con quell’attenzione che gli veniva dall’esperienza di
quanto complicato fosse l’animo umano. E se alle
volte la battuta poteva anche essere salace, immediatamente si riscattava sul piano della genialità
dell’inventiva oppure del gioco pirotecnico dell’intelligenza. Poi, spesso, ti guardava in silenzio.
Ed era il momento in cui ti trovavi nel maggior
imbarazzo. Poi che non ti venivano più le parole.
Ecco, appunto. L'insegnamento. Il maestro
veniva da una scuola severa che alla teoria e pratica musicale univa un rigido codice comportamentale ed etico. Per conto suo il futuro maestro
coniugava un cursus studiorum rigido una ferrea
volontà di raggiungere quel benedetto diploma in
organo e composizione organistica. Di quella stagione di studio, intensissimo, condotto in condizioni disagiate su quel suo pianoforte verticale
sistemato alla meglio in locali di fortuna della
casa paterna e su quel suo organo della parrocchiale di Pravisdomini di ridotte capacità sonore,
il risultato è stato una formazone musicale di tale
intensità, da riuscire a selezionare - all'interno
delle schematiche proposte didattiche del
Conservatorio - quelle esercitazioni che veramente potevano servire a chi della musica avesse a
farsi servo.
La musica, appunto. La musica era per lui una
sposa esigente, gelosa, coinvolgente, totale. Non
gli lasciava spazio per altri interessi. Tutta lo
abbracciava, tutta gli si concedeva, ma tutto lo
prendeva e lo pretendeva. Spietata e splendida. E
gli assicurava praterie infinite sulle quali camminare verso orizzonti sempre antichi e sempre
nuovi e persino imprevedibili. Ma voleva l'abbandono totale. La musica era per lui amante fedelissima che lo avrebbe accompagnato dal momento
in cui aveva deciso di seguirla sino alla morte. Ma
pure amante esigente capace di dargli gioie indicibili e chiedergli sacrifici indicibili. Poi che la
musica egli ben sapeva come stesse al di là di lui
e nonostante lui. E però bisognosa di lui.
Altrimenti non sarebbe la musica.
Poco o nulla, ritengo, capisse di economia
contento di quelle poche lire che si ritrovava ad
avere in tasca per le piccole spese della giornata
consumata nell'ambito cittadino. O meglio, per
lui i problemi economici ruotavano tutto attorno
al dare ed all'avere del bilancio famigliare. Quel
bilancio che avrebbe gestito, fin dai primi giorni
del matrimonio, con estrema sagacia ed accortezza, Marilù. I soldi per il maestro non sono mai
stati non un problema, ma, ritengo, una fastidiosa necessità. Era uomo di estrema generosità.
Forse perché aveva conosciuto il bisogno. Forse
anche umiliante. Dal momento in cui nel 1957
riuscirà ad ottenere una cattedra quale insegnante di musica presso le scuole pubbliche, non vorrà
più percepire una lira da parte della parrocchia
per le sue prestazioni in duomo quale maestro
d'organo. Generoso. Generoso perché pronto a
regalare quello che era il suo tesoro più caro: la
sua musica. Facendola partecipe, rifiutando sdegnosamente qualunque profferta di compenso,
delle liturgie del duomo sanvitese, e delle celebrazioni matrimoniali e degli addii funerari. Sempre
pronto a sedere all'organo. Fino a quando, oramai segnato profondamente dalla malattia, siccome mi viene raccontando Marilù, al sentire suo-
nare le campane che davano il segno della messa
cantata festiva tutto si agitava per non poter più
sedere al suo organo del duomo. Splendido
signore. Insegnante generoso. Calcolando la difficoltà dei mezzi che all'epoca garantivano dei percorsi territoriali, diventa persin oggetto di meraviglia come il maestro, allora e per lunghi decenni, unico insegnante diplomato in organo della
diocesi di Concordia (oggi ConcordiaPordenone), riuscisse a raggiungere il seminario e
centri minori per insegnare nelle scuole musicali
ceciliane diocesane.
Ha regalato la sua musica ovviamente ai figli
accompagnandoli alla soglia dello studio delle arti
musicali. Con quella accortezza, cui appena sopra
si faceva accenno, capace di rifiutare l'inutilità
dell'esercitazione marginale per puntare su quella
che avrebbe diventare la sostanziale. Pronto a ritirarsi, nel momento in cui i suoi allievi di famiglia,
avessero incontrato, in corsi di studio regolari, gli
insegnanti di cattedra. Quelli che per il maestro
diventavano, da quel momento, i titolari cui affidare i passi dei propri figli. Con una ritrosia eccezionale che lo faceva intervenire con un consiglio,
un giudizio, un incitamento solo in momenti
eccezionali e comunque "di passaggio".
Ha regalato la sua musica ad un gruppo di
allievi che hanno cominciato a mettere le mani
sulla tastiera con la sua guida, i suoi suggerimenti, le sue indicazioni. Preziose. Ma soprattutto la
generosa dedizione a quell'insegnamento in cui
travasava, con la scienza, tutto il suo cuore ed il
suo entusiasmo mai stanco.
Ha regalato la sua musica ad amici che si sposavano, che portavano alla sepoltura parenti od
amici. Che celebravano anniversari o genetliaci.
A tutti. Senza mai nulla chiedere. Festoso. L'ha
regalata pure a me, in una nebbiosa serata del 22
dicembre 1971, quando, dopo avermi accolto
nella sua seicento, da San Vito mi ha scaricato
presso la chiesa di Sant'Antonio di Porcia. Una
chiesetta in cui, su una pianolina elettronica, ha
accompagnato le mie promesse matrimoniali.
Con un fagottino di confetti, dopo gli auguri di
rito, se ne è tornato a casa sua.
Ha regalato la sua musica ancora, di quando
in quando, a conclusione di una visita di amici
con cui aveva trascorso un felice momento conviviale. Mentre Marilù riassettava, con la Rosi, la
cucina, il maestro raggiungeva il duomo e si metteva all'organo per un'esecuzione di circostanza
che avesse a concludere l'incontro conviviale della
mattinata nell'ospitale casa Dean. Io non ero,
ovviamente, della compagnia, ma ricordo l'intimo dispiacere che provavo per questa esclusione
convinto quale ero di come in quel momento di
abbandono il maestro fosse in grado di dare il
meglio di se stesso. Per converso, rimango ancora
convinto di come il maestro, pur sublimando
questi passaggi con il rifugio nell'amplissimo ed
accoglientissimo utero della sua musica, in qualche misura abbia sofferto, pur pronto a prestare
in duomo il proprio servizio, di non vedere valorizzato, durante la reggenza parrocchiale di monsignor Pietro Corazza, il proprio servizio: Nino,
l'organo, che nol xe una soneta a boca. Te soni sempre masa forte. L'organo il ga de sonar quando che
il prete prega sotto vose. Se no la xente la parla. Che
sono consigli e considerazioni francamente piuttosto riduttive.
Poi il maestro regalava la musica a se stesso.
Quella durante la quale poteva suonare da solo,
per se stesso, in colloquio intimo, soprattutto con
il suo J. S. Bach.
E però mi pare come questa generosità del
maestro avesse a confinare con un'altra sua dote
che mi immagino, qui, di definire la sua pratica
della povertà. Ma una povertà straordinaria che ho
sempre ammirato senza trovare il coraggio di dirglielo sicuro com’ero che mi avrebbe mandato in
mona. Eccola: stava questa sua povertà (sempre che
il temine mi è consentito) in quel suo continuo
ripassare i brani, nel suonarli e risuonarli nella convinzione sincera, profonda, di una semplicità quasi
infantile, di non averne ancora afferrate tutte le
profondità, nella necessità di limare, di ripetere, di
rileggere. Nella certezza insomma, di non essere
mai all’altezza del suo J. S. Bach.
Avveniva poi però, che una volta alla tastiera,
egli s’allontanasse del tutto da chi lo ascoltava
lasciando proprio in quell’ascoltatore la percezione che oramai il maestro stesse camminando in
territori lontanissimi ove non era possibile seguirlo a meno che lui, con una frase, un sospiro, un
grugnito anche non ti mandasse un messaggio
rivelatore di quanto stesse passando nel suo cuore.
E di riflesso si intestardiva, salve rare eccezioni, lui così ricco di musicalità e di cultura musicale, fatta salva qualche rara eccezione di non particolare rilievo, nel non voler comporre. Mi diceva: O se xe Bach o no se scrive gnente. Sbagliava,
probabilmente. Anche perché qualche cosina in
carta gli riuscirà di mettere. Ma, in termini generali, il maestro era fatto così: juxta modum,
appunto. Di fronte ai grandi, taceva e studiava,
nel mentre invece si lasciava andare nella realizzazione di splendidi accompagnamenti delle melodie gregoriane, che sapeva trasportare a meraviglia (mettendo a frutto l'insegnamento del suo
insegnante di Conservatorio Sandro Dalla Libera
che voleva fare dei suoi allievi degli organisti,
prima di tutto, di chiesa), o, pur senza particolari entusiasmi, si acconciava ad accompagnare la
meschina produzione musicale ecclesiastica di
questa nostra grigia stagione musicale postconciliare. La chiave di lettura di queste sue irreversibili scelte credo sia questa: la necessità di ruminare
in silenzio. Perché finito di studiare a lungo un
brano scendeva dalla panca dell'organo, si accendeva una sigaretta dietro la sacrestia per quella
che chiamava una pipadina, faceva quattro passi e
quindi esclamava: benon. Ades tornemo dentro e
comincemo tutto da capo.
Solo da qualche poco di tempo sono riuscito
a capire il maestro quando si poneva all'organo.
Mentre andavo pensando che al suo posto avrei
cercato di leggere il maggior numero possibile di
testi musicali, il maestro continuava a suonare,
salvo qualche raro sconfinamento, il suo Bach
nella classica edizione tedesca Peters, capace di
andare avanti per due e più ore filate ripetendo,
in termini ossessivi, quelle cinque o sei pagine
della partitura. E mi tornava alla mente, mentre
lo ascoltavo, il professore di latino e di greco del
liceo che, mentre con una sudicia pezzuola andava pulendo le lenti di certi occhiali degni di
Cavour, solennemente asseriva: Si vis totum
cognoscere, totum lege. In traduzione: se vorrai
conoscere tutto quanto si potrà mai conoscere a
questo mondo, leggi tutto quello che è stato scritto. Ma era lo stesso che, in altra occasione a noi
scolari accucciati nei banchi suggerendo di prendere appunti, proclamava Opportet non legere
multa, sed multum. E di nuovo in traduzione:
non è opportuno leggere molti testi, ma quelli
che si leggono vanno letti in maniera estremamente approfondita. E però mi torna alla mente
il frammento di Eraclito: «L'intima natura delle
cose ama nascondersi». Di fronte ad un'infinita
offerta musicale (che all'epoca dei suoi studi era
senza dubbio di gran lunga inferiore a quella che
la letteratura è in grado di offrire oggi), il maestro
non si spaventava. Non gli interessava totum legere e nemmeno totum scire. Gli bastava essere
ammesso al convito dei grandi. Mi diceva, di
fatti: Co te pol magnar la torta, parché gastu de
contentarte de le paste? Sorrideva, mi guardava
negli occhi, e tirava diritto sempre con quella sua
andatura oscillante. Era in quei momenti che, al
di là dell'infinito cicalare di testi filosofici e di
trattati più o meno pretenziosi, ho cominciato a
capire che cosa voglia dire essere umili.
Non ho mai conosciuto con precisione - se
poco raccontava di sé, di questo argomento mai
ebbe a far con me parola - quali le tappe evolutive del suo credo religioso. Certo le radici della sua
religiosità saranno ora da ricercare nell'ambito
famigliare e nel ristrettissimo ambiente in cui si
sono susseguite le giornate e le stagioni della fanciullezza, dell'adolescenza e della giovinezza del
maestro. Un panorama che qui sarebbe troppo
lungo e complicato anche solo provare a tratteggiare, ma di cui basterà dire che era tutto intessuto di una serie di coordinate ben precise delle
quali, e delle primarie, una era quella della presenza, nella vita di tutti - si badi bene credenti o
meno credenti - inevitabile e totalizzante del
«Signor». Una presenza che rientrava di prepotenza in quella sorta di microcosmo che era il
paese con i suoi rapporti sociali ed economici, i
ritmi delle stagioni e delle feste di chiesa e che
trovava plastica rappresentazione nella chiesa, nel
suono delle campane, nelle funzioni liturgiche,
nella figura del «pievan». Un "piccolo mondo
antico" nel quale il fanciullo Ferruccio si è ritrovato a vivere, con ritmi sempre uguali: dalla casa
alla chiesa tutte le mattine, dapprima come chierichetto e poi come giovane organista per accompagnare le messe De requie, pressoché quotidiane,
e poi alla scuola. Quindi il rientro attraverso i
campi con il sole e con la pioggia, con il freddo e
con la neve. Senza possibilità, o forse ancora
senza voglia, di ribellarsi. Un «Signor» che poi
avrebbe ritrovato nelle pagine del catechismo e
che ritornava in modo imperativo nelle prediche
domenicali che forse, già allora, poco amava. Al
di sopra di queste prime immagini e progressivamente fusa con queste questo «Signor» deve aver
assunto i connotati dell'autorità e della austerità
forse dal maestro recuperati nei contatti giovanili
con le severe figure dei preti o degli insegnanti (si
pensi, ad esempio, all’impatto che deve aver
avuto sul timido ragazzino di Pravisdomini l’incontro al Conservatorio Musicale di Venezia con
il direttore dell’epoca, il mitico Gian Francesco
Malipiero). Stava questo «Signor» al di là dello
spazio e del tempo degli uomini: un Dio con cui
non scherzava e di fronte al quale gli era di fastidio l’eccessiva confidenza che con lui riteneva
avessero anche alcuni dei preti incontrati sul suo
cammino. Non deve meravigliare quindi se progressivamente il maestro ha sfrondato questo suo
stare di fronte al «Signor» di una serie di manife-
stazioni particolari fino ad arrivare ad una estrema dignità e ad un’esigenza sempre più rigida di
interiorità e di silenzio. Un «Signor» di fronte al
quale stava in piedi come il profeta Eliseo: Vivit
Dominus ante quem sto (Re IV, 5, 16): “un
Signore vivo è quello di fronte al quale io sto in
piedi”. Per ricordare il maestro in ginocchio devo
riandare a tempi molto lontani. Aveva imparato a
presentarsi di fronte a Lui con il suo corredo
umano e soprattutto con la sua intelligenza ed il
suo bisogno di capire e di razionalizzare anche il
rapporto e le manifestazioni del credo religioso.
Era di fatti un rimpianto che si portava dietro
quello di non aver potuto studiare con comodo
ed a tempo debito la filosofia. Ma nonostante
questo, egli è stato un filosofo o meglio ancora un
umanista in quel suo sentirsi completo solamente
quando - di fronte ad ogni circostanza e momento della vita oppure di fronte ad ogni incontro (e
quale incontro più importante di quello con il
«Signor») - non gli veniva richiesto di annullarsi e
di rinunciare a pensare. Forse per questo naturale
bisogno di indagine e di ordine gli piaceva tanto
la musica bachiana dall’architettura così geometricamente ferrea e dai rapporti così terribilmente
sorvegliati. E così intrisa di riguardo per quello
che sta al di là del perimetro terreno.
È il momento del commiato che è, ben spesso,
un passaggio non del tutto facile. Almeno per me.
La musica, si è detto poco sopra, era sua. O
meglio: era diventata sua, al solito juxta modum,
frutto di una conquista faticata, ma tenace,
testarda, e, soprattutto, senza mai un ripensamento. Uno sponsale perfetto. Un approdo gratificante. Dodici anni di Conservatorio, ore e ore
passate al pianoforte a ripetere lo stesso esercizio
fino a quando il brano non fosse filato liscio senza
una piega, un attimo di esitazione, un'incertezza.
Sicché, alla fine del percorso, lui diveniva della
musica. Tutto e sempre, fino a quando, oramai
gravemente ammalato, ma lucidissimo, si riproponeva, al sentire suonare le campane del duomo
per la messa solenne domenicale, di andare all'organo per un'altra volta ancora, accompagnare le
liturgie per le quali aveva consumato, per anni,
tempo, amore, intelligenza, competenza. Lo sapeva fin dall'inizio come fosse difficile, per non dire
impossibile, denegarsi ad un'amante esigente,
invasiva, avvolgente, ma di una dolcezza straordinaria quale la musica incontrata in condizioni
eccezionali ed inseguita con una fedeltà straordinaria per tutta la vita. Marilù asserisce spesso, con
quella sua convinzione che commuove, come il
suo Ferruccio fosse stato un sacerdote della musica. Ed aveva ed ha ragione. Egli ha amato la
musica, ma la musica ha amato lui in un connubio che negli anni, mentre si veniva lentamente
dissolvendo l'impegno liturgico, si faceva sempre
più stretto nell'abbraccio dello studio quotidiano:
una fatica fatta di silenzio, di un continuo riprovare battuta per battuta, affrontando i brani,
anche i più difficili con calma: Ciapemola in
dolce, che dopo pian pianin ghe rivemo.
È difficile credere tutti i giorni in Bach in un
piccolo centro come San Vito. Non è tanto questione di voler fare cultura. È piuttosto continuare a credere in quella che è stata la cultura della
tua vita. Resistere, ogni giorno, alla voglia di non
incontrare più il tuo Bach. Da solo. Quando gli
altri sono da un'altra parte, oppure si accalcano
sulla porta della chiesa, per uscire dopo la messa,
mentre il maestro proponeva una delle tante
composizioni dell'immortale organista di Lipsia.
Le ultime note si disperdevano in una chiesa oramai vuota in cui, lesto, si affacendava il sacrestano desideroso di andare a pranzo oppure a cena.
Spero di non sbagliarmi. Ma mi vien da pensare che il maestro abbia cominciato a morire, come
al solito senza darlo troppo a vedere, nel momento in cui, oramai ammalato, ha dovuto abbandonare la tastiera e la frequentazione del suo organo.
La morte era passata a fianco del maestro più
volte fin dagli anni della adolescenza e della giovinezza in Pravisdomini. Lo aveva sfiorato al
momento della febbre maltese. Aveva imparato a
considerarla una delle componenti di questo
nostro stare sulla terra. Abituato com'era a prendere le cose come venivano ed a vivere la giornata contento di quello che il buon Dio regalava dal
mattino alla sera. Diceva a me e ad altri: La morte
primo o dopo la vien per tutti. Se te ghe seri la porta
la vien comunque dentro, ma cattiva. Se la porta te
ghela versi, la vien dentro più bona.
La morte si fece preannunciare con la diagnosi di un male incurabile. La aspettò, per un'ultima volta ancora, juxta modum per più di tre anni.
Senza rivoltarsi, ma aprendole un pochino alla
volta la porta perché venisse a trovarlo più bona.
Volle farsi accompagnare ancora una volta da
J.S. Bach. Si mise a studiare quel corale che il
grande musico aveva dettato, fino alla 19a battuta, sul letto di morte: «Dinanzi al tuo trono io mi
presento o Dio». Un piccolo gioiello musicale,
privo di tutti gli straordinari «ornati» di altre
similari composizioni. Un discorso nudo, quasi
arcaico, che procede per singole frasi pur splendidamente armonizzate. Una preghiera affidata a
respiri. Quasi una voglia del grande compositore
di ritornare alle origini a conclusione del suo
lungo e splendido percorso musicale. Nudus
egressus sum de utero matris meae et nudus revertar illuc (Giobbe, 1, 21). Come a dire, in traduzione: di un latinetto piuttosto facile, «nudo
sono uscito dall'utero di mia madre e nudo vi
ritornerò». Quel bisogno di "nudità" estrema che
il maestro, proprio lui che mai aveva bramato di
possedere, giunto alle porte dell'eternità, chiedeva di tradurre in preghiera al suo Bach. Un ultimo richiamo, fors'anche, agli inizi della sua
vicenda musicale. Alla "nudità" del suo oramai
lontano ed indissolubile incontro amoroso con
la musica in quella chiesa di Pravisdomini fredda
e sorda ed indifferente.
Chiudeva gli occhi per sempre attorno alle
11.00 del 25 giugno 2001. Un commiato discreto come si addiceva ad una persona sempre ed
anche alla fine pudica e gelosa dei propri senti-
menti. La mattina era cominciata con la tradizionale visita di Fabrizia che, prima di raggiungere il
Conservatorio Musicale di Udine, si era data da
fare per l'assistenza al papà. Se lo era preso in
braccio con quell'energico e straordinario suo
amore - oramai pesava più o meno una trentina
di chili - lo aveva accudito, lo aveva poi ridisteso
sul letto. La radio, inconscia del momento, continuava a trasmettere musica classica. Al capezzale arriva, convocato da Luciana, monsignore arcidiacomo Nicola Biancat.
Un piccolo, impercettibile sospiro e poi la
partenza definitiva. Ai piedi del letto gli occhioni
della nipote prediletta, Valentina, figlia della sua
Cristiana, quella Valentina che gli aveva cinguettato attorno al divano od al letto durante gli ultimi tempi dell'esistenza. Sopra la testiera il quadro
della Madonna con il Bambino che, in anni oramai lontani, gli aveva regalato don Tullio. Quella
immagine di fronte alla quale il maestro, prima di
affrontare il riposo notturno (con il quale, mi
confessava Marilù, egli aveva da tempo un rapporto piuttoso difficile) recitava la sua preghiera:
Signor, ciome come che son. Prima del trapasso,
monsignore, con una felicissima intuizione, aveva
lasciato la casa del maestro ed aveva raggiunto il
duomo dove si era messo all'organo. Sotto le abili
dita di don Nicola, quell'organo che il maestro
aveva tante volte fatto suonare per Iddio e per gli
altri questa volta cantava solo per lui.
L'addio ufficiale, registrerà un lungo corteo di
popolo, ventinove o trenta sacerdoti, autorità ed
associazioni, una straordinaria esecuzione musicale, un'omelia di monsignor Biancat. Il quale,
vincendo la sua tradizionalmente nobile signorilità, riuscirà ad avviare quella non facile predica
raccontando una barzelletta del maestro.
Il picolo nio xe vodo, maestro mio, da quando te
lo ga lasà, e noi ghe stemo tuti atorno, inamorai.
E però, mentre il feretro usciva, fendendo una
ressa che quasi sembrava voler trattenere ancora,
almeno per un poco, quell'amico che se ne era
andato, mi sembra possano essere riproposti i già
citati versi di Biagio Marin:
Ninte ne dà sto porto,
marsise el bastimento
se no l'ha vele al vento
e mar sul bocaporto.
Se ne è volato via, ancora una volta "maestro
rivoluzionario" di vita, lui che per natura e formazione era un intelligente e saggio conservatore,
lasciando non tanto un vuoto che oramai è tradizione asserire essere incolmabile. No davvero.
Lasciandoci piuttosto la feroce constatazione di
come quel vuoto nessuno di noi sarà capace di
colmare. E dunque davvero più soli.
Si vogliono chiuse queste note chiuse, come
lo sono state aperte, con dei versi. Sono di
Martina, la nipote del maestro, figlia di Fabrizia.
Li ha dedicati al maestro (e Marilù mi dice che
forse egli non ha potuto ascoltare) nemmeno tredicenne, il 12 maggio 2001 a poco più di un
mese e mezzo avanti la scomparsa del nonno. Il
testo è stato quindi messo in musica dal bravo
Daniele Zanettovich.
Così esisti
Una fiamma mi culla la mente
un lampo ricorda il presente
così ricordo la tua amicizia.
Così ricordo la melodia del tuo sperare
e la forza del tuo credere.
Così ricordo il bimbo che ti guarda
da un abbracio di mamma.
Così ricordo la tua scienza imparata dalla vita.
Così ricordo la tua cultura imparata dall'esperienza.
Così ricordo la tua ingenuità, saggezza del tuo essere.
Così non ti ricordo.
Perché così esisti.