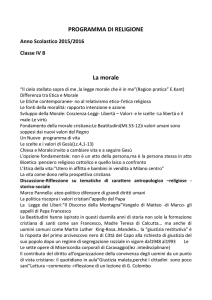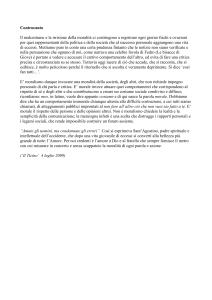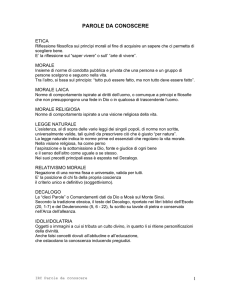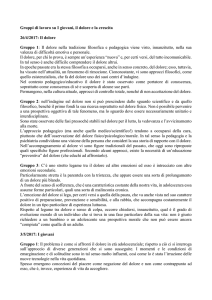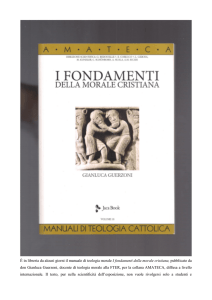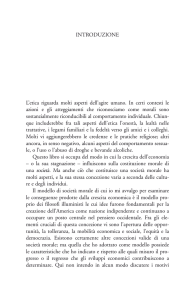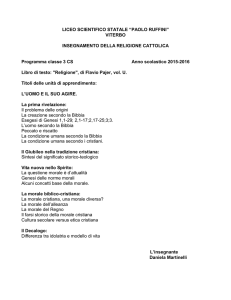CONGRESSO TOMISTA INTERNAZIONALE
L’UMANESIMO CRISTIANO NEL III MILLENNIO:
PROSPETTIVA DI TOMMASO D’AQUINO
ROMA, 21-25 settembre 2003
Pontificia Accademia di San Tommaso
–
Società Internazionale Tommaso d’Aquino
L’esperienza morale
L’antropologia di Karol Wojtyla tra tomismo e fenomenologia
Prof. Antonio Livi
Pontificia Università Lateranense, Roma (Italia)
Come ha giustamente osservato Schmitz nel suo accurato lavoro
sull’antropologia di Karol Wojtyla 1 , l’attuale Pontefice – in sintonia con i suoi
studi e le sue ricerche filosofiche degli anni di insegnamento dell’etica a Lublino
- ha fatto uso del metodo fenomenologico, anche nel contesto schiettamente
teologico del suo magistero, per rifondare la ricerca metafisica, ossia per
riproporre in termini attuali la necessità di un passaggio “dal fenomeno al
fondamento” e recuperare così il tesoro della sapienza cristiana antica e
medioevale, in particolare quella di Tommaso d’Aquino. Dove meglio si scorge
l’opportunità e l’efficacia dell’innesto della fenomenologia sulla radice del
tomismo operato da Karlo Wojtyla è nei suoi studi sulla natura etica della
persona umana2 ; in tali studi, infatti, si vede come Wojtyla si sia impegnato a
lungo nella ricerca di una nozione metafisico-gnoseologica in grado di fondare
il rapporto tra verità, libertà e responsabilità. La nozione che Wojtyla individua
come fondamento critico di questo rapporto - e della possibilità di individuarne
l’unità antropologica - è la concezione dell’esperienza come fondamento
veritativo di ogni altra forma di conoscenza. Nell’esperienza viene individuato
un primum cognitum (il mondo come insieme ordinato di enti interdipendenti) e
ad esso viene riconosciuto il primato gnoseologico, nel senso che alla realtà
“oggettiva” (il mondo) deve conformarsi l’atto “soggettivo” di ricerca della
Cfr Kenneth L. Schmitz, At the Center of the Human Drama: the Philosophical
Anthropology of Karol Wojtyla / Pope John Paul II, The Catholic University of America
Press, Baltimore, MD, 1994.
2 Cfr Karol Wojtyla, Subjectivity and the Irreducible in the Human Being, in Person and
Community, Peter Lang Publisher, Nuova York 1975; Idem, Il problema dell’esperienza
nell’etica, trad. it., in I fondamenti dell’ordine etico, Cseo, Bologna 1980, pp. 7-28; Idem,
Amore e responsabilità, trad. it., IV ed., Ed. Marietti, Genova 1983; Idem, Persona e atto,
trad. it., II ed., Ed. Rusconi, Milano 1999.
1
© Copyright 2003 INSTITUTO UNIVERSITARIO VIRTUAL SANTO TOMÁS
Fundación Balmesiana – Universitat Abat Oliba CEU
A. LIVI, L’esperienza morale
verità (l’io che si riconosce situato nel mondo e in un ineliminabile rapporto di
responsabilità con gli altri). Nella ricerca di Wojtyla sull’esperienza si rilevano
infatti preziose riflessioni sul raccordo che l’esperienza della soggettività ha con
l’esperienza della moralità, e questa a sua volta con l’esperienza religiosa.
Per comprendere quanto segue è indispensabile premettere qualche
chiarimento terminologico. Il termine “esperienza” è quanto mai ambiguo, dato
il senso radicalmente diverso con cui esso è impiegato dai vari sistemi filosofici
che si sono succeduti nella storia e anche nel linguaggio ordinario dei nostri
giorni3 . Io qui, per riferirmi al pensiero antropologico di Wojtyla, uso il termine
nell’accezione filosofica moderna di “conoscenza primaria”, o immediata, in
contrapposizione alla conoscenza “secondaria” o mediata, detta anche “di
secondo livello”, la quale è costituita dai vari tipi di inferenza. In questa
accezione, il termine “esperienza” si usa sempre al singolare e non ammette
aggettivi qualificativi ma solo aggettivi determinativi che ne restringano il
significato (come “esperienza sensibile” o “estetica”, “morale”, “spirituale”,
“mistica” e così via), anche se non implica di per sé alcuna limitazione di
àmbito che non sia quella che caratterizza la conoscenza umana nei suoi modi e
nei suoi limiti costitutivi. Pertanto, la nozione di “esperienza” non va ridotta
alla dimensione sensistica, come fecero i filosofi di scuola “empiristica”; essa
connota certamente i dati forniti immediatamente dai processi sensoriali, ma
non si circoscrive a essi: fa parte dell’esperienza, infatti, anche l’intuizione
immediata delle dimensioni metafisiche degli enti percepiti con i sensi, quali
soprattutto l’esistenza (il fatto di esserci), la sostanza (le cose concrete nella loro
individualità), l’essenza (o natura delle cose), le relazioni di una cosa con le altre
(singolarmente o nel loro insieme), e pertanto la nozione di causalità efficiente.
Dunque, la nozione di esperienza, in questo senso, non è una nozione
relativa ma assoluta: essa si riferisce a ciò che sta alla base e all’inizio di ogni
conoscenza di ogni soggetto; pertanto, non connota la cultura di un certo
gruppo sociale, né un tempo individuale di accumulo delle conoscenze, né una
riflessione metodica o un’intenzionale sperimentazione scientifica… Proprio
per questo, tale nozione di esperienza può e deve applicarsi – come vedremo innanzitutto alle certezze del “senso comune”; secondariamente, poi, a quelle
conoscenze immediate e indubitabili che però non sono – dal punto di vista dei
soggetti e anche per l’oggetto - comuni a tutti ma riguardano determinati
soggetti conoscenti oppure determinati oggetti di conoscenza.
L’esperienza, così intesa, può essere denominata “esperienza originaria”;
essa consta di giudizi con i quali il soggetto esprime la coscienza di essere in
Cfr Antonio Livi, “Esperienza”, in Dizionario storico della filosofia , II ed., Società Ed.
Dante Alighieri, Roma 2001, p. 54.
3
p. 2
Congresso Tomista Internazionale
possesso di una conoscenza immediata e indubitabile, potendo formulare
giudizi che esprimono l’innegabile presenza dell’oggetto, la sua “evidenza”, e
come tali costituiscono il motivo per superare ed eliminare ogni possibile
dubbio. I giudizi dei quali consta l’esperienza hanno il massimo grado possibile
di garanzia circa la verità da essi espressa, e per questo sono il fondamento
della verità del pensiero in generale.
I caratteri essenziali dell’esperienza (conoscenza originaria) sono
l’immediatezza e l’indubitabilità dell’oggetto, cui fa riscontro la certezza o fermezza
dell’assenso da parte del soggetto. “Immediatezza” è un termine gnoseologico
che fa riferimento al processo di acquisizione delle conoscenze da parte del
soggetto, mentre “indubitabilità” e “certezza” si riferiscono a uno stato mentale
del soggetto che è cosciente di possedere quei dati di immediata evidenza. Che
secondo termine – “certezza” – indichi ciò che dipende dal primo (ma può
dipendere anche da evidenze mediate), è vero; ma l’esperienza comprende
anche il caso di conoscenze indubitabili – e di stati di certezza - che non
conseguono a un approccio immediato all’oggetto ma a inferenze intuitive,
come è il caso della conoscenza dell'esistenza di Dio.
A differenza di molta parte della filosofia contemporanea, che restringe il
senso della “razionalità” alla possibilità di dimostrare la verità di un asserto
(come se l’evidenza fosse soltanto quella mediata dal raziocinio), la filosofia
classica e medioevale privilegiava giustamente quella dimensione cognitiva che
chiamava “intellectus” (in greco “nous”), rispetto alla “ratio” (corrispondente al
greco “diànoia”), riconoscendo che ogni attività discorsiva (dialettica) parte
dall’intellectus (possesso delle premesse) per poi tornare all’intellectus stesso
(possesso delle conclusioni). Perciò qui occorre ricordare, per comprendere
bene la dottrina etico-filosofica di Karol Wojtyla, che la mediazione (riflessione,
inferenza, raziocinio, induzione, deduzione, verifica, testimonianza) presuppone
l’esperienza, che costituisce l’immediato: non si dà alcuna conoscenza mediata
(che abbia valore epistemico) senza una conoscenza immediata (che abbia
altrettanto o più valore aletico). Questa immediatezza è la principale proprietà
logica dell’esperienza, l’essere il fondamento sempre attuale e sempre attivo del
processo razionale, che su essa poggia a ogni passo, e a essa deve arrivare come
esito finale del processo, con un guadagno di immediatezza rispetto al
momento di inizio.
Ora, tutto sta a determinare di quale immediatezza si tratti. Per Descartes
e per il soggettivismo che lo seguì (razionalismo e empirismo), l’immediato è il
pensiero stesso in uno qualsiasi dei suoi modi, ossia le rappresentazioni
(“pensées”, “ideas”, “Vorstellungen”), mentre per la filosofia classica e per il
realismo moderno l’immediato è l’oggetto del pensiero, sono le cose conosciute,
p. 3
A. LIVI, L’esperienza morale
la realtà in sé, il mondo delle cose e lo stesso soggetto conoscente in quanto
facente parte di questo mondo. Il realismo consiste proprio in questo:
l’immediato, che la riflessione filosofica “trascende”, va innanzitutto
riconosciuto come un fatto (fenomenologia) che si dà con la qualità iniziale del
rapporto soggetto/oggetto. Immediatezza, insomma, non vuol dire identità del
pensiero con sé stesso, ma vuol dire invece rapporto (diretto, senza
intermediazioni, ma rapporto) con altro dal pensiero. L’immediatezza, inoltre, è
compatibile con l’assunto che la verità non sta propriamente in una nozione
semplice (concetto), ma sta invece di un atto complesso come il giudizio (atto
complesso, perché riflessivo, sia quando è sintetico che quando è analitico),
perché la riflessione che è costitutiva del giudizio è una riflessione concomitante
l’atto stesso, non susseguente: solo la riflessione susseguente costituisce una
mediazione che toglie alla conoscenza il carattere di immediatezza.
L’esperienza originaria, nella sua immediatezza, ha come “hard core”
l’apprensione dell’essere degli enti che costituiscono il “mondo”: è lì infatti che
l’esperienza ha il massimo di immediatezza, in quanto precede logicamente la
riflessione sull’io come soggetto e la qualificazione delle cose come oggetto.
Tutto ciò serva a capire ancora meglio che il termine “esperienza”, usato
nell’accezione primaria di “conoscenza universale e necessaria”, indica una
conoscenza che non ha bisogno di essere comunicata perché è già di per sé
comune: è il “senso comune”: resta incomunicabile, ineffabile e inespressa,
eppure consente ai diversi soggetti di avere un implicito referente comune e
quindi di comunicare4 .
La dottrina tommasiana sui fondamenti del conoscere.
Per determinare meglio in che cosa consista il carattere di certezza
dell’esperienza, cercherò di fissare con la massima esattezza l’àmbito logico
dell’asserzione in rapporto alla sua innegabilità. Cito innanzitutto una celebre
tesi tommasiana, che direttamente riguarda i “primi princìpi” astratti ma
indirettamente si applica ai giudizi di esistenza sulla realtà concreta del mondo,
dell’io, degli altri soggetti, delle norme moralità e di Dio come primo principio e
ultimo fine: «Nullus potest cogitare oppositum eius quod est per se notum, ut patet per
Philosophum circa prima demonstrationis principia» (Summa theologiae, I, q. 2, art. 1).
Il soggetto della frase è “nessun uomo”; si tratta, quindi, della conoscenza
umana presa in senso universale: nessuna intelligenza può sfuggire alla legge
enunciata; l’azione considerata impossibile è proprio il “pensare” ( = affermare)
il contrario di ciò che si vive come evidenza immediata, cioè di una realtà (res)
conosciuta in modo immediato per mezzo della sensibilità e dell’intelletto. In
Vedi Antonio Livi, Filosofia del senso comune (Logica della scienza e della fede), Edizioni
Ares, Milano 1990.
4
p. 4
Congresso Tomista Internazionale
altri termini, riflettendo sull’evidenza di quanto è stato recepito dal soggetto
con la “conoscenza degli indivisibili” (simplex apprehensio), l’intelligenza altro
non può fare se non aderirvi conformandosi (adaequatio) a questa realtà
attraverso il giudizio. L’evidenza, mediata o immediata che sia, impone infatti
un assenso; la struttura della conoscenza, se correttamente intesa, possiede un
carattere intenzionale che consente, nell’àmbito conoscitivo — che è, di per sé,
soggettivo —, una relazione con la realtà che si manifesta come data, come
“altro”.
Bisogna ora capire che cosa intenda Tommaso con l’espressione “per se
notum”; questa espressione potrebbe essere un sinonimo di “evidente”, ma resta
in ogni caso da precisare che cosa si intenda con tale termine in questo specifico
contesto. Nel “per se notum” si distinguono due aspetti: 1) da un lato, esso
esprime qualcosa che è di per sé intelligibile in modo completo, ossia che non
contiene in sé niente di inintelligibile; 2) dall’altro lato, considerando il modo in
cui la cosa si presenta all’intelletto, “per se notum” vuol dire che l’intelletto
recepisce la res direttamente, di per sé (“per se”), ossia in modo istantaneo, non
discorsivo, senza alcuna mediazione di altre verità (il che vuol dire che tale
evidenza non dipende da altre evidenze logicamente anteriori, quindi non
deriva da ragionamento o dimostrazione). Il “per se notum” non si riferisce a un
grado di certezza dell’intelletto, ma al fatto che le cose che si recepiscono in
questo modo sono innegabili, poiché l’intelletto non può non pensarle. Il
principio del “per se notum” è, tra l’altro, collegato al principio di noncontraddizione; infatti, così come non si può dire che una cosa sia e allo stesso
tempo non sia, così anche che l’evidenza di ciò che è “per se notum” non può
essere negata né con una evidenza contraria (in quanto nessuna delle due
sarebbe “evidenza”) né per mezzo di un ragionamento, poiché l’evidenza della
conclusione di un ragionamento è sempre minore rispetto all’evidenza
dell’esperienza immediata delle cose, che costituisce il punto di partenza del
ragionamento induttivo, dal quale poi deriva quello deduttivo.
In base a questa caratterizzazione, si comprende come i dati
dell’esperienza che generano conoscenze immediatamente evidenti non si
possano collocare tutti sullo stesso piano, né si presentano tutti allo stesso
tempo; vi sono certezze intuitive che non ne presuppongono altre, e sulle quali
tutte le altre sono edificate. Bisogna pertanto tener conto del fatto che la verità
dell’esperienza implica pluralità e gerarchia delle conoscenze. E, in questo
senso, il primo campo cognitivo al cui interno si deve applicare la logica della
“presupposizione”5 è proprio il campo dell’esperienza.
Per il significato e la portata di questo termine della logica aletica vedi Antonio
Livi, Verità del pensiero(Fondamenti di logica aletica), Lateran University Press, Roma,
2002.
5
p. 5
A. LIVI, L’esperienza morale
Nella percezione delle cose esistenti noi captiamo di ciascuna cosa il
“qualche cosa” e l’”esistere” (entrambi immediatamente, anche se in maniera
confusa). Tale percezione intellettiva dà forma metafisica ai dati materiali forniti
dalla sensibilità, ossia a quell’immagine concreta dell’oggetto (“experimentum”)
che è stato elaborato dal “sensorio comune” (koine aisthesis), dalla memoria e
dalla “vis cogitativa”. Infatti la conoscenza sensibile è la base per la conoscenza
sia dell’essenza che dell’esistenza, anche se non allo stesso modo. Si ricordi
come, secondo Tommaso, il valore dell’oggettività troverebbe il suo
fondamento in nella “conversio ad phantasmata”, nella continuità funzionale tra
senso e intelletto nel suo processo di ritorno: nella misura in cui
dall’experimentum emerge l’intelligibile per mezzo della conversio, l’intelletto ha
la conoscenza del particolare e pertanto della ratio entis, e così è garantita
l’intenzionalità. L’atto della percezione è esercitato dall’intelligenza in quanto
questa è continuazione dei sensi, e l’apprensione dei criteri dell’essenza e dei
criteri dell’esistenza è cosa che compete propriamente all’intelligenza, ma viene
effettuata in dipendenza dalla sensibilità e in continuità con essa, sia perché da
essa assume la materia dell’intuizione, sia perché ad essa deve continuamente
ritornare.
Così, il primum cognitum è il risultato di una esperienza immediata
dell’essere in atto (l’essere delle cose); ma non si tratta certamente - per dirla con
la terminologia di un autorevole tomista del Novecento come Cornelio Fabro dell’essere come atto (l’essere universale); si ricordi che Fabro giustamente
distingue tra “esse in actu” e “esse ut actus” e respingere le interpretazioni di altri
tomisti, come Jacques Maritain, che postulano una esperienza diretta dell’actus
essendi in quanto tale. Fabro distingue giustamente l’esistenza, come fatto
empirico di realizzazione effettiva e presente, dall’atto di essere come atto primo;
all’affermazione della conoscenza dell’esistenza come dimensione necessaria
del “primum cognitum” si arriva per mezzo della riflessione fenomenologica
sull’atto percettivo, che distingue tra contenuto essenziale ed esistenza, mentre
non sembra possibile includere nell’esperienza originaria la nozione di “esse”,
che è successiva e riservata alla riflessione propriamente metafisica, che vi
giunge solamente dopo un lungo e difficile cammino (e lo stesso Maritain
riconosce che solo alcuni godono del privilegio dell’intuizione dell’essere).
Certamente, l’apprensione dell’ens non consiste nel captare il mero dato della
presenza delle cose, ma connota l’essere in atto delle cose stesse, il che fa sapere
che questa presenza è di per sé indipendente dal nostro conoscere ed è effetto
dell’essere proprio di ciò che si conosce. Si deve dunque dire che
nell’esperienza originaria si coglie molto di più che la mera esistenza di fatto
delle cose: si coglie - almeno indirettamente – l’atto di essere delle cose, nel
senso che le cose le conosciamo in quanto ciascuna di esse è un ente-in-atto
(Dasein). Contingenza (esserci di fatto) e necessità (esserci in virtù dell’essere,
manifestare l’essere) sono dimensioni entitative che l’intelletto coglie in un
p. 6
Congresso Tomista Internazionale
unico giudizio primo, un giudizio che è poi capace di fondare una metafisica
dell’atto di essere e della libertà dell’atto creativo di Dio, origine di un mondo
di cose contingenti.
Tutto quanto ho detto finora serve per ribadire che alla base di ogni
certezza empirica sta l’esperienza dei fatti, delle situazioni, ossia l’esperienza
delle cose nel loro aspetto esistenziale, che il giudizio esprime attraverso la sua
funzione “indicale”, la cui importanza non si deve mai dimenticare6 ; l’aspetto
direttamente essenziale (quello che si esprime attraverso la funzione
“predicativa”, no quello connotato dai giudizi esistenziali) è necessariamente
secondo, susseguente, e anche ipotetico (perché la domanda sull’essenza delle
cose non sempre viene posta; e quando viene posta non sempre trova risposta).
Chi adopera la logica modale e mette la nozione di “verità” in rapporto con le
tre modalità dell’essere – la necessità, la realtà di fatto, la possibilità – rileva
parimenti che la modalità della realtà è quella logicamente predominante. In
altri termini, la verità logica – la verità del giudizio – richiede, in base alla legge
della “presupposizione”, che i giudizi esistenziali precedano e fondino quelli
predicativi.
L’esperienza del mondo, come conoscenza certa di un insieme ordinato
di enti, è così il fondamento della verità del pensiero. Il mondo è costituito da
“tutte le cose” (ta panta), ossia dagli enti. Ciò che lega gli enti tra loro non è solo
la comune appartenenza logica all’essere (“esse commune rerum”) ma anche un
intreccio di reciproche relazioni, soprattutto di quelle relazioni che interessano
l’essere stesso (l’esistenza o l’essenza) nelle varie forme di passaggio dalla
potenza all’atto, ossia l’ordine causale; l’ordine del mondo è infatti soprattutto
ordine dinamico, secondo la causalità efficiente e la causalità finale. Il rapporto
di tale caratteristica cognitiva dell’esperienza – l’ordine causale - con la verità
del pensiero è un rapporto assolutamente primario: basti pensare che
l’intelligibilità delle cose consiste proprio nella scoperta delle cause intrinseche
(materiale e formale) ed estrinseche (efficiente e finale) che permettono di
comprendere perché una cosa ci sia e perché sia fatta in quel modo. La filosofia
analitica anglosassone riconosce ormai apertamente che la prima apprensione
intellettuale (il principio primo dell’esperienza) è il mondo delle cose nella loro
multiforme correlazione e interrelazione.
In conclusione, se la funzione principale del giudizio è di esprimere
l’essere delle cose, a ragione abbiamo potuto dire che il giudizio esistenziale ha
una priorità logica rispetto al giudizio predicativo, che esprime la conoscenza
dei predicati essenziali e accidentali (quidditas) della cosa. I giudizi predicativi
Vedi in proposito Antonio Livi, La ricerca della verità: dal senso comune alla dialettica,
II ed., Casa editrice Leonardo da Vinci, Roma 2003.
6
p. 7
A. LIVI, L’esperienza morale
costituiscono insomma il discorso su che cosa sia (quid sit) la tale cosa, quella
certa cosa (aliquid), cioè, della quale logicamente si presuppone l’esistenza (quod
sit). La differenza tra i due tipi di giudizio e la loro giusta relazione di
dipendenza (nel senso che il giudizio predicativo presuppone il giudizio
esistenziale) hanno la massima importanza nel nostro discorso. Si dà il caso,
infatti, che a volte la conoscenza umana si arresta all’intuizione o alla deduzione
dell’esistenza di qualcosa, senza poterne afferrare l’essenza: questo è il motivo
per cui si parla giustamente di “senso del mistero”, non in rapporto al
soprannaturale ma anche e innanzitutto in rapporto alla conoscenza della realtà
naturale.
Se analizziamo – applicando sempre il metodo fenomenologico - l’atto
percettivo, noi riconosciamo in esso sia alcuni contenuti (nozioni, essenze) sia il
fatto che tali contenuti sono reali (appartengono alle cose); in modo
concomitante rileviamo anche l’autocoscienza del soggetto, che avverte sé
stesso come diverso dalle cose conosciute ma in rapporto con esse. È questa una
delle risultanze del metodo fenomenologico in pensatori come Edmund
Husserl, Max Scheler, Edith Stein, Roman Ingarten e l’autore che ora più ci
interessa, Karol Wojtyla; quest’ultimo parla di due “aspetti” rilevabili
nell’esperienza: il “senso della realtà” e il “senso della conoscenza”; il primo fa
riferimento
al
contenuto dell’esperienza, ossia a ciò che esiste
indipendentemente dal soggetto, e in esso prevale il piano della “realtà”,
costituito dalle cose in quanto trascendono l’atto di conoscerle; il secondo
aspetto è costituito dalla «percezione di un particolare vincolo con ciò che esiste
in modo reale e oggettivo. Ancora di più, è la percezione di un particolare
contatto o fusione con ciò che esiste propriamente in quel modo» 7 .
In conclusione, la prima notizia che abbiamo nel percepire la realtà è
proprio che “le cose sono”; è questo il vero primum cognitum. Nell’analisi
filosofica della percezione si conclude che, già dal punto di vista
fenomenologico, in ogni atto percettivo l’intelligenza umana capta non solo
alcune formalità delle cose ma anche l’esistenza delle stesse. Precisando le
osservazioni fenomenologiche con criteri metafisici, possiamo dire con Karol
Wojtyla che la percezione della realtà è la percezione dell’essenza di certe cose e
allo stesso tempo la percezione del loro esse. È evidente a tutti noi nell’atto di
conoscere il mondo, che non ci troviamo solo di fronte a delle “forme”, ma
anche e soprattutto di enti, cioè di essenze-che-sono, di soggetti reali. Inoltre, in
ogni attività percettiva, la prima cosa che la coscienza capta è (insieme ad
alcune prime caratteristiche di che-cosa-è) anche il suo carattere di reale che-è.
Anche Tommaso d’Aquino ritiene che la «ratio entis» venga captata «statim» e
non attraverso una mediazione; l’intelletto potrà poi sviluppare questa
7
Karol Wojtyla, Il problema dell’esperienza nell’etica, cit., p. 336.
p. 8
Congresso Tomista Internazionale
intuizione attraverso l’analisi concettuale della metafisica, ma la ratio entis già è
presente fin dal principio. Nell’analisi fenomenologica del primum cognitum si
presenta dunque una dualità tra un “qualche cosa” e il fatto che questo qualche
cosa “sia”: la dualità intrinseca alla nozione di ente è attestata dall’analisi
fenomenologica della conoscenza iniziale, nella quale il fatto che le cose siano
non si riduce alle loro proprietà nozionali. Tra l’altro, visto che questa
distinzione si rileva chiaramente nella riflessione fenomenologica, sarà possibile
tematizzarla anche metafisicamente ricercandone il fondamento ontologico, che
è quello del rapporto tra essenza ed esistenza; certo, è proprio della metafisica il
considerare tale rapporto nella sua portata assoluta, ma la metafisica però non
potrebbe considerarlo in astratto se la fenomenologia non lo avesse presente in
concreto.
Dunque, l’ens come “primum cognitum” significa la presenza del concreto
all’inizio stesso del pensiero: infatti, ciò che è, ciò che ha l’essere, è il concreto, il
mondo inteso come l’insieme delle cose. Del loro esserci (Dasein) ci rendiamo
conto fin dall’inizio perché fin dall’inizio ci sono presenti. Nel confrontarci con
le determinazioni che sono presenti di fronte a noi le conosciamo come
determinazioni di enti che sono esistenti, reali. Tommaso insegna: «Siccome una
cosa include sia la sua essenza (quidditas) che il suo atto di essere (esse), la verità
radicata nell’atto di essere di una cosa più che nella sua essenza [veritas fundatur
in esse rei magis quam in ipsa quidditate]. Infatti, il nome di “ente” [ens] deriva
dall’essere [esse], e pertanto l’adeguazione nella quale la verità consiste si
raggiunge attraverso una specie di assimilazione dell’intelletto all’essere [esse]
della cosa, proprio per mezzo dell’operazione con cui lo apprende così com’è»
(Scriptum super libros Sententiarum, dist. 19, q. 15, art. 1).
Se si accetta questa caratterizzazione del primum cognitum, allora non si
può parlare di una conoscenza dell’ens sulla linea dell’astrazione delle essenze
(perché captare l’ens non è captare un’essenza), come nemmeno nella linea di
qualunque altro processo astrattivo. La conoscenza dell’ens è primaria e
universale, e non si può, per questo motivo, considerare l’ens come un
“sopraintelligibile mistico”, còlto attraverso una “intuizione superiore”, come
sembra dire Maritian. Il problema, comunque, non è di facile soluzione: da una
parte, infatti, il primum cognitum ha un carattere intellettuale, il che significa che,
pur fondandosi su ciò che captiamo attraverso la sensibilità, richiede
l’intervento dell’intelletto agente (ma non per arrivare a un concetto, ossia a una
forma astratta); d’altra parte, esso è strettamente legato alla percezione, ma non
è un contenuto sensibile: non è percepito sensibilmente e non si manifesta
separato dalla conoscenza delle forme sensibili.
p. 9
A. LIVI, L’esperienza morale
Comunque, per quanto ci riguarda adesso, occorre concludere che la
verità dell’esperienza funge da fondamento sempre attuale e sempre attivo del
pensiero in ogni sua forma e in tutta la sua universalità. La certezza di pensare
il giusto (“recta ratio”) riposa sul fondamento della incontrovertibilità assoluta
dei dati dell’esperienza. Infatti: 1) la conoscenza è ciò per cui si entra in
relazione intenzionale con la realtà (l’altro da sé come oggetto e l’io che vi è
implicato come soggetto); 2) solo con l’atto di giudicare, ossia di “comporre”
(sintetizzare) e “scomporre” (analizzare) i dati empirici e i concetti, la
conoscenza acquista la qualità di “espressione della verità”; 3) pertanto, solo
nell’àmbito di un giudizio si può verificare l’errore, la falsità; 4) l’errore non è
comunque possibile quando l’evidenza è tale da costituire “id quod est per se
notum”: è anzitutto il caso delle nozioni del senso comune, intese come i
primissimi giudizi di esistenza, fondamento oggettivo di tutta l’esperienza e
condizione di possibilità logica per la formulazione dei primi princìpi
speculativi e pratici. Il senso comune può dunque essere definito come
esperienza universale e necessaria della realtà. L’unità dell’esperienza, pertanto,
fa capo al senso comune, fondamento noetico originario e anche necessariamente
attuale, perché consiste in giudizi basati sull’innegabilità di dati sempre
immediatamente presenti. Il senso comune non è un reperto della “archeologia
del sapere” ma un dato della fenomenologia della coscienza, in quanto
fondamento logico attuale di ogni conoscenza in atto. E il primo elemento di
quel sistema organico di giudizi universali e necessari che formano il senso
comune è il giudizio “le cose sono (res sunt)”, nel quale è implicata la nozione di
ens come primum congnitum. Ogni possibile verità del pensiero no può
prescindere da questa prima verità, anzi vi si deve coerentemente fondare;
cosicché anche la filosofia – anzi, soprattutto la filosofia, per la sua essenziale
funzione aletica – deve tener conto della prima verità e svilupparsi in coerenza
logica con essa: questa legge - che io denomino “principio di coerenza”8 - viene
tenuta presente e rigorosamente applicata da Wojtyla a tutti i problemi di fondo
della riflessione filosofica, e in particolare ai fondamenti dell’ordine etico.
L’emergenza dell’io dalla conoscenza del mondo e l’esperienza della
soggettività.
L’apprensione dell’essere degli enti non connota direttamente il soggetto
dell’apprensione. La presenza al soggetto delle cose in mezzo alle quali egli
vive non è la presenza di un “oggetto” (in senso cartesiano o kantiano): non è
cioè la presenza di qualche cosa di diverso da me come soggetto ma che io
rilevo all’interno di me; è semplicemente una presenza grazie alla quale io sto
Cfr Antonio Livi, Il principio di coerenza: senso comune e logica epistemica, Ed.
Armando, Roma 1997.
8
p. 10
Congresso Tomista Internazionale
effettivamente conoscendo che “le cose sono”, non che un oggetto (il mondo) è
presente alla mia coscienza. La presenza alla quale qui ci si riferisce è la
presenza di ciò che è reale di fronte a me, come un qualche cosa che io non sono
e che non si può ridurre al mio io. Il mondo non è in alcun modo riducibile alla
soggettività: non si può dire che si trova di fronte a me solo in quanto si
manifesta in me; bisogna invece dire che io mi conosco e mi riconosco come
soggetto proprio perché ciò che è concreto si trova “fuori” di me, e la sua
presenza “esteriore” mi parla del suo essere-in-sé.
L’emergenza dell’io dal mondo delle cose conosciute è un passaggio,
richiede la mediazione di un’operazione intellettiva, che è la negazione: le cose
che conosco non sono io, e io non sono le cose che conosco. Si tratta
dell’esperienza primaria della negazione, che segue all’esperienza primaria
dell’affermazione: l’io infatti giunge a conoscersi attraverso la negazione di tutto
ciò che conosce come oggetto, perché l’io non è nulla di ciò che esso conosce –
non è oggetto – ma è colui che conosce, è appunto il soggetto. La conoscenza in
atto fa emergere la coscienza del soggetto come polo dialetticamente opposto a
tutto ciò che è oggetto della conoscenza stessa: sempre, beninteso, nell’unità del
mondo al quale il soggetto appartiene e sa di appartenere (la conoscenza,
d’altronde, è sentita come un influsso del mondo sull’io e una presa dell’io sul
mondo; insomma, come relazione). Come è stato giustamente osservato da un
altro studioso di scuola fenomenologica, «l’identificazione che il soggetto fa di
se stesso consiste fondamentalmente in un giudizio di essere (giudizio con il
quale egli si coglie distinto da altri esseri), in un giudizio di relazione (giudizio
con il quale egli si coglie in comunicazione di esistenza con altri esseri), e in un
giudizio di limite (giudizio che di per sé lo preserva da ogni presunzione di
comprensione di sé). Questi sono […] i termini nei quali il soggetto intravede la
sua identità. Essere, relazione, limite sono i termini che illuminano il soggetto a
se stesso e per i quali, appunto, egli ha coscienza di sé» 9 . Sull’argomento anche
Max Scheler (uno dei punti di riferimento di Wojtyla filosofo) aveva
individuato il giusto rapporto dell’io con il mondo attraverso la conoscenza
diretta e riflessa: «L’uomo, in quanto persona, è l’unico ente che può elevarsi –
come essere vivente – al di sopra di sé stesso; egli può, a partire da un centro
collocato, per così dire, al di fuori del mondo spazio-temporale, trasformare
tutte le cose (e tra queste anche sé stesso) in oggetto della sua conoscenza»10 .
Un altro concetto da chiarire è il rapporto tra la prima certezza del senso
comune (la verità del mondo) e la seconda (la verità dell’io, l’autocoscienza); il
Luciano Baccari, “Considerazioni sul problema della conoscenza”, in Aquinas, 35
(1992), pp. 570-571.
10 Max Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo e altri saggi [1928], trad. it., Ed. Fabbri,
Milano 1962, p. 65.
9
p. 11
A. LIVI, L’esperienza morale
chiarimento può essere fornito da questo testo di Tommaso d’Aquino: «La
verità risulta dall’operazione dell’intelletto che formula un giudizio nel quale
l’intelletto stesso si riferisce alla cosa così come essa è. Tale verità, poi, è
conosciuta dallo stesso intelletto che riflette sul proprio atto: in questa
riflessione, infatti, l’intelletto conosce non solo il proprio atto ma anche la
corrispondenza di questo atto alla cosa. Ora, tale corrispondenza non può
essere conosciuta se prima non si conosce la natura dell’atto intellettivo, e
questo a sua volta non può essere conosciuto se prima non si conosce la natura
del principio attivo, cioè l’intelletto stesso, la cui natura è appunto di potersi
conformare alle cose» (Quaestiones disputatae de veritate, q. 1, art. 9). Si noti
anzitutto, in questo testo tommasiano, la concatenazione dei presupposti
dell’adeguazione rilevati dall’Aquinate, che mostra di saper fare ricorso al
procedimento della presupposizione. Affermando poi la priorità logica della
conoscenza del mondo sulla conoscenza di sé o autocoscienza, egli scrive:
«L’anima si conosce attraverso i suoi atti. Infatti, uno di noi si accorge di avere
un’anima, di vivere e di esistere accorgendosi di sentire e di conoscere e di
svolgere le altre funzioni vitali. […] Ma nessuno si accorge di conoscere se
prima non conosce qualcosa [ = una delle cose del mondo], perché la
conoscenza di qualcosa precede la conoscenza della conoscenza» (Quaestiones
disputatae de veritate, q. 10, art. 8). Non si tratta certamente di priorità
cronologica, bensì - lo ho già detto - di priorità logica; dal punto di vista
cronologico (cioè fisico, psicologico), la conoscenza e l’autocoscienza sono atti
concomitanti, e infatti Tommaso precisa altrove che «con la medesima
operazione io conosco l’oggetto e conosco di conoscere» (Scriptum super libros
Sententiarum, I, dist. 1, q. 2, art. 2). In questo senso è stato giustamente detto che
l’esperienza fa il soggetto: il soggetto si riconosce e si identifica come “soggetto
di esperienze” (cfr González 1983).
L’io, logicamente inteso, non è dunque nient’altro che il soggetto in senso
stretto, e per questo non è oggettivabile: l’autocoscienza non è l’impossibile
trasformazione del soggetto in oggetto (cosa contraddittoria), ma la conoscenza
(oggettivazione) di qualcosa che appartiene al soggetto, senza identificarsi
metafisicamente con esso. La terminologia metafisica classica aiuta a
comprendere questa verità, che il pensiero moderno ha peraltro in vari modi
riproposto; per Tommaso, ad esempio, ciò che egli chiama “anima” (e che in
certi contesti teoretici corrisponde proprio a ciò che noi contemporanei
chiamiamo “io”) conosce sé stessa non direttamente – come oggetto – bensì
indirettamente, come fonte e origine e fondamento dei propri atti (che sono
“accidenti” rispetto all’anima intesa come “sostanza”), soprattutto gli atti
superiori dell’intelletto e della volontà. Questi atti possono sì essere oggetto di
conoscenza; per cui il soggetto può essere ed è ordinariamente consapevole di
conoscere direttamente le cose e di ragionare, di desiderare qualche oggetto e di
decidere un’azione, e in concomitanza con queste “appercezioni” o atti di
p. 12
Congresso Tomista Internazionale
“coscienza psicologica” intuisce il proprio io come soggetto di tali pensieri e
volizioni. In altri termini, l’autocoscienza è la riflessione del soggetto sui propri
atti: questi – che sono di per sé atti con i quali si può oggettivare ciò che è
esterno alla coscienza – possono diventare a loro volta oggetti della conoscenza
da parte dell’io, il quale ha così indirettamente coscienza di sé (senza che però
l’io stesso sia mai appreso come oggetto!).
L’inoggettivabilità dell’io fa sì che si parli dell’esperienza di sé in due
modi: come intuizione di sé in quanto soggetto, e allora si tratta di
un’esperienza indiretta, concomitante, che viene detta “conoscenza che l’io ha
di sé”; oppure intuizione di sé come oggetto, e allora non è propriamente l’io a
essere conosciuto bensì le sue Erlebnisse, ciò che gli appartiene, lo manifesta, lo
descrive e lo qualifica, e questo oggetto viene detto in alcune lingue “il Sé” (“the
Self”, “das Selbst”, “le Soi”), con un significativo passaggio dalla prima persona
alla terza. In ogni caso, la ricerca fenomenologica sviluppata da diverse scuole
filosofiche del Novecento ha messo in chiaro la specificità dell’autocoscienza,
arrivando a ipotizzare la conoscenza di sé come un “oggetto speciale” che
sarebbe frutto non di una vera e propria “funzione riflessa” ma di una
“funzione riflessiva”, mediante la quale avrebbe luogo «la fondamentrale
intuizione della persona, così come essa si rivela nell’atto [w czynie] e attraverso
l’atto [czyn]»11 .
C’è da precisare ancora che la “conoscenza di sé” raggiungibile
attraverso l’oggettivazione di qualcosa che appartiene al soggetto costituisce la
conoscenza della natura umana, dell’uomo in quanto essenza universale:
certamente, riferita all’individuo che possiede tale natura, ma pur sempre
diversa dall’io come soggetto; scriveva in proposito Wojtyla: «Partendo
“dall’interno” di noi stessi, usciamo dal nostro “io” per andare verso l’”uomo”,
e contemporaneamente, partendo dall’uomo ritorniamo all’io, e quindi di
nuovo all’interno. In tal modo la nostra conoscenza dell’uomo ha, per così dire,
carattere ciclico. Ciò è pienamente giustificato, poiché oggetto della conoscenza
non deve essere solo il nostro io ma all’uomo, che al tempo stesso è anche “me
stesso”, è anche il mio io» 12 . Vi è addirittura chi spinge l’inoggettivabilità dell’io
fino a includere la conoscenza dei propri atti intenzionali, che sarebbero
anch’essi solamente “connotati”: ma per il momento basta riaffermare che la
verità del pensiero comprende l’autocoscienza, ossia la conoscenza che l’io ha di
sé, in quanto implicata nella conoscenza di ogni altra cosa come “oggetto”, ossia
come “altro da sé”.
11
12
Karol Wojtyla, Persona e atto, cit., p. 229.
Wojtyla, op. cit., p. 145.
p. 13
A. LIVI, L’esperienza morale
Viene dunque a essere confermato che il primissimo dato di evidenza
inconfutabile – quello che costituisce il nucleo veritativo dell’esperienza - è
l’esistenza delle cose, presupposto per l’emergenza dell’io nella coscienza del
soggetto che conosce il mondo come alterità oggettiva. Abbiamo già visto,
infatti, che la prima certezza del senso comune è che “le cose sono”; dopodiché
il possessore di questa conoscenza certa - la mente che conosce il mondo delle
cose - distingue in questa totalità degli enti sé stesso come soggetto, in
contrapposizione a tutto il resto, visto come oggetto. La conoscenza è dunque
conosciuta (con un atto riflesso, almeno implicitamente) fin dall’inizio della
coscienza, già nella conoscenza del mondo: ed è conosciuta come rapporto
dell’io con le cose. Possiamo dire pertanto che l’esperienza contiene (almeno
implicitamente) una concezione realistica della conoscenza, in modo tale che
ogni asserto contrario a questa evidenza primaria si trova a essere privo di
consistenza logica dal punto di vista aletico: non può avere giustificazione.
L’esperienza morale, nucleo dell’antropologia.
Tra i tanti modi di affrontare lo studio del comportamento umano o
“agire” – dalla fenomenologia alla psicologia – ha una sua specificità lo studio
del comportamento umano sub specie moralitatis, ossia in quanto esso è avvertito
come libero e pertanto indice di una responsabilità del soggetto che così ne viene
qualificato (buono o cattivo, giusto o ingiusto). La valutazione dell’agire umano
riguarda propriamente i singoli atti o determinate inclinazioni (habitus), ma
sempre in rapporto a qualcosa di universale e necessario, ossia in rapporto alla
“giustizia” o rettitudine morale, al “fine” che l’uomo per natura ha e che deve
consapevolmente realizzare, in quanto costituisce il “dovere”, il “bene”
propriamente umano, quello che rende buono l’uomo come tale.
Ma, anche nello studio dell’agire umano dal punto di vista etico possono
darsi approcci del tutto differenti: quello che qui interessa è l’approccio
gnoseologico-veritativo, l’unico che possa cogliere una intrinseca connessione
tra il metodo fenomenologico wojtyliano e la metafisica tommasiana. Restano
dunque esclusi, in questo contesto, altri tipi di approccio, a cominciare da
quello “di secondo livello” che discute la natura e lo statuto epistemologico
della filosofia morale (etica filosofica) e della teologia morale (etica teologica).
Infatti, la connessione profonda e permanente tra l’agire morale e i problemi
della logica aletica sta nella nozione di “senso morale”, e gli studiosi di etica,
pur nella diversità profonda di orientamenti e metodologie, sembrano oggi
d’accordo almeno su questo punto: il senso morale, nel suo nucleo fondamentale
– costituito dall’intuizione dei “valori”, ossia dell’ordine morale -, è esperienza, è
una dimensione dell’esperienza, fa parte dell’esperienza in generale.. Per
“esperienza pratica” si intende l’esperienza del proprio io in rapporto al valore
delle intenzioni e delle azioni, lì dove l’io esercita la sua libertà e si “sente”
p. 14
Congresso Tomista Internazionale
responsabile (cioè autore unico, causa esclusiva) delle sue iniziative o delle sue
reazioni, con un “sentire” che è squisitamente intellettuale (ed è questa infatti
l’accezione con cui i moralisti britannici del XVIII secolo trattarono del “moral
sense”). Alla fine del XVIII secolo, Kant esprime con forza un concetto che anche
nel mio discorso è importante: che l’esperienza morale precede e fonda ogni
riflessione filosofica, ogni “scienza della morale”; pur esprimendosi in termini
di apriorismo, con la conseguente svalutazione dei dati empirici (a motivo del
suo rifiuto di ammettere un’intuizione intellettuale), Kant riconosce che
l’essenza del senso morale non è una conquista della scienza: «Non c’è bisogno
di scienza né di filosofia per sapere ciò che si deve fare per essere onesti e
buoni, e persino saggi e virtuosi. […] Tutti i concetti morali hanno la loro sede e
la loro origine interamente a priori nella ragione, senza differenza fra la ragione
umana più comune [die allgemeine Menschenvernunft] e la ragione umana
speculativa al livello più alto» (Fondazione della metafisica dei costumi, trad.it., Ed.
Laterza, Bari 1988, pp. 25, 36). La riflessione scientifica sui princìpi morali non
fonda l’esperienza morale, ma si fonda su di essa; anzi, per Aristotele la filosofia
morale è superflua quando l’uomo già possiede la capacità di vivere secondo i
dettami della ragione pratica (cfr Etica nicomachea, I, 4, 1096 b 6-8), e addirittura
inutile quando tale capacità non si possiede (cfr op. cit., X, 9, 1179 b 6).
L’essenza della moralità è l’esperienza originaria: la conoscenza etica
centrale e determinante non è quella concettuale, tantomeno quella che
proviene dai sistemi filosofici, ma quella che deriva dall’esperienza interna
della persona e che consiste in una percezione morale complessa e soggettiva.
Dico “complessa e soggettiva” perché tale percezione si fonda, da una parte,
sulla sintesi che il soggetto opera di tutti i dati dell’esperienza (del mondo, di sé
e degli altri) riconducendoli al valore di una “giusta prassi” o “dovere”; e,
dall’altra, si fonda sul riferimento che il soggetto fa di tutto ciò che conosce (il
mondo) a sé, interpretando ogni cosa alla luce di una totalità di senso che
consiste nel desiderare e perseguire il proprio bene o “felicità”, ossia la riuscita
della propria esistenza. Così si può dire che «l’agire morale è quell’agire che in
ogni momento vive della presenza di una totalità di senso» 13 .
Questo connotato di “esperienza” universale e necessaria permette di
includere la moralità tra le certezze del “senso comune”, dopo la certezza circa
l’esistenza del mondo, l’esistenza dell’io e l’esistenza di propri simili (“gli
altri”). L’esperienza morale è dunque squisitamente soggettiva e oggettiva allo
stesso tempo: non solo perché accomuna tutti gli uomini, ma anche e
soprattutto perché li accomuna nella verità. L’esperienza morale, insomma, è
molto di più della semplice “interiorità” della quale parlava Kant,
Robert Spaemann, Glück und Wohlwollen, Ernst Klett & Cotta Verlag, Stoccarda
1989, p. 200.
13
p. 15
A. LIVI, L’esperienza morale
distinguendo, sulla base di questa nozione, tra “moralità” e “legalità”: «La
moralità degli atti [Moralität der Handlungen] è qualcosa di interiore [innerliches] e
pertanto non può essere regolata da leggi umane pubbliche; le leggi esteriori
servono a istituire una comunità giuridica e quindi riguardano unicamente la
legalità degli atti [Legalität der Handlungen], cosa che cade sotto i sensi, non la
moralità interiore» (Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, ed. a
cura di Karl Vorlander, Felix Meiner Verlag, Amburgo 1966, p. 107). Si tratta di
qualcosa di “interiore” ma anche di più “valido” – come valore aletico – rispetto
a ogni altra forma di conoscenza morale; l’esperienza morale è infatti ciò che
permette alla coscienza morale di agire, giudicando della moralità dei singoli
atti (bonum faciendum in concreto, nella vita vissuta), ed è anche ciò che permette
di elaborare una teoria etica e di stabilire princìpi etici (bonum faciendum in
generale, nelle norme che reggono e regolano la vita sociale e religiosa). Senza
l’esperienza morale – che è comune a tutti ma anzitutto propria di ciascuna
persona – ogni singolo atto di valutazione morale è aleticamente infondato, e
ogni teoria morale è destinata a produrre concetti falsamente universali, dotati
talvolta di una verità astratta e generica, ma più spesso arbitrari. È la persona il
luogo dell’esperienza morale, la sola che apprenda la verità dei valori e della
libertà e che possa poi – a partire da questa “presa diretta” - parlarne in termini
legittimamente universali, in virtù della logica dell’induzione e dell’analogia.
Secondo Spaemann, proprio perché la singola persona è dotata di un
orizzonte conoscitivo di estensione infinita (il mondo, sé stesso, gli altri suoi
simili), egli è anche capace di riconoscere il valore in sé di ciò che si dà
concretamente nell’esistenza storica del suo mondo; ciò si manifesta in modo
emenente in quel tratto dell’esperienza morale che Spaemann - rifacendosi allo
“amor benevolentiae” o “amor amicitiae” della filosofia tommasiana - chiama
“benevolenza (Wohlwollen)” e definisce come «l’essere desti alla realtà
dell’essere-sé»14 , aggiungendo che «l’essere si rivela soltanto alla benevolenza;
[…] e questo mostrarsi precede ogni dovere. Esso è il dono che sta a
fondamento di ogni possibile dovere»15 . Il nucleo dell’esperienza morale
consiste dunque nella percezione di un “ordine” che rende “giusti” i rapporti
interpersonali, un ordine che trascende quello che intercorre tra l’uomo e la
natura e ancora di più quello intrinseco al mondo fisico, ossia la sfera delle leggi
della natura materiale. In altri termini, l’esperienza morale è un salto di qualità
rispetto alla percezione dei rapporti deterministici vigenti nella realtà del
mondo: quando si parla di “legge naturale” a proposito delle norme essenziali
dell’ordine morale, non si vuole certamente confondere l’ordine morale con
quello cosmologico, perché nell’àmbito morale la parola “legge” e la parola
“natura” hanno un significato del tutto diverso da quello che tali termini
14
15
Robert Spaemann, op.cit., p. 132.
Robert Spaemann, op.cit., p. 135.
p. 16
Congresso Tomista Internazionale
assumono quando si parla di mondo fisico o di strutture psicologiche e
sociologiche.
L’esperienza morale è dunque qualcosa di elementare (la ricchezza
concettuale appartiene ad altre forma della conoscenza) e al tempo stesso di
fondamentale nella vita umana, sia al livello della coscienza individuale che al
livello degli usi e dei costumi sociali; e dicendo che è “fondamentale” voglio
dire che tutte le altre manifestazioni della vita morale presuppongono questa
esperienza, che è sempre latente anche se occasionalmente le sovrastrutture
culturali possono contraddirla. Agostino lo aveva intuito quando scriveva: «Gli
uomini credono che non ci sia giustizia perché vedono che i costumi variano da
popolo a popolo, mentre la giustizia dovrebbe essere immutabile. Ma essi non
comprendono che il precetto di non fare agli altri ciò che non vorremmo fosse
fatto a noi è un precetto che mai cambia, un precetto che rimane constante nel
tempo e nello spazio» (De doctrina christiana, III, 7). Come dice Giovanni Paolo
II, «l’uomo porta scritta nel suo cuore una legge [cfr Rm 2, 15 e Dignitatis
humanae, § 3] che non è lui a darsi, ma che esprime le immutabili esigenze del
suo essere personale creato da Dio, finalizzato a Dio e in sé stesso dotato di una
dignità infinitamente superiore a quella delle cose. Questa legge non è solo
costituita da orientamenti generali, la cui precisazione nel loro rispettivo
contenuto è condizionato dalle varie e mutabili situazioni storiche. Esistono
norme morali aventi un loro preciso contenuto immutabile ed incondizionato»
(Discorso ai partecipanti al Congresso di teologia morale, 10 aprile 1986, n. 4).
La ragione di questa “costanza” o immutabilità delle norme
fondamentali è che esse esprimono, non la valutazione occasionale di un atto o
di un comportamento concreto, contingente, bensì la natura stessa dei rapporti tra
i soggetti, o meglio del soggetto con i propri simili. In termini strettamente
gnoseologici, posso dire che l’esperienza morale è la conoscenza del fatto che i
rapporti del soggetto con i propri simili hanno un carattere unico, innanzitutto
perché si tratta di persone umane, e poi perché i rapporti interpersonali sono
qualificati dalla libertà e sono pertanto carichi di responsabilità: sono rapporti
necessariamente buoni o cattivi, sono espressione di un valore o di un
disvalore, debbono essere giudicati. Dalla conoscenza del carattere morale dei
rapporti tra gli uomini deriva poi l’evidenza dei contenuti essenziali della
moralità, evidenza che la tradizione filosofica cristiana ricollega alla “sinderesi”
o “abito dei primi princìpi della ragione pratica”; a loro volta, i primi princìpi
della moralità (denominati “legge naturale”) consentono il giudizio morale
pratico, ossia l’atto valutativo del “da farsi” denominato “coscienza”. Pertanto,
l’esperienza morale – lo vedremo meglio tra poco – non è la coscienza, ma è la
costante esigenza razionale che induce il soggetto a valutare i suoi atti alla luce
di questo criterio fondamentale che è la legge naturale: appunto l’atto di
p. 17
A. LIVI, L’esperienza morale
valutazione dei singoli atti è la coscienza morale. Come ha insegnato Giovanni
Paolo II, «il giudizio della coscienza è un giudizio pratico, ossia un giudizio che
intima che cosa l’uomo deve fare o non fare, oppure che valuta un atto da lui
ormai compiuto. È un giudizio che applica a una situazione concreta la
convinzione razionale che si deve amare e fare il bene, ed evitare il male.
Questo primo principio della ragione pratica appartiene alla legge naturale,
anzi ne costituisce il fondamento stesso, in quanto esprime quella luce
originaria sul bene e sul male, riflesso della sapienza creatrice di Dio che, come
una scintilla indistruttibile (scintilla animae) brilla nel cuore di ogni uomo.
Mentre però la legge naturale mette in luce le esigenze oggettive e universali
del bene morale, la coscienza è l’applicazione della legge al caso particolare, la
quale diventa così per l’uomo un interiore dettame, una chiamata a compiere
nella concretezza della situazione il bene. La coscienza formula così l’obbligo
morale alla luce della legge naturale: è l’obbligo di fare ciò che l’uomo, mediante
l’atto della coscienza, conosce come un bene che gli è assegnato qui e ora. Il
carattere universale della legge e dell’obbligazione non è cancellato, ma
piuttosto riconosciuto, quando la ragione ne determina le applicazioni
nell’attualità concreta» (enc. Veritatis splendor, 6 agosto 1993, § 59). In questo
senso insegna Tommaso d’Aquino che la coscienza individuale è sì regola della
moralità, ma una “regula regulata”, in quanto dipende direttamente e
interamente dalla “sinderesi”, ossia dall’abito dei primi princìpi dell’ordine
morale, che coincide con ciò che io denomino “esperienza morale
fondamentale” (cfr Quaestiones disputatae de veritate, q. 17, art. 4).
A questo proposito, è utile tornare sulla distinzione operata da Kant tra
“moralità” e “legalità”. I due concetti non vanno intesi come in una dialettica di
opposizione, perché la legalità è una proiezione della moralità.
Qual è dunque l’oggetto specifico dell’esperienza morale? Si deve dire, in
estrema sintesi, che l’esperienza morale riguarda la qualità e l’ordine dei rapporti
tra il soggetto cosciente e gli altri soggetti, e che al centro di questi rapporti c’è
la persuasione che il campo delle libere scelte è anche il campo della
responsabilità, nel senso che il soggetto si riconosce responsabile nei confronti
degli altri per ciò che pone in atto con le sue decisioni libere, le quali sempre
coinvolgono (almeno indirettamente) il bene e gli interessi altrui (vedi Molinaro
1973; Ingarten 1982). La responsabilità implica la solidarietà tra gli uomini:
prima ancora che una conquista della cultura (religiosa e filosofica), la
solidarietà è avvertita come costitutivo essenziale della natura umana; prima
ancora che la religione (soprattutto quella cristiana) metta in luce il legame di
fraternità che lega tutti gli uomini in quanto figli di un unico Padre, e prima
ancora che Aristotele metta in luce la natura sociale della persona umana (“zoon
politikon”), l’esperienza della famiglia e delle più elementari relazioni sociali
produce nella coscienza la categoria etica dell’amicizia. Occorre dunque,
p. 18
Congresso Tomista Internazionale
adesso, mettere in luce come l’esperienza morale sia fondata nel senso
dell’amicizia, sostanziato di gratitudine e radicato nel riconoscimento dell’altro
come “dono”.
Il senso morale consiste in una fondamentale e operativa dimensione
dell’esperienza, quella per cui che il soggetto, posto di fronte alla totalità delle
sue relazioni con il mondo, percepisce immediatamente e con assoluta evidenza
la radicale “differenza qualitativa” che caratterizza i suoi rapporti con i suoi
simili, ossia con gli altri soggetti; ogni soggetto pensante avverte che i suoi
rapporti con gli altri soggetti non sono come i rapporti con le “cose”, ma lo
coinvolgono personalmente e intimamente; sono rapporti che hanno un valore
peculiare, che si manifesta attraverso la dialettica di sentimenti opposti:
amicizia/ostilità, gratitudine/risentimento, amore/odio, interesse/disinteresse,
ricerca/fuga….
Nel rapporto con gli altri soggetti liberi la persona scopre il senso
(l’orientamento necessario) della propria libertà, giacché la libertà personale è in
funzione della ricerca e della scoperta dell’assoluto da amare, che non può
essere che un’altra persona. Come è stato opportunamente rilevato, a Tommaso
d’Aquino non sfuggiva questa dimensione personalistica: «Il momento della
libertà nell’azione determina la costituzione del fine, voluto per se stesso, cioè
della persona amata, verso cui si dirige l’azione, per realizzare la comunione. Il
giudizio che guida la scelta acquista razionalità solo nel momento in cui si
appoggia sull’assoluto della persona a cui tende e che merita di essere amata
per se stessa. Infatti, il termine proprio dell’atto di amore è sempre e solo una
persona, colta come ultimum dilectum, fine ultimo del dinamismo affettivo» 16 . La
coscienza morale è dunque esperienza della scoperta del proprio orientamento
originario e del proprio fine, da raggiungere attraverso l’esercizio della libertà
nel senso proprio della verità. Questa dimensione intersoggettiva della moralità
va messa in piena luce fin dall’inizio dello studio dell’agire morale; già
Giuseppe Capograssi, nella prima metà del Novecento, aveva messo in luce
fenomenologicamente il rapporto tra l’agire della persona e la struttura
dell’esperienza morale17 .
La presenza e la conoscenza degli altri è ciò che genera nella mia
intelligenza l’intuizione della necessità di rispettare i diritti altrui, così come gli
altri sono tenuti a rispettare i miei diritti; parlando in termini di “etica dei
Livio Melina, La conoscenza morale. Linee di riflessione sistematica sul commento di san
Tommaso all’Etica nicomachea, Ed. Città Nuova, Roma 1988, p. 450.
17 Cfr Giuseppe Capograssi, Analisi dell’esperienza comune, in Opere, vol. II, Ed.
Giuffrè, Milano 1959; Idem, Introduzione alla vita etica, in Opere, vol. III, Ed. Giuffrè,
Milano 1959.
16
p. 19
A. LIVI, L’esperienza morale
valori” (Wertethik), il primo valore che si presenta alla coscienza nell’esperienza
umana è la persona dell’altro, che non può essere trattata come una “cosa”, non
può essere “strumentalizzata”, ma va riconosciuta nella sua irripetibile unicità e
nel suo valore di dono. Come aveva ben visto Max Scheler, dall’esperienza del
risentimento – reazione morale all’ingiustizia perpetrata da altri nei miei
confronti - nasce la categoria di base della moralità, che la Sacra Scrittura
enuncia in questi termini: “Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto
a te”; è un principio costantemente richiamato dai libri sapienziali dell’Antico
Testamento (cfr Libro di Tobia, 4, 16: «Ciò che detesti che gli altri ti facciano, non
lo fare tu a loro») e poi ribadito da Gesù stesso: «Tutte le buone azioni che
volete gli uomini facciano a voi, fatele anche voi a loro: questa è infatti [in
sintesi] la Legge e i Profeti» (Vangelo secondo Matteo, 7,12). Paul Ricoeur ha
osservato che questa norma rappresenta la “regola d’oro” della moralità e che si
può identificare con la giustizia; la morale evangelica – morale della carità che
perdona e si sacrifica per gli altri – non è in contraddizione con la giustizia,
fulcro dell’esperienza morale sul piano naturale, ma vi si rapporta come
paradossale ma sublime perfezionamento sul piano soprannaturale18 .
Questa “categoria di base”, peraltro, può però essere sviluppata
coerentemente in varie direzioni; come ben ha messo in rilievo Hans Jonas, i
rapporti con gli altri generano nella coscienza categorie morali quali la
“responsablità” e prima ancora il “rispetto”: «Soltanto il rispetto, rivelandoci
qualcosa di sacro, cioè di inviolabile in qualsiasi circostanza (il che risulta
percepibile persino senza religione positiva), ci preserverà anche dal profanare
il presente in vista del futuro, dal volere comprare quest’ultimo a prezzo del
primo»19 . Ancora prima, queste riflessioni si trovano nell’opera di Martin Buber,
e questa tradizione di pensiero ebraico rifiorisce con Emmanuel Lévinas, il
quale ha scritto: «La prossimità del prossimo è la mia responsabilità per lui» 20 .
Peraltro, questa impostazione registra anche nel pensiero cristiano (Paul
Ricoeur, Joseph della Finance) notevoli assonanze, ciò che accomuna questi
pensatori è la qualifica di “sacro” che essi attribuiscono al rapporto morale con
gli altri; ora, questo carattere “sacro” che la coscienza morale percepisce nel
mondo è la strada che unisce la moralità alla religione.
“Gli altri” connotano anche la società civile, connotano quel sistema di
convenzioni e di leggi che costituiscono il “diritto”, emanazione della categoria
morale fondamentale, che è la giustizia. Ma il diritto non esprime mai
perfettamente la coscienza morale: sia perché le leggi hanno sempre carattere
Cfr Paul Ricouer, Amore e giustizia , trad.it., Ed. Morcelliana, Brescia 2000.
Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung [1981], trad. it.: Il principio responsabilità:
un’etica per la civiltà tecnologica, Ed. Einaudi, Torino 1990, p. 286.
20 Emmanuel Lévinas, Noms propres, Ed. Fata Morgana, Montpellier 1978, p. 118.
18
19
p. 20
Congresso Tomista Internazionale
“ipotetico”, sia anche perché nessuna legge, in quanto regolatrice della vita
pubblica, esaurisce l’esigenza di verità che la coscienza morale possiede e che si
esprime soprattutto nella libertà di iniziativa personale del soggetto. Come
papa Karol Wojtyla ha insegnato che «non si può semplicemente identificare
quanto stabilito e autorizzato dalla legge in un sistema democratico di governo
con i princìpi della morale, come se fossero praticamente equivalenti, perché è
noto che la libertà di espressione e di voto non bastano per sé stesse – per
quanto siano nobili e conformi a verità – per conseguire una libertà veramente
umana. Perciò la Chiesa, fedele alla sua missione, insegna che la libertà fiorisce
realmente quando affonda le sue radici nella verità sull’uomo. Questa stessa
verità sull’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, deve ispirare tutte le
azioni intraprese nella costruzione della società» (Giovanni Paolo II, discorso
del 10 gennaio 1997: L’Osservatore romano, 11 gennaio 1997, p. 2).
L’esperienza morale non è un fenomeno avulso dal contesto generale
della conoscenza intuitiva (immediata e mediata), che io chiamo appunto
“esperienza”: per “esperienza morale” non si intende altro che l’intuizione –
previa a ogni riflessione critica e a ogni dialettica o discorso propriamente
scientifico, sia filosofico che teologico – del dovere che il soggetto ha in relazione
con l’esercizio della sua libertà nella situazione (storica, sociale) nella quale si
trova. L’oggetto dell’esperienza morale è dunque il “valore” da vivere, il
“bonum faciendum”, la scelta giusta da fare, il bene da realizzare, il diritto altrui
da rispettare: insomma, non direttamente l’essere (il “fatto”) ma il “doveressere”, ossia un fatto non attuale ma possibile, che l’ordine delle cose (la “legge
naturale”) affida alla responsabilità di chi può e deve intervenire. Tutto questo è
racchiuso nel concetto di “obbligazione” o “norma” morale, che ha il suo
fondamento appunto nell’esperienza morale; essa rende possibile che il
soggetto percepisca l’obbligazione come qualcosa che lo riguarda, nel momento
in cui interviene quella che viene chiamata la “coscienza morale” (che non è
altro che l’intelletto in quanto coglie immediatamente, nella situazione data, la
verità dell’obbligazione in concreto).
Infatti, la “norma” o il “dovere” non possono assolutamente fondare di
per sé la morale: sono nozioni che implicano un “perché”, un rimando alle
ragioni per cui un soggetto libero dovrebbe scegliere di comportarsi in un certo
modo. Le ragioni del dovere – ossia la razionalità che fonda il dovere sull’ordine
morale naturale o finalismo della natura, nel quale è rispecchiata la sapienza del
Creatore e il bene autentico dell’uomo - sono la fondazione aletica della morale
e impediscono ogni ipotesi di formalismo etico come quello kantiano. Tommaso
d’Aquino ancorava la nozione di “norma” (“lex”) alla logica (“ordinatio rationis”)
definendo la norma come «quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui
curam communitatis habet promulgata» (Summa theologiae, II-II, q. 90, art. 4, c.), e
p. 21
A. LIVI, L’esperienza morale
riferendola al soggetto con un collegamento logico (“scientia”): «Nullus ligatur
per praeceptum aliquod, nisi mediante scientia illius praecepti» (Quaestiones disputatae
de veritate, q. 17, art. 3).
Come è risaputo, si parla di “logica deontica” quando si studiano i
discorsi riguardanti i comportamenti dal punto di vista del “dovere” (deon). La
logica deontica suole dividersi in due sezioni: la prima è detta “deontonomica”,
ossia risultante dall’unione del “deon” (= dovere) con il “nmos” ( = legge), e
riguarda i comportamenti considerati come obbligatori oppure come liberi, il che
dà luogo alla discussione sulla logica del “legale” (giuridico, religioso, politico);
la seconda (detta “adeontonomica”) riguarda i comportamenti presentati o
come leciti o come illeciti, il che dà luogo al discorso propriamente “etico”. Per
comprendere l’importanza di queste distinzioni basterà ricordare come la
morale cristiana si presenti – nelle esplicite affermazioni di Cristo stesso nei
vangeli, e poi nella riflessione teologica di Tommaso d’Aquino – non sotto
l’aspetto “legale”, tipo del giudaismo (che ha come categoria religiosa
fondamentale la Torah), ma sotto l’aspetto “spirituale” che ne fa una morale
della libertà, della spontaneità, della coscienza creatrice. Quando la logica
aletica – che è il presupposto della logica deontica e di quella pragmatica in
generale – si occupa della verità degli enunciati morali, queste distinzioni
hanno scarsa importanza, mentre ha molta importanza esaminare il
fondamento delle obbligazioni per la coscienza del soggetto, così come il
fondamento delle scelte operative per l’intelligenza pratica; in ambedue i casi –
“coscienza” morale e “intelligenza pratica” – si tratta di individuare la
razionalità della prassi nei motivi che il soggetto recepisce nella propria
intelligenza critica. Ed è appunto questo il problema che interessa la logica
aletica: quando un’obbligazione si riconosce come vera? È il problema che ogni
soggetto si pone quando riflette sul “da farsi” e delibera circa l’atteggiamento
da assumere nei confronti di una situazione data; esso può essere formulato con
la domanda: “che cosa debbo (veramente) fare?”. E tale domanda implica la
differenza sostanziale – che non vuol dire sempre né necessariamente
opposizione - tra norma esteriore (comando, prescrizione, legge) e “dovere”
avvertito dalla coscienza come tale (obbligazione morale). La differenza della
quale sto parlando comporta che una “norma” (o legge morale) diventa
concreta ed efficace obbligazione per la coscienza del soggetto solo dopo che
questi l’ha riconosciuta come assolutamente vera in sé stessa (in astratto) e
assolutamente vera per lui (in concreto), nel senso che l’ha riconosciuta non solo
come legittima (emanata dall’autorità competente) ma anche giusta (diretta al
bene comune) e infine pertinente (ossia riguardante in concreto la situazione che
il soggetto si trova a vivere). Detto in altri termini, ciò significa che la logica
delle norme e dei doveri (logica deontica), nell’àmbito più ampio della logica
pragmatica (la logica dell’efficacia dell’azione), dipende intrinsecamente dalla
logica aletica.
p. 22
Congresso Tomista Internazionale
Ma non basta sottolineare l’intrinseca dipendenza della logica
pragmatica da quella aletica; occorre notare che la connessione è anche nel
senso opposto, in quanto la logica aletica comporta sempre – in un modo o
nell’altro – degli sviluppi di tipo pragmatico. Il pensiero umano non è mai in
condizioni di “sostare” nella contemplazione della verità teoretica: il pensiero
umano è parte integrante e principale della vita, e la vita è azione, decisione,
scelta. La vita umana è caratterizzata dal dinamismo, dal movimento di
realizzazione della propria natura, in vista del raggiungimento della felicità
(eudamonismo), intesa sia come “bonum proprium” che come “bonum commune”
(quest’ultima è la dimensione caratteristica dell’etica aristotelica, finalizzata al
bene della polis), e poi sia come “bonum utile” che come “bonum honestum”. Ecco
allora che acquista senso la profonda intuizione di Gregorio Magno, che
afferma: «La conoscenza della verità precede sempre l’amore della verità»
(Homiliae super Evangelia, 14, 3: Migne, Patrologia Latina, vol. LXXVI, p. 1129);
parole alle quali fa seguito Tommaso d’Aquino quando afferma che «la verità è
il fine ultimo di tutto l’universo» (Liber de veritate catholicae fidei, I, cap. 1). Del
resto, il messaggio evangelico ribadisce proprio questo nesso tra verità e scelte
di vita quando si esprime in termini come “vivere secondo la verità nell’amore
[aletheuontes en agape]” (Lettera di Paolo agli Efesini, 4, 15), oppure “camminare
nella verità [peripatountas en aleteheia]” (II Lettera di Giovanni, 1, 4). In una
struttura metafisico-etica che ha come intrinseca e necessaria dinamica il
raggiungimento di fini intermedi in vista del fine ultimo, tale fine ultimo
acquista valore agli occhi dell’intelletto – cui spetta orientare la volontà e tutte
le energie vitali – se è conosciuto nella sua verità. La logica aletica si colloca
dunque al vertice di una struttura dinamica, nella quale di fatto prevale il
momento pragmatico, sia “deontico” che “tecnico”.
La prevalenza del momento pragmatico comporta il dramma
dell’insuperabile inadeguatezza della singola azione umana e dell’agire umano
in generale rispetto all’ideale di giustizia (rettitudine) percepito dalla coscienza
come norma o “dovere”. Qualche studioso di scuola fenomenologica è arrivato
a dire che «la morale è l’esperienza che io faccio della distanza tra la mia azione,
inseparabile dalla mia limitazione, e il mio ideale, che si propone di andare
verso l’infinito più perfetto che sia possibile concepire»21 . Il dramma della
coscienza morale è innegabile; da esso non può che derivare un’unica soluzione
giusta, che è quella della speranza religiosa in una “salvezza” e in una “santità”
trascendente, doni di Dio e non conquista dell’uomo. Questo è appunto uno dei
motivi per i quali, secondo Wojtyla, la coscienza morale trapassa nella coscienza
religiosa; notiamo però che la fenomenologia permette di rilevare anche altre
21
Michel Adam, La Moral à contretemps, Ed. L’Harmattan, Parigi 1998 p. 15.
p. 23
A. LIVI, L’esperienza morale
soluzioni, inadeguate e false, al problema della coscienza sofferente: una di
queste false soluzioni (che Adam chiama “faux-fuyants”, scappatoie) è il
“narcisismo” (che corrisponde al biblico “farisaismo”), ossia il tentativo di
persuadersi di essere già giunto alla perfezione morale, negando l’evidenza
della propria costitutiva inadeguatezza; l’altra è la volontaria cecità di fronte ai
valori morali (si pensi all’immoralismo di Nietzsche), riguardo alla quale Adam
scrive: «Prima di essere colpevole in rapporto al male, l’uomo può rendersi
colpevole per mancanza di disponibilità verso l’etica. Qui sta precisamente la
colpevolezza fondamentale» 22 .
È il momento adesso di stabilire una distinzione concettuale e allo stesso
tempo una connessione logica tra “esperienza morale” e “coscienza” (in senso
morale, non nel senso psicologico di “appercezione”). Mentre l’esperienza
morale è lo sfondo (background) sul quale si muovono le valutazioni dei singoli
atti compiuti o da compiersi, la coscienza è la concreta valutazione dell’atto alla
luce dei princìpi fondamentali della moralità (che la filosofia cristiana ha
denominato “sinderesi” sul versante soggettivo e “legge naturale” sul versante
oggettivo). La connessione tra l’evidenza di una necessaria moralità nella
condotta e l’evidenza di un concreto dovere nella situazione concreta è ricercata
e trovata dalla ragione, la quale necesita appunto di “ragioni” per avvertire una
personale obbligazione. Per effetto dell’esperienza morale, il soggetto umano si
sente vincolato all’ordine morale, che ha carattere universale: obbliga il singolo
come tutti gli altri uomini; obbliga in un caso come in tutti i casi; obbliga adesso
come ieri e come sempre; ora però, in rapporto alla situazione particolare, sia che
si tratti di azioni immanenti (prattein, agere, conversari) che nel caso di azioni
transeunti (poiein, facere), il soggetto si sente indotto (tenuto, obbligato) a un
certo comportamento solo quando sa con certezza che esso è richiesto da chi ha
veramente l’autorità di dirigerlo. La coscienza morale è appunto un giudizio
dell’intelletto che afferma con certezza la doverosità di un comportamento da
parte del soggetto in una situazione determinata; e, per affermare ciò con
certezza, l’intelletto deve sapere la verità circa l’autorità che lo ha formulato (che
sia cioè una “legge autentica”) e circa il precetto stesso (che sia cioè anche una
“legge giusta”). Si vede dunque che il discorso razionale sulla morale implica
una fondamentale dimensione di logica aletica. Non è la volontà che decide
della moralità dell’atto, ma la conoscenza: la scelta volontaria è sempre tra un
bene e un male percepiti come tali dall’intelletto della persona che vive quella
situazione nella quale è chiamato a decidere, alla luce di quell’esperienza
originaria che è l’evidenza della legge morale e l’evidenza del proprio fine
ultimo come espresso proprio dalla legge morale.
22
Adam, op.cit., 1998, p. 280.
p. 24
Congresso Tomista Internazionale
A questo proposito, in uno studio sulla filosofia morale di Tommaso
d’Aquino viene giustamente osservato che, «se la legge esprime l’ordine
dell’agire rispetto al fine, non può che essere espressione di un’intelligenza: è
aliquid rationis. Ovviamente qui il termine “ragione” è inteso in senso analogico:
vi è una legge che è espressione della ragione divina, la quale crea l’ordine e
costituisce la regola e la misura di tutto ciò che è; vi è poi una legge che è
l’espressione della ragione umana, che scopre l’ordine creato ed è regolata e
misurata dalla legge divina, conosciuta attraverso i suoi effetti. Con questi limiti
e con questa grandezza, la ragione umana costituisce la regola-regolata e la
misura-misurata dell’agire umano» 23 .
Ciò stabilito, nulla vieta di riconoscere che Kant aveva ragione nel
sottolineare la dimensione soggettiva (non necessariamente soggettivistica) del
valore morale, in quanto fondato sulla coscienza del soggetto; nessun altro
fondamento – meno che mai la casistica relativa agli “oggetti morali” - rispetta
le caratteristiche essenziali dell’esperienza morale. Come sostiene giustamente
un filosofo moralista italiano, la qualità morale delle azioni non dipende
principalmente da ciò che è rilevabile esteriormente, in quanto realizzazione
pratica, ossia il comportamento: dipende dalle ragioni che il soggetto assume
per scegliere una linea di condotta e per agire in tal senso, con tutta la sequela
di effetti sulla sensibilità che tali ragioni comportano. Ma, se questo è
pienamente compreso, appare evidente d’altra parte l’insufficienza della
dottrina kantiana della moralità come razionalità universalmente riconoscibile.
Occorre ribadire infatti che la norma morale obbliga in coscienza un soggetto
solo quando la sua razionalità è percepita da questo soggetto come verità, non in
astratto per chiunque ma per lui in concreto, in quelle determinate circostanze
della sua vita: in altri termini, la norma è condivisibile perché vera, non vera
perché condivisibile da parte di ogni soggetto. Dal punto di vista della logica
aletica, l’intersoggettività (il consenso) non è il fondamento ma la conseguenza
della razionalità della norma in rapporto al soggetto. In questo senso è stato
giustamente detto che «le ragioni per agire nelle quali mi riconosco sono
sempre un messaggio rivolto a tutti gli altri agenti razionali, cui intendo
suggerire che sento soggettivamente di dover fare una certa cosa,
attendendomi, però, che anche ogni altro possa riconoscere o almeno
comprendere che dovevo farla e perciò possano eventualmente approvare il
tipo di persona che sto cercando di essere. Ciò presuppone che io dia alla mia
azione il senso di un’azione di un agente razionale tra altri, che intende
esprimere la propria razionalità nella scelta compiuta. Ogni azione morale, per
il fatto di essere eseguita in un contesto di attese e di interpretazioni, implica da
parte mia una pretesa di intelligibilità e perciò di accettabilità o criticabilità per
Aldo Vendemiati, “Analogia della legge. Uno studio su san Tommaso d’Aquino”,
in Rivista di filosofia neo-scolastica, 1994, p. 490.
23
p. 25
A. LIVI, L’esperienza morale
altri agenti razionali, che presuppone che il mio senso del dovere non sia così
irrimediabilmente soggettivo da non poter essere compreso o riconosciuto come
vero (anche se solo in riferimento a me qui e ora) da un altro agente
razionale» 24 .
In realtà, Kant e i filosofi dell’etica da lui dipendenti rimangono fermi
alla “legge di Hume”, per la quale non c’è possibilità di stabilire una
connessione razionalmente evidente tra il piano dei fatti e il piano dei valori, tra
l’essere e il dover-essere, tra la cognitività e la normatività. Nel Novecento si
sono avute invece scuole filosofico-morali che hanno saputo ricostruire tale
connessione, e tra queste è significativa quella che si rifà al “principio
responsabilità” di Jonas, che restituisce all’ontologia la funzione fondativa
dell’etica filosofica, non solo nell’approccio metafisico al problema ma anche e
soprattutto nell’approccio esistenziale del soggetto all’oggetto morale o valore.
Ecco infatti che cosa scrive Jonas, indicando come paradigma del rapporto di
responsabilità il rapporto padre/figlio: «Il concetto di responsabilità implica
quello del dover essere, anzitutto come normatività dell’essere di qualcosa e poi
come normatività dell’agire di qualcuno in risposta a quella normatività
dell’essere»25 . Ma ancora più costruttivamente hanno ristabilito la connessione
tra cognitività e normatività quei filosofi cristiani contemporanei che hanno
saputo reinterpretare la riflessione di Tommaso d’Aquino sull’esperienza
morale; uno dei più recenti tra questi scrive giustamente: «Il riferimento alla
volontà di Dio e ai fini naturali delle cose insito nell’etica tomista ha spesso dato
origine, nei diversi periodi storici, a tendenze razionalistiche e volontariste
nell’interpretazione della legge naturale. Il pensiero positivista degli ultimi due
secoli, inoltre, imperniato sui princìpi della netta separazione tra fatti e valori e
dell’impossibilità logica di passare dai primi ai secondi, ha causato un generale
scetticismo verso qualunque forma di naturalismo etico. In quest’ottica vanno
letti sia il tentativo analitico della scuola neoclassica di delineare un’etica
oggettiva della legge naturale non basta sulla conoscenza della natura, sia la più
generale tendenza di diversi interpreti di Tommaso (anche oltre l’ambito
analitico) di fondare le norme e le esigenze morali senza fare ricorso a Dio. Dato
il risultato teonomo e naturalista della nostra ricerca sul pensiero etico di
Tommaso, ci siamo dunque sforzati […] di evidenziare l’ampiezza e la
profondità con cui egli pensa la conoscenza della volontà di Dio da parte degli
esseri umani. E abbiamo argomentato poi che se è vero che l’ordine della natura
assume per lui un rilievo etico in virtù della volontà di Dio, è anche vero che il
riferimento alla volontà di Dio sfugge alla fallacia naturalistica in quanto
dipende da una particolare interpretazione dell’esperienza morale, cioè della
Roberto Mordacci, “Agire per ragioni morali: razionalità e motivazioni nelle analisi
della scelta morale”, in Rivista di filosofia neo-scolastica, 1999, pp. 623-624.
25 Hans Jonas, op. cit., p. 162.
24
p. 26
Congresso Tomista Internazionale
conoscenza originaria del bene e da cui dipende l’agire umano: qui il problema
non è la legge di Hume ma la validità di quella interpretazione» 26 .
Una delle condizioni a priori della pensabilità di un dovere che obblighi
“in coscienza” è rappresentata dalla seconda certezza del senso comune (con il
suo prolungamento nella terza), ossia la consapevolezza di essere – nel mondo
in cui si vive – un io libero e responsabile, un essere che, pur tra mille
condizionamenti, può e deve dare autonomamente una direzione alla sua vita
in base ai propri valori esistenziali e alla logica del proprio divenire (dalla
nascita alla maturità dell’esperienza, con l’educazione e la socializzazione, con
le alterne vicende della crescita, della perdita di capacità, di certezza della
prossima morte). In effetti, questo punto di partenza che è la coscienza dell’io
non solo fonda il rapporto con i propri simili e il carattere etico di tale rapporto,
ma fonda anche il rapporto con Dio, visto come fonte dell’ordine morale, di
modo che religione e morale non sono assolutamente scindibili in due àmbiti
aletici diversi.
La soggettività personale è il cuore dell’esperienza morale. Essa non vede
il valore morale degli atti (non li percepisce come “buoni” o “cattivi”, come
doverosi o come colpa o peccato) se non in rapporto con l’individualità,
l’unicità e la libertà dell’io, ossia in rapporto con il soggetto degli atti, che è
l’essere personale. Certamente, l’essere personale non esclude, anzi esige
costitutivamente la dimensione sociale, l’appartenenza alla comunità; ma qui è
importante sottolineare che la moralità degli atti non è percepita dalla coscienza
del soggetto perché determinata dell’evoluzione del costume (dimensione
storica, oggetto dell’antropologia culturale) o perché richiesta da certe
situazioni sociali (genere e classe di appartenenza, ruolo nella società,
gratificazioni o disagio). Se così fosse, la moralità dell’agire umano non sarebbe
più il connotato specifico della persona ma il semplice risultato di varie forze
esteriori che si incontrano e si scontrano; e invece la coscienza morale consiste
proprio nel percepire che l’essere persona e la moralità originaria di ogni singolo atto
umano formano un’unità inseparabile: io avverto che è morale (buono o cattivo)
solo ciò che io consapevolmente e deliberatamente decido di fare, come anche
ciò che ho fatto con piena consapevolezza e libera scelta. Importano più o meno,
ma sempre relativamente, gli effetti esteriori delle azioni di un soggetto (anche
quegli effetti che costituiscono il bene comune della società), mentre importano
assolutamente gli effetti immanenti delle azioni, ossia il miglioramento o il
deterioramento morale del soggetto, il suo diventare migliore o peggiore come
persona, il suo essere o non essere orientato all’ultimo fine.
Alberto Di Blasi, Dio e la legge naturale. Una rilettura di Tommaso d’Aquino, Edizioni
Ets, Pisa 1999, p. 240.
26
p. 27
A. LIVI, L’esperienza morale
Un tomista spagnolo, rilevando le categorie logiche fondamentali
dell’etica in Tommaso, precisa: «Il dovere non è una categoria fondamentale
negli scritti del Dottore Angelico, ma è soltanto una mediazione cognitiva che si
basa sull’ontologia stessa della persona umana e sulla sua libertà nel dialogo
morale con il Dio, che si esprime nella vita etica. La verità riguardo al dovere ha
il suo fondamento nella verità riguardo al bene, e non viceversa. A sua volta, la
verità riguardo al bene ha il suo fondamento nella verità riguardo all’essere
della persona e alla sua radicale inclinazione a realizzarsi in una felicità che
trascende le categorie meramente filosofiche. Questa verità non è accessibile
solo all’intuizione: essa è accessibile anche al ragionamento etico, a condizione
che esso parta dalla comprensione adeguata della dignità della persona in sé
stessa, comprensione che costituisce un momento iniziale puro e semplice con il
quale la persona comprende sé stessa come un “qualcuno” e non come un
“qualcosa”, comprendendo il fondamento della propria dignità e della portata
etica del proprio comportamento. L’argomentazione deontica acquista pienezza
di significato quando radica su questa esperienza personale originaria»27
I caratteri di questa esperienza personale originaria (l’esperienza morale,
l’abbiamo chiamata) sono stati messi in luce da Karol Wojtyla nell’analisi della
coscienza, nell’intreccio di conoscenza e volontà e nei termini di “autopossesso”
(corrispondente a “autocoscienza”) e “autodominio” (corrispondente a “libertà
del volere”); scriveva il filosofo polacco: «L’autodeterminazione, che è la base
dinamica propria di quel fieri della persona, presuppone nella stessa persona
quasi una particolare complessità. Persona è cioè chi possiede se stesso, e, nel
contempo, chi è posseduto solo ed esclusivamente da sé. Infatti, si può decidere
solo di ciò che realmente si possiede. Ma può decidere soltanto chi possiede.
L’uomo decide di sé con la volontà, poiché possiede sé stesso»28 .
Le categorie fondamentali della coscienza sono dunque la libertà e la
responsabilità, nel senso che la responsabilità personale è avvertita dalla
coscienza come fondata sulla libertà personale, cosicché ogni atto della
coscienza morale è un atto di un io sostanzialmente libero: libero nel cercare il
vero bene, libero nell’aderire all’evidenza del dovere, libero nel rispondere alle
sollecitazioni del “senso morale”, libero nel dare compimento all’azione
esteriore quando è richiesta dalla norma. Si deve dunque parlare sempre di
“libertà della coscienza” (cosa ben diversa dalla “libertà di coscienza”, che
riguarda il punto di vista dell’autorità esteriore, politica, quando ritiene di non
vincolare i sudditi in qualche materia).
Francisco Cristóbal Fernández Sánchez, “Analogía y argumentación deóontica en
Sto. Tomás”, Annales theologici, 12, 1998, p. 408.
28 Wojtyla, Persona e atto, cit., p. 26.
27
p. 28
Congresso Tomista Internazionale
La libertà della coscienza non va però intesa al modo kantiano, ossia
come “autonomia”; l’autonomia kantiana, in quanto contrapposta a
“eteronomia”, implica la massima astrattezza nella formulazione dell’etica, e
anche la più sostanziale insignificanza: astrattezza per quanto ignora i dati
concreti dell’esperienza morale che dianzi ho ricordato, e insignificanza in
quanto l’aggettivo “autonomo” (autos + nomos), applicato alla coscienza morale,
equivale a dire che la coscienza “è legge a sé stessa”, il che è contraddittorio (la
nozione di legge, per definizione, implica l’obbligazione di obbedire a un
comando formulato da un’autorità, dunque presuppone qualcuno che non sia il
soggetto stesso). L’autonomia si dà nella coscienza, ma solo nel senso di una sua
funzione autonoma riguardo al discernimento del dovere e alla decisione di
eseguirlo: non si dà nell’oggettività del dovere stesso, ossia nella verità della
legge da osservare. Riguardo a questa verità, la caratteristica della coscienza
morale è che inclina il soggetto all’obbedienza. Obbedienza e libertà sono dunque
correlati, e non vanno messi in contrapposizione l’una all’altra.
Come osservava molto acutamente Romano Guardini, non c’è differenza
tra il riconoscimento della verità morale e quello della verità in generale: in
entrambi i casi si tratta di obbedienza dell’intelletto alla verità delle cose, e in
questa obbedienza il soggetto non si sente affatto limitato o coartato, bensì vive
con pienezza la sua libertà, il perseguimento del suo bene autentico: «Le cose –
prendendo questa parola nella sua accezione più ampia: le cose della natura e
gli avvenimenti, l’essere umano e la sua vita, lo Stato e la storia – hanno
un’identità nella loro essenza, perché la loro essenza è quella che è e non una
diversa. Questa identità dell’essenza può essere conosciuta, ossia tramutata in
verità. Ora, l’essere umano non può procedere arbitrariamente in questa
conoscenza: egli si trova in una situazione di obbedienza rispetto all’identità
delle essenze. Conoscere, quindi, è obbedire. Se io dico che le cose stanno in un
certo modo, non lo dico arbitrariamente, né perché quello che dico gratifichi la
mia sensibilità o perché assecondi i miei interessi, ma solo perché le cose stanno
così. La volontà di conoscere è dunque volontà di trascendere la soggettività.
[…] D’altra parte, il riconoscimento della verità presuppone la libertà. La libertà
non è arbitrarietà: è una realtà che nasce dal fatto che la ragione è interpellata
dal contenuto di verità dell’esperienza e mossa dal senso del dovere: ma non è
in alcun modo forzata da questo contenuto oggettivo di verità, perché la libertà
deve dischiudersi all’obbligazione con spontanea disponibilità»29 .
Anche dal punto di vista oggettivo – ossia, nell’oggetto stesso della
coscienza morale -, la norma non obbliga se non perché corrisponde al vero
Romano Guardini, Ethik. Vorlesungen an der Universitat Munchen, a cura di H.
Mercker e di M. Marschall, vol. I, Grunewald & Sconing Verlag, Mainz-Paderborn
1993, pp. 123-124).
2929
p. 29
A. LIVI, L’esperienza morale
bene del soggetto, il quale, osservandola, realizza la sua natura e giunge al suo
fine, attuando la sua autentica libertà. È una verità ricordata anche da Giovanni
Paolo II nel suo pellegrinaggio sul monte Sinai, quando parlò della legge
naturale, storicamente codificata nei dieci Comandamenti della legge mosaica:
«Osservare i Comandamenti significa essere fedeli a Dio, ma significa anche
essere fedeli a noi stessi, alla nostra autentica natura e alle nostre più profonde
aspirazioni. Il vento che ancora oggi soffia dal Sinai ci ricorda che Dio desidera
essere onorato nelle sue creature e nella loro crescita: Gloria Dei, homo vivens.
[…] I dieci Comandamenti sono la legge della libertà: non la libertà di seguire le
nostre cieche passioni, ma la libertà di amare, di scegliere ciò che è bene in ogni
situazione, anche quando farlo è un peso» (Omelia nella Messa sul monte Sinai, 26
febbraio 2000, § 3-4). Anni prima Giovanni Paolo II aveva sintetizzato questa
logica con parole dall’evidente eco biblica: «Solamente la libertà che si
sottomette alla Verità conduce la persona umana al suo vero bene. Il bene della
persona è di essere nella Verità e di fare la Verità» (Discorso al convegno di teologia
morale, 20 giugno 1989). Ancora prima, Gabriel Marcel aveva descritto in
maniera suggestiva la coscienza che ogni uomo ha di potersi realizzare
compiutamente solo nella comunione con gli altri, nell’esercizio della sua libertà
intesa come «fedeltà creatrice e fraterna»: ragione per cui il doveroso rispetto
degli altri e l’osservanza dei diritti altrui non sono vissuti come una penosa
limitazione della propria libertà (“l’inferno”, diceva Jean-Paul Sartre) ma come
un guadagno positivo. Il futuro papa Giovanni Paolo II, a sua volta, aveva
messo in luce la correlazione logica tra libertà dell’uomo e dipendenza della
coscienza dai valori riconosciuti come tali, ossia dalla verità: «L’indipendenza
[…] nel campo intenzionale si spiega con quell’intrinseco riferimento alla verità,
essenziale alla volontà, e con dipendenza dalla stessa. Proprio questa
dipendenza rende la volontà indipendente dagli oggetti e dalla loro
presentazione» 30 .
Un discorso del genere, però, è convincente solo se sorretto dalla logica
aletica, ossia se al centro di tutto sta la nozione di verità: il soggetto, infatti, vive
l’obbligazione morale come libertà, e la attua con spontaneità, solo se la avverte
come valore, solo se la giudica assolutamente giusta, solo se la ha sperimentato
come massimamente confacente alla sua natura, come vero bene per lui e per gli
altri. E proprio per questo Giovanni Paolo II aggiunge alle parole che prima
citavo questa espressione efficace: «Rivelando se stesso sul Monte e
consegnando la sua Legge, Dio ha rivelato l’uomo all’uomo. Il Sinai sta al centro
della verità sull’uomo e sul suo destino» (ibidem).
La seconda dimensione riguarda invece il giudizio della coscienza. Il
giudizio morale vero e proprio ha come oggetto, non la teoria in rapporto
30
Wojtyla, op. cit., p. 337.
p. 30
Congresso Tomista Internazionale
all’ipotesi (fattispecie) ma la realtà effettiva, l’azione concreta, i fatti. La
coscienza si interessa direttamente di ciò che il soggetto ha veramente fatto
(“coscienza susseguente”) o sta veramente facendo (“coscienza concomitante”),
come pure di ciò che egli deve veramente fare (“coscienza previa”), sempre
nella concretezza delle circostanze (interiori ed esteriori) e delle volizioni
(intenzioni) che il soggetto si trova a vivere in quella determinata situazione. In
altri termini, il soggetto, nel fare uso la sua coscienza, prima della decisione sul
da farsi si domanda: “io, adesso, che cosa mi trovo a dover fare? ossia, come
posso usare proficuamente della mia libertà? quale responsabilità ho nei
confronti di chi è coinvolto nella mia scelta? quale mia scelta sarà quella giusta
agli occhi di Dio che mi ha affidato anche la vita altrui?”; così come, dopo aver
fatto qualcosa deliberatamente, si domanda: “quello che ho fatto è ben fatto?
come mi avrà giudicato Dio per quello che ho fatto? Ho voluto fare quello che
Dio voleva che facessi?”. In tutti i casi, sia prima che dopo l’azione,
l’intelligenza umana è guidata da un presupposto fondamentale: che bonum est
faciendum, male vitandum. Tale presupposto costituisce, secondo Tommaso, il
“principio primo della ragione pratica”. Sulla base di tale principio, l’esperienza
morale avverte la necessità di vivere moralmente, ossia operare sempre delle
scelte responsabili, riconoscendo i valori in gioco in ogni situazione concreta: il
che equivale a inquadrare ogni situazione in quell’ordine morale dal quale il
soggetto non può mai prescindere perché esso costituisce la sua stessa “natura”
e si identifica con la sua “ragione”.
Riepilogando: il giudizio di coscienza assume, come elementi di
valutazione, sia i princìpi morali generali (la legge) con le relative norme specifiche
(la “fattispecie”), sia la situazione (i fatti riguardanti la responsabilità del
soggetto): è infatti nella situazione che il soggetto è chiamato a “vedere” il
valore da attuare, rapportando la sua personale responsabilità all’ordine morale
e individuando così il modo di applicare alla sua situazione vitale i princìpi e le
norme. Ora, però, bisogna avvertire che il rapporto da stabilire tra i due poli
della considerazione – da una parte i princìpi e le norme, dall’altra la situazione
concreta - non è un rapporto logico che possa intendersi come esclusivamente
deduttivo o come esclusivamente induttivo. Non è deduttivo, perché tra norma e
fatto concreto c’è solo analogia, non identità, e pertanto non può stabilirsi un
“termine medio” unico che colleghi correttamente la premessa maggiore con la
premessa minore; e non è nemmeno induttivo, perché compito della coscienza
non è di elaborare nuove norme (per di più, norme strettamente private,
riservate al soggetto!) ma di formulare un giudizio che vale solo per quel
momento e per quel fatto, e che obbliga soltanto la sua coscienza morale.
L’effettiva categoricità di una norma morale va intesa nel senso della cogenza
derivante dalle circostanze dell’azione così come sono percepite dall’agente: è la
considerazione della situazione a generare nell’agente la risposta – che sarà una
p. 31
A. LIVI, L’esperienza morale
risposta adeguata se l’agente è “virtuoso” – e non il pensiero astratto
dell’esistenza di un comando morale che si può mettere in relazione con detta
situazione. Occorre dunque evitare, sia il formalismo che intende la coscienza
come “pensiero astratto dell’esistenza di un comando morale”, sia la concezione
della coscienza come assolutamente “creativa”. Commentando l’enciclica
Veritatis splendor di Giovanni Paolo II, dove questi temi sono autorevolmente
chiariti, una studiosa argentina ha giustamente osservato che questo
documento «propone una coscienza nella verità, ossia una coscienza che sappia
conciliare, in un medesimo atto, la risonanza personale che l’ordine morale ha
nell’intimità del soggetto con la verità sul bene e sul male morale fondata sulla
percezione originaria della legge naturale; e tale conciliazione si dà quando
l’atto di coscienza determina la responsabilità del soggetto. La coscienza nella
verità media tra l’interpretazione formale e l’interpretazione creativa, in quanto
orienta il soggetto all’impegno responsabile nell’esercizio della sua libertà»31 .
In conclusione, da quanto detto finora si capisce perché ho voluto
sottolineare come la coscienza morale (che è assolutamente personale e
riguarda i casi singoli) non si identifichi con l’esperienza morale (che è comune
a tutti gli uomini e genera i “princìpi” della moralità); e nemmeno è legittimo
assimilare la coscienza morale alla “scienza morale” o “etica”. La coscienza
opera sul concreto, e il giudizio della coscienza può considerarsi in sé stesso
compiuto anche prima o al margine o al di fuori della conoscenza scientifica dei
princìpi e delle norme; è proprio il carattere pre-scientifico ed extra-scientifico –
ma pur sempre razionale - dell’esperienza morale e della coscienza morale ciò
che va riconosciuto e rispettato dalla riflessione sistematica dell’etica, evitando
sia l’astrattezza del pensiero razionalistico (che per garantire la razionalità
dell’etica ne pretende l’autofondazione) sia l’irrazionalismo vitalistico (che si
esalta interpretando come contrario alla ragione ciò che invece è soltanto previo
alla ragione scientifica).
Maria Celestina Donadío Maggi de Gandolfi, “La necesidad de revalorizar la razón
humana”, in Cuadernos de la Sociedad Tomista, 24, 1999, p. 123.
31
p. 32