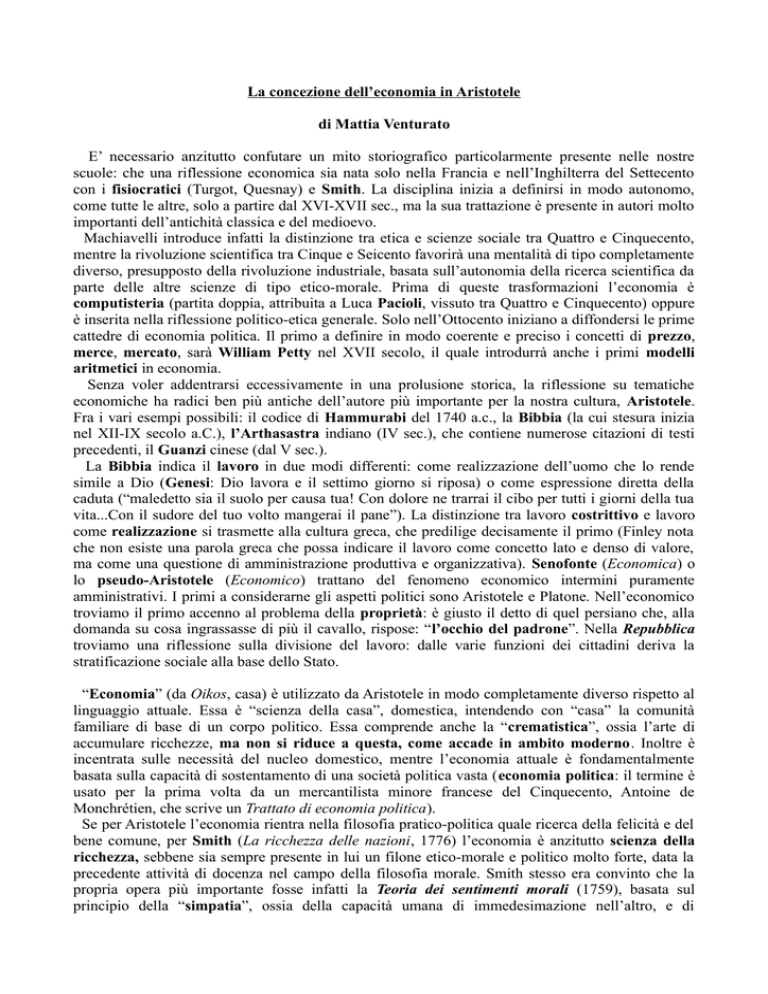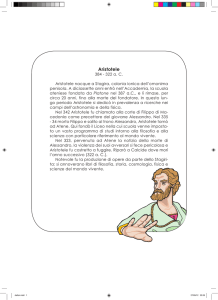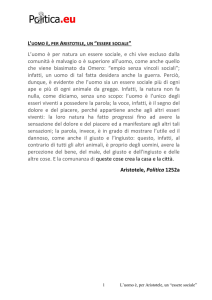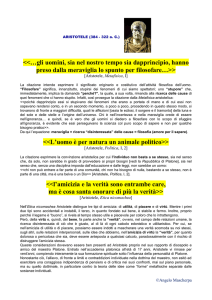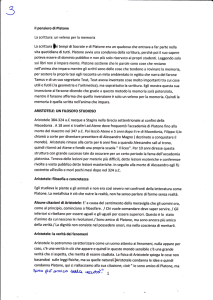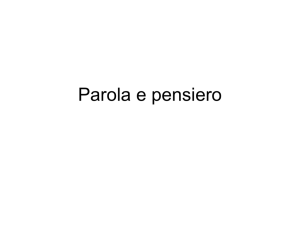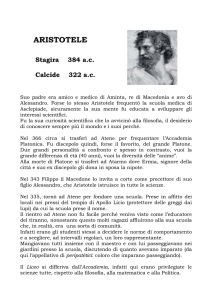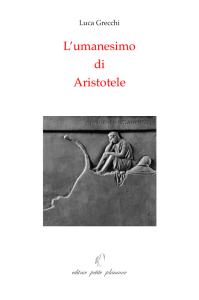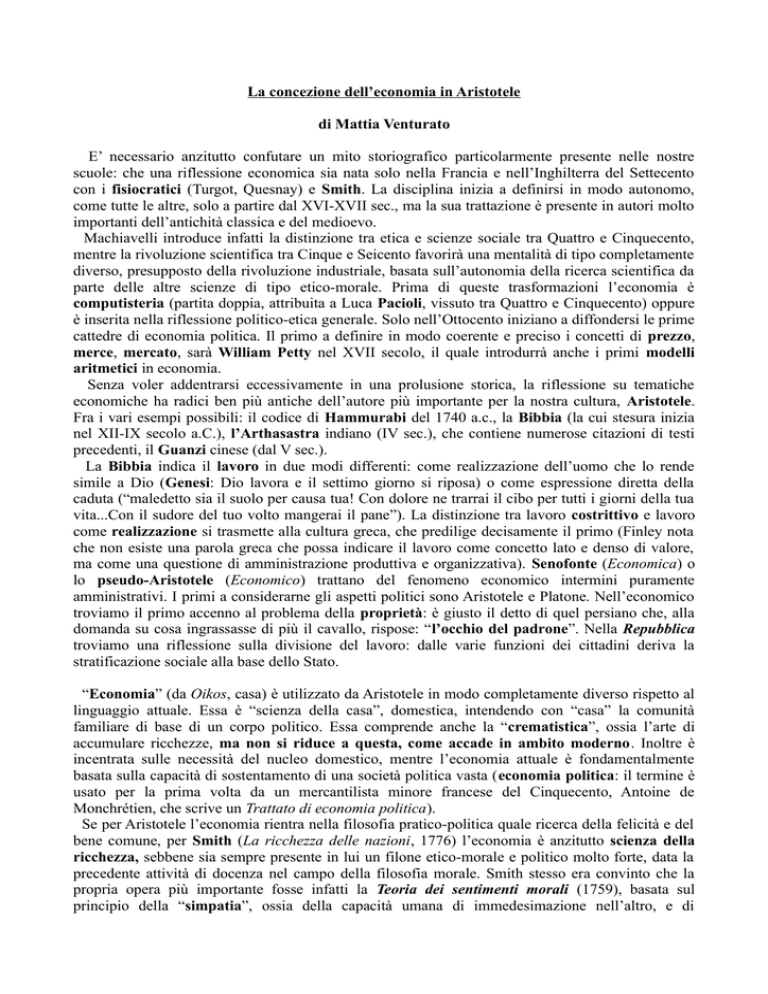
La concezione dell’economia in Aristotele
di Mattia Venturato
E’ necessario anzitutto confutare un mito storiografico particolarmente presente nelle nostre
scuole: che una riflessione economica sia nata solo nella Francia e nell’Inghilterra del Settecento
con i fisiocratici (Turgot, Quesnay) e Smith. La disciplina inizia a definirsi in modo autonomo,
come tutte le altre, solo a partire dal XVI-XVII sec., ma la sua trattazione è presente in autori molto
importanti dell’antichità classica e del medioevo.
Machiavelli introduce infatti la distinzione tra etica e scienze sociale tra Quattro e Cinquecento,
mentre la rivoluzione scientifica tra Cinque e Seicento favorirà una mentalità di tipo completamente
diverso, presupposto della rivoluzione industriale, basata sull’autonomia della ricerca scientifica da
parte delle altre scienze di tipo etico-morale. Prima di queste trasformazioni l’economia è
computisteria (partita doppia, attribuita a Luca Pacioli, vissuto tra Quattro e Cinquecento) oppure
è inserita nella riflessione politico-etica generale. Solo nell’Ottocento iniziano a diffondersi le prime
cattedre di economia politica. Il primo a definire in modo coerente e preciso i concetti di prezzo,
merce, mercato, sarà William Petty nel XVII secolo, il quale introdurrà anche i primi modelli
aritmetici in economia.
Senza voler addentrarsi eccessivamente in una prolusione storica, la riflessione su tematiche
economiche ha radici ben più antiche dell’autore più importante per la nostra cultura, Aristotele.
Fra i vari esempi possibili: il codice di Hammurabi del 1740 a.c., la Bibbia (la cui stesura inizia
nel XII-IX secolo a.C.), l’Arthasastra indiano (IV sec.), che contiene numerose citazioni di testi
precedenti, il Guanzi cinese (dal V sec.).
La Bibbia indica il lavoro in due modi differenti: come realizzazione dell’uomo che lo rende
simile a Dio (Genesi: Dio lavora e il settimo giorno si riposa) o come espressione diretta della
caduta (“maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua
vita...Con il sudore del tuo volto mangerai il pane”). La distinzione tra lavoro costrittivo e lavoro
come realizzazione si trasmette alla cultura greca, che predilige decisamente il primo (Finley nota
che non esiste una parola greca che possa indicare il lavoro come concetto lato e denso di valore,
ma come una questione di amministrazione produttiva e organizzativa). Senofonte (Economica) o
lo pseudo-Aristotele (Economico) trattano del fenomeno economico intermini puramente
amministrativi. I primi a considerarne gli aspetti politici sono Aristotele e Platone. Nell’economico
troviamo il primo accenno al problema della proprietà: è giusto il detto di quel persiano che, alla
domanda su cosa ingrassasse di più il cavallo, rispose: “l’occhio del padrone”. Nella Repubblica
troviamo una riflessione sulla divisione del lavoro: dalle varie funzioni dei cittadini deriva la
stratificazione sociale alla base dello Stato.
“Economia” (da Oikos, casa) è utilizzato da Aristotele in modo completamente diverso rispetto al
linguaggio attuale. Essa è “scienza della casa”, domestica, intendendo con “casa” la comunità
familiare di base di un corpo politico. Essa comprende anche la “crematistica”, ossia l’arte di
accumulare ricchezze, ma non si riduce a questa, come accade in ambito moderno. Inoltre è
incentrata sulle necessità del nucleo domestico, mentre l’economia attuale è fondamentalmente
basata sulla capacità di sostentamento di una società politica vasta (economia politica: il termine è
usato per la prima volta da un mercantilista minore francese del Cinquecento, Antoine de
Monchrétien, che scrive un Trattato di economia politica).
Se per Aristotele l’economia rientra nella filosofia pratico-politica quale ricerca della felicità e del
bene comune, per Smith (La ricchezza delle nazioni, 1776) l’economia è anzitutto scienza della
ricchezza, sebbene sia sempre presente in lui un filone etico-morale e politico molto forte, data la
precedente attività di docenza nel campo della filosofia morale. Smith stesso era convinto che la
propria opera più importante fosse infatti la Teoria dei sentimenti morali (1759), basata sul
principio della “simpatia”, ossia della capacità umana di immedesimazione nell’altro, e di
“interesse personale”, distinto dall’egoismo individualista perchè sempre in armonia con quello
degli altri. Inoltre egli assegna un ruolo fondamentale allo Stato: garantire la protezione dalla
violenza e dal sopruso, la certezza del diritto, il sostentamento di pubbliche opere e istituzioni di cui
non si può fare carico il privato e che rappresentano un investimento per la società intera ( ). Lo
stesso famigerato concetto di “mano invisibile” è presente in una sola occorrenza nel libro, e non
ne costituisce certo un concetto centrale. L’aumento dei prezzi poi è sempre dovuto ad un aumento
dei profitti e delle rendite: mai si configura una “responsabilità” dei salari nella definizione di un
prezzo finale eccessivo. Semmai la differenza tra Smith e la tradizione di tipo aristotelico sta nei
contesti, che sono completamente diversi: Smith sta vivendo il pieno sviluppo della rivoluzione
industriale in Inghilterra: divisione del lavoro e ampliamento dei mercati (trasporti; impero
inglese) sono strettamente connessi e configurati in un modo totalmente “nuovo” rispetto
all’antichità e al medioevo (tesi di Cipolla su rivoluzione industriale come unica vera
periodizzazione storica). La lettura puramente liberista di Smith è quindi filologicamente
discutibile, e deriva dalla lettura conservatrice da parte dei biografi successivi: un pensiero
decisamente avverso alla concentrazione dei poteri, progressista e vicino alle necessità degli umili
viene trasformato in un’analisi che toglie agli imprenditori qualunque interesse nei confronti dei
costi sociali dell’economia. Inoltre Smith sottolinea quelli che possono essere gli aspetti negativi
della divisione del lavoro. Dopo aver ribadito, di fronte alle critiche, che non esistono distinzioni
naturali nell’intelligenza umana, ma che queste sono sempre riconducibili alle professioni svolte,
Smith afferma che la riduzione dell’attività lavorativa a poche semplici operazioni imbarbarisce
l’operaio, la cui intelligenza, in assenza di altri stimoli, non gli permetterà mai di interessarsi ai
grandi problemi del Paese e di maturare sentimenti positivi; ponendo le basi della successiva critica
di Marx sull’alienazione. La soluzione sta nel ricorso all’istruzione elementare.
La comunità domestica non si riferisce solo alla famiglia vera e propria, ma anche a quella
allargata. Aristotele parla di associazione marito-moglie, padrone-servo e padre-figli per
descrivere il nucleo familiare.
Il primo basilare problema che si pone Aristotele è dunque quello della schiavitù. Egli è il primo
pensatore a riflettere sul problema, poiché si rende conto (come farà poi Marx) che la schiavitù ha
una necessità storica, e dunque deve essere in qualche modo giustificata, ma che allo stesso tempo
essa è in radicale contrapposizione con la concezione dell’uomo quale animale politico capace di
governarsi autonomamente, desideroso di sapere e realizzarsi tramite la contemplazione e la
ricerca della felicità .
Egli trova quindi una soluzione di mezzo tra chi, come Platone, assimila il rapporto padrone-servi
a quello governanti-governati, e chi, come i sofisti, dichiara essere la schiavitù una convenzione che
non ha alcun fondamento naturale, affermando che il capo-famiglia deve provvedere alle necessità
della casa attraverso due tipologie di strumenti: quelli inanimati e quelli animati; i secondi sono
necessari per far funzionare i primi. Conseguentemente, dice Aristotele: “se le spole tessessero da
sé, i padroni non avrebbero bisogno di schiavi” (Pol, 1,4, 1253b-1254a).
Gli schiavi sono proprietà del padrone perché funzionali non a se stessi, ma all’oggetto che
producono. Essi sono “strumenti di azione” e non di semplice produzione (come la spola): per
essere usati devono quindi esser posseduti in senso proprio. La scienza del padrone consiste nel
loro utilizzo.
Dunque, quale sia la natura dello schiavo e quali le sua capacità, è chiaro da queste
considerazioni: un essere che per natura non appartiene a se stesso ma a un altro, pur essendo
uomo, questo è per natura schiavo: e appartiene a un altro ciò che, pur essendo uomo, è oggetto di
proprietà: e oggetto di proprietà è uno strumento ordinato all’azione e separato (I, 4, 1254a)
Aristotele conclude la sua trattazione sulla la schiavitù in un modo fondamentalmente incoerente,
sebbene le sue argomentazioni siano molto importante per comprendere le questioni basilare nei
rapporti economici. La schiavitù sarebbe naturale in quanto, mentre il padrone rappresenta l’anima,
ossia la capacità di dirigere e comandare secondo ragione, lo schiavo rappresenta il corpo, ossia
la partecipazione puramente passiva alla ragione e l’espressione della forza animale. Infatti gli
altri animali non sono soggetti alla ragione, ma alle impressioni (I,5, 1254b). Secondo Berti (1979)
ciò è in palese contraddizione con l’antropologia e la logica aristoteliche. Per Aristotele l’anima, o
ragione, è la differenza specifica che distingue l’uomo come specie dal resto del genere animale. Di
conseguenza, assumerlo come criterio di separazione tra individuo e individuo è contraddittorio,
poiché esso è casomai criterio di unione.
Marx direbbe che ci troviamo di fronte ad una atteggiamento ideologico, cioè mirante alla
giustificazione di un fatto non coerente con la teoria.
Numerose possono quindi essere le eccezioni alla teoria: altri autori notano giustamente che molti
sono schiavi per legge, a causa della guerra, mentre dovrebbero essere liberi; e viceversa sono
liberi per legge coloro che per natura dovrebbero essere schiavi perchè non sanno controllare le loro
passioni (distinzione tra diritto naturale e positivo). Ciò dimostra che è necessario ritenere valida
una suddivisione naturale tra liberi e servi, al di là delle deformazioni introdotte dalle legge, che può
essere considerata giusta o sbagliata, e dalla guerra, che può essere anche ingiusta. Alcuni pensatori
ritengono assolutamente illegale la schiavitù di guerra, altri solo nel caso di guerra ingiusta.
Resta fermo che i greci sono liberi, mentre i barbari sono naturalmente schiavi e vivono in regimi
dispotici e assolutistici. L’autorità del padrone si esercita infatti su schiavi e diseguali, mentre
quella del governante su liberi ed eguali. La schiavitù non si risolve sempre in un rapporto ostile.
Vi può essere amicizia nel caso di convenienza reciproca, odio in quello di subordinazione tramite
la violenza (come nel caso della guerra).
Non libero è anche l’operaio, sebbene possa essere ricco, poichè le necessità produttive che
caratterizzano la sua esistenza, pur non essendo legate ad un individuo preciso ma all’intera
comunità nella quale vive, lo allontanano dalla sua realizzazione politica di cittadino.
Molto interessante è il discorso aristotelico riguardante la crematistica, ossia il modo col quale si
acquistano i beni materiali. Aristotele si chiede infatti se essa faccia parte dell’economia. Vi è infatti
una forma naturale di crematistica, quella atta a procurarsi il necessario per la buona
amministrazione della casa (economia) e della città (politica): per essa il bene materiale è solo
strumento per la realizzazione morale e politica dell’uomo; ve ne è una innaturale in cui la
moltiplicazione dei beni materiali è supposta poter essere tendenzialmente illimitata, mentre nella
realtà non lo è (Marx: crisi da sovrapproduzione per produzione allargata).
Per spiegarsi Aristotele fa l’esempio della scarpa. Essa può essere usata come calzatura o come
mezzo di scambio. La crematistica naturale serve ad entrambe le cose, ma la seconda si suddivide
in una modalità propria ed una impropria. Nella prima le famiglie si scambiano i beni per il
proprio sostentamento, secondo quelle che sono le finalità proprie della loro esistenza; nella
seconda lo scambio ha l’obiettivo di accumulare una quantità tendenzialmente illimitata di
ricchezze, cosa impossibile per natura, poiché nessun’arte ha strumenti illimitati: a tutto vi è un
limite. La crematistica innaturale è spesso confusa con quella naturale, ma è in realtà una cosa
completamente diversa (I, 8-9, 1256b-1257a), dato che consiste piuttosto in una tecnica o abilità
derivata dalla “economia” grazie all’invenzione del denaro, il cui scopo è quello di rendere più
facile il commercio al minuto. Questo si trasforma in un sistema nella quale il denaro non è più uno
strumento per scambiare le merci, ma ciò che deve essere incrementato attraverso lo scambio delle
merci. Il denaro, da pura convenzione per facilitare lo scambio, si trasforma in idolo che può
perdere improvvisamente tutto il suo valore, come nel caso del mito di re Mida. La crematistica,
come tutte le arti, non ha teoricamente limiti nel tentare di raggiungere il proprio fine, ossia la
ricchezza infinita; allo stesso modo in cui la medicina cerca la salute. Le due crematistiche si
confondono a causa dell’utilizzo degli stessi beni (frutti della terra e animali), sebbene i fini siano
completamente diversi: una bada all’accrescimento ed è ottenuta a spese degli altri, l’altra alla
buona amministrazione (necessariamente con limiti). L’ingordigia di ricchezza snatura tutte le arti,
come nel caso del medico che mira all’opulenza e al potere invece che alla salute dei pazienti.
Aristotele conclude affermando che chi ritiene essere la crematistica innaturale il modo giusto di
amministrare la casa, scambia il vivere con il vivere bene, ossia trasforma degli strumenti, i beni, in
un fine, la felicità (Pol. I, 9-10, 1257b-1258°; p. 20-21). Infatti per l’amministrazione domestica
(economia) la preoccupazione fondamentale è per le persone e non per i beni inanimati (Pol. I, 13,
1259b-1260a; p.25-26).
Aristotele intuisce quindi che l’economia di mercato rappresenta il luogo naturale di sviluppo
della crematistica innaturale, anticipando alcuni concetti base dell’economia moderna: la
distinzione tra valore d’uso e valore di scambio (basilare nella scuola classica e superata con
quella marginalista di fine Ottocento), le relazioni MDM e DMD (M come “merce”, D come
“denaro”: il “feticismo delle merci” descritto da Marx), il legame tra crescita, sfruttamento, guerra.
Logica conclusione del ragionamento aristotelico è la condanna dell’usura, fondamentale nella
riflessione cristiana scolastica in epoca medievale. In essa il guadagno proviene dal denaro stesso e
non dallo scambio delle merci, di cui i soldi dovrebbero essere funzione. Interessante è l’intuizione
del concetto di monopolio (Smith), descritto con l’aneddoto di Talete il quale, prevedendo un
abbondante raccolto di olive in base ai propri calcoli astronomici, avrebbe acquistato tutti i frantoi
di Mileto per poi noleggiarli ad alto prezzo ai disperati acquirenti. Aristotele sottolinea come spesso
gli stati utilizzino tali stratagemmi per arricchirsi (Pol, I, 11, 1259°; p. 24): mercantilismo.
I nessi tra politica ed economia sono ovviamente strettissimi. Non a caso quello economico è il
primo argomento affrontato da Aristotele nella trattazione della politica. Senza entrare nel merito
delle varie costituzioni politiche possibili (monarchia, aristocrazia, politia, con relative
degenerazioni, che vengono analizzate tramite una raccolta di 158 esempi storici), Aristotele
suddivide la società in tre classi: i ricchi, i poveri, quelli che stanno nel mezzo. Ora, non solo è vero
che la medietà è sempre il carattere migliore per il cittadino, nel dominio dell’etica come in quello
politico, ma anche che una costituzione non può essere certa della propria sopravvivenza se non è
basata sul ceto medio. Il possesso moderato delle ricchezze permette infatti di avere comportamenti
conformi a ragione, mentre la ricchezza e la povertà eccessive causano un allontanamento dal
comportamento razionale secondo virtù. I troppo “ricchi, nobili e belli” diventano grandi e violenti
criminali; i troppo poveri diventano piccoli e violenti criminali. Il problema è chiaramente legato
all’educazione. I ricchi si abituano sin da piccoli a non farsi governare (A. fa addirittura riferimento
esplicito alla scuola e alla “mollezza” dell’infanzia), i poveri al contrario diventano eccessivamente
remissivi e passivi. Dato che per Aristotele, al contrario di Platone, la costituzione politica più
giusta è quella in cui tutti i cittadini governano e sono governati a turno, è chiaro come si giustifichi
la possibilità, che è in certi casi una necessità, della rivoluzione (concetto marxista di riv.
necessaria; spiegazione di Hobsbawm su capacità dell’Europa occidentale di evitare socialismo
reale grazie a strategie keynesiane di redistribuzione del reddito). Infatti se i ricchi non sanno farsi
governare e governano come despoti, e i poveri si fanno governare come servi, lo Stato diventerà
una polis formata da schiavi e tiranni, e non da cittadini. Lo Stato, conclude Aristotele, “vuole
essere costituito, per quanto è possibile, di elementi uguali e simili, il che succede soprattutto con le
persone del ceto medio” (Pol. IV, 11, 1295 a-b, 1296 a-b; p.135-139). I cittadini del ceto medio sono
quelli che hanno l’esistenza più garantita di tutti, poiché non desiderano le ricchezza altrui né le loro
sono desiderate. Gli stati più fortunati sono quelli in cui il ceto medio è preminente rispetto alle altre
due tipologie sociali: dove la società è divisa tra chi ha troppo e chi niente, si creano un’oligarchia o
una democrazia “sfrenata”, da cui deriva con molta facilità la tirannide (implicito il riferimento ad
Atene e Sparta). Infatti i maggiori statisti provengono dal ceto medio, come Solone e Licurgo.
Queste sono le ragioni per le quali le costituzioni più diffuse sono oligarchiche o democratiche.
Essendo i popoli suddivisi in fazioni, chi vince impone il proprio governo senza stabilire una
“costituzione comune”.
A. si distingue quindi nettamente da Platone quando parla dei cittadini e del loro ruolo nello Stato.
Non è qui il caso di entrare nel merito dell’argomento, ma è necessario affrontare un problema
importante comune sia alla Politica che alla Repubblica, quello della proprietà privata, che
rientra pienamente nel campo dell’economia. A. su questo è esplicito: l’eliminazione della proprietà
privata è un danno, poiché gli uomini si interessano veramente solo del proprio: infatti è necessario
che essa esista, “ma sia comune nell’uso” (Pol, II (b), 4-5, 1262b-1266°), poiché il collettivismo
implica una deresponsabilizzazione degli individui ed una eccessiva difficoltà nel giustificare le
differenze economiche e le modalità operative di azione. Inoltre , al contrario di quel che ritiene
Platone (il cosiddetto “comunismo platonico”), lo Stato è pluralità di coscienze, famiglie, comunità,
e il legislatore deve educare i cittadini ad armonizzarsi attraverso l’uso comune dei beni privati (art.
41 Cost.: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali”).
La patristica tende a non interessarsi del rapporto con la politica prima della svolta costantiniana.
Dopo i Padri fanno riferimenti al problema della proprietà privata, che viene considerata un’
espressione di diritto civile e non divino. Giovanni Crisostomo (340-407) afferma che Dio ha
donato i beni della terra in proprietà comune agli uomini; secondo il contemporaneo Ambrogio la
proprietà privata nasce da un atto di usurpazione; Girolamo definisce il ricco un uomo ingiusto o
erede di uomo ingiusto; Agostino (354-430) considera la proprietà privata fonte della guerre e
ingiustizie sociali, sebbene giustifichi la violenza in nome dell’alleanza tra fede e potere e dichiari
che il buon cristiano deve sempre adeguarsi alle leggi del suo tempo, accettando i doveri naturali di
subordinazione: inoltre accetta la schiavitù quale espressione del diritto civile e non di quello
divino o naturale, a differenza di quanto ritengono Platone o Aristotele (uno schiavo può essere più
degno del Paradiso rispetto a un ricco, ma resta schiavo).
Scopo della riflessione cristiana è generalmente quello di limitare gli aspetti peggiori delle
sperequazioni economiche e sociali, senza metterle in discussione. Duns Scoto (1265-1308) ritiene
che la proprietà privata sia conforme al diritto naturale in seguito al peccato originale.
Escludendo le versioni più radicali legate alla riforma della Chiesa, quale la lezione francescana
originaria, i pensatori cattolici spingono ad una concezione del sostegno economico nei confronti
dei poveri che non metta in discussione l’assetto sociale esistente.
Le tesi della patristica saranno poi assimilate dal pensatore che ha costruito le fondamenta della
dottrina cattolica medievale, S.Tommaso, che assimila integralmente Aristotele all’interno del
contesto culturale cristiano. E’ chiaro che le tesi contenute nella Politica, già diffuse in Europa a
partire dal XII sec. circa, diventano ora stimolo centrale per la riflessione sui principali problemi
economici. La proprietà privata, nell’ottica di Tommaso, non è contraria al diritto naturale perché,
se ben utilizzata, ha effetti positivi e conformi a ragione; la proprietà comune è adatta solo a certi
livelli di perfezione, quali quelli che caratterizzano una comunità monastica. Il profitto
mercantile è lecito in certi casi, ossia quando non comporta la pratica dell’usura.
Con Tommaso siamo ormai entrati nella scolastica, la quale non si interessa alle dinamiche
dell’economia, ma a quei precetti morali che devono impedirne gli eccessi negativi. I temi principali
affrontati, che anticipano alcune importanti questioni della economia moderna, sono quelli
dell’usura e del giusto prezzo (Smith: economia di mercato e “di comando”, saggio di profitto
uniforme come risultato di equilibrio concorrenziale, rapporto tra prezzo naturale e prezzo di
mercato). Prima di Tommaso la tradizione cristiana fa spesso riferimento al passo evangelico in cui
Gesù esorta a prestare “senza sperarne nulla”. Con Tommaso si sviluppa una sofisticata casistica
per determinare quali comportamenti sono leciti e quali no. La realtà e che, in un contesto come
quello dei secoli centrali del medioevo, opporsi ad una diffusione del prestito a interesse,
rispettando il “divieto” aristotelico, è impossibile: tanti sono infatti i modi in cui i commercianti
aggirano i divieti ecclesiastici, perchè questo è legato allo sviluppo commerciale.
La legalizzazione completa dell’interesse è molto lenta, e si conclude pienamente solo con la
Riforma protestante e il Rinascimento. Restano vietati i prestiti caratterizzati da un eccessivo tasso
di interesse di fronte ad una condizione di debolezza del mutuatario. Il Discorso sull’usura di
Thomas Wilson (1572) considera i problemi trattati nell’atto del 1571 col quale sono dichiarati
illegali tutti i prestiti con tassi superiori al 10 percento.
Calvino (1509-1564) ritiene legittimi i prestiti a interesse ma non il credito al consumo, concesso
per sfruttare situazioni di debolezza economica del debitore. In generale l’interesse è sempre
regolamentato, fino a quando, con l’affermarsi del liberismo, importanti autori come Turgot o
Bentham (Difesa dell’usura, 1787) non ne denunciano la dannosità. Lo stesso Smith ritiene ancora
validi i limiti ai tassi di interesse, dato che altrimenti i “progettatori di iniziative chimeriche”
spiazzerebbero dalle borse gli imprenditori onesti. Bentham identifica invece i “chimerici” con gli
imprenditori capaci di innovare (anticipando in certo qual modo Schumpeter). Le leggi inglesi
sull’usura vengono abolite solo nel 1854.
Riguardo al giusto prezzo, Tommaso lo intende come quello prevalente in assenza di frodi e
monopoli. Alcune intuizioni che saranno poi alla base dei successivi sviluppi economici già presenti
in Agostino ed altri Padri, sono formulate da Tommaso e altri: il valore dei beni è definito dalla loro
capacità di soddisfare i bisogni (indigentia); mentre Pietro di Giovanni Olivi afferma che le tre fonti
del valore sono virtuositas, complacibilitas e raritas, ossia capacità di soddisfare i bisogni,
rispondenza alle preferenze, scarsità, concetti che sembrano anticipare alcuni aspetti della teoria
marginalista di fine Ottocento (Menger, Jevons, Walras, molto diversi fra loro ma accomunati dal
concetto analitico di utilità marginale, basato su: il processo col quale si soddisfano i bisogni
attraverso risorse scarse; la definizione del valore come utilità attraverso la percezione che hanno
dei beni i consumatori; la definizione della distribuzione del reddito come caso particolare della
teoria dei prezzi). E’ opportuno precisare che l’approccio marginalista non è nato improvvisamente,
ma accompagna tutta la storia dell’economia. Vari autori infatti, sin dal medioevo, riprendono questi
elementi avvicinandosi alla definizione di un rapporto organico valore d’uso-valore di scambio
attraverso l’interrelazione domanda-offerta, cosa non accettata nell’approccio classico: per Smith e
Ricardo valore d’uso e di scambio restano nettamente distinti, sebbene il primo non sia
quantificabile.