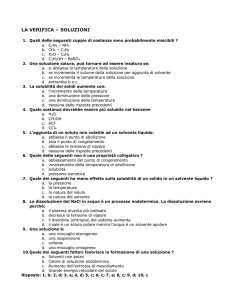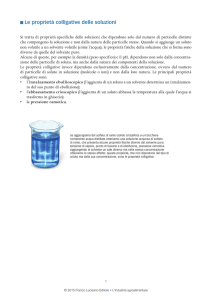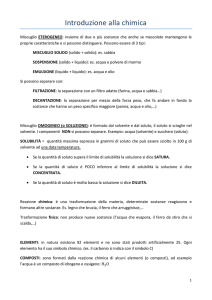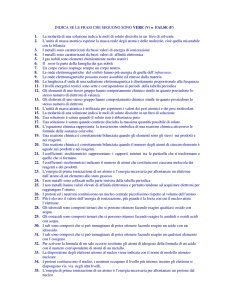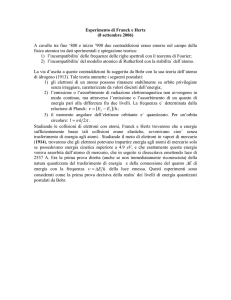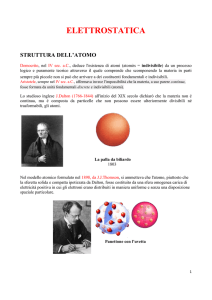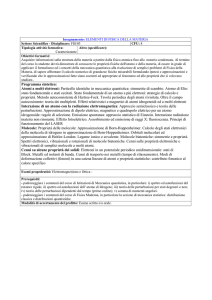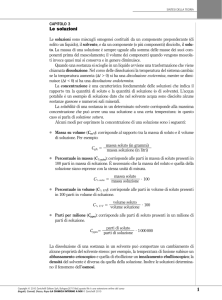LE SOLUZIONI E LE LORO PROPRIETÀ – GLI ACIDI E LE BASI
Una soluzione è una miscela omogenea di due o più sostanze, la
cui separazione è realizzabile mediante cambiamenti di stato
fisico; la sostanza presente in quantità maggiore è detta solvente,
quella in quantità minore è definita soluto.
C’è nessuno?
Si ha una soluzione indipendentemente dallo stato fisico proprio, in
condizioni normali, di ciascun componente, purché le particelle
siano uniformemente disperse e le loro dimensioni non superino
l’ordine di grandezza molecolare (d < 1 nm).
La caratteristica essenziale delle soluzioni è rappresentata dal
variare continuo delle proprietà al variare delle proporzioni fra gli
elementi che le compongono, entro certi limiti più o meno ampi,
ma definiti.
Considerando i tre stati di aggregazione della materia (solido, liquido e gassoso) possono
originarsi soluzioni fra due elementi che si trovino in uno qualsiasi di tali stati (soluzioni gas –
gas, liquido – liquido, solido - solido, gas – liquido, gas – solido e solido – liquido), anche se le
più comuni si formano fra un solido ed un liquido o fra due liquidi. I gas sono miscibili tra loro
in ogni proporzione, dando luogo alla formazione di sistemi omogenei (es. l’aria che noi tutti
respiriamo). Vere e proprie soluzioni solide sono rappresentate dalle leghe metalliche.
Nel linguaggio quotidiano, e non solo, il termine soluzione viene utilizzato per indicare un
sistema costituito da un solvente liquido e da un soluto solido, liquido o gassoso.
Le soluzioni di un solido in un liquido sono sempre possibili, pur di scegliere l’opportuna
sostanza liquida.
La soluzione che si forma ha normalmente un volume minore della somma dei volumi dei
singoli componenti e comporta un lavoro di disgregazione molecolare con relativo scambio di
energia tra le diverse componenti del sistema. Affinché si formi una soluzione, devono essere
vinte le forze di attrazione tra le molecole del soluto e quelle fra le molecole del solvente: tutto
ciò richiede energia. Quando il soluto si scioglie, si instaurano nuove forze di attrazione tra le
molecole del soluto e quelle del solvente: questo processo libera energia. La differenza di
energia tra i passaggi appena descritti viene definita calore di soluzione. In base al valore di
questo parametro, la formazione di una soluzione può avvenire con cessione di energia (NaOH)
oppure con assorbimento di energia (NH4NO3).
Il processo mediante il quale gli ioni o le molecole di un soluto sono circondati dalle molecole
del solvente è detto solvatazione. Se il solvente è l’acqua, la solvatazione è definita
idratazione.
A seconda delle loro proprietà e della loro struttura, le sostanze si possono sciogliere nell’acqua
attraverso tre meccanismi: per dissociazione, per solubilizzazione e per ionizzazione.
Fattori che influenzano la velocità di solvatazione
Così come per la velocità di reazione, anche la velocità di solvatazione dipende dalla frequenza
e dall’energia delle collisioni che avvengono tra le particelle: in questo caso, tra le particelle
del soluto e quelle del solvente.
I fattori che influenzano la velocità di solvatazione sono:
L’area superficiale del soluto: quanto maggiore è l’area superficiale che un soluto
possiede, tanto più numerose saranno le collisioni tra le sue particelle e quelle del solvente.
Poiché la solvatazione è un processo che avviene sulla superficie dei soluti, la stessa quantità
di sostanza può essere solvatata più velocemente se la riduciamo in parti molto piccole
piuttosto che in un unico campione di grosse dimensioni (Es. zucchero in polvere vs zolletta
di zucchero, sale grosso vs sale fino).
L’agitazione della soluzione: mescolando continuamente, aumentiamo l’energia cinetica
delle particelle del soluto e del solvente e, di conseguenza, le collisioni dovute ai moti caotici.
Tutto ciò facilita la solvatazione dei solidi nei liquidi, mentre diminuisce quella dei gas, i quali,
a causa dell’agitazione, hanno l’energia sufficiente per allontanarsi dalla soluzione.
La temperatura alla quale si forma la soluzione: un aumento della temperatura ha lo
stesso effetto dell’agitazione meccanica.
SOLUBILITÀ E CONCENTRAZIONE
La solubilità di una sostanza in un dato solvente è definita come la quantità massima
(espressa in grammi o moli) che si scioglie, in condizioni di equilibrio con il corpo di fondo
(particelle disperse, sospese, non sciolte), in un volume definito di solvente ad una data
temperatura.
Spesso ci si riferisce alla solubilità come la massima quantità di soluto che
si può sciogliere in 100 g di un dato solvente ad una data temperatura.
Conoscere la solubilità di una sostanza ci aiuta a classificare le soluzioni in
base a quanto soluto contengono. Le soluzioni, a seconda delle quantità di
soluto, sono classificate come sature, insature o sovrassature. Una
soluzione si dice:
Satura: se, ad una data temperatura ed in una certa quantità di
solvente, non è possibile sciogliere ulteriore soluto. Quando una
soluzione è satura, se aggiungiamo altro soluto questo non si scioglie,
ma si deposita come corpo di fondo.
Insatura: se, ad una data temperatura ed in una certa quantità di
solvente, la quantità di soluto disciolto è minore della quantità necessaria
affinché la soluzione sia satura. In questo caso possiamo aggiunger
ulteriore soluto fino al raggiungimento della concentrazione di
saturazione.
Sovrassatura: se, ad una data temperatura ed in una certa quantità di
solvente, la quantità di soluto disciolto è maggiore della quantità
necessaria affinché la soluzione sia satura. Le soluzioni sovrassature sono
instabili e tendono a raggiungere lo stato di soluzioni sature separando
soluto allo stato puro.
La solubilità di un certo soluto in un certo solvente dipende, oltre che dalle
caratteristiche delle due sostanze, anche dalla temperatura e dalla pressione.
Proprietà del soluto e del solvente
La celebre frase "Il simile scioglie il simile" attribuita agli alchimisti medievali trova
spiegazione nella polarità ed apolarità delle molecole (ma vi sono anche i casi di
complessazione, che richiedono trattazione a parte).
Sostanzialmente un soluto è tanto più solubile in un solvente quanto più sono forti i legami
intermolecolari che forma con le molecole del solvente. Se i legami sono più deboli di quelli
che il solvente forma con sé stesso esso sarà poco solubile o insolubile, mentre se sono più
forti sarà solubile, molto solubile o addirittura infinitamente solubile (ossia solubile in
qualunque proporzione). Da ciò consegue che, in linea di principio, sostanze polari saranno
solubili in sostanze polari poiché i legami intermolecolari solvente - soluto sono più forti (o di
forza comparabile) dei legami solvente - solvente e soluto - soluto. Lo stesso vale per le
sostanze apolari.
Quindi la condizione sufficiente, in prima approssimazione, per determinare la solubilità di un
soluto in un solvente è che i legami soluto - solvente non siano più deboli di quelli che il
soluto od il solvente formano con sé stessi. Se, per esempio, abbiamo un sale ad alta polarità
si potrà pensare che esso sarà solubile in acqua, dato che anche questo solvente è polare.
Ma se i legami intermolecolari che il sale forma fra le sue molecole sono molto forti, ed in
particolare più forti di quello che forma col solvente, esso rimarrà legato con sé stesso (e qui
si potrebbe considerare le probabilità relative che i legami di diversa forza hanno di
rompersi).
Esistono anche molecole che presentano caratteristiche sia polari che apolari (è il caso degli
eteri) e che possono essere pertanto solubili in una certa misura sia in sostanze polari che in
sostanze apolari.
Aumento della temperatura
In generale, all'aumento della temperatura aumenta la
solubilità delle sostanze solide, mentre diminuisce quella
delle sostanze gassose.
Basti pensare ai mari tropicali, più caldi, che sono più
"salati" di quelli glaciali, oppure alle diverse quantità di
zucchero che si sciolgono nello stesso volume di acqua a
diverse temperature. Non tutte le sostanze, però, hanno
comportamenti analoghi riguardo alla dipendenza della
solubilità dalla temperatura: ad esempio, la solubilità del
carbonato di litio in acqua diminuisce con l'aumentare
della temperatura.
Aumento della pressione
L'aumento di pressione provoca un aumento della solubilità, ma solamente nei gas. Secondo
la legge di Henry, infatti, la quantità di un gas che si scioglie in un liquido è proporzionale
alla pressione parziale del gas a temperatura
costante.
Nelle bevande gassate fino a quando la bottiglia è
sigillata la maggior pressione interna permette
all'anidride di rimanere in soluzione, quando la
bottiglia viene aperta la diminuzione di pressione
comporta la rapida gassificazione dell'anidride
disciolta con la conseguente formazione delle
bollicine.
La concentrazione di una soluzione è la quantità di soluto sciolto in una determinata quantità
di solvente.
La concentrazione può essere espressa in diversi modi:
percentuale in volume (% V/V) = (volume di soluto/volume di soluzione) 100
perc in massa su volume (% m/V) = (volume di soluto/volume di soluzione) 100
percentuale in massa (% m/m) = (massa di soluto/massa di soluzione) 100
molarità (M) = moli di soluto/volume di soluzione (L)
PROPRIETÀ COLLIGATIVE DELLE SOLUZIONI
Una soluzione molto diluita, nella quale non si manifestano interazioni fra molecole di soluto e
molecole di solvente, si dice soluzione ideale; in questo caso si assume che il mescolarsi
delle molecole di soluto e di solvente avvenga senza cambiamenti di volume e di contenuto
termico.
Per le soluzioni ideali valgono le cosiddette proprietà colligative: proprietà fisiche di una
soluzione che non dipendono dalla natura del soluto ma solo dal numero delle particelle
presenti nella soluzione. Sono proprietà colligative di una soluzione l’abbassamento relativo
della tensione di vapore, l’innalzamento ebullioscopico, l’abbassamento crioscopico e la
pressione osmotica (Nei gas ideali sono proprietà colligative la pressione ed il volume).
Le leggi che regolano queste proprietà sono valide per tutte quelle soluzioni diluite, in cui siano
presenti soluti non volatili che non si dissociano in ioni e non danno soluzioni solide con i
solventi; spesso, però, sono anche utilizzate per ottenere risultati approssimati relativi a
soluzioni reali, le quali vengono confrontate con le prime per valutarne il maggiore o minore
scostamento dalle leggi valide nel caso teorico.
La legge di Rault
Anche in una soluzione ideale, la tensione di vapore (La pressione esercitata dalla fase di
vapore in equilibrio con la fase condensata) non è nulla e cambia al variare della composizione
della soluzione a temperatura costante.
Indichiamo la frazione molare del solvente con X1 e con P°1 la tensione di vapore del solvente
puro alla temperatura dell’esperimento. Quando X1 tende a zero (La miscela è costituita quasi
soltanto da soluto puro), la tensione di vapore del solvente P1 deve anch’essa tendere a zero,
poiché il solvente è praticamente assente. Dunque, al variare di X 1 da 1 (solvente puro) a 0
(soluto puro), la tensione di vapore del solvente passa da P°1 a 0.
Il chimico francese Francois Marie Rault ha trovato che, per alcune soluzioni, il grafico della
tensione di vapore del solvente in funzione della frazione molare del solvente stesso è
approssimabile ad una retta, rappresentata dall’equazione:
P1 = X1 P°1
che è nota come legge di Rault. Le soluzioni che vi obbediscono sono dette soluzioni ideali,
mentre quelle che si discostano da essa sono definite soluzioni non ideali. Queste ultime
possono mostrare sia deviazioni in positivo (Hanno tensioni di vapore maggiori di quelle
previste dalla legge) che in negativo (Con tensioni di vapore inferiori a quelle teoriche). Le
deviazioni negative sono dovute al fatto che le molecole di solvente e di soluto si attraggono
con particolare forza, ostacolando il passaggio alla fase di vapore del solvente; le deviazioni
positive derivano da cause opposte: una ridotta attrazione tra soluto e solvente.
La legge di Rault è alla base dell’interpretazione di tutte e quattro le proprietà colligative.
Abbassamento della tensione di vapore della soluzione rispetto al solvente puro
Secondo la legge di Rault, la tensione di vapore P di una soluzione ideale contenete le sostanze
1, 2, 3, 4 ..., ad una data temperatura, è data dalla relazione:
P = X1P°1 + X2P°2 + X3P°3 + X4P°4 + ...
cioè dalla somma dei prodotti delle tensioni parziali delle sostanze pure per le rispettive frazioni
molari.
Nel caso di una soluzione contenente un unico soluto non
volatile la tensione di vapore coincide con quella del solvente:
P1 = X1P°1
Poiché , per una miscela a due componenti X1 = 1 – X2, la
legge di Rault può anche essere scritta come:
ΔP1 = P1 - P°1 = X1P°1 - P°1 = P°1(X1 – 1) = -X2 P°1
dalla quale risulta che la variazione della tensione di vapore è
proporzionale alla frazione molare del soluto ed il segno
negativo indica un abbassamento della tensione di vapore.
Nelle soluzioni diluite, infatti, la tensione di vapore è sempre inferiore a quella del solvente
puro.
Innalzamento ebullioscopico
La temperatura di ebollizione di un liquido puro
o di una soluzione è la temperatura alla quale la tensione di vapore del liquido uguaglia la
pressione esterna.
Dal momento che l’aggiunta di un soluto ad un solvente puro ne abbassa la tensione di vapore,
la temperatura di ebollizione di una soluzione risulterà maggiore rispetto a quella del solvente
puro. Questo fenomeno viene definito innalzamento ebullioscopico ed è proporzionale alla
concentrazione molale (m = moli di soluto/kg di solvente) del soluto:
ΔTe = kem
ke è una costante che dipende esclusivamente dal solvente. Esso può essere spiegato anche
attraverso la maggiore energia richiesta per vincere le interazioni che si instaurano tra soluto e
solvente e che si vanno ad aggiungere a quelle presenti nel solvente puro tra le sue stesse
molecole.
Abbassamento crioscopico
La temperatura di solidificazione o di fusione è la temperatura alla quale la fase solida e quella
liquida coesistono, il che equivale a dire che le tensioni di vapore delle due fasi devono essere
uguali al punto di fusione/solidificazione.
Dal momento che l’aggiunta di un soluto
ad un solvente puro ne abbassa la
tensione di vapore, anche la temperatura
di solidificazione/fusione di una soluzione
risulterà inferiore rispetto a quella del
solvente puro. Questo fenomeno viene
definito abbassamento crioscopico ed è
proporzionale alla concentrazione molale
(m = moli di soluto/kg di solvente) del
soluto:
ΔTc = kcm
Kc
è
una
costante
che
dipende
esclusivamente dal solvente. Esso può
essere spiegato come la difficoltà che il
solvente incontra a trasformarsi in solido a causa delle interazioni tra soluto e solvente, che
competono con l’instaurarsi di quelle tra le molecole del solvente e che sono necessarie perché
avvenga il passaggio di stato.
Pressione osmotica
Quando una soluzione è separata dal suo solvente mediante una membrana semipermeabile
(Una membrana che permette il passaggio delle molecole di solvente ma non le molecole o gli
ioni del soluto) si verifica un flusso, attraverso la
membrana, di molecole di solvente verso la
soluzione. Questo fenomeno si chiama osmosi.
La pressione che deve essere esercitata sulla
soluzione per impedire il passaggio del solvente
nella soluzione si chiama pressione osmotica.
Nel 1887 Jacobus Van’t Hoff scopri una relazione
tra la pressione osmotica π, la concentrazione c e
la temperatura assoluta T:
π = cRT
da cui
πV = nRT
IL PRODOTTO IONICO DELL’ACQUA ED IL pH DELLE SOLUZIONI ACQUOSE
Tutte le sostanze che, sciolte in acqua, formano ioni, sia per dissociazione sia per ionizzazione,
sono definite elettroliti ed, a causa della presenza di ioni (cioè entità chimiche dotate di
carica), le soluzioni acquose di elettroliti conducono la corrente elettrica.
Gli elettroliti sono classificati in forti e deboli a seconda che siano molto o poco dissociati e la
costante che regola il loro equilibrio è detta costante di dissociazione.
Allo stato puro l’acqua presenta una bassissima conducibilità elettrica, sintomo della presenza
di ioni al suo interno seppur in piccolissima quantità. L’acqua, infatti, è caratterizzata dal
seguente equilibrio di dissociazione
H2 O
H+(aq) + OH-(aq)
in cui viene mostrato come le molecole di acqua si dissocino in ioni idrogeno (H +) ed idrossido,
od ossidrile, (OH-). Questa espressione, però, non è del tutto corretta, in quanto lo ione
idrossido non può esistere libero in presenza di acqua, poiché l’acqua lo cattura per formare lo
ione idronio H3O+:
2 H2O
H3O+(aq) + OH-(aq)
Per ragioni di semplicità, spesso, si utilizza la prima espressione, sebbene imprecisa.
La costante di equilibrio per il processo di dissociazione dell’acqua è data dall’equazione:
Keq = [H3O+] [OH-] / [H2O]2
Per le reazioni acquose, dato che la frazione di molecole d'acqua che all'equilibrio è allo stato
dissociato è piccolissima (soltanto due molecole di acqua su un miliardo), si considera costante
(a 25°C e 1 atm) la concentrazione delle molecole di acqua non ionizzate. Quindi, si può
semplificare l'equazione precedente moltiplicando entrambi i membri per tale concentrazione
ed ottenere una costante di equilibrio che va sotto il nome di prodotto ionico dell'acqua (o
costante di ionizzazione o costante di dissociazione o costante di semiionizzazione),
ed è espresso dalla relazione:
Kw = Keq [H2O]2 = [H3O+] [OH-] = 1,0 10-14
Il prodotto ionico dell’acqua è costante in tutte le soluzioni acquose. Questo significa
che, in una soluzione acquosa, all’aumentare della concentrazione degli ioni H 3O+, si ha una
diminuzione degli ioni OH- e viceversa.
Così, nota la concentrazione degli ioni H 3O+ presenti in una soluzione acquosa è sempre
possibile calcolare la concentrazione degli ioni OH -, e viceversa ovviamente, dalla relazione
[H3O+] [OH-] = 1,0 10-14.
Concludendo, possiamo affermare che: in ogni soluzione acquosa esistono sempre
concentrazioni di ioni [H3O+] ed [OH-] tali da conservare il prodotto ionico dell’acqua.
Diremo inoltre che una soluzione acquosa è:
neutra se le concentrazioni di [H3O+] ed [OH-] sono uguali ([H3O+] = [OH-] = 1,0 10-7);
acida se la concentrazione degli ioni [H3O+] è maggiore di quella degli ioni [OH-];
basica se la concentrazione degli ioni [H3O+] è minore di quella degli ioni [OH-].
Poiché la concentrazione degli ioni H 3O+ espressa mediante le potenze del 10 è scomoda da
usare, i chimici preferiscono impiegare una scala logaritmica, nota come scala del pH, che
assume valori da 0 a 14:
pH = -log10 [H3O+]
Poiché il prodotto ionico dell’acqua deve rimanere costante, minore è il valore del pH, maggiore
sarà la concentrazione degli ioni H3O+ presenti in soluzione; viceversa, maggiore è il valore del
pH, minore sarà la concentrazione degli ioni H 3O+ presenti in soluzione. Questi ragionamenti
possono essere fatti al contrario utilizzando la misura della concentrazione degli ioni OH-.
Da quanto appena illustrato ricaviamo che le soluzioni acquose possono essere definite:
neutre se il valore del pH = 7;
acide se il valore del pH < 7;
basiche se il valore del pH > 7.
L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI ACIDO E DI BASE
Acidi e basi sono classi di composti chimici strettamente correlate che combinandosi danno
origine ai sali. Precedentemente abbiamo definito l’acidità e la basicità facendo riferimento a
misure sperimentali relative alla concentrazione degli ioni idronio ed ossidrile ([H 3O+] e [OH-]);
vediamo ora come, a livello teorico, si è evoluto il concetto di acido e di base.
Teoria acido – base di Arrhenius
La prima e più semplice definizione, sebbene incompleta, stabilisce che:
gli acidi siano sostanze che in soluzione acquosa si dissocino liberando ioni idrogeno (H+);
le basi siano sostanze che dissociandosi liberano ioni ossidrile (OH-).
Questa distinzione risale al chimico svedese S. A. Arrhenius (1859 – 1927), che la formulò a
conclusione di studi riguardanti la dissociazione elettrolitica (cioè la scissione in ioni) dei
composti chimici in soluzione acquosa. Essa fà riferimento all’acqua ed al suo equilibrio di
dissociazione, descritto nel paragrafo precedente. L’acqua viene considerata neutra e
debolmente dissociata; la distinzione tra acidi e basi risulta direttamente legata alla
determinazione del prodotto ionico della soluzione acquosa della sostanza in esame (il pH è
compreso tra 0 e 7 per gli acidi, da 7 a 14 per le basi).
Questa teoria spiega come si possa ottenere una soluzione neutra mescolando in opportune
proporzioni un acido con una base. Spiega inoltre l’acidità degli acidi e la basicità degli idrossidi
in base alle reazioni di dissociazione:
HCl → H+ + Cl-
NaOH → Na+ + OH-
H2SO4 → 2 H+ + SO42-
Mg(OH)2 → Mg2+ + 2 OH-
Ma non spiega affatto la basicità dell’ammoniaca (NH 3), che non avendo ossigeno non può
liberare ioni OH-, né l’acidità del diossido di carbonio (CO 2), che non avendo idrogeno non può
liberare ioni H+. in seguito, queste osservazioni furono spiegate come conseguenza delle
reazioni del composto acido o basico con l’acqua, ma tale spiegazione era valida solo se il
solvente era l’acqua.
Secondo l’entità maggiore o minore di dissociazione/ionizzazione in soluzione acquosa, acidi e
basi possono essere distinti in forti e deboli, rispettivamente:
acidi e basi forti si presentano in soluzione acquosa completamente, o quasi, dissociati;
acidi e basi deboli sono presenti in soluzione acquosa prevalentemente indissociati.
Gli acidi si distinguono in acidi ossigenati (contenenti ossigeno: es. HNO3) ed idracidi (privi
di ossigeno: es. HCl). In base al numero di atomi di idrogeno ionizzabili, si possono dividere in
monoprotici (es. HClO) e poliprotici (H2SO4 è diprotico, mentre H3PO4 è triprotico).
Analogamente le basi si possono classificare secondo il numero di OH - che rilasciano in
soluzione.
Le titolazioni
Una titolazione è un’operazione chimica effettuata nell’analisi quantitativa allo scopo di
determinare la quantità di sostanza contenuta in una soluzione (concentrazione o titolo).
Consiste nell’aggiungere alla soluzione con concentrazione incognita del componente che si
vuole dosare, una soluzione a concentrazione nota di un opportuno reattivo, scelto in modo che
reagisca stechiometricamente e rapidamente con la sostanza da dosare e la sua aggiunta cessi
esattamente alla fine della reazione, nel cosiddetto punto di equivalenza (volume di
soluzione titolante che contiene esattamente lo stesso numero di grammi equivalenti della
soluzione di cui vogliamo individuare la concentrazione), spesso reso più evidente dall’impiego
di indicatori (sostanze in grado di subire una reazione che comporta un notevole
cambiamento di colore, viraggio, facilmente apprezzabile dall’analista, non appena viene
raggiunto il punto di equivalenza).
Dalla conoscenza della reazione che ha avuto luogo e misurando il volume di reattivo aggiunto,
si risale con facilità, attraverso il calcolo stechiometrico, alla quantità di sostanza da dosare.
Poiché, in definitiva, è necessario compiere la misura basandosi su volumi, tutta la branca
dell’analisi chimica che si basa sulle titolazioni prende il nome di volumetria.
REAZIONI CHIMICHE ED EQUAZIONI CHIMICHE
Una reazione chimica è un processo di trasformazione della materia nella quale
gli atomi, pur restando inalterati, si legano o si distribuiscono in modo diverso da
quello originario, formando così sostanze diverse da quelle di partenza. In una
reazione chimica, le sostanze presenti prima che la reazione abbia luogo sono
chiamate reagenti, mentre quelle che si formano sono dette prodotti.
In generale, si dice che una sostanza sta partecipando ad una reazione chimica
quando si trasforma in un’altra.
Per poter capire che cosa sia una reazione chimica, prima di tutto
dobbiamo essere in grado di descriverla. Una buona descrizione di
una reazione chimica deve raccontare quali sostanze sono presenti
prima della reazione e quali dopo. Ciò è reso possibile dall’impiego
di simboli e di numeri che vengono ordinati come in un’equazione
matematica, definita equazione chimica. Il primo ad utilizzare
questo tipo di rappresentazione fu Antoine Lavoisier.
Un’equazione chimica è una notazione utilizzata per descrivere
una reazione chimica, fornendo una relazione tra le quantità delle
sostanze che vi partecipano. Essa esprime il principio, o legge, di
conservazione della massa: “Il numero di atomi o di moli delle
sostanze che si trovano a sinistra del segno di uguaglianza deve
essere uguale al numero di atomi o di moli che si trovano a destra.”
Ciò equivale a dire che “In ogni procedimento chimico la quantità di
materia prima e dopo il procedimento rimane la stessa.”
Le reazioni chimiche vengono rappresentate mediante equazioni del tipo
aA + bB
cC + dD
alla sinistra compaiono le sostanze (A, B) che prendono parte alla reazione (reagenti) ed alla
destra le sostanze (C, D) che si formano nella reazione (prodotti);
le lettere a, b, c, d indicano il numero di molecole o di atomi o di moli che prendono parte
alla reazione e sono definite coefficienti stechiometrici;
tra i reagenti ed i prodotti viene interposta una freccia (
) o, più raramente un segno di
uguale (=), indicante il verso di svolgimento della reazione;
nel caso in cui le reazioni chimiche siano reversibili, possano cioè procedere in entrambi i
versi, si interpongono due frecce (
) tra reagenti e prodotti.
Un’equazione chimica, in cui compaiono a sinistra del segno di reazione le formule dei reagenti
ed a destra quelle dei prodotti, ha un significato qualitativo: indica cioè che i reagenti si
trasformano, in determinate condizioni sperimentali, nei prodotti della reazione.
Perché l’equazione chimica acquisti anche un significato quantitativo è necessario far precedere
le formule chimiche dagli opportuni coefficienti stechiometrici, affinché sia rispettata la legge di
conservazione della massa, cioè, l’equazione chimica deve essere bilanciata. Questo
significa che i coefficienti stechiometrici devono essere tali che il numero di atomi di ciascun
elemento sia lo stesso sia a destra sia a sinistra dell’equazione; essi, inoltre, devono essere
numeri interi ed i più piccoli possibili; il rapporto tra di essi è definito rapporto
stechiometrico.
I coefficienti stechiometrici in una reazione chimica rappresentano il numero minimo di
molecole che possono prendere parte alla reazione.
Regole per bilanciare correttamente equazioni chimiche
Esaminiamo, come esempio, la reazione di combustione del butano in presenza di ossigeno per
formare il diossido di carbonio e l’acqua.
Scrivere correttamente le formule molecolari dei reagenti e dei prodotti.
CH3CH2CH2CH3 + O2
CO2 + H2O
Assegnare 1 come coefficiente di una specie, preferibilmente a quella più complessa con il
numero più alto di elementi (Il coefficiente unitario, generalmente, non viene indicato).
1CH3CH2CH2CH3 + O2
CO2 + H2O
Identificare, in sequenza, gli elementi che appaiono in una sola specie di cui non è stato
determinato il coefficiente e scegliere il valore che bilancia il numero di atomi (moli di atomi)
di quell’elemento; proseguire fino ad identificare tutti i coefficienti.
1CH3CH2CH2CH3 + O2
1CH3CH2CH2CH3 + O2
1CH3CH2CH2CH3 + 13/2O2
4CO2 + H2O (bilanciamento degli atomi di carbonio)
4CO2 + 5H2O (bilanciamento degli atomi di idrogeno)
4CO2 + 5H2O (bilanciamento degli atomi di ossigeno)
Moltiplicare tutta l’equazione per il più piccolo numero intero che elimina ogni coefficiente
frazionario.
2CH3CH2CH2CH3 + 13O2
8CO2 + 10H2O
Durante il bilanciamento dei coefficienti stechiometrici, non bisogna mai modificare gli indici
di formula dei composti (I pedici ai simboli degli elementi), perché cambiarli significherebbe
cambiare l’identità dei reagenti e dei prodotti.
Di seguito sono elencati alcuni esempi di bilanciamento di equazioni chimiche:
Li + O2
Li2O
Al + O2
Al2O3
Al2O3 + H2O
Al(OH)3
4Li + O2
2Li2O
4Al + 3O2
2Al2O3
Al2O3 + 3H2O
2Al(OH)3
LA STRUTTURA ATOMICA
L’atomo [dal greco ἄτομος - àtomos -, indivisibile, unione di ἄ - a –
(alfa privativo) + τομή - tomé – (divisione)] è la più piccola parte di un
elemento che conserva le proprietà chimiche dell’elemento stesso. Allo
stato attuale della conoscenza, l’atomo rappresenta l’unità base della
materia ed è costituito da un nucleo denso e carico positivamente,
posto al centro, circondato da una nuvola di elettroni carichi
negativamente.
Tutte le sostanze sono costituite da atomi che si uniscono tra di loro in molecole; la
straordinaria varietà della materia è dovuta alla combinazione di poche specie atomiche (gli
elementi conosciuti sono 118).
Il concetto di atomo come entità indivisibile, da cui il nome, venne elaborato
nell’antica Grecia in ambito filosofico. I filosofi greci proposero due teorie per spiegare la
materia su scala microscopica:
Secondo Empedocle (Agrigento, 490 a.C.
circa – 430 a.C. circa), Platone (Atene, 428
a.C. – Atene, 348 a.C.) ed Aristotele (Stagira,
384 a.C. – Calcide, 322 a.C.), gli elementi
(fuoco, aria, acqua, terra), di cui è costituita
la materia, sono delle qualità continue che si
mescolano, con l'aiuto delle forze dell'Amore e
dell'Odio, per formare le sostanze con le loro
proprietà. Questo punto di vista considera la
materia divisibile senza limiti.
L’altro punto di vista, sostenuto dai filosofi Leucippo (Mileto, inizio-prima metà del V secolo
a.C. – terzo quarto del V secolo a.C.), Democrito (Abdera, 460 a.C. – 360 a.C.) ed Epicuro
(Samo, 341 a.C. – Atene, 271 a.C.) (definiti per tale motivo “atomisti”), ipotizza l’esistenza
degli atomi come limite inferiore oltre il quale la materia non può essere suddivisa.
Secondo questi filosofi esistono numerosi atomi, ciascuno con specifiche caratteristiche, in
continuo movimento, dalla cui unione traggono origine la materia e la vita e dalla cui
separazione deriva la degradazione della materia e la morte.
I filosofi greci, tuttavia, rimasero fermi alla formulazione delle ipotesi senza procedere alla loro
verifica sperimentale.
Affinché vengano mossi i primi passi verso la comprensione della natura
microscopica della materia bisogna attendere il XVIII ed il XIX secolo. Il
vero progresso poté essere realizzato solo dopo che l’utilizzo della
bilancia, per controllare le masse dei reagenti e dei prodotti di una
reazione chimica, divenne una prassi comune, grazie al chimico francese
Antoine Lavoisier (Parigi, 26 agosto 1743 – Parigi, 8 maggio 1794).
Egli scaldò del mercurio in una beuta sigillata contenente anche dell’aria.
Dopo alcuni giorni si era prodotta una sostanza rossa, l’ossido di mercurio
(HgO). La massa del gas rimasto nel recipiente era minore ed esso non
era in grado di sostenere una combustione o la vita: una candela accesa
si spegneva e gli animali messi a contato con esso soffocavano. Oggi
sappiamo che il gas residuo era azoto e che l’ossigeno presente nell’aria aveva reagito con il
mercurio. Lavoisier prese una quantità accuratamente pesata della sostanza rossa e poi la
scaldò. In seguito, pesò il mercurio liquido ed il gas che si era prodotto e riuscì a dimostrare
che la somma delle loro masse era identica a quella dell’ossido iniziale. Dopo ulteriori
esperimenti Lavoisier poté formulare la legge della conservazione della massa:
“In ogni procedimento chimico la quantità di materia prima e dopo il procedimento rimane la
stessa.” Ciò equivale a dire che “in una reazione chimica la massa non può essere né creata né
distrutta”.
Lavoisier fu anche il primo ad utilizzare un’equazione algebrica per rappresentare una reazione
chimica. Nell’esempio sopra descritto abbiamo:
2HgO
2Hg + O2
Sempre un chimico francese, Joseph Proust (Angers, 26 settembre 1754 – Angers, 5 luglio
1826), formulò la fondamentale legge delle proporzioni definite:
“In un dato composto chimico i rapporti in massa degli elementi di cui
esso è costituito sono costanti, indipendentemente dall’origine del
composto o dal modo di preparazione.” Questo è vero perché “quando
due sostanze si combinano/reagiscono per formare un composto, le loro
masse si combinano in proporzioni definite e costanti”.
Proust giunse a questa legge osservando che quando si facevano reagire
due sostanze, se una delle due era presente in eccesso, l’andamento della
reazione non cambiava; la massa in eccesso non reagiva e si trovava alla
fine della reazione, insieme al prodotto di reazione. Tale eccesso si
formava solo quando uno dei due reagenti aveva reagito completamente. Da ciò egli stabilì che
il rapporto tra le masse dei reagenti, detto rapporto di combinazione, dovesse essere costante
indipendentemente dalle quantità iniziali dei reagenti stessi.
Gli studi dello scienziato inglese John
Dalton (Eaglesfield, 6 settembre 1766 –
Manchester, 27 luglio 1844) fornirono
l’evidenza sperimentale dell’esistenza degli
atomi, così come avevano ipotizzato oltre
duemila anni prima i filosofi greci definiti
atomisti. Egli riuscì a dimostrare che le
relazioni tra le masse osservate da Lavoisier
e Proust potevano essere interpretate in
modo semplice postulando l’esistenza degli
atomi dei vari elementi. Nel 1808, egli
pubblicò il testo “Un nuovo sistema di
filosofia chimica”, all’interno del quale sono
racchiusi i principi della teoria atomica
della materia secondo Dalton:
tutta la materia è costituita da particelle singole chiamate atomi che non possono essere
suddivise in porzioni più piccole;
tutti gli elementi sono composti da atomi;
tutti gli atomi dello stesso elemento hanno la stessa massa e le stesse proprietà e gli atomi
di elementi diversi hanno masse e proprietà diverse;
i composti contengono atomi di uno o più elementi;
in un particolare composto, gli atomi si combinano sempre nello stesso modo;
gli atomi sono indistruttibili e mantengono la loro identità nelle reazioni chimiche; non
possono essere né creati né distrutti e nemmeno essere trasformati gli uni negli altri.
in questo modello gli elementi sono rappresentati come sfere solide, caratterizzate da una
massa ben precisa e diversa dalle altre.
Dalton notò che due elementi possono combinarsi tra loro secondo rapporti differenti, dando
origine a due o più composti differenti, sebbene costituiti dagli stessi elementi. Per esempio,
quando il carbone brucia e si combina con l’ossigeno dell’aria in un ambiente chiuso, si produce
un gas molto velenoso, il monossido di carbonio (CO); se invece il carbone brucia all’aria
aperta, si forma un gas con caratteristiche diverse, il diossido di carbonio detto anche anidride
carbonica (CO2). Analogamente esistono diversi ossidi di ferro (FeO, Fe2O3), rame e così via.
In base a queste osservazioni, Dalton enunciò una regola generale che estende il campo di
applicazione della legge di Proust a tutti i composti; essa è nota come legge di Dalton o
legge delle proporzioni multiple:
“Le masse di un dato elemento, che si combinano con la stessa quantità di un altro elemento
per dare origine a composti diversi, stanno tra loro in un rapporto che è espresso da numeri
interi, generalmente piccoli.”
Negli esempi precedenti abbiamo per CO ed FeO che O/C ed O/Fe è uguale ad 1; per CO 2 O/C
è uguale a 2. Nel caso di Fe 2O3 il rapporto O/Fe è uguale ad 1,5 ma essendo gli atomi
indivisibili si dovranno moltiplicare per 2 entrambi i coefficienti.
Da ciò deriva la possibilità di rappresentare la molecola di un composto con una formula
chimica, oppure mediante un modello a sferette in cui ogni sferetta rappresenta un atomo.
Una formula chimica è la rappresentazione schematica della composizione qualitativa e
quantitativa di un composto chimico. Nelle formule chimiche gli elementi contenuti nella
molecola sono indicati con i loro simboli, affiancati da un numero, in basso a destra, che
esprime il numero degli atomi di quell’elemento presenti nella molecola del composto. Queste
formule sono anche dette formule brute, grezze o molecolari in quanto non danno
informazioni sulla reale disposizione degli atomi nel composto.
Il modello atomico di Thomson
Se un gas è posto in un tubo di vetro sigillato tra due placche conduttrici
(anodo e catodo) e tra esse viene applicata una differenza di potenziale
elettrico sufficientemente alta, si osserva un passaggio di corrente elettrica tra
le due placche metalliche (analogamente alla scarica elettrica di un fulmine
attraverso l’aria).
Il fisico britannico Joseph John Thomson (Cheetham, 18 dicembre 1856 –
Cambridge, 30 agosto 1940) condusse una serie di esperimenti volti a capire
da dove si originasse la corrente elettrica osservata e le proprietà delle entità
che la trasportavano da un punto all’altro dello spazio. Egli osservò che i
misteriosi trasportatori della carica, chiamati raggi catodici, viaggiavano
secondo traiettorie rettilinee e producevano un punto luminoso dove urtavano nel tubo di
vetro. I raggi catodici venivano deviati sia da forze elettriche (erano allontanate da una placca
carica negativamente ed attratte da una carica positivamente) che magnetiche ed erano in
grado di scaldare, fino all’incandescenza, un foglio di metallo contro cui venivano “sparate”. In
base a tali evidenze sperimentali Thompson concluse che i raggi catodici erano dovuti ad un
flusso di cariche negative, provenienti dall’interno degli atomi di metallo, che furono chiamate
elettroni.
Questi esperimenti fornirono la prima prova del fatto che gli atomi sono costituiti da particelle
più piccole. Da ciò egli propose un nuovo modello atomico, formulato nel 1898, in cui si
ammetteva che l'atomo, piuttosto che la sferetta solida e compatta ipotizzata da Dalton,
fosse un aggregato di particelle più semplici. Alla luce dei pochi dati sperimentali in suo
possesso, J.J.Thomson ipotizzò che l'atomo fosse costituito da una sfera omogenea
carica positivamente in
cui gli elettroni erano
distribuiti in maniera
uniforme e senza una
disposizione
spaziale
particolare (come gli
acini di uvetta in un
panettone). Tale modello
è conosciuto anche come
“modello a panettone”.
Il modello atomico di Rutherford
Nel 1899 lo scienziato neozelandese Ernest Rutherford (Brightwater, 30
agosto 1871 – Cambridge, 19 ottobre 1937) scoprì che l’uranio emetteva
particelle veloci con carica positiva, che chiamò particelle alfa.
Un decennio più tardi, egli chiese ad un suo studente, Ernest Marsden, di
studiare che cosa accadeva quando queste particelle venivano utilizzate per
bombardare una sottile lamina d’oro; uno schermo rivelatore indicava poi i
punti di arrivo della particelle alfa, permettendo quindi di stabilirne la
traiettoria dopo il passaggio attraverso la lamina.
Se fosse stato valido il modello di Thomson, cioè se l'atomo avesse avuto una struttura
omogenea, la particelle alfa avrebbero dovuto comportarsi tutte nello stesso modo, perché in
qualunque punto avessero colpito la lamina metallica avrebbero trovato situazioni equivalenti.
In realtà, le particelle alfa si comportarono in modo diverso: per la maggior parte passarono
senza subire nessuna deviazione, ma alcune vennero deviate secondo vari angoli e alcune
vennero addirittura respinte. In base a questi dati Rutherford ipotizzò che:
Poiché le particelle α nella maggior parte dei
casi oltrepassavano la lamina d'oro senza
subire deviazioni, significava che
non
incontravano alcun ostacolo sul proprio
cammino e che quindi, l'atomo doveva
essere formato prevalentemente da
spazio vuoto.
Poiché in qualche caso le particelle α venivano
deviate ed in rarissimi casi venivano riflesse,
l'intera
carica
positiva
(protoni)
dell'atomo doveva essere concentrata in
un "nocciolo" piccolissimo e centrale: il
nucleo.
Gli elettroni negativi dovevano muoversi
lungo orbite circolari. Il diametro del
nucleo doveva essere molto più piccolo
del diametro dell'atomo.
Questo modello atomico è detto “modello
planetario”, poiché ricorda, in miniatura, il
Sistema Solare in cui il sole rappresenta il
nucleo dell'atomo e i pianeti gli elettroni, che si muovono, lungo le proprie
orbite attorno al sole (nucleo dell'atomo).
Anche se geniale, il modello atomico di Rutherford non teneva conto di un
importantissimo dato sperimentale della fisica: una particella in
movimento elettricamente carica perde incessantemente energia. Poiché
ciò deve valere anche per l'elettrone (carico negativamente), esso
perdendo via via energia avrebbe finito per muoversi lungo orbite sempre
più piccole, fino a cadere sul nucleo.
Il modello atomico di Bohr
Niels Bohr (Copenaghen, 7 ottobre 1885 – Copenaghen, 18 novembre
1962), un fisico danese che lavorò con Rutherford alla comprensione della
struttura atomica, partendo dal precedente modello planetario, concentrò i
suoi studi sugli elettroni cercando di fornire una descrizione di come essi si
disponevano intorno al nucleo, senza però contraddire le leggi della fisica.
Egli esaminò le emissioni elettromagnetiche dell'atomo di idrogeno quando
stimolato chimicamente, notando che l'idrogeno emetteva una serie
particolare e ben definita di onde luminose. Studiando il valore energetico
delle emissioni si accorse che queste erano "quantizzate" (cioè la quantità di
energia emessa assumeva valori ben definiti), esattamente come descritto da Planck nei suoi
lavori. Poiché tali variazioni energetiche venivano attribuite ai cambiamenti di energia degli
elettroni, significava che gli elettroni potevano presentare solo "livelli di energia" ben definiti.
Da questo Bohr dedusse che l'atomo di idrogeno poteva avere solo orbite ben definite, alle
quali attribuire un particolare livello energetico.
Secondo la sua teoria, fornendo sufficiente energia all'elettrone (uno o più quanti di energia),
esso può saltare verso una orbita superiore assorbendo l'energia ricevuta, per poi ritornare
dopo un certo tempo alla sua orbita originaria, rilasciando però l'energia assorbita
precedentemente, sotto forma di onda elettromagnetica (in questo caso luce, quanti di luce).
A seguito dei suoi studi Bohr presentò nel 1913, al Consiglio Solvay, la sua teoria
quantistica dell'atomo che si rifaceva al modello atomico di Rutherford, ma con alcune
modifiche essenziali:
L' atomo consiste in un nucleo di carica positiva
intorno al quale ruotano gli elettroni di carica
negativa che percorrono orbite stazionarie, non
equidistanti da esso. L'elettrone non può ruotare
su orbite qualsiasi ma su orbite fisse privilegiate,
corrispondenti ai vari livelli di energia; ci sono
infiniti livelli possibili.
Se l'elettrone persiste nel ruotare su queste orbite
privilegiate non emette energia nonostante la sua
accelerazione e la frequenza di rotazione.
L'elettrone può saltare spontaneamente, oppure in
seguito ad assorbimento di energia, da un livello
energetico all'altro.
La frequenza della radiazione emessa o assorbita
nel salto è legata al "quanto" di energia dalla
formula:
E = h
dove “h” è la costante di Planck (6,626176 10-34
Js) e “” è la frequenza della radiazione emessa o
assorbita.
Le
proprietà
chimiche
dell'atomo
sono
determinate dal numero di elettroni che occupano
il livello energetico più esterno.
Da questo momento in poi il modello atomico inizia ad essere modificato e completato secondo
la nascente meccanica quantistica.
La scoperta del neutrone avvenne nel 1932 per opera del fisico inglese Sir
James Chadwick (Bollington, 20 ottobre 1891 – Cambridge, 24 luglio
1974). Essa rappresentò un passo molto importante nello studio dei nuclei
atomici. Chadwick bombardando sottili lamine di berillio (Be) con particelle α
emesse dal polonio (Po), scoprì che dal berillio venivano emesse delle
radiazioni secondarie che non risentivano né di un campo elettrico né di un
campo magnetico. Ripetendo l'esperimento su molti altri materiali, dimostrò
che tali raggi erano costituiti da particelle aventi tutti la stessa massa,
indipendentemente dal materiale usato, ma prive di carica elettrica e,
pertanto, dette neutroni.
Il modello della nuvola elettronica
Come i modelli precedenti, anche il modello di Bohr è stato modificato grazie a scoperte
scientifiche successive. Bohr nel suo modello, aveva introdotto l'ipotesi della quantizzazione,
ma per il resto aveva trattato l'elettrone come una particella classica, che si muove su orbite
ben determinate, stazionarie, il cui raggio può essere calcolato in base a semplici
considerazioni meccaniche sulle forze in gioco.
La fisica classica è in grado di descrivere la realtà solamente ad un livello approssimato. Tale
approssimazione è impercettibile quando le dimensioni dei sistemi descritti sono ordinarie,
cioè, macroscopiche, ma diventa inaccettabile quando si cerca di descrivere sistemi aventi
dimensioni atomiche o subatomiche. Questo è il motivo per cui la limitatezza delle leggi della
fisica classica è emersa solo in tempi relativamente recenti, dopo che le tecniche sperimentali
si sono evolute al punto da consentire lo studio di sistemi microscopici, come gli atomi e le
molecole. In seguito alle fondamentali scoperte avvenute negli ultimi cento anni, la meccanica
classica ha lasciato il posto alla meccanica quantistica (vedi scheda di approfondimento).
La meccanica quantistica si distingue in maniera radicale dalla meccanica classica in
quanto si limita a esprimere la probabilità di ottenere un dato risultato a partire da
una certa misurazione, rinunciando così al determinismo assoluto proprio della fisica
precedente. Questa condizione di incertezza o indeterminazione non è dovuta ad una
conoscenza incompleta, da parte dello sperimentatore, dello stato in cui si trova il
sistema fisico osservato, ma è da considerarsi una caratteristica intrinseca, del
sistema e del mondo subatomico in generale.
Oggi gli scienziati sanno che gli elettroni non si comportano come le
cose che ci sono familiari nel nostro mondo macroscopico e che quando
devono prevedere la posizione ed il movimento di un elettrone
possono farlo solo in termini probabilistici.
Gli scienziati, infatti, per descrivere quali sono le posizioni più probabili in
cui si può trovare un elettrone che si muove intorno ad un nucleo,
utilizzano il modello della nuvola elettronica, secondo il quale gli
elettroni non si muovono lungo orbite lineari e stazionarie ma, tale
concetto deve essere sostituito con quello di distribuzione
(stazionaria) di probabilità: un elettrone si può, cioè, trovare con una determinata
probabilità in ogni punto attorno al nucleo e le zone dello spazio dove la probabilità è
maggiore corrispondono alle orbite; la descrizione matematica di tali distribuzioni spaziali
è fornita da equazioni matematiche molto complesse (equazione di Schrödinger) definite
funzioni d’onda.
La nuvola elettronica, che circonda il nucleo di un atomo,
rappresenta l’insieme degli orbitali di quell’atomo, dove per
orbitale si intende uno spazio, caratterizzato da forma
ed energia caratteristiche, all’interno del quale è
massima la probabilità di trovarvi l’elettrone.
Gli elettroni non si sistemano casualmente nei livelli
energetici e negli orbitali poiché ogni livello energetico
ha un determinato numero di orbitali. Ogni livello
energetico è identificato da un numero intero positivo,
detto numero quantico principale “n”, che assume
valori positivi 1, 2, 3, 4, ...
Il valore di n = 1 corrisponde al livello più interno, ad energia più bassa, che è il livello
fondamentale. All’aumentare del valore di n aumenta l’energia che l’elettrone deve avere per
rimanere nel corrispondente livello.
Ciascun livello energetico può essere ulteriormente suddiviso in diversi sottolivelli,
caratterizzati da orbitali di diverse forme e valori di energia; tali orbitali vengono
indicati con le lettere s, p, d, f, ...
Quelli di tipo s hanno simmetria sferica intorno al nucleo atomico e per ogni livello energetico
ne esiste solo uno; quelli di tipo p, sono tre per ogni livello energetico, si presentano con due
lobi (uno positivo ed uno negativo) e possono avere gli assi di simmetria in tre direzioni tra
loro ortogonali, per cui vengono indicati come orbitali di tipo p x, py, pz; quelli di tipo d sono
cinque e quelli di tipo f sette.
Per quanto riguarda la distribuzione degli
elettroni negli orbitali, valgono tre regole
fondamentali:
Principio di esclusione di Pauli: ogni
orbitale può contenere al massimo due
elettroni; poiché gli elettroni ruotano sul loro
asse,
all’interno
dell’orbitale
essi
si
dispongono in maniera tale da ruotare uno in
un verso e l’altro in quello opposto.
Principio dell’aufbau: gli elettroni tendono
ad occupare gli orbitali liberi riempiendoli con
un
elettrone
alla
volta,
cominciando
dall’orbitale a più bassa energia.
Regola di Hund: quando sono liberi più
orbitali a parità di energia, gli elettroni, a
causa della repulsione elettrostatica, si
dispongono il più lontano possibile l’uno
dall’altro, in maniera tale che in ogni orbitale
dello stesso livello energetico sia presente un
solo elettrone; in queste condizioni gli
elettroni tendono a disporsi con lo stesso
verso di rotazione. Solo quando in ogni
orbitale dello stesso livello energetico sarà
presente un elettrone i rimanenti inizieranno a
saturare gli orbitali, partendo sempre da
quello a più bassa energia.
e non
La configurazione elettronica di un elemento
esprime il modo in cui gli elettroni di quell’elemento si dispongono nei suoi orbitali. Essa si
ottiene indicando tutti i suoi orbitali e rispettando le regole descritte sopra. Per rappresentare
un singolo orbitale, si deve indicare prima il livello energetico, cioè il numero quantico n, poi il
tipo di sottolivello al quale appartiene (s, p, d, f, ...) ed infine quanti elettroni (uno o due)
l’orbitale contiene.
Il guscio elettronico più esterno (caratterizzato dal massimo valore di n per un certo atomo)
viene detto guscio di valenza ed i suoi elettroni, elettroni di valenza. Gli elettroni dei gusci
più interni sono in media più vicini al nucleo ed hanno energie più basse degli elettroni di
valenza; essi vengono definiti elettroni
interni o di core. Un atomo a guscio
chiuso presenta il guscio più esterno
completamente pieno di elettroni, per
cui ogni eccitazione richiede una grande
quantità di energia; conseguentemente,
tali atomi risultano molto stabili (es. i
gas nobili). Come si può notare
dall’immagine
accanto,
nella
configurazione
elettronica
dei
vari
elementi, gli elettroni interni vengono
rappresentati con il simbolo del gas
nobile del periodo precedente.
La configurazione elettronica più stabile
è quella in cui gli elettroni si sistemano
negli orbitali a più bassa energia.
Quando tutti gli elettroni di un atomo
hanno la più bassa energia possibile, si
dice che l’atomo è nel suo stato
fondamentale.
Se
un
atomo,
nel
suo
stato
fondamentale, assorbe una quantità di
energia sufficiente (E = h), uno dei
suoi elettroni può spostarsi verso un
orbitale di un livello energetico ad
energia più alta e la configurazione
elettronica risultante è detta stato
eccitato. Uno stato eccitato è molto meno stabile di uno stato fondamentale e l’atomo tenderà
a ritornare nella condizione più stabile. Quando un elettrone passa da uno stato eccitato
ad un livello energetico più basso viene emessa energia ( E = h) sotto forma di
radiazione elettromagnetica.
Le proprietà chimiche degli atomi possono essere spiegate completamente dal
comportamento degli elettroni dello strato esterno, cioè di quello che ha un legame più
debole con il nucleo. Sono infatti gli elettroni di valenza che partecipano alla formazione
dei legami tra gli atomi di una molecola costituendo nuovi orbitali, definiti orbitali
molecolari, che interessano più nuclei anziché uno soltanto.
In ogni atomo il guscio di valenza non possiede mai più di otto elettroni; gli elementi
che ne hanno otto (ottetto completo) o eccezionalmente due (come nel caso dell’elio) sono i
cosiddetti gas nobili (elio, neon, argo, cripto, xeno, rado), i quali sono zerovalenti, ossia
reagiscono molto raramente.
Gli atomi degli altri elementi hanno sempre la tendenza ad assumere una struttura
elettronica analoga a quella dei gas nobili, cioè ad ospitare nel loro guscio più esterno
otto elettroni (“Regola dell’ottetto”); questo è possibile perché, in opportune condizioni,
gli atomi tendono a cedere o ad acquistare elettroni.
In seguito a questi movimenti di elettroni, l’equilibrio degli atomi coinvolti viene perturbato dal
momento che la carica elettrica positiva del nucleo resta invariata. Ciò può determinare la
polarizzazione degli atomi, ovvero la comparsa di una carica elettrica positiva o negativa su
di essi a seconda della loro capacità di attrarre gli elettroni coinvolti nel legame chimico. Al
limite, gli atomi possono trasformarsi in unità indipendenti, con carica (positiva o negativa)
pari a quella dell’elettrone o multipla di essa; queste nuove entità vengono definite ioni. Gli
ioni, a loro volta, possono essere distinti in anioni (se hanno acquistato elettroni e quindi sono
corichi negativamente) o cationi (se hanno perso elettroni e di conseguenza hanno una carica
positiva).
Nelle pagine precedenti abbiamo visto come, nel corso dei secoli, le conoscenze sulla struttura
dell’atomo siano divenute sempre più ampie e ci abbiano condotto al modello attualmente
riconosciuto e brevemente descritto all’inizio del capitolo. Alla luce di questo “viaggio nella
storia”, possiamo ora vedere e comprendere meglio quella che si ritiene essere la struttura
atomica. Sulla base delle informazioni a nostra disposizione, l’atomo, che in passato era visto
come la particella più piccola ed indivisibile, è oggi considerato come costituito da
particelle ancora più piccole. Queste sono di tre tipi:
i neutroni, dotati di massa ma privi di carica
elettrica;
i protoni, dotati di massa quasi uguale a quella dei
neutroni e di carica elettrica positiva;
gli elettroni, particelle di massa molto piccola (circa
1/1840 della massa dei protoni), con carica elettrica
uguale a quella dei protoni, ma di segno opposto,
quindi negativa.
Tra di essi solo gli elettroni, allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono considerate
particelle elementari (cioè non ulteriormente divisibili), mentre protoni e neutroni sono
composti da altre particelle elementari, i cosiddetti quark.
Il modello a cui facciamo riferimento vede l’atomo come costituito da un nucleo
centrale composto da protoni e neutroni, quindi elettricamente positivo, attorno al
quale si muovono, a determinate distanze e con una determinata energia, gli
elettroni.
Particella
Massa
(kg)
Carica elettrica
elementare
Carica elettrica
(C)
Neutrone
Protone
Elettrone
1,674954310-27
1,672648510-27
9,10953410-31
0
+1
-1
0
+ 1,602189210-19
- 1,602189210-19
Il diametro esterno dell’atomo ha dimensioni comprese tra 210-10 m e 510-12 m; privando
l’atomo dei suoi gusci di elettroni il diametro del nucleo risulta però di 10 -14 m soltanto. È
perciò evidente che considerare l’atomo come una sfera compatta non è corretto, anzi nel suo
complesso l’atomo è essenzialmente vuoto e soltanto il nucleo è relativamente
compatto. Poiché, però, la meccanica quantistica dimostra che gli elettroni non possono
distribuirsi a distanze qualsiasi rispetto al nucleo, ma devono assumere posizioni particolari e
rigidamente determinati, l’atomo può essere considerato, con un’approssimazione
sufficiente nella maggior parte dei fenomeni chimici e macroscopici, come una sfera
compatta.
Il numero di protoni presenti nel nucleo è importante perché determina le
caratteristiche chimiche dell’elemento al quale l’atomo appartiene e permette di
distinguere un elemento da un altro; esso viene definito numero atomico ed indicato con la
lettera Z. Gli atomi dello stesso elemento hanno tutti lo stesso numero atomico.
I neutroni sono presenti nel nucleo in quantità variabile, ma molto spesso in numero uguale a
quello dei protoni. Non avendo carica elettrica, i neutroni non influiscono sulle proprietà
elettriche dell’atomo e neppure sulla sua natura chimica, ma solo sulla sua massa.
Una seconda caratteristica degli atomi, oltre al numero atomico, è il numero di massa;
indicato con la lettera A, rappresenta il numero complessivo dei protoni e dei neutroni,
N, che costituiscono il nucleo di ogni determinato elemento (A = Z + N).
A causa della loro carica elettrica, i protoni dovrebbero respingersi, provocando l’esplosione del
nucleo, ma questo non avviene, perché neutroni e protoni sono saldamente legati da una forza
attrattiva molto intensa, la forza nucleare forte. Essa agisce solo a brevissima distanza,
quindi la sua azione si sente solo all’interno del nucleo e non riguarda gli elettroni che si
trovano nella parte periferica dell’atomo. A differenza di neutroni e protoni, gli elettroni sono
molto più liberi di muoversi, essendo trattenuti da una forza più debole che li attira verso il
nucleo, la forza elettrostatica.
In condizioni normali, ogni atomo ha una specifica massa atomica,
quindi si può stabilire il numero di neutroni che esso contiene.
Esistono, tuttavia, anche atomi dello stesso elemento, quindi
caratterizzati dallo stesso numero di protoni, che però hanno un
diverso numero di neutroni e, conseguentemente, un diverso
numero di massa; essi sono chiamati isotopi.
Per distinguere i vari isotopi (detti anche neuclidi) si è soliti indicare
ogni elemento con il suo simbolo, scrivendo accanto al simbolo, in
basso a sinistra il numero atomico ed in alto a sinistra il numero di
massa. Ad esempio, per l’idrogeno abbiamo: 11H (prozio 99,98%), 21H (deuterio), 31H (trizio).
Ciascun elemento, in natura, è costituito da una miscela di isotopi (di cui quello predominante
è l’isotopo rappresentativo inserito nella tavola periodica) in percentuale sempre costante. Il
carbonio naturale contiene il 98,892% di 12C e l’1,108% di 13C in massa; in aggiunta a questi
isotopi stabili, esiste un isotopo radioattivo ( 14C o radiocarbonio) e quindi, instabile, presente in
piccolissime percentuali; quest’ultimo viene impiegato nella datazione dei reperti archeologici.
Se un elemento è costituito da n isotopi in cui lo imo isotopo ha massa Ai ed una percentuale in
atomi pi, allora la massa atomica media, detta anche peso atomico, dell’elemento è data da:
A = A1p1 + A2p2 + ... + Anpn
Le masse degli atomi misurate in kilogrammi o in grammi sono valori molto piccoli. Non è
conveniente, da un punto di vista pratico usare numeri così piccoli. È più conveniente infatti
usare masse atomiche relative (o pesi atomici relativi), cioè masse atomiche che sono
rapportate ad una grandezza di riferimento. Nel 1961, con un accordo internazionale, si decise
di usare come riferimento la massa del 12C. le masse atomiche relative non hanno unità di
misura essendo esse rapporti di due masse. La massa molecolare relativa di un composto è
data dalla somma delle masse atomiche relative degli elementi costitutivi moltiplicate per il
numero di atomi dell’elemento presenti nella molecola.
L’unità di massa atomica (che abbrevieremo in u) viene definita come 1/12 esatto della
massa del 12C.
Il numero di Avogadro (N0) è definito come il numero di particelle contenute esattamente in
12 g dell’isotopo 12C. Attualmente gli si attribuisce il valore di N0 = 6,0220451023 ma potrebbe
essere modificato a seguito di nuove evidenze sperimentali.
Pertanto, la massa di un singolo atomo di 12C viene ricavata dividendo 12 g per N0, ottenendo
un valore pari a 1,992648·10-26 kg.
Per misurare la quantità di sostanza è utile raggruppare gli atomi e le molecole in unità,
multipli e sottomultipli di N0; questa unità è la mole (dal latino moles, quantità). Una mole di
sostanza è la quantità di materia contenuta in un numero di Avogadro di particelle, la
cui tipologia deve essere sempre specificata. Per esempio, dire una mole di ossigeno è
ambiguo, si deve dire o una mole di atomi di ossigeno oppure una mole di molecole di
ossigeno.
La massa, in grammi, di N0 atomi di ogni elemento, cioè la sua massa molare, è
numericamente uguale alla sua massa atomica relativa, adimensionale, e la stessa cosa vale
per le molecole.
Da ciò deriva che per calcolare il numero di moli di una certa sostanza è sufficiente dividere il
valore della sua massa per la sua massa molare. Ad esempio, il numero di moli contenuto in un
campione di ferro di 8,232 g è dato da:
n° di moli di ferro = grammi di ferro/massa molare del ferro = 8,232 g/55,847 g mol -1 = 0,1474 mol