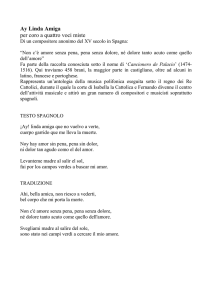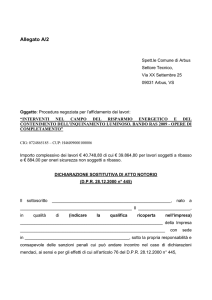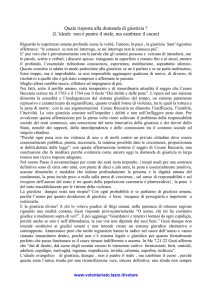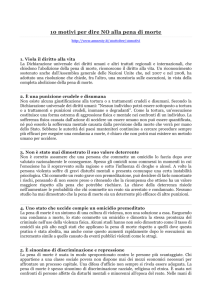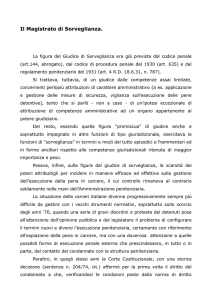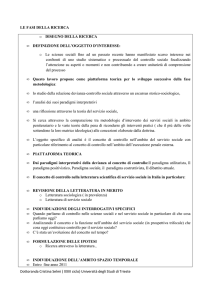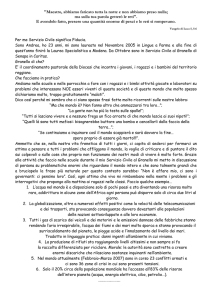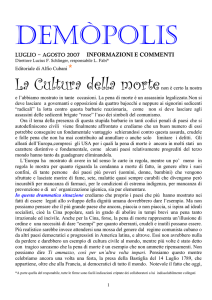Magistratura di Sorveglianza: problemi attuali e
prospettive
Sommario: 1. Premessa. 2. Il problema del concorso di pene. 3. (segue) Il cumulo materiale. 4.
(segue) Il reato continuato. 5. Sospensione della esecuzione della pena prima della esecuzione e
Magistratura di Sorveglianza. 6. Il differimento della esecuzione della pena. 7. Misure alternative.
Affidamento in prova e detenzione domiciliare generica. 8 (segue). Le prescrizioni dell'affidamento
in prova. Le prescrizioni tipiche. 9. (segue) Le prescrizioni atipiche e il principio di legalità e
tassatività. 10. L'esito dell'affidamento in prova. La revoca. 11. (segue) La dichiarazione di
cessazione della misura, la declaratoria di estinzione o non estinzione, le pronunce di
annullamento. 12. La liberazione anticipata. 13. Le misure di sicurezza. 14. Magistratura di
sorveglianza e tutela dei diritti dei soggetti ad esecuzione di pena. 15. (segue) la tutela
semplificata. 16. (segue) La sentenza 26/1999 C.Cost. e le posizioni giuridiche tutelabili. 17.
(segue) il procedimento applicabile. 18. (segue) l’effettività della tutela. 19. La sospensione delle
ordinarie regole di trattamento ex art. 41 bis O.P. La prova della permanenza dei collegamenti con
la criminalità organizzata.
1. Premessa.
Nell'ambito del corpo della Magistratura, quella di Sorveglianza è indubbiamente quella che
mostra la maggior vitalità e tasso di innovazione dell'arco degli ultimi decenni.
Ciò non tanto per l'entità quantitativa di riforme che hanno investito il relativo settore, non
superiore certo a quelle che hanno riguardato altri campi quali il processo penale o, in minor misura,
quello civile, ma per la profonda rivisitazione del senso della relativa funzione.
Senza addentrarsi in troppi particolari e solo a livello di descrizione generale del fenomeno, è
sufficiente rilevare come, schematicamente, il Magistrato di Sorveglianza sia nato, storicamente,
come Garante dei diritti delle persone sottoposte a pena, in uno scenario ove l'esecuzione
concerneva, in buona sostanza, l'esecuzione della pena del carcere.
Il sistema si è profondamente modificato fino ad affiancare alla funzione di tutela dei diritti
quella che, ormai preminente, è la funzione della Magistratura di Sorveglianza come giudice della
pericolosità sociale. Il giudice che determina l'effettivo trattamento penale che dovrà essere
applicato al condannato, in considerazione della sua pericolosità sociale.
Le direttrici della modifica sono essenzialmente due.
La prima, rilevante sul piano tecnico giuridico, è la progressiva erosione delle funzioni
collegiali, a vantaggio di quelle monocratiche.1
La seconda, rilevantissima in generale, è la decarcerizzazione del sistema, tale che attualmente,
il sistema penale non ha più la sua pietra angolare nell'istituto penitenziario, ma nelle misure (ma
sarebbe ormai meglio dire pene) alternative. Le sanzioni penali eseguite fuori dal carcere sono
ormai la assoluta maggioranza.
Si impone qualche precisazione.
1
Simboleggiata dallo spostamento delle decisioni in tema di liberazione anticipata dal Tribunale al Magistrato,
dalla introduzione di poteri cautelari e anticipatori, dalla attribuzione di tutte le nuove funzioni inerenti la esecuzione
(esempio, espulsione, visti sulla corrispondenza, ecc.) all'organo monocratico.
Di misure alternative si può in effetti, parlare in almeno due accezioni distinte. La prima, più
ristretta, è quella di sanzioni penali, applicate dopo che il giudice della cognizione abbia inflitto la
pena detentiva, in luogo di tutto o parte di essa, e che non implichi neppure un parziale contatto con
il carcere. La seconda, prescinde dalle due limitazioni appena dette, comprendendo, da un lato,
anche sanzioni diverse dalla detenzione inflitte fin dal giudice della cognizione e, dall’altro, anche
sanzioni che comprendano il contatto parziale con il carcere. Nella prima accezione, si intendono,
restrittivamente, l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la liberazione
condizionale. Nella seconda, il campo di attenzione si allarga fino a comprendere la semilibertà, ma
anche le sanzioni sostitutive della semidetenzione, libertà controllata, permanenza domiciliare et
similia.
A ben vedere, nell’economia del discorso odierno, tale distinzione è importante per la chiarezza
concettuale, ma non decisiva, e possiamo, quindi, tranquillamente ritenere il discorso, almeno a
livello introduttivo generale, esteso a tutto il ventaglio di sanzioni diverse dalla mera detenzione in
carcere, salvo qualche riferimento, specifico, alla materia delle misure alternative in senso stretto.
Semmai, il problema è che non tutte le sanzioni diverse dal carcere sono amministrate dal
Magistrato di Sorveglianza: né la distinzione passa per il soggetto che applica tali sanzioni: ce ne
sono di applicate dal giudice della cognizione che sono amministrate dal magistrato di sorveglianza
(le sanzioni sostitutive della libertà controllata e della semidetenzione) e altre che non lo sono (ad
esempio, quelle inflitte dal Giudice di Pace).
Posta questa prima premessa, per così dire qualitativa, è il caso di svolgerne una di tipo
quantitativo, relativa, cioè, alla dimensione, giuridica e sociologica del fenomeno di cui trattiamo.
Dal punto di vista giuridico, si può osservare che si tratta di un vero e proprio sottosistema, la cui
complessità, a partire dal 1975 e per giungere ad oggi, si è andata costantemente ampliando. Anche
solo limitandosi a considerare le misure alternative in senso stretto, basti osservare che esistono
almeno tre tipi di affidamento in prova (ordinario, affidamento per persone malate di AIDS,
affidamento terapeutico2), due tipi di liberazione condizionale (ordinaria e per collaboratori di
giustizia3), addirittura otto tipi di detenzione domiciliare (i quattro tipi previsti dall’art. 47 ter O.P.:
per ultrasettantenni delinquenti primari, ordinaria, c.d. generica, c.d. umanitaria;4 la detenzione
domiciliare per malati di AIDS,5 la detenzione domiciliare speciale per le detenute madri e la
detenzione domiciliare speciale c.d. di prosecuzione;6 la detenzione domiciliare per i collaboratori
di giustizia7). Non solo, ma, allargando il discorso, non è più nemmeno possibile parlare di una
unica pena detentiva in carcere, visto che, almeno, devono distinguersi dalla carcerazione ordinaria
il regime del c.d. carcere duro di cui all’art. 41 bis O.P. e, all’altro estremo di una ipotetica “scala di
durezza”, la custodia attenuata per persone con problemi di tossicodipendenza.
Si tratta, insomma, di uno strumentario giuridico che, già da queste semplici considerazioni,
mostra tutta la sua imponenza.
2
Rispettivamente, art. 47 e 47 quater Ordinamento Penitenziario, art. 94 d.p.r. 309/1990.
3
Rispettivamente, art. 176 c.p. e 16 nonies L. 45/2001.
4
Rispettivamente, i commi 01, 1, 1 bis e 1 ter dell’art. 47 ter O.P.
5
Art. 47 quater O.P.
6
Art. 47 quinquies O.P.
7
Art. 16 nonies l. 45/2001.
E tale rilevanza non viene certo meno, se si consideri il fenomeno dal lato, per così dire,
sociologico. E’ sufficiente l’esposizione di un dato numerico. A decorrere dall’anno 2000,8 sono più
numerose le persone che espiano la pena fuori dal carcere, che non quelle che la espiano all’interno
del carcere. E tale tendenza è in via di costante consolidamento.
Tale dato, che stupisce persino gli addetti ai lavori, concerne non centinaia, non migliaia di
persone, ma decine di migliaia di condannati in tutta Italia.
Per esprimere lo stesso concetto in altro modo, ciò significa che oltre il 60% delle condanne
penali passa al vaglio del Tribunale di Sorveglianza per la eventuale concessione di misure
alternative (in senso stretto), prima ancora dell'inizio della esecuzione.
Praticamente la totalità delle condanne a pena detentiva non sospesa condizionalmente, poi, se
non altro per la liberazione anticipata o la concessione di forme di graduzione della pena, viene
trattata dalla Magistratura di Sorveglianza.
Si può pertanto senza alcuna possibilità di smentita che la magistratura di sorveglianza è il
cardine della esecuzione ed effettività della pena. Per quello che possono valere i nomi, si potrebbe
tranquillamente dire che essa, ben più che della sorveglianza, è il giudice della pena (o della
esecuzione penale, se ci si vuole riportare alla denominazione che tale funzione ha, ad esempio, in
Francia)
Non può che lasciare allora più che perplessi, stupefatti, il sostanziale cono d'ombra in cui le
funzioni di sorveglianza vengono lasciate.
Richiamata con la massima forza l'importanza dei temi che andremo a trattare e la conseguente
necessità di sensibilizzazione della cultura giuridica, si possono esaminare alcune questioni attuali.
Si privilegeranno le questioni strutturali e la rilevanza concreta delle questioni.
A livello di impostazione, si userà come falsariga la distinzione tra funzioni di giudizio della
pericolosità sociale e tutela dei diritti.
2. Il problema del concorso di pene
Un tipico problema strutturale che affligge il diritto della esecuzione penale è correlato alla
concorrenza di più titoli esecutivi. Tale problema è la conseguenza di due premesse. La prima è che,
dagli anni '80, la legislazione ha abbandonato l'impostazione per così dire classica del diritto
penitenziario. Secondo tale concezione, deve esistere un unico regime penitenziario legale e la
unica variabile, a livello normativo deve essere quella quantitativa: il trattamento penitenziario si
determina in durata della pena. Determinata dal giudice della cognizione l'entità di questa, non
esiste alcuna categoria particolare di condanne: i condannati si distinguono solo per la durata della
sanzione: per il resto, le uniche differenze sono quelle individuali. Detto in altre parole, a tutti si
applica lo stesso regime, l'unica differenza essendo il grado di rieducazione (e la pericolosità
residua, valutate singolarmente).
Questo sistema evidentemente non è stato ritenuto soddisfacente, posto che il legislatore, a
partire dalla disciplina c.d. “antimafia” degli anni '80, lo ha abbandonato, cominciando a introdurre
una serie di regole con un denominatore comune: distinguere tra tipologie di condannati, a seconda
del titolo di reato commesso. Si tratta di una rivoluzione copernicana per il diritto della esecuzione
penale: la discriminazione qualitativa (la cui norma principe è l'art. 4 bis O.P.) è ormai un cardine
del diritto penitenziario moderno: ormai non esiste un solo regime penitenziario, da adattare al
singolo, ma un complesso sottosistema di regimi penitenziari, che dipendono dal reato commesso.
8
Fonte: statistiche Ufficiali Ministero della Giustizia, reperibili sul relativo sito web, alla url www.giustizia.it.
Un altro dato strutturale che va sottolineato è che, bisogna dirlo con chiarezza, tale rivoluzione
normativa è la evidente risposta alla insoddisfazione per la resa del regime precedente. Tale regime
si ritenne non adeguato a garantire le esigenze di sicurezza contro la criminalità più allarmante.
Poiché in realtà il regime previgente non imponeva (ma consentiva soltanto) margini più ampi di
quello attuale, quanto all'accesso a misure alternative, rimettendosi la valutazione, caso per caso,
alla discrezionalità della Magistratura di Sorveglianza, deve sottolinearsi che tale intervento è, a ben
vedere, una reazione a un esercizio della discrezionalità della Magistratura di Sorveglianza che il
legislatore valutò negativamente. Anche sotto questo aspetto, tale vicenda è istruttiva, posto che è
anche essa un dato che si è avviato a diventare strutturale.9
Ciò ha comportato che la stessa persona può essere considerata particolarmente pericolosa
rispetto a certi fatti e ordinariamente pericolosa rispetto ad altri. Il legislatore, il cui livello di
elaborazione è, per la materia penitenziaria, talvolta lontano dalla conoscenza della consistenza dei
problemi reali, non ha, in buona sostanza, calcolato che lo stesso soggetto non solo può trovarsi a
subire, in tempi diversi, pene per reati diversi, ma anche trovarsi a subirle in un unico torno di
tempo.
Ciò ha determinato uno dei problemi più ricorrenti del diritto penitenziario: quello del cumulo
di pene. Il problema non esisterebbe, è ovvio, se le pene avessero tutte il medesimo regime
penitenziario, ma esiste ed è complesso quando, come nell'ordinamento attuale, siano previste
differenze.
Esemplificando, un soggetto può trovarsi ad espiare un cumulo di pene in cui rientra: a) una
pena per un delitto del c.d. Primo gruppo dell'art. 4 bis; b) una pena per un delitto compreso nel c.d.
Secondo gruppo; c) una pena su cui è stata riconosciuta la recidiva art. 99 comma 4 c.p.; d) una
pena, per così dire, normale.
Uno dei problemi più complessi del diritto penitenziario è regolare tali casi.
Mancando la disciplina normativa, la soluzione non può che desumersi dai principi generali.
In primo luogo, va individuato il fondamento razionale del sistema. Esso è, evidentemente una
presunzione assoluta di maggior pericolosità sociale dell'autore dei reati che il legislatore individua
come oggetto di una disciplina penitenziaria restrittiva. Tale presunzione assoluta ha come
contenuto l'imporre una maggior durata10 o l'indefettibilità del trattamento penitenziario,11 in
assenza di certe circostanze.12 La durata obbligatoria del trattamento in carcere viene tarata sulla
pena per il reato ostativo.
La applicazione di tale sistema è evidentemente complessa quando siano in esecuzione
concorrente pene disciplinate diversamente.
Vale subito la pena di osservare che il diritto penale prevede, come noto, due diverse forme di
cumulo delle pene. La semplice somma aritmetica (cosiddetto cumulo materiale), ovvero un regime
9
Per rimanere nell'ambito della esecuzione penale, si pensi alla ratio di molte norme della legge c.d. Ex Cirielli:
la discriminazione quantitativa dei recidivi ben avrebbe potuto (e forse dovuto) farsi nell'ambito della discrezionalità
giudiziaria: il legislatore è verosimilmente intervenuto per correggere quella che ha valutato come un'inadeguatezza
della giurisdizione.
10
Il senso delle norme che prevedono quote di pena maggiorate per certi reati (ad esempio l'espiazione di metà
pena invece che un quarto di pena per accedere ai permessi premio in caso di rapina aggravata) è proprio quello di
ritenere che il rapinatore non possa essere maturo per il permesso premio se non ha espiato metà della pena.
11
Ad esempio, per l'associazione a delinquere di stampo mafioso e i delitti del c.d. primo gruppo di cui all'art. 4
bis..
12
Tipicamente, l'aver collaborato con la giustizia.
legale (non aritmetico, c.d. cumulo giuridico). Esempio principale13 del secondo tipo è
evidentemente il reato continuato.
3. (segue) Il cumulo materiale
L'individuazione del regime penitenziario applicabile è relativamente semplice, sul piano
concettuale e poste le premesse di cui sopra, rispetto al c.d. cumulo materiale. Formalmente, l'art.
76 c.p. prevede che le pene cumulate si considerano pena unica: ciò in un primo momento creò
l'interrogativo: ma se è pena unica, è da considerarsi pena tutta ostativa o non ostativa ? Sia pure
progressivamente, si è fatta strada una interpretazione illuminata dalla ratio sopra detta: in tali casi
non può valere l'unificazione, per il semplice fatto che se essa valesse, il condannato che si vede le
pene cumulate si troverebbe irragionevolmente discriminato in senso favorevole (se la pena
cumulata si dovesse ritenere tutta non ostativa) o sfavorevole (se la pena cumulata si dovesse
ritenere tutta non ostativa, come in un primo tempo si ritenne), rispetto a quello che, a parità di reati
e condotta, semplicemente non si fosse visto cumulare le pene. In effetti la effettuazione del cumulo
dipende dalla attività del pubblico ministero e non dipende dalla condotta del condannato e il
diverso trattamento non avrebbe alcuna ragione d'essere. Ecco perchè è ormai risultato acquisito che
il cumulo (materiale) di pene deve essere “sciolto” ai fini del diritto penitenziario. Ciò significa che
le singole pene devono scorporate e che se per una è previsto un divieto di misura alternativa e per
l'altra una possibile ammissione, il condannato può essere ammesso a misura solo sulla seconda.
Il che determina alcuni problemi ulteriori.
Il primo è, tra le pene concorrenti, quale debba ritenersi espiata per prima. Il problema nasce
perché, in omaggio al principio della progressività del trattamento, si ritiene che prima debba
praticarsi il trattamento penitenziario e dopo, eventualmente, misure diverse. Se così non fosse il
problema non avrebbe ragion d'essere: se anche si ritenesse prima in esecuzione la pena non
ostativa potrebbe applicarsi la misura alternativa e, terminata questa, la carcerazione.
Sulla base della generica affermazione della preminenza del principio del favor rei, si dice che
dovrebbe ritenersi applicata per prima la pena per il delitto ostativo.14 Tale soluzione è convincente,
anche se tutto sommato è dubbio che il fondamento di essa sia il favor rei: si potrebbe anche
ragionare in un modo diverso: se il legislatore presume la necessità di un trattamento più pregnante
per i delitti più gravi, è il principio della progressione trattamentale e non un generico favor rei a
imporre la applicazione prima della pena ostativa.
Unico limite da ritenere applicabile è che non possa imputarsi a pena ostativa la carcerazione
patita prima del relativo delitto. Altrimenti si considererebbe come trattamento differenziato già
avvenuto una carcerazione avvenuta intervenuta addirittura prima che la stessa necessità di tale
trattamento fosse, per definizione, stabilita (ergo, prima del delitto che la determina). Lo schema è
simile a quello di cui all'art. 657 comma 4 c.p.p., in tema di fungibilità, richiamato ordinariamente a
sostegno di questa soluzione.15
13
Ma non unico,si pensi all'effetto della norma che limita a 30 anni il massimo delle pene detentive, salva
l'applicazione dell'ergastolo o il concorso formale di reati.
14
Il riferimento al favor rei è tradizionale nella giurisprudenza della Suprema Corte, ad esempio in Cass. Sez. I
12/12/200, Geria in Ced Cass. rv 226470
15
A ben vedere, peraltro, la norma del c.p.p., almeno nelle internzioni del legislatore originario, non era intesa a
disciplinare il profilo di cui al testo, ma la determinazione della pena da espiare ai fini dell'ordine di esecuzione. La sua
formulazione, avulsa dal contesto degli altri commi, si presta peraltro a valere come principio generale, visto che si
riferisce genericamente alla determinazione della “pena da eseguire”.
Problema ulteriore è quello della imputazione di eventuali sconti e decurtazioni di pena. Se
interviene indulto o, più frequentemente, liberazione anticipata, a quale pena esse vanno imputate ?
Per l'indulto, che è un beneficio sganciato dalla effettiva espiazione di pena, può effettivamente
ritenersi di fondare una soluzione sul favor rei e quindi ritenere che esso estingua la pena ostativa.
Ciò. Ovviamente, a patto che tale pena rientri nella previsione del beneficio indulgenziale.16
Per la liberazione anticipata, che è uno sconto che si salda a una effettiva espiazione di pena, la
soluzione più lineare è imputarla con gli stessi criteri della pena cui accede: se la pena cui accede
può essere imputata al delitto ostativo, lo potrà essere anche la relativa liberazione anticipata.
4. (segue) Il reato continuato.
Un po' più complessa è invece la vicenda per il reato continuato.
In effetti, mentre l'unificazione effettuata nel provvedimento di cumulo del Pubblico Ministero
è un mero dato estrinseco, che criminologicamente non è evidentemente in grado di assumere alcun
rilievo, il delitto continuato presenta una unità ontologica e che a tale unità ontologica possa
corrispondere un unico regime penitenziario è ipotesi apparentemente meno peregrina.
Esemplificando, che l'autore di una rapina aggravata e, separatamente, di un delitto in materia di
armi da fuoco (reati in concorso materiale) esprima una capacità criminale diversa da chi si procura
un'arma per commettere una rapina (reato continuato) è un fatto innegabile: l'identico disegno
criminoso unifica le condotte sotto il profilo criminologico, il cumulo del P.M. no.
Ritenere tuttavia che in caso di continuazione tutta la pene debba essere considerata ostativa si è
peraltro ritenuto in contrasto con la ratio del reato continuato, che sarebbe quella di mitigare il
trattamento sanzionatorio.
La giurisprudenza è allora giunta ad affermare che anche la pena per il reato continuato va
“sciolta”.17
Nel caso in cui il delitto ostativo sia quello più grave la pena da considerarsi ostativa è quella
concretamente inflitta dal giudice, nel caso il reato ostativo sia stato ritenuto meno grave, pena
ostativa non si è ritenuta il solo aumento per la continuazione, ma il minimo edittale previsto dalla
legge per il delitto ostativo.18
In realtà, questa soluzione, per quanto consolidata, non si impone con forza di cogenza logica.
Che il reato continuato sia un criterio di temperamento della pena è senz'altro esatto, ma non è detto
che tale temperamento, che la legge prevede specificamente per il quantum della pena, debba
estendersi anche al quomodo di essa. Non sembra che vi sia incoerenza tra il prevedere una pena di
durata inferiore, in caso di continuazione, ma dal contenuto più pregnante. In effetti, dal punto di
16
Che potrebbe, invece, esplicitamente essere escluso per le pene per i reati più gravi. Allo stesso modo, occorre
ovviamente che la pena ostativa si riferisca a reati e condanne che rientrino nei limiti temporali dell'indulto.
17
18
Cass, SS. UU, 30 giugno 1999, Ronga in Ced Cass. RV. 214355. C. Cost. 27 luglio 1994, n. 361.
Cass. Sez. I, 11 febbraio 2000, Fusaro, in Ced Cass. RV. 215501Anche questa soluzione è razionale:
corrisponde all'idea che il trattamento penitenziario differenziato debba avere la durata minima stabilità in astratto dal
legislatore con la pena edittale. Si può notare, en passant, che non risulta ancora affrontato in modo consolidato il
problema della continuazione tra più delitti ostativi. Il problema non si pone ovviamente quando abbiano lo stesso
regime (entrambi del primo o secondo gruppo dell'articolo 4 bis o.p.), ma quando siano di categoria diversa. In realtà
sembra di potersi esportare la stessa soluzione di cui al testo: se quello del primo gruppo è quello ritenuto più grave dal
giudice della cognizione, la preclusione assoluta riguarderà la pena concretamente inflitta, se è stato ritenuto più lieve la
preclusione assoluta riguarderà la pena edittale minima. Nel caso concorrano anche delitti non ostativi occorrerà fare
ponderata applicazione di tutti i criteri appena esposti.
vista criminologico si potrebbe forse sostenere che il reato non ostativo commesso nel quadro di un
disegno volto a commettere un reato ostativo è anch'esso più grave del medesimo reato commesso
allo scopo di commetterne uno non ostativo.19
La giurisprudenza è comunque consolidata nel senso dello scioglimento del reato continuato e
ritiene applicabili anche in questi casi le regole sopra dette per il cumulo materiale.
5. Sospensione della esecuzione della pena prima della esecuzione e Magistratura di
Sorveglianza
Una ulteriore serie di questioni concerne poi la condizione del condannato nel momento in cui
giunge davanti alla Magistratura di Sorveglianza.
Ciò corrisponde alla grossolana distinzione tra il condannato “libero” e il condannato
“detenuto”. Ci sono infatti posizioni che vengono esaminate dalla Magistratura di Sorveglianza
prima dell'inizio della esecuzione e posizioni che vengono esaminate dopo.
La distinzione ha una enorme importanza sul piano sociologico, oltre che, ovviamente, sul
piano della condizione soggettiva del condannato (ed è quindi di grandissima importanza dal punto
di vista dell'attività dei difensori). Sotto il primo profilo è evidente che il periodo dell'attesa della
esecuzione è un periodo pericoloso: un soggetto gravato da un titolo esecutivo è privo di vincoli e
controlli: ciò costituisce una condizione che potenzialmente può indurre alla fuga e, d'altro canto,
trattandosi di condannato che ancora non ha subito trattamento rieducativo, è ragionevole pensare
che si tratti del principale serbatoio della recidiva. Queste però sono considerazioni di ordine
sociologico, rilevantissime dal punto di vista organizzativo generale, ma non corrispondenti a
problemi giuridici.20
Allo stesso modo, fuoriesce dai temi di interesse diretto della Magistratura di Sorveglianza,
tutto ciò che sta a monte del suo intervento, e quindi la eventuale sospensione della pena al
momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in attesa della decisione del
Tribunale di Sorveglianza. Il sistema si è sempre maggiormente articolato con le reiterate emende
dell'art. 656 c.p.p., che costituisce oramai una norma di notevole complessità concettuale, ma
fuoriesce completamente dalle competenze della Magistratura di Sorveglianza: il Tribunale esamina
le istanze di misure alternativa sia del soggetto libero (sospeso) sia di quello detenuto (non
sospeso), senza alcuna differenza né di rito né di merito e le questioni sulla doverosità o meno della
sospensione sono di compentenza non del Tribunale di Sorveglianza ma del Giudice della
Esecuzione.
La ripartizione delle competenze è chiara è agevole: al Pubblico Ministero spetta la decisione
sulla sospensione della esecuzione al momento del passaggio in giudicato della sentenza (o.
eventualmente. al momento della emissione di un provvedimento di cumulo di più sentenze). Una
volta che tale snodo sia completato, la palla passa al Magistrato di Sorveglianza.
Ci si può domandare se il Magistrato di Sorveglianza possa ancora impedire, nel caso si pena
non sospesa dal pubblico ministero, l'ingresso in carcere del condannato. Vale subito la pena di
19
Che ad esempio, il furto di un auto finalizzato a predisporre la fuga dopo una rapina sia più grave del
medesimo furto per assicurarsi la fuga dopo un danneggiamento. Per la contraria opinione si è tuttavia pronunciata C.
Cost. 27 luglio 1994, n. 361.
20
Dimostrano ad esempio come una tardiva trattazione dei relativi fascicoli possa determinare ricadute gravi in
termini di sicurezza dei cittadini e come un un investimento in tale settore, tutto sommato di poca entità rispetto a quelli
necessari rispetto alle strutture del giudizio di cognizione, potrebbe determinare notevolissimi aumenti di resa
complessiva del sistema.
osservare che rilevano qui non solo le sospensioni di pena in senso proprio, ma anche la
applicazione provvisoria di una misura alternativa (che per definizione esclude la carcerazione).
L'ingresso in carcere può essere certamente evitato ai sensi dell'art. 684 c.p.p., il problema è se
possa arrivarsi a tale conclusione anche in altre ipotesi.
Il problema ha una rilevanza concreta per il semplice motivo che i presupposti per l'adozione
del differimento provvisorio della pena ex art. 684 sono estremamente restrittivi (maternità,
malattia, istanza di grazia), e possono, ovviamente, sussistere ragioni diverse.
A tutta prima, la conclusione negativa sembra poter ben fondarsi su una coppia di argomenti. Il
primo è testuale: gli artt. 47, comma 4, 50 comma 6 O.P., 47 ter comma 1 quater, prevedono
rispettivamente che il Magistrato di Sorveglianza può può “sospendere l'esecuzione della pena e
ordinare la liberazione del condannato” (nei primi due casi: istanze di affidamento o semilibertà)
ovvero applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare se “l'istanza di applicazione della
detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena”. Le
espressioni “inizio della esecuzione della pena” e il riferimento, per l'affidamento e la semilibertà,
alla “liberazione” del condannato, fanno pensare a una applicazione della disciplina ai soli soggetti
già detenuti.
Il secondo argomento è sostanziale: il condannato, si direbbe, ha già avuto la possibilità di
ottenere la sospensione dal Pubblico Ministero, se non l'ha ottenuta o chiesta, imputet sibi.
Non ostante l'apparenza, potrebbero esserci anche ragioni per opinare il contrario. Sotto il
secondo profilo, è ben possibile che le condizioni per ottenere la sospensione della pena maturino
dopo il diniego di sospensione da parte del Pubblico Ministero e anche senza alcuna responsabilità
del condannato. Per fare qualche esempio, si pensi alla definizione solo successiva di un programma
terapeutico, magari già in atto ma non attestato nelle forme dovute, oppure all'intervento di
modifiche successive sulla entità della pena, tali da riportarla, ex post, nei limiti per una
sospensione prima non ottenibile. A corroborare l'interesse pratico della sospensione si osservi che
tra l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte del P. M. e la sua esecuzione, di fatto, possono
trascorrere anche anni.
Sul piano letterale, il riferimento all'”inizio della esecuzione della pena” potrebbe intendersi
riferito, non senza un certo sforzo, all'inizio della procedura di esecuzione, e il riferimento alla
“liberazione” inteso alla relativa eventualità, nel caso ordinario, ma senza esclusione della
possibilità contraria (sospensione prima della carcerazione).
Naturalmente, chi volesse ammettere tali istanze dovrebbe limitarle ai casi di a) sopravvenuta,
rispetto alla decisione del P.M., sussistenza dei presupposti per la sospensione; b) sopravvenienza
non dovuta a colpa del condannato (colpa che sussisterebbe nel caso di negligenza difensiva o
tardiva attivazione del condannato).
6. Il differimento della esecuzione della pena
Limitandosi ad alcune questioni tra le questioni controverse, in tema di differimento della pena
si può rilevare quanto segue.
In primo luogo, quanto all'ipotesi di differimento obbligatorio per malattia (art. 146 c.p.), è un
problema delicato stabilire se il requisito previsto dalla legge circa il fatto che la persona si trovi
“in una fase della malattia cosí avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del
servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative” sia
previsto anche per il caso dell’AIDS o grave immunodeficienza.
L’interpretazione secondo cui tale requisito si applichi alla sola malattia diversa dalla infezione
da HIV o AIDS conclamato si può giustificare solo se lo stato di AIDS conclamata o la grave
immunodeficienza siano equivalenti alla condizione di malato di altra affezione che non risponda
più alle terapie.
La definizione di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria viene rinviata dall'art.
286 bis C.P.P. a decreto del Ministro della Sanità, nel quale devono essere anche stabilite le
procedure diagnostiche e medico legali per il relativo accertamento.
Il decreto è stato emanato il 21 ottobre 1999 ed emendato il 7 maggio 2001 (21).
La dizione letterale della norma non lascia spazio alcuno a valutazioni del tribunale di
sorveglianza sulla pericolosità sociale del condannato, né a valutazioni sulla effettività della
incompatibilità certificata ai sensi della disposizione citata, né possibilità di scelta di altre misure, in
mancanza di un'opzione esplicita in tale senso da parte del condannato.
Evidente la ratio della disposizione, che va riferita non solo alle condizioni del singolo, ma
soprattutto alla necessità di impedire la diffusione del contagio all'interno degli istituti.
L'automatismo della concessione del beneficio in esame e la prevalenza di esso sui benefici
della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 ter, ovvero affidamento in prova al servizio
sociale o detenzione domiciliare ex art. 47 quater O.P. (22), fa sorgere non trascurabili dubbi di
conformità al sistema costituzionale. L'art. 2 Cost. (sub specie di tutela dei diritti della collettività),
anche in combinato disposto con gli articoli 3 (principio di ragionevolezza e proporzione) e 27
Cost. (finalità rieducativa della pena), sembrerebbe meglio fondare un sistema in cui, attesa la
incompatibilità predetta, sia prevista l'applicazione dello strumento che realizzi il miglior
contemperamento delle esigenze di salvaguardia della salute, da un lato, della rieducazione e
prevenzione, dall'altro. Tale sarebbe quello che, a parità di idoneità alla salvaguardia della salute,
dia la preferenza a misure alternative alla detenzione dotate di un contenuto di sostegno al
condannato e di salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti.
Ugualmente, nel caso di tutela della maternità, data l'obbligatorietà del differimento dovrebbe
affermarsene la prevalenza rispetto alla detenzione domiciliare. Poiché, tuttavia, il legislatore ha
espressamente attribuito al tribunale di sorveglianza una facoltà di scelta in materia, può ritenersi
che, fermo il diritto della donna incinta o che abbia partorito da meno di 6 mesi di ottenere il
differimento, sia in facoltà dell'interessata di formulare istanza di detenzione domiciliare. E l'ipotesi
appare tutt'altro che assurda, ben potendosi configurare un interesse della persona chiamata a
espiare una pena, specie se di lieve entità, ad assoggettarsi all'esecuzione nella forma alternativa
anziché ottenere un differimento destinato a riproporre, nel futuro, il problema della privazione
della libertà.
In alternativa, considerato che la misura alternativa assicura sia un maggior controllo della
eventuale pericolosità sociale, sia un miglior supporto al condannato, sia l'espiazione della pena,
potrebbe ritenersi che i rapporti tra il differimento obbligatorio e la detenzione domiciliare si
atteggino in modo differente. Il carattere distintivo della detenzione domiciliare potrebbe ravvisarsi
nella disponibilità, da parte del condannato, di supporto logistico (luogo di dimora o cura) adeguato
alla misura. Nel caso in cui esso vi sia, dovrebbe disporsi la misura alternativa. In tale
interpretazione, il significato dell'obbligatorietà del differimento, nei casi previsti, consisterebbe nel
fatto che la condannata, ha diritto di non espiare la pena in carcere, nelle condizioni descritte,
anche se non dispone di sistemazione adeguata alla misura alternativa.
Altro interrogativo assai frequente, nella prassi, è se il differimento obbligatorio dell'esecuzione
della pena possa essere cautelarmente sospeso o revocato. La questione si pone, soprattutto, con
riferimento alla ipotesi di recidiva nel delitto della persona differita.
L'art. 51 ter O.P. non prevede la possibilità di sospensione del beneficio in oggetto, né la revoca
del medesimo è contemplata dalle norme del codice penale, salvo che per il caso del venir meno del
presupposto, nei confronti di donna incinta o puerpera.
Tale revoca non sembra possibile, tranne che nei casi espressamente previsti. La
21
22
V. Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 1999 e Riv. it. med. leg. 2000, 346 e Gazz. Uff. 19 ottobre 2001, n. 244.
Cosí, per il regime previgente, Cass. sez. I, 29 aprile 1996, Passavanti, Ced Cass. RV. 205017.
giurisprudenza, tuttavia, ha sí escluso la revocabilità del beneficio per l'ipotesi di violazioni della
legge penale, ma la ha ammessa nel caso, ugualmente non previsto, di mutamento in melius delle
condizioni di salute (23).
7. Misure alternative. Affidamento in prova e detenzione domiciliare generica.
Il legislatore, al comma 1-bis dell'art. 47-ter, ha previsto la generale possibilità di applicazione
della detenzione domiciliare per l'espiazione di pene detentive di misura non superiore a 2 anni,
anche se costituenti parte residua di maggior pena, indipendentemente dalla sussistenza delle
condizioni di cui agli altri commi della disposizione, quando non ricorrono i presupposti per
l'affidamento in prova e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato
commetta altri reati. La disposizione non è applicabile ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis
O.P.
La più grossa difficoltà creata dalla norma è nel rapporto con l'affidamento in prova al servizio
sociale. La formula legislativa configura l'affidamento come fattispecie dai requisiti più rigorosi e
specifici, posto che questa detenzione domiciliare può concedersi se difettano i presupposti di
quello. La differenza tra i due istituti sembra doversi trovare nel fatto che il nucleo centrale
dell'affidamento in prova al servizio sociale è costituito dal suo carattere propulsivo, connesso alle
prescrizioni anche di contenuto positivo, mentre la detenzione domiciliare appare di contenuto
essenzialmente contenitivo e interdittivo. Se ciò è corretto, dovrà preferirsi l'affidamento in prova al
servizio sociale tutte le volte che la rieducazione del condannato necessiti di prescrizioni del tipo
predetto. Ne consegue che la corrente affermazione secondo cui la misura della detenzione
domiciliare sarebbe più restrittiva (e limitata ai casi più gravi) non sarebbe sempre corretta (24).
Nella ricostruzione qui proposta la detenzione domiciliare si porrebbe, per cosí dire, ai due
estremi dell'affidamento in prova al servizio sociale, applicandosi, da un lato, ai casi in cui l'uscita
dall'abitazione sia comunque fattore di pericolo di recidiva, dall'altro, ai casi in cui non vi sia alcuna
necessità di prescrizioni positive. Correlativamente, solo nel primo caso il tribunale di sorveglianza
farà un uso restrittivo della autorizzazione all'uscita dalla dimora di cui all'art. 284 C.P.P. Coerente
con tale ricostruzione è sia il fatto che il limite di ammissibilità della detenzione domiciliare in
esame sia in una pena massima di entità inferiore (due anni) a quella di cui all'art. 47 (tre anni), sia
che solo per l'affidamento in prova al servizio sociale sia possibile una revoca retroattiva.
8 (segue). Le prescrizioni dell'affidamento in prova. Le prescrizioni tipiche.
Nucleo centrale della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale sono le relative
prescrizioni. Alla sapiente individuazione delle medesime è rimessa, pressoché integralmente, la
funzione risocializzante della misura, a parte l'aspetto, puramente negativo, dell'evitare essa la
desocializzazione connessa alla permanenza nell'istituto penitenziario.
La massima secondo la quale tanto più penetranti e rigorose sono le prescrizioni (rectius, tanto
più sono adeguate alla personalità del condannato), tanto maggiore è la prognosi di idoneità della
misura, si trova riconosciuta nella giurisprudenza della S.C. (Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 1992,
Manzo, CP 1994, 172).
Il primo contenuto delle medesime, stando alla dizione di cui al primo comma, sta nella
svolgimento della prova fuori dell'istituto. La portata della disposizione è quella di riconnettere
23
Cass. Sez. I, 5 aprile 1994, Ponzio, Ced Cass. RV. 197847.
Per considerazioni simili, a proposito della detenzione domiciliare di cui al comma 1, si veda Cass. sez. I 5 luglio 1990, Cuccatto, in Ced
Cass. rv. 184986, nonché Cass. sez. I, 14 marzo 1988, Pepe, in Ced Cass. rv. 178120.
24
l'esecuzione della pena a alla condizione di persona non ristretta in carcere. Nulla nella medesima,
né nella ratio esclude, almeno in astratta ipotesi, che possa, in ipotesi, ipotizzarsi un programma di
risocializzazione che implichi la presenza dell'affidato all'interno dell'istituto penitenziario, con lo
status di non detenuto (ad esempio, attività di volontariato).
Nell'ambito delle prescrizioni può distinguersi tra prescrizioni c.d. tipiche, previste almeno
categorialmente dalla norma, e c.d. atipiche. Nell'ambito delle prime, per comodità di esposizione,
tra prescrizioni di contenuto positivo (prescrizioni vere e proprie) e prescrizioni di contenuto
negativo (interdizioni).
Per quanto attiene le prescrizioni tipiche positive, la norma prevede, innanzitutto che con
l'ordinanza si disponga l'obbligo di contatto con l'Uepe (organo cardine e propulsore della misura),
si stabilisca il luogo di dimora, e si dettino disposizioni circa lo svolgimento di attività lavorativa.
Va segnalata l'espansione del settore del lavoro c.d. risarcitorio o socialmente utile. Sempre più
frequentemente le prescrizioni impongono di dedicare una quota di tempo ad attività di utilità
sociale, già individuate o da individuarsi di concerto con l'Uepe. Tali prescrizioni trovano la
"copertura" della norma predetta, ma non mancano di profili problematici.
A parte la contraddizione, solo apparente, tra attività di volontariato (rectius, a titolo gratuito) e
imposizione di un obbligo, il profilo più disagevole risulta essere la compatibilità con la normativa
previdenziale.Nella prassi la questione viene risolta con la una prescrizione che grava di tale onere
l'affidato, in difetto di soluzione alternativa.
Esplicitamente menzionato e decisivo nel caso di condanne per reati connessi con il relativo
contesto, l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare. Altrettanto esplicita è la previsione
di una attivazione, nei limiti delle proprie possibilità, nei confronti della vittima del reato, resa
doverosa dalla novella del 1986. Deve sottolinearsi con la massima chiarezza che la prospettiva
della norma in esame è solo ed esclusivamente quella della prognosi di risocializzazione e che solo
in questa ottica deve determinarsi e apprezzarsi l'adempimento della relativa obbligazione. Ne
consegue, innanzitutto, che è del tutto ultroneo il riferimento all'integrale assolvimento delle
obbligazioni, non essendo questo immancabilmente necessario (Cass. sez. I, 7 dicembre 1999,
Nanocchio, in Ced Cass., rv 215204) e, per contro, neanche sufficiente, il tutto dovendosi
inscrivere nel quadro di personalità del condannato e dei fattori criminogeni, interni ed esterni, che
lo hanno accompagnato. Per le medesime ragioni, non appare necessariamente rilevante, l'eventuale
remissione del relativo debito da parte del danneggiato, che può solo assumere il valore di una
prognosi di superamento del fattore criminogeno rappresentato dalle tensioni tra reo e vittima. Per
le medesime ragioni, ancora, e per gli evidenti e gravi rischi di strumentalizzazione bilaterale,
sembra di doversi valutare caso per caso e con estrema prudenza la previsione di una diretta messa
in contatto delle due parti e largamente preferibile la previsione di una mediazione istituzionale e
neutra, con il sapiente vaglio professionale dell'Uepe . A maggior ragione, del tutto irrilevante
l'atteggiamento serbato dalla vittima del reato (in particolare il perdono).
Quanto alle prescrizioni tipiche di contenuto negativo, nella previsione normativa, largo spazio
è riservato a prescrizioni di contenuto interdittivo, con una scelta che la dottrina più autorevole ha
ritenuto di collegare a opzioni di politica criminale proprie di altri settori (misure di sicurezza e di
prevenzione) e giudicato, sotto vario profilo, insoddisfacente.
Sono, innanzitutto, previste possibili limitazioni alla libertà di locomozione, che, nella prassi,
concernono sia il divieto di raggiungere o soggiornare in determinati luoghi, sia uscire da confini di
circoscrizioni, sia l'utilizzazione di determinati mezzi (tipicamente i veicoli a motore, talvolta al fine
di garantire la più facile reperibilità, talvolta a quello di evitare una condotta pericolosa in sé stessa,
esempio la guida). Largamente praticato è il divieto di frequentazione di persone e ambienti
controindicati (pregiudicati, tossicodipendenti e in genere persone che possano offrire occasione di
recidiva, case da gioco, locali ove si vendano bevande alcoliche, locali o zone urbane frequentate da
pregiudicati ecc.). Meno battuta è la via del divieto di svolgimento di attività. Un settore di preziosa
applicazione è stato riscontrato nell'ambito della criminalità economica, con l'interdizione a
assumere direttamente o indirettamente, in via simulata o interposta ruoli direttivi e di
rappresentanza nell'ambito di imprese commerciali, ovvero divieti di contrattare con Pubbliche
Amministrazioni. In tale fattispecie, si è posta la questione della riproponibilità, nell'ambito delle
prescrizioni della misura alternativa del contenuto di sanzioni tipiche (pene accessorie),
eventualmente inapplicabili in sede di pena per effetto di c.d. patteggiamento.
La soluzione positiva, operando l'affidamento in prova al servizio sociale su di un piano del
tutto diverso da quello della condanna, ha trovato il conforto della giurisprudenza del S.C. (Cass.
pen. sez. I,.7 aprile 1998, Girardo, Ced Cass. RV. 211030). Tale autonomia concettuale parrebbe
rendere applicabili tali prescrizioni anche ove la corrispondente pena accessoria sia stata
esplicitamente esclusa in sentenza, non configurandosi alcuna lesione del giudicato, quantomeno
nei casi in cui l'esclusione sia determinata dalla mancata ricorrenza di uno dei casi in cui esse
possono essere inflitte nel giudizio di cognizione.
9. (segue) Le prescrizioni atipiche e il principio di legalità e tassatività.
Oggetto di incertezze è stata la conformità con i precetti costituzionali di cui agli articoli 13
comma 2, e 25 comma 2 Cost. del sistema delle prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio
sociale. Ciò sotto almeno due profili. Il primo, la descrizione decisamente generica delle
prescrizioni "tipiche", nel corpo della norma di cui all'art. 47. Il secondo, la imponibilità di
prescrizioni non espressamente previste.
Quanto al primo aspetto, si è osservato, in dottrina, che il principio di tassatività potrebbe
tollerare un contemperamento, tenuto conto della finalità rieducativa di cui all'art. 27, comma 3
Cost. (e con il limite dei trattamenti disumani di cui alla medesima norma), di tal che la
funzionalizzazione alla rieducazione (e non il mero contenuto afflittivo) riequilibrerebbe il quantum
di indeterminatezza del dettato legislativo e troverebbe ulteriore garanzia nella
giurisdizionalizzazione della relativa procedura, a condizione che ci si muova nell'ambito delle
"categorie" di prescrizioni di legge . A tale argomento potrebbe soggiungersi che un ulteriore
"copertura" costituzionale potrebbe, probabilmente, ritrovarsi per tutte le limitazioni che sarebbero,
comunque, ricomprese nel trattamento e nella restrizione penitenziaria, posto che si tratta,
comunque, di persona condannata in via definitiva a pena detentiva nei casi e con le modalità
previste dalla legge.
Si noti che l'argomento citato da ultimo potrebbe fornire sostegno anche alla tesi della
ammissibilità di prescrizioni atipiche. Tali sono quelle che o aggrediscono beni diversi da quelli
oggetto delle prescrizioni tipiche (la libertà di comunicazione, con il divieto di comunicazione, ad
esempio, a mezzo di telefoni cellulari, frequente nella prassi nei confronti di condannati per spaccio
"da strada" di sostanze stupefacenti), oppure aggrediscono beni oggetto di prescrizioni tipiche, ma
con modalità differenti (il patrimonio, ad esempio, imponendo oblazioni a favori di enti aventi scopi
istituzionali in qualche modo connessi al reato). Deve osservarsi che l'area più dubbia è allora
quella delle prescrizioni atipiche di contenuto positivo, per le quali la copertura dell'essere
comunque comprese nella detenzione, non può operare. E' dubbio che la congruità alla funzione
(rieducativa), il limite della disumanità e la garanzia giurisdizionale siano sufficienti. Non può,
tuttavia, sottacersi che la più gran parte di tali prescrizioni potrebbero rientrare in una
interpretazione estensiva della portata delle prescrizioni tipiche. Per rimanere agli esempi
prospettati, attività socialmente utili potrebbero ricondursi al "lavoro" e, lato sensu, all'adoperarsi a
favore della vittima del reato. In tale ultima direzione, potrebbe cercarsi altresì la giustificazione di
"oblazioni", purché abbiano a destinatari enti e soggetti in qualche modo rappresentativi, anche nel
solo senso sociologico, delle vittime del reato.
Il fatto che le prescrizioni atipiche "purché non contrarie alla legge e non immotivatamente
afflittive, devono considerarsi legittime se rispondenti alla finalità di impedire al soggetto di
svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati" è
stato riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione (Cass. pen. sez. I,.7 aprile 1998,
Girardo, Ced Cass. RV. 211030). L'orientamento non è tuttavia consolidato. La S.C. ha escluso che
possa ad esempio essere ordinata la demolizione di un manufatto abusivo, perché non compatibile
neppure con la interpretazione estensiva o applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 47
(Cass. sez. I 24 febbraio 1999, Rizzuti, in Ced Cass. rv 213514. Al di là della osservazione, critica,
che tale demolizione apparirebbe comunque collegata alla rimozione delle conseguenze dannose del
reato, è da dire che la decisione si segnala per il riferimento alla possibile applicazione assai
estensiva della disposizione in oggetto.
10. L'esito dell'affidamento in prova. La revoca.
La fine naturale della misura è la declaratoria di estinzione della pena per esito positivo della
prova. Per quanto i commi 11 e 12 dell'articolo in esame appaiano limitare le pronunce possibili alla
alternativa tra revoca e declaratoria di estinzione, deve segnalarsi la ricorrenza, nella prassi, anche
delle diverse fattispecie della declaratoria di non estinzione della pena, dell'annullamento
dell'ordinanza concessiva, della cessazione della misura, oltre che quella, già menzionata, della
declaratoria di inefficacia.
Tutte le ordinanze diverse dalla declaratoria di estinzione hanno come effetto che, in tutto o in
parte, la pena oggetto del procedimento di sorveglianza riacquisterà la natura di pena detentiva, con
la doverosa emissione di ordine di carcerazione (con la sola eccezione dell'affidamento in prova al
servizio sociale concesso sulla libertà controllata, ove ritenuto ammissibile e dei casi in cui
l'annullamento della ordinanza sia motivato dalla estinzione della pena medesima).
La più armonica sistemazione della materia risulta la seguente. Occorre distinguere tra
ordinanze adottate nel corso della misura e ordinanze adottate a misura conclusa, da un primo punto
di vista; tra situazioni o fatti incompatibili con la prosecuzione della prova verificatisi nel corso
della medesima e situazioni o fatti verificatisi prima dell'inizio o dopo la relativa conclusione, in
secondo luogo; tra situazioni e fatti imputabili a colpa del condannato e fatti e situazioni
incolpevoli.
Appare proprio, per ragioni di univocità terminologica, riservare la denominazione di revoca
alle sole pronunce a) adottate nel corso della misura; b) fondate su fatti e situazioni incompatibili
con la relativa prosecuzione di carattere colpevole. Costituisce oggetto di interrogativo se i relativi
fatti e situazioni debbano necessariamente essere cronologicamente situati all'interno dello
svolgimento della medesima. Considerato il requisito appena espresso sub a), il quesito concerne
solo i fatti antecedenti. La soluzione varia a seconda che si assuma che la decisione del Tribunale di
Sorveglianza sia emessa allo stato e tenuto conto di quanto astrattamente conoscibile in esito
all'istruttoria al momento della pronuncia (ergo, del conosciuto e del conoscibile), ovvero allo stato
degli atti. Nel primo caso, evidentemente, la conclusione non potrebbe che essere per l'irrilevanza
dei fatti antecedenti.
La giurisprudenza è divisa: nel primo senso, Cass. pen. sez. I, 24 settembre 1996, Russo, Ced
Cass. RV. 206000, nel secondo, Cass. pen. sez. I 6 febbraio 1996, Sfragara, Ced Cass. RV.
203979). Si noti che, nel caso di ritenuta rilevanza dei fatti antecedenti, trattandosi di ragioni di
merito preesistenti alla pronuncia dell'ordinanza, parrebbe preferibile parlare di revoca
dell'ordinanza concessiva, più che di revoca della misura tout court. Va inoltre sottolineato che
nella prassi tale pronuncia viene spesso denominata di annullamento (v.infra), ma la distinzione tra
i profili di legittimità e quelli sul merito della misura rende preferibile la dizione proposta.
L'articolo in esame detta alcuni chiari criteri guida per individuare il presupposto della revoca.
Essa può essere pronunciata solo quando: 1) l'affidato ha violato la legge o le prescrizioni (la
violazione) e 2) tale condotta è incompatibile con la prosecuzione della prova (il fallimento della
misura).
Agevole, in termini generali, definire il secondo presupposto: alla luce del fatto nuovo deve non
risultare più possibile affermare che l'affidamento in prova al servizio sociale contribuisce alla
rieducazione del reo e assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. La
determinazione concreta di tale presupposto non può che rimettersi alla prudente valutazione del
Tribunale di Sorveglianza, caso per caso.
Più articolato il discorso quanto il primo aspetto. Appare ozioso tentare una casistica delle
violazioni che possano costituire motivo di revoca del beneficio, e più produttivo il riferimento ad
alcuni criteri e osservazioni di ordine generale. Va ribadito, anzitutto, che la violazione di legge
comportante revoca non ha da essere necessariamente di rilievo penale (Cass. pen. sez. I, 11 maggio
1992, De Zen, CP, 1993, 2100), e che ad una violazione penale non consegue automaticamente la
pronuncia caducatoria (Cass. pen. sez. I, 7 novembre 1977, Boari, CP 1977, 557). Di un certo
interesse il principio di tassatività dei fatti comportanti la revoca, implicito nella norma in
commento. La notevole (e doverosa) genericità e ampiezza delle prescrizioni "di chiusura", adottate
per prassi dai Tribunali di Sorveglianza, limita però grandemente il rilevo della circostanza.
G. Per effetto della sentenza 343/1987 (su cui supra sub 1) della Corte Costituzionale, il
Tribunale di Sorveglianza, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, è tenuto a
stabilire quanto, del periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale, possa scomputarsi
dalla pena espianda. L'alternativa è tra la declaratoria di non computabilità dell'intero periodo
trascorso nella misura (c.d. revoca ex tunc) e declaratoria di computabilità almeno parziale del
periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale (c.d. revoca ex nunc). La Corte ha
sancito che ai fini della decisione predetta debba tenersi conto a) dell'entità e pregnanza delle
limitazioni alla libertà personale patite dall'affidato durante la misura (all'evidente scopo di evitare
un bis in idem); b) del suo comportamento durante la misura e della gravità soggettiva e oggettiva
del fatto che da luogo alla revoca, in connessione con il carattere sanzionatorio della revoca e con
la necessità di dare attuazione al principio di proporzionalità ed individualizzazione della pena
anche in tale fase. Nella prassi e con il conforto della S.C, (Cass. pen. sez. I, 13 gennaio 1999, Rodi
Ced Cass. RV. 212712) un peso preponderante viene assegnato alla gravità del fatto che
determina la revoca, di modo che si distingua se la prova possa dirsi ab initio completamente fallita
(e solo simulata l'adesione al programma di risocializzazione e la soggezione del condannato alle
limitazioni imposte), oppure solo parzialmente. In tale ultimo caso la data viene di solito
individuata nella data di commissione della violazione (o, in caso di progressione di violazioni, la
prima, se se ne ravvisa una connessione interna). La S.C. ha altresì chiarito che il Tribunale di
Sorveglianza, in caso di revoca ex tunc, è soggetto a onere di esplicita, "molto approfondita e
puntuale" motivazione sul thema (Cass. pen. sez. I, 13 gennaio 1999, Rodi Ced Cass. RV. 212712).
Va, inoltre, ricordato che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, anche la
pronuncia di revoca è da intendersi emessa rebus sic stantibus, almeno nei casi in cui sia fondata
esclusivamente su elementi suscettibili di successiva caducazione. La conseguenza è la possibile
revoca della ordinanza di revoca della misura (sottintesa da C. Cost. 31 maggio 1996, n. 181, con
nota di Della Casa, GiC, 1996, 1692). Tale fattispecie ricorre, nell'insegnamento della Corte delle
Leggi, ad esempio nell'ipotesi di revoca del beneficio fondata su pendenza giudiziale, conclusasi,
successivamente, con esito assolutorio. La pronuncia caducatoria si renderebbe necessaria per la
rimozione degli effetti preclusivi del provvedimento di revoca della misura (in particolare, art. 58
quater o.p.).
Sul piano processuale, ci si è chiesti se osti alla pronuncia di revoca l'inosservanza del termine
di 30 giorni di cui all'art. 51 ter o.p. Soluzione corretta appare la negativa, osservandosi che tale
termine opera al differente scopo di stabilire il termine massimo di carcerazione cautelare per
effetto della sospensione di cui alla norma medesima. L'unico effetto della scadenza di tale termine
è l'obbligatoria liberazione del condannato (Cass. pen. sez. I, 14 febbraio 1997, Calabrese, Ced
Cass. RV. 207039), alla quale la Direzione dell'Istituto Penitenziario deve provvedere
automaticamente, senza la necessità di alcun provvedimento apposito.
11. (segue) La dichiarazione di cessazione della misura, la declaratoria di estinzione o non
estinzione, le pronunce di annullamento.
La dichiarazione di cessazione è una fattispecie esplicitamente prevista dall'art. 51 bis o.p. per
il caso in cui sopravvenga, nel corso della misura, una ulteriore pena tale che la durata complessiva
ecceda il limite triennale. Nella prassi, spesso tale pronuncia viene definita anche revoca
incolpevole (così anche in C. Cost. 6 dicembre 1985, n. 312). La presenza di una espressa dizione
legislativa e l'opportunità della distinzione fanno preferire la soluzione proposta.
La declaratoria di estinzione della pena è, invece, una pronuncia a) successiva al termine
della misura; b) avente ad oggetto la verifica (negativa) di eventuali fatti e situazioni colpevoli,
incompatibili con l'affermazione di una effettiva idoneità della misura agli scopi per cui era stata
concessa.
Orientamento consolidato è, infatti, quello secondo il quale l'estinzione della pena opera
unicamente in seguito all'esito positivo della prova e, perché si verifichi un tale effetto estintivo,
non é sufficiente il mero decorso del periodo di prova, senza che sia intervenuta la revoca
dell'affidamento, ma é necessario un accertamento della stessa Tribunale di Sorveglianza
sull'avvenuta, almeno parziale rieducazione del reo (Cass. pen. sez. I 21 febbraio 1984, Didona, Ced
Cass. RV. 163357; Cass. pen. sez. I, 6 maggio 1985, Falcetelli, Ced Cass. RV. 169562)
Altrettanto consolidato è l'orientamento secondo il quale il Tribunale di Sorveglianza può
acquisire ai fini di tale pronuncia ogni elemento utile, non limitandosi alla relazione c.d. finale del
CSSA (informazioni polizia, certificato carichi pendenti, atti processuali ecc.).
In giurisprudenza si è posto il quesito se possa procedersi a revoca della misura dopo la
declaratoria di esito positivo della prova. Rilevato che, da punto di vista della terminologia qui
adottata, più propriamente si dovrebbe parlare di dichiarazione di non estinzione successiva a una
prima dichiarazione di estinzione, va detto che consta un precedente negativo (C.App. Brescia, 18
giugno 1980, Miglioli, Rass. penit. e criminologica, 1982, 835). Tale soluzione appare corretta, a
meno di non ritenere annullabile, perché emessa allo stato degli atti la pronuncia di estinzione
Largamente dibattuta, ma ora risolta, è la questione della portata dell'effetto estintivo rispetto
alla pena pecuniaria. Il comma 12 dell'art. 47 O.P. prevede che “Il tribunale di sorveglianza,
qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la
pena pecuniaria che non sia stata già riscossa”. I problemi che tale norma, introdotta di recente, 25
comporta sono molteplici.
Innanzitutto non sembrano esservi ostacoli alla applicazione di essa agli affidamenti in corso.
In secondo luogo, è da domandarsi quale sia la procedura applicabile e in particolare se sia
necessaria una apposita istanza dell'interessato e come vada accertata la sussistenza dei presupposti.
Visto che tale estinzione si inserisce nell'attuale procedimento di estinzione, la soluzione più pratica
appare procedere d'ufficio e, semplicemente, inserire nella richiesta di relazione finale all'Uepe,
sull'andamento dell'affidamento anche la richiesta di riferire sul tenore di vita per come rilevato
durante la misura.
25
Art. 4-vicies semel, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione
La declaratoria di non estinzione della pena costituisce l'esatto inverso di quello appena
descritto. Vale la pena di sottolineare che nella prassi, spesso, tale pronuncia viene
indifferentemente anche denominata "revoca". Rigore terminologico consiglia una denominazione
distinta. La giurisprudenza tende ad affermare che, dopo la scadenza della misura, solo tale
pronuncia sia ammissibile e non la pronuncia di revoca (Cass. Sez. I, 17 febbraio 2000, Cornero, in
Ced Cass., rv 215706), fondandosi il giudizio non su singoli episodi (come nella revoca) ma
sull’esito globale della misura. Invero, anche nel procedimento di revoca è imposta una valutazione
complessiva circa la compatibilità con la prosecuzione della misura.
Sul piano della sostanza, problematico è se possano essere valorizzati fatti e situazione
cronologicamente situati al di fuori dello svolgimento della misura. Lo si esclude pacificamente per
i fatti antecedenti.
Per i fatti successivi (tipicamente la commissione di reati subito dopo il termine della misura),
la tesi negativa è ben rappresentata nella giurisprudenza del S.C. (Cass. pen. sez. I, 15 maggio 1998,
Allegrucci, Ced Cass. RV. 211404; Cass. pen. sez. I, 14 novembre 1996, Motta, Ced Cass. RV.
206514, Tali pronunzie si segnalano anche, dal punto di vista terminologico, per denominare
"revoca" la pronuncia considerata). Tale tesi pare doversi temperare con una precisazione. Cosa
distinta dall'assumere a fondamento del provvedimento di revoca il fatto successivo, sarebbe
l'utilizzare tale fatto "ad colorandum" per meglio lumeggiare il fallimento della prova già risultante
da altri elementi (irregolarità nei rapporti con CSSA, ecc.). Tale soluzione ha trovato riscontro nella
medesima giurisprudenza (Cass. pen sez. I, 19 giugno 1998, Quaranta, in Ced Cass. RV. 211421).
La tesi della valutabilità a tali condizioni di fatti successivi si è fatta successivamente strada (Cass.
SS. UU. 27 febbraio 2002, ric. Martola, in Ced Cass. rv. 220877).
Fattispecie particolare è quella relativa alla valutazione di fatti commessi dopo la scadenza del
termine originario di durata, per l’ipotesi di estensione della misura a titoli esecutivi sopravvenuti.
Nel caso di fatto verificatosi in “troncone” di misura alternativa successivo al primo, non è mancata
una opinione giurisprudenziale che ha ritenuto comunque formalmente distinte le varie esecuzioni
e, pertanto, anche in caso di c.d revoca ex tunc, il limite della retroazione all’inizio del troncone di
misura in cui si colloca la violazione (Cass. Sez. I, 22 maggio 2000, in Ced Cass., rv 216281). Tale
soluzione appare ispirata a una concezione formale della misura alternativa che appare suscettibile
di critica. Sul piano formale, almeno nel caso in cui la pena sopravvenuta sia ricompresa in un
provvedimento di cumulo, sembra ostarvi il disposto dell’art. 76, comma 1, c.p.. E, soprattutto,
sembra ostarvi, sul piano della ratio e del sistema, il fatto che la valutazione da compiere è quella
della idoneità della misura in relazione alla personalità complessiva dell’affidato, avendo come
metro – alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra citata – l’entità complessiva delle
limitazioni della libertà personale patite e la gravità della condotta. Sotto nessuno dei profili appena
segnalati il mero dato, formale della intervenuta estensione ad altro titolo sembra introdurre una
necessaria soluzione di continuità. Si noti, ad ulteriore conferma della unitarietà della misura, che il
provvedimento di estensione non impone una innovazione del contenuto precettivo della misura in
corso.
Altro interrogativo è se si possa procedere a declaratoria di non estinzione della pena dopo una
pronuncia che ha escluso la revoca del beneficio. La soluzione positiva è certamente corretta,
posto che i fatti valorizzabili al momento della revoca costituiscono un insieme assai più ristretto di
quelli utilizzabili al momento della valutazione finale della misura. In tale ultima sede viene infatti
valorizzato l'atteggiamento complessivo serbato dal condannato durante la misura e la precedente
pronuncia non può avere, di per sé, un valore ostativo, non coincidendo il thema decidendum. Ciò
che pare precluso è la sola declaratoria di non estinzione motivata esclusivamente sul fatto che fu
esaminato effettivamente e nel merito nella precedente pronuncia.
Ulteriore problema è se sia ammissibile una declaratoria di estinzione parziale della pena (e di
non estinzione del residuo). Il fatto che tale esito non sia contemplato ex professo dalla norma in
commento e che la C.Cost non si sia pronunciata su tale aspetto della questione ha portato ad
escluderlo (Cass. pen. sez. I ,18 settembre 1997, Renda, Ced Cass. RV. 208765).A tale conclusione
parrebbe potersi obiettare che, se per lo stesso fatto, esaminato in sede di procedimento di revoca,
sarebbe possibile ritenere valida a fini espiativi una certa parte del tempo trascorso in misura, la
soluzione rigorosa apparirebbe violare l'art. 3 Cost., posto che la circostanza che tale elemento sia
valutato durante la misura o successivamente dipende da fatto accidentale e non imputabile al
condannato. Dubbio è se a una tale conclusione potrebbe pervenirsi anche in sede interpretativa o
solo in approdo a una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tale soluzione è stata accettata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. 27 febbraio 2002, n 10530, Martola, in Ced
Cass. RV. 220878)
Ulteriore profilo è se, ai fini della disciplina restrittiva di cui all'art. 5 quater o.p., la non
estinzione possa essere ritenuta equivalente alla revoca. In effetti, sul piano razionale le due
fattispecie coincidono, in entrambe il soggetto ha fallito la prova. Sul piano strettamente formale,
tuttavia, osta a tale estensione, il fatto che l'art. 58 quater richiama esclusivamente la revoca ex art.
47 comma 11 O.P.26
Nella ccategoria delle pronunce di annullamento, non espressamente prevista dalla legge, si
fanno confluire una serie di ipotesi di incompatibilità con la prosecuzione (o concessione) della
misura, da tenere distinte da quelle fino a qui ricordate. Essenzialmente, si tratta di a) pronunce
adottate nel corso della misura; b) relative a situazioni e fatti incompatibili con la misura
incolpevoli. La dottrina vi fa rientrare, esemplificativamente, casi di: sopravvenienza di infermità
mentale, richiesta di cessazione della misura da parte dell'interessato, interruzione a seguito del
sopravvenire del provvedimento ex art. 41 bis o.p.. La prassi, invero, fa largo uso di tale pronuncia
anche per casi di travisamento dei fatti risultanti dall'istruttoria, errore di persona, sopravvenuta
insussistenza del titolo o della sua esecutività (es. a seguito di vittorioso incidente di esecuzione con
remissione in termini per impugnazione, ecc.). Deve ulteriormente osservarsi che tale tipologia di
pronuncia trova un uso in progressivo espansione, valorizzandosi con essa non solo sopravvenienze
incompatibili con la misura, ma altresì fatti antecedenti non considerati. I relativi limiti all'idoneità
al giudicato e la controversa portata del loro essere emesse "allo stato" (degli atti ?) ha favorito
l'utilizzo di tale strumento anche per la valorizzazione di circostanze antecedenti non risultanti dagli
atti, da un lato, e, talvolta, di veri e propri errores in jure, in procedendo e in judicando (es. ragioni
di inammissibilità originarie), con la sola esclusione, in pratica, del riesame di merito della
fattispecie. Apparirebbe, tuttavia, sistematicamente corretto limitare il campo di tali pronunce
quantomeno in correlazione con l'area riservata alle impugnazioni e lasciare al campo
dell'annullamento solo ciò che non sia valorizzabile attraverso la via del ricorso per Cassazione (ne
risulterebbero doverosamente escluse, quantomeno, le ipotesi di errores in jure).
12. La liberazione anticipata
Un primo problema concerne l'interrogativo se la valutazione della ricorrenza dei presupposti
della liberazione anticipata debba indefettibilmente essere condotta separatamente, per ogni
semestre di pena, ovvero se e in che limiti, fatti verificatisi in semestri diversi possano essere presi
in considerazione.
L’orientamento giurisprudenziale attualmente maggioritario si attesta, invece, pur accettando la
premessa di principio che l’analisi giudiziale deve essere condotta per singoli semestri,
sull’ammissione della possibilità, per il giudicante, di valutare l’impatto di condotte particolarmente
26
In senso opposto, per la applicazione del regime restrittivo: Trib. Sorv. Torino 19 aprile 2006 in
www.dirittopenitenziario.it
negative tenute dal condannato in periodi posteriori al semestre (o ai semestri) in valutazione,
qualora tali comportamenti si rivelino altamente sintomatici della carenza di un’effettiva adesione
del soggetto all’opera di rieducazione (Cass.I, n.6259 dd.28.1.98, Pistolesi, CED; Cass.I, n.5819
dd.4.1.00, Signorello, CED; Cass.I, n. 3297 dd. 25.6.96, Guillemet, CED; Cass.I, n.29352
dd.19.7.01, Carbonaro, CED; Cass.I, n.1517 dd.13.4.96, Celentano, CED).
Anche nella giurisprudenza di merito tale orientamento è quello maggiormente seguito:
(Trib.Sorv.Torino, 26 marzo 2003, n.1204/03RG, www.dirittopenitenziario.it 2003).
Altro problema è se il semestre di pena ai fini della concessione della liberazione anticipata
possa essere composto di spezzoni di durata inferiore, senza limite alcuno al frazionamento o alla
distanza tra le frazioni medesime. La Corte di Cassazione ha affermato che “la decisione del
Tribunale, trattandosi di provvedimento confermativo, appare ineccepibile ed immune da vizi, non
essendo possibile una valutazione unitaria di periodi separati, pur se complessivamente integranti
un semestre, distanti fra loro e tanto frazionati anche per il tipo di esecuzione da non potere
integrare una unitarietà trattamentale” (Cass. Sez. I, 28 novembre 2005, n. 43013)
La consolidata giurisprudenza della Cassazione inclina a ritenere legittima la valutazione
dell’incidenza negativa della commissione di reati, commessi nel corso di periodi di libertà
successivi alla detenzione, ai fini della verifica della sussistenza di un’effettiva partecipazione
all’opera di rieducazione del condannato, in rapporto a semestri di pena espiata antecedentemente
alla perpetrazione degli illeciti penali (Cass.I,17.4.00,n.1740,Greco,CED;Cass.I,25.3.92,
Badalamenti,CP,1993,2102;Cass.I,23.3.93,Privitera,CP,1995,2279;Cass.I,14.4.97,Pirrozzi,CP,1997
,962;Cass.I,7.7.99, n.3342,Bayrak,CED).
Nella giurisprudenza di merito, la commissione di un reato successivamente ai semestri di
pena in valutazione ai fini di cui all’art.54, O.P., è generalmente considerata ostativa al
riconoscimento della riduzione di pena (Trib.Sorv.Torino 23 novembre 2004,in Giurisprudenza di
merito, 2005).
Non è raro che al condannato siano riconosciute, nel corso dell’esecuzione, plurime riduzioni di
pena a titolo di liberazione anticipata per effetto di decisioni relative agli stessi semestri di
detenzione espiata.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, spetta all’organo del PM provvedere al c.d.
ridimensionamento della riduzione di pena concessa in tali casi, in applicazione analogica di quanto
prevede l’art.579, c.p.p., in tema di plurime applicazioni dell’indulto (Cass.I,12.1.88
n.5383,Cimone,CED).
13. Le misure di sicurezza
Il settore delle misure di sicurezza gode di una vitalità, nella giurisprudenza di merito degli
Uffici di Sorveglianza, che risulta sorprendente, se rapportata alla, tradizionale, scarsa attenzione
(se non manifesta ostilità) della dottrina specialistica.
Nella elaborazione teorica le misure di sicurezza restano infatti collocate nelle appendici poco
frequentate dei manuali di diritto penale, schiacciate da un generalmente condiviso giudizio che
assegna loro la scomoda palma di reliquato di concezioni giuridiche ormai tramontate.
Nella prassi e nella realtà giuridica esse hanno invece una notevole vitalità e finiscono per
assolvere a due notevoli funzioni.
La prima, generale, è di estensione della finalità preventiva e, in questo senso lato
sanzionatoria, per i soggetti nei confronti dei quali la pena abbia concretamente dimostrato la sua
inefficacia.
Con una certa rotazione concettuale rispetto al disegno originario del Codice Penale, esse,
soprattutto dopo la abolizione dei meccanismi di automatica applicazione, e saldandosi con il
sistema delle misure alternative, hanno finito per rappresentare strumento di attuazione di una pur
minima flessibilità bilaterale della pena.27 In questo senso e direzione, le misure di sicurezza hanno
assunto la funzione di accessorio e strumento che certifica il fallimento della rieducazione attuata
con lo strumento ordinario (della pena della reclusione) o attenuato (misure alternative).
La seconda, particolare, concerne la prevenzione e, anche, francamente, terapia della malattia
psichiatrica, ove associata a condotte devianti. Particolarmente fecondo è infatti il campo delle
misure di sicurezza applicate sotto la veste della libertà vigilata, a carico di autori di delitti che siano
portatori di malattia mentale.
Sotto il primo aspetto (flessibilità bilaterale del trattamento penale) risulta indicativa la
giurisprudenza che applica la misura di sicurezza della colonia agricola, per il tramite della
declaratoria di delinquenza abituale, a soggetto evaso da permesso premio (Magistrato di
Sorveglianza Alessandria ord. 20 maggio 2001, in www.dirittopenitenziario.it)
L’inflizione di misura di sicurezza detentiva nel corso della esecuzione della pena è possibile, in
particolare, nel caso della declaratoria di delinquenza abituale o professionale. Valorizzare tuttavia
tale declaratoria come strumento di sanzione del fallimento del progetto rieducativo in atto
(desumibile da condotte poste in essere dopo la sentenza di condanna e durante la pena), deve
superare l’apparente ostacolo del disposto dell’art. 109, comma 2 c.p..
In giurisprudenza si è tuttavia sottolineato che la limitazione temporale, circa gli elementi
valutabili, consistente nel divieto di tener conto di fatti sopravvenuti alla condanna, concerne solo i
presupposti della dichiarazione di delinquenza abituale o professionale (dedizione al delitto o vivere
almeno in parte dei relativi proventi), ma non la valutazione della attualità della pericolosità sociale.
(Magistrato di Sorveglianza Alessandria 13 febbraio 2002, in www.dirittopenitenziario.it)
L’altro settore di vitalità delle misure di sicurezza è rappresentato dalla terapia e contenimento
della pericolosità del soggetto infermo di mente.
In tale caso la valutazione della magistratura di sorveglianza deve combinare il consueto
strumentario criminologico con nozioni ed esperienze tratte dalla psichiatria forense.
Il profilo senz’altro più innovativo è tuttavia un altro, ed è quello dato dalla possibilità di
riconoscere, nella prassi, un’ipotesi socialmente tipica di misura di sicurezza: la libertà vigilata
terapeutica.
Essa è figlia della flessibilità della misura prevista dal codice penale (che ammette qualsiasi
prescrizione, purché idonea a contenere il pericolo di recidiva) e del bisogno di contenimento del
paziente psichiatrico. Molto spesso, sia a fini di tutela sociale che di tutela della salute, la presenza
di un obbligo giuridico di sottoporsi a terapia costituisce uno strumento necessario. E tale strumento
è stato individuato, di fatto, proprio nella libertà vigilata.
Se ne riconoscono oramai due tipologie, che finiscono per corrispondere alle due omologhe
tipologie che la prassi individua per i programmi di recupero dalla tossicodipendenza: la libertà
vigilata terapeutica c.d. comunitaria, per il malato psichiatrico allocato in comunità terapeutica e la
libertà vigilata c.d. ambulatoriale, per il malato che ha adeguati supporti abitativi e personali
autonomi.
(Magistrato di Sorveglianza Alessandria ord. 3 febbraio 2005, in Osservatorio di diritto
penitenziario online - www.dirittopenitenziario.it))
27
Con questa felice formula, la cui paternità si deve a Paolo Gibelli, si designa uno strumentario penalistico che
assicuri una pena adeguatamente modulabile sulle esigenze di rieducazione e prevenzione, con una capacità di
adattamento non orientata esclusivamente in bonam partem, ma, pur nel rispetto del principio di predeterminazione e
tassatività, anche in malam partem.
Per quanto attiene la libertà vigilata terapeutica, c.d. ambulatoriale, risulta centrale la funzione
della rete di supporti rappresentata dai Centri Salute Mentale e dagli Uffici per l’Esecuzione Penale
esterna (ex CSSA)
14. Magistratura di sorveglianza e tutela dei diritti dei soggetti ad esecuzione di pena.
In primo luogo è opportuno l’inquadramento generale della tutela dei diritti delle persone
detenute.
Successivamente, si potrà trattare degli aspetti specifici che mi sono stati indicati, con
particolare riguardo alla materia della sospensione delle regole di ordinario trattamento e il diritto
alla salute.
Sul piano generale e astratto sono possibili diversi schemi di tutela, che vanno dalla
generalizzata attuazione di una tutela giurisdizionale, con forme a contraddittorio pieno e di fronte a
una giurisdizione unica, a forme più variegate, che distinguano, ad esempio, a seconda della
posizione giuridica fatta valere e da questo facciano dipendere differenze circa la procedura e la
giurisdizione.
Senza addentrarsi nell’esame di modelli solo teorici e limitandosi al dato normativo concreto, si
può osservare come la scelta operata dall’Ordinamento Penitenziario e della Legge Gozzini si
reggesse, sostanzialmente, su una tripartizione.
In primo luogo, diritti dei detenuti configurati esattamente alla stessa stregua di quelli delle
persone libere, con la stessa tutela. Così, evidentemente, non portando la detenzione una capitis
deminutio del condannato, c’è tutta un area di situazioni nelle quali la posizione di questo non è
modificata: o perché si tratta di questioni che non sono incise dalla detenzione, o perché si tratta di
posizioni che non devono essere incise dalla detenzione. Esempio del primo tipo: la lesione di
interessi patrimoniali del condannato avvenuta all’esterno del carcere. Salvi gli effetti della
eventuale interdizione legale, il condannato gode della tutela ordinaria: può citare persone in
giudizio per l’adempimento, esercitare rivendiche, ecc. Altro esempio, l’impugnazione al Tar di una
delibera che neghi una concessione edilizia. Esempio del secondo tipo, il danno biologico patito per
effetto di colpa medica nelle cure praticate durante la detenzione. Anche in questo caso la tutela
segue, pacificamente, le forme ordinarie.
In questa prima area, l’affermazione della Corte Costituzionale secondo cui “l’esecuzione della
pena e la rieducazione che ne è finalità – nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e
disciplina – non possono mai consistere in "trattamenti penitenziari" che comportino condizioni
incompatibili col riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro
libertà" (Corte cost. n. 26/99)” ha il significato più pieno: significa: la persona detenuta è
uguale alla persona libera.
E’ molto interessante osservare che l’ambito in cui si esplica tale tutela ordinaria non è rigido e
immutabile, ma dipende da valutazioni e dalla sensibilità sociogiuridica del momento. Esemplare,
in proposito, la questione della tutela dei diritti del detenuto lavoratore. Stando a una notissima
sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,28 per esempio, la giurisdizione in tema di
lavoro penitenziario spetterebbe al Magistrato di Sorveglianza, ai sensi della previsione dell’art. 69
O.P. tenuto conto del fatto che “Le diversità strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie
controversie di lavoro e quello proprio del procedimento delineato dall'art. 69 della legge n. 354
del 1975 per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo
denominatore comune delle une come dell'altro, manifestamente non escludono la ragionevolezza
della scelta del legislatore di prevedere una diversa competenza per le controversie concernenti
28
Cass. Sez. Un. 26 gennaio 2001, n. 26
quest'ultimo tipo di lavoro, attese le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un
detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività che risultano strettamente connesse e
consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice
penale.
Secondo questa impostazione, insomma, il lavoro sarebbe un’area sulla quale incide (nel senso
giuridico appena precisato) la detenzione, di tal che è ammessa la differente giurisdizione e tutela.
A dimostrazione della relatività di tali impostazioni, è interessante sottolineare l’esistenza di un
diverso orientamento, ben rappresentato dalla recente e nota sentenza della Corte di Appello di
Roma,29 secondo cui, il sistema di tutela affidato al Magistrato di Sorveglianza non sostituirebbe
quello ordinario, ma vi si affiancherebbe, rimettendosi all’interessato la scelta, irrevocabile, tra
l’uno e l’altro. La Corte di merito osserva, tra l’altro che “il legislatore del 1986 non intendesse
modificare l'art. 409 c.p.c. risulta evidente dalla notevole diversità dei due rimedi, il che esclude
che il rimedio dinanzi al magistrato di sorveglianza sia idoneo a "sostituire" il rimedio ex art. 409
c.p.c., avendo una struttura ed una funzione ben diversa ed essendo dotato di congegni processuali
ben più riduttivi rispetto agli strumenti previsti per l'esplicazione del diritto di difesa dei lavoratori.
Tanto riduttivi che la diversa interpretazione sostenuta dalle Sezioni Unite non potrebbe che
scontrarsi, come si dirà, con principi costituzionali e sovranazionali.
Basti osservare che la procedura ex art. 14 ter non prevede la partecipazione del
contraddittore necessario del rapporto di lavoro e cioè del Ministero della Giustizia (datore di
lavoro nel rapporto carcerario "interno" come quello in esame), che non assume la veste di parte,
non prevede la partecipazione personale dell'interessato, che non può essere sentito personalmente,
non prevede la pubblicità del procedimento. Va anche considerato che la procedura è configurata
come reclamo entro 10 giorni avverso un provvedimento dell'amministrazione (art. 14 ter), che non
sempre è riscontrabile nelle controversie lavorative, e il magistrato di sorveglianza può solo
pronunciarsi sulla fondatezza o meno del reclamo, ma non può emettere ad esempio provvedimenti
di condanna (tipico corollario della diversa configurazione della natura dei giudizi, il primo
impugnatorio, il secondo di tutela dei diritti soggettivi nel rapporto bilaterale a prestazioni
corrispettive). Si è anche osservato in dottrina che il magistrato di sorveglianza, - per i compiti
istituzionali di vigilanza che gli sono attribuiti dall'ordinamento penitenziario -, sembra svolgere
una funzione propria diversa da quella che si riconosce all'ordinario organo giudicante delle
controversie civili, sicchè la procedura in esame ha funzione e struttura del tutto diverse
dall'ordinario processo del lavoro, costituendo in realtà una tutela "interna" al regime carcerario e
come tale non sovrapponibile nè sostituibile alla normale tutela giurisdizionale, se non in base ad
una libera scelta del detenuto lavoratore.”
Questi due orientamenti scolpiscono plasticamente, con la forza del caso concreto, il problema
della interazione delle posizioni giuridiche con la detenzione e la relatività di tali valutazioni.
Nel merito, a me pare che la soluzione formulata dalla Corte di Appello di Roma sia preferibile:
la soluzione mi pare equilibrata nell’individuare i rapporti tra le due giurisdizioni e più appagante
laddove riconosce la più ampia tutela conseguente al riconoscimento della giurisdizione ordinaria.
Si noti che tale pienezza non è solo sul piano della teorica ampiezza del contraddittorio ma su
quello, assai più immediato e concreto, della pronuncia ottenibile. Si osserva che solo davanti al
giudice del lavoro sarebbe possibile ottenere una pronuncia di condanna, esecutiva nei confronti del
datore di lavoro.
15. (segue) la tutela semplificata.
29
Corte Appello Roma 3 giugno 2004, 5215/2002 R.G., reperibile sul web in
http://www.unicz.it/lavoro/CdAROMA_03062004.pdf
A fianco delle posizioni suscettibili di tutela ordinaria, il legislatore dell’O.P. e della legge
Gozzini aveva poi configurato una situazione intermedia, disciplinata dall’art. 69, quanto a materia,
e 14 ter e 71 e ss. quanto a procedura. Grossolanamente, si tratta di una procedura semplificata,
posto che il contraddittorio si attua mediante il deposito di memorie (ed è esclusa la fisica
partecipazione dell’interessato all’udienza), il provvedimento terminativo è una ordinanza del
Magistrato di Sorveglianza ricorribile in Cassazione.
Tale rito era intermedio, siccome collocato tra la tutela con le forme ordinarie (vista sopra) e il
c.d. reclamo generico, di cui all’art. 35 O.P. In questo ultimo caso, di fatto, l’istituto previsto è una
“segnalazione” al Magistrato di Sorveglianza, che non conduce a un vero e proprio
procedimento/provvedimento giurisdizionale, ma conduce a iniziative amministrative il cui esito è,
essenzialmente, l’adozione da parte del Magistrato di Sorveglianza dei poteri di sollecitazione,
relazione, intervento previsti in generale dall’art. 69 comma 130 e 531 O.P. All’interessato non è
riconosciuta una partecipazione o tutela particolare all’interno di tale procedimento.
Su un piano teorico e generale, anche questo sistema aveva una sua logica coerente. A una
tutela con procedimento giurisdizionale nelle materie di cui all’art. 69 comma 6 O.P. (lavoro e
responsabilità disciplinare) affiancava, per le materie residue, una garanzia costituita dal potere di
intervento di un organo terzo e imparziale, il Magistrato di Sorveglianza. A prescindere dai
problemi sul rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e ragionando in termini di potenziale
efficienza del sistema, vale la pena di sottolineare che tale strumento avrebbe potuto avere anche
una efficacia dirompente. Ormai la questione si può dire superata dagli eventi (in particolare, la
sentenza 26/1999 della C. Cost.), ma forse avrebbe potuto una fortuna diversa, in pratica, quanto
disposto dal comma 5 dell’art. 69 O.P.: “il Magistrato di Sorveglianza impartisce nel corso del
trattamento le disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati”.
Sarebbe stato sufficiente intendere “trattamento” come regime penitenziario e non come
“programma di trattamento” e calcare la mano sulla vincolatività di quelle “disposizione” del
Magistrato di Sorveglianza.
Sempre sul piano generale, e prima di prendere atto della sentenza 26/1999 della Corte
Costituzionale, che ha comportato la giurisdizionalizzazione di tutta la materia, è anche interessante
osservare che non si può nemmeno affermare che l’aumento dell’area della giurisdizionalizzazione
sia una tendenza reale dell’ordinamento giuridico nel suo complesso. A parte la spinta, interna alla
materia penitenziaria, per la creazione di Garanti dei detenuti, spinta che è compatibile con tale
tendenza, volendosi affiancare un organo propulsivo a quello giurisdizionale, vale la pena di
ricordare come, in altri settori, ci sia una tendenza opposta. Penso alla diffusa creazione di
authority, con competenza su settori di rilevante importanza economica o finanziaria. O, senza
andare troppo lontani, alla resistenza della c.d. clausola compromissoria negli sport professionistici.
In ogni caso, l’architettura descritta fino qui è stata rivoluzionata dalla sentenza 26/1999 della
Corte delle Leggi. Essa, sulla base del sillogismo per cui a ogni posizione giuridica meritevole di
tutela deve corrispondere una tutela e che questa tutela deve essere giurisdizionale ha, come noto,
dichiarato incostituzionale la disciplina appena descritta proprio perché non prevedeva l’accesso a
forme giurisdizionali per le materie non disciplinate dall’art. 69 comma 6 O.P.
Si tratta di sentenza fondamentale, per il rigore del principio affermato.
Tale sentenza della Corte ha però lasciato sul campo due interrogativi. Il primo è quello delle
posizioni giuridiche tutelabili. Il secondo, esplicito già nella stessa sentenza, quello procedura
applicabile.
30
31
Secondo cui il Magistrato di Sorveglianza prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi.
Secondo cui il Magistrato di Sorveglianza impartisce nel corso del trattamento le disposizioni dirette ad
eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati.
16. (segue) La sentenza 26/1999 C.Cost. e le posizioni giuridiche tutelabili.
Sul piano della portata, va subito rilevato che, come già sottolineato, la sentenza non impatta,
come è ovvio, su tutta l’area delle posizioni giuridiche già suscettibili di tutela ordinaria (che
godono già di tutela piena), così come di quelle già oggetto di disciplina espressa (ad esempio, la
materia disciplinare).
Il problema più complesso (e più importante in pratica) è però un altro: dove passi il confine tra
le posizioni tutelabili e aspettative di mero fatto. In effetti, si possono ipotizzare modelli teorici
assai diversi, ma la soluzione resta difficile. Una delle tentazioni più irresistibili per l’interprete, in
proposito, è cercare di selezionare tra diritti soggettivi e interessi legittimi, o modelli concettuali
simili. A mio avviso, si tratta però di una strada poco produttiva. Al di là dell’enfasi che si mette
normalmente sulle affermazioni – assolutamente corrette - della dignità della persona detenuta e
l’esistenza di posizioni giuridiche non comprimibili, sta il fatto che delle due l’una. O sono in gioco
interessi che effettivamente non sono o non devono essere incisi dalla detenzione (e allora la tutela è
quella ordinaria), ovvero si tratta di interessi che vengono incisi dalla detenzione. Ma se si verifica
questa seconda situazione è evidente che l’interessato si trova in una posizione giuridicamente
differente da quella del soggetto libero. Nella posizione di chi ha posizioni giuridiche da
contemperare con la detenzione, o meglio con lo scopo della detenzione. Tale situazione è
delicatissima e meritevole della massima attenzione e tutela, anzi forse di tutela più attenta e intensa
di quella di un soggetto libero, ma differente. Il giudizio da compiere è sempre quello della
proporzione tra le esigenze di sicurezza (sociale e penitenziaria) e interesse del singolo.
Siamo nell’ambito della valutazione della proporzionalità dell’azione amministrativa,
nell’attuazione dei suoi scopi, rispetto ai diritti individuali. Il sacrificio imposto al singolo non deve
eccedere quello minimo necessario, oltre a non ledere posizioni non sacrificabili in assoluto.32
Il tentativo, insomma, di distinguere tra ciò che è tutelabile e ciò che non lo è passando per le
categorie del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo è destinato a sicuro fallimento. Il criterio è
allora diverso, saranno tutelabili tutte le posizioni giuridiche: a) espressamente riconosciute dalle
norme penitenziarie; b) riconoscibili a un soggetto libero, non importa di quale natura.
17. (segue) il procedimento applicabile.
Come noto, la sentenza 26/1999 della Corte Costituzionale, dichiarata incositutuzionale la
normativa dell’art. 35 O.P per la mancata attuazione delle garanzie della giurisdizione, e rilevata
l’esistenza di molteplici modelli procedimentali, rinviava al legislatore per la concreta
individuazione di quello applicabile nella fattispecie.
Il legislatore, tuttavia, non interveniva nella materia. E’ così rimasto sul tappeto il problema,
teorico e pratico, della scansione procedurale da utilizzare. Nella materia sono infine intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione,33 che hanno ritenuto applicabile il rito di cui all’art. 14 ter
O.P. Gli artt. 14-ter, 69, 71 e seguenti dell'ordinamento penitenziario prevedono il termine di dieci
giorni per proporre reclamo; il termine di cinque giorni per l'avviso dell’udienza al pubblico
ministero, all'interessato e al difensore; la partecipazione non necessaria del difensore e del
pubblico ministero all’udienza; la facoltà dell'interessato di presentare memorie; la possibilità di
proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Tale
32
Evidente l’eco nella materia della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, in materia di principio di
proporzionalità dell’azione amministrativa. Ad esempio: Corte Giustizia CE, Joined Cases C-286/94, C-304/95, C401/95 and C-47/96, Garage Molenheide BVBA v Belgian State
33
Cass. Sez. Unite, 26 febbraio 2003, n. 25079 ric. Gianni
ricorso per cassazione è nelle facoltà anche dell’Amministrazione Penitenziaria, per le materie di
cui agli artt. 14 ter e 69 comma 6 O.P. Pena un evidente lesione del diritto al contraddittorio, se
questa è la procedura applicabile alla tutela dei diritti dei detenuti, dovrà ammettersi anche in questi
casi la legittimazione al ricorso per la P.A.
La individuazione di tale procedura, al di là della somma autorevolezza del collegio giudicante,
è da ritenersi soddisfacente. La Corte osserva che “un simile mezzo non può che ricondursi proprio per le esigenze di speditezza e semplificazione che necessariamente devono
contrassegnarlo, considerando le posizioni soggettive fatte valere - a quello di cui agli artt. 14-ter e
69 dell'ordinamento penitenziario, che prevede la procedura del reclamo al magistrato di
sorveglianza nelle materie indicate dalla prima di tali disposizioni.” E, ancora, che altre soluzioni,
in particolare quella con la partecipazione dell’interessato costituirebbero “modello esorbitante la
necessaria semplificazione della procedura, da attuarsi attraverso il pronto intervento del
magistrato di sorveglianza così da omettere, almeno in parte, gli indugi della seriazione generale
prevista dal codice di procedura penale.” Resta solo un passaggio oscuro nella motivazione della
Suprema Corte, laddove si afferma che “la semplificazione della procedura resta in gran parte
ridimensionata dalla possibilità di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza secondo il
modello prefigurato dall'art. 14-ter della legge adesso ricordata”. In effetti l’art. 14 ter è
applicabile per il modello di procedimento, ma nelle procedure prese a tertia comparationis (69
comma 6), laddove la competenza sul reclamo è prevista in capo al Magistrato di Sorveglianza, non
è assolutamente ammesso un ulteriore reclamo intermedio al Tribunale di Sorveglianza. Né avrebbe
pregio il tentativo di costruire un parallelo con la procedura di cui al novellato articolo 18 ter O.P.,34
in materia di corrispondenza. In tali casi vi è effettivamente un reclamo ex art. 14 ter al Tribunale di
Sorveglianza contro un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. Ma il provvedimento del
Magistrato di Sorveglianza è proprio l’atto che dispone la limitazione di cui si duole il condannato.
Nei casi di cui stiamo trattando l’atto che si assume lesivo è quello dell’Amministrazione e
l’intervento del Magistrato di Sorveglianza è già una forma di reclamo. Semmai, ci si potrebbe
domandare perché la legge 95/2004 abbia attribuito la competenza in tema di reclamo al giudice
collegiale e se da ciò non si possano trarre argomenti per desumerne, a posteriori, l’opportunità di
analoga soluzione per la tutela dei diritti in genere. Tale suggestione non è convincente: la
procedura di cui all’art. 18 ter è permeata di maggiori garanzie (la più evidente è che la limitazione
del diritto proviene da organo giurisdizionale, il Magistrato di Sorveglianza) proprio perché si tratta
della tutela di diritto costituzionalmente garantito e con garanzia di giurisdizione: art. 15 comma 2
Cost. Ne risulta confermato che l procedura applicabile è quella di cui all’art. 14 ter: reclamo al
Magistrato di Sorveglianza e ricorso per Cassazione, udienza senza la presenza delle parti.
18. (segue) l’effettività della tutela.
Ciò posto, si impone almeno un doppio ordine di considerazioni, a garanzia della effettività
della tutela.
Il primo interrogativo riguarda l’individuazione delle possibilità di selezionare, tra tutte le
doglianze che pervengono alla Magistrato di Sorveglianza, quali debbano comportare l’adozione
della procedura in esame. Il problema non è tanto rispetto alle ipotesi in cui sia applicabile una
procedura diversa, visto che queste sono ipotesi espressamente previste (es. corrispondenza), oppure
ipotesi che ricadono nella giurisdizione generale (es. azione per risarcimento danni da colpa
34
Legge 8 aprile 2004, n. 95
medica), ma quelle in cui resti utilizzabile la via, interamente amministrativa, dell’art. 35 O.P. Non
il confine interno, ma il confine esterno.
Si tratta di un aspetto che incide pesantemente sulla efficacia della tutela, posto che, come è ben
noto a chi svolge le funzioni di Magistrato di Sorveglianza, molto spesso è la stessa materiale
difficoltà di governare la massa delle istanze, denuncie, segnalazioni a rendere tardiva e inefficiente
la tutela. Detto in altri termini, una indiscriminata attuazione di tali modelli per ogni segnalazione
ricevuta non solo rischia di comportare la paralisi della attività, ma renderebbe pressoché
impossibile la selezione dei casi: la diluizione degli interventi su una miriade di casi ne eliderebbe
la capacità di penetrazione.
In effetti, per le ragioni viste sopra, la linea di confine sembra dover essere quella delle
aspettative di mero fatto: non è azionabile la procedura a fronte di doglianze che non coinvolgano
lesione di posizioni giuridicamente tutelate, ma mere aspettative. Tale selezione non è detto però
che sia così efficace: anche solo implicitamente, la più gran parte delle doglianze può andare a
concernere interessi teoricamente meritevoli di tutela (incontrare persone o ricevere oggetti può
consentire l’espressione della personalità, il diritto di manifestazione del pensiero, del credo
religioso, ecc. mentre molte condotte o situazioni potrebbero incidere, almeno in teoria, sul diritto
alla salute). Non solo, ma occorre tener ben ferma la distinzione tra allegato fondamento della
domanda, da un lato e fondatezza della medesima, dall’altro. Se implicitamente o esplicitamente
una domanda afferma di denunciare una violazione di un diritto, la causa pretendi è quel diritto, e la
procedura va attivata. La domanda sarà poi ritenuta infondata, ma la procedura è doverosa.
Viene allora da domandarsi se il sistema non manchi di uno strumento di selezione, quale, per
l’art. 666 c.p.p. il rilievo della manifesta infondatezza o della mera reiterazione.
Ma esiste un altro profilo problematico, ancora più grave, in termini di efficacia della tutela:
quello della attuazione della decisione del Magistrato di Sorveglianza. Si tratta di un terreno non
particolarmente esplorato.
La soluzione, in diritto, dipende dalla natura che si voglia attribuire all’intervento del
Magistrato di Sorveglianza. Sono ipotizzabili almeno tre diverse ricostruzioni. Quella di giudizio di
annullamento su atti; quello di accertamento di fatti; quello di accertamento e condanna.
Nella prima configurazione, al Magistrato di Sorveglianza spetterebbe solo di verificare la
legittimità di un provvedimento della P.A. ed eventualmente annullarlo.
Nella seconda configurazione il Magistrato di Sorveglianza dovrebbe accertare la situazione di
fatto e se questa sia conforme a diritto, con una pronuncia dichiarativa.
Nella terza dovrebbe accertare quanto appena espresso e ordinarne la rimozione, il suo
provvedimento costituendo titolo esecutivo contro la P.A.
La prima soluzione sconta la difficoltà rappresentata dal fatto che molto spesso a ledere i diritti
non sono tanto singoli provvedimenti espressi, ma scelte organizzative generali, se non addirittura
mere situazioni materiali.
La terza è, di fatto, tendenzialmente respinta dalla stessa giurisprudenza (da ultimo, la sentenza
della Corte di Appello di Roma in tema di lavoro, affermava a chiare lettere di presupporre
l’impossibilità per il Magistrato di Sorveglianza di condannare la P.A.). Tra l’altro, dal lato della
Amministrazione, è fortemente dubbio che sarebbe costituzionalmente legittima la possibilità di
ottenere un titolo esecutivo, con cadenze di contraddittorio così semplificate. Questa soluzione
sarebbe probabilmente incostituzionale.
Resta sul campo la soluzione mediana.
In ogni caso, l’ottemperanza alla decisione rimane un aspetto problematico, qualunque sia
l’opzione che si adotta.
Anche sotto questo aspetto, si possono ipotizzare soluzioni molto diverse.
La più “forte” (ragionando in termini teorici: non mi risulta abbia precedenti) è ritenere che
quanto previsto dall’art. 69 comma 5 O.P. significhi che le direttive del Magistrato di Sorveglianza
si sostituiscono a quelle del vertice della Amministrazione (che sarebbe una sorta di commissario
ad acta ex lege), con conseguente immediato dovere degli operatori penitenziari di attuare la
decisione, disapplicando gli eventuali ordini contrari di Direttore, Provveditorato e Dipartimento. In
tale ricostruzione il potere di ingerenza del Magistrato di Sorveglianza assumerebbe un contenuto
invasivo nell’area dell’Amministrazione di eccezionale (e forse non opportuna) rilevanza. E’
quantomeno dubbio che questo fosse il significato della norma in esame.
Nell’ipotesi in cui si ritenesse il provvedimento una condanna, sarebbero attivabili le reazioni
per l’inottemperanza al giudicato, con tutti i problemi ben noti, rispetto all’esecuzione coattiva di un
facere, per di più da parte della P.A.
Se invece si ritiene che il provvedimento sia un accertamento, l’effetto della decisione è
limitato alla dichiarazione di illegittimità di un certo assetto. Tale accertamento non ha però effetti
diretti dal punto di vista esecutivo. Potrà essere semmai oggetto della valutazione incidentale
quando sorga un diverso giudizio (disciplinare o penale) sulle eventuali responsabilità. E’ però
quantomeno dubbio che tale accertamento sia vincolante in quelle sedi.
In questa prospettiva, allora, l’esito complessivo non può che ritenersi largamente
insoddisfacente, sul piano della effettività, non ostante l’importanza delle affermazioni di principio
che hanno costituito il punto di partenza delle riflessioni
19. La sospensione delle ordinarie regole di trattamento ex art. 41 bis O.P. La prova della
permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata.
Circa poi gli aspetti particolari e in particolare la tutela dei soggetti sottoposti al regime di
sospensione delle normali regole di trattamento, la mia attenzione si limita, al profilo della prova
del permanere del collegamento con la criminalità organizzata, che costituisce il vero e proprio
punto dolente ricorrente per chi si occupa della materia.
La prima considerazione che deve essere svolta è che l’espressione prova dei collegamenti (e,
più in generale, della pericolosità particolarmente qualificata su cui si fonda il provvedimento
ministeriale) è, a ben vedere, impropria.
Impropria se si pensa di esportare al giudizio in esame lo strumentario concettuale della prova
in senso pieno di cui al giudizio di cognizione. La stessa Corte di Cassazione, con un orientamento
costante in tutta la materia di competenza della Magistratura di Sorveglianza, ha sempre sottolineato
le particolarità del giudizio di pericolosità e la sua differenza rispetto al giudizio di responsabilità.
Da ultimo, e proprio con riferimento alla materia dell’art. 41 bis O.P., ha, ad esempio, affermato che
“Va aggiunto, peraltro, che l'art. 41-bis O.P. mira a prevenire che attraverso il mantenimento dei
contatti tra il detenuto e le organizzazioni esterne possano essere messi in pencolo l'ordine e la
sicurezza pubblica. Il regime differenziato in esame non è, infatti, una sanzione per il reato
commesso, ma una misura diretta ad evitare, in via preventiva, il pericolo del turbamento
dell'ordine pubblico: di conseguenza non è necessario l'accertamento con la certezza propria del
giudicato della commissione di uno dei reati previsti dalla disposizione in esame, ma è sufficiente
che vi siano elementi quali possa desumersi la "commissione" di uno di tali reati, elemento certo,
che secondo la stessa legge, è costituito dalla detenzione di titoli di reato disposta dal giudice.”
Tale decisione esamina il profilo della valenza della pendenze giudiziali rispetto ai reati di cui
all’ipotesi accusatoria, ma è evidente che si tratta di affermazioni perfettamente esportabili a ogni
frazione del giudizio di pericolosità. Non di prova in senso proprio, ma di indizi gravi, puntuali
concordanti, si deve trattare. I relativi provvedimenti devono essere motivati in modo completo,
rigoroso e convincente sulla sussistenza dei relativi presupposti ma concettualmente non vanno
confusi i profili della prova in senso proprio, che sono estranei al giudizio di pericolosità.
Quanto poi al contenuto della prova (nel senso appena precisato) della permanenza dei
collegamenti, è sorto un problema correlato alla nuova dizione della normativa. In effetti, laddove si
stabilisce35 che “i provvedimenti (…) sono prorogabili (…) purché non risulti che la capacità del
detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive
sia venuta meno”, si crea lo spazio per un interrogativo: la proroga è da disporsi salvo che il
soggetto detenuto provi che i collegamenti sono venuti meno ? Vi è una presunzione legale di
permanenza dei collegamenti correlata a una inversione dell’onere della prova (nel senso predetto) ?
Tale affermazione sarebbe probabilmente in contrasto con la Costituzione.36 Tradizionalmente,
si afferma, per tre motivi. Il primo è che si tratterebbe di provare un fatto negativo, probatio
diabolica. Il secondo è che si tratterebbe di una presunzione contra reum, il terzo che si tratterebbe
di una presunzione non ragionevole.
In effetti, ci sono ragioni a mio avviso per ritenere che il motivo più fondato sarebbe il terzo.
Non è propriamente vero che la prova sarebbe impossibile: più che provarsi il fatto negativo, si
tratterebbe infatti di provare il fatto incompatibile (con la persistenza dei collegamenti): la
collaborazione, la dissociazione, il venir meno dell’organizzazione criminale, il decorso di un
tempo incompatibile con il loro permanere, ecc.
Né del tutto convincente sarebbe il riferimento alla presunzione di non colpevolezza, posto che
nella fattispecie non è in gioco la colpevolezza (ma si tratta del giudizio di pericolosità).37
E’ vero invece che una generalizzata presunzione di permanenza, senza limite, di permanenza
dei collegamenti non sarebbe legittima, perché equiparerebbe, pur salva la prova contraria,
situazioni diversissime, nelle quali non è uguale la probabilità di permanenza dei collegamenti.
La disposizione, del resto, si presta agevolmente a non essere interpretata nel senso di prevedere
una tale presunzione: ma ha un significato diverso. Disciplina, a mio avviso, il modo di operare
dell’istruttoria dell’Autorità Centrale. Poiché, nel nuovo regime dell’art. 41 bis, scende il
“giudicato” sul carattere indiziante38 dei fatti indicati nel primo decreto (di applicazione)39, tali fatti
e il loro potere indiziante costituiscono un punto di partenza assodato. L’istruttoria del Ministero
deve allora vertere sulla eventuale modificazione del quadro. E’ onere dell’Autorità: a) porre in
essere una istruttoria in tal senso; b) motivare sugli esiti di tale istruttoria e sul permanere, alla luce
di essa, dell’originario collegamento. L’onere della prova del permanere dei collegamenti grava sul
Ministero, ma, tenuto conto della natura dei medesimi (normalmente idonei a permanere per un
certo tempo), è sostanzialmente diverso il contenuto di tale onere tra l’ipotesi in cui si tratti di
provare che tali collegamenti sono esistiti, come fatto storico, e che essi, ormai accertati come fatti
verificatisi, permangono. Ciò, vale la pena di ribadirlo, non si traduce, di fatto, in una soluzione
equivalente all’affermazione di una presunzione legale di permanenza dei collegamenti, visto che, a
differenza dell’ipotesi in cui tali collegamenti fossero presunti:
a) il Ministro deve compiere una apposita istruttoria (che ha però ad oggetto i soli fatti nuovi);
b) il Ministro deve motivare sugli esiti di tale istruttoria.
Si noti, inoltre, quanto al contenuto di tale istruttoria, che esso appare dover essere il seguente.
Essenzialmente, richieste agli organi investigativi circa l’eventuale mutamento del quadro
indiziario, probatorio o giudiziario, e acquisizione di eventuali provvedimenti giurisdizionali (nuove
35
Art. 41 bis comma 2 bis O.P.
36
C. Cost. 376/1997, C. Cost. 349/1993
37
C.Cost. 5/12/1997, n. 376
38
Figura di giudicato anomala, almeno nel senso che è il giudicato sulla pericolosità in un momento dato e sul
valore indiziante di certi fatti ai fini di tale pericolosità.
39
Cass. Sez. I 12/12/2003, P.G. in proc. Mazzitelli, Ced Cass. RV. 226471
condanne o assoluzioni, ecc.). Si tratta di adempimenti di agevole realizzazione. Inoltre, costituisce
fatto doverosamente valutabile, e dal provvedimento ministeriale e dal Tribunale di Sorveglianza, il
decorso del tempo. Anche esso è una variabile da tenere in conto, tale da erodere progressivamente
il fondamento indiziante dei fatti di cui al primo accertamento. Tale impostazione si inserisce
perfettamente nella ricostruzione fino qui seguita. Valutate tutte le circostanze del caso concreto
anche il decorso di un cospicuo lasso di tempo finisce per essere un fatto nuovo che può escludere il
permanere dei collegamenti.
Ciò si traduce nella necessità che con il susseguirsi delle proroghe la verifica della
permanenza dei presupposti vada fatta con crescente rigore, istruttorio e argomentativo.
Si tratta di materia nella quale non possono formularsi regole automatiche, ma solo principi
tendenziali, la cui applicazione è rimessa alla prudente discrezionalità (dell’organo ministeriale e
del Tribunale di Sorveglianza).
Al di là degli accenti formali, non è diversa sul punto la giurisprudenza più recente della Corte
di Cassazione, laddove afferma che: la disposizione contenuta nell'art. 41 bis, comma 2, ord. pen.
svela la sua coerenza a tale insegnamento, ove sia interpretata nel senso che le limitazioni al
trattamento possono essere adottate solo in presenza di positivi, dimostrati, motivati elementi, che
comprovino la permanenza dei legami con l'associazione di appartenenza, e che le proroghe
possono intervenire solo in assenza di positivi, dimostrati elementi circa la rescissione dei legami
con l'associazione di appartenenza e purché sorrette da adeguata motivazione in ordine alla
permanenza dei pericoli attuali per l'ordine pubblico e la sicurezza che le misure stesse mirano a
prevenire.
Ne consegue che, una volta verificata, con sentenza passata in giudicato, l'affiliazione del
detenuto ad associazioni criminali di stampo mafioso (oppure verificata, comunque, la sussistenza
di gravi indizi in tal senso da parte dell'Autorità giudiziaria procedente nelle ipotesi di
procedimenti pendenti), la permanenza del vincolo associativo può ritenersi connaturata
all'ontologia di tali associazioni, con quanto è consentito indurne, pur sempre con rigorosa
motivazione in punto di attualità, in ordine all'inidoneità di un ordinario regime detentivo ad
interrompere l'attività del sodalizio mafioso e la capacità di collegamenti con l'esterno del recluso.
Tali argomenti appaiono coerenti al senso della lezione della Consulta e a quanto affermato da
questa Corte con riguardo all'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, che ha introdotto un principio
di presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata da parte di chi è stato
condannato per i delitti in esso indicati e consente la concessione di misure alternative alla
detenzione soltanto nel caso che emergano elementi idonei a determinare il superamento di detta
presunzione (Sez. 1^, 24.7.2000, n. 2761, ric. D'Avino, riv. 216598).
È indubitabile, comunque, che, in sede di controllo giurisdizionale del Tribunale di
sorveglianza, una volta che le circostanze concrete che connotano la fattispecie e che siano state
oggetto di congrua motivazione, lascino operare la succitata presunzione relativa alla persistente
adesione al contesto mafioso, il ricorrente ha la facoltà di esercitare un mero onere di allegazione onere che costituisce l'in sè della dialettica processuale - funzionale a superare la presunzione
relativa sopra ricordata.”40
La Corte, in apparente difformità da quanto espresso qui, si pronuncia per la sussistenza di una
presunzione relativa. Essa tuttavia ribadisce la necessità di specifica e rigorosa motivazione sulla
attualità del collegamento, di tal che la differenza sembra fortemente stemperarsi. Essa addirittura
non esiste, nella misura in cui si ritenga comunque necessaria per il Ministero la previa richiesta
(peraltro assai agevole) agli organi investigativi delle eventuali modifiche della situazione e un
richiamo sul punto nella motivazione della proroga.
40
Cass. Sez. 1, 5/03/2004, n. 20943 Garonfolo
Ovviamente importante, in questo quadro, una volta che il Ministero abbia assolto il proprio
onere, l’allegazione di eventuali circostanze contrarie da parte dell’interessato, come insegna il
Supremo Collegio: “Tutt'al più, si potrà ritenere che sussista a carico dell'interessato un onere di
allegazione degli elementi di fatto da cui sia possibile dedurre che la capacità di mantenere i
collegamenti con l'esterno sia venuta meno; ma su tali allegazioni il giudice avrà comunque
l'obbligo di esprimere motivatamente il proprio giudizio.”41
41
Cass. Sez. I, 26/01/2004, n. 417 Madonia