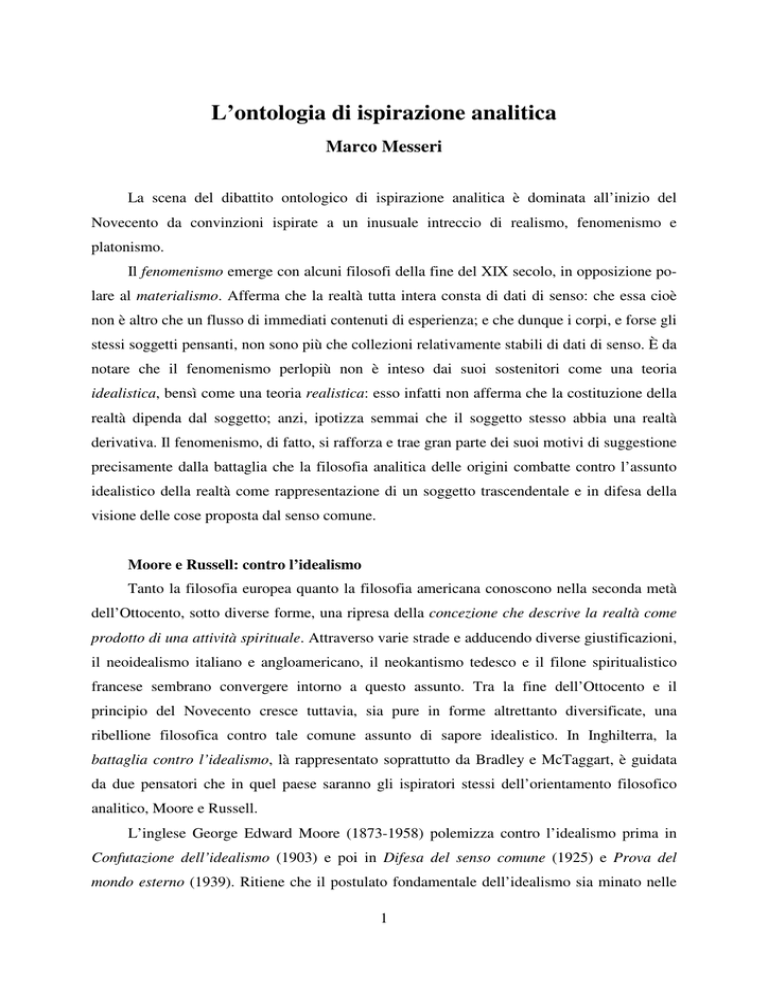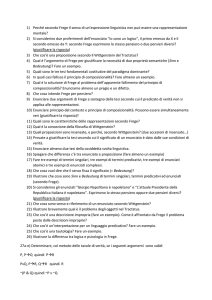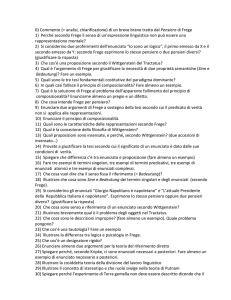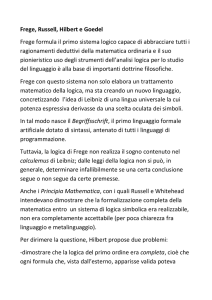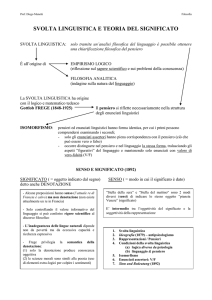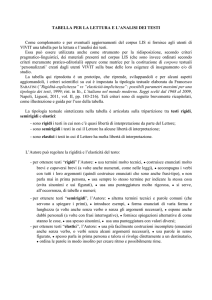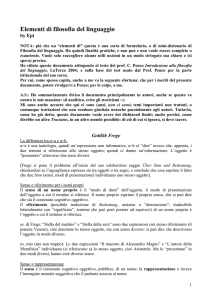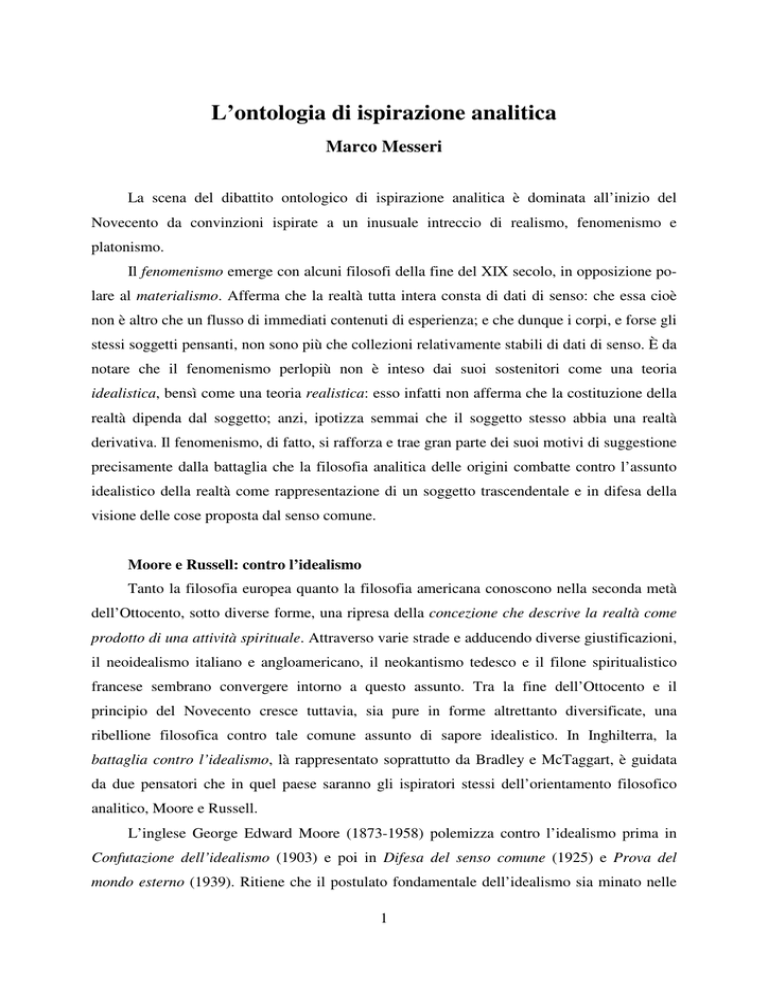
L’ontologia di ispirazione analitica
Marco Messeri
La scena del dibattito ontologico di ispirazione analitica è dominata all’inizio del
Novecento da convinzioni ispirate a un inusuale intreccio di realismo, fenomenismo e
platonismo.
Il fenomenismo emerge con alcuni filosofi della fine del XIX secolo, in opposizione polare al materialismo. Afferma che la realtà tutta intera consta di dati di senso: che essa cioè
non è altro che un flusso di immediati contenuti di esperienza; e che dunque i corpi, e forse gli
stessi soggetti pensanti, non sono più che collezioni relativamente stabili di dati di senso. È da
notare che il fenomenismo perlopiù non è inteso dai suoi sostenitori come una teoria
idealistica, bensì come una teoria realistica: esso infatti non afferma che la costituzione della
realtà dipenda dal soggetto; anzi, ipotizza semmai che il soggetto stesso abbia una realtà
derivativa. Il fenomenismo, di fatto, si rafforza e trae gran parte dei suoi motivi di suggestione
precisamente dalla battaglia che la filosofia analitica delle origini combatte contro l’assunto
idealistico della realtà come rappresentazione di un soggetto trascendentale e in difesa della
visione delle cose proposta dal senso comune.
Moore e Russell: contro l’idealismo
Tanto la filosofia europea quanto la filosofia americana conoscono nella seconda metà
dell’Ottocento, sotto diverse forme, una ripresa della concezione che descrive la realtà come
prodotto di una attività spirituale. Attraverso varie strade e adducendo diverse giustificazioni,
il neoidealismo italiano e angloamericano, il neokantismo tedesco e il filone spiritualistico
francese sembrano convergere intorno a questo assunto. Tra la fine dell’Ottocento e il
principio del Novecento cresce tuttavia, sia pure in forme altrettanto diversificate, una
ribellione filosofica contro tale comune assunto di sapore idealistico. In Inghilterra, la
battaglia contro l’idealismo, là rappresentato soprattutto da Bradley e McTaggart, è guidata
da due pensatori che in quel paese saranno gli ispiratori stessi dell’orientamento filosofico
analitico, Moore e Russell.
L’inglese George Edward Moore (1873-1958) polemizza contro l’idealismo prima in
Confutazione dell’idealismo (1903) e poi in Difesa del senso comune (1925) e Prova del
mondo esterno (1939). Ritiene che il postulato fondamentale dell’idealismo sia minato nelle
1
sue stesse basi da un equivoco concettuale. Gli idealisti infatti credono di potere sostenere che
tutta la realtà è oggetto della nostra coscienza, solo perché identificano erroneamente l’oggetto della nostra esperienza cosciente col contenuto di tale esperienza stessa. Oggetto e
contenuto tuttavia dovrebbero essere tenuti attentamente distinti: oggetto è la cosa percepita
tramite l’esperienza cosciente; contenuto è invece la modalità di presentazione sotto la quale
la cosa stessa è coscientemente percepita. Oggetto e contenuto non coincidono tra loro. Il fatto
è che la relazione tra una esperienza cosciente e il suo contenuto è una relazione interna. Essa
contribuisce a determinare l’identità dell’esperienza stessa: se l’esperienza cambia il suo
contenuto, si trasforma in un’altra esperienza; per es., in una persona che mette a fuoco la
visione, passando da un’immagine parzialmente sfocata a una più precisa, muta lo stato di
coscienza. Invece, la relazione tra l’esperienza e il suo oggetto è una relazione esterna. Si
tratta infatti di un rapporto estrinseco, che non determina l’identità dei relati, e perciò non li
modifica quando viene ad essere o cessa di essere: il vaso da fiori che guardo non cambia per
il fatto che io lo guardo.
Moore si sente dunque di difendere il realismo caratteristico del senso comune. Tale
realismo non deve essere messo da parte come una posizione ingenua: non c’è niente di
inconsistente
nell’assumere
che
le
cose
di
cui
facciamo
esperienza
sussistano
indipendentemente dalla nostra esperienza stessa. Beninteso, Moore non vuole difendere tutte
le credenze del senso comune. Egli concede senz’altro che molte di esse siano radicalmente
erronee. Riconosce inoltre che le credenze del senso comune sono storicamente variabili.
Moore difende piuttosto il nucleo concettuale del senso comune, che persiste attraverso la
storia e assicura una giustificazione preliminare a tutte le diverse possibili imprese conoscitive
umane: la credenza che esista un mondo esterno; che di esso faccia parte un corpo, quello che
chiamiamo il nostro corpo, più direttamente soggetto alla nostra volontà e veicolo delle nostre
esperienze; che tramite questo corpo noi possiamo agire nel mondo esterno; e così via.
Esattamente come il senso comune ha sempre ritenuto, la realtà del mondo esterno è provata
infinite volte, a giudizio di Moore, dagli innumerevoli oggetti materiali che noi incontriamo
nella nostra esperienza quotidiana, per es. dal fatto ovvio che noi possiamo vedere e mostrare
agli altri le nostre mani.
L’inglese Bertrand Russell (1872-1970) condivide pienamente la battaglia contro l’idealismo impegnata dall’amico Moore. Scrive Russell, ricordando con garbata autoironia il
loro comune punto di vista: «Con la sensazione di evadere da una prigione, ci permettemmo
2
di credere che l’erba è verde, che il sole e le stelle esisterebbero anche se nessuno le
percepisse, ed anche che c’è un mondo pluralistico senza tempo di idee platoniche». Tanto
Moore quanto Russell credono infatti alla realtà degli universali. Moore riconosce tra questi i
valori, oggetto dell’etica e delle altre discipline valutative. Russell per parte sua insiste
soprattutto sul ruolo degli universali nel funzionamento semantico del linguaggio. Il nuovo
realismo troverà seguaci numerosi soprattutto nell’ambito della filosofia americana.
Russell: dalla realtà dei dati di senso al fenomenismo
Tra le cose che sono oggetto della nostra esperienza e che sussistono indipendentemente
dalla nostra esperienza stessa, Moore ammette anche i «dati di senso»: le qualità, posizioni,
disposizioni, durate, che noi percepiamo immediatamente attraverso i sensi. In effetti Moore
non ha mai voluto pronunciarsi in modo perentorio circa la questione del rapporto tra dati di
senso e realtà. Non si è mai spinto in particolare fino a sostenere il fenomenismo e a ridurre
tutta la realtà empirica a dati di senso. Egli si limita piuttosto a riconoscere i dati di senso
come parte della realtà.
È Russell invece a farsi sostenitore del fenomenismo, soprattutto in La nostra
conoscenza del mondo esterno (1914), Misticismo e logica (1918) e L’analisi della mente
(1921). Russell pensa infatti che tutte le parole del nostro linguaggio possano essere risolte
attraverso un processo di analisi logica, o, come egli dice, di «costruzione logica», in nomi
elementari, che designano degli universali oppure dei dati di senso. Gli oggetti materiali, così
come gli stati e i processi mentali, non sono altro che combinazioni molto complesse di dati di
senso. In conformità col punto di vista che era stato di Berkeley e di Hume, un corpo per
Russell non è altro che l’organizzazione complessiva di una serie di dati di colore, odore,
calore, pressione, resistenza, consistenza, etc.: una organizzazione che non necessariamente
conserva permanentemente inalterati i suoi componenti, ma che comunque li vede almeno
variare in maniera coordinata. Non c’è una sostanza che soggiaccia alle qualità sperimentabili
nella materia. Analogamente, la mente non è una sostanza che soggiaccia ai fenomeni
mentali, ma la semplice organizzazione coordinata dei fenomeni mentali stessi. Tutta la realtà,
per il Russell dei primi decenni del secolo, si risolve in un flusso di dati di senso.
È importante soprattutto notare come, per lui, il fenomenismo non sia affatto in contrasto col rifiuto dell’idealismo: d’accordo con Moore, Russell accusa l’idealismo di
confondere l’oggetto dell’esperienza con il suo contenuto. Egli si ritiene realista appunto in
3
virtù del fatto di distinguere tra i due, e non attribuisce al realismo proprio e di Moore una necessaria vocazione materialistica: anche il dato di senso è oggetto e non contenuto dell’esperienza; scivolerebbe nell’idealismo, secondo il Russell di questo periodo, solo il fenomenista che identificasse la sensazione, cioè l’evento soggettivo dell’esperienza, col dato di
senso, che costituisce invece il suo correlato oggettivo.
Avenarius e Mach: il monismo fenomenista
Il nuovo realismo che si origina dalla polemica analitica contro l’idealismo non nasce
dunque contraddistinto dall’assunto materialistico della irriducibilità degli oggetti corporei ai
dati di senso. Soprattutto con Russell, esso va anzi ad incontrare un fenomenismo di tipo
monista, e cioè sostenitore della riducibilità tanto della mente quanto della materia a un unico
genere di entità di base, che nella filosofia continentale era stato sviluppato da filosofi di
ispirazione positivista come Avenarius e Mach. Il tedesco Richard Avenarius (1843-1896),
già negli ultimi vent’anni del XIX secolo e soprattutto in Critica dell’esperienza pura (18881890), sostiene che effettivamente reale è solo l’«esperienza pura»: il flusso dei dati, che in se
stesso non è né fisico né psichico. L’esperienza pura infatti è anteriore alla distinzione tra
soggetto e oggetto: i corpi e l’io non sono che aggregazioni relativamente persistenti di dati.
Per Avenarius, il pensiero opera, organizzando i dati dell’esperienza pura tramite reticoli
concettuali astratti, che hanno la funzione di semplificare la memorizzazione dei dati e di
facilitarne l’applicazione, contribuendo, secondo il principio del «minimo sforzo», ad adattare in maniera economica l’organismo umano al suo ambiente. Avenarius ritiene inoltre
che la filosofia debba risolversi in una critica della conoscenza, avente per scopo di mettere in
luce il reale fondamento che la conoscenza stessa trova entro l’esperienza pura e a combattere
le degenerazioni metafisiche che la imprigionano nelle astrazioni concettuali. In ragione di
questa
interpretazione
dei
compiti
della
filosofia,
egli
designa
col
nome
di
«empiriocriticismo» la propria proposta teorica.
Le vedute sviluppate dall’austriaco Ernst Mach (1838-1916), scienziato e storico della
scienza oltre che filosofo, sono affini a quelle di Avenarius. Come Avenarius, in Analisi delle
sensazioni (1886) e Conoscenza ed errore (1905) Mach nega che la realtà consti di sostanze
materiali e spirituali. La realtà è piuttosto un fluire spazio-temporale di dati di senso. I dati di
senso sono infatti gli «elementi» che noi possiamo trovare alla base di tutte le entità materiali
e spirituali riconosciute dal senso comune e dalla scienza. Nessuna di tali entità è dunque una
4
«sostanza» o una «cosa in sé», soggiacente alle qualità direttamente sperimentate, bensì solo
un «complesso» di tali qualità stesse, e cioè un insieme di fenomeni.
La conoscenza non può superare il piano dei dati e d’altra parte non ha bisogno di farlo:
infatti, se i fenomeni non hanno dei fondamenti extrafenomenici, c’è un numero imprecisabile
di relazioni funzionali, esprimibili da leggi più o meno facilmente memorizzabili, e talvolta
anche formulabili matematicamente, che reggono la variazione coordinata dei fenomeni
attraverso lo spazio e il tempo. Il concetto di «funzione» dovrebbe dunque prendere il posto di
quello di «causa» nella descrizione della realtà. La sola persistenza che è dato di riscontrare è
quella della connessione funzionale tra i dati stessi. Nella sua storia della meccanica, Mach
insiste sulla irrilevanza scientifica dei presupposti metafisici, primi tra tutti lo spazio e il
tempo assoluti, che Newton ha affiancato alle semplici correlazioni funzionali dei dati, nell’edificare la nuova scienza del movimento.
Secondo Mach, è l’esigenza di prevedere le trasformazioni dell’ambiente per potere
intervenire in esso, che ci spinge a notare i raggruppamenti di dati di senso che si presentano
con maggiore frequenza. Il fatto è che il continuo dei dati di senso non comprende né
complessi di dati assolutamente solidali né congerie di dati totalmente caotiche: gli elementi
che compongono ciascun complesso variano, ma variano con diverso grado di regolarità. Noi
registriamo mnemonicamente e designiamo attraverso un nome precisamente i complessi di
dati che manifestano un più evidente coordinamento funzionale: sono questi infatti che
riusciamo a prevedere nel loro comportamento in modo più agevole, e che ci offrono dunque
le maggiori opportunità di esercitare un controllo sulla realtà. Anche per Mach, il pensiero ha
una finalità di adattamento biologico ed è retto da un «principio di economia»: sistematizza
concettualmente i dati di senso attraverso classificazioni e correlazioni, e, tra tutte le possibili
sistemazioni concettuali, persegue ed elabora quelle capaci di convogliare il massimo di
informazioni con il minimo di risorse concettuali; i sistemi teorici sono dunque convenzioni
utilitarie e non rappresentazioni della struttura della realtà.
Circa la natura degli elementi, Mach rifiuta ogni posizione dogmatica: come esempio di
elementi, egli cita colori, suoni e altre qualità sensibili, e in generale ogni sorta di impressioni
vissute, ma concede che ulteriori analisi potrebbero individuare dati di livello ancora più
elementare. Nega comunque che la natura degli elementi possa essere qualificata come
materiale o come spirituale, e si pronuncia espressamente a favore del «monismo». Egli infatti
sostiene esplicitamente che gli elementi sono anteriori alla distinzione stessa di mente e
5
corpo: «un colore è un oggetto fisico fintanto che noi consideriamo, per esempio, la sua
dipendenza dalle fonti luminose (altri colori, calore, spazio, etc.); ma se lo consideriamo nella
sua dipendenza dalla retina, esso è un oggetto psicologico, una sensazione». I fenomeni non
sono così di per se stessi rappresentazioni di un soggetto: essi preesistono al soggetto. Come
il corpo, anche l’io è, per Mach, solo un complesso relativamente persistente di dati, e non
una sostanza.
In proposito Mach cita il saggista tedesco del XVIII secolo Georg Lichtenberg (174299), il quale aveva rimproverato a Cartesio di avere commesso una forzatura registrando il
fatto del pensiero nella formula “Io penso” invece che con quelle impersonali “Si pensa”,
“C’è del pensiero”. Quando osserviamo un lampo non presupponiamo che ci sia un soggetto
che lampeggia. Mach scrive che l’esperienza dovrebbe essere considerata in modo altrettanto
impersonale. Come il fenomenismo di Russell, il monismo fenomenista di Mach è agli
antipodi di ogni dottrina idealistica del primato ontologico del soggetto. L’esperienza di
Mach non ha affatto un possessore o una sorgente. Come esperienza senza un soggetto, d’altronde, la intende e la accetta Schlick, che, nel Novecento, porta l’eredità di Mach entro la
tradizione dell’empirismo logico. Analogamente, e del resto per influenza di Schlick, come
flusso di dati senza un soggetto intende l’esperienza anche Wittgenstein, tra la fine degli anni
Venti e i primi anni Trenta, quando le sue posizioni si avvicinano a quelle del Circolo di
Vienna. La tesi del carattere non-soggettivo dell’esperienza, che tutti i promotori del nuovo
fenomenismo riconoscono come ineludibile corollario del fenomenismo stesso, tuttavia, finirà
per retroagire sulle basi della stessa ontologia dei dati di senso, indebolendone la credibilità:
è ancora esperienza un flusso di dati che non è esperienza di nessuno? Russell stesso, in
particolare ne La conoscenza umana (1948), abbandonerà il fenomenismo, precisamente nella
convinzione che il fenomenismo rigoroso dovrebbe risolversi in un paradossale solipsismo
senza un soggetto.
Bolzano e le origini del platonismo
Come accettavano l’esistenza dei dati di senso, Moore e Russell accettavano anche
l’esistenza di entità ideali di tradizione platonica. In ambiente analitico il platonismo si
afferma soprattutto sotto lo stimolo dei problemi posti dall’interpretazione filosofica della
matematica. La matematica della fine dell’Ottocento non era più solo la vecchia scienza delle
figure e dei numeri, ma si trovava a trattare di generi via via più ampi e imprevedivilmente
6
diversi di oggetti: numeri reali, numeri complessi, e poi ennuple ordinate, vettori, insiemi,
spazi topologici, funzioni, serie, grafi, etc. in una dilatazione progressiva di campo che non si
sapeva bene come delimitare. A molti sembrava che il platonismo fosse la soluzione più
lineare: la matematica tratta di un mondo di entità ideali, irraggiungibile per l’esperienza e
accessibile solo alle peculiari procedure intuitive e dimostrative del matematico.
Il boemo Bernhard Bolzano (1781-1848) può essere considerato il promotore di questo
nuovo platonismo. L’indirizzo si afferma nella filosofia europea in polemica con lo
«psicologismo» prevalente tra i logici di ispirazione positivista della seconda metà del secolo
scorso. In particolare, l’inglese John Stuart Mill (1806-1873), che può essere considerato il
maggiore tra i logici positivisti del secolo scorso, aveva inteso appunto la logica come
descrizione dei procedimenti inferenziali caratteristici del pensiero umano, e dunque come
una parte della psicologia. Bolzano rifiuta esplicitamente questo genere di approccio alla
logica. Egli ricorda infatti che compito della logica non è elencare gli schemi secondo i quali
il pensiero umano di fatto costruisce le inferenze, bensì gli schemi che conferiscono validità a
tali inferenze. Il pensiero umano non segue sempre le leggi della logica: quando vi si adegua,
produce inferenze corrette; quando non lo fa, inferenze scorrette. Compito della logica è
indicare le regole secondo le quali gli uomini dovrebbero pensare, non quelle secondo le quali
pensano. La logica non può essere così una parte della psicologia: la psicologia ha un’ottica
descrittiva, la logica normativa; la psicologia studia comportamenti soggettivi, la logica
procedure oggettive.
È in questa prospettiva che Bolzano introduce gli assunti caratterizzanti del platonismo
semantico. Una logica non psicologistica è possibile solo se vi sono delle strutture oggettive
del pensabile. La logica, in particolare, non può avere a che fare col «giudizio», che è un atto
soggettivo e personale di pensiero, ma con la «proposizione», che è il suo contenuto
concettuale oggettivo, vero o falso secondo i casi, suscettibile di essere pensato da persone diverse, in momenti diversi e dunque attraverso atti di pensiero distinti, e di essere espresso da
enunciati di lingue differenti. Non ha inoltre a che fare con la «rappresentazione», che è tanto
soggettiva quanto la connessione di rappresentazioni costituente il giudizio, ma con l’«idea»,
che è il singolo concetto, inteso come elemento oggettivo della proposizione in sé.
La logica non si interessa, per es., del fatto che Carlo, in ogni occasione in cui si trova a
formulare i giudizi “Tutti gli uomini sono mortali” e “Socrate è un uomo”, si senta psicologicamente costretto a formulare l’ulteriore giudizio “Socrate è mortale”. Si interessa
7
invece delle condizioni oggettive che determinano la correttezza dei ragionamenti che Carlo e
gli altri uomini sono in grado di costruire con i loro giudizi, indipendentemente dalle particolari rappresentazioni personali che essi possono convogliarvi, e dalle risonanze che lingue
diverse possono associare ai medesimi concetti. Vi è infatti un’idea in sé della mortalità, che
ha la sua identità oggettiva, malgrado il fatto che possa essere espressa da parole diverse come
“mortale”, come “perituro”, o come “sterblich” (che le traduce in tedesco), e essere associata
a rappresentazioni personali diverse; e questa idea può essere combinata con altre idee in
varie proposizioni in sé, come per es. la proposizione vera che tutti gli uomini sono mortali, la
quale ha una propria identità oggettiva e un proprio comportamento inferenziale caratteristico,
al di là del fatto che essa possa essere asserita in occasioni diverse ed espressa in modi diversi,
come per es. dall’italiano “Tutti gli uomini sono mortali” o dal tedesco “Alle Menschen sind
sterblich”. Il linguaggio trova appunto il suo contenuto, o aspetto semantico, in questo
complesso di pensieri oggettivi e indipendenti dalle forme espressive, complesso rappresentato dalle possibili connessioni delle varie idee in sé e delle varie proposizioni in sé.
Frege: il linguaggio formale
La tesi di Bolzano dell’esistenza di strutture semantiche oggettive ha una ampia
risonanza nel mondo filosofico tedesco. La accolgono in primo luogo il tedesco Gottlob Frege
(1848-1925), e, più tardi, per influenza di Frege, il tedesco Edmund Husserl e gli altri
fenomenologi. La maniera in cui Frege rielabora il platonismo semantico di Bolzano ha alle
spalle gli sviluppi che Frege stesso ha saputo dare alla logica già con Ideografia (1879). Qui,
in primo luogo, Frege mette a punto il linguaggio il cui comportamento inferenziale è studiato
dalla logica matematica, specificando la forma canonica che gli enunciati debbono assumere
per essere inseriti negli schemi di inferenza previsti dalla logica matematica stessa. Egli si
rende conto dei difetti che impediscono alla logica predicativa tradizionale di codificare al
meglio le strutture del ragionamento ammesse dal pensiero scientifico e, specificamente, dal
pensiero matematico. Elaborata entro la matrice originaria dell’essenzialismo aristotelico,
infatti, la logica predicativa tradizionale concentra la sua attenzione sui concetti che
esprimono proprietà e trascura quelli che esprimono relazioni, costruendo per questi ultimi
interpretazioni che risultano forzate e non riescono a dare ragione di tutte le inferenze
possibili con essi: il fatto è che la sillogistica tende a interpretare la relazione come una
giustapposizione di proprietà godute dai relati singolarmente considerati. Le proposizioni che
8
hanno una struttura relazionale non si prestano ad essere analizzate come connessione di un
concetto e di un solo oggetto. È controintuitivo per es. presentare la proposizione che Andrea
è amico di Enzo come risultato dell’applicazione all’oggetto Andrea dell’astruso concetto essere-amico-di-Enzo. Una simile proposizione infatti pare chiamare in causa due oggetti e non
uno soltanto: pare coinvolgere Enzo altrettanto che Andrea. Oltre tutto se si immagina che
nella proposizione il predicato sia predicato di un unico soggetto, dalla proposizione che
Andrea è amico di Enzo diviene impossibile dedurre la proposizione che Andrea è amico di
qualcuno: il concetto essere-amico-di-qualcuno infatti viene ad essere distinto e indipendente
dal concetto essere-amico-di-Enzo. La teoria classica della proposizione dunque non è in
grado di dar conto di tutte la naturalissime inferenze consentite dalle relazioni. Bisogna perciò
abbandonare la teoria classica e fare posto ai concetti di relazione accanto ai concetti di
proprietà. L’incapacità di affrontare in maniera naturale il comportamento inferenziale delle
relazioni aveva conseguenze particolarmente gravi nel campo del ragionamento matematico,
dove le inferenze relazionali giocano un ruolo molto rilevante. Di fatto, anche per questo, i
matematici avevano fatto sempre un uso assai limitato dei risultati della logica e avevano
preferito confidare nella legittimità intuitiva di un corpo di schemi di ragionamento ben più
ampio di quelli codificabili in forma sillogistica.
Frege indica una via per superare questi difetti della logica predicativa tradizionale. Egli
infatti abbandona la concezione ordinaria della struttura dell’enunciato - la concezione dell’enunciato come connessione di un soggetto e di un predicato attraverso una copula -, ed
ammette entro il linguaggio canonico da lui elaborato predicati relazionali di diversa
complessità (predicati monadici, diadici, triadici, etc.) che determinano enunciati applicandosi
simultaneamente a più di un soggetto (i monadici a un solo soggetto, i diadici a due soggetti, i
triadici a tre, etc.). Il linguaggio canonico di Frege include poi nomi che designano particolari
oggetti. Ma include anche delle variabili, che permettono di fare riferimento a oggetti non
specificati, cioè non determinati tramite un nome, come capita quando parliamo in generale di
tutti gli oggetti di un certo tipo o diciamo che c’è un oggetto, senza nominarlo, che gode di
una certa proprietà.
Il linguaggio canonico fregeano include inoltre delle costanti logiche, cioè delle parole
impiegate in ogni caso e in qualsiasi ragionamento, indipendentemente dalla materia specifica
del discorso. Sono costanti logiche i connettivi, gli operatori, cioè, che consentono di costruire
enunciati composti a partire da enunciati più semplici: la negazione “non ...” (che rovescia un
9
enunciato nel suo contraddittorio), la disgiunzione “... o ...”, la congiunzione “... e ...”, l’implicazione “se ..., allora ...”, l’equivalenza “... se e solo se ...” (che si applicano a coppie di
enunciati, ed hanno un comportamento logico studiato già dai megarici e dagli stoici).
Saranno più tardi correntemente indicati rispettivamente dai simboli ¬, ∨, ∧, →, ↔.
Ma nel linguaggio canonico elaborato da Frege c’è anche un secondo genere di costanti
logiche: i quantificatori, necessari per specificare il numero degli oggetti cui il predicato è
riferito quando è applicato a variabili e dunque impiegato per compiere un riferimento
indeterminato: quando facciamo uso di variabili in un enunciato, abbiamo infatti bisogno,
affinché l’enunciato abbia un significato definito, almeno di specificare a quanti oggetti la
variabile sia riferita. I quantificatori prendono il posto dei meno precisi indicatori di quantità
della logica tradizionale (“ogni”, “tutti”, “alcuni”, “qualche”, “un”, etc.). Di particolare
importanza risultano il quantificatore universale (“Per ogni oggetto x”, che traduce in maniera
univoca parole come “ogni”, “tutti”, etc.) e il quantificatore esistenziale (“Esiste un oggetto x
tale che”, che traduce in maniera univoca parole come “qualche”, “alcuni”, “un”, etc.).
Saranno più tardi correntemente indicati rispettivamente dai simboli ∀ e ∃. Applicando un
quantificatore, o, se il predicato è poliadico, un certo numero di quantificatori, a una formula
costituita da un predicato e da variabili, le variabili stesse vengono vincolate, il senso della
formula viene chiarito univocamente e si ottiene un enunciato di senso altrettanto definito che
l’enunciato costituito da un predicato applicato a dei nomi. Così, una frase come “Nessuno
ama tutti” dovrebbe essere resa in forma canonica con un predicato diadico “amare” – per
brevità indichiamolo con A … …, con gli spazi vuoti da riempire con espressioni che si
riferiscano a oggetti individuali –, applicato a oggetti indeterminati, dunque non precisati da
un nome, ma espressi da variabili, e il numero di tali oggetti dovrebbe essere specificato da
opportuni quantificatori: esattamente da due quantificatori, quanti sono i soggetti del
predicato e quante sono dunque le variabili unite a esso. La sua riduzione in forma canonica
potrebbe suonare:
¬ ∃x ∀y Axy,
cioè “Non esiste un x, tale che, per ogni y, x ama y”. La forma canonica prevista da
Frege dissipa tutte le ambiguità create dai pronomi indefiniti del linguaggio ordinario. Così,
“Tutti gli uomini hanno un padre” può essere reso – indicando per brevità con P … … la
relazione “essere padre di” – da
∀x ∃y Pyx
10
se si vuole ammettere, secondo il significato consueto della parola padre, che uomini
diversi possano avere padri diversi; ma verrebbe reso da
∃y ∀x Pyx,
con i quantificatori in ordine inverso, se si volesse intendere che c’è un unico padre di
tutti gli uomini, come lo intenderebbe per es. chi impiegasse la parola padre in un senso
religioso.
L’ordine dei quantificatori è particolarmente prezioso in matematica per il chiarimento
dei concetti fondamentali, si pensi al concetto di limite. Così, p.es., la nozione di limite finito
di una funzione con argomento che tende a un valore finito
lim f(x) = l
x→a
deve essere tradotta, per esprimere in modo rigoroso il concetto di Cauchy, con
un’espressione contenente tre quantificatori:
∀ε ∃δ ∀x ( ε>0 ∧ δ>0 ∧ a–δ < x < a+δ ) → (l–ε < f(x) < l+ε ),
un’espressione che ha un senso molto diverso da quella che invece iniziasse con ∃δ ∀ε
… o con ∀δ ∃ε … .
Frege mostra che in realtà un solo quantificatore è sufficiente per dotare il linguaggio di
pieno potere espressivo: tutti i quantificatori possono infatti essere successivamente definiti a
partire da un solo quantificatore assunto come primitivo. Egli introduce in particolare il
quantificatore esistenziale e definisce il quantificatore universale tramite l’esistenziale e la
negazione. Asserire che ∀x Px non è diverso infatti da asserire che ¬∃x ¬Px. Altri
quantificatori di uso comune in matematica, p.es. ∃! – “esiste uno e un solo” –, possono
facilmente essere definiti con l’uso dei due principali e di altri concetti come l’identità:
∃!x Px ↔df ∃x Px ∧ ∀y ( Py → y = x).
Il linguaggio canonico adottato dalla logica matematica successiva è nella sostanza
quello elaborato da Frege, che contiene variabili e costanti, e assume come costanti logiche
connettivi e quantificatori, e come costanti non logiche nomi e predicati di varia complessità.
Non ha fortuna invece il simbolismo ideato da Frege per esprimere tale linguaggio, che
necessita di una scrittura su due dimensioni e risulta perciò eccessivamente macchinoso. Gli
sarà preferito il simbolismo ideato dal matematico Giuseppe Peano (1858-1932) che consente
di esprimere in modo più agevole le categorie linguistiche fregeane ed è adottato ancora oggi.
11
Frege: l’ontologia platonista
Frege elabora la propria ontologia in Funzione e concetto (1891), Oggetto e concetto
(1892) e Senso e riferimento (1892). Si ricollega al platonismo di Bolzano. Per lui le strutture
individuate dalla logica hanno una portata ontologica: dato che esse sono connessioni di ciò
che è oggettivamente pensabile, appartengono all’essere, anche se evidentemente non all’essere empirico; formano un «terzo regno» distinto tanto dal regno delle cose fisiche quanto dal
regno degli atti soggettivi di pensiero.
L’ontologia di Frege è ricavata dall’analisi del linguaggio. Secondo Frege, infatti, il
funzionamento del linguaggio non può essere analizzato senza adeguate assunzioni
ontologiche. Ogni espressione linguistica si caratterizza infatti per la circostanza di rimandare
a un certo contenuto extralinguistico. A giudizio di Frege, tuttavia, il contenuto semantico dell’espressione è complesso e incorpora due generi distinti di rimando alla realtà
extralinguistica: nel contenuto dell’espressione infatti dobbiamo distinguere il «riferimento»
(Bedeutung, in tedesco) e il «senso» (Sinn, in tedesco), cioè, rispettivamente, la cosa indicata
dall’espressione e il modo in cui, o l’aspetto sotto il quale, la cosa è indicata dall’espressione.
Il pianeta Venere, per es., è il riferimento sia dell’espressione “la Stella del mattino” sia di
quella “la Stella della sera”: con entrambe le espressioni infatti gli antichi indicavano l’oggetto celeste che noi abbiamo scoperto essere il secondo pianeta del sistema solare. Le due
espressioni però hanno un senso diverso. Esse infatti indicano la medesima cosa, ma la
indicano in modi diversi, ovvero sotto aspetti diversi: qualificandola cioè rispettivamente
come ultimo corpo celeste a svanire nel mattino e come primo corpo celeste a brillare la sera.
Tutte le espressioni comprensibili hanno un senso. Non tutte hanno però un riferimento: per
es., sia “Harrison Ford” sia “Indiana Jones” hanno un senso e sono perciò entrambe
comprensibili; ma solo “Harrison Ford” ha un riferimento.
Frege pensa che la distinzione tra riferimento e senso sia resa necessaria dall’analisi dei
giudizi di identità. Egli nota infatti che gli enunciati di identità hanno un valore informativo
molto diverso e ritiene che se il solo rimando alla realtà delle parole fosse il loro riferimento
tale diversità rimarrebbe inesplicabile. Consideriamo p.es. i due enunciati “Napoleone è il
vincitore di Austerlitz” e “Napoleone è Napoleone”. Il primo veicola una conoscenza, il
secondo no. Se le espressioni “Napoleone” e “il vincitore di Austerlitz” indicassero nella
realtà solo il loro riferimento, indicherebbero la medesima cosa, e dunque i due enunciati non
comunicherebbero nient’altro che il fatto banale che quella determinata cosa è se stessa:
12
nessuno dei due potrebbe avere un valore informativo. Se invece – pensa Frege – si
distinguono senso e riferimento, allora si comprende perché il primo enunciato sia
informativo e il secondo no: il primo infatti dice che due espressioni di senso diverso hanno il
medesimo riferimento (cosa che talvolta si verifica, come in questo caso, talvolta no), il
secondo dice solo che una certa unica espressione ha il riferimento che ha (cosa sicuramente
vera, ma anche banale).
Da platonista Frege pensa che riferimento e senso siano parimenti entità oggettive. Egli
tuttavia ritiene essenziale distinguere due tipi di entità oggettive: le chiama rispettivamente
«oggetti» e «funzioni», generalizzando in modo consapevole l’impiego matematico dei
concetti di funzione, argomento e valore. Una funzione infatti, per Frege, non è
necessariamente una operazione numerica. È una funzione qualunque relazione univoca a
destra, qualunque relazione, cioè, tale da associare a un determinato elemento preso entro un
insieme in cui la funzione è definita (dominio), non più di un unico elemento preso nello
stesso o in un altro insieme (codominio), senza che abbia importanza la natura di tali elementi;
anche, dunque, se tali elementi non sono numeri.
Frege dunque chiama oggetti le entità «sature», e cioè le entità autosufficienti, complete
in se stesse, capaci di autonoma sussistenza, o, come dice anche, capaci di essere indicate da
un nome proprio; funzioni le entità «non sature», cioè le entità incomplete che si completano
solo in connessione con altre entità. Il tre, per es., è un oggetto; il successore e la somma sono
invece funzioni: il tre infatti è già una entità determinata; il successore e la somma non sono
entità determinate, lo divengono solo quando vengono completate da altre entità,
trasformandosi, per es., nel successore di quindici o nella somma di quattro e due. Le funzioni
si applicano ad «argomenti» e assumono «valori»: argomenti sono le entità che saturano i
posti vuoti della funzione; valori le entità determinate dalla funzione saturata. Col variare
degli argomenti una medesima funzione può assumere valori diversi. Argomenti e valori poi
possono essere individui, insiemi, coppie ordinate, ennuple, e ogni sorta di oggetti
insiemistici, secondo la maniera in cui la funzione è definita. Ci sono funzioni che per essere
saturate hanno come argomento individui, funzioni che hanno come argomento coppie, terne,
o, genericamente, ennuple. Per es. il successore è una funzione ad argomento individuale, la
somma una funzione che ha come argomento coppie di numeri.
Idea centrale dell’ontologia di Frege è che i sensi delle espressioni siano non oggetti, ma
concetti, e che il concetto possa essere inteso come un particolare genere di funzione. Il
13
concetto ha per sua natura un carattere predicativo. La proposizione, nel senso di Bolzano,
infatti è determinata dal fatto che un certo concetto è predicato di certi oggetti. Il concetto
potrebbe essere inteso allora, per Frege, come una funzione che assume come argomento gli
oggetti che fungono da soggetto, generando proposizioni, e determinando, secondo i casi, una
situazione di verità o di falsità; ovvero, secondo la terminologia che a partire da Frege diverrà
corrente, potrebbe essere inteso come una funzione proposizionale. Il concetto è una funzione
proposizionale che, col variare degli oggetti cui è applicata, assume come valore di volta in
volta uno dei due «valori di verità»: il «vero» se la proposizione generata è vera, il «falso» se
essa è falsa. Il concetto di coniglio sarebbe, p.es., la funzione proposizionale che, applicata ai
vari singoli individui costituenti il mondo, determina il valore vero quando gli individui sono
simpatici roditori dalle lunghe orecchie ghiotti di carote, del genere di Bugs Bunny, e il valore
falso quando essi sono sassi, lucertole, dèi, e così via. Il concetto di padre sarebbe invece la
funzione proposizionale che, applicata alle varie coppie possibili di persone, determina il vero
quando il primo elemento della coppia è un maschio e il secondo è un suo figlio o una sua
figlia, il falso altrimenti.
Infatti, per Frege è fuorviante interpretare la proposizione come applicazione di un
concetto ad una singola entità, come tende invece a fare la logica predicativa tradizionale,
dogmaticamente attaccata all’idea che la proposizione abbia sempre una struttura soggettocopula-predicato. Egli, come ha spiegato nella sua costruzione del linguaggio formale,
ammette concetti che sono funzioni con argomento individui, come essere italiano (concetti
monadici o unari); concetti che sono funzioni con argomento coppie, come essere amico di
(concetti diadici o binari); e così via senza limite prefissato (in una gerarchia di concetti che
prendono come argomenti ennuple di ordine via via più elevato, o, come si dice talvolta, da
crescente adicità o arietà). La proposizione stessa può essere considerata come un concetto
limite: la funzione proposizionale degenerata 0-adica, ovvero un paradossale concetto ad
argomento vuoto.
Frege pensa la distinzione tra concetto e oggetto come rigorosa e assoluta: nessun
oggetto è un concetto e nessun concetto è un oggetto. Perciò egli rifiuta la pretesa caratteristica di una parte del pensiero filosofico, ma anche di una parte del pensiero scientifico,
soprattutto matematico, di ricavare gli oggetti che cadono sotto un concetto analizzando il
concetto stesso, e cioè di dimostrare tramite procedure analitiche l’esistenza di oggetti. Una
simile pretesa è per lui mal concepita perché concetti e oggetti sono tra loro eterogenei e dun-
14
que perché dall’analisi di nessun concetto si può mai stabilire se degli oggetti cadano sotto di
esso e quanti eventualmente siano. Il concetto infatti può sempre risultare contraddittorio: tale
dunque da non potersi applicare ad alcun oggetto. E l’unico modo di stabilire che il concetto
non è contraddittorio è precisamente di esibire un oggetto che cada sotto di esso. Con Kant,
ma per ragioni differenti da Kant, anche Frege nega che un giudizio di esistenza possa mai
essere analitico. L’eterogeneità di concetto e oggetto ha anche altre conseguenze. Se la
proposizione deve essere vista come un genere specifico di concetto, e non come un oggetto,
essa non può essere identificata in particolare con l’oggetto che rappresenta il valore della
funzione data dal concetto stesso. In effetti, i valori di verità di Frege, il vero e il falso, sono
due veri e propri oggetti, anche se oggetti peculiari. Essi sono infatti i due oggetti-limite che
segnano i confini dell’intero campo degli oggetti possibili: il vero è inteso da Frege in qualche
modo come oggetto totale e il falso come oggetto vuoto.
Frege ritiene che riferimento e senso possano sempre essere identificati con qualche
particolare tipo rispettivamente di oggetto o di concetto. L’ordinaria analisi logica del
linguaggio aveva distinto dai vari tipi di espressioni incomplete gli enunciati, cioè le
espressioni suscettibili di dar luogo a un discorso di senso compiuto. Aveva poi individuato
essenzialmente due classi di parole che si combinano tra loro a formare gli enunciati: i nomi,
cioè le parole che svolgono la funzione di designare, ovvero di indicare un oggetto (tutti i
nomi e in particolare i nomi propri); e i predicati, cioè le parole che svolgono la funzione di
predicare, ovvero di qualificare un oggetto (gli aggettivi e i verbi, ma, in certi contesti, anche
alcuni usi del nome). Frege spiega che l’eventuale riferimento di un nome proprio coincide
con l’oggetto singolo da esso denominato e che il suo senso è il «pensiero», fisso e
indipendente dalle associazioni soggettive di idee, che il nome comunica. Il nome proprio
“Harry Potter”, p.es., è privo di un riferimento, perché il personaggio della Rowling non è mai
esistito. Tale nome però ha un senso, e noi, infatti, lo comprendiamo. Il senso, che ci permette
di comprendere il nome, è dato dal pensiero di certe caratteristiche individuanti, come essere
un piccolo mago, essere sfuggito a Woldemort, essere grande amico di Ronald Weasley ed
Hermione Granger, etc., cui pensano subito tutti coloro che hanno imparato il nome,
indipendentemente da eventuali associazioni soggettive fatte di simpatie, antipatie o ricordi
personali. Il senso del nome proprio, dunque, per Frege, è un concetto singolare, cioè una
funzione proposizionale che dà il vero per uno e un solo argomento. Frege identifica poi il
senso del predicato con la funzione che costituisce il concetto universale, e il suo riferimento
15
con la classe di tutti gli argomenti per cui il valore della funzione è il vero. Identifica infine il
senso di un enunciato con la proposizione di Bolzano. Quanto al riferimento dell’enunciato,
Frege lo identifica col valore di verità dell’enunciato stesso: egli arriva a dire che ogni possibile enunciato è solo un diverso nome, secondo il caso, del vero o del falso. Nella
prospettiva di Frege, tutte le espressioni linguistiche sono pensate dunque come se fossero
nomi: il nome proprio come nome del singolo oggetto, il predicato come nome di una intera
classe di oggetti, l’enunciato come nome del vero o del falso.
Per comprendere in particolare la scelta fregeana circa il riferimento dell’enunciato
bisogna analizzare in maniera più precisa le nozioni di senso e di riferimento. Infatti, Frege
considera senso di una espressione ciò che dobbiamo conoscere per potere impiegare l’espressione stessa e riferimento dell’espressione ciò che miriamo a conoscere tramite il suo
impiego. Il senso è la via d’accesso alla nostra indagine, il riferimento il suo scopo. Tramite i
nostri pensieri noi infatti miriamo a conoscere gli oggetti. Ma per Frege è evidente che nel
caso dell’enunciato il nostro interesse conoscitivo è rivolto al valore di verità. Un tale punto di
vista giustifica d’altra parte la scelta di presentare il vero e il falso come oggetti-limite. Infatti,
dire che tutti gli enunciati veri hanno il medesimo riferimento, e che esso è il vero, è dire che
il vero è l’oggetto che riassume ogni obiettivo possibile della nostra conoscenza; dire che tutti
gli enunciati falsi hanno il medesimo riferimento, e che esso è il falso, è dire che il falso è
l’oggetto che riassume ogni pericolo cui è esposta la nostra conoscenza.
Ci sono poi anche degli assunti più generali nella filosofia del linguaggio di Frege che
influenzeranno in modo cruciale gli sviluppi a lui successivi, quattro in particolare. In primo
luogo, Frege assume che l’enunciato può avere un senso solo a patto che tutti i nomi propri
che esso contiene abbiano un riferimento: non dice niente l’enunciato che parla di qualcosa
che non c’è. In secondo luogo, Frege assume che il senso dei predicati può essere compreso
solo passando per la comprensione del senso degli enunciati formati da quei predicati in
congiunzione con i vari nomi propri: capisce il predicato “è rosso” solo chi capisce gli
enunciati della famiglia “x è rosso” per le diverse possibili sostituzioni di “x”. In terzo luogo,
egli lascia anche affiorare l’idea che il senso dell’enunciato sia costituito dalle sue condizioni
di verità: comprendere un enunciato è per lui infatti sapere come dovrebbe essere fatta la
realtà perché quell’enunciato possa essere vero; e comprendere una parola è conoscere il suo
contributo alle condizioni di verità degli enunciati in cui essa compare. Infine, guida la teoria
fregeana del contenuto semantico il principio di composizionalità: il contenuto di un’e-
16
spressione composta è determinato dal contenuto dei suoi componenti; la semplice forma di
combinazione che caratterizza un’espressione composta, cioè, consente a chi conosce il
contenuto delle parole che entrano in essa anche di individuare il contenuto dell’espressione
complessiva. Il principio vale tanto per il senso quanto per il riferimento: Frege ritiene infatti
che il senso di un’espressione composta sia determinato solo dal senso dei suoi componenti e
che il riferimento di un’espressione composta sia determinato solo dal riferimento dei suoi
componenti; non ci possono essere interferenze tra i due piani.
Frege si rende conto che la sua teoria della composizionalità ha un punto debole. Infatti,
se il principio di composizionalità si accorda in modo ovvio con la gran parte degli usi del
linguaggio, esso sembra a prima vista incompatibile col funzionamento semantico dei
«contesti obliqui» o «indiretti», cioè degli enunciati composti da un enunciato subordinato
introdotto da un verbo che esprime il sapere, il credere, il giudicare o simili. È chiaro che nei
contesti obliqui il valore di verità dell’insieme del discorso non è determinato solo dal valore
di verità dell’enunciato introdotto da tale verbo: per quanto “2+2=4” e “Il numero atomico del
berillio è 4” abbiano lo stesso valore di verità, e cioè il vero, non è scontato che abbiano lo
stesso valore di verità enunciati composti come “Giuseppe sa che 2+2=4” e “Giuseppe sa che
il numero atomico del berillio è 4”: Giuseppe infatti può sapere la prima cosa e non la
seconda. Frege si rende conto che nei contesti obliqui il valore di verità è influenzato anche
dalle proposizioni espresse dagli enunciati componenti, e non solo dal loro valore di verità.
Propone perciò di superare la difficoltà identificando il riferimento dell’enunciato contenuto
in un contesto obliquo con il senso che il medesimo enunciato avrebbe quando fosse
impiegato da solo, e cioè con la proposizione espressa dall’enunciato.
Russell: la teoria delle descrizioni
L’ontologia elaborata da Russell alle soglie della Prima guerra mondiale si collega
esplicitamente al complesso di problemi e di concetti messi in campo dall’ontologia fregeana.
Russell riconosce infatti al pensiero di Frege un valore filosofico generale. Non ne accetta
tuttavia la totalità dei contenuti e mira ad alleggerire l’impegno ontologico del platonismo. In
particolare, già con la «teoria delle descrizioni» elaborata nel saggio Sulla denotazione
(1905), egli combatte l’appesantimento che il platonismo aveva ricevuto a opera di Meinong e
in particolare la stravagante ipotesi meinonghiana delle «entità non-esistenti». L’austriaco
Alexius von Meinong (1853-1920) muoveva dal presupposto che il pensiero ha la capacità di
17
riferirsi distintamente a entità che sappiamo inesistenti nella realtà, come draghi e chimere,
oppure addirittura impossibili, come i cerchi quadrati. Ora, chi pensa a un drago, magari per
dire che non esiste, sta comunque pensando a qualche cosa, e non sta pensando alla medesima
cosa cui sta pensando chi, sia pure per concludere che è impossibile, pensa a un cerchio
quadrato. Se draghi, chimere e cerchi quadrati fossero niente, riteneva Meinong, risulterebbe
inesplicabile la varietà di riferimenti di cui di fatto è capace il nostro pensiero. Dunque,
concludeva Meinong, bisogna riconoscere che la sfera delle entità non coincide con quella
delle semplici entità esistenti e neppure con quella delle entità semplicemente possibili. Le
entità intese in senso estensivo postulate da Meinong non erano troppo lontane dai concetti e
dai sensi di Frege, e la sua proposta ontologica era di un platonismo particolarmente radicale.
Russell giudica però una pura contraddizione in termini l’idea di un’entità non-esistente:
entità è appunto ciò che esiste. Per lui «la logica non può ammettere un unicorno più della
zoologia». Elabora allora il concetto di descrizione per mostrare come sia possibile risolvere il
problema filosofico posto da Meinong senza fare ricorso alla proposta teorica di questi, ma
mantenendo due presupposti che gli paiono indiscutibili. In primo luogo, che gli enunciati che
paiono chiamare in causa i cerchi quadrati, gli unicorni e simili hanno un senso, anche se
quelle cose non ci sono: infatti noi comprendiamo benissimo un enunciato come “Gli unicorni
hanno zoccoli”, cui possiamo assentire, ma anche un enunciato come “In Podolia vivono
parecchi unicorni”, che giudichiamo falso proprio perché lo comprendiamo. In secondo luogo,
con Frege, che un enunciato ha un senso solo se i designatori che in esso compaiono hanno un
riferimento. La soluzione che consente a Russell di tenere assieme i due presupposti sarà di
mostrare che quegli enunciati che paiono riferirsi agli unicorni, non hanno in realtà unicorni
come riferimento.
La soluzione del problema ha la forma seguente. Russell chiama «descrizioni» le
espressioni che paiono riferirsi a una cosa specificandola attraverso le sue qualità: sono
«descrizioni definite» quelle introdotte dall’articolo determinativo, come per es. “la capitale
della Francia”; «descrizioni indefinite» quelle introdotte dall’articolo indeterminativo, come
per es. “una capitale europea”. Russell nota, in primo luogo, che le espressioni che
apparentemente si riferiscono a entità non-esistenti non sono mai nomi propri, cioè parole che
indichino direttamente una qualche cosa, bensì sempre delle descrizioni; afferma perciò, in
secondo luogo, che tali espressioni non hanno in realtà una funzione designativa, come i
nomi, bensì solo una funzione predicativa; e mette in chiaro, in terzo luogo, che esse
18
comportano un riferimento esteso solo alle usuali entità esistenti. L’enunciato “L’attuale re di
Francia è calvo” per es. non tratta di una entità determinata ma non-esistente – appunto
l’attuale re di Francia. Tale enunciato va inteso piuttosto come una doppia predicazione
indeterminata. Esso infatti, se indichiamo con C … la proprietà di essere calvo e con R …
quella di essere attualmente re di Francia, equivale a
∃!x Rx ∧ Cx,
esiste uno e un solo oggetto che è attualmente re di Francia e tale oggetto è calvo. L’enunciato
pare riferirsi a entità non-esistenti, ma, come l’analisi dimostra, esso non parla che delle
normali entità esistenti: quelle appunto cui si riferisce il solo designatore dell’enunciato, la
variabile x, perché R e C non sono designatori, meno che mai nomi, bensì predicati.
L’enunciato asserisce che tra le entità esistenti ne esiste esattamente una che ha la proprietà di
essere adesso re di Francia e che tale entità è calva. Si tratta dunque di un enunciato falso, ma
che non implica il controsenso in cui cade Meinong. È sensato perché parla di entità esistenti:
non parla però di ciò di cui sembra parlare a prima vista (il fantomatico attuale re di Francia),
bensì parla, in modo indeterminato attraverso la variabile quantificata che in esso compare,
delle normali entità esistenti (tavoli, sedie, fiocchi rossi, presidenti della repubblica francesi,
re e regine inglesi, e via dicendo).
La proposta di Russell rappresenta un momento capitale nella storia dell’ontologia. È
vero che essa non sarà accolta da tutti. Russell consegue comunque un risultato essenziale.
Egli mette in evidenza il fatto che la struttura profonda dell’enunciato può non coincidere con
quella superficiale, e che l’enunciato compiutamente analizzato può effettuare riferimenti e
comportare predicazioni che non sono quelli apparenti. L’ontologia richiede dunque una
analisi logica del linguaggio che non si identifica con la semplice analisi grammaticale.
Russell: i nomi logicamente propri
Guida Russell nella costruzione della propria versione dell’ontologia la convinzione
che, al di là dell’apparenza grammaticale, la gran parte delle parole non logiche del
linguaggio, aggettivi ma anche nomi, svolgano una funzione predicativa e non una funzione
designativa. Non tutti i nomi grammaticalmente propri sono «nomi logicamente propri».
Effettivo nome proprio è solo il termine che mostra da sé di avere un riferimento. Ora, nota
Russell, per la maggior parte i nomi grammaticali equivalgono a descrizioni e non sono nomi
logicamente propri. Un nome come “Socrate”, per es., per noi ha più o meno lo stesso
19
significato di “il maestro di Platone” o di “il filosofo condannato a morte nel 399 a.C.”:
equivale a una descrizione. Non garantisce perciò da sé di avere un riferimento. Frege non ha
indicato dei criteri per distinguere i nomi apparentemente propri dai veri nomi propri: egli
infatti si è limitato a notare che i nomi propri della grammatica hanno sempre un senso, ma
non sempre un riferimento. Russell pensa però che sia essenziale possedere dei criteri per
operare tale distinzione. Senza di essi infatti è impossibile dire quali tipi di entità dovranno
essere ammessi dall’ontologia e dunque elaborare dettagliatamente tale disciplina. La
conclusione di Russell è che nome logicamente proprio non è in effetti nessuno dei nomi
grammaticalmente propri, ma solo il pronome dimostrativo accompagnato dall’esibizione di
una entità: solo parole come “questo” o “quello” associate all’intuizione immediata di una
entità svolgono una effettiva funzione designativa, e cioè esibiscono il fatto di avere un
riferimento.
Le altre parole, se hanno un riferimento, equivalgono a descrizioni: hanno quindi un
riferimento solo indirettamente, e che l’abbiano non è garantito dalla loro stessa forma logica,
bensì da circostanze logicamente contingenti. Solo di alcune entità noi infatti abbiamo una
«conoscenza diretta» (knowledge by acquaintance). Delle altre entità noi abbiamo soltanto
una «conoscenza per descrizione» (knowledge by description). Conoscere Socrate, per es., è
solo sapere, sulla base di un complicato procedimento inferenziale, perciò indiretto e sempre
esposto al dubbio, che c’è un essere che è filosofo, maestro di Platone, condannato a morte nel
399 a.C.; e cioè, in definitiva, conoscere la verità di un complesso enunciato esistenziale,
piuttosto che entrare direttamente in contatto con una entità. Invece conoscere, per es., la
luminosità azzurrina che sperimento adesso, è entrare in contatto diretto e indubitabile con
una entità, senza avere bisogno di conoscere preliminarmente la verità di alcun enunciato. La
conoscenza per descrizione presuppone l’accertamento della verità di certi enunciati. La
conoscenza diretta invece precede e rende possibile qualsiasi accertamento della verità di
enunciati.
Frege ha giustamente insegnato che gli enunciati hanno un senso solo se i designatori
che in essi operano hanno un riferimento. Per Russell, i nomi logicamente propri, che in virtù
della loro specificità logica garantiscono di possedere un riferimento e rendono possibile agli
enunciati tutti avere un senso, devono identificarsi con le parole che indicano cose note per
conoscenza diretta. Egli qualifica come conosciuti direttamente, e dunque come riferimento
dei nomi logicamente propri, in primo luogo i «dati di senso», e cioè i dati immediati offerti
20
dall’esperienza, i particolari contenuti visivi, sonori, tattili, etc., sperimentati grazie ai sensi.
Gli oggetti materiali, che postuliamo sulla base dei dati di senso immediatamente percepiti,
sono invece conosciuti per descrizione. Un oggetto materiale non è che una complicata
«costruzione logica» di dati di senso. Ma i dati di senso non sono le sole entità conosciute
direttamente. Accanto alle entità particolari noi dobbiamo ammettere infatti anche degli
universali, come le qualità e le relazioni che ineriscono ai dati di senso e li connettono tra
loro. Anche gli universali sono conosciuti direttamente. Russell nota infatti che non tutta la
conoscenza di verità può essere data solo dalla conoscenza diretta di entità particolari. Anche
per conoscere un fatto assolutamente elementare relativo a dei dati di senso, noi abbiamo
bisogno almeno di sapere che a quei dati di senso ineriscono certe qualità o che tra di essi
sussistono certe relazioni: per conoscere delle verità bisogna dunque conoscere direttamente
tanto dei particolari quanto degli universali.
Russell: l’atomismo logico
L’«atomismo logico» elaborato da Russell e da Wittgenstein costituisce l’esito ultimo di
questa strategia russelliana di alleggerimento del platonismo. L’atomismo logico si differenzia
dall’ontologia di Frege soprattutto per il tentativo di ridimensionare l’importanza semantica
dell’idea del senso, spiegando il valore conoscitivo degli enunciati solo tramite il riferimento
delle parole che compaiono in essi: ricordiamo che Frege aveva ritenuto necessario introdurre
la distinzione tra riferimento e senso, proprio per spiegare come mai alcuni enunciati di
identità avessero un valore informativo e altri no. Nell’atomismo logico gli enunciati hanno
un senso, le parole che li compongono solo un riferimento. La dottrina assume il nome di
atomismo logico perché rifiuta la concezione olistica di Hegel e dei neohegeliani britannici,
secondo la quale «il vero è l’intero» e non ci sono verità parziali: Wittgenstein e Russell
assumono invece che ci sia una pluralità di enunciati veri e che essi siano veri in virtù di
condizioni di verità tra loro indipendenti, costituite da una pluralità di fatti separati che
componendosi tra loro formano la realtà.
Ne La filosofia dell’atomismo logico (1918-19), egli conclude che la significanza del
linguaggio presuppone che ci sia una molteplicità di entità particolari logicamente
indipendenti tra loro, connesse per mezzo di universali in una molteplicità di «fatti atomici»
logicamente indipendenti tra loro. Questi fatti atomici sono rappresentati nel linguaggio da
«enunciati atomici». Sono enunciati atomici in primo luogo gli enunciati particolari,
21
contenenti solo predicati con vario numero di argomenti e nomi logicamente propri. In
secondo luogo sono enunciati atomici gli enunciati generali, che hanno variabili vincolate da
quantificatori in luogo dei nomi logicamente propri. Essi non esprimono delle collezioni di
«fatti particolari», bensì dei veri e propri «fatti generali». L’enunciato atomico è vero, se la
connessione di parole da cui è formato corrisponde alla struttura formata dalle entità espresse
da tali parole e costituenti il fatto; falso in caso contrario. I soli altri enunciati che godano di
un senso precisamente definibile sono «enunciati molecolari» composti da enunciati atomici
combinati attraverso i connettivi verofunzionali elencati da Frege: negazione, congiunzione,
disgiunzione, implicazione, equivalenza. Secondo Russell, l’atomismo logico non fa altro che
esplicitare le condizioni ontologiche minimali necessarie per comprendere il funzionamento
del linguaggio quale è descritto dalla logica moderna.
Wittgenstein: l’atomismo logico
Nell’elaborazione dell’atomismo logico, Russell stesso si dichiara profondamente
influenzato dalle idee suggerite dal discepolo e amico austriaco Ludwig Wittgenstein (18891951), idee da questi esposte poi in prima persona nel Tractatus logico-philosophicus (1921).
È Wittgenstein a osservare che i connettivi fregeani sono delle «funzioni di verità», e cioè
degli operatori che generano enunciati composti a partire da altri enunciati più semplici, in
maniera tale che il valore di verità dei primi dipende esclusivamente dal valore di verità dei
secondi. Wittgenstein concepisce l’ontologia come una ricerca intorno alle condizioni di
possibilità del linguaggio inteso come «totalità degli enunciati». Egli pensa che nel linguaggio
non vi possano non essere degli enunciati atomici, o «elementari», come preferisce dire, e
cioè degli enunciati tra loro indipendenti che stanno a fondamento del senso di tutti gli altri:
infatti, se il senso di ogni enunciato dovesse sempre derivare dal senso di altri enunciati,
nessun enunciato potrebbe più avere senso; la catena della comprensione deve avere un inizio.
Inoltre, perché l’enunciato possa in generale «raffigurare» la realtà, le parole dell’enunciato
elementare devono «designare» gli elementi di essa: sviluppando una suggestione di Frege,
Wittgenstein afferma che tutte le parole non logiche presenti nell’enunciato sono nomi,
intende i predicati come nomi di qualità o relazioni, e sostiene che l’enunciato elementare non
è che «una concatenazione di nomi», impiegata per raffigurare la concatenazione degli
elementi della realtà, gli «oggetti». Che oggetti vi debbano essere Wittgenstein crede
necessario ammetterlo, perché, con Frege e Russell, ritiene che gli enunciati abbiano senso
22
solo se i loro soggetti sono oggetti esistenti. Wittgenstein d’altra parte, contestando un’altra
importante tesi di Frege, nega che la connessione di nomi che costituisce l’enunciato
elementare formi essa stessa un nome. Egli accantona perciò la problematica fregeana del
riferimento degli enunciati, e afferma che l’enunciato ha un senso, ma non un riferimento.
Sulla scorta poi dell’idea russelliana che i nomi riconosciuti dalla grammatica sono associati
ad un pensiero appunto perché essi non sono logicamente propri e cioè perché equivalgono a
descrizioni, conclude simmetricamente che il nome ha un riferimento, ma nessun senso.
Secondo Wittgenstein, in virtù della corrispondenza fissata dai rapporti di designazione
convenzionalmente stabiliti tra i nomi dell’enunciato elementare e gli elementi della realtà,
ogni enunciato elementare ha una «relazione interna» con uno «stato di cose»: enuncia cioè
un possibile fatto. Lo «spazio logico» è l’insieme degli stati di cose, di quelli che sussistono,
cioè i «fatti», e di quelli che non sussistono. Se lo stato di cose enunciato sussiste, e cioè se è
un fatto, l’enunciato elementare è vero. Se non sussiste, e cioè se lo stato di cose non è un
fatto, l’enunciato elementare è falso. Il «mondo» è la «totalità dei fatti». La verità o falsità
dell’enunciato, che noi la conosciamo o meno, dipende dunque dal «confronto» di questo con
la realtà, cioè dalla corrispondenza o non corrispondenza della struttura dell’enunciato con la
struttura del fatto, e non semplicemente dalla struttura dell’enunciato.
Con la sua tesi che verità e falsità dell’enunciato elementare dipendano dal confronto
con la realtà, Wittgenstein non intende dire d’altronde che l’enunciato elementare è verificato
o falsificato dall’esperienza, né suggerire che la realtà sia costituita da dati di senso ed
eventualmente da universali, come aveva ritenuto necessario concludere Russell. La posizione
di Wittgenstein è neutrale riguardo alla natura della realtà e non influenzata dalla
preoccupazione epistemologica di individuare gli elementi della realtà che fondano l’intero
edificio della conoscenza. Le sole conclusioni che Wittgenstein ritiene legittime circa gli
oggetti sono che gli oggetti sono «semplici» e suscettibili di combinarsi in complessi; che
ciascuno di essi deve la sua «natura» alle possibilità di combinazione che ha con altri tipi di
oggetti; che, in virtù della loro semplicità, gli oggetti non sono generabili o distruttibili; che,
dunque, ogni possibile mondo deve contenere i medesimi oggetti di quello reale, per quanto
combinati diversamente.
Wittgenstein dice che gli oggetti costituiscono la «sostanza» del mondo, ciò che in esso
c’è di inalterabile: le sole cose che ci siano in ogni mondo possibile, in virtù della struttura
dello spazio logico stesso. In una prospettiva più o meno esplicitamente spinoziana, egli
23
immagina infatti che ogni possibile enunciato, anche l’enunciato che tratta di cose transitorie,
possa essere tradotto in enunciati dal valore di verità invariabile e cioè in enunciati che
chiamano in causa solo entità definite in maniera non-temporale. Quanto alla semplicità degli
oggetti, Wittgenstein ritiene necessario riconoscerla per una ragione che richiama le tesi di
Russell: conformemente alla teoria russelliana delle descrizioni, egli pensa infatti che il senso
di un qualunque enunciato non elementare sia garantito, quand’anche il suo soggetto
grammaticale si rivelasse privo di un riferimento, dal fatto che tale soggetto ha comunque un
senso, e che questo senso equivale a quello di una certa descrizione, analizzabile in termini di
nomi logicamente propri: ogni ipotetico oggetto apparentemente designato da un nome
grammaticale può essere scomposto dall’analisi in una combinazione di oggetti designati da
nomi. Dunque il senso di tutti gli enunciati poggia sul fatto che vi sono dei nomi logicamente
propri, e cioè delle parole che designano e hanno un riferimento garantito. Se il linguaggio ha
un senso, ci devono quindi essere degli oggetti semplici, e cioè non ulteriormente
scomponibili dall’analisi.
Wittgenstein: il paradosso dell’ineffabilità della forma logica
È essenziale notare che il punto di vista di Wittgenstein circa l’ontologia non si
differenzia da quello di Russell solo a proposito della questione dei rapporti tra ontologia ed
epistemologia, con un Wittgenstein che rivendica la neutralità epistemologica dell’atomismo
logico e un Russell che ritiene viceversa di doverlo inquadrare nell’ambito di una metafisica
fenomenista, da lui ritenuta essenziale per dar conto della genesi della conoscenza. Anche lo
stesso Russell infatti finirà per distaccarsi dal fenomenismo. Il dissenso maggiore tra i due
affiora piuttosto intorno a una diversa e più decisiva questione: la questione stessa dello
statuto conoscitivo dell’ontologia. Centrale per definire il punto di vista di Wittgenstein è
infatti una posizione assolutamente radicale, che Russell non condividerà mai: la tesi
dell’ineffabilità della struttura logica che accomuna il linguaggio e la realtà, e, di
conseguenza, la convinzione del carattere intrinsecamente aporetico dell’ontologia.
Wittgenstein giustifica la propria posizione per mezzo di una riflessione intorno al
rapporto di raffigurazione che sussiste tra l’immagine e la cosa raffigurata. Perché sussista un
tale rapporto Wittgenstein afferma che ci deve essere una identità di struttura tra le due:
l’immagine e la cosa raffigurata saranno certo diverse nella natura degli elementi da cui sono
costituite, ma esse dovranno condividere almeno un medesimo insieme di relazioni. Un
24
quadro, per es., sarà costituito da molecole di tipo del tutto diverso da quelle che compongono
il paesaggio rappresentato, ma dovrà condividere con esso almeno certi angoli e certi rapporti
di misura. Non è necessario poi che la struttura comune sia di un tipo particolare. Una cosa
non spaziale, per es. un’equazione, può anche essere raffigurata da un diagramma spaziale. È
necessario però che ci sia in comune una qualche struttura. Wittgenstein chiama la struttura
che di volta in volta è comune «forma della raffigurazione». Wittgenstein sostiene che anche
l’enunciato è un’immagine: l’enunciato (elementare) raffigura un determinato stato di cose in
virtù del fatto che la combinazione di nomi che costituisce l’enunciato replica la
combinazione degli oggetti nello stato di cose. A motivo della flessibilità delle convenzioni
che definiscono la sua forma della raffigurazione, il linguaggio è per Wittgenstein il genere
supremo cui appartiene ogni immagine. La forma della raffigurazione propria del linguaggio
come tale è dunque nient’altro che la forma minimale della raffigurazione che una qualsiasi
immagine deve condividere con la realtà in generale e che la rende idonea a riprodurre lo
spazio logico di tutti i possibili stati di cose: Wittgenstein la chiama «forma logica». Ogni
immagine dunque è almeno «immagine logica dei fatti» e cioè «pensiero»: il pensiero infatti
non è altro che l’enunciato dotato di senso in generale.
Il cuore della posizione scettica di Wittgenstein sta nel seguente paradosso: che, mentre
è sempre possibile raffigurare quella struttura specifica che costituisce una particolare forma
della raffigurazione, è impossibile raffigurare il comune denominatore di ogni possibile forma
della raffigurazione, e cioè la forma logica stessa; per fare questo infatti dovremmo uscire
fuori dalla forma logica e dunque da ogni possibilità di raffigurazione. È impossibile dunque
creare una disciplina capace di dar conto della logica: «la logica deve prendersi cura di sé»; la
struttura comune del pensiero e della realtà «si mostra» da sé nel linguaggio chiarito
dall’analisi, ma non può «essere detta», come se fosse una particolare combinazione di oggetti
sussistente nel mondo accanto ad altre. Wittgenstein, con una reminiscenza dell’etimo (la
parola greca mysterion, «pratica segreta», dal verbo myo, «stare chiuso»), chiama «il mistico»
tutto ciò che appartiene alla forma logica, e che appunto può essere mostrato, ma non detto.
La forma logica non è l’oggetto che fa da sfondo a tutte le possibili combinazioni degli
oggetti. Essa non è affatto un oggetto. Le costanti logiche non devono quindi essere concepite
come nomi di presunti elementi della forma logica: contro Frege e la sua ipotesi che i numeri
siano entità logiche, Wittgenstein insiste sul fatto che non ci sono entità logiche: le costanti
logiche sono simboli che permettono di creare enunciati composti, e che dunque attraverso le
25
descrizioni entrano nella definizione dei nomi del linguaggio ordinario e consentono ad essi di
designare gli oggetti composti, ma esse, da sole, non designano alcunché. L’esistenza di leggi
logiche non contrasta con ciò. La legge logica infatti è una «tautologia», cioè una frase che,
concatenando le parole in una maniera che non è suscettibile di alternative e perciò di
confrontarsi con i fatti, non dice niente. Al pari della «contraddizione», la legge logica non è
un enunciato sensato: essa infatti non enuncia alcunché; l’enunciato deve costitutivamente
essere suscettibile tanto di verità quanto di falsità.
Come tutta la logica, anche l’ontologia è dunque una disciplina impossibile in linea di
principio, l’atomismo logico è una teoria incapace di ricevere una sensata formulazione. Tutta
la metafisica in generale, con la sua pretesa di raffigurare l’insieme della realtà, è per
Wittgenstein una disciplina impossibile: prive di senso sono le sue formule. Prive di senso le
sue domande, come, per esempio, se il mondo sia rappresentato da un soggetto o se abbia
un’esistenza indipendente da qualsiasi rappresentazione. Nessuno – neppure l’idealista
sostenitore del più radicale solipsismo – pretende che l’eventuale «soggetto metafisico» che si
rappresenta l’intera realtà coincida con una particolare entità psicofisica, nessuno pretende
che tale soggetto sia esso stesso un certo particolare frammento della realtà. Tutte le persone
di buon senso concordano: il mondo non comincia con la nascita di alcuno tra i suoi ospiti
umani e non finisce con la morte di alcuno di essi. Perciò il «soggetto metafisico»
dell’idealismo «si contrae in un punto inesteso» ai margini del mondo e la tesi idealista va
intesa come l’affermazione che l’intera realtà è rappresentata, senza che questa qualità di
essere rappresentata possa essere intesa come l’essere rappresentata in qualche particolare
raffigurazione o da qualcuno in particolare. Un’affermazione che risulta impossibile
distinguere in maniera comprensibile dalla negazione che le contrappone il realista: la realtà
non è nel suo complesso rappresentata. Dunque, realismo e idealismo, intesi nelle loro
implicazioni, coincidono tra loro; la loro presunta opposizione è impossibile a dirsi.
L’ineffabilità del soggetto, per Wittgenstein, si riflette subito in una parallela ineffabilità
del valore. Infatti, il possesso di valore da parte di un oggetto non può essere un fatto. Tutti gli
stati di cose infatti stanno sullo stesso piano, nessun fatto rivela di per sé una importanza
particolare. Supponiamo, argomenta Wittgenstein, che sia a sua volta un fatto che certi fatti –
diciamo f1 e f2 – siano buoni e altri – f3 e f4 – eticamente condannabili. Che cosa accadrebbe se
io, che mi sto interrogando intorno al valore dei fatti, non riuscissi a trovare importante il fatto
che f1 sia positivo e che f3 sia negativo. Avrebbe ancora senso dire che f1 è positivo e che f3 è
26
negativo, anche se tali valori non possono essere confermati dalla mia volontà? L’importanza
è concessa alle cose solo dalla nostra volontà: la presunta importanza assoluta dovrebbe essere
concessa da una volontà assoluta esterna al mondo. Ma un soggetto del mondo, come il
soggetto che l’idealismo ha creduto di potere riconoscere dietro la realtà fenomenica, elude in
linea di principio ogni possibilità di determinazione nel linguaggio. L’etica è dunque
ineffabile: non può esserci una conoscenza etica. Wittgenstein dichiara che il presunto
enunciato etico è privo di senso. In esso tuttavia, a giudizio di Wittgenstein, si esprime la
fondamentale tendenza umana a trascendere i confini dell’esprimibile e ad avvertire il mondo
come enigmatico.
Il Tractatus stesso si riduce a un gesto filosofico di ostensione della forma logica, che
non può essere condensato e codificato in un sapere, e che è inevitabile superare una volta che
lo si sia compreso. «Le mie proposizioni illustrano così: colui che mi comprende, infine le
riconosce prive di senso, se è salito per esse – su esse – oltre esse. (Egli deve, per così dire,
gettar via la scala dopo che v’è salito.) Egli deve superare queste proposizioni; allora vede
rettamente il mondo. Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere.»
Il Circolo di Vienna: la critica convenzionalistica dell’ontologia
Negli anni tra le due guerre mondiali, lo scetticismo di Wittgenstein nei confronti dell’ontologia trova una risonanza importante, se non propriamente una esatta riproposizione,
nell’«empirismo logico» del Circolo di Vienna. Il Circolo si forma intorno al seminario tenuto
a Vienna dal tedesco Moritz Schlick (1882-1936) a partire dal 1923, col nome ufficiale di Associazione Ernst Mach. Ne fanno parte i filosofi Friedrich Waismann (1896-1959) e Herbert
Feigl (1902), il matematico Hans Hahn (1879-1934), il fisico Philipp Frank (1884-1966), lo
storico Victor Kraft (1880-1975), il sociologo Otto Neurath (1882-1945), il giurista Felix
Kaufmann (1895-1949). Hanno contatti occasionali col gruppo anche il giurista Hans Kelsen
(1881-1973), nonché i logici Kurt Gödel (1906-1978) e Alfred Tarski (1901-1983). Dal 1925
i membri del Circolo tengono delle riunioni settimanali il giovedì sera. Nel 1926 entra a far
parte del Circolo il tedesco Rudolf Carnap (1891-1970), allievo di Frege e da quell’anno
istruttore di filosofia presso l’Università di Vienna. Nel 1926 il Circolo studia e discute il
Tractatus di Wittgenstein. Nel 1929, viene pubblicata a firma di Neurath, Carnap e Hahn La
concezione scientifica del mondo, manifesto programmatico dell’empirismo logico. Il Circolo
di Vienna stabilisce legami con i filosofi di analogo orientamento che formano la Scuola di
27
Berlino, promossa dal tedesco Hans Reichenbach (1891-1953) con Carl Gustav Hempel
(1905-1997). Insieme, a partire dal 1930, pubblicano la rivista “Erkenntnis”, diretta da
Reichenbach e Carnap. Hanno inoltre contatti col gruppo, sebbene restino su posizioni
autonome, l’austriaco Karl R.Popper (1902-1994) e l’inglese Alfred J.Ayer (1910-1989). Con
Schlick, con Waismann, e più saltuariamente anche con altri membri del Circolo di Vienna,
tra il 1927 e il 1932, ha degli incontri anche lo stesso Wittgenstein.
Sulla base della concezione verificazionistica del significato, gli empiristi logici
rifiutano ogni possibile metafisica, dunque anche la stessa metafisica dell’atomismo logico, e,
in definitiva, tutta la problematica dell’ontologia. Come Wittgenstein, essi pensano che
specificare i rapporti che sussistono tra il linguaggio e la realtà ecceda in linea di principio le
possibilità interne del linguaggio stesso. A giustificazione di questa tesi, tuttavia, gli empiristi
logici forniscono una ragione che, sebbene essi non ne siano del tutto consapevoli, è
sostanzialmente diversa da quella indicata da Wittgenstein: il fatto è per loro che solo gli
enunciati verificabili hanno un senso; la questione se al di là dei dati dell’esperienza vi sia
una realtà indipendente dall’esperienza stessa, oppure la realtà si riduca ai dati di senso
soltanto, eccede ovviamente i limiti di ciò che è verificabile entro l’esperienza; ogni questione
ontologica è dunque di per sé priva di senso.
Anche sulla questione del fenomenismo, l’evoluzione è interessante. Infatti, retroagisce
sulle basi teoriche del fenomenismo lo stesso principio convenzionalista, che, esplicitamente
in Avenarius e in Mach, accompagnava il fenomenismo fino dalle sue origini. Il fenomenismo
infatti giudica reale solo il flusso dei dati di senso e considera i sistemi concettuali come
convenzioni elaborate al fine di organizzare in maniera economica le nostre informazioni
circa tale flusso. Il fatto è però che anche il fenomenismo è un sistema concettuale e non un
dato, e che anch’esso dunque, al pari di qualsiasi altra teoria circa la struttura della realtà,
potrebbe e dovrebbe essere considerato come una convenzione più o meno utile per
organizzare la nostra esperienza, ma, propriamente, né vera né falsa.
Un simile percorso di pensiero è appunto quello che segna la vicenda del fenomenismo
entro l’empirismo logico. I maggiori esponenti del movimento muovono da posizioni che
sono, come nel fenomenismo britannico e soprattutto in Russell, di ispirazione realista e di
netta contrapposizione all’idealismo. Ma la vicenda dell’empirismo logico modifica tali
posizioni iniziali. Reichenbach rimpiazza il realismo dogmatico del senso comune con un
realismo inteso come semplice ipotesi empirica: l’esistenza di una struttura causale
28
indipendente dalla nostra mente spiega l’evidente successo delle nostre predizioni induttive
con una credibilità che nessuna posizione idealistica è in grado di raggiungere.
È tuttavia soprattutto Carnap a imprimere un nuovo orientamento al dibattito. Nella
Costruzione logica del mondo (1928) Carnap infatti sostiene che tutti i concetti di interesse
scientifico grazie ai quali conosciamo la realtà si lasciano risolvere in semplici
rappresentazioni dell’esperienza immediata. Egli sottolinea il fatto che i concetti impiegati
entro un certo ambito scientifico possono essere analizzati come «costruzioni logiche» di
concetti appartenenti ad ambiti più elementari: che i concetti più complessi, cioè, possono
essere sostituiti da opportune combinazioni degli altri, in modo tale che, senza la pretesa di riprodurre l’intensione dei primi, e cioè il loro senso, i secondi riproducano almeno la loro
estensione, e cioè il loro campo di applicazione. In particolare, per Carnap, i concetti del
«campo spirituale», usati dalle scienze sociologiche, possono essere riportati a quelli
psicologici del «campo psichico altrui»: i concetti relativi a collettivi di uomini possono
essere analizzati in termini di azioni e di condizioni psichiche dei singoli esseri umani che
fanno parte di essi. A loro volta, i concetti psicologici possono essere riportati a quelli
naturalistici del «campo fisico», interpretando comportamentisticamente ciascun fenomeno
mentale come la disposizione a realizzare un determinato tipo di atti. I concetti delle scienze
naturali, poi, possono essere definiti attraverso quelli del «campo psichico proprio»,
intendendo ogni espressione relativa a corpi come una costruzione logica di espressioni
relative a dati di senso. Noi infine possiamo classificare i dati di senso senza ulteriori mediazioni grazie all’esperienza del « riconoscimento di similarità».
Ora, d’altra parte, Carnap insiste sul fatto che una simile catena di procedimenti riduttivi
ha un puro valore convenzionale, e che non deve essere considerata come una ricostruzione
dei “veri” rapporti sussistenti tra i “livelli della realtà’: essa infatti vale solo come una
possibile scelta «metodologica», utile soprattutto a esibire le basi empiriche che nei diversi
campi scientifici dovrebbero orientare le nostre assunzioni, e non come una teoria
«ontologica» riguardante la natura delle cose. Carnap non vuole affatto sostenere con il
fenomenismo di Avenarius, di Mach e di Russell, che i dati di senso siano i costituenti ultimi
di tutta quanta la realtà. Ritiene infatti che ogni teoria circa la struttura della realtà sia
parimenti inverificabile e perciò priva di senso. La metafisica fenomenista è dunque per lui
altrettanto inconsistente della metafisica materialista. Ciò che è legittimo, invece, è trattare il
fenomenismo come una convenzione concettuale utile in particolare ai fini della ricerca
29
epistemologica, e assumerne il linguaggio, senza preclusioni per eventuali opzioni alternative:
Carnap insiste sul fatto che il linguaggio materialista, che assume come primari i nomi di oggetti fisici, potrebbe essere altrettanto utile in vista di ulteriori scopi.
Il suo è un «solipsismo metodologico», non una metafisica dei dati di senso. Carnap
dichiara esplicitamente che nessun linguaggio deve essere escluso in linea di principio come
linguaggio di base. Proclama il «principio di tolleranza» asserente che «in logica non c’è
morale»: ogni linguaggio formale può andare bene; la questione non è di verità o falsità, ma
solo di vantaggi o svantaggi pratici.
Molti esponenti dell’empirismo logico si fanno convincere dalle considerazioni di
Carnap del fatto che un fenomenismo accettabile dovrebbe avere carattere metodologico e
non ontologico: primo tra tutti Schlick, che è il punto di riferimento riconosciuto della
corrente. Anche Schlick infatti accetta la natura puramente convenzionale del linguaggio
fenomenistico e riconosce come priva di senso l’intera controversia metafisica tra
fenomenismo e materialismo.
Carnap: la filosofia come sintassi logica del linguaggio
Il punto è che Carnap pensa che il filosofo possa occuparsi solo di «sintassi logica» e
non di ontologia: nella Sintassi logica del linguaggio (1934) afferma che il filosofo deve
limitarsi a descrivere in un metalinguaggio la struttura sintattica del determinato linguaggiooggetto che ha liberamente scelto di elaborare, alla maniera in cui Hilbert ha descritto a livello
metamatematico il linguaggio della matematica: specificandone il vocabolario, le regole per la
formazione dei termini e degli enunciati, gli assiomi, le regole di inferenza. La filosofia può
produrre chiarificazioni solo interne al linguaggio, e dunque, per come Carnap vede
originariamente la questione, chiarificazioni di genere esclusivamente sintattico: ogni
considerazione semantica è implicitamente metafisica, e dunque priva di senso.
La sintassi logica permette anzi di dissipare le confusioni della metafisica. Una cosa
infatti sono gli enunciati «sintattici», espressi in termini di categorie linguistiche, come per es.
“Il termine “gatto” è un nome”, e una diversa quelli «oggettuali», espressi in termini di categorie non linguistiche, come per es. “Il gatto è un animale”. Ora, Carnap dice che gli enunciati
della metafisica, i quali mirano a classificare oggetti, proprietà e relazioni, e a descrivere la
struttura della realtà, sono enunciati «pseudo-oggettuali»: tali enunciati cioè presentano in
termini di categorie non linguistiche degli assunti che riguardano in effetti le categorie
30
linguistiche; essi sono enunciati sintattici travestiti da enunciati oggettuali. Un enunciato
pseudo-oggettuale come per es. “Il gatto è un oggetto” equivale infatti a “Il termine “gatto” è
un nome”; uno come “Il nero è una proprietà” a “Il termine “nero” è un aggettivo”. Per
eliminare la metafisica bisogna dunque passare dal «modo di parlare contenutistico», che si
esprime in termini di enunciati oggettuali, al «modo di parlare formale» adottato dalla sintassi
logica, che si esprime in termini di enunciati sintattici.
La prospettiva dichiaratamente sintattica del primo Carnap è condivisa da tutto l’empirismo logico delle origini e non solo da esso. Un filosofo come John Wisdom (1904-1993)
per es. difende sì la tecnica russelliana dell’analisi logica del linguaggio, ma lo fa anch’egli
assumendo una prospettiva strettamente sintattica: spiegare la «costruzione logica» dei concetti del linguaggio è infatti analizzare i rapporti di riducibilità che sussistono all’interno del
linguaggio tra differenti ambiti lessicali, non indagare rapporti di dipendenza che connettano
presunti livelli della realtà. Wisdom contesta la compromissione dell’analisi logica col
fenomenismo, una compromissione che a suo parere distorce le scoperte filosofiche tanto dell’empirismo classico quanto dello stesso Russell.
Neurath: il dibattito sui protocolli
L’empirismo logico tuttavia non si assesta definitivamente su queste posizioni:
attraverso una decisiva opera di ripensamento, infatti, esso precisa ulteriormente le proprie
posizioni circa la questione del fenomenismo e le arricchisce di nuove considerazioni. È
promotore di tali ulteriori sviluppi soprattutto l’austriaco Otto Neurath. Innanzitutto, proprio
allo scopo di fare risultare in maniera inequivocamente chiara la natura metodologica e non
ontologica delle preoccupazioni dell’empirismo logico, Neurath suggerisce una ridefinizione
dei termini della discussione. I filosofi hanno discusso in passato dei dati elementari che
stanno alla base dell’edificio della nostra conoscenza: si sono chiesti se tali elementi di base
siano dei dati di senso oppure degli oggetti fisici. Neurath propone di rendere chiaro che la
discussione verte sul linguaggio da assumersi come primario e non sulla struttura della
realtà, sostituendo al concetto di elemento della realtà quello di «enunciato protocollare»:
l’empirismo logico non si interroga infatti circa la natura delle unità elementari che è possibile
riscontrare analizzando la realtà, bensì circa la natura degli enunciati per mezzo dei quali
registriamo le nostre osservazioni e che fungono da strumento per controllare empiricamente
l’elaborazione delle teorie. L’empirismo logico si chiede, secondo Neurath, se gli enunciati
31
protocollari debbano adottare un vocabolario fenomenistico oppure un vocabolario fisicalistico: se essi, cioè, debbano contenere parole come “io”, “adesso”, “impressione visiva di
rosso”, “impressione tattile di solidità”, etc., ossia termini esprimenti dati di senso, e avere
dunque la forma “io adesso ho l’esperienza vissuta ...”; oppure se debbano contenere parole
come “Otto Neurath”, “il giorno 31 marzo 1931”, “osservare”, “lancetta del manometro”,
“indice del termometro”, etc., ossia nomi di cose, persone, posizioni e tempi del mondo
pubblicamente osservabile, e avere dunque la forma “la persona ... nel momento ... nel luogo
... osserva lo stato di cose fisico ...”.
Contro la predilezione di Schlick per il linguaggio fenomenistico, Neurath sostiene che
il linguaggio protocollare dovrebbe essere fisicalistico. Solo il linguaggio fisicalistico infatti
rende possibile l’intersoggettività che è necessaria alla ricerca scientifica. Il linguaggio
fenomenistico infatti è un linguaggio essenzialmente privato ed egocentrico: prevede cioè
enunciati che, se rivendicano il fatto di essere verificabili in maniera conclusiva, risultano
esserlo però solo da parte di un unico soggetto. Il linguaggio fisicalistico invece consta di
enunciati che non pretendono di esprimere un’evidenza immediata e irrevocabile, come non lo
pretende in generale ogni pronunciamento che ecceda la presunta sfera privata della
coscienza, ma che almeno sono pubblicamente controllabili. Il fenomenismo, anche il
fenomenismo metodologico, a parere di Neurath, è una scelta teorica incapace di far fronte
alle esigenze della concreta indagine scientifica.
Il «dibattito sui protocolli» aperto dagli interventi di Neurath, divide profondamente
l’empirismo logico, e contribuisce alla dissoluzione dei circoli di Vienna e di Berlino, che ne
avevano rappresentato i centri originari di aggregazione. Carnap aderisce alle considerazioni
di Neurath e riconosce la superiorità del fisicalismo, insistendo d’altra parte sul fatto che la
scelta a favore del fisicalismo deve essere intesa, al pari della scelta fenomenista che aveva
precedentemente suggerito, come scelta metodologica e non ontologica, e che essa dunque
non equivale all’adesione a una metafisica materialistica. Schlick invece si oppone
fermamente alla scelta fisicalistica di Neurath e continua a difendere il fenomenismo metodologico: vede infatti nel fisicalismo di Neurath una strategia filosofica gravida di pericoli; vi
legge una rinuncia a commisurare la teoria scientifica a evidenze immediate e indubitabili, e,
con ciò, ad assicurare alla scienza un fondamento incrollabile. Con la scelta fisicalistica, a
giudizio di Schlick, Neurath finisce per vanificare l’idea stessa della scienza come impresa
conoscitiva.
32
Wittgenstein: contro l’ipotesi del linguaggio privato
La critica convenzionalistica del fenomenismo, sviluppatasi soprattutto all’interno dell’empirismo logico, sfocia infine nella successiva filosofia analitica in una contestazione
generale dell’idea stessa di dato di senso. Divenuto evidente il fatto che il concetto di dato di
senso è scarsamente utilizzabile allo scopo di ricostruire la struttura della conoscenza umana,
si diffonde tra i filosofi del filone analitico il dubbio ancora più radicale che il concetto di dato
di senso sia in se stesso poco consistente. È anche in questo caso Wittgenstein ad anticipare le
direttrici della filosofia analitica. La sua critica dell’idea della mente come ambito di evidenze
assolute e insieme private costituisce l’inizio della battaglia analitica contro il concetto del
dato. Nelle Ricerche Filosofiche (postume, 1953), prendendo le distanze dal fenomenismo da
lui stesso sostenuto nei primissimi anni Trenta, e accogliendo alcune considerazioni
sviluppate anche da Neurath e da Carnap, Wittgenstein fa osservare come il presunto dato di
senso sarebbe in linea di principio accessibile all’esperienza di un soggetto soltanto, e che
dunque esso non potrebbe essere descritto entro un linguaggio pubblicamente comprensibile.
Egli ritiene d’altra parte che un «linguaggio privato», comprensibile cioè solo da parte di una
persona, sia intrinsecamente impossibile, perché incapace di dare senso in un qualsiasi modo
alla distinzione tra uso corretto e uso scorretto delle parole. L’idea che tutto il linguaggio
possa poggiare sul fondamento di un linguaggio elementare direttamente esprimente i dati di
senso è quindi in se stessa un controsenso. La nozione di dato di senso viene ad apparirgli in
definitiva solo una gratuita finzione filosofica ereditata dal positivismo.
Sellars: contro il mito del dato
Una critica radicale dell’idea del dato di senso viene elaborata anche dallo statunitense
Wilfrid Sellars (1912-1989). Come Wittgenstein, se pure attraverso un differente percorso
argomentativo, in Empirismo e filosofia della mente (1956) anche Sellars contesta la nozione
della mente come sfera di evidenze private, nata con Cartesio e riproposta in varie forme da
gran parte della filosofia moderna, fino alla teoria dei dati di senso e al fenomenismo.
Secondo Sellars, i concetti ordinari dei fenomeni mentali sono nati per indicare le cause
interne del comportamento: sono nati dunque per spiegare dall’esterno le azioni degli altri
uomini piuttosto che per descrivere dall’interno i dati di una qualche propria esperienza
immediata. Solo gradualmente essi hanno cominciato ad essere impiegati anche dai soggetti
33
stessi delle azioni per effettuare resoconti in prima persona della loro condizione interna. Tali
resoconti in prima persona d’altra parte sono risultati nella pratica particolarmente affidabili
per la spiegazione delle azioni, e in generale più credibili delle ipotesi esplicative formulate
dalle altre persone. Il fatto che i concetti dei fenomeni mentali permettano di rappresentare la
condizione interna delle persone tuttavia non significa, a giudizio di Sellars, che essi siano
rappresentazioni di una condizione interiore e tanto meno di una condizione privata: le cause
interne del comportamento degli uomini infatti sono i processi del loro sistema nervoso
centrale, e dunque eventi che, sebbene poco facilmente ispezionabili, appartengono pur
sempre alla sfera di ciò che è pubblicamente accessibile. Se il soggetto dello stato mentale ha
un privilegio conoscitivo sugli altri, è solo perché si trova ad avere nei confronti del proprio
stato mentale una posizione osservativa migliore di quella degli altri, un po’ come chi sorvola
in aereo una regione è in grado di coglierne la struttura topografica meglio di chi vive sulla
superficie del suolo.
Inoltre, secondo Sellars, non si può sostenere che il pensiero elabori dei dati forniti dalla
sensazione. È vero infatti che la sensazione ha un contenuto non meno del pensiero: il
pensiero è pensiero di qualcosa, così come la sensazione è sensazione di qualcosa. Ma, mentre
il carattere contenutivo del pensiero è di natura intenzionale, non è di natura intenzionale il
carattere contenutivo della sensazione. Il fatto, a giudizio di Sellars, è che hanno natura
intenzionale solo i fenomeni mentali che rimandano a proposizioni. Il pensare è un fenomeno
intenzionale perché il contenuto del pensiero è sempre una proposizione: pensare a una
determinata cosa è sempre pensare che tale cosa sia in un determinato modo o che abbia una
determinata caratteristica. Questo però non è il caso della sensazione. Il contenuto della
sensazione infatti, secondo Sellars, non è di natura «proposizionale», bensì «avverbiale»:
avere la sensazione del caldo non è sentire che qualcosa è caldo, bensì sentire “caldamente”;
è, in altri termini, avere una sensazione di una determinata qualità, e non sentire una certa
qualità presente in una certa altra cosa. La sensazione dunque non può fungere da fondamento
per le nostre credenze, come ritiene l’empirismo: essa infatti è sprovvista di quel contenuto
proposizionale del quale abbisognano invece le credenze. Il sostenitore della teoria dei dati di
senso è ancora prigioniero di questo mito empiristico della sensazione come sorgente dei
contenuti del pensiero.
Alla base della conoscenza, nella funzione di istanza di controllo per le nostre credenze,
può esserci solo qualcosa che abbia esso stesso un contenuto proposizionale: c’è, in
34
particolare, il protocollo linguistico. Il protocollo linguistico tuttavia non si limita a esplicitare
il contenuto della sensazione, ma lo elabora e lo interpreta, e dunque non può avere l’immediatezza della sensazione stessa. Il «mito del dato», come Sellars battezza la teoria dei dati
di senso, è la gratuita certezza degli empiristi che possa esserci un contenuto dotato insieme
dell’immediatezza della sensazione e della funzione fondante del protocollo. Sulla scorta di
Wittgenstein e di Sellars, tutto un filone di pensiero analitico metterà in evidenza il ruolo
attivo, e, in qualche misura, arbitrario delle convenzioni concettuali che reggono il linguaggio
osservativo dei protocolli, rifiuterà l’idea di un linguaggio osservativo neutrale rispetto agli
assunti teorici, e concluderà che l’osservazione stessa è « carica di teoria».
Austin e Ryle: contro i dati di senso
La denuncia delle incongruenze contenute nell’idea del dato di senso sollecita d’altra
parte la filosofia analitica a ricostruire in maniera più aderente alla realtà la problematica della
percezione. La teoria dei dati di senso sostiene che vero oggetto della nostra diretta percezione
non è la cosa fisica collocata nello spazio, bensì il dato di senso solo interiormente accessibile.
Il nuovo orientamento critico che si diffonde nella filosofia analitica smantella drasticamente
la visione dell’esperienza percettiva assunta dalla teoria dei dati di senso. Nel libro Senso e
sensibilia (postumo, 1962; ma elaborato tra il 1947 e il 1959), l’inglese John L.Austin (19111960) contesta in particolare l’«argomento dell’illusione», che i teorici dei dati di senso usano
addurre a sostegno della loro posizione. Essi dicono infatti che le percezioni veridiche sono
qualitativamente indistinguibili dalle percezioni illusorie: chi è vittima di un’illusione si trova,
secondo loro, in uno stato mentale internamente non diverso dallo stato di chi ha un’autentica
esperienza percettiva. Ma, continuano i sostenitori dei dati di senso, chi ha una percezione
illusoria non percepisce un oggetto materiale: percepisce piuttosto un oggetto puramente
interiore, un dato privato di senso. Ne consegue, secondo la teoria dei dati di senso, che l’oggetto diretto della percezione non può essere nemmeno nel caso della percezione veridica un
oggetto materiale: oggetto diretto della percezione deve essere dunque sempre il dato di
senso.
Austin contrasta l’argomento dell’illusione, analizzando dettagliatamente i concetti di
percezione e di illusione, quali sono espressi dal nostro linguaggio ordinario: fondandosi su
tale analisi, egli contesta in particolare il presupposto che l’illusione possa essere trattata
come un caso specifico di percezione, e che dunque anche nel caso dell’illusione ci debba
35
essere un oggetto percepito, appunto il dato di senso. L’illusione non è affatto una percezione.
Ma se nell’illusione non c’è necessariamente un oggetto che venga percepito, allora non c’è
alcuna ragione di ammettere in generale il dato di senso. Austin d’altronde ritiene altrettanto
astratta e semplicistica l’idea che le cose percepite siano sempre classificabili come oggetti
materiali. La nostra percezione porta piuttosto su di un numero indefinito di cose le più
diverse tra loro: arcobaleni, immagini residue, figure sullo schermo cinematografico, voci,
figure dei libri, immagini allo specchio, etc.
Contro l’idea stessa del dato di senso polemizza poi anche l’inglese Gilbert Ryle (19001976), il quale sostiene che la teoria dei dati di senso si fonda tutta su di una confusione del
concetto di sensazione con quello di osservazione. Secondo Ryle, infatti, il sostenitore di tale
teoria immagina la sensazione precisamente come un particolare genere di osservazione:
ritiene che la sensazione sia appunto osservazione di dati di senso; interpreta il senziente
come se fosse un puro osservatore angelico di dati di senso, invece che un essere coinvolto
dalla sensazione stessa. Con tale sua pretesa paradossale di spiegare «il fatto di avere
sensazioni col fatto di non averne», secondo Ryle, la teoria dei dati di senso finisce nel
controsenso, prospettando certo, come sostiene Austin, una rappresentazione distorta dell’oggetto della percezione, ma, prima ancora, fornendo una rappresentazione distorta della
sensazione medesima.
Carnap: questioni ontologiche interne ed esterne
È solo in un secondo tempo, mentre peraltro si sta sviluppando la polemica analitica
contro l’idea stessa dei dati di senso, che Carnap supera anche la visione dell’analisi filosofica
come impresa strettamente sintattica. E anche questo ripensamento sarà gravido di
conseguenze per l’ontologia. Riflettendo sulle scoperte semantiche del logico polacco Alfred
Tarski (1902-1983), egli, come altri empiristi logici, accoglie l’idea che il filosofo possa legittimamente indagare l’aspetto semantico del linguaggio. Da notare, a riprova del fatto che la
semantica tarskiana non è di per sé compromessa con la metafisica, che Carnap non ritratta
affatto la denuncia del carattere intrinsecamente insensato della metafisica tradizionale e di
ogni altro tentativo di descrivere la struttura della realtà. Contro la nuova prospettiva accolta
da Carnap, Neurath si fa portavoce del punto di vista originario dell’empirismo logico e rifiuta
come in se stesso metafisico ogni pronunciamento semantico. In Empirismo, semantica e
ontologia (1950) Carnap replica alle accuse di Neurath distinguendo due generi differenti di
36
questioni ontologiche: da un lato, le «questioni interne», cioè quelle relative alle entità postulate all’interno della semantica dei nostri linguaggi; dall’altro, le «questioni esterne», cioè
quelle relative all’adeguatezza dei nostri linguaggi stessi considerati nel loro complesso,
dunque con le loro strutture sintattiche e insieme anche con i loro postulati semantici. È una
questione di esistenza interna, per es., se entro l’aritmetica sia ammessa l’esistenza di numeri
primi; o se entro il linguaggio cosale o fisicalistico, che ammette solo ciò che è esprimibile in
termini di oggetti pubblicamente osservabili e di comportamenti fisici, si possa parlare di stati
mentali come sensazioni o sentimenti. Una questione di esistenza esterna, invece, per es., se
l’aritmetica sia una buona teoria; se il linguaggio cosale sia altrettanto legittimo, o addirittura
più legittimo, del linguaggio dei semplici dati di senso. Secondo Carnap, discutere questioni
ontologiche interne a un certo linguaggio è perfettamente sensato e la teoria di Tarski mostra
la via per farlo correttamente: non compromette con la metafisica perché non obbliga a decidere se certe pretese entità esistano davvero, ma solo se esse siano riconosciute dal linguaggio
che analizziamo. È invece insensato e caratteristico della metafisica discutere questioni
ontologiche esterne. Le questioni esterne, correttamente intese, infatti, non sono materia di
indagine teoretica, come pretende la metafisica, bensì di decisione pragmatica: stabilire se un
certo sistema sintattico e semantico sia adeguato non è accertare se esso corrisponda alla realtà, ma solo decidere se esso sia uno strumento adatto a soddisfare le nostre esigenze.
Quine: la teoria dell’impegno ontologico
Nello spiegare come si risolvono le questioni interne, Carnap si richiama alla teoria
dell’«impegno ontologico» elaborata dall’allievo statunitense Willard V.O. Quine (19082000). Ribaltando la tradizione dell’ontologia che aveva riconosciuto in linea di principio un
riferimento a tutti i tipi di parole non logiche, in Su ciò che vi è (1948) Quine nega che tutte le
parole non logiche siano ontologicamente impegnative, e cioè che tutte le parole non logiche
pretendano di riferirsi a delle entità. Con la tradizione nominalistica, Quine insiste sul fatto
che
su aggettivi, verbi e avverbi non cade alcun impegno ontologico: possiamo infatti
spiegare soddisfacentemente la funzione di queste parole anche senza presupporre che esse
denotino proprietà, eventi o azioni. Parole di queste categorie sono «vere di» quelle entità che
sono introdotte dai soggetti delle nostre asserzioni, ma non è necessario supporre che esse «si
riferiscano a» ulteriori specifiche entità. Nell’enunciato “Enzo è un poeta”, per es., la parola
“poeta” non denota la proprietà dell’essere-poeti, e cioè una entità universale da riconoscersi
37
accanto all’individuo Enzo; analogamente, in “Giuseppe medita” la parola “medita” non
denota un’azione del meditare da aggiungersi all’individuo Giuseppe. Parole come queste non
hanno affatto la funzione di denotare: piuttosto, esse sono rispettivamente vere di Enzo e di
Giuseppe, e cioè si possono applicare agli individui Enzo e Giuseppe, che restano le sole
entità chiamate in causa dagli enunciati considerati.
Sarebbe sbagliato però, secondo Quine, ritenere che l’impegno ontologico ricada
esclusivamente o anche primariamente sui nomi. Recuperando il senso di fondo della teoria
delle descrizioni di Russell, Quine afferma che in realtà nessun nome gioca un ruolo
essenziale nel linguaggio: ogni nome infatti può essere sostituito senza perdita di
informazione da espressioni contenenti solo predicati e quantificatori. Così, per es., il nome
“Pegaso” in “Pegaso è il cavallo di Perseo” può essere sostituito dal predicato “esserePegaso”, e noi possiamo riformulare l’enunciato in “Esiste uno e un solo x, tale che x èPegaso e x è il cavallo di Perseo”. Quine quindi conclude che l’impegno ontologico ricade
solo sulle variabili vincolate dai quantificatori: «essere è essere il valore di una variabile
vincolata». Ora, naturalmente, la teoria di Quine circa l’impegno ontologico di per sé è solo
una teoria intorno alla corretta soluzione delle questioni di esistenza interne: non ci dice se le
entità postulate da un certo enunciato ci siano davvero, ma solo quali siano le entità postulate
da quell’enunciato. Come Carnap, Quine ritiene che le questioni esterne siano materia di
decisione pragmatica, e cioè che esse si risolvano nella domanda se un certo linguaggio con i
suoi postulati semantici sia o no desiderabile.
Quine: la deflazione dell’ontologia
Quine ha almeno due ordini di considerazioni pragmatiche da suggerire allo scopo di
decidere circa la desiderabilità di un linguaggio. In primo luogo, egli riafferma il principio del
rasoio di Ockham: a parità di altre considerazioni, deve essere preferito il linguaggio meno
impegnativo ontologicamente. La teoria delle descrizioni ci insegna come fare a meno delle
entità non-esistenti di Meinong. Un uso adeguato dei quantificatori ci permette di fare a meno
degli universali. In secondo luogo, egli suggerisce che non dovremmo mai ammettere entità
delle quali non conosciamo le condizioni di identità. Noi dovremmo cioè accettare un
linguaggio solo se disponiamo di un metodo per determinare l’identità degli oggetti che
introduce, stabilendo in quali circostanze essi si distinguano tra loro e in quali invece si
identifichino: il linguaggio è un nostro strumento e non dovrebbe creare più problemi di
38
quanti non ci aiuti a risolvere. Quine condensa il suo suggerimento nello slogan: «Niente
entità senza identità».
Questa considerazione vale, secondo Quine, in particolare contro i linguaggi che
postulano l’esistenza delle proprietà e contro quelli che introducono nella loro ontologia
interna i possibili inattuati. Noi infatti non abbiamo nessuna chiara idea circa l’identità di
entità del genere: sappiamo per es. che i triangoli equilateri si identificano con i triangoli
equiangoli, ma non sapremmo dire se la proprietà essere-un-triangolo-equilatero coincida con
la proprietà essere-un-triangolo-equiangolo o se esse siano semplicemente proprietà che ineriscono alle medesime cose; non abbiamo la minima idea di come decidere se il possibile
Napoleone che vince la battaglia di Waterloo coincida o no col possibile Napoleone che
muore a Parigi nel 1830.
Quine manifesta la sua perplessità riguardo alla semantica dei mondi possibili
elaborata da Kripke e da altri logici per chiarire l’interpretazione dei linguaggi modali,
appunto in ragione del fatto che essa fa un uso essenziale dell’idea dei possibili inattuati. Tale
perplessità coinvolge la nozione stessa di una verità necessaria. La maggior parte della precedente filosofia del linguaggio e Carnap in maniera esemplare avevano sostenuto infatti che la
verità necessaria si risolve nell’analiticità, e cioè in una verità determinata dai rapporti tra i
concetti costituenti l’enunciato. Quine mostra però l’insufficienza di questa soluzione, e
sostiene che la logica dei linguaggi modali, in particolare quella dei linguaggi che ammettono
la quantificazione, non viene giustificata se non si accetta una forma di essenzialismo, e cioè
se non si riconosce che la necessità e la possibilità non si risolvono nei rapporti definitori dei
concetti che noi impieghiamo per parlare delle cose, ma si radicano nell’essenza delle cose
stesse che noi concepiamo per loro tramite. Ciò risulta chiaro in particolare dalla logica degli
enunciati di identità. Come ha dimostrato Ruth Barcan Marcus, infatti, nella logica modale
vale il teorema “Per ogni x e per ogni y, se x è y, allora necessariamente x è y’: gli enunciati di
identità che contengono designatori associati a oggetti determinati debbono dunque essere
considerati necessari. Ora, Quine nota appunto che tale comportamento modale dell’identità
non si spiega in termini di verità a priori come le verità analitiche e di modalità epistemiche,
cioè di necessità e contingenza interpretate rispettivamente come certezza indipendente
dall’esperienza o ricavata da essa. Si considerino i seguenti esempi. Gli antichi battezzarono
“Fosforo” la stella del mattino ed “Espero” la stella della sera. Battezzarono “acqua” una certa
sostanza, e noi abbiamo battezzato “H2O” un certo composto di idrogeno e ossigeno. Ma ve39
rità come “Espero è Fosforo” e “L’acqua è H2O” sono a posteriori, cioè epistemicamente
contingenti: esse infatti sono state conosciute solo per mezzo di scoperte empiriche. Non sono
dunque analitiche. La logica modale ci dice però che noi dovremmo considerarle necessarie.
Segno, a parere di Quine, che la necessità e la possibilità con le quali si compromette la logica
modale sono più impegnative di semplici rapporti tra i nostri concetti. Giudicando l’essenzialismo una forma di metafisica tra le più irresponsabili e dunque una proposta
filosoficamente inaccettabile, Quine trae la morale che tutta la problematica della modalità
deve essere messa al bando.
Nella rosa delle proposte ontologiche che Quine trova indesiderabili il posto di maggior
riguardo va tuttavia riconosciuto alle intensioni: le presunte entità che la tradizione dell’ontologia, si pensi solo a Bolzano e a Frege, ha chiamato di volta in volta concetti, idee,
sensi, significati, pensieri in senso oggettivo. Per Quine noi non dovremmo ammettere le
intensioni perché neppure di esse possiamo chiarire le condizioni di identità. E non siamo in
grado di chiarirne le condizioni di identità perché non abbiamo alcun criterio empirico per
stabilire se due enunciati o due termini abbiano o no il medesimo senso. Come spiega nei Due
dogmi dell'empirismo (1951) la natura olistica dei controlli empirici infatti, secondo Quine,
comporta che qualsiasi enunciato preliminarmente accolto può essere rigettato in seguito, di
fronte a nuove osservazioni empiriche, per ripristinare la coerenza d’insieme del patrimonio
linguistico. Nessun enunciato è immune da revisione; dunque non ci sono verità analitiche all’interno del linguaggio e con ciò non siamo neppure in grado di stabilire presunte identità di
significato tra espressioni linguistiche. Seguendo con coerenza tale linea di pensiero Quine
invita inoltre i filosofi a sbarazzarsi del concetto husserliano di intenzionalità, che resta
inesplicabile se non si ammettono delle entità suscettibili di fare da bersaglio ai possibili atti
di pensiero, entità che non potrebbero che essere appunto le oscurissime intensioni.
Quine: l’empirismo senza dogmi
Ma il rifiuto delle intensioni retroagisce in Quine sull’originario impianto carnapiano
delle problematiche ontologiche. Infatti, se non è possibile individuare enunciati analitici, non
è possibile neppure distinguere tra questioni di esistenza interne ed esterne: se non ci sono
enunciati analitici, non c’è niente che possa rappresentare l’ossatura concettuale di un certo
sistema linguistico e delimitarne l’identità, tracciando un confine tra ciò che fa parte degli assunti interni di quel sistema e ciò che riguarda il rapporto tra quel sistema stesso e le altre
40
parti del nostro patrimonio conoscitivo. Perde dunque ogni fondamento la distinzione carnapiana tra procedure teoretiche interne al sistema linguistico, miranti a stabilire che cosa il
sistema assuma come esistente, e procedure pragmatiche esterne, miranti a sostituire il
sistema stesso con un sistema che faccia diverse assunzioni: poiché tutte le decisioni sono
guidate solo flessibilmente dall’esperienza, di qualsiasi decisione si deve dire che ha una
importanza conoscitiva e insieme che incorpora considerazioni di semplicità e comodità. È
fuorviante quindi affermare che, mentre la metafisica azzarda un impegno ontologico
assoluto, la scienza si limita a un impegno ontologico solo relativo: scienza e metafisica, ma
anche scienza e mito, e tutte le altre imprese intellettuali umane, appartengono al medesimo
piano epistemologico.
Quine: la relatività ontologica
L’empirismo radicale di Quine invita allo scetticismo nei confronti delle intensioni.
Esso tuttavia invita a un atteggiamento perlomeno disincantato anche nei riguardi del
riferimento. Un tale atteggiamento d’altronde non è se non l’altra faccia del rifiuto della
distinzione tra questioni ontologiche interne ed esterne. Quine infatti arriva alla conclusione
che non è possibile dire che cosa costituisca il riferimento dei termini di un certo linguaggio
in assoluto e senza presupporre lo sfondo di un qualche patrimonio culturale. Non ha senso
parlare dei postulati ontologici di un certo linguaggio: ogni descrizione dei postulati
ontologici di un certo linguaggio è relativa al sistema culturale all’interno del quale noi
stiamo operando, potrebbe essere diversa se noi ci trovassimo a operare entro un diverso
sistema culturale, e non ha senso dire quale tra le diverse possibili descrizioni sia quella
giusta. C’è una «relatività ontologica»: se tutte le questioni ontologiche sono pragmatiche, e
dunque in un certo senso esterne, esse sono anche tutte in un certo senso interne, e dunque
relative.
Quine raggiunge questa conclusione riflettendo sui problemi che incontrerebbe nell’individuare il riferimento dei termini di un determinato linguaggio un linguista che si trovasse
in una situazione di «traduzione radicale», e cioè un linguista che non condividesse nemmeno
in parte la cultura di coloro che parlano il linguaggio che egli cerca di tradurre, perciò non
potesse avvalersi di informazioni collaterali sulle credenze dei parlanti, ma dovesse contare
solo sull’osservazione empirica relativa alle parole che vengono pronunciate nei differenti
contesti d’uso. In una situazione di traduzione radicale, non tutto sarebbe ugualmente
41
problematico. Bisogna distinguere innanzitutto tra enunciati con un valore di verità che varia
in dipendenza dal contesto di emissione (come per es. “Guarda, un coniglio!”) ed enunciati
permanentemente veri o permanentemente falsi (come per es. “2+2=4”, “2+2=5”, “Napoleone
muore a Sant’Elena nel 1821” o “Napoleone muore a Parigi nel 1830’). La traduzione dei
primi presi nel loro complesso non presenta problemi maggiori di quelli presentati da
qualsiasi ipotesi empirica da confermare induttivamente. Immaginiamo, come propone Quine,
che all’apparire di un coniglio il parlante indigeno che stiamo osservando esclami “Gavagai!”.
La nostra ipotesi sarà che la frase “Gavagai!” nella lingua dei nativi equivalga alla nostra “Un
coniglio!”, “Guarda, un coniglio!” o simili. È un’ipotesi che potremo controllare ed
eventualmente correggere con ulteriori osservazioni del comportamento linguistico dei nativi.
Presenterebbe invece una difficoltà insuperabile di genere differente la traduzione dei
singoli termini impiegati negli enunciati, anche quando questi sono enunciati con valore di
verità variabile secondo il contesto. Il termine “gavagai” impiegato nella frase esclamativa
sopra riferita equivale al nostro “coniglio”? oppure a “parti non separate di coniglio”, o a
“stadio temporale di coniglio”, o a “spirito del coniglio”, oppure a “pelliccia di un coniglio
vivente”? Non sapremmo dirlo: è chiaro infatti che nella stessa situazione reale in cui
compare un coniglio, compaiono anche delle parti non separate di coniglio, uno stadio
temporale di coniglio, lo spirito del coniglio e la pelliccia di un coniglio vivente. Il medesimo
comportamento linguistico si presta a un numero illimitato di diverse interpretazioni: non
possiamo mai dire come il parlante analizza la situazione concreta nella quale si trova a
pronunciare gli enunciati che noi abbiamo imparato a tradurre nel loro insieme, e cioè quali
generi di entità componenti egli riconosca presenti nella situazione. La traduzione radicale è
dunque intrinsecamente indeterminata. E non ha senso perciò parlare del riferimento di un
termine in assoluto, come se fosse qualcosa che è associato al termine preso in se stesso e che
può essere determinato indipendentemente dallo sfondo culturale entro cui si svolge l’interpretazione del linguaggio.
Davidson: la struttura di una teoria dell’interpretazione
Va osservato peraltro che, proprio muovendo dalla discussione quineana del problema
della traduzione radicale e accettando anche la conclusione che esso non ammetta soluzioni libere da decisioni pragmatiche, lo statunitense Donald Davidson (1917-2003) ha elaborato un
importante approccio al problema dell’interpretazione. Davidson riprende l’idea di Frege che
42
il senso dell’enunciato sia dato dalle sue condizioni di verità. Ora, la semantica di Tarski
spiega come descrivere le condizioni di verità per gli enunciati di un certo linguaggio:
indicando ricorsivamente le condizioni di verità per gli enunciati complessi a partire da quelle
per gli enunciati elementari. D’altra parte, osserva Davidson, una descrizione elaborata
secondo i canoni indicati da Tarski potrebbe svolgere una funzione diversa da quella di teoria
della verità che Tarski stesso le assegna: invece di intenderla come una teoria che caratterizza
gli enunciati riconosciuti come veri presupponendo che i loro termini dispongano di un’interpretazione entro il metalinguaggio, potremmo intenderla come una teoria che spiega come i
loro termini debbano essere interpretati nel metalinguaggio, e cioè come possano essere
tradotti nel linguaggio che noi comprendiamo, presupponendo che noi sappiamo quando gli
enunciati sono veri. Ma anche nel caso di una situazione di traduzione radicale, a giudizio
dello stesso Quine, è possibile stabilire quando gli enunciati sono giudicati veri dai parlanti.
Davidson conclude perciò che la teoria tarskiana della verità per un determinato linguaggio
può automaticamente essere capovolta in una teoria dell’interpretazione di quel linguaggio.
La soluzione dei problemi di traduzione radicale conseguibile per questa via d’altra parte è
sempre empirica e come tale soggetta a un controllo soltanto olistico: essa dunque può essere
via via confermata o smentita solo nel suo insieme dal comportamento, linguistico e non, dei
parlanti. E si tratta anche, e soprattutto, di una soluzione che riconosce la presenza nella
semantica di un’ineliminabile componente di scelta pragmatica. Le teorie dell’interpretazione
astrattamente possibili per un certo linguaggio sono infatti illimitate, stabilire un’interpretazione impone di sceglierne una e una teoria è capace di funzionare come un’autentica
interpretazione solo se è scelta conformemente al «principio di carità», e cioè solo se
attribuisce al parlante il maggior numero possibile di credenze che l’interprete stesso
considera vere: in altri termini, solo se risponde il più possibile all’imperativo pragmatico di
facilitare l’integrazione del punto di vista del parlante con quello dell’interprete.
Davidson: contro l’idea stessa di uno schema concettuale
Davidson è arrivato alla conclusione che in ogni interazione linguistica si svolge un
lavoro di interpretazione, e che dunque non ha senso parlare di una pluralità di lingue distinte
concepite come patrimoni condivisi da specifiche comunità di parlanti che non hanno
necessità di interpretare reciprocamente i rispettivi atti linguistici: non esistono infatti
comunità linguistiche internamente trasparenti e non esistono perciò le lingue; esiste solo il
43
linguaggio, inteso come generale capacità umana di capire e di farsi capire tramite processi di
interpretazione.
In Sull'idea stessa di uno 'schema concettuale' (1974) Davidson elabora un celebre e
discusso argomento, per mostrare l’incoerenza dell’ipotesi stessa di una pluralità di lingue
concettualmente intraducibili. Secondo Davidson, infatti, innanzitutto, non può darsi una
lingua completamente intraducibile nella nostra, perché, se noi ci trovassimo nella totale
impossibilità di comprendere il comportamento verbale di determinate persone, finiremmo per
non avere neppure motivo di identificarle davvero come persone, e perciò per attribuire loro
un qualsiasi linguaggio. D’altra parte, non può essere ammessa una intraducibilità solo
parziale, perché, secondo la metodologia della traduzione, il fatto che tutte le ipotesi di
traduzione già escogitate per un certo segmento del linguaggio straniero risultino implausibili
dimostra solo la necessità di cercare ulteriori ipotesi e non prova affatto la definitiva
intraducibilità di quel segmento del linguaggio. Da questo argomento Davidson trae la prima
conclusione che non ha senso parlare di schemi concettuali alternativi: infatti, ci sarebbero
degli schemi concettuali alternativi solo se potessero esserci dei linguaggi mutuamente
intraducibili.
Fondandosi su tale prima conclusione, egli trae poi la conclusione ulteriore e più
drastica che non ha senso neppure continuare a distinguere uno schema concettuale e un
contenuto concettualizzabile: infatti, avrebbe senso farlo solo se il medesimo contenuto
potesse essere concettualizzato entro schemi diversi; se non sono possibili più schemi concettuali, non ha senso neanche parlare di un singolo schema concettuale. Secondo Davidson,
dobbiamo dunque abbandonare l’idea che ci sia un contenuto rappresentabile come il mondo
o l’insieme dei dati grezzi di esperienza, e che la nostra conoscenza consista nell’organizzare
tale contenuto tramite i concetti. Nell’intento di liberalizzare compiutamente l’empirismo,
Quine ha rifiutato come «dogmi non empirici» le due idee dell’analiticità e della integrale
riducibilità empirica del contenuto di ciascuna teoria. Davidson prosegue l’opera quineana di
demistificazione, affermando che la distinzione tra schema concettuale e contenuto
concettualizzabile rappresenta solo un «terzo dogma» arbitrario. Egli fa notare, tuttavia, che,
abbandonando tale distinzione, come senz’altro dobbiamo fare, veniamo ad abbandonare del
tutto anche l’empirismo stesso, perché rinunciamo a ogni rapporto con l’idea che l’esperienza
faccia da stabile punto di riferimento per la nostra attività concettuale.
44
Goodman e Putnam: l’autoconsunzione del realismo
Emerge poi sempre più evidente il fatto che precisamente ciò che rende insostenibile un
relativismo radicale rende anche privo di senso il realismo che è stato originariamente
contrapposto al relativismo. Come ha lucidamente visto Davidson, non ha senso l’idea di uno
schema concettuale puro e indipendente dagli altri, ma non ha senso neppure l’idea di un
contenuto concettualizzabile puro e indipendente dai concetti. Non ha senso l’idea di una
realtà preconcettuale. Il pensiero dello statunitense Nelson Goodman (1906-1998)
rappresenta un esito conseguente e consapevolmente dissacratore di questa linea di pensiero.
Riprendendo alcune suggestioni dell’idealista neokantiano tedesco Ernst Cassirer (18741945), Goodman descrive i diversi schemi concettuali scientifici, artistici, religiosi, etc., come
istitutivi di differenti «versioni del mondo», e parla del pensiero come di una attività di
«costruzione di mondi» (world-making, in inglese). La sua posizione d’altra parte non è, a
rigore, di carattere idealistico come quella di Cassirer. Il senso ultimo della posizione di
Goodman è infatti quello stesso della quineana relatività ontologica: che cioè è sterile la
pretesa di risolvere le questioni ontologiche in assoluto e indipendentemente dallo schema
concettuale al cui interno ci troviamo.
Il processo di autoconsunzione del realismo emerge con chiarezza dalla parabola
filosofica dello statunitense Hilary Putnam (1926-). Putnam infatti, rettificando le proprie
posizioni iniziali e avvicinandosi a quelle di Goodman, o, almeno, reinterpretandole, finisce
per promuovere una polemica assai acuta contro il «realismo metafisico», e cioè appunto
contro la tesi dell’esistenza di una realtà indipendente dagli schemi concettuali. Putnam
osserva che, se tale tesi fosse corretta, anche la teoria scientifica migliore e più conforme a
tutti i nostri criteri metodologici potrebbe dopo tutto non corrispondere alla realtà: credere in
una realtà indipendente dal nostro pensiero è infatti credere che una cosa sia la persuasività
del pensiero stesso e un’altra la sua verità; e cioè credere che ogni nostra struttura di pensiero,
per quanto internamente convincente possa sembrare, sia comunque suscettibile di essere
falsa. Ma una simile eventualità è inintelligibile. Noi infatti non riusciamo a farci alcuna idea
di che cosa possa essere una credenza perfettamente coerente con tutte le evidenze empiriche
e con tutti i requisiti teorici e insieme non corrispondente alla realtà: la nostra idea della
corrispondenza alla realtà si risolve in concreto nell’idea dell’accordo con i consueti criteri
di accettabilità razionale.
45
Putnam illustra la sua critica del realismo metafisico tramite un argomento che richiama, sia pure per capovolgerla, l’ipotesi cartesiana del genio ingannatore. Il realismo metafisico ritiene che non ci sia nessuna connessione necessaria tra la rispondenza di una opinione
ai nostri criteri di accettabilità razionale e la sua corrispondenza alla realtà. Per il realismo
metafisico è dunque possibile che tutte le nostre opinioni apparentemente più credibili siano
false. È possibile in particolare che non ci siano affatto i tavoli, le sedie e tutti gli altri oggetti
che crediamo di vedere intorno a noi; nella sua ottica è possibile per es., argomenta Putnam,
che noi siamo solo dei cervelli mantenuti artificialmente in vita da fantascientifici
neuroscienziati in vasche piene di sostanze nutrienti, e che l’illusione della vita ordinaria sia
prodotta in noi tramite qualche sapiente stimolazione elettrochimica delle nostre terminazioni
nervose.
Ma Putnam obietta che una simile ipotesi è incoerente. Degli esseri che si trovassero
davvero nella condizione descritta, infatti, con parole come “tavolo”, “sedia”, ed anche
“vasca” e “cervello”, non potrebbero intendere le stesse cose che intendiamo noi, perché non
avrebbero alcun tipo di rapporto reale con le cose del nostro mondo e non avrebbero dunque
neppure potuto istituire alcuna relazione di riferimento tra le parole del loro linguaggio e tali
cose stesse. Potrebbero solo intendere le cose con cui hanno effettivamente dei rapporti, e cioè
le apparenze percettive di cui hanno esperienza: le apparenze-di-tavolo, le apparenze-di-sedia,
le apparenze-di-vasca, etc. Così, un essere simile che dicesse “Davanti a me c’è un tavolo”,
non potrebbe se non intendere che sperimenta una apparenza-di-tavolo. Supponiamo che questo essere subisca il fascino del realismo metafisico. Supponiamo che egli sospenda la sua
credenza di essere seduto su una sedia, davanti a un tavolo, in sereno ozio filosofico, e che
formuli la congettura di essere in realtà solo un cervello chiuso in una vasca. Il punto è che un
simile essere, dicendo “Sono un cervello chiuso in una vasca”, potrebbe solo intendere di
essere una apparenza-di-cervello apparentemente-chiuso in una apparenza-di-vasca. Ma tale
congettura sarebbe falsa. Egli infatti per ipotesi non sarebbe una apparenza-di-cervello, bensì
una apparenza-di-uomo-intero; e non sarebbe affatto apparentemente-dentro una apparenzadi-vasca, bensì apparentemente-seduto su di una apparenza-di-sedia.
La conclusione di Putnam, in completo parallelismo col caso di questi esseri
immaginari, è che anche la nostra ipotesi di essere permanentemente ingannati dalle
apparenze, di essere per es. cervelli chiusi in una vasca, o comunque di essere inseriti in una
realtà sistematicamente diversa dalla rappresentazione che noi ci formiamo di essa, sarebbe
46
necessariamente falsa: noi infatti parlando di “realtà” non potremmo riferirci affatto a una
realtà inaccessibile alla nostra intelligenza, bensì solo alla realtà-con-cui-siamo-in-rapporto, e,
in riferimento a quest’ultima, la congettura diventerebbe automaticamente falsa. Dunque il
realismo metafisico è una posizione incoerente: una realtà indipendente dai nostri schemi
concettuali e dai criteri di accettabilità razionale che ne fanno parte è altrettanto inconcepibile
della cosa in sé della metafisica pre-kantiana.
Al realismo metafisico Putnam contrappone una prospettiva «internistica»: non c’è una
realtà «esterna» ai nostri schemi concettuali; la verità consiste nella «accettabilità razionale
idealizzata», cioè nella ideale rispondenza completa ai criteri di verità contenuti nei nostri
schemi concettuali, e la realtà si identifica con il contenuto di una credenza razionalmente
accettabile e idealmente completata. D’altra parte, secondo Putnam, l’internismo non equivale
a un idealismo degli schemi concettuali: per quanto definibile solo in riferimento agli obiettivi
cognitivi caratteristici dei nostri schemi concettuali, la realtà è pur sempre una. Piuttosto
Putnam tenta in qualche modo una mediazione tra Davidson e Goodman. L’atteggiamento di
Putnam nei confronti di Davidson è complesso. Per un verso, Putnam riconosce che l’argomento di Davidson confuta l’idea di schemi concettuali incapaci di comunicazione. Per l’altro, egli non pensa che esso dimostri l’assurdità della nozione medesima di schema
concettuale: l’internismo stesso infatti si serve in modo essenziale di tale nozione. Nei confronti di Goodman, Putnam tenta invece una operazione di decantazione filosofica. Egli infatti
mira a liberare il discorso di Goodman dalle forzature retoriche che accompagnano la teoria
della costruzione dei mondi: mette in evidenza come nella sostanza Goodman non intenda
proporre una teoria idealistica intorno alla sorgente della realtà, ma inviti piuttosto a
ridimensionare la nozione stessa di realtà e a non confidare nel suo potere esplicativo. L’internismo di Putnam finisce per non essere altro che una formulazione non paradossale delle
posizioni di Goodman.
Putnam ritiene inoltre che sia ancora possibile sostenere una forma di realismo. Però il
solo realismo logicamente legittimo è un «realismo interno»: un realismo cioè che si risolve
nella tesi che la maggior parte delle idee scientifiche sono vere, o, per lo meno, che esse si
vengono approssimando alla realtà, intesa appunto come la meta ideale interna dei nostri
schemi concettuali. Si tratta di un realismo «empirico». Secondo Putnam, infatti, esso è
giustificato empiricamente dall’analisi dello sviluppo delle credenze scientifiche, e soprattutto
dai fenomeni della convergenza delle teorie nella scienza matura e del successo tecnologico
47
della scienza: la migliore spiegazione empirica del fatto che le divergenze teoriche tra gli
scienziati tendano a diminuire nel corso dello sviluppo scientifico e del fatto che le credenze
scientifiche si rivelino suscettibili di importanti applicazioni tecniche è appunto che la scienza
si venga avvicinando alla verità.
Non molto lontano da questa conclusione di Putnam è lo statunitense Arthur Fine
(1937-). Anche Fine sostiene che l’osservazione della concreta modalità di sviluppo della
scienza non giustifica né il realismo metafisico né l’idealismo metafisico, bensì solo il punto
di vista ontologicamente neutrale che egli battezza «atteggiamento ontologico naturale», e
cioè la convinzione che la gran parte dei risultati scientifici sia vera, indipendentemente da
ogni interpretazione metafisica a proposito della natura di tale verità.
Kripke: il nuovo essenzialismo
In controtendenza rispetto al processo intellettuale che condurrà prima Wittgenstein, poi
l’empirismo logico e infine Quine, Davidson e Goodman a mettere in discussione uno dopo
l’altro tutti i presupposti dell’ontologia, negli ultimi decenni è affiorato in seno all’ontologia
stessa un filone che ha viceversa rafforzato questi presupposti, richiamando in auge categorie
ontologiche tipiche della metafisica tradizionale che parevano ormai condannate all’oblio. I
filosofi appartenenti a questo filone hanno tratto i loro argomenti soprattutto dall’analisi delle
categorie modali di possibilità e necessità, e dalla rilevazione delle difficoltà incontrate dall’atomismo logico su questo terreno.
Tra di essi un posto eminente è occupato dal logico statunitense Saul Kripke (1940-),
che, in Identità e necessità (1971) e in Nome e necessità (1972), ha ritenuto legittimo
riproporre le nozioni classiche di essenza e di necessità metafisica. Il punto di vista di Kripke
ha un rapporto complesso con l’atomismo logico. Tra i nomi propri della grammatica, infatti,
l’atomismo logico aveva distinto quelli dotati di un senso, ma non necessariamente dotati di
un riferimento, e cioè i nomi equivalenti a descrizioni, e quelli logicamente propri, che per
definizione hanno un riferimento, ma non hanno alcun senso. Che i due tipi di nomi propri
avessero un diverso comportamento semantico, l’atomismo logico - Wittgenstein in modo
paradigmatico - lo aveva sostenuto anche guardando al modo in cui si comporta il loro
riferimento col variare degli stati di cose ovvero dei possibili fatti. Si considerino i diversi
possibili insiemi massimi di stati di cose, e cioè i diversi modi possibili in cui il mondo
avrebbe potuto essere fatto: per usare l’espressione kripkiana, i diversi «mondi possibili».
48
Secondo l’atomismo logico, il riferimento dei nomi propri del primo tipo può variare nei
diversi mondi possibili e perfino non esserci. Se per es. il nome “Socrate” equivale a “il
maestro di Platone”, nei diversi mondi possibili “Socrate” può designare individui diversi o
anche non designare alcunché: se la storia fosse stata diversa, Platone avrebbe potuto avere un
diverso maestro o anche nessun maestro. Il riferimento dei nomi propri del secondo tipo
sarebbe invece, per definizione, lo stesso in tutti i mondi possibili: essi nominerebbero infatti
gli oggetti semplici, e cioè la «sostanza del mondo».
Ora, la posizione di Kripke si distingue innanzitutto per il fatto di sostenere che ogni
nome proprio è un «designatore rigido», e cioè che il nome proprio, se è tale, designa sempre
lo stesso oggetto in tutti i mondi possibili; e di conseguenza per il fatto di rifiutare a qualsiasi
nome proprio un senso, e cioè l’equivalenza a una descrizione, che è peculiarmente un
designatore non rigido. Kripke dunque per un verso accantona la distinzione altamente
metafisica tra nomi logicamente propri e non, e la connessa problematica degli oggetti
semplici che i primi designerebbero; per l’altro, estende a ogni nome proprio precisamente la
trattazione che l’atomismo logico riservava ai nomi logicamente propri.
Secondo Kripke, infatti, la capacità di designazione del nome proprio non si spiega con
la sua pretesa equivalenza a una descrizione. Piuttosto, si spiega col fatto che il suo riferimento è fissato da un «battesimo iniziale» che collega il nome proprio stesso a un
determinato oggetto. Tale riferimento, in mancanza di una esplicita ridefinizione, continua a
coincidere col medesimo oggetto, anche se possono variare le rappresentazioni che i parlanti
si fanno dell’oggetto in questione, in virtù del fatto che i successivi impieghi del nome
formano una «catena causale» che connette ogni nuovo atto d’impiego ai precedenti. Così, per
es., “Socrate” si riferisce all’individuo determinato che fu inizialmente designato con tale
nome, e con tale nome anche noi ci riferiamo a quell’individuo, in virtù del fatto che il nostro
uso si ricollega tramite una storia unitaria all’impiego originario, indipendentemente dal fatto
che, poniamo, noi oggi associamo correttamente o scorrettamente al nome “Socrate” l’immagine di un uomo barbuto e maestro di Platone. Se infatti, per assurdo, si dovesse scoprire
che il maestro di Platone non era la persona chiamata “Socrate” dagli ateniesi della fine del
quinto secolo, noi non dovremmo concludere che il nome “Socrate” da allora ha cambiato
riferimento, bensì che tale nome, diversamente da come pensavamo, non si riferisce al
maestro di Platone. La connessione col battesimo che istituisce la funzione designativa del
nome proprio chiarisce il fatto che il nome proprio designa lo stesso oggetto in tutti i mondi
49
possibili: il fatto cioè che la sua funzione designativa è indipendente dall’eventuale modalità
concettuale di designazione, o, in altri termini, il fatto che esso continuerebbe a designare il
medesimo oggetto, anche se tale oggetto dovesse rivelarsi dotato di caratteristiche diverse da
quelle che gli erano state anteriormente attribuite.
Kripke pensa d’altra parte che, oltre i nomi propri, siano designatori rigidi, e dunque che
abbiano una funzione designativa indipendente dalla modalità concettuale della designazione,
anche i nomi dei generi naturali. Parole come per es. “acqua” o “cane” designano lo stesso
genere di cose in tutti i mondi possibili: il genere delle cose che furono battezzate originariamente con quei nomi, indipendentemente da qualsiasi idea che i parlanti si facessero allora,
o si facciano oggi, delle sostanze o degli animali, e indipendentemente da ogni revisione
intervenuta in tali idee a seguito di scoperte scientifiche; eventuali revisioni di tale tipo non
comporterebbero infatti la conseguenza di cambiare il riferimento dei nomi “acqua” o “cane”,
bensì quella di farci scoprire che le cose designate con tali nomi hanno caratteristiche diverse
da quelle che erano state originariamente attribuite loro.
Coerentemente con la sua visione semantica, Kripke arriva inoltre alla conclusione che
ogni enunciato vero di identità nel quale il riferimento venga effettuato per mezzo di designatori rigidi è vero in tutti i mondi possibili, e dunque in base a una comprensibile
interpretazione della necessità, che esso è ontologicamente necessario, per quanto possa
essere epistemicamente contingente, ovvero a posteriori. La presa di posizione di Kripke va
inquadrata nel dibattito filosofico precedente intorno alla modalità. Kripke concorda con la
diagnosi di Quine circa il rapporto tra identità, modalità ed essenzialismo, ma sceglie la via
opposta: è vero che la logica modale compromette con il riconoscimento di essenze; ma, contrariamente al punto di vista di Quine, la logica modale è irrinunciabile; noi dunque dobbiamo
ripristinare la nozione dell’essenza, intesa come proprietà che appartiene all’oggetto in tutti i
mondi possibili, e cioè come condizione d’identità dell’oggetto indipendente dai concetti che
noi impieghiamo per riferirci ad esso. Che un certo oggetto abbia una certa proprietà
essenziale (per es. che l’acqua sia H2O) è una verità ontologicamente necessaria, ma non
sempre una verità a priori o analitica: per quanto appartenga alle condizioni d’identità dell’oggetto e valga di esso in tutti i mondi possibili (un liquido trasparente, incolore, inodore,
che bollisse a 100°, ma non fosse H2O, sembrerebbe acqua, ma non sarebbe acqua), essa non
è infatti una verità definitoria, può essere oggetto di una scoperta contingente e tarda, o
50
addirittura restare ignota. Le tesi essenzialiste di Kripke hanno trovato un’eco anche nella
teoria elaborata da Putnam intorno ai nomi di generi naturali.
51