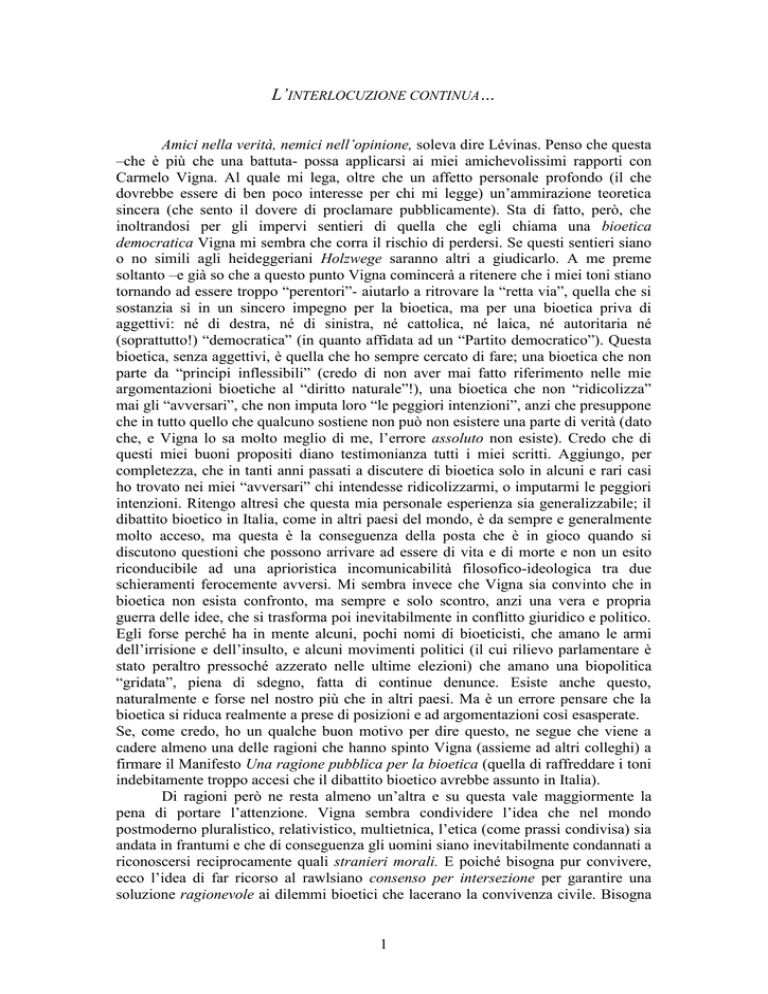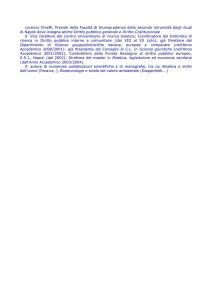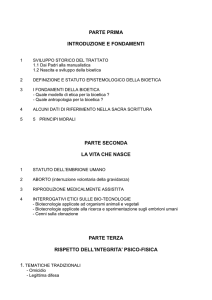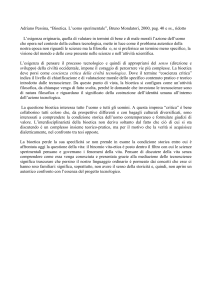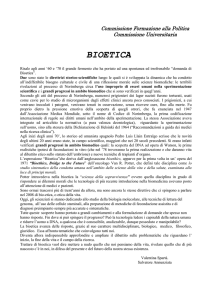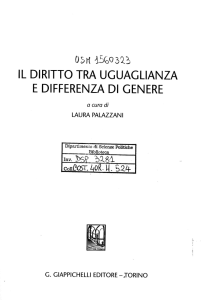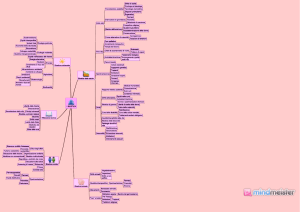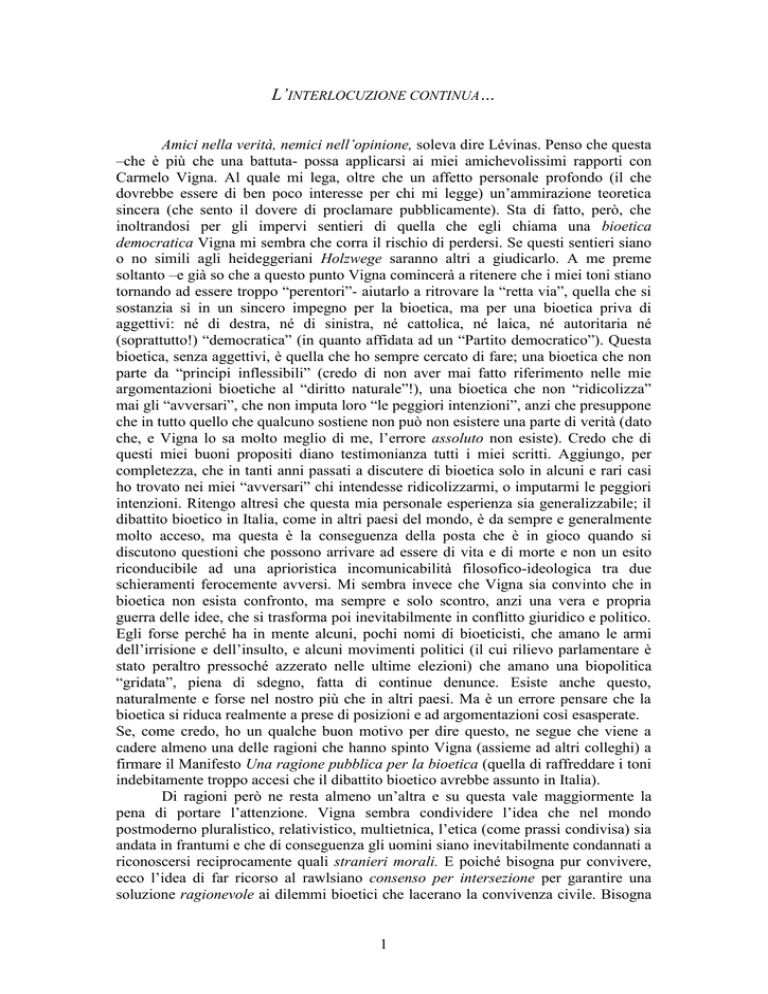
L’INTERLOCUZIONE CONTINUA…
Amici nella verità, nemici nell’opinione, soleva dire Lévinas. Penso che questa
–che è più che una battuta- possa applicarsi ai miei amichevolissimi rapporti con
Carmelo Vigna. Al quale mi lega, oltre che un affetto personale profondo (il che
dovrebbe essere di ben poco interesse per chi mi legge) un’ammirazione teoretica
sincera (che sento il dovere di proclamare pubblicamente). Sta di fatto, però, che
inoltrandosi per gli impervi sentieri di quella che egli chiama una bioetica
democratica Vigna mi sembra che corra il rischio di perdersi. Se questi sentieri siano
o no simili agli heideggeriani Holzwege saranno altri a giudicarlo. A me preme
soltanto –e già so che a questo punto Vigna comincerà a ritenere che i miei toni stiano
tornando ad essere troppo “perentori”- aiutarlo a ritrovare la “retta via”, quella che si
sostanzia sì in un sincero impegno per la bioetica, ma per una bioetica priva di
aggettivi: né di destra, né di sinistra, né cattolica, né laica, né autoritaria né
(soprattutto!) “democratica” (in quanto affidata ad un “Partito democratico”). Questa
bioetica, senza aggettivi, è quella che ho sempre cercato di fare; una bioetica che non
parte da “principi inflessibili” (credo di non aver mai fatto riferimento nelle mie
argomentazioni bioetiche al “diritto naturale”!), una bioetica che non “ridicolizza”
mai gli “avversari”, che non imputa loro “le peggiori intenzioni”, anzi che presuppone
che in tutto quello che qualcuno sostiene non può non esistere una parte di verità (dato
che, e Vigna lo sa molto meglio di me, l’errore assoluto non esiste). Credo che di
questi miei buoni propositi diano testimonianza tutti i miei scritti. Aggiungo, per
completezza, che in tanti anni passati a discutere di bioetica solo in alcuni e rari casi
ho trovato nei miei “avversari” chi intendesse ridicolizzarmi, o imputarmi le peggiori
intenzioni. Ritengo altresì che questa mia personale esperienza sia generalizzabile; il
dibattito bioetico in Italia, come in altri paesi del mondo, è da sempre e generalmente
molto acceso, ma questa è la conseguenza della posta che è in gioco quando si
discutono questioni che possono arrivare ad essere di vita e di morte e non un esito
riconducibile ad una aprioristica incomunicabilità filosofico-ideologica tra due
schieramenti ferocemente avversi. Mi sembra invece che Vigna sia convinto che in
bioetica non esista confronto, ma sempre e solo scontro, anzi una vera e propria
guerra delle idee, che si trasforma poi inevitabilmente in conflitto giuridico e politico.
Egli forse perché ha in mente alcuni, pochi nomi di bioeticisti, che amano le armi
dell’irrisione e dell’insulto, e alcuni movimenti politici (il cui rilievo parlamentare è
stato peraltro pressoché azzerato nelle ultime elezioni) che amano una biopolitica
“gridata”, piena di sdegno, fatta di continue denunce. Esiste anche questo,
naturalmente e forse nel nostro più che in altri paesi. Ma è un errore pensare che la
bioetica si riduca realmente a prese di posizioni e ad argomentazioni così esasperate.
Se, come credo, ho un qualche buon motivo per dire questo, ne segue che viene a
cadere almeno una delle ragioni che hanno spinto Vigna (assieme ad altri colleghi) a
firmare il Manifesto Una ragione pubblica per la bioetica (quella di raffreddare i toni
indebitamente troppo accesi che il dibattito bioetico avrebbe assunto in Italia).
Di ragioni però ne resta almeno un’altra e su questa vale maggiormente la
pena di portare l’attenzione. Vigna sembra condividere l’idea che nel mondo
postmoderno pluralistico, relativistico, multietnica, l’etica (come prassi condivisa) sia
andata in frantumi e che di conseguenza gli uomini siano inevitabilmente condannati a
riconoscersi reciprocamente quali stranieri morali. E poiché bisogna pur convivere,
ecco l’idea di far ricorso al rawlsiano consenso per intersezione per garantire una
soluzione ragionevole ai dilemmi bioetici che lacerano la convivenza civile. Bisogna
1
costruire e condividere una ragione pubblica, perché il riferimento esclusivo a valori
etici, inevitabilmente “privati”, rischia di creare fratture non più ricomponibili nel
corpo sociale. A questo fine. è necessario, per garantire il vivere insieme, adottare un
metodo realistico, flessibile, più attento a dare risposta ai bisogni dell’uomo che non a
riaffermare dogmi inevitabilmente astratti, perché –ribadisce Vigna- “il sabato è per
l’uomo e non l’uomo per il sabato”.
Non si potrebbe dir meglio. Sono uno studioso di Rawls dal lontanissimo
1988, quando per i tipi della Jaca Book pubblicai, col titolo Materiali sul
neocontrattualismo, un fitto volume di studi rawlsiani. Per questo, nessuno meglio di
me sa quanto l’illustre e compianto studioso tenesse a qualificare il suo pensiero come
politico e non come metafisico. E qui nascono le difficoltà. Se ha ragione Vigna –e
come potrebbe aver torto- a ripetere che “il sabato è per l’uomo e non l’uomo per il
sabato” è solo ad una condizione (inevitabilmente metafisica): che si sappia chi sia
l’uomo. Siamo convinti di sapere davvero chi sia l’uomo? Anzi, siamo davvero
convinti che tutti ritengano importante saperlo?
La mia impressione è che questa questione (cioè la “questione antropologica”)
venga ampiamente rimossa nei dibattiti contemporanei e in quelli bioetici in
particolare. Si badi: qui non sto sostenendo di sapere come si possa elaborare (per poi
mettermela in tasca) una compiuta e definitiva antropologia, tale –una volta esibita
pubblicamente- da imporsi all’evidenza e quindi da dover essere accettata da tutti,
come solido basamento per qualsiasi ulteriore dibattito bioetico. Sono convinto (e
credo che Vigna la pensi come me) che il pensiero antropologico, come ogni forma di
pensiero filosofico, è e non può che essere un work in progress. Una cosa però è il
pensiero, altra l’impegno: quello presuppone questo. Se infatti lo stesso impegno
antropologico viene messo da parte come irrilevante e superfluo, se la stessa
intenzionalità filosofica viene messa da parte, perché ritenuta capace di concretizzarsi
soltanto in un tale told by an idiot, signifying nothing (per dirla con Shakespeare)
dubito che si possa andare molto avanti in bioetica. Da pensiero etico, cioè filosofico,
essa si trasformerà inevitabilmente in pensiero retorico, o, se così si preferisce dire,
ideologico, in una bioetica giustificativa, un pensiero cioè finalizzato a tranquillizzare
l’opinione pubblica, ad indurla ad accettare senza troppi turbamenti, i “progressi”
della biomedicina, troppo veloci per essere legittimati, senza adeguate mediazioni, dal
senso comune. Questa è la critica sostanziale che continuo a rivolgere agli amici che
hanno elaborato e firmato il manifesto dal titolo Una ragione pubblica per la
bioetica: senza accorgersene (quindi non attribuisco loro “le peggiori intenzioni”) si
sono trasformati da filosofi in “ideologi” (e non voglio con questo termine –va da séridicolizzare né criminalizzare nessuno, dato che l’”ideologia” è serenamente
accettata da tanti come l’unico orizzonte filosofico residuo del nostro tempo).
Facciamo un esempio, attualissimo. In queste settimane il Belgio si sta
dividendo su quattro progetti di legge (presentati dal partito liberal-democratico
fiammingo) volti ad estendere la legalizzazione dell’eutanasia anche ai malati di
mente incurabili. Gli esperti di bioetica sanno benissimo che questa pratica, grazie a
diversi cavilli, è in atto da anni in Olanda (dove si pratica anche l’eutanasia
pediatrica): la novità sta nel tentativo di legalizzare formalmente il diritto ad una
morte con dignità. L’espressione è suggestiva; attira consensi; sembra auto-evidente
(come si può sostenere il diritto a morire senza dignità ?) ed è difficilissimo
contrapporle un’ espressione alternativa, altrettanto efficace. Nello stesso tempo,
poche espressioni, come questa, sono antropologicamente carenti. A chi sostiene che
bisogna legalizzare l’eutanasia per dare a tutti il diritto di morire con dignità, io non
obietto mai che la vita è sacra e quindi indisponibile; mi limito a chiedere che si apra
2
una discussione bioetica in merito, che la si apra con pazienza, onestà intellettuale,
con profonda attenzione alle ricadute giuridiche e sociali delle posizioni che si
vengono ad assumere, adottando come linea guida fondamentale quel medesimo
“principio di precauzione” che siamo soliti adottare per garantire l’ambiente o i diritti
degli animali. In molti, in coloro che sono animati da un sincero impegno
antropologico, questa richiesta trova ascolto: è con questo metodo, ad es., che si è
lentamente arrivati ad autentiche forme di consenso per intersezione su temi
delicatissimi, come quello del rifiuto delle cure da parte di pazienti competenti, come
quello sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, come quello sulla illiceità di
qualsiasi forma di accanimento terapeutico. Ma dobbiamo pur riconoscere che se si
nega senso in linea di principio non solo al pensiero, ma anche all’ impegno
antropologico, è ben difficile arrivare a un qualsiasi risultato. In assenza di un
radicamento antropologico evitare lo slippery slope è pressoché impossibile. Il
consenso per intersezione è una formula molto felice per ottenere efficaci mediazioni
politiche, nel contesto di valori costituzionali assunti come principi indiscutibili e
condivisi da tutti; ma se si fuoriesce dalla politica in senso stretto (cioè dalla
regolamentazione degli interessi) questa forma di consenso (con buona pace di Rawls,
che peraltro non si illudeva troppo al riguardo) si manifesta prima o poi come
illusoria. Insisto su questo punto. Vigna si preoccupa del fatto che io, ragionando in
tal modo, sia tentato dall’abbandonare la sfera pubblica alla sfera dell'utile:
naturalmente non è così. Semplicemente, sono convinto che è solo sull’utile che ha
senso esprimersi attraverso il voto o, al contrario, che sul bene non ha senso votare.
Lungi da me rigettare la “tradizione veneranda e vera, che fa dell'amicizia politica
l'architrave del bene comune”. Ma l’amicizia politica altro non è che il presupposto
non politico della politica come prassi, esattamente come l’amore coniugale è il
presupposto, non giuridico, del coniugio come vincolo giuridico.
Un’ultima considerazione. Nella sua amichevolissima “interlocuzione” con
me, Vigna ribadisce che lo scopo essenziale del Manifesto dal titolo Una ragione
pubblica per la bioetica era quello di portare l’attenzione del nascente “Partito
democratico” sulle modalità ottimali per risolvere in modo condiviso controverse
questioni bioetiche. Insomma, i firmatari del Manifesto si sono intenzionalmente
attribuiti il compito di farsi “consiglieri del Principe”. Vigna stesso riconosce che il
“Principe” ha però lasciato cadere i volenterosi (e non richiesti) suggerimenti. Così
comportandosi, è stato saggio il “Principe”? E’ stato stolto? La questione mi lascia,
come studioso di filosofia, relativamente indifferente; i filosofi, a mio avviso, esistono
per dare testimonianza, non per dare consigli; quando purtroppo si mettono in testa, a
mio avviso sbagliando (e qui torno ad essere “perentorio”!), che è questo che devono
fare, corrono il rischio di diventare così importuni da essere alla fine venduti come
schiavi (il che potrebbe comunque avere almeno un buon effetto su di loro, quello di
fargli aprire gli occhi). Spero bene che questo triste destino a Vigna non capiti mai;
ove capitasse, stia pur certo che correrò a riscattarlo, come ad Egina fece Anniceide
per Platone. Perché, senza Vigna e senza il suo intenso lavoro filosofico, e di questo
sono assolutamente sicuro, il panorama della filosofia italiana non sarebbe più lo
stesso.
Francesco D’Agostino
3