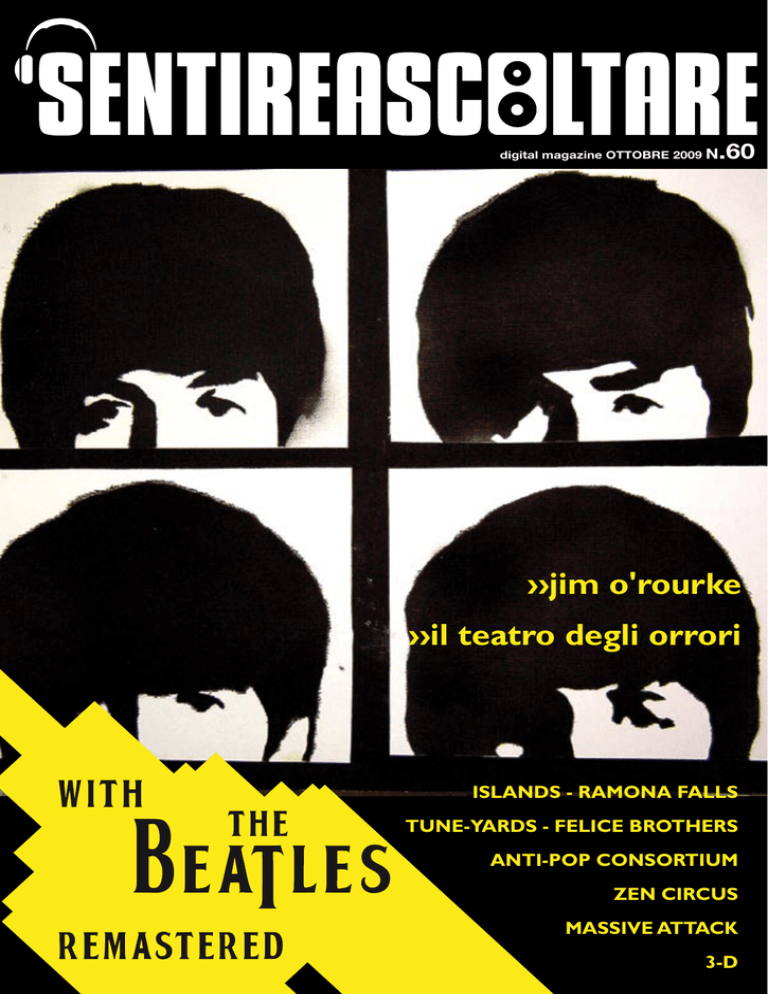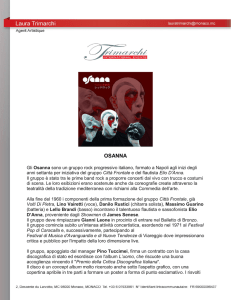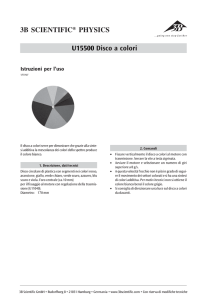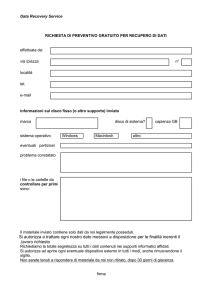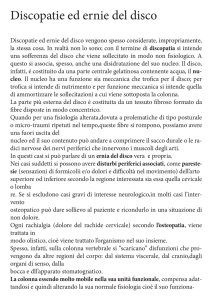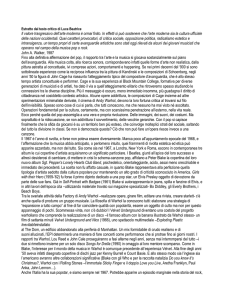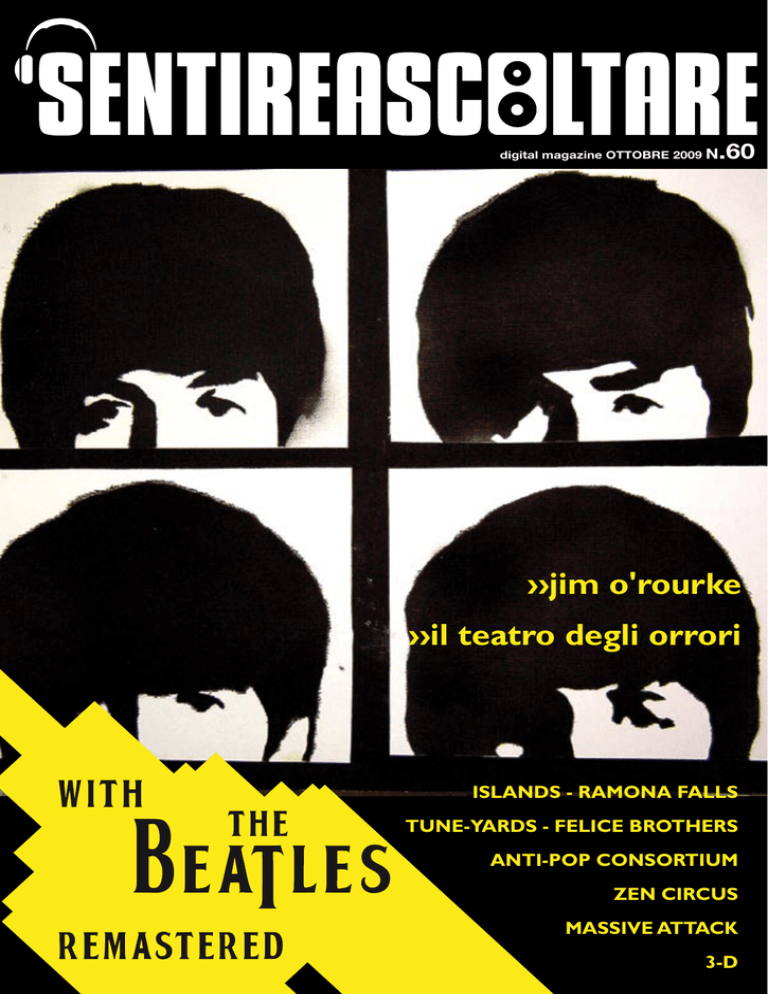
digital magazine ottobre 2009
N.60
››jim o'rourke
››il teatro degli orrori
ISLANDS - RAMONA FALLS
TUNE-YARDS - FELICE BROTHERS
ANTI-POP CONSORTIUM
ZEN CIRCUS
MASSIVE ATTACK
3-D
Sentireascoltare n.60
Turn On
p. 4
Islands
5
Ramona Falls
6
Tune-Yards
8
The Felice Brothers
Tune In
10 Anti-Pop Consortium
14
Zen Circus
Rubriche
130
Giant Steps
131
Classic Album
132
La sera della prima
150
I cosiddetti contemporanei
Drop Out
18
With the Beatles Remastered
34 Jim O'Rourke
40
Il Teatro degli Orrori
Recensioni
48
Gianluca Petrella, Helado Negro, Lightning Bolt, Luciano, Mountain Goats...
Rearview Mirror
126
Massive Attack, Tim Buckley, Harmonia...
Direttore: Edoardo Bridda
Ufficio Stampa: Teresa Greco
Staff: Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Daniele Follero, Stefano Solventi, Antonello Comunale, Teresa Greco
Hanno
collaborato:
Leonardo Amico, Gianni Avella, Giorgio Avezzù, Luca Barachetti, Salvatore Borrelli,
Sara Bracco, Marco Braggion, Luca Collepiccolo, Luca Colnaghi, Gabriele Marino, Francesca Marongiu,
Andrea Napoli, Massimo Padalino, Giulio Pasquali, Stefano Pifferi, Andrea Provinciali, Antonio Puglia, Aldo
Romanelli, Costanza Salvi, Vincenzo Santarcangelo, Giancarlo Turra, Fabrizio Zampighi.
Guida
spirituale:
Grafica
In
e
Adriano Trauber (1966-2004)
Impaginazione: Nicolas Campagnari
copertina:
The Beatles by feti
SentireAscoltare online music magazine
Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05
Editore: Edoardo Bridda
Direttore responsabile: Antonello Comunale
Provider NGI S.p.A.
Copyright © 2009 Edoardo Bridda. Tutti i diritti riservati.La riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo, è proibita senza
autorizzazione scritta di SentireAscoltare
Islands
Soluzioni impensate
In un balletto di alias e formazioni, ripercorriamo la storia dei canadesi Islands
e del loro indie pop intelligente. Con un
piccolissimo aiuto da parte di Eno
N
on accontentarsi mai. Questa la motivazione
che lo fa evolvere. Stiamo parlando di Nick
Thornburn alias Nick Diamonds, come si fa
chiamare da un po’, deus ex machina dei canadesi
Islands. Thornburn era nome da lui usato al tempo degli Unicorns, indie pop band from Montreal
attiva nei primi anni 2000, nome che lo ha accompagnato in altre formazioni più o meno parallele, quali
Th' Corn Gangg, Reefer e Human Highway.
L’altro nominativo da tenere a mente è quello
del batterista e “motore ritmico” Jamie Thompson (alias J'aime Tambour), con Diamonds sia negli
Unicorns, sia nei Th' Corn Gangg che negli Islands.
Se in questo balletto di alias e formazioni ci si è già
smarriti, la cosa non sembri poi così peregrina, visto
il grado di intrecci, nonché autoironia dei personaggi coinvolti.
Unicorns allora innanzitutto, quasi meteora da
due album, che hanno definito il suono già allora
(2003-2004) caratteristico del duo, un indie pop tendente al melodico. Spezie che ritroviamo più o meno
intatte negli Islands, che esordiscono nel 2006 con
Return To The Sea, disco composito e bilanciato
che tiene insieme indie, guitar, calipso, prog rock (!)
e chamber pop, con l’aiuto di alcuni Arcade Fire
e Wolf Parade, confermando l’ottimo momento
della scena di Montreal. Segue l’affermazione della
4
Turn On
band ma anche l’abbandono di Thompson.
Così il buon Diamonds ricompatta tutto intorno a sé allargando la formazione e realizzando, nel
2008, Arm’s Way, un semi-concept assai orchestrato, che si nutre di continue variazioni sul tema,
tra epicità Arcade, sinfonie, caraibicità e andamenti
dance. La classica quadratura del cerchio. Si arriva
dunque al terzo atto degli Islands con un colpo di
teatro: il ritorno quest’anno del buon Jamie Thompson e la conseguente virata decisa verso il ritmo
con l’ultimo Vapours (in recensioni). Album snello,
melodico e ritmico, di sapore Ottanta ma non solo.
L’alchimia tra Diamonds e Thompson si concretizza in un altrove che produce un valore aggiunto,
che Diamonds gestisce bene in termini di leadership, tirando le fila all’interno delle varie incarnazioni della band. Il modo in cui risolve le indecisioni nel
comporre e non solo, l’ha svelato di recente in una
intervista ripresa dal suo Twitter, nella quale racconta come sin dai tempi del primo disco abbia fatto
uso delle Oblique Strategies, le carte inventate
da Brian Eno e Peter Schmidt nel 1975, basate
su intuizioni e processi psicologici. Un mezzo per
confrontarsi con un responso e decidere di conseguenza considerando soluzioni impensate. In questo
c’è tutto di Diamonds.
Teresa Greco
Ramona Falls
L’arte della costruzione pop
Un pop d’artigianato che nasce da contraddizioni e
giustapposizioni, una miscela ben dosata di acustico
ed elettronico, stratificazioni ed eclettismo
C
osa fare se la lavorazione del fatidico terzo album della tua band si prolunga oltre il dovuto
(più o meno 3 anni) ? Questo deve essersi chiesto
Brent Knopf, l’uomo dietro alle programmazioni elettroniche e non solo dell’eclettico trio psych
pop-rock Menomena, da Portland. Ecco allora che
in parallelo compone in solitaria e con pochi mezzi il suo materiale, concependo il solo side project
Ramona Falls, fin dal nome un omaggio ai luoghi
natali nell’Oregon.
Tipo con le idee chiare Brent, che approfitta
dell’occasione per chiedere aiuto a molti amici della scena di Portland (tra cui Helio Sequence, la
band di Mirah, 31 Knots, Loch Lomond), realizzando, in un work in progress di cui tira man mano
le fila, l’esordio Intuit (recensito il mese scorso),
un album dallo spiccato sapore pop, che rispetto
alla band di provenienza presenta una certa regolarità ritmica e un più deciso senso della melodia.
Miscelando acustico ed elettronico (è lui nella band
l’inventore del Deeler, un programma che usa sequenze in loop durante la composizione), ballad e
sovrapposizioni, melodie stratificate e cambi non
esagerati di ritmiche - al contrario dell’indiavolato marasma dei Menomena - riesce a realizzare
un’opera omogenea e personale, quietamente più
introspettiva rispetto al lavoro trino con la band.
I nomi più immediatamente accostabili sono i
Mercury Rev psych rock, i Flaming Lips per
l’acidità e il senso giocoso del pop melodico, ma anche Beatles, R.E.M. e i più contemporanei Arcade Fire e TV On The Radio per i cambi ritmici. C’è anche l’amore autodichiarato (che si nota
in certi incastri) per il gruppo art post-punk inglese
di fine ‘70 The Homosexuals, autori di un coacervo articolato che a dire di Knopf, lo ha colpito
“per la produzione, per aver inserito molti elementi in
ogni canzone, ma senza farlo sembrare un virtuosismo,
solo una interessante esperienza d’ascolto”.
Ma c’è dell’altro dietro a un personaggio come
Knopf, che si rivela facendo caso ad alcuni particolari; un retaggio letterario - che si intuisce dalle
liriche introspettive e non banali - che fa del fantastico e delle figure d’artista dell’argentino Jorge
Luis Borges una delle sue ispirazioni; l’amore per
il Tao e il suo interrogarsi sulle contraddizioni, metodo usato nella composizione musicale. E ancora,
il rivelare come costruisce i pezzi, celando “piccole
easter eggs che si possono trovare solo ascoltando più
volte una canzone, per scoprire qualcosa di nuovo ogni
volta nella musica”. Un artigiano, un paziente cesellatore del suono. L’arte della costruzione pop è tutta
qua.
Teresa Greco
Turn On
5
Tune-yards
Suoni dal mondo dal pianeta casa
Pensate a MIA e al significato più intimo del pop globale d'oggi, in chiave lo-fi si chiama per forza TuneYards
6
Turn On
L
’indie da cameretta lo vedo sempre più un frullatore di spezie mainstream e indie. E nell’immaginarlo così penso a M.I.A.. Un nome lontano e vicino parlando di Merrill Garbus in arte Tune-Yards. E
il paragone la riguarda soprattutto ricordandoci che
la cameretta non significa soltanto un appartamentino crepato a Londra o a Portland, ma anche una
stanza a Dheli o una capannina di palme ai caraibi.
Siamo nei 2000 e siamo globali e se dici mainstream
pensi all’hip hop, alle slavatissime produzioni nu soul,
al sincopato e alle rime, basi che in contesti diversissimi come l’alt folk o il pop più narrativo, diventano
terreni fertilissimi se presi nell’originaria giocosità
e nella fatica del fare musica e dell'esprimersi fuori
dai cori. Poi, in pratica, dietro le sincopi c’è sempre
una drum machine. E pure dietro le tracce e i layer
c'è un suono è pur sempre riconducibile ad un hardware economico.
Pensate indie. Alle Cocorosie tra i vinili e la
mossetta sincopata, o al Casiotone For The
Painfully Alone nella cover della Streets Of Philadelphia springsteen-iana. Incroci di un sound big
con obiettivi, mezzi e strumenti necessariamente
(volutamente) ristretti. Soprattutto con fini e potabilità circoscritte. L’attitudine di Merrill, ragazzona
dall’aspetto rustico e sbilenco, prende linfa da queste parti. Registra in digitale e poi sporca in cassetta. Pure lei usa l’hop e il soul ma apparecchiandolo
nel salotto di una cameretta dopo aver messo nel
box il figlio esce una melodia piuttosto disallineata e difficilmente accordabile secondo i programmi
autotune.
Poi sulle pareti casalinghe c'è il classico patchwork
da studenti off. Un poster del Tirolo, una cartolina
dal Punjab, un quadro di una tribù keniota, e più giù,
sul tappeto, dischi di Woody Guthrie, Juana Molina,
Bob Marley, Odetta e dozzine di folk singer, cantanti
a cappella d'ogni latitudine, gruppi feedle. Quando
stai già pensando alla posa intellettuale della musicista che te la svolterà avant alla nova york, lei invece
ti parla punk al naturale proprio come le Slits o le
Raincoats, quindi, sincera e naif ti canta un folk
che chiamiamo folk soltanto perché lo strumento
prediletto è l’ukulele. E il chitarrino non è certo
roba mainstream attualmente, come neppure la dieta e l'occhiaia da monitor notturno. Merrill non ci
bada, mangia di tutto e dalla bocca gorgheggia speziato, corde legnose, ululati free che ti riempiono
di libertà. Non è la solita slaker, epperò così vicina
all’istinto sembra un tutt’uno con le proprie fascinazioni e dunque la musica Tune-Yards, nome d’arte
programmatico, ti racconta la storia di una fuga e un
ritorno. Musica infantile nel senso di dialogo però.
L’esordio BiRd-BrAiNs si costruisce attorno
a una catarsi terzomondista perennemente intinta
di troniche povere che la direbbero folktronica se
usare questa parola non portasse sfiga. Poi, infine, ci
sono le schegge impazzite; colpi di genio straccione
e straziato che le escono dal cervello. Belli come
il sole. Altri mondi mainstream masticati e ributtati
nella pappa: una Björk, un Thom Yorke, persino
lo Sting isterico dei primi Police. Tutto sale che
glielo senti nelle labbra tra un ruttino del bambino e un setting di freeware. La sacra promessa del
from me to you del lo-fi difficilmente si realizza. Per
quest’esordio, su una 4AD a caccia di talenti in chiaro, ecco che ci viene servito: canzoni variegate, registrate in due anni di session e di cui questa versione
non è che la ristampa a un anno di distanza, anzi, il
corso ufficiale dopo l’autoproduzione.
Canzoni da riciclaggio creativo perché il progetto tUnE-YaRdS - che solo qui ci prendiamo l’amore
di scriverlo così come lei lo vorrebbe – considera
warholamente il furto come nobile arte. Canzoni
simpaticamente mutanti come piacerebbero a un
fan di Futurama, dacché dentro ci trovi anche un
albero genealogico di passione che parte dai genitori musici. Infine la fortuna, gioca anche lei nelle
sorti di Merrill: della personale ossessione per la
Christmas Music non vi è traccia nell’album. Ci troviamo, invece, le tracce dei suoi amori per i Pupi e il
teatro (in cui si è laureata by the way), che l'hanno
ispirata verso un folk-pop d’interpretazione e non
d’immedesimazione. Soprattutto, BiRd-BrAiNs è
due anni e mezzo di talento coltivato ed espresso
con lei e con noi (e il figlio …sempre che sia il suo
quello che sentiamo nel disco) e tanti saluti anche a
Thao Nguyen, ragazza simpatica e compagna di
tour americano (nuovo album all’attivo anche per
lei, tra l'altro). Per chi fosse interessato al vinile di
questo bell'esordio contatti la Marriage Records,
guarda caso Portland, Oregon.
Edoardo Bridda
Turn On
7
The Felice Brothers
Di radici e di ali
Non tutti riescono a farsi schiacciare dal passato e
incidere sull'attualità. I tre fratelli Felice, ad esempio.
8
Turn On
I
nutile far finta di non saperlo: i gruppi attuali hanno una gran fortuna che tuttavia in pochi sanno
sfruttare. Possono avere a disposizione il senno di
poi sonoro di cinque decenni d’evoluzione della
“cosa rock” e dei suoi derivati, il privilegio di scartabellare tra testi sacri e note a pie’ di pagina in cerca di un linguaggio il più possibile “originale”. Non
appartengono però a tutti la capacità critica e l’attitudine sincretica necessarie; né l’attenzione rivolta
verso le Canzoni in un epoca in cui la maggioranza
bada alla peculiarità del suono. Non basta mettere
in relazione tra loro segmenti di stile differenti: li si
deve legare con un collante, altrimenti ci si blocca
a metà del guado. Perché, potenzialmente, non vi è
limite alcuno a ciò che si può cavare dal cilindro per
sottrarre il rock al ruolo di vuota pantomima in cui
è caduto. Capito come si fa, Arciduchi Ferdinandi e
Babbuini Polari? Come gli LCD Soundsystem,
come gli Art Brut, come i Felice Brothers.
Che si stanno vieppiù imponendo - con la serenità del saggio provinciale - come uno dei più
scintillanti aggiornamenti di The Band. Della stessa
indagine nel cuore rurale dell’America ottimista e
lavoratrice che non è probabilmente mai esistita se
non nei sogni di D.H. Thoreau e Walt Whitman. I
quali avrebbero gradito un soggiorno nella piccola
Palenville dove tutto è iniziato, piccolo borgo sulle Catskill Mountains a venti minuti da Woodstock
e dunque da quel Big Pink che sappiamo. La storia,
bella e molto americana, vede tre fratelli - Simone
(batterista, scrittore di racconti), Ian (chitarra, voce)
e James (fisarmonica, tastiere) - trascorrere le domeniche a suonare, diventare grandi e tirar dentro
il compagno di dadi e bassista Christmas Clapton; trasferirsi in seguito a New York e suonare dovunque, dai locali alla metropolitana.
Finché nel novembre del 2006 esordiscono con
verve tutta da sbozzare e l’autoprodotto Through
These Reigns And Gone (6,8/10). Più a fuoco
l’opera seconda di una stagione più vecchia e baciata
da superiore maturità, Tonight At The Arizona
(Loose, 2007; 7,2/10), foriera sul resto della narrativa The Ballad Of Lou The Welterweight e della polvere
dylaniana raccolta in Rockefeller Druglaw Blues. Sono
i miti sempiterni che da sempre indaga Greil Marcus a essere investiti di nuova luce, quella Storia
che si fa leggenda e l'opposto alla radice del Nuovo
Mondo e dei suoi destini. Nei quali viene voglia di
credere, apprendendo che - una volta che la ruota
ha preso a girare - i Nostri si trovano a condividere palchi (pare che dal vivo siano immensi) con
Bright Eyes e a prendere parte a uno dei concerti della serie Midnight Ramble organizzata da Levon
Helm. Poi uno non deve credere al fato…
Palato fino, Conor Oberst decide di metterli
sotto contratto per la Team Love Records, impegno
onorato nei primi mesi del 2008 dal passo avanti di
un album omonimo (Team Love, 2008; 7,3/10)
assai gradito da queste parti, solido come una quercia e vigoroso da schiantare qualsiasi cartolina in
circolazione. La strada che ha condotto alla primavera scorsa e a un opera splendida come Yonder
Is The Clock è costellata da concerti su concerti,
particolarmente memorabile quello del celeberrimo Newport Folk Festival (dove Zimmie si mise
contro i puristi e chi non poteva capire) nel quale
nemmeno una tempesta e la mancanza di elettricità hanno potuto fermare la band. Semplice la spiegazione: è l’onestà ferma di chi ha sudato di fatica
per arrivare lì partendo dal basso (di nuovo The
Band…); di chi sembra incarnare a beneficio della
contemporaneità un’era che reputavamo consegnata ai musei, al rimpianto, alla seppiata nostalgia.
Così non è, perché con il “vero” terzo LP i Brothers impongono la cifra autoriale nella quale avevamo sperato, ma che per timore e scaramanzia
preferivamo rimandare a un futuro molto prossimo.
Sono invece splendido “qui e ora” l’uscire a testa
alta dal passato (il traditional Memphis Flu, la festa
sull’aia Penn Station); la tradizione restituita a nuova
vita sulla scorta dei Maestri (All When We Were Young
rivaleggia amichevolmente con I Shall Be Released); i
frammenti di ieri che compongono la linfa vitale di
oggi (Chicken Wire un Bob Dylan mai esistito tra
Blonde On Blonde e The Basement Tapes,
The Big Surprise e Boy From Lawrence County ponti
stesi tra Blood On The Tracks e Time Out Of
Mind). Quando poi si mostra la capacità di usare
lo studio di registrazione e strapazzare il cajun, si
ricorda a Leonard Cohen come si scrivono brani immensi e si conosce la lezione vocale di Steve
Earle e Micah P. Hinson, lo stupore si fa meraviglia e infine certezza. La certezza di avere tra
di noi gente destinata a lasciare il segno danzando
come indomita e coraggiosa tra le epoche, sotto un
lucido cielo stellato.
Giancarlo Turra
Turn On
9
Anti-Pop
Consortium
Fluorescent Back è un ritorno a buoni livelli per il combo che ha minato le basi
dell'hip-hop. Niente di meglio per ripercorrerne le gesta
- Marco Braggion
90 s : G ioventù
pre - millennium
Sì, anche loro vengono dalla pre-millennium tension. Loro chi? Beans, Sayyid e High Priest (più il
produttore Earl Blaize): più comunemente detti
Antipop Consortium. Un nome, un programma.
La leggenda dice che si siano incontrati nel 1997 in
un poetry slam a New York. Il nome della crew primigenia è Brooklyn Boom Poetic Collective. Quella
sera al Nuyorican Theatre lo spettacolo guidato dal
santone Bob Hollman si chiama 'Rap Meets Poetry'. Praticamente una palestra per nerd della parola,
come i tre MC dimostrano di essere. Il trio sta lì a
10
TUNE IN
parlare di filosofia, a buttare giù testi e rime contro
il sistema e a pensare una nuova strada per l'hip-hop:
un percorso che svicoli dal gangsta, che abbia delle
idee più interessanti del solito 'yo yo' e che scateni en passant - una rivoluzione. Il pre-consorzio all'inizio è solo un affare di cassettine, stampate per la label autoprodotta Anti Pop
Recordings. Dopo aver fatto circolare nei giri giusti i
corpi del reato, i quattro si nominano definitivamente Antipop Consortium e nell'anno di grazia 1999
qualcuno con le orecchie a punta li sente. L'alieno
è DJ Vadim che produce insieme a Prime Cuts
l'esordio del trio: The Isolationist (sulla sua mitica label di battaglia Jazz Fudge). Siamo nell'anno a
specchio, l'anno di attesa, il millennium bug che incombe e quella tensione non risolta professata dal
santone Tricky, quel millenarismo che sfocierà in
un nulla di fatto, in una delusione che precede questi
'cazzo di anni 00'. La dissoluzione del manicheismo post-muro-diBerlino se la portano avanti anche i tre. Si abituano
presto al suono UK e si fanno di suoni Ninja Tune. Il
loro produttore e mentore è infatti uno degli alfieri
di quell'abstract-hop che farà la fortuna della label
col ninja volante che lancia vinili come stellette. Un
po' eclissati dalla presenza del maestro (che 3 anni
prima aveva pubblicato quella bomba/manifesto 'althop' che è USSR Repertoire), un po' imbarazzati
dal debutto, i tre b-boyz americani ci regalano un
disco di rap ben fatto, uno standard di suoni inglesissimi tagliati con l'accetta dal capoccia Vadim: quei
vibrafoni in loop sovrapposti alle voci di Hydrogen
Slush, lo slow motion tempo caro a Funky Porcini di Sensory Deprivation e la parlata spastica e
compulsiva che è il loro marchio di fabbrica, le atmosfere cupe ereditate dal primo Dr. Dre ma concentrate a bomba sul testo. Se hip-hop vuol dire strada, nel passaggio da
New York a Londra si lascia la sporcizia e si zooma
dall'alto sul panorama street. L'estetica del poetry
slam viene ripulita e l'incontro con il DJ/produttore
incomincia a mettere i paletti all'estetica del combo.
Il suono appartiene a Vadim, ma i testi sono nelle menti dei ragazzi che ci raccontano di mondi à
la Ballard (Mechanic Robotic), di sogni disturbati da
voci sintetiche computerizzate (che in altri ambienti avevano creato il continuum 'ardkore, esperienza
e non-movimento sempre e comunque UK, con le
voci in elio strafatte), declamazioni che hanno nel
sangue le esperienze di Allen Ginsberg (la meditazione di Timeless Void) o effetti speciali che vengono
direttamente dal turntable (Masters of the Scratch).
Per iniziare, quindi, un disco old school. Un buon
biglietto da visita che non esplode ma che si regge
solido in piedi. 00 s : P iccoli
rappers crescono
Il passaparola è velocissimo e il nome del trio
inizia a sentirsi nei circoli, nelle stanze della critica
più attenta, nelle redazioni e nei club più 'avant'. La
tensione si scioglie nel 2000 con l'esordio Tragic
Epilogue sulla 75 Ark del mago dello scratch Dan
The Automator. E qui si inizia a spaccare. Te-
sti e suoni, tutta l'anima spremuta in due direzioni
convergenti: un magma che si mixa a perfezione. La
cupezza della visione narrata dalle voci (il sogno in
acido di 9.99: Like Manson, like Manson / Something's
fucked up here, it's just not right) è duplicata e assistita dalle basi sullo stesso piano delle lyrics. Da qui il
parallelo con la Anticon, l'altra sponda che iniziava
a staccare mattoni su mattoni dal wall dell'hop (Gun
talk run New York / Down here we run lyrics). C'è ancora un po' di influenza di old school Ninja, ma sono le
sperimentazioni, le linee melodiche quasi a cappella
dei tre che si sovrappongono e stravolgono la classica forma canzone. Song che viene innestata con
elementi elettronici, hip-hop mutante per eccellenza, che non lo puoi quasi più chiamare hip-hop se
non fosse per la cadenza ereditata dalle gare di poesia newyorkesi (vedi la meditazione in What Am I:
Necks twist turn off selective words / Play double effects
you triple tapes flex and nerves / Revenge of the nerds /
Seen in blurs / Only the sound of words splurred / Now
you remember when men get dis-mem-bered). I ragazzi
si staccano dalla sottile linea dorata dei medaglioni
e delle dentiere gangsta e fanno propria la lezione
del Wu Tang Clan: gente che ha da sempre segnato un solco, l'ortodossia più puntigliosa che mai
per quanto riguarda le tattiche indie usate nella produzione/marketing delle loro uscite. Ma il consorzio
non è un affare di label. I tre sono - già dall'inizio
- un'intersezione postmoderna, una cosa che va e
viene, un continuo rimando a esperienze altre. Le collaborazioni si moltiplicano e la crew si
vede face to face con il joker dell'hop: Mike Ladd
li invita a far parte del progetto alieno The Infesticons su Big Dada. Su Gun Hill Road Beans e
Priest si mettono sullo stesso piano del gotha del
rap alieno internazionale. La loro Quarterback Theme è l'incontro con l'elettronica sperimentale che li
porterà all'evoluzione deviante. Pieni di entusiasmo
raccolgono le forze e sempre nello stesso anno
(è già il 2001) escono pure con Shopping Carts
Crashing (autoproduzione su Antipop Recordings):
un disco che inizia a contaminare strumenti ereditati dalla musica classica con lyrics taglienti, il misto
che non c'è ancora ma di cui inconsapevolmente il
pubblico hop ha bisogno. Anticipa le atmosfere gloomy del grime, The Hand Behind The Piano Of Time
Is God innesta vocals dalla lirica con il pendulum di
DJ Krush, New York è puro field street sound con
laser in acido, Systaltic Quiescenceè glitch ambient
in slow motion per i Massive Attack. Nello stesso
anno aprono le date dei tour dei Radiohead e
TUNE IN
11
fanno pure un giro per il mondo con DJ Shadow.
Il live con i due pesi massimi è il preludio al botto.
Nel 2002 la Warp li chiama e nasce uno dei dischi
culto dell'alt-hop di sempre.
C apolavori ,
seeding e
dissoluzioni
Se con i lavori precedenti avevano buttato idee
e spunti, con Arrhythmia raggiungono la maturità.
Quel disco è fresco e già classico. A riascoltarlo non
risente del passare del tempo: le voci si amalgamano alla perfezione, i ritmi non cadono nella banale
ripetizione dell'hop, gli strumenti sono insoliti e non
convenzionali. Tanto per dire i ragazzi creano una
track con una pallina da ping pong (Ping Pong), con
dei suoni a 8 bit à la Sega Megadrive (Mega), con
inserti da club (Ekg, Ghost Lawns), vocoder robotici
(Tron Man Speaks), archi orchestrali (Conspiracy Of
12
TUNE IN
Truth) e altre diavolerie pseudosintetiche. La parola
d'ordine non è tanto sorprendere, come sembrerebbe dall'organico straniante, bensì esplorare e
nello stesso tempo coniare un nuovo linguaggio (I
only spit pure hot, it's the brolic / so what if it's popular /
I got to infect you in order to affect you / and I don't expect you go get it at first... devo infettarti per fare effetto
su di te / e non mi aspetto che tu capisca subito) che
da lì in poi sarà di base per qualsiasi discorso altro
sul beat, magari anche politico (Please Mr. politician
don't feed us your empty promises / it's obvious you're
oblivious but not impervious / and you still will crumble,
stay humble still number one). Arrythmia inaugura
una strada che anticipa El-P, Subtle, Doom, il
miscuglio dell'hip-hop con il rock e l'elettronica di
centinaia di futuri emuli. Il successo li porta ancora
una volta ad interrogarsi sulla funzione della proposta, sull'essenza di quello che stanno traducendo in suono. I tre moschettieri
hanno in testa troppi mondi,
troppe coordinate. Il loro è
l'eterno dilemma estetico del
postmoderno (Celebrate every day as new year's / Is lookin'
in the mirror to watch my balls
drop) che non riesce a descrivere e che seziona all'infinito.
L'ossimoro mai risolto della
frammentazione e del relativismo (Schemes are not always
what they seem / In the maze
these days there's many demons
/ To get you soul by any means)
che attanaglia negli stessi anni
anche i Radiohead. In questo
capolavoro si riesce per un
istante - lungo poco più di 40
minuti - a riprendere la tradizione e a distruggerla da dentro. I semi che lanciano i Nostri
si nutrono di una terra ricca e
feconda; ma il successo spiazza
il combo e le piante generate
hanno una fioritura troppo veloce. L'effimero che scompare
nel mare magnum della rete,
nel brainstorming dei dischi
autoprodotti e del sampling
selvaggio. I tre provano allora
a giocare la carta della sperimentazione jazzy con l'aiuto di
uno dei maghi del crossover: Matthew Shipp.
Per la sua Blue Series si inventano uno split che
va ad intaccare anche il mondo impolverato della
noblesse black. Antipop Vs. Matthew Shipp è
il lascito prima della dissoluzione. Nei suoi solchi
digitali c'è la coda lunga della tradizione nera che si
affianca alle armonie del pianoforte del maestro e
lo brucia come aveva già proposto Jerry Lee Lewis
qualche decennio prima. Là era il rock, qui è l'hiphop sbilenco che tracima e che si sgretola in infiniti
rimandi. Lo split con il guru del free è il canto del cigno prima del divorzio: A Knot In Your Bop è l'intaglio
della ballad mid-tempo, Monstro City è grime ante
litteram che si fa di pianoforte in echi dub, Free Hop
la proposta che mescola la blackness più violenta
del free con il math-noise che già aleggiava nelle
menti dei Battles, Places I've Never Beenla cassa in
quattro con gli innesti electro analogici cosmici. Un
disco che promette e che mantiene. Uber nu-jazz
squadrato hop. Da qui si decide all'improvviso di
separarsi per la classica 'pausa di riflessione': nessun rimpianto, nessun piatto che vola. La notizia del
divorzio in casa Antipop spiazza i fan. Ma oggi (che
i quattro son di nuovo sul palco insieme) si capisce che non era poi così strano proporre proprio
all'apice della carriera un nuovo cambio di rotta.
Come sempre, il consorzio sa quello che fa. La scelta è il test per la convivenza in solitaria delle menti.
La partenza verso strade personali è presto fatta:
Beans se ne sta su Warp, gli altri due approdano con
Airborn Audio su Ninja; come a dire il gotha del
breaking, sia esso più electro, sia esso più votato al
turntablizm. Beans lo vedi che è l'uomo immagine.
Da subito i suoi lavori sono uno sfoggio di tecnica e
stile, le copertine sciccose e la furbizia nel riciclarsi
one man show ci propongono un personaggio che
sa cosa vuol dire produzione. Sia in senso strettamente musicale che di marketing. Lui è sempre lì
in copertina, con quel faccione black perfetto, quel
fascino classico da divo. I suoi quattro dischi in solitaria (Tomorrow Right Now, Now Soon Someday, Shock City Maverick e Thorns) non
approfondiscono le premesse consolidate insieme
agli altri due soci, la sua è una mossa di discesa nella
piazza pop, il farsi bello per le classifiche e per il palco. Fakeness dentro le vene ma con stile. La presa
di posizione di chi ha bazzicato i sobborghi della
sperimentazione e si vuole riscattare ma che in fondo non riesce a trovare la via sulla passerella con il
tappeto rosso. Lui ci ha provato, ma ha bisogno degli
altri. Trasferiti temporaneamente su Ninja, Sayyid e
Priest si mettono a smanettare sul giradischi. Tra il
2003 e il 2005 sfornano anodini mix underground
e qualche EP. L'album che li riporta agli onori della
cronaca (ma non della critica) è Good Fortune.
Una cosa cupa, lenta e doom nell'anima che tenta di
sperimentare con l'elettronica ma si insabbia nelle
paludi dell'ostinato hop. Un disco ordinario, senza
infamia e senza lode che è fatto di trucchetti per i
novizi, ma che non mostra cuore. Il sangue è stato
prosciugato e c'è bisogno di una flebo di vita, di un
ritorno ai fasti precedenti. Il ritorno al consorzio/
casa madre è dietro l'angolo.
N ow
Nel 2007 la voce di una imminente reunion diventa realtà. I quattro (ormai con Blaize novello
d'Artagnan con contratto a tempo indeterminato)
supportano il tour dei Public Enemy. E con il
live ritorna la magia. Abbiamo avuto bisogno di tempo per crescere e maturare come artisti singolarmente.
Ora che abbiamo valutato i nostri punti di forza e di
debolezza, siamo pronti a ritornare più in forma che
mai. La chimica che abbiamo tutti insieme sul palco
rende eccezionale la nostra nuova musica; è tempo di
ritornare sulle scene.Questa la dichiarazione congiunta dei quattro oggi. Come già osservato (vedi
la recensione di Fluorescent Back sul numero
di Settembre) il coming back abbassa il tiro 'alt' e
guarda al pop. Lo shift su Big Dada e la lungimiranza
di un pezzo grosso del calibro di Roots Manuva
sono il contorno giusto per il gran spolvero. Tutto
misurato, il nuovo successo annunciato da tempo
è solo una manovra commerciale? Per i più scafati
è probabilmente la prima cosa che viene in mente,
ma per chi scrive non è (per fortuna) l'unica chiave
interpretativa. La storia è infatti nelle vene e i quattro uomini
sanno come interpretare il famigerato 'quanto basta' del loro cookbook. C'è quindi la giusta dose
di techno (NY To Tokyo, C Thru U), di electroragga
spocchioso à la Gorillaz (Born Electric) e ovviamente di hip-hop trasversale (Shine, Reflections) con
le proposte sperimentali sul potere alla parola (End
Game, Superunfrontable) che sono ormai marchio di
fabbrica storicizzato. Più che di barocchismo viene
da pensare ad una maturità stabile che si muove. Insomma, se oggi non si può più definire alcunché, né
parlare di correnti (soprattutto per il non genere
che è oggi l'hip-hop), il consorzio le attraversa con
delle surfate decise e senza sbavature. Quello che in
una parola possiamo definire classico.
TUNE IN
13
Zen Circus
Andate tutti affanculo
Irriverenti e senza mezze misure, sboccati ma lucidi, proletari ed essenziali: il punk-rock
d'autore degli Zen Circus
- Fabrizio Zampighi
14
TUNE IN
“P
agliacci ubriachi del proletariato del Duemila”. Cinismo e disillusione tipiche del
clown fuori scena che si mescolano a
una visione della musica proletaria - quanto può
essere proletario il punk virato folk –, acuta e nel
medesimo istante immediata. Perché essere innovatori partendo da presupposti stilistici riconoscibili
e mantenere il tutto nei confini di una musica che
crea identità all'istante – in una parola, “popolare” è ben più complesso che ricercare crossover inediti
per farsi passare da sperimentatori. E allora punk
sia, ma alla maniera della band pisana: “Il punk è un
approccio alla musica senza pregiudizi. Una possibilità
in più di sbagliare per aggiustare il tiro. La buona fede
dell'errore. Una sana risata fatta fra persone che sanno
bene che non sarà per sempre, ma sarà comunque fantastico finché durerà. Punk non è no future. Punk vuol
dire budget-rock, costanza, artigianato di classe e creatività allo stato puro. è sempre stato così, finché i Sex
Pistols prima ed i Nirvana poi hanno portato via tutta
la poesia”. Coscienza di classe applicata alla musica,
almeno a giudicare da una storia discografica lunga
un decennio vissuta come un percorso accidentato,
tortuoso, ricco di esperienze ma anche di cambiamenti. In grado di partire dalla base per arrivare a
una maturazione graduale ma inevitabile.
è il 1999 quando esce l'esordio del gruppo pisano. About Thieves, Farmers, Tramps And
Policemen (Ice For Everyone, 1999) dichiara una
parentela stretta con formazioni d'oltreoceano speculari (Violent Femmes) e cede a un'estetica
essenziale che mescola punk, folk e attitudini da
busker. Oltre a un nomadismo musicale fuori dagli steccati di genere capace di mescolare batterie
spazzolate, strumentazione acustica, rockabilly, infatuazioni tex-mex, su testi in inglese, spagnolo e francese. C'è personalità in questa Babele in note e già si
coglie quell'approccio da “cittadini del mondo” che
caratterizzerà tutta la parabola artistica degli Zen
Circus. Come sottolinea anche Appino: “Come tutti
i ragazzini che si innamorano del rock volevo scappare
dalla provincia, dall'“italietta”. Volevo andare in Europa,
mescolarmi a quello che ritenevo fosse mio di diritto: il
mondo. Quindi mi sono informato, ho imparato, sono
andato a vivere in Olanda, ho viaggiato tanto. In treno e
a scuola leggevo libri in inglese. Guardavo i film in lingua
originale. Parlavo con i miei colleghi stranieri nelle loro
rispettive lingue. Facevo l'amore in altre lingue. Sognavo
in altre lingue.” Di contro la fedeltà ai modelli di riferimento è fin troppo evidente e se da un lato non
impedisce di godersi un disco comunque riuscito,
dall'altro fa storcere il naso a chi cerca maggiore
personalità in un opera prima. Nel 2002 Visited By
The Ghost Of Blind Willie “Lemon Juice”
Namington IV (Ice For Everyone, 2002) ribadisce
la statura artistica del gruppo, partendo dalle buone
premesse del primo disco e cercando nel contempo di svilupparle. Questa volta ci sono le chitarre
elettriche a punteggiare gli scambi, c'è una preminenza di strutture punk-rock'n'roll, c'è il tentavo di
acquistare credito e libertà d'azione allargando lo
spettro delle influenze. In un disco che suona meno
omogeneo rispetto al predecessore, sospeso com'è
tra blues ubriachi à la Gun Club e beat accelerato
Talking Heads, country slabbrati e ralenti narcotici, e che fa pensare a un momento di transizione
in vista di un cambio di registro imminente. E infatti
il successivo Doctor Seduction (La Parc Music/
Linfa, 2004) mette in pratica ciò che fino ad allora si
era solo paventato: la svolta indie-pop. I referenti in
questo caso sono i Pixies – almeno in apparenza –
ma a cambiare è soprattutto la concezione generale
della musica. Le ritmiche rallentano, ci si concentra
sulla scrittura lasciando perdere l'irruenza scapestrata degli esordi, cresce l'importanza dei fraseggi
e dei contributi strumentali. In Sweet Me compaiono anche gli archi, mentre il mood generale vira
verso toni pacati e un'orecchiabilità immediata. è il
disco della maturità. O comunque della svolta stilistica. Molto di quello che si ascolta in queste dieci
stazioni finirà anche nei titoli successivi diventando
parte integrante del suono della formazione. Anche
in quel Vita e opinioni di Nello Scarpellini, gentiluomo (I dischi de l'amico immaginario,
2005) che esce un anno dopo e da cui emerge più
che altrove la fusione tra gli Zen Circus del primo
periodo e quelli di Doctor Seduction: un'entità in
bilico tra punk e pop, garage e folk. Anche se l'impressione è che non tutto giri a dovere, a cominciare da quei primi esperimenti con l'idioma nazionale
troppo sbracati (Apriro' un Bar), poco significativi
(L'amico immaginario), o legati a una psichedelia al
Valium di facciata (Fino a spaccarti sue o tre denti).
Tutto fa sospettare che per il momento l'italiano
sia solo una delle tante possibilità del gruppo (oltre
all'inglese e al francese di Les Poches sont vides les
gens) e non una scelta consapevole foriera di nuovi
traguardi artistici.
Bisogna aspettare tre anni perché il lavoro sui
testi dia i frutti sperati. Talmente succosi da convincere i musicisti a puntare proprio su uno dei tre
brani in lingua madre del programma, per lanciare
TUNE IN
15
Villa Inferno (Unhip, 2008). Il pezzo si chiama Figlio di puttana e nella sua irriverenza rappresenta il
nuovo corso di una band che punta evidentemente
a un suono in bilico tra punk-rock e canzone d'autore, dileggio e ironia. Una sintesi mediata dall'ottimo lavoro di un Brian Ritchie (Violent Femmes) temporaneamente quarto Zen Circus nonché
produttore artistico: “Avere avuto a che fare in studio
e dal vivo con le persone che ci hanno influenzato o
che stimiamo musicalmente ci rende elettrici, orgogliosi
e felici. Collaborare è diventato anche necessario per
alimentare il rapporto fra noi tre. è un po' come far ingelosire la moglie o il marito dopo anni di matrimonio: si
ravviva il rapporto. Inoltre se prima eravamo convinti di
esserci dati alla musica che facevamo al 100%, ci siamo
poi resi conto che non era vero. Potevamo fare di più,
molto di più. E sono felicissimo di suonare in uno di quei
16
TUNE IN
pochissimi gruppi che, al contrario di quanto avviene con
il modello inglese, migliorano disco dopo disco”. Sono
della partita anche Giorgio Canali, Kim e Kelly
Deal, Jerry Harrison, per un'opera matura sospesa tra il synth-pop di Punk Lullaby e il post-punk
di Wild Wild Life (cover dei Talking Heads), il buskerrock di Vana gloria e il punk à la Clash di Beat The
Drum, il folk-rock di He Was Robert Zimmerman e la
canzone d'autore sdrucita di Vent'anni.
E arriviamo al 2009. Con un titolo come Andate tutti affanculo (Unhip, 2009) - in spazio
recensioni - non rimangono molti dubbi sul contenuto dell'ultima fatica del gruppo: “Volevamo scrivere
un disco di protesta alla nostra maniera che fosse anche popolare. Tutto è nato dall'urgenza di confezionare
una raccolta di brani che potesse essere intesa come
una serie di piccole istantanee del nostro Paese visto da
anni di furgone”. Un'opera che istituzionalizza l'avvicinamento a certa canzone d'autore anni settanta
ruvida e graffiante - pur in chiave punk-folk - e al
tempo stesso fortifica il valore del testo in italiano
esaltandone la forza critica, le potenzialità semantiche ma anche la musicalità. Coerentemente con lo
stile del gruppo, al solito irriverente, senza mezze
misure e deciso a non rinunciare a prese di posizione nette nei confronti di un modello sociale per
lo meno discutibile. E allora Gente di Merda (“e tutti
importanti / e tutti son qualcuno / un miliardo di artisti
e in fabbrica nessuno / pensieri prepotenti / morali latitanti / è il genere di bestia che la odian tutti quanti”)
e Vecchi senza esperienza (“Sembra che oramai vada
di moda quello che / prendevo solo a schiaffi a farlo
nel '93 / i pantaloni stretti eran da froci e non da fighi
/ le Converse da pezzenti / computer da perdenti”), la
fine delle illusioni giovanili di Amico mio (“un mutuo
su una casa in periferia / una bambina nata tre anni fa
/ sua moglie si è scopata mezza città / mentre lui va
a calcetto con la sua Smart”) e il quadretto familiare
allucinante di Canzone di Natale (“Sei un uomo ormai
/ ma come sei sciupato / non sei neanche pettinato /
penso sfido io / da quanto mi son fatto / ho venduto
pure / il mio motorino nuovo”), la nuova gioventù trendy di Andate tutti affanculo (“a chi è andato a vivere a
Londra / a Berlino, a Parigi, Milano o Bologna / male e
paure non han fissa dimora / le vostre svolte son sogni
di gloria”) e la religione di We Just wanna live (“Vivere
male, vivere tutti / per nostro Signore dei compromessi /
nel Vangelo di Giuda è scritto così / che tu sia maledetto,
tu che regnerai”).
Si parla di maturità raggiunta, di incontro con la
tradizione musicale più nobile del Belpaese, di personalità ed esperienza acquisite per superare lo scoglio del primo disco scritto completamente in italiano. Una tappa che, a sentire i Nostri, ricopre meno
importanza di quel che potrebbe sembrare a prima
vista: “Ci sono gruppi che comunicano e altri gruppi che
non comunicano niente a prescindere dalla lingua che
usano per mettere parole sopra la loro musica. Ho molti
amici di valore che partono per queste crociate proitaliano che fondamentalmente servono solo a difendere
un tipo di lazyness (pigrizia) tipicamente italiota”. Discorso ragionevole e dalle implicazioni sociologiche
condivisibili, ma che può essere affrontato anche da
altri punti di vista. Osservando, ad esempio, come
strutture linguistiche profondamente diverse dall'inglese necessitino oggettivamente di un adattamento supplementare della musica, perché si arrivi non
ad una semplice traduzione bensì a un'interpreta-
zione di nuovi significati e forme. Del resto ci sarà
un motivo se il Teatro degli Orrori stupisce con un
Dell'impero delle tenebre praticamente perfetto e cantato in italiano (diversamente da quanto avveniva in passato con One Dimensional Man);
se gli stessi Zen Circus trovano identità, una larga
diffusione e un plauso di critica soprattutto con gli
ultimi due dischi; se una Beatrice Antolini intervistata qualche tempo fa rivelava: “Nutro un forte rispetto
verso chi scrive bene brani in italiano, proprio perché ho
delle difficoltà in questo senso. Per me le parole sono
più assonanze, suoni o magari veri e propri strumenti”.
E il motivo è che se da un lato la comunanza di
idioma tra pubblico e artista favorisce certo una ricettività maggiore, dall'altro il mettersi in discussione dovendo adattarsi al nuovo modello linguistico
porta spesso a generare soluzioni musicali originali
e meno in linea con l'ortodossia di genere.
Al di là delle riflessioni estemporanee da critico
bacchettone, resta comunque un'opera capace di
confermare le aspettative di chi vedeva già gli Zen
Circus come un piccolo tesoro nazionale – tra i tanti, anche gli Afterhours della compilation Il paese è
reale - o di sorprendere chi nel gruppo non aveva
riposto grosse speranze. In attesa di un futuro dalle mire ragionevoli ma già ricco di soddisfazioni: “
Qual'è il destino di una band come la nostra in un Paese
come l'Italia? Ah, diccelo tu! Paradossalmente, dopo 10
anni di delirio ed in piena crisi economica e del disco,
stiamo vivendo da due anni a questa parte i momenti
più belli della nostra carriera (in piccolo sicuramente).
Siamo arrivati dove volevamo, ovvero a pagarci l'affitto
e il cibo con i concerti. Per il resto vedremo. Ogni giorno
che passiamo così è un giorno perfetto. Speriamo solo
che duri il più possibile, in modo da poter avere sempre
uno sguardo lucido, obliquo ed adeguatamente rabbioso
nei confronti delle sanguisughe e dei narcolessici che
ammorbano questo meraviglioso paese e la sua gente”.
TUNE IN
17
18
DROP OUT
- Edoardo Bridda,Teresa Greco, Stefano, Solventi,
Gaspare Caliri, Stefano Pifferi, Antonello Comunale
L
o scorso 9 settembre 2009, complice il solito diabolico gioco di numeri che da sempre accompagna la cabala beatlesiana, la EMI
ha licenziato il catalogo dei Fab Four in una
nuova e già collaudatissima versione, il remaster. La
gran parte di voi magari s’accontenterà dei compact
disc acquistati nel lontano 1987, ma quegli stessi album, comprensivi dei Past Masters (contenenti tutti
gli editi inediti agli album ufficiali), sono nuovamente
disponibili in formati si spera definitivi. A dir il vero,
ci potrebbe stare una versione blue ray tra un lustro o due, eppure quel che abbiamo sugli scaffali
dei negozi di dischi (o meglio dei supermercati) è
un doppio formato: Stereo e Boxset, quest'ultimo
anche nella versione The Beatles In Mono, per sentirli come allora. Inoltre, per chi non fosse già soddisfatto del librone uscito qualche Natale fa, i booklet
sono stati tutti addizionati di foto anche inedite e,
librettini a parte, come già ampiamente sbandierato, la pulizia del suono, per opera di Allan Rouse e
Guy Massey, ha richiesto un lavoro minuzioso durato quattro anni. Tanto tempo si giustifica e no per
gli esperti del settore, soltanto cinque i minuti che
hanno necessitato di cure particolari, ma il vero salto di qualità è legato alla dinamica.
Pure i Beatles, travasati su CD agli albori del
supporto digitale, erano stati vittime delle tipiche
piattezze del suono "eterno" ma, per l'appunto non
c’è alcun miracolo rispetto a chi disponeva di un
buono stereo e dei vinili ben conservati. Piuttosto
che fare gli Indiana Jones, eroe peraltro un po’ imbolsito, ci troviamo perciò a parlare dei Beatles per
motivi tangenti e fendenti, sempre sul bordo o anche al di fuori del detto e stradetto verbo sonoro
del Fab Four. Del resto con loro è sempre stato
così. Un periodo ad ascoltarli (da giovani) e tutta la
vita a discuterli, a difenderli alla morte o a condannarli alle pene dell’inferno.
Una cosa è sicura: chi li ha voluti conoscere sa
tantissimo, anzi tutto. Raccontargli qualcosa di nuovo
è impresa forse più noiosa della telecronaca dell’allunaggio. Più intelligente – dacché intelligenza è relazione e adattamento – concentrarci sulle relazioni
tra i contenitori, quello musicale e sociale anche se
fa un po’ vecchi social studies, o quello puramente
prospettico, economico critico (con tutte le divaga-
zioni che gli conseguono e competono ovviamente).
Crediamo sia il modo migliore senza dubbio, perché
i Beatles sono sempre stati un portale; e nell’acqua
in verticale dello Stargate ci siamo sempre specchiati, amandoci e odiandoci, ritrovandoci i nostri tempi
d’oro e quelli dei nostri genitori, la via spontanea
e quella dell’intelletto, rimettendo continuamente
in discussione i valori da associare alla prima e alla
seconda. E così via, di giustapposizioni, di rimandi, in
sistemi sempre più grossi, massimi.
C arnival
of
C apitals
Il Capitale di Marx? Facciamo il dio denaro. Lui,
Belzebù, ci interessa per primo. Dall’ovvio si parte,
perché l’ovvio proprio ovvio non è quando si parla
dell’altrimenti del denaro. Money che i Beatles in vita
hanno sempre macinato come vacche obese e cash
che i Beatles del dopo, e dei Beatles in quanto prodotto tra i prodotti, hanno finito per far fare a chi,
darwinianamente, li ha comparati. Ed eccoci anche
noi a parlare di Michael Jackson finalmente, personaggio abusatore e abusato, zombie per scherzo
e poi per davvero. Era il 1985, l’allora negretto cerbiatto compra all’asta il catalogo più danaroso del
pianeta e - grazie ai consueti giostrai senza scrupoli - lo spremerà negli anni successivi come il più
scafato degli investitori. Quei 200 brani, assieme ad
altri di altri più o meno grandi, girarono tante volte
il pomello dell’interesse di capitale. E così il loro
valore aumentò ancora: più i Beatles si dileguavano nella virtualità della borsa, dei passaggi di mano
anch’essi virtuali, e più erano qualcosa di ben più
liquido della loro materializzazione in spot di pannoloni per Procter & Gamble o jingle radiofonici.
Muovevano mercati muti ma sonanti. Di reale, c’erano gli allora milioni di fan e gli oggi milioni di milioni
di fan. Gente che sarebbe stata dalla parte di Paul se
solo i media avessero avuto interesse a sparare su
Michael facendogli perdere un Fort Knox di lingotti.
Niente da fare, la mungitura dei diritti non ha mai
fatto troppa notizia. Far soldi non fa certo scandalo, sopratuttto se non ci metti il sesso accanto e
non badi neanche a quella dichiarazione di comodo
rilasciata, lo scorso giugno, firmata dal suo ex dipendente (ora sotto Sony). Per tanti anni, anzi che
dico, per sempre dopo il fattaccio, il vissero felici e
DROP OUT
19
all'ed sullivan show
contenti a base di Say Say Say (prodotta da George
Martin per il mediocre Pipes of Peace) e la disneyiana The Girl Is Mine, ovvero le due collaborazioni tra
i più ricchi e famosi cantanti pop del pianeta, era
rotto per sempre. Macca e Michael avevano chiuso
e l’ironia fa parte naturalmente della storia. Fu il baronetto medesimo a raccontare al giovane guantato
quanto fosse diabolicamente esaltante il montante
delle royalties. “Vedi caro, queste sono le canzoni di
cui io detengo i diritti. Ogni volta che qualcuno le usa,
vengo pagato. Ogni volta che passano alla radio o dal
vivo, vengo pagato”. Jacko lo deve aver guardato con
quegli occhi da cerbiatto che faceva nei video di Off
The Wall; ed era il periodo delle session di Say Say
Say, Macca lo stava ospitando a casa sua e di Linda. I
tre cenavano sempre assieme, erano diventati amici... Bastano tre anni e Bang!
Squalo Michael, più grande dei Beatles, più famoso di Lennon e di Dio messi assieme, se li mangia, i
20
DROP OUT
Four. Precisamente si mangia il catalogo Northern
Songs, dell’omonima società per azioni, che prima
dimenticavamo di chiamare per nome. A dir il vero,
McCartney non era stato chiaro. S’era scordato di
aggiungere che per una super cazzata che fece tanto
tempo prima, proprio lui, assieme a Lennon (che ne
fece altre di concomitanti), avevano perso la quota
azionaria nella società. L’avevano venduta altroché,
e per svincolarsi da un accordo allora inaccettabile ai massimi livelli. Prevedeva che i due avrebbero
dovuto scrivere canzoni fino al 1973, dando ovviamente piena libertà alla società di disporne. Ridicolo, ma ancor più dal momento che, salvo tenersi
una quota di rendita (royalties), Paul vendette con
la consapevolezza di dover accettare quel perfido
gioco: avrebbe dovuto, da lì in poi, pagare i diritti
ogni qualvolta avesse suonato canzoni dei Beatles.
Quelle che in un paio d'album live con i suoi Wings
intestò P. McCartney – J. Lennon, a nomi invertiti,
perché, con grossa indignazione della vedova Yoko,
ci teneva che quel che era di Cesare spettasse a Cesare o meglio al King del pop. Ma il Re degli Ottanta
era un altro: Michael. Il suo Thriller aveva venduto
un botto e venderà 30 milioni di copie soltanto in
America battendo nel globo tutto e tutti, persino
Sgt. Pepper's. Aspetto clou della faccenda: il mix
di soul, disco e r’n’b, complice il nuovo George Martin della situazione, Quincy Jones, era destinato a influenzare le future star più di quanto lo avesse fatto
il pop dei Beatles. Almeno in America era già così e
per il futuro chissà… Sicuramente tra i balletti dei
concorsi canori televisivi e non, da Britney Spears
all’ex amichetto Justine, e il gotha hip hop più allargato, il lascito del decolorato è notevole. Eppure,
quel catalogo e quelle canzoni, quando Michael finì
di torchiarli, valevano il doppio (o quasi) di quando
lo aveva soffiato al beatle. Per la cronaca il re del
moonwalk fu poi costretto a cedere metà della sua
quota azionaria con la fusione Sony / ATV. Il motivo erano i perenni debiti che lo affliggeranno fino
al crepacuore. Eppure, quella quota strategica se la
tenne stretta, fino alla morte. Anzi, soltanto l’averla
promessa in vendita a qualcuno (la Sony), e avrebbe
goduto di tassi agevolati. E fu proprio così che andarono le cose. Era il 2006. Quest’anno, nel luglio
2009, smentite le romantiche voci che volevano un
Jacko mortificato e pieno di sensi di colpa lasciare in
eredità a zio Paul la quota Northern, è tempo di una
nuova operazione commerciale. Questa volta però
decisiva. In palio, la supremazia di quel che rimane
della gloria (economica) del pop. Se ne è fatta carico la EMI, perché il mercato dei supporti musicali,
vacca non più grassissima, stagionata a dovere rende
ancora. E allora via con i numeri, perché i Beatles
sono da sempre la album-band più venduta al mondo e non vogliono perdere il guinness. Facciamo
due conti: il pacchetto remaster sta vendendo più di
2 milioni di copie in rapida crescita nelle nazioni che
possono fare numero. Nella sola Inghilterra, in undici giorni, sono state smerciate 354,000 copie che
gli esperti fanno salire a 6,755,000 considerando il
totale delle vendite di album dal 2000 (considerando anche vinili, Love, Let It Be Naked e prime
versioni cd). Negli USA va ancora meglio: Billboard
parla di un milione di remaster venduti in cinque
giorni. E dovete sapere che, sia per Beatles che per
Jacko, gli statistici considerano uno zoccolo duro di
fan che compra tutte le versioni presenti sul mercato. Operazioni come queste fanno strabuzzare gli
occhi agli investitori e poi ci sono i calcoli com-
binatori: il nuovo record, l’ennesimo del Fab Four,
sarebbe quello del numero maggiore di album presenti contemporaneamente nelle charts del Regno
Unito. A metà settembre, gli scarafaggi totalizzano
quattro album nella top 10, sette nella top 40 e 16
nella top 75. Negli USA di Beyoncé, Jay-Z, Mariah
Carey, Shakira e compagnia nuove indie soul, ancora
meglio, con cinque dischi in top 10 e nove in top
20, mentre il Giappone talloneggia con quattordici
titoli, più i due box set, in top 25, per un totale di
840,000 album venduti in pochissimi giorni.
Gli osservatori, proprio vedendo tali successi,
e dopo aver guardato con interesse la crescita del
mercato (di nicchia) dei vinili, ci raccontano che i
consumatori sono ancora interessati al supporto
fisico, a patto che sia ben fatto, ricco di gadget e,
ancor meglio, se è collezionabile. Ricordiamo che
proprio il nove settembre scorso tutto il masterizzato circolava in rete per i consueti blog del pianeta,
senza fermare le vendite. E poi c’è il videogioco. I
Beatles, virtuali, lo sono sempre stati, ma sicuramente vettoriali no, e se avevano bisogno del game, il
mercato che attualmente smuovono le Playstation e
gli Xbox è più grande di quello musicale. In pratica,
sposta i capitali che il music-business spostava negli
Ottanta. I Beatles sfornano The Beatles: Rockband. E il
Capitale economico Fab Four ha un nuovo mercato.
La logica del denaro è un po’ quella del pop, si insedia, allaga, spazza via. All’epoca di Thriller, i Capitali
musicali si erano massicciamente allargati al video
con i clips. Cortometraggi particolari che proprio i
Beatles avevano sperimentato per primi. Il risultato
fu virtuoso, meglio, fece fare un nuovo giro attorno
al pomello del muzik biz, che s’ingrossò come una
balena. Gli occhi di Bowie in quegli anni sono il miglior esempio di come la lampadina catodica aveva
acceso letteralmente un mondo nuovo, ma è ancora
Jacko, e la sua VHS sul making di Thriller, il barometro dei bigliettoni verdi. Da solo era riuscito a
riportare l’introito del mercato musicale ai fasti del
1978, anno della disco music per eccellenza. Ora, i
remaster dei Beatles arrivano in una grande secca: il
mercato, nei soli anni zero, segna un 25/30% negativo, mentre un nuovo messia del Pop, non solo non
arriva, ma può darsi pure che parli un'altra lingua. Di
nuovo, inoltre, c’è l’assimilazione culturale del videoclip come parte della stessa moneta, e un modello
di musicista che ha prepotentemente assorbito la
performance più che l’autorialità, l’interpretazione
più che l’espressione.
Jacko – assieme alla coetanea Madonna – ha
DROP OUT
21
sostituito il portale ed è questo il modello con il
quale le nuove generazioni fanno i conti. Una relazione che se ne porta dietro un’altra: se McCartney non è altri che l’avv. Agnelli del Pop, allora Jacko
ne è stato il Murdoch o, se preferite, il Berlusconi.
Da un punto di vista prettamente imprenditoriale,
il primo ha rappresentato, e rappresenta, la vecchia
scuola, fatta di un misto di ego, intelligenza e artigianato (quella che "certe cose che non hanno stile
non si fanno"); il secondo, la controparte più liquida
e mutaforme, l’intuito e la velocità senza più nessuna remora. La spremuta Northern Song. La gara
che portò Michael a vincere per colpa di Yoko (che
negò l’appoggio finanziario a Paul) potrebbe avere
così un altro scenario. Non è chiaro fino in fondo
quel che successe quel giorno e preferisco credere
all’ingenuità di Macca e Yoko, al loro disegno secondo il quale Jacko li avrebbe fatti vincere, proprio per
una questione di stile. Una tipica mossa cavalleresca
da signori ricchi di una volta. C'era un precedente:
i Beatles avevano fondato la Apple (anche un brand
preso da un quadro di Magritte), oltre che per sfuggire alle tasse, investire e controllare direttamente
i propri guadagni, anche perché erano seriamente
animati da quel mecenatismo ingenuo che li portò,
nel 1967, a dichiarare di "averne fatti abbastanza di
soldi", e se questa era una contraddizione, dati gli
ambiti in cui la società era invischiata, voler aiutare
altri artisti era una missione concreta. Chiaro, il magna magna all’italiana che si scatenò nei successivi
due anni portò l’azienda a diventare sempre di più
tale e non ci stupisce ritrovarcela a litigare con Steve Jobs, proprietario di un'altra mela, l’Apple – iPhones e iPod – Computers per i diritti sul nome e, ancora, le canzoni dei Beatles, questa volta su iTunes.
D’accordo, anche Mr. Mookwalk aiutò, senza ironie,
milioni di bambini con beneficenze e presenza stile
principesco Lady Diana, ma, appunto, l’ingombro di
voler aiutare altri artisti, l’espressione e l’arte non
era contemplato, così come il gesto cavalleresco
mancato sopra. Michael morirà d’infarto. Macca, forse, nel 2018, complice una Copyright Act, tornerà in
possesso degli amati diritti, sempre se non ce la faccia prima la Ono, dato che con la morte dell’autore i diritti si giocano diversamente nel tempo. Long
live the King. E ricordate che per lui, vecchia scuola,
1 dollaro per 1 download dei Beatles è ridicolo. E
c’è già qualcuno che sta dicendo alla Apple che ogni
giorno senza iTunes e sono miliardi che volano. In
fin dei conti, la mossa dei remaster è nostalgica an-
22
DROP OUT
che soltanto per un motivo Capitalistico, con iTunes
o in proprio i Beatles approderanno ufficialmente
anche in mp3. E un nuovo mercato sarà pronto a
sverginarsi per loro. Io nel frattempo metto all’asta
su EBay quelle plasticacce che comprai nell’Ottantasette. (EB)
L a neve, la bestia
l ' antimateria
e
L'11 febbraio del 1964 non fu un giovedì come gli
altri. Due giorni dopo l'esibizione all'Ed Sullivan
Show che incollò allo schermo 73 milioni di telespettatori, i Beatles raggiunsero Washington.
Quella sera stessa al Coliseum avrebbero sostenuto la prima tappa del tour nella terra dello Zio Sam,
ponendo basi concrete a quella conquista vissuta
fino ad allora sulla scorta di una potente infatuazione mediatica. La prima picconata vera che avrebbe
aperto la breccia. L'invasione stava per avere inizio.
Ad attenderli, oltre ad un plotone di giornalisti,
c'era una fitta nevicata. Un giornalista non si fece
sfuggire l'occasione per apparire particolarmente
arguto e domandò: "Oggi voi e la neve siete arrivati a
Washington insieme. Quale delle due cose pensate che
avrà l'effetto maggiore?" John Lennon rispose sciorinando il più tipico understatement del suo repertorio: "Probabilmente la neve durerà di più".
Lo sketch fu estemporaneo e si risolse con qualche risatina a denti stretti. Ma battute del genere
punteggiavano con regolarità le interviste dei quattro. Quei ragazzi poco più che ventenni, già balzati
in vetta alle classifiche inglesi e in procinto di conquistare il mondo (più o meno), coi loro "mop-top"
e le urla incessanti degli eserciti di fan, all'epoca non
perdevano occasione per ribadire la propria consapevolezza anzi la ferrea convinzione che nel giro
di un paio d'anni tutto sarebbe finito. Evaporato. E
forse dimenticato. Si muovevano con la garrula impertinenza di chi vuole godersela finché dura. E non
facevano nulla per nasconderlo.
Due anni e qualche mese più tardi, i Beatles
cambiarono per sempre la storia del pop. Uscito
nell'agosto del 1966, Revolver è il disco che porta
a compimento le avvisaglie di espansione già palpabili in Rubber Soul (dicembre 1965) e persino - anche se molto più embrionali - in Help! (dell'agosto
1965). I primi cinque secondi della traccia di apertura bastarono ad infrangere l'illusione/tabù della musica registrata, rivelando il chiacchiericcio dei musicisti prima che attaccassero Taxman. Oggi non ci fai
neanche caso. Magari anche
allora non furono in molti a
realizzare la gravità dell'accaduto: palesandosi per la
prima volta il lavoro del musicista, la sua presenza come
facitore di musica, d'un tratto
l'ascoltatore prese coscienza
dello studio d'incisione.
Fu come abbattere le
quinte e far entrare fra i solchi l'aria impollinata di intuizioni, espedienti, magia, fatica,
eccitazione degli Abbey Road
Studios. Fu come aggiungere
una dimensione all'avvolgente bidimensionalità del vinile. Una sensazione simile a
quella provata dai lettori dei
Fantastici Quattro (anch'essi
Fab Four, no?), che nel numero 51 del giugno '66 - appena
due mesi prima - assistettero
alla scoperta del Portale sulla
Zona Negativa da parte del
geniale Mister Fantastic (per
la cronaca, i Beatles e Fantastici Quattro si erano
già incontrati in occasione di un'altra pubblicazione
Marvel, per la precisione sul numero di marzo del
1964 di Strange Tales).
L'antimateria fumettistica da una parte e il "golfo mistico" dello studio d'incisione dall'altra: zone
franche della fantasia, luoghi dove l'immaginazione
si espande svincolata dalle limitazioni del codice reale (realistico). Nel caso specifico di Revolver, lo
squarcio è aperto da (e si apre su) Tomorrow Never
Knows: malgrado sia posta a fine scaletta, fu il primo
pezzo inciso per il disco. Uno stordente vortice percussivo monoarmonico, come un mantra meccanico sulla china elettrificata del progresso. Ispirandosi
al Libro Tibetano dei Morti, John Lennon avrebbe
voluto per la linea vocale un vero coro di monaci buddisti, ma George Martin non volle saperne di
accontentarlo. Provate ad immaginare cosa sarebbe stato. Su, sforzatevi. Fatto? Bene, probabilmente
converrete che Martin tutti i torti non li avesse.
Quindi, reso omaggio al prode George - non a
caso "quinto Beatles" ad honorem - ci attende un
altro sforzo d'immaginazione: cosa sarebbe accaduto se i Beatles avessero fatto un album intero sulla
falsariga di Tomorrow Never Knows? La domanda è,
oltre che oziosa, a trabocchetto. Di più: è illecita.
Non avrebbero potuto, sarebbe stato come piovere
all'insù o credere all'esistenza di Pepperland e dei
Biechi Blu (ehm...). Perché l'esistenza di Revolver
- e dei Beatles stessi - implicava necessariamente
l'immersione nel crogiolo del pop, da cui i Fab Four
ed il pop sarebbero usciti definitivamente cambiati.
Quel pop che per i Beatles, vissuti per anni in equilibrio sul suo filo caduco, non era più, non doveva essere l'aggiornamento e la capitalizzazione dei suoni
più cool che giravano attorno.
Una pratica che, ad esser proprio bravi, avrebbe
consentito di sfornare la hit del momento, garantendogli però un conseguente rapido oblio. No, grazie.
Avevano già dato. Avevano già recitato la parte degli
zazzeruti cazzoni in sella al proprio quarto d'ora di
celebrità. Il fatto che si trovassero ancora lì, presenti
e vivi, doveva significare qualcosa. Forse non stavano
cavalcando la spuma di un'onda, ma la Bestia vera e
propria. E, cazzo, magari la stavano pure domando.
Porco cane, John, Paul, George, Ringo!
Non è dato sapere quando se ne siano resi conto. La fama sovrumana che li travolse sembrò scuoterli, ovviamente, ma loro si rifiutarono di realizzare.
Almeno pubblicamente. Col senno di poi, possiamo
DROP OUT
23
intravedere qualche sintomo anche precoce, come
quando il 16 gennaio del 1964 furono informati dal
loro manager che I Want to Hold Your Hand aveva
raggiunto la vetta della hit-parade statunitense: i
quattro rimasero storditi, senza parole, seduti sul
pavimento della stanza d'albergo dell'Hotel George
V a Parigi. Scossi dall'assedio della consapevolezza.
Eppure continuarono a rifiutare la realtà delle cose.
Malgrado migliaia di fan gliela gridassero ossessivamente ad ogni concerto. Malgrado i 73 milioni di
spettatori dell'Ed Sullivan Show (più altri 70 milioni
nella puntata del 16 febbraio, una settimana dopo).
Alla fine, ovviamente, ne furono investiti. Come la
classica rana che bolle, se ne accorsero a cose fatte.
Metteteci pure l'influenza di Dylan, il fattaccio del
"più famosi di Gesù" (una semplice constatazione),
la confidenza con le droghe e la conseguente espansione psichica (e viceversa). Fatto sta che, proprio
in quell'agosto del 1966, il 29 per la precisione, con
Revolver ad impazzare tra i timpani e le sinapsi del
pianeta rock, andò in scena a San Francisco la loro
ultima esibizione dal vivo, il ritiro dai palcoscenici
(che perdurerà fino al commiato definitivo del 30
gennaio 1969, il giorno del celebre Rooftop Con24
DROP OUT
cert). Ufficialmente la scelta
fu giustificata dalle insostenibili condizioni ambientali, con
le urla dei fans a sovrastare
l'amplificazione non trascendentale dell'epoca (al punto
che essi stessi non riuscivano
a sentirsi suonare), così come
la pressione nevrastenica dei
tour, giunta oramai a livelli
parossistici (che toccarono
l'apice coi tragicomici eventi
filippini).Tutto ciò è assodato,
confermato, Storia. è altresì vero però che i Beatles si
svincolarono dalla realtà. Ne
rifiutarono l'attrito urlante.
La zavorra. L'ostacolo.
Ora, mi sembra che non
esista una situazione musicale - gruppo, artista, scena
- più conosciuta dei Beatles.
Dei quali, almeno dopo le
Anthology, sembra proprio
non ci sia null'altro da sapere.
Dopodiché il copiaincolla di
George Martin con Love e la pseudo filologia di
Let It Be Naked ci hanno insegnato quanto la
manipolazione possa cambiare tutto senza cambiare nulla, perché l'immaginario lo plasmi ma non lo
sposti, si rimette in piedi come l'omino del subbuteo dopo ogni spinta o giravolta. Tutto nei Beatles e
dei Beatles è chiaro, esplorato, indagato, ipotizzato.
Giorno dopo giorno, ogni giorno della vita. Nessuna concessione alla normalità anzi la normalità promossa ad evento straordinario. Sappiamo tutto, di
tutto. Anche quello che non è mai accaduto. Anche
quello che forse, chissà, è accaduto.
L'unico modo sensato per esplorarli ancora è
l'ipotesi pura. Quindi, è giusto, ragionevole, auspicabile forzare la mano a questa cosa. D'altronde, non è
già abbastanza incredibile di per sé passare in dodici
mesi dalla deliziosa Ticket To Ride all'imponente delirio di Tomorrow Never Knows? Poniamo quindi che
Revolver sia stato progettato per rappresentare
l'idea stessa del pop beatlesiano: un ribollire superficiale perché la sotto c'è un mostro che brancola nel
mistero. L'inaudito come pratica di interpretazione
e decodifica della quotidianità sommersa, reso potabile e quindi collettivo, perciò indissolubilmente
agganciato alla Storia. Tomorrow Never Knows è il mo-
stro che fa capolino, il capogiro che ti prende constatando la realtà del mito (avvisti un UFO, scorgi
il capoccione di Nessie spuntare dal lago, incontri
Elvis ancora vivo...).
Una volta definito questo perno poetico, fu
spostato in coda alla scaletta per mimetizzarlo da
stordente bizzarria. Quindi, venne il resto: l'effervescenza aspra e vivida di I Want To Tell You e And Your
Bird Can Sing, l'esotismo patologico di Love You To, il
torpore radiante di I'm Only Sleeping, gli spurghi soul
di Got to Get You into My Life, la patafisica fumettistica di Yellow Submarine, l'estro sfrigolante di She Said
She Said, il melò barocco di Eleanor Rigby, il delicato
struggimento di Here,There and Everywhere...
Un plotoncino di potenziali singoli da cui paradossalmente fu estratto il solo Yellow Submarine con
Eleanor Rigby quale lussuosissima B-side (il pezzo
"fanciullesco" da una parte, il più "adulto" del loro
repertorio dall'altra...). Numero uno per oltre un
mese. Revolver, dal canto suo, da buon fenomeno
pop stazionò in vetta alle chart per sette settimane
in UK e per sei negli States. Preparando il terreno
al mostruoso impatto del Sergente Pepe. Un altro
capitolo della stessa storia. (SS)
Al
cinema
"Bene. Grazie a tutti da parte mia e del gruppo, e speriamo proprio di aver superato questo provino!".
L’accostamento Beatles e cinema ha costituito
un connubio perfetto per diversi motivi. I cinque
film di cui furono protagonisti, soprattutto i primi
due, contribuirono da un lato a ratificare la Beatlemania, dall’altro si pongono a tutt’oggi come contributi artistici originali nel contesto della nascente
pop culture.
Da quando all’inizio degli anni ‘50 i giovani erano
diventati - prima in America e poi in Inghilterra ed
Europa, di pari passo al miglioramento delle condizioni economiche del ceto medio-basso - una vera e
propria categoria socio-culturale (con lo sviluppo di
gusti estetici, modelli di comportamento e di conseguenza la nascita di mitologia e linguaggi propri),
l'unione tra musica e cinema era diventata inevitabile. L’immaginario della nuova cultura rock finiva
così per riversarsi sul grande schermo, attirando il
pubblico giovane, aumentando il numero di spettatori e, naturalmente, promuovendo i musicisti. I
film con Elvis Presley ne sono certo un esempio
folgorante, oggi forse il più immediato; ma in realtà
il rock’n’roll aveva iniziato sin dalla nascita a popolare alcune pellicole, sancendo la propria legittimità
ed affermazione: la prima canzone ad essere sentita
in un film è stata significativamente Rock Around the
Clock di Bill Haley (ne Il seme della violenza di
Richard Brooks, 1955), laddove nella ormai leggendaria commedia del ’56 The Girl Can’t Help It
di Frank Tashlin facevano la loro prima apparizione
di fronte al grande pubblico Little Richard, Fats
Domino, Platters, Gene Vincent e Eddie Cochran; in
questo contesto non va dimenticato, ovviamente, il
ruolo dell’icona giovane James Dean, lanciata in
contemporanea dal Gioventù bruciata di Nicholas Ray.
Negli anni ’60, quando il quartetto di Liverpool si cimenta con il grande schermo, il connubio
musica-cinema aveva già cominciato a definirsi, in
parallelo con lo sviluppo del movimento giovanile,
con caratteristiche abbastanza precise (il cosiddetto “film musicale”, da noi musicarello), sia come
oggetto di consumo, sia come prodotto originale
di affermazione della nascente cultura rock. È in
quest’ultima direzione che si innesta decisamente
l’attività cinematografica dei Beatles. Nei cinque film
(1964-1970) al loro attivo, i quattro musicisti allora compartecipano attivamente alla costruzione di
un’estetica propria, proponendosi al loro pubblico
in modo più diretto ed esplicito, attraverso l’unione
di diversi media (televisione, arti visive, pubblicità)
che rivelano una consapevolezza dei mezzi usati da
non sottovalutare. Film che, d’altro canto, serviranno poi da modello per il successivo cinema rock.
Le prime due esperienze, A Hard Day's Night
(Tutti per uno, 1964) e Help! (Aiuto!, 1965) avvengono sotto la regia di Richard Lester, esordiente americano trapiantato in Inghilterra che fino ad
allora si era occupato in prevalenza di pubblicità;
scelto da John Lennon dopo aver visto un suo corto realizzato insieme a Peter Sellers (di cui i Fab
erano fan dai tempi del seminale Goons Show, pietra
fondante della comicità british), Lester rivela tutte
le sue influenze di free cinema inglese (il realismo di
ambienti e storie) mescolando il semidocumentario
al musical in A Hard Day's Night, insieme all’idea
del viaggio (come si sa, trattasi di un avventuroso
passaggio in treno da Liverpool a Londra dove i
quattro devono registrare un concerto in uno studio tv, mentre sono braccati dai fan). è il ’64 e il film
ripropone, in versione casalinga, lo straordinario
successo americano riscosso a inizio anno all’Ed
Sullivan Show e la loro affermazione planetaria, a cui A Hard Day's Night contribuirà largamente.
Mescolamento di linguaggi (teatro, danza, fumetto),
DROP OUT
25
Yellow submarine
riflessione sui meccanismi di costruzione della celebrità, surrealtà, impertinenza, racconto delle caratteristiche dei quattro musicisti: il film da un lato rivela
tutto il suo debito nei confronti dei fratelli Marx
e dei citati Goons, dall’altro si pone come precursore
della sbeffeggiante e oltraggiosa estetica dei Monty Python. Nel successivo Help! Lester ritorna
ancora sulla celebrità, attraverso vicende surreali
ambientate in India e varie location, in un film che è
un tripudio di espressività pop e una parodia della
spy story alla James Bond. C’è l’antimilitarismo - nel
1965 siamo già in pieno Vietnam - bandiera di Lennon (che nel ’67 reciterà in How I Won The War
/ Come ho vinto la guerra dello stesso regista),
c’è l’invenzione di proto videoclip con largo anticipo
e una libertà che si riflette nelle associazioni anarchiche piuttosto che nella narrazione. Come detto,
questi primi due film contribuiscono a cementare la
26
DROP OUT
Beatlemania nel mondo.
Dal canto suo, Magical Mystery Tour (1967)
fa storia a sé. è stato l’unico caso di pellicola girata
in piena autonomia (con Brian Epstein scomparso da alcuni mesi, il gruppo aveva in realtà perso
la guida e il motore), accreditato ai quattro ma in
realtà da attribuirsi quasi per intero al solo Macca.
Ed è stato l’unico insuccesso commerciale. Realizzato su proposta della BBC come film di Natale, fu
trasmesso in TV nel periodo natalizio: la struttura
prettamente surreale spiazzò, c’era da aspettarselo,
il pubblico televisivo e la ricezione in b/n (nella maggior parte delle case degli inglesi non c’era ancora il
colore, nonostante il pionierismo in technicolor dei
Fab) fece il resto. Ispirato da un viaggio di McCartney negli Stati Uniti e privo di una vera e propria
trama, Magical Mystery Tour raccoglie confusamente
una serie di episodi spalmati nel corso di un tragitto
in un bus nell’Inghilterra meridionale. Essenzialmente un prodotto psichedelico ricolmo di LSD, non ha
più, venuto a mancare l’apporto registico di Lester
e quello morale di Epstein, un equilibrio fondante.
È frammentario al massimo, con l’unico motivo ricorrente del viaggio. Film non riuscito, che ha però
il merito di esprimere un’estetica; altro punto a suo
favore, a parte la novità nel vedere dei musicisti (un
musicista!) alla regia, quello di essere precursore dei
videoclip (già in parte realizzati con i film di Lester);
per ogni canzone c’è infatti una sequenza musicale
staccata dal contesto narrativo. E poi sono presenti
una miriade di segni e di influenze disparate, dalla lisergicità e dai colori della controcultura, all’oniricità
delle sequenze, alle citazioni di spettacoli popolari
come le fiere e il circo, anche nelle stranezze fisiche
presentate (riferimenti a Freaks di Todd Browning),
le citazioni da Alice di Lewis Carroll (la testa d’uovo, I am the egg man) e al Mago di Oz. Tanto, troppo per una visione televisiva casalinga!
L’attenzione e il successo verranno ristabiliti dal
successivo Yellow Submarine (1968), coloratissimo lungometraggio animato di George Dunning
e Dennis Abey dove i quattro compaiono in carne
ed ossa solo in un breve cameo finale. Protagonisti sono i loro corrispettivi animati, in un’atmosfera
sospesa e anche qui psichedelica (segno che le idee
seminate sin qui sono state raccolte in lungo e in
largo), da cultura hippy (il regno dell’amore di Pepperlandia), tra percezioni alterate, mondi paralleli
e riferimenti alla Pop Art. La partecipazione fattiva
del gruppo è per la prima volta minima, già immersi
in atmosfere da pre-disgregazione al punto di non
prendersi neanche il disturbo del doppiaggio. Intanto per il pubblico ci sono i loro alias in cartoon,
che li sostituiscono perfettamente e rispondono ai
bisogni di iconizzazione.
E si arriva così all’epilogo: il documentario Let it
Be, diretto nel 1969 da Michael Lindsay-Hogg
– lo stesso di The Rolling Stones Rock’n’Roll
Circus - e uscito nel 1970, a scioglimento ormai
avvenuto. Funestato dalle stesse peripezie artistiche
e produttive dell’omonimo album (in origine destinato alla TV con il titolo primigenio di Get Back, doveva riprendere la gestazione dei nuovi brani in vista
di un clamoroso ritorno dal vivo), è testimonianza
realistica quanto amara dell’ultimo periodo di attività in studio; un climax di scazzi, frustrazioni e faide
interne che miracolosamente culmina nel rooftop
concert del 30 gennaio ’69, qui proposto quasi integralmente come agrodolce finale (del film, e di
un’epopea intera). Come per tutto il resto della cinematografia beatlesiana, è quindi un’occasione per
mostrare un ulteriore tassello di un’evoluzione artistica e soprattutto personale. Un tassello definitivo
stavolta, doloroso al punto da non essere ancora
edito in DVD. Curiosamente, Let It Be si è aggiudicato un Oscar nel 1970 per la colonna sonora.
Aggiungiamo infine che, singolarmente, i quattro
sono sempre stati calati nel pieno della vita artistica
e culturale della loro epoca. Nello specifico, è noto
che Lennon seguisse il mondo dell’arte; meno noto
forse che fosse un appassionato di cinema (da ricordare il sodalizio con il cileno Alejandro Jodorowsky, al quale finanziò film e happening a partire dal 1971, quando persuase il suo manager Allen
Klein a comprare i diritti di El Topo e a finanziare
al regista il successivo La montagna sacra, 1973),
nondimeno titolare di una produzione filmografica
indipendente in tandem con Yoko Ono (Smile, Two
Virgins, Self Portrait, Fly, Imagine…); anche Paul McCartney si interessava di avanguardie, si veda il suo
trasferimento a Londra nel ’67 in piena era “swingin” (interessi che cercò di riportare nell’anarchico
Magical Mystery Tour). Oltre che in quelli di attore
(citiamo su tutti The Magic Christian del 1969
- al fianco di Sellers - e il delirante 200 Motels
di Frank Zappa, 1971), Ringo Starr è da ricordare
anche come regista del rockumentary dedicato
all’amico Marc Bolan (Born To Boogie, 1973);
non bisogna poi dimenticarsi del George Harrison
produttore: tra i finanziatori di Life Of Brian degli amici Monty Python nel 1978, avviò in seguito la
Dark Horse Production, che proseguì la sua attività
fino a metà degli Ottanta occupandosi prevalentemente di film low-budget. (TG)
D ark
side
Possono i quattro baronetti, i Fab Four dai caschetti innocenti, avere una controparte al nero? Si può
concepire gli autori di inni zuccherosi e inoffensivi
come Can’t Buy Me Love e She Loves You, fungere da
pietra angolare e/o influenza più o meno dichiarata
per musiche heavy & hard? O ancora, è possibile immaginare quelli che nella prima metà dei 60s furono protagonisti di scene di isteria collettiva nonché
fidanzatini ideali per la gioventù pre-68 impelagati
in storie di esoterismo di matrice satanica, omicidi
efferati, deliri d’onnipotenza, ecc? La risposta è sì.
Come ogni yin ha il suo yang anche i quattro di
Liverpool hanno aspetti a dir poco inquietanti. Saltando a piè pari la famigerata, shockante “butcher
DROP OUT
27
Butcher's attitude
cover” censurata di Yesterday And Today (1966),
è la fase che prende il via dalla pubblicazione di Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band, soprattutto. Prendete pezzi come Lucy In The Sky With Diamonds e Strawberry Fields Forever, o Revolution 9 e
Happiness Is A Warm Gun, con quest’ultima addirittura bandita dalla programmazione BBC per i riferimenti sessuali e alle droghe. C’è poco da fare o da
star lì a discutere: musicalmente, ma soprattutto a
livello di atmosfere e rimandi testuali, questa è roba
che ha ben poco a che spartire coi Beatles prima
maniera, usi a solleticare gli aspetti più pruriginosi
dell' adolescenza piuttosto che addentrarsi dentro
le più recondite spire della psiche umana. Questi
sono pezzi, insomma, in cui si palesa il flirt non tanto
con la concomitante summer of love quanto coi suoi
aspetti più psicotropici, deviati, perversi e malati.
Sarà forse un caso che questo lieve scarto avvenga
dopo il famoso viaggio in India? No, così come non
è un caso che proprio nel primo album successivo
all’esperienza presso il Maharishi Mahesh Yogi i riferimenti a qualcosa di socialmente poco accettabile
si palesino fin da ciò che è (era) il primo impatto
col pubblico: la cover. Sì, avete indovinato. È proprio
28
DROP OUT
nella copertina di Sgt. Pepper’s che si trova l’ormai risaputissimo omaggio al padre del satanismo
moderno, sir Aleister Crowley. Bello pacioso, lì
in mezzo alle persone che ci piacciono – esattamente
tra Mae West e il guru indiano Sri Kteswar Giri –
l’occultista più famoso e più citato del pianeta fa
indubbiamente la sua sporca figura contribuendo,
seppur post-mortem, a fomentare le voci sulla svolta
esoterica del quartetto. Insomma, quando l’ora del
tramonto allunga la sua ombra sulla summer of love,
sui caschetti neri dei fab four si vanno addensando
ben altre ombre; inquietanti e malefiche, cominciano a svelare al mondo la dark side del quartetto di
Liverpool. È però soprattutto grazie a (o a causa di)
un pezzo che l’aspetto diabolico, l’altra faccia del
bel sorriso inoffensivo e pop-oriented dei quattro
prende forma mostruosa e aberrante. Non per colpa loro in verità, o per lo meno non direttamente,
quanto di chi interpretò quel messaggio alterandolo
in base alle proprie manie e applicandolo al proprio,
devastante e malefico ego: Charles Milles Manson, per gli amici semplicemente Charlie.
È lui, il pazzo psicopatico from Cincinnati, colui
che scoperchia il vaso di pandora sui Beatles al
negativo, che li marchia definitivamente e li trascina
– almeno nell’immaginario collettivo – verso l’inferno e verso il male, esaltandone il lato oscuro quando guida (spiritualmente, ovvio) quell’accolita di
pazzi della Family nella villa di Roman Polanski
per ucciderne la moglie incinta Sharon Tate e un
paio di ospiti. È il 9 agosto del 1969: la summer of
love è finita da un pezzo e a quell’altezza anche i Beatles non se la passano proprio bene, tra contrasti
intestini e inarrestabili spinte isolazioniste (il matrimonio Lennon-Ono, vera e propria ufficializzazione
della frattura è, guarda caso, di qualche mese precedente).
La genesi della Family e la follia del suo indiscusso leader sono state trattate in lungo e in largo negli ultimi 40 anni (cfr. il libro del pm del processo
Vincent Bugliosi, Helter Skelter, Mondadori 2006),
così come le gesta che insanguinarono quell’estate da fine della verginità, inanellando una serie di
omicidi gratuiti quanto efferati. Riti satanici, depravazione sessuale, istinti omicidi, follia generalizzata
mascherata per metà da richiami esoterici, per metà
da ribellismo anarco-paranoide. Tutto e il contrario
di tutto si addensava nella mente di un non più giovane Manson e di rimbalzo, grazie al suo magnetico
carisma – chiedere a Dennis Wilson, la pecora nera
dei Beach Boys, ma soprattutto al suo conto in
banca, per conferme – nelle menti di quei derelitti
fuori di testa che formavano la Family. Ad ammassarsi nella mente del leader era però Helter Skelter. Il
pezzo consegnato al White Album si trasformava
nella mente contorta e sfregiata di Manson in ossessioni da ottovolanti apocalittici e satanici richiami
alle armi; i quattro autori, invece, nei cavalieri della
sua deviata e personale apocalisse. La guerra, altrettanto personale, che Manson col suo sgangherato
eserciti di drop-out borderline e troiette strafatte
si apprestava a vivere in quella torrida estate, non
poteva che chiamarsi Helter Skelter.
Stop. Fast Forward. Anni ’90. 1993, ad esser precisi. Morte ai porci, scrivevano, esaltati da un altro
pezzo del White Album, Piggies, gli invasati della
Family su uno specchio di casa Polanski col sangue
di una Sharon Tate incinta e ferocemente uccisa; e
morte ai porci rimbalza nella litania che gli Starfuckers regalano alla compilation Comin’ Down
Fast. Sottotitolo, A gathering of garbage, lies and reflections on Charles Manson. Pausa. Cosa c’entrano
i Beatles con una oscura compilation in vinile 10”
pubblicata in edizione numerata e limitata da una
minuscola etichetta italiana? C’entrano, c’entrano.
charles manson
Per almeno un paio di buoni motivi. Il primo, banale.
L’etichetta in questione – all’epoca anche distributore, e tra i più importanti – aveva sede a Roma e
prendeva il nome proprio dal pezzo-ossessione di
Manson, Helter Skelter. Secondo, molto più sottile.
Quanti gruppi dell’underground più vario, dal punk
all’industrial passando per l’avanguardia e il noise
(da Skullflower ai Motorpsycho), si sarebbero cimentati nel tributo al limite dell’agiografico di
un personaggio come Manson se fosse stato "solo"
uno dei tanti santoni assassini provenienti dalla terra di tutti e di nessuno? Se, insomma, non fossero
stati i Beatles, e quel pezzo dei Beatles, a innescare
la miccia di una latente bomba paranoide? Oppure,
rovesciando la prospettiva, quanto fascino avrebbero esercitato nei subdoli e putridi sotterranei della
musica underground – da Siouxsie agli Skinny
Puppy, per capirsi – i Beatles senza l’influsso negativo del magnetico Manson, la follia iconoclasta (insieme politica e satanica, ma in percentuali variabili)
DROP OUT
29
della Family e il sangue fresco e giovane della bianca
e ricca Hollywood? Quanto appeal avrebbe avuto il
portato, indubbiamente epocale, del quartetto inglese in band distanti anni luce se non fosse esistito
quel tramite maleodorante e nauseabondo che fu
Manson e la sua Family? Ovvero, i Sonic Youth
avrebbero inciso quel delirante capolavoro che è
Death Valley ’69 se non fosse successo quello che è
successo in quella valle nell’estate del 69? O ancora,
Trent Reznor a.k.a. mr. Nine Inch Nails, si
sarebbe spinto all’estrema azione di affittare la villa
dell’eccidio per trasformarla in studio di registrazione per il suo The Downward Spiral?
Insomma, quello tra i quattro di Liverpool e il
pazzo Charlie è un legame indissolubile, per forza di
cose bidirezionale, troppo ampio per essere trattato in questa sede ma indubbiamente in grado di fare
la fortuna l’uno degli altri. O viceversa. Dopotutto, ci si ritrova sempre tutti a bordo di quell’helter
skelter, no? (SP)
U no
contro tutti
Anonimo fan dei Beatles: Soltanto un incompetente
puo` negare che i Beatles abbiano fatto la storia del
rock.
Piero Scaruffi: Spero che su almeno una cosa siamo
tutti d'accordo: meno uno s'intende di musica rock, più è
convinto che i Beatles abbiano fatto la storia del rock....
Come erigere la propria attendibilità demolendo
il senso comune, il valore dato per assodato e fatto
proprio dalla collettività? La chiave per interpretare
un personaggio come Piero Scaruffi, che di base
è un critico musicale e/o cinematografico e/o d’arte,
ma anche storico, matematico, poeta, ingegnere, teorico politico, esperto di viaggi, filosofo, scienziato... e
molto altro ancora, sta tutta nell’iconoclastia come
modus operandi e cartina al tornasole del proprio
successo. Come dire: molti nemici, molto onore. Piero Scaruffi ha costruito tutto il suo successo sulla
capacità retorica e argomentativa con cui ha saputo
rovesciare miti dell’epoca dei consumi, mettendo in
piedi contemporaneamente tutto un altro mondo,
ai più sconosciuto, di cui si è fatto il portavoce. Da
qui poi anche un modo molto tagliente e categorico
di produrre giudizi senza colpo ferire e una retorica abilissima nel testimoniare quello che altrimenti
non potrebbe essere: un'opinione diversa da quella di cui si è profeti. è l’identikit perfetto di quello
che finisce per risultare poco simpatico. Non che ci
si voglia allineare alla folla di detrattori, per lo più
colleghi di mestiere o fan inviperiti, che lo vedono
30
DROP OUT
come un pagliaccio autocostruito sul nulla che non
capisce alcunché e spara sentenze un tanto al chilo,
ma che il personaggio sia di quelli difficili da gestire
lo si comprende subito. Poi per carità… di meriti
indiscussi il suo curriculum è pieno, a partire dal
suo sito web, primo esempio di comunicazione rock
online in Italia, con la maggioranza delle sue schede,
prima pubblicate nella sua Storia del Rock in più
volumi, disponibili gratuitamente e a portata di click
(anche qui i detrattori però sostengono che Scaruffi
non sia stato proprio il primo. Forse IAMR c’era già
prima. Forse c’era già un primordiale database in
un’epoca pre-Amiga 500… ma anche questo fa parte del nostro discorso…). Ed è qui che si innesca il
ring. Internet accorcia le distanze, Piero nonostante
i suoi innumerevoli viaggi in tutti i posti del mondo
è costretto a fare i conti con la folla inferocita del
villaggio globale, che con due mail ti viene dentro a
casa a sbatterti sul muso la propria disapprovazione
per i tuoi giudizi. Il fanatismo degli utenti rock si
scontra con il monolitico e irraggiungibile profilo
del critico super partes.
Da qui nascono pagine indimenticabili e irripetibili che fanno testo a parte nella nostra micro
cosmogonia storiografica di scrittori rock italiani
online anni 2000… I botta e risposta tra Piero e i
fan indispettiti per le sue schede. In un paio di casi
si raggiungono vertici assoluti: David Bowie e
i Beatles. Pochi altri artisti nella storia del rock
hanno avuto una tale massa adorante. In entrambi
i casi lo scaruffismo si abbatte come la mannaia del
boia. Cosa aspettarsi da uno che inizia la scheda di
Bowie in questo modo: "David Bowie fece del marketing l'essenza della sua arte.Tutti i grandi fenomeni della
musica popolare, da Elvis Presley ai Beatles, erano stati
innanzitutto fenomeni marketing (come la Coca Cola e
i Blue Jeans prima di loro), ma Bowie ne fece un'arte".
Con Bowie tutto sommato siamo ancora nell’ambito della discussione tra diverse opinioni. I fan sostengono questo, Piero sostiene quello e lo spiega
non senza la classica chiosa di chi si rompe anche
le scatole di stare li a spiegare l’ovvio, cioè la verità
della propria opinione: "Bowie è un ottimo esempio di
come uno finisca per scrivere una scheda molto lunga
e dettagliata su un argomento che gli interessa molto
poco. Mentre gran parte delle 5.000 schede di questo
website non vengono analizzate da quasi nessun lettore,
quella di Bowie viene analizzata da centinaia di lettori".
Con i Beatles però si raggiunge il top. Arrivati a
questo punto bisogna per forza di cose fare gli ipertestuali e mettere il link ad una pagina a suo modo
piero scaruffi
mitica: http://www.scaruffi.com/vol1/beatles.html.
L’attacco fa subito impressione, con tutta quella serie di 3 e 4 dati ai primi album fino a Revolver.
Abituati a sentirci dire che Sgt. Pepper e il White
Album sono patrimoni dell’umanità, che andrebbero messi sul Voyager come testimonianza artistica
per gli alieni, si rimane basiti da smilzi ed emaciati 7
e 6. Ma le argomentazioni sono ancora più pirotecniche. Si inizia caldi e decisi: "I Beatles appartengono
certamente alla storia del costume degli anni '60, ma i
loro meriti musicali sono quantomeno dubbi". Si prosegue demolendo il mito, non basandosi sulla capacità
tecnica e musicale dei Fab Four, quanto proprio sul
contesto social/musicale dell’epoca, tagliando subito
le gambe alle pretese rivoluzionare della loro musica, che lui pone automaticamente come reazione
normalizzate e pop al rock’n’roll selvaggio degli anni
‘50: "L'arrivo dei Beatles rappresentò il salvagente per
la middle-class bianca, terrorizzata all'idea che il rock
and roll rappresentasse una vera rivoluzione di costume.
I Beatles tranquillizzarono quella vasta fascia di pubblico e conquistarono i cuori di tutti coloro (soprattutto al
femminile) che volevano essere ribelli ma senza violare
i codici imperanti. [...] I Beatles sostituirono le immagini
di quei giovani arrabbiati col pugno chiuso con i loro
visi simpatici e le loro dichiarazioni amabili. I Beatles
sostituirono le parole d'accusa di quei musicisti militanti
con filastrocche corrive". E da un punto di vista strettamente musicale? Un disastro! "Per il resto della loro
carriera i Beatles furono quattro musicisti mediocri che
cantavano ancora canzoni melodiche di tre minuti (le
stesse che si facevano da decenni) in un'era in cui la
musica rock tentava di spingersi al di là di quel formato (un formato originariamente dovuto alle limitazioni
tecniche del 78 giri). I Beatles furono la quintessenza
del "mainstream", assimilando nel formato della canzone melodica le innovazioni che venivano man mano
proposte dalla musica rock". Le più grandi colpe o,
per meglio dire, le macchie che coprono la capacità
artistica dei Beatles per Scaruffi stanno soprattutto
nell'aver copiato pedissequamente i Beach Boys
e affidato tutto a George Martin, che in veste di
produttore è il vero deus ex-machina degli arrangiamenti che fecero il loro successo.
Come pensate che i fan dei Fab Four possano
reagire leggendo simili cose? Pensate forse che il ridurre l’importanza dei Beatles al rango di fenomeno
di costume possa avere in qualche modo attenuato
il colpo al cuore di parole tanto dure? Manco per
idea. Le lettere partono e arrivano. Probabilmente
Piero è costretto ad inserire una regola in Outlook
(ma lui da scienziato dell’ICT forse usa Eudora o
Thunderbird…) che letta la voce Beatles nell’oggetto del messaggio indirizza automaticamente nel
cestino. Non di meno ci prova a rispondere, e l’ego
del personaggio si abbevera ad una fonte che non
va mai in siccità. "La benché minima "critica" (ovvero
analisi approfondita) ai Beatles viene interpretata dai
fans dei Beatles come "odio": lascio agli psicologi spiegare questo fenomeno". Qualcuno prova a sbattergli
in faccia decenni di storia popolare: "La storia del
rock e` scritta anche da milioni di dischi venduti, concerti esaltanti, mode lanciate", ma la risposta è saccente e implacabile come compete al personaggio:
"Chiunque compia una ricerca sociale degli anni '60,
deve parlare di Beatles, Monroe, le minigonne, Pelè e (in
Italia) Carosello". è ovvio, a questo punto, che le due
fazioni non si possano mai incontrare a metà strada.
DROP OUT
31
Del resto, è indubbio che il taglio delle melodie e la
progressione degli accordi era già all’epoca abbondantemente sopra le righe. Come dire che di suonare rock’n’roll ai Beatles importava fino ad un certo
punto… ma a conti fatti sono questioni di lana caprina. Il fan dei Beatles ha gioco facile nello sbattere
in faccia a Scaruffi il falso storico secondo cui la
leggendaria capigliatura a caschetto sia invenzione
del produttore Epstein, quando invece sembra che
sia merito del gusto estetico della ragazza del primo
bassista del gruppo, Stu Sutcliffe… Come ci si rende
conto dopo un po’… il confine tra critica ragionata
e questione di principio diventa un nebulosa linea
di confine, ma va bene così. Il mondo non è bello
perché è vario, ma perché c’è gente che si accapiglia
per il taglio di capelli di Ringo Starr. (AC)
C ommunication
breakdown
Facce pulite e rassicuranti, sia che facciano canzonette rock, sia che tornino dall’India con un souvenir psichedelico ad uso e consumo delle giovani
generazioni (ma niente a che vedere con quanto
pre-scriveva in quegli anni Raoul Vaneigem nel suo
Trattato di saper vivere). Ma non è solo qui che ci
porta l’argomentazione scaruffiana. L’impressione,
32
DROP OUT
per chiudere questo elenco di porte che abbiamo
cercato di aprire, è che probabilmente attorno ai
Beatles si sia creata l’espressione massima del riduzionismo in musica.
Spieghiamoci meglio. I Beatles hanno fatto sicuramente della musica un mestiere, e hanno trovato l’apparato giusto dove inserirlo. L’ipotesi è che
non si tratti fino in fondo di questioni di intenzioni
autoriali. E che alla fine il tutto si risolva in un pro
e contro ingigantito. Certo l’opzione di Scaruffi ci è
utile, oltre che come lettura di un fenomeno – propagato ormai da più di un decennio tramite flame e
contro-flame dei forum musicali della rete – come
lettura di un pubblico. E da qui vogliamo ripartire
per mettere dei puntini di sospensione finali…
Erano gli anni Cinquanta quando Roland Barthes
parlava di Miti d’oggi, esponendo alcuni casi celebri
di nuove icone culturali - si direbbe oggi - create
tramite una sottile (perché meno evidentemente
oppressiva) forma di ideologia dominante: il consumismo occidentale. Il suo lavoro era di decostruzione, di demistificazione, di guerriglia semiologica.Va da
sé che un’operazione simile si potrebbe provare coi
Beatles, specie nel momento in cui 09/09/09 esce
con un tempismo eccezionale per stabilire il prima-
to di vendite anche nei Duemila (battendo così presumibilmente Eminem, che al momento attuale si
attesta sui 32 milioni di dischi venduti, quattro in
più di Macca e soci). Il mito – fatto di caratteristiche
iconiche e in qualche modo inarrivabili, se non sfuggenti – è pieno e sfaccettato insieme; è solido ma al
suo interno ha piccole storie, che hanno la funzione di rinnovarne la presenza sulle bocche di tutti;
esemplare il caso della bufala (vera o falsa, poco importa) creatasi attorno alla presunta esistenza di un
sosia di Mc Cartney, che si sarebbe insediato dopo
la morte del vero Paul, dal quale può essere distinto
solo per la cartilagine dell’orecchio e per l’ampiezza
dell’arcata dentale.
Per costruire un mito è necessario lavorare moltissimo su tutto l’impianto che può e deve promuoverne l’aura. Abbiamo parlato non a caso del rapporto tra cinema e Fab Four. È un capitolo che in
un discorso come questo ci interessa quasi quanto
l’analisi di un’uscita discografica. Sì, perché i Beatles sono stati anzitutto espressione di una capacità
mediatica. Sembra l’ennesima banalità detta a proposito della musica pop, ma, forse, bisogna terminare l’analisi – anzi, la scomposizione della questione
Beatles in tanti rami di discussione – provando a
sfogliare i livelli di quello che su di loro è stato detto
di più ovvio. Non è certo una novità che una band
abbia un apparato promozionale studiato sinergicamente attorno a tutte le possibilità offerte dai
mezzi di comunicazione di massa. Eppure, ciò che
forse non ebbe pari fu la disinvoltura e la leggerezza
con cui i quattro – ancora una volta, Paul in primis,
e Magical Mystery Tour ne è testimonianza –
affrontarono le possibilità che ebbero di fronte; il
modo in cui si buttarono a pesce sui mondi che
quei tempi vedevano nascere (ancora la psichedelia,
come esempio magistrale). Un esercizio di essenza
naive che non è così distante dall’impegno assunto
da Lennon con la fluxiana Yoko.
La tesi neanche troppo originale che vorremmo
proporre è che il riduzionismo nero/bianco pro/
contro è funzione dell’ideologia del mito. E quello
che ci ha interessato è dare elementi per complessificare la relazione. E su questo: se vi diciamo cultura giovanile? Espressione che, fra l’altro, fece la sua
comparsa ad opera di nugolo di avanguardisti rivoluzionari sempre provenienti dagli anni Cinquanta,
i lettristi di Isidore Isou, che inventarono di fatto
i "giovani" come "classe" sociale, prima assente da
discorsi politici e di conseguenza anche di pubblico,
da allora in poi centrale per ogni progetto sovversi-
vo. Fatto, questo, non così astruso dal contesto musicale e dallo show-biz inglese; vi ricordate un certo
Malcolm McLaren? Colui che partì dai Pistols
per arrivare a coniare la musica per pre-adolescenti,
come nuovo pubblico a cui dare la caccia? Proprio
Malcolm non ha mai fatto mistero delle proprie letture lettriste e situazioniste, quasi sbeffeggiandosene; altro grande banalizzatore di un potenziale di
ribellione sociale.
A prima vista non sembrerebbero esserci dubbi
riguardo all’impatto dei Beatles sulla cultura giovanile. Ma si potrebbe altrettanto dire che eppure
oggi non sono solo i giovani il pubblico dei Beatles.
O almeno che quei giovani ormai sono cresciuti. E
che, se anche i Beatles hanno reso innocuo il riot
adolescenziale, la loro caratteristica di oggi – il loro
apporto alla questione della ricezione musicale nei
nostri anni - è la trasversalità trans-generazionale. Altra banalità apparente. Il suono dei Beatles nei CD
2.0 (o 3.0) può forse essere un piano di traduzione
tra gli ascoltatori dei Beatles di allora e, da una parte, i giovani del mainstream odierno (abituati ormai
a un’idea di hi-fi che è tecnologico e ha come primo
obiettivo la separazione dei suoni, più che l’impasto
complessivo), dall’altra, gli ex-giovani che ora si godono le possibilità della tecnica e riscoprono il loro
amore originario con le orecchie di oggi.
La conclusione potrebbe essere che i Beatles
hanno inventato la trans-generazionalità. È però
anche questo un atteggiamento partorito dal riduzionismo. Nessuno ha inventato niente. Una cosa
su cui chi ha promosso promuove e promuoverà i
Fab sa riflettere è il vecchio dubbio amletico sulle
comunicazioni di massa: funzionano da uno a uno o
da uno a molti? I Beatles puntano sulle masse, ma
ognuno, direttamente e in un rapporto uno a uno,
si sente offeso da Scaruffi. Cosa interessante e permessa dal personalismo del web, in qualche misura.
Il critico ha capito che se ha davanti un organo fatto
di milioni di corpi, ognuno di questi corpi, preso singolarmente, rivela i propri dubbi.
Vogliamo concludere mettendo l’ultimo pezzo di
carne sul fuoco. L’enorme dispositivo strategico che
attorno alle canzoni beatlesiane ha costruito una
vera e propria cultura ha anzitutto puntato sulle necessità di "movimento". Questo è il punto con cui
vorremmo chiudere. Il fatto che quella cultura ha
bisogno di un continuo aggiustamento. E si muove
lentamente come la società. Che in realtà non cambia così in fretta… (GC)
DROP OUT
33
Jim O’Rourke
Le dimensioni
di un fenomeno sotterraneo
Dai monasteri dell'indie-rock alla tentatrice industria
hollywoodiana, parabola di un uomo che mai ha messo
da parte la sua variegata ispirazione.
Attentando spesso ai sacri luoghi del rock.
- Luca Collepiccolo
34
DROP OUT
A
volte è sufficiente un pretesto. Qualora il
pretesto si manifestasse nella forma di un
vero e proprio disco, quale occasione migliore per tornare su uno degli alchimisti
del pop contemporaneo? D'accordo, il termine pop
potrebbe - nel nostro caso – essere poco confortante, dato che Jim O' Rourke i generi musicali li
ha attraversati in lungo e largo, eccellendo peraltro
in ogni singola categoria. E questo è un giudizio di
carattere oggettivo, che vuole tagliare fuori coloro
che pensano – volutamente – male. Gli estremi si
toccano nella carriera di Jimbo che a soli 40 anni ha
messo da parte un'invidiabile discografia, sfiorando
ipotesi e realizzando teoremi. Romanticismo, astrazione, ma anche una superficie dura da scalfire. Alle
volte. Perchè gli accenti posti da O' Rourke sulla
sua musica non si sono mai rivelati necessariamente
gentili. Lo si può dedurre da un attento studio degli
articoli in campo, qualora si passasse da una bucolica aria in odor Burt Bacharach ad un riottoso
incedere chitarristico assieme al samurai levantino
KK Null.
Un corto circuito nervoso o un semplice desiderio di docile ritiro debbono aver accompagnato
il musicista in alcune delle sue più recenti scelte
artistiche. Che ovviamente collimano con rigorose
scelte di vita. è facile realizzare come un uomo completamente assorbito dal suo lavoro, quasi offuscato
da una viscerale passione, spesso dimentichi tutto e
tutti. è tempo di meditare ora, di concedersi altre
gioie, ecco perchè il Jim O' Rourke di The Visitor,
album con cui sancisce il ritorno alla confraternita
Drag City, appare sostanzialmente più sereno, intento a godersi un lungo – e meritato – momento di
riposo.Le sue dichiarazioni possono oggi assumere
un tono sprezzante, all'apparenza, ma sono dettate
dall'esigenza di evadere. Per troppi anni immerso
nel rutilante mondo della musica indipendente, O'
Rourke è oggi molto restio ad esprimersi in merito,
evitando a tutti i costi quel ruolo di termometro
artistico che per circa 10 anni ne ha caratterizzato
l'esistenza. Non facciamo dunque fatica ad immaginarlo immobile, a contemplare il silenzio, dopo che
la sua musica lo ha in qualche modo investito o rivelato attraverso altri costumi. Se nel 2000 la sua firma sembrava essere ovunque, oggi gli scenari sono
drasticamente mutati, anche perchè all'orizzonte
altre attività hanno cooptato l'interesse del nostro,
in maniera quasi prepotente. Se la musica ambient
ha in qualche misura caratterizzato i suoi esordi artistici, anche con il combo Illusion Of Safety
sotto la guida del leader Dan Burke, è con il rock
più trasversale che Jim raccoglierà le prime – grandi – soddisfazioni, scegliendo Chicago come centro
nevralgico delle sue operazioni, lasciando che le
collaborazioni fioccassero quasi senza soluzione di
continuità.
Un atteggiamento quasi assoluto, che parimenti
a quello di 'biografo' ed avido consumatore di musica, lo ha spesso relegato ai margini della produzione artistica. Raccogliendo in quest' ambito risultati
poco meno che eccelsi.
L a Joint - venture
D avid G rubbs
Non chiedete nè a lui, nè tanto meno a David Grubbs cosa ha portato alla deflagrazione dei Gastr
Del Sol, uno dei più sfuggenti esempi di un'estetica retro-rock che combinava avangurdia ed istanze pop da salotto colto. Ovvio che l'intervento di
O'Rourke abbia letteralmente sconvolto i piani di
Grubbs, reduce dalle martellanti progressioni dei
Bastro e ancor prima dall'ipercinetico hardcore
dei giovani Squirrel Bait. I Gastr Del Sol di Serpentine Similar (con il contributo alla batteria del
futuro Tortoise John McEntire) sommariamente
potrebbero essere indicati come un gruppo rock
che guarda ai visionari di casa Vanguard.
Era solo il '92 ed ulteriori – capitali – avvenimenti
avrebbero per sempre ridefinito l'estetica del dopopunk. Un disco che contribuirà in maniera clamorosa ad una rivoluzione estetica è Crookt, Crakt,
Or Fly, che come il precedente uscirà per Drag
City. Nel 1993 i Gastr Del Sol sono essenzialmente
una creatura dalle quattro braccia con O' Rourke
che raggiunge Grubbs e precipita sulla scena una
serie di elementi atipici, quasi stranianti, che molto
debbono alla dinamica passione per certo minimalismo e musica contemporanea. Ovvio che la scuola
isolazionista, con la relativa ricerca di microsuoni,
informano le scelte stilistiche di O'Rourke che pone
in essere una serie di sviluppi inediti per il suono
dei Gastr Del Sol. Ora prepotentemente coi piedi
nel mondo delle musiche eterodosse. A suggello di
questa avvenuta profezia un brano come Work From
Smoke, in cui presenzia il magistrale clarinetto basso
di Gene Coleman. Uno sviluppo essenzialmente pirotecnico che porta dal virtuosismo sulla sei corde
– John Fahey, ma anche Sandy Bull – a ipotesi di
musica concreta, con cartoline distinte provenienti dall'Italia del Gruppo Di Improvvisazione
Nuova Consonanza.
con
DROP OUT
35
Gastr del sol
Continuo a preferire quest'album per la sua varietà tematica al pur epocale Upgrade & Afterlife – di mezzo c'è anche il bellissimo Ep Mirror
Repair, che riportava in auge la loro versione del
Canterbury sound – che in qualche misura sposterà
il baricentro dei Gastr Del Sol verso un'intima ricerca, fatta di sottrazioni e lunari digressioni verso
la musica dei primi del '900 (pur con la partecipazione di un brutista come Kevin Drumm, un maestro come Tony Conrad ed un selvaggio jazzista
come Mats Gustaffson). Certo è che la rilettura di
Dry Bones In The Valley del buon John Fahey chiudeva
in maniera commosa non solo lo stesso Upgrade
& Afterlife, ma anche la joint-venture tra Grubbs e
O'Rourke, che mai torneranno ad incrociare i loro
flussi artistici.
M oikai
e l ’ impro - jazz
Dissidi evidentemente insanabili, come è lecito speculare, consci dei loro ingombranti ego. Val la pena
ricordare come la stessa Drag City offrì ai due musicisti lo spunto per mettere in cassaforte alcuni dei
propri dischi preferiti, attraverso ristampe o pubblicazioni ex-novo.
Due sotto etichette di cui Grubbs e O' Rourke
sono anche direttori artistici, il primo lancia Dexter's
Cigar il secondo la Moikai. E – a dirla tutta - sulla
distanza è proprio Jimbo a farla franca, ripescando
36
DROP OUT
almeno due capolavori. Il primo è il doppio cd Live
At The I.C.A./Retrospective del gigante della sei
corde inglese Ray Russell, uno dei reali innovatori del
jazz-rock d'oltremanica. Coadiuvato da mostri sacri
come Elton Dean ed Harry Beckett si prodigava tra libera improvvisazione e jazz elettrico, come
un autentico funambolo. L'altra perla è Plux Quba
del portoghese Nuno Canavarro, disco originariamente pubblicato in tiratura irisoria (1988) e capace di influenzare prepotentemente le stelle del glitch,
Matmos in primis. Non deve sorprendere del resto
lo sconfinamento di O' Rourke verso le camere assai riservate dell'avant-jazz. In carriera il nostro ha
infatti avuto modo di confrontarsi con Derek Bailey – anche in una seduta della Company - i due
AMM Eddie Prevost e Keith Rowe e con figure di
più muscoloso impianto come Mats Gustaffson
(segnaliamo a proposito il gioco a incastri di Parrot
Fish Eye per la Okka Disc di Chicago con lo stesso sassofonista svedese, la vecchia conoscenza Gene
Coleman ed uno dei migliori percussionisti del nostro tempo, Michael Zerang).
Q uei
doverosi recuperi
Riuscite a cogliere l'implacabile senso di onnipotenza dell'apparentemente timido musicista? Sul finire
dei '90 è l'uomo ovunque, disposto peraltro a riesumare i miti della sua 'elevata' post-adolescenza.
Conscio dei meccanismi che animano il mercato
discografico, all'alba del downloading, realizza come
gli eroi del passato necessitino ora di una nuova
opportunità. Jim recupera così dall'oblio John Fahey,
o quanto meno ne rilancia la stella producendo nel
1997 per Table Of The Elements Womblife, uno
dei dischi più sperimentali del chitarrista. Operazione analoga – sempre su marchio TOTE – era toccata
ai redivivi Faust, che con soli due elementi della
formazione originale tornavano in studio per licenziare Rien, disco in qualche maniera spartiacque,
che documentava il rinnovato interesse per il rumore e le rinnovate tecniche di registrazione.
I mprendibile
Chi è allora O' Rourke? Un inguaribile esteta? La
tentazione è forte, sarebbe del resto un'affermazione più che plausibile. Nulla è lasciato al caso nella
sua tentacolare carriera artistica, anche se questo
non sottintende ad una scalata verso le zone alte
delle classifiche indipendenti. C'è semmai un forte
senso di auto affermazione, che implica una sorta di
redenzione nei confronti del passato. I miti non sono
intoccabili e spesso rientrano nel processo produttivo. è così nel superguppo Brise Glace, una delle
tante joint-venture fiore all'occhiello della stagione
d'oro di Skin Graft, in piena esuberanza now wave.
Ancora Chicago, una forte appartenenza, il proscenio per quel When In Vanitas del 1994, tra soluzioni massimaliste e la malsana idea di scompigliare
in definitiva le austere vie del rock progressivo. C'è
ancora Grubbs – prima dello split in seno ai Gastr
Del Sol – ma l'altra testa pensante è Darin Gray,
ex-bassista di Dazzling Killmen.
Al disco – prodotto da Steve Albini – partecipa un pezzo grosso dell'avanguardia americana dei
primi '80 Henry Kaiser, altro chitarrista con cui
O' Rourke ebbe più di un incontro rivelatorio.Parallelamente ai pachidermici solchi dei Brise Glace vive
un'anima più sprezzante, virtualmente noise rock.
Sono gli Yona Kit, il cui omonimo disco del 1995 è
davvero una delle maggiori uscite in casa Skin Graft.
O'Rourke, Gray ed il batterista dei Cheer Accident Thymme Jones fanno quadrato attorno al chitarrista cantante KK Null, giapponese gelido noto
in occidente soprattutto per le malefatte con Zeni
Geva.
Sempre del '95 è l'uscita in solo di Terminal
Pharmacy per la Tzadik di John Zorn, episodio
che va ben oltre l'attestato di stima. Segno di estrema poliedricità il disco ricalca la passione per la
musica elettro-acustica andando a sondare – solo
virtualmente – le zone d'interesse di uno dei suoi
primigeni lavori in solo, quel Disengage del '92, doppio disco licenziato dall'olandese Stalplaat, successivamente alla sentita esperienza con Illusion Of
Safety.
Q uell ’ essenza
pop
Quando nel 1997 torna ad affacciarsi su Drag City
con Bad Timing, coglie ancora tutti di sorpresa,
realizzando un album in realtà molto disteso, preso dal rispetto profondo per il maestro Fahey e le
prime 'innate' tentazioni verso l'alternative-country.
C'è il solo John McEntire a spalleggiarlo alle percusisoni, del resto non occorrono fragorosi accenti a
questi diversi esercizi
in stile fingerpicking.
L'album è delizioso,
ma nulla poteva preparare il terreno alla
grandeur di Eureka
che nel febbraio del
1999 segnerà l'ingresso prepotente
di O'Rourke nell'universo del pop. Dalla
porta principale.
Il brutto anatroccolo s'è fatto cigno.
Jimbo arrangia e canta, stupendo più di un detrattore col suo fare placido e la sua verve cristallina, quella di un veterano a
ben vedere. Gli arrangiamenti fiatistici sono di due
pezzi grossi della nuova Chicago jazz, il trombettista Rob Mazurek
ed il trombonista Jep
Bishop, cresciuto alla
corte di Ken Vandermark. Eureka è
a posteriori uno dei
più imprevedibili sigilli sulla musica pop
indipendente di fine
secolo, tanto che a
distanza di 10 anni le
sue fluttuanti e lussuriose melodie sembrano
primeggiare
nell'Olimpo dei grandi produttori/interpreti anglo americani: da Joe
Meek a Van Dyke Parks, passando per Scott
DROP OUT
37
Walker. A conferma di tutto ciò anche la bella
rendition di Something Big, brano autografo di Burt
Bacharach. Che questo sia un punto d'arrivo nella
folta discografia dell'uomo è anche certificato dalle
discrete vendite ottenute, oltre che dalla visibilità di
un progetto che mette d'accordo i meno ortodossi seguaci dell'avanguardia con i più discreti fautori
della musica melodica. Jim non è mai stato estraneo
nemmeno al mondo della più risaputa pop music,
già dai tempi del trio elettronico Fenn O'Berg –
con gli austriaci Fennesz e Peter Rehberg aka
Pita – mise in scena una sconvolgente rilettura di
un medley live delle Spice Girls. Darà poi seguito
all'iniziativa firmando una commovente Viva Forever
– sempre delle signorine inglesi - per la raccolta
Guilty By Association, come si evince dal titolo
un tributo alquanto trasversale ai miti delle charts
internazionali presenti e passate.
Un
uomo instancabile
Potrebbero spalancarsi nuovi mondi ora, ma proprio
38
DROP OUT
quando la strada si mostra in discesa continuano a
fioccare le collaborazioni, battendo - parallelamente
alla strada maestra - il viale dell'avventura in suono.
Un viaggiatore dunque, che volentieri si ricongiunge
al vecchio amico Mats Gustafsson per Xylophonen Virtuosen, disco di improvvisazione rilasciato
dalla Incus di Derek Bailey. Per un ritorno più
consono alla forma canzone bisogna attendere il
novembre del 2001 con l'uscita di Isnignificance ancora per l'etichetta-madre Drag City. Un disco più
smaccatamente rock, che concorrerà a dividere la
critica, pur mostrando una serie di numeri efficaci.
Sotto il suo tetto ancora l'intellighenzia di Chicago,
per arrangiamenti che addirittura sembrano scomodare il southern rock, pur non abbandonando
del tutto le scintillanti vie del pop di Eureka. Un
altro passaggio cruciale della sue vita artistica è I'm
Happy, I'm Singing And A 1,2,3,4 melanconico capolavoro elettronico, che fa un solo boccone
della cosiddetta IDM, sferrando un deciso attacco
alle istituzioni del minimalismo. Tre lunghi episodi
che spostano nuovamente l'orologio biologico di O'
Rourke, in un continuo raccordo con il passato e le
sue eredità artistiche. Che a livello di compositori
contemporanei rispondono ai nomi di John Oswald,
Bernard Günter, Gerhard Schtebler, Helmut Lachemann e Salvatore Sciarrino.
A lla corte
W ilco
di
S onic Youth
e
Inizia da qui una fase di progressivo abbandono del
proprio io solista, nel frattempo si solidificano importanti joint-venture, che più che distrarre il nostro aprono nuove porte nell'asfittico mondo del
mainstream-rock. è infatti l'incontro coi Sonic
Youth ad inaugurare un altro capitolo importante
nell'esistenza di O' Rourke; partito in sordina con le
collaborazioni nella serie prospettive musicali (per
la stessa Sonic Youth recordings) il discorso si amplia sempre più con
l'investitura nel ruolo di produttore per
NYC Ghost & Flowers del 2000. Il nostro finisce anche col
ricoprire il ruolo di
bassista – e dal vivo e
da studio – permettendo a Kim Gordon di tornare al suo
vecchio amore per la
sei corde. Per Murray Street e Sonic
Nurse O' Rourke
sarà il quinto membro della storica band newyorkese. Solo nel 2004 Jim deciderà di abbandonare la
nave con l'enigmatica collaborazione Hydros 3
per la norvegese Smalltown Supersound, con ancora in bella vista il contributo di Gustaffson (sempre
per la label nordeuropea vale la pena di
ricordare anche il supergruppo Original
Silence, cui i due
partecipano assieme
allo stesso Thurston Moore, Massimo Zu, Terie Ex e
Paal Nilssen-Love)
Nel frattempo Jim
guadagna ulteriore
credito nelle vesti di
produttore e musicista da studio. Consente ai Wilco di Jeff Tweedy di spiccare letteralmente il volo
nel 2002 con Yankee Foxtrot Hotel, illuminando
l'originario alternative-country del gruppo nel susseguente A Ghost Is Born (2004), in cui si carica
anche la piccola incombenza di sessionmen, facendo
sì che la verve sperimentale – oltre a certe mutazioni kraute - prendano addirittura il sopravvento in
fase di songwriting. Una collaborazione che va aldilà
delle pubblicazioni Nonesuch, grazie al triumvirato
formato con lo stesso Tweedy ed il percussionista
Glenn Kotche a nome Loose Fur. Due album
deliziosi pubblicati dalla solerte Drag City, con una
netta preferenza per il secondo – Born Again In
The Usa – che vuole rivedere con una ricerca mai
estrema le istanze del rock americano.
L’ alternativa
Per allontanare Jimbo dal mondo della musica ci
vuole dunque un ingaggio irrinunciabile, una prospettiva professionale che gli consenta di allentare
la presa rispetto ai numerosi impegni discografici.
Il mondo della celluloide, attraverso una chiamata
davvero inedita, regala un altro tipo di notorietà al
nostro, del resto mai avulso al cinema d'avanguardia
ed alla sonorizzazione di performance tout court
(si pensi al lavoro svolto al fianco del compositore
Takehisa Kosugi per la compagnia di danza di
Merce Cunningham). Si diverte un mondo in
School Of Rock – basta vedere i bonus dell'omonimo dvd, in cui spende parole di elogio per i giovani
virgulti da lui stesso 'addestrati' – con uno scoppiettante Jack Black protagonista. O' Rourke inizia così
una parallela carriera di consulente per il grande
cinema, che solo momentaneamente lo allontana
dai circuiti musicali. Dopo il trasferimento a New
York – assisterà anche lui in diretta al famoso attacco alle torri gemelle – Jimbo stabilirà il proprio
domicilio a Tokyo, Giappone, una terra da lui sempre profondamente amata e rispettata. Dell’ultimo
– enigmatico - The Visitor riferiamo in altra parte
del giornale, puntando magari il dito su un lavoro
all’apparenza incostante, nell’atipica forma di suite
modern-pop. Ancora un disco strumentale che agita spettri e avanza incerto il baricentro dell’autore,
che – onestamente – non ha più nulla da dimostrare alla sostenuta intellighenzia del vecchio e nuovo
continente.
DROP OUT
39
Il Teatro degli Orrori
Aspettando la "seconda"...
Giulio Ragno Favero a rapporto per ripercorrere traiettorie e
dimensioni di due progetti che in italia pesano come macigni. E
nel frattempo l'atteso comeback del Teatro è realtà.
- Stefano Pifferi
40
DROP OUT
C
i si ritorna a distanza di un paio d’anni,
con quel giusto distacco che ogni manuale di critica consiglia. Ci si ritorna perché
in tempi di parossistiche accelerazioni di
mercato, Dell’Impero Delle Tenebre è un disco
che cresce ad ogni ascolto, tanto da meritarselo tutto lo status di classico del rock italiano e in italiano.
E ci si ritrova su quel playground delittuoso, dopo
averne colto le sfumature e contemplato l’insieme,
pronti ad accogliere una nuova, cruciale prova, dal
titolo capotiano: A Sangue Freddo. Disco che - ci
scommettiamo - rappresenterà una piccola svolta.
Ci troveremo più Inghilterra in produzione e più
compattezza nel suono. Ma ancora non è dato saperne di più e perciò eccoci a mettere legna al vecchio camino. Quel Dell’Impero Delle Tenebre
(La Tempesta, 2007) che è l'incipit ideale di questa
storia di bordoni a volumi elevatissimi e parole
pe(n)santi come macigni legati al collo. Era un disco
diretto quello, lanciato a mille, con le sue parole a
presa rapida, anteprima a reti unificate di una medaglia a due facce: fitti rimandi alla letteratura e alla
tradizione del cantautorato colto italiano e, insieme,
suono potente, stordente, mirato.
Un esordio che ha lavorato sottopelle e a distanza, che si è solidificato nei concerti, innestato nelle
menti, pure dei distratti; un album che col tempo si
è fatto classico. Che è un classico. E che è anche il
risultato della scalata di un gruppo precedente, di
un percorso che ha aperto esperienze e disordini.
Amplificato suoni e smanettato chitarre.
In
principio era il noise a una
dimensione …
Ascolti stratificati di musiche cresciute all’ombra
delle (ex) torri gemelle, nauseabonde come i budelli
stretti del Lower East Side o maleodoranti come i
cessi del (fu) CBGB’s. Questo è ciò che ci si aspetta essere il background del Teatro. Non è difficile
immaginarseli – Pierpaolo Capovilla (voce e basso),
Massimo Sartor (chitarra) e Dario Perissutti (batteria) – cresciuti a pane e punk newyorchese, imberbi
adolescenti del nord-est italiano in fissa con Ramones e Television, Patti Smith e Swans a
tal punto da rimanere sempre ai margini della vita
di paese. Drop-out li definirebbero negli States; drogati li definirebbero le anime fintocandide di ogni
paesello italiano, così abili e meschine nel ridurre
fenomeni frastagliati o animi sensibili a becera paccottiglia ben identificabile. Quale che sia la reale genesi di One Dimen-
sional Man, ci piace immaginarceli reagire a quel
falso perbenismo paesano con una volontaria reclusione in una casetta di campagna, magari di quelle
silenti e desolate in cui, approfittando della notte, ci
si può lasciare andare a distruggere amplificatori e
percuotere pelli, tra uno spinello e una birra. Puro
punk della provincia.
Ci piace anche immaginare che dopo poco più
di un anno di inarrestabili prove, da quel casolare
immerso nelle nebbiose lande dell’entroterra veneto sia uscito l’omonimo esordio (Wide 1997). Un
album che all’epoca si proponeva se non innovativo, per lo meno degno antagonista dei suoni che
giungevano dall’altra parte del cielo rumoroso. La
registrazione in (quasi) presa diretta contribuiva in
maniera decisiva a fare di quel disco qualcosa che
ancora oggi sarebbe competitivo: noise-rock brutale, mid-tempo assassini, voce malsanamente newyorchese. Insomma, un debutto di culto. Per pochi,
ovviamente, ma anche per sempre. Alla faccia del
marcusiano uomo unidimensionale, quel disco offre
tante sfaccettature quante sono le note triturate
nei suoi 10 pezzi.
… poi
venne l ’ era del blues …
L’etichetta noise-rock, vago ed immenso calderone
in cui inserire musiche poco definibili e molto diverse, va però subito stretta. Già nell’immediatezza
dell’esordio i 3 parlavano di guitar sound, dividevano
il palco con deformi mostri blues-punk rumorosissimi e devastati (gli immensi Cows, tanto per fare un
nome) e si avvicinavano forse inconsapevolmente ad
una forma “tradizionale” di musica. L’entrata in gioco
del jolly Giulio “Ragno” Favero (chitarra, ma anche
molte produzioni attuali portano il suo segno), avvenuta nella torrida estate del 1998, sposta il baricentro
del suono verso altri, infuocati lidi. E quale delle musiche tradizionali migliore di quella del diavolo? Quello
triturata dalla nuova formazione è un blues malato,
dissonante e a tutto volume che si rifà a quello di
gruppi come Birthday Party o Scratch Acid.
Di nuovo e ancora: non musica per educande, ma per
gente devota al culto del rumore.
1000 Doses Of Love (Wide, 2000) non soffre di “sindromi da secondo disco” e vira verso un
loud-rock deturpato secondo la legge non scritta
della rielaborazione (ovviamente in chiave noise)
della tradizione rock e blues (Jinx e Tupelo, per
fare due nomi italiani, giravano intorno alla stessa
idea di fondo). I volumi in saturazione sembrano
calare, le atmosfere ferine placarsi. Ma è un bluff,
DROP OUT
41
one dimensional man
anzi una impressione superficiale derivante dal fatto che per la prima volta ODM usano uno studio
vero. La musica continua a sputare fulmini e saette
dopo aver bevuto veleno (come suggerisce Drink
The Poison), anche quando si cerca di realizzare un
concept sulla “storia di un amore che muore”. La
title track è uno stop’n’go tagliente, Tom svisa quasi
di funk elettrico, My Ship è uno scivolare di slide
continuo in omaggio ai padrini Jesus Lizard, Annalisa! e Louis sono possedute dagli stessi demoni
che devastavano il giovane Nick Cave quando si
dilettava coi Birthday Party. Insomma, più che
una catastrofe amorosa esce fuori una catastrofica
rendition blues-core annegata in ironia e sputi punk.
Condizione che si ripete, giungendo alla definitiva
maturazione, in You Kill Me (Gammapop, 2001).
Il trio è ormai rodato da una attività live incessante, borderline e punk al midollo. L’interplay
ormai, non è un segreto, funziona a meraviglia e i
14 pezzi dell’album scivolano sul crinale di un noise’n’roll blueseggiante. Capovilla è ormai un frontman carismatico e un cantante maturo, tanto (ehm)
semi-lucido su disco quanto ferino e fuoriditesta sul
palco. Teatralità è il termine col quale si è tentati di
definire la maturità espressiva del trio e che, guarda
caso, tornerà in tempi futuri: Saint Roy è uno scioglilingua da ottovolante, I Can’t Find Anymore guarda
42
DROP OUT
all’Inghilterra degli XTC, This Man In Me è seduta
psicanalitica pubblica, Sad Song uno psicotico boogie’n’roll alla Jon Spencer dei tempi Cryptici, la
title track rievoca l’accoppiata Brecht-Weill.
Take Me Away (Ghost Records/Midfinger
Records, 2004) giunge dopo un paio d’anni ed è, a
tutt’oggi, l’ultima manifestazione conosciuta del trio.
La chiusa della parabola, non necessariamente discendente. Quelle dell’album sono infatti canzoni, a
pieno titolo, melodiche, pop in modalità power- e/o
noise-, cacciate fuori dal solito armadio ma rivestite di una sensibilità nuova. Metà esperienza, metà
freschezza. Un bel respiro, una bella soffiata e via,
tutto il catrame-core che ha per anni ricoperto le
melodie se ne va, lasciando il posto a semplicità e
linearità.
Manca ancora un qualcosa però. Un piccolo scarto. Quella barriera sempre più sottile che ci divide
dal “rock”: la lingua.
Piccola postilla alla fase ODM. Prima della messa
in pausa del progetto fa la sua comparsa un giovane
batterista, Francesco Valente, in luogo del dimissionario Dario Perissutti. Un pischello sbarbato che
sarà elemento cardine di ciò che è lì lì per venire.
Come un gesù lucertola che si redime ogni volta
mutando la propria pelle, è infatti tempo ormai di
affrontare l’ultima, decisiva trasformazione.
…e
infine , quella del
cantautorato rumoroso …
Per comprendere appieno la “svolta cantautorale”
degli ormai ex One Dimensional Man – sebbene sia
più corretto parlare di evoluzione che di svolta –
bisogna risalire sull’ottovolante e ritornare ancora
più indietro, a una decina d’anni fa. “Io credo che il
r’n’r non sia il regno dell’originalità, ma della tradizione”,
affermava Pierpaolo Capovilla in una vecchia intervista, dichiarazione che ora, col Teatro Degli Orrori
sul ciglio del secondo disco, acquista un senso ulteriore.
Aiuta cioè a rielaborare l’idea critica su un disco
e una band che condensa alla perfezione tradizione
musical-letteraria (in una parola, cantautorale) italiana e crudezza di suoni pur sempre riconducibili
ad una tradizionale idea di rock che dal blues arriva
alle sue più cacofoniche deformazioni.
Il cerchio è chiuso, insomma. Nulla si crea nel
mondo del rock, ma tutto si trasforma. E se dal punto di vista strumentale questo assioma è facilmente
rintracciabile in una mistura potente e letale che abbonda in ricercate citazioni e prestiti dalla tradizione
noise-blues-rock, è nelle liriche che la “tradizione”
tanto agognata si manifesta. E in Italia, per certe musiche di denuncia o impegnate, la tradizione è quella
che cova nel retroterra cantautorale più off e engagé,
e che si manifesta sotto forma di una ricerca letteraria profonda. Roba che, però, i quattro applicano ad
un suono furibondo e devastante figlio di tradizioni
d’oltreoceano, che scuote l’ascoltatore ad ogni parola pronunciata e/o urlata con la consueta teatralità
da Pierpaolo Capovilla. Chiamata alle armi (Carrarmatorock), rifiuto della guerra (Compagna Teresa), elogio
della memoria (L’Impero Delle Tenebre) che sia, la certezza è una sola. Il Teatro – e il suo paroliere, come
definirlo altrimenti? – gestisce ormai alla grande il
background letterario che da sempre (Celine e Borroughs citava Capovilla come ispirazioni all’altezza di
You Kill Me) ne contraddistingue il portato extramusicale: dall’Artaud che è fonte di ispirazione per il
nome al Truman Capote che segna il comeback con
la sua opera più forte e compromettente, passando
per il lirismo contro di De Andrè (troppo sputtanato
ultimamente, ma non è questo ovviamente il caso…),
sempre punto di riferimento ideale nella galassia delle influenze di Capovilla. Altri nomi tutelari emergono di prepotenza accanto al poeta ligure: Carmelo
Bene, innanzitutto, per quella carica anarcoide e sovversiva che il frontman ha ben adattato all’iconografia
classica del reietto-rock che un David Yow a caso ben
rappresenta. Oppure quel Gaber metà attore, metà
cantante (e nell’interezza, grillo parlante per una società apatica e finto-perbenista) nell’avanguardistico
teatro-canzone rintracciabile un po’ ovunque nella
forma mentis del Teatro.
Il muoversi sul terreno della lingua italiana presuppone perciò in seno alla traiettoria ODM/Teatro una maggiore e più diretta comunicatività; o
viceversa, la necessità di “impegno civile”, di “resistenza attiva” del nuovo progetto ha bisogno di un
qualcosa che limi la distanza con la lingua rock per
antonomasia, che superi gli ostacoli che per forza di
cose vi si frappongono, plasmando quel messaggio
su un terreno loud-rock derivativo ma mai banale.
Uno scarto fondamentale, che fa di quel disco, e di
conseguenza anche di tutto il progetto, un qualcosa
di estremamente politico. La musica come arma di
risveglio di massa. Lo stridore del rock come sirena
d’allarme sulle coscienze assopite. Le parole come
fermacarte sull’oblio della memoria.
Ora, a distanza di due anni certamente non inoperosi (live praticamente senza soste, l’inedito Refusenil nel manifesto post-Sanremo accroccato dagli
Afterhours, Il Paese È Reale, l’ottimo 10” split
coi romani Zu) è in dirittura d’arrivo un nuovo
album, l’ennesimo passo in avanti che i quattro ci
hanno riservato. Magari più apparentemente accessibile, ma non per questo meno criptico e denso.
O forse, altrettanto incompromissorio e feroce, ma
sempre inserito in quell’humus cantautorale che ne
impregnava l’esordio. Abbiamo perciò deciso di fare
due chiacchiere con Giulio Ragno Favero, bassista e
produttore del quartetto veneto.
DROP OUT
43
Che cosa avete fatto in questi due anni?
Di tutto un po’, 130 date più meno in tutta Italia,
scritto brani nuovi, lavorato ad altri progetti (Zu,
Super Elastic Bubble Plastic) e lavorato al disco nuovo. Più o meno le stesse cose che fanno tutti
i gruppi, con l’aggravante che comunque dobbiamo
come tutti pagare le bollette, per cui ci siamo fatti
un bel mazzo tra suonare e lavorare…insomma, le
cosiddette “solite cose”…
Due anni, in tempi di accelerazione discografica come gli attuali, possono sembrare una eternità…cos’è, ansia da comeback?
La tua o la nostra? Nel senso sono passati due anni
in cui abbiamo fatto il possibile. La promozione del
vecchio disco, un bel po’ di concerti, abbiamo scritto
il disco nuovo, non credo si riescano a fare troppe
cose contemporaneamente. E non vivendo di sola
musica, il tempo che rimane è quel che è…e poi
francamente a noi, dell’accelerazione discografica,
non ce ne frega molto…cioè ci siamo presi il tempo
44
DROP OUT
necessario per fare bene le cose, e per quanto mi
riguarda, non è nemmeno stato abbastanza.
Del nuovo si sa poco: il titolo innanzitutto A Sangue Freddo, poi gli ospiti (Giovanni Ferliga, Nicola Manzan, Jacopo Battaglia), alcune caratteristiche tecniche
(dove e come è stato registrato e mixato)
e poco altro… ci vuoi suggerire qualcosa?
Abbiamo registrato alle Officine Meccaniche di Milano, nella sala A, che è una delle sale di registrazione più belle d’Italia, che da la possibilità di fare delle
riprese in diretta di ottima qualità. Volevamo registrare tutto in analogico, con solo qualche add in
digitale, poi le cose però non sono andate così lisce
come speravamo, e quindi abbiamo optato per un
ibrido: le batterie e il basso sono su nastro e tutto
il resto in digitale: i due sistemi sono linkati assieme,
permettendo così di mantenere le ritmiche “vive”
su nastro, e avere un editing più preciso su voce
e chitarre. Per quanto riguarda gli ospiti, abbiamo
chiamato i nostri amici di sempre, a fare qualche
apparizione qua e là: c’è un pezzo in cui Jacopo degli
Zu suona la batteria assieme a Franz, in cui i fratelli
Tiso suonano cristallofono e basso, il primo pezzo
del disco, Io ti aspetto, vede la collaborazione in fase
di scrittura di Paola Segnana, che suona il piano
Abbiamo cercato di fare un disco più poliedrico dell’altro, con più soluzioni, dall’elettronica alla
classica, al rumore. Quello che suoniamo è quello
che vogliamo suonare: per dirtene una, un pezzo
che non ci piaceva com’era venuto, l’abbiamo fatto
remixare a Bob Rifo, mente e mannaia dei Bloody Beetroots oltre che amico di vecchia data,
che ha dato al pezzo una vena quasi dance-electro,
mantenendo comunque l’idea di fondo. Il pezzo si
allontana moltissimo dall’idea che la gente ha di noi,
e questo ci piace perché non crediamo molto nei
generi ma nelle persone, il resto è fuffa, o come mi
suggeriscono, noia! Comunque quello che vi dovete aspettare, è un
disco nuovo del Teatro Degli Orrori. Di sicuro è
meno graffiante dal punto di vista sonoro: ha meno
impatto e come dire, ci sono meno pezzi “cattivi”. Questo forse farà storcere il naso ai nostri fan
più metallari e incazzosi, ma fondamentalmente io
e Paolo siamo un arrivati a un punto di svolta: chi
vede il teatro solo come una italiana copia di Jesus
Lizard o Melvins, si dovrà ricredere perché noi
ascoltiamo moltissima altra musica. Io e Pierpaolo di
dischi noise che aprono culi e orecchie ne abbiamo
fatti almeno 5 per cui, se il tiro cambia un po’, siamo solo che contenti. Con questo non voglio dire
che abbiamo fatto un disco pop, ma sicuramente è
accessibile a un pubblico più ampio. Poi per carità
chi ha voglia di farsi del male alle orecchie venga a
vederci dal vivo, di sicuro troverà quello che cerca.
Dell’Impero Delle Tenebre colpiva per il
potenziale strumentale ma soprattutto per i rimandi letterari. A Sangue Freddo, sin dal titolo, non sembra essere da
meno. Cosa ci ha riservato Pierpaolo e
le sue liriche? È sempre lui a occuparsi
dell’aspetto letterario del Teatro?
La voce del gruppo è sicuramente sempre lui. Direi
che in questo disco le tematiche affrontate si sono
ampliate: è un disco molto più diretto e politico del
precedente, con nomi e cognomi, e indici puntati verso persone e situazioni che rendono questo mondo
uno dei mondi peggiori di sempre, in cui razzismo,
ignoranza, disonestà intellettuale e una quantomeno
sbalorditiva apatia nei confronti dei soprusi ricevuti
super el astic bubble pl astic
e inflitti, regnano sovrane. Si parla di immigrazione,
speculazione ecologica ai danni di comunità inermi,
di degrado culturale, di uxoricidio. Insomma, come
dicono a Milano, “è bello spèsso”. Altra cosa che abbiamo deciso di fare è che oltre a parlare di determinati argomenti, abbiamo deciso di “fare” qualcosa,
supportando “A_SUD”, un’associazione indipendente nata per affiancare i movimenti sociali e indigeni
del Sud del mondo attraverso la costruzione di ponti
di comprensione, reciproco sostegno e solidarietà:
metà dei proventi della vendita del singolo di A Sangue Freddo su iTunes, andranno a questa associazione.
Non si può rimanere inermi a guardare il mondo che
va allo sfascio, senza nemmeno tentare di rendere le
cose un po’ più facili a chi soffre sul serio, non perché
è stato lasciato dalla ragazza o ha perso il cellulare, o
perché non l’hanno accettato al “grande fratello”. Nel
disco si parla anche di amore, come mezzo narrativo
per raccontare altre storie: alla base della vita di ogni
persona o quasi c’è la convivenza diretta con persone che si amano e che sono molto spesso quelle che
vengono meno considerate: l’amore non è fatto solo
di baci e carezze o liti e divorzi, ma anche di situazioni di stallo in cui, per mille motivi, si convive senza
più parlarsi, capirsi e osservarsi, come in un limbo di
desolazione.
DROP OUT
45
© MarkusSottoCorona
Vuoi presentarci la tracklist del nuovo album? Non so, qualche aneddoto, qualche
curiosità...
Per quanto riguarda aneddoti e curiosità non saprei
bene cosa raccontarti…non è successo granché se
non che abbiamo lavorato incessantemente per più
di trenta giorni, almeno 10 ore al giorno, e ancora ce ne sarebbero volute. Ne è uscito un disco
diverso dal precedente, più intenso e musicato e
sicuramente più profondo e meno derivativo. E poi
scusa, ma dove lo trovate un gruppo che mette in
musica “il padre nostro”??? Mi sembra una ragione
sufficiente, visto che non siamo un gruppo “White
rock” e nemmeno il Gen Rosso…
Il Teatro è un punto di riferimento ormai
consolidato, come dimostrano le date
sold out a distanza di 2 anni dall’uscita
del disco. Come vivete questo ruolo di
trait d’union tra un passato carbonaro e
appassionato (pensiamo a ODM) e questo doveroso riconoscimento (anche) del
pubblico?
L'aspetto più bello dell'affluenza di massa ai nostri
concerti, è l'amore per quello che facciamo. Difficilmente qualcuno se ne va insoddisfatto e anche
perché sa esattamente cosa troverà: quattro matti
46
DROP OUT
che ci danno a più non posso, al 101%. E questo
facendo un gran baccano, non certo finta di essere
qualcun’altro o accontentando i rilevatori di decibels. C’è di bello che il pubblico partecipa in prima
persona, cantando i pezzi e ballando. Diamo quel
“nonsoche” che si è perso negl’ultimi anni, suonando rock, come lo abbiamo visto fare ai nostri eroi,
e cioè non sculettando e ammiccando, ma mettendoci anima, ossa, sangue e sudore. La gente lo adora,
perché ormai è praticamente subissata da playbacks
e falsi artisti. Poi l’italiano conta. Chi ti sta guardando negl’occhi durante il concerto capisce che quello
che stai dicendo, lo stai pensando, e non recitando.
Paolo parla dritto al cuore e senza fronzoli. La gente
apprezza la “veridicità”: si vede che siamo gente comune, che lavora 40 ore a settimana, da anni e che
suona per passione, e urgenza emotiva.
Sulle tue capacità in cabina di regia non ci
sono dubbi, e non a caso sei tu il produttore di A Sangue Freddo. Si parla di scelta
analogica, vintage alla moda o ricerca di
un suono più caldo, umano, passionale e
appassionato?
L’analogico suona meglio. Fine. Suona retorico e non
ho voglia di spiegare perché. Ognuno dovrebbe fare
un percorso e uno studio. Certo, il digitale aiuta, è
© Daniele Bianchi
comodo ed economico ma non ha nulla a che vedere con l’espressività e la qualità.A tutt’ora il formato
digitale migliore al mondo, ancora non utilizzato in
modo “popolare”, è il DSD o SuperAudioCD, superiore in qualità e profondità al cd, non è nemmeno
paragonabile col suo fratello analogico, ovvero il nastro stereo da mezzo pollice. Il nastro Suona. Il DSD
si sente bene. Al contrario del digitale l’analogico
invita all’ascolto, il digitale stanca per mancanza di
espressione. Sono solo numeri non onde. E tra le
onde e i numeri c’è una bella differenza…
Di Dell’Impero Delle Tenebre mi colpì ovviamente l’eccellente perizia strumentale e la forza trainante delle liriche. Ma
c’era a segnare quel disco anche lo spessore dei suoni, una grana americana...
Di certo quella produzione risente dei nostri gusti.
Dell’Impero Delle Tenebre suona più come un
disco di One Dimensional Man che come un disco
del Teatro degli Orrori, per il semplice fatto che da
qualcosa bisogna pur partire. Abbiamo messo su
disco quello che siamo dal vivo, ruvidi e granitici.
L'americanità deriva dalla mia vicinanza a band che
cercavano quel tipo di suoni che, per dirla breve,
sono anche quelli che di solito escono dagl’amplificatori, se uno usasse un po’ le orecchie. La produzione di A Sangue Freddo è sicuramente più
omogenea. La grana americana poi non mi interessa
più, preferisco gli inglesi.
L’esperienza ODM è stata fondamentale per il Teatro, mi sembra di notare una
sottile linea rossa, un percorso giunto a
compimento.
è un'evoluzione possibile, non l’unica, anche perché
gli ODM non sono ancora sciolti. Possibile che in
futuro avremo un nuovo One Dimensional Man che
suona come quello del Teatro. Anche se per il futuro speriamo di fare cose diverse, tipo un disco in
inglese. Oppure da camera. Mi piace pensare che
quello che facciamo sia quello che siamo e - grazie
a dio, o al demonio - non siamo a una dimensione.
La specializzazione è una cosa da insetti: un uomo
dovrebbe essere in grado di fare qualsiasi cosa, diceva un tizio…
DROP OUT
47
Recensioni::::ottobre::
►►►►
7 Worlds Collide - The Sun Come
Out (Columbia Records, Settembre
2009)
G enere : pop rock
7 Worlds Collide atto secondo. A distanza di
otto anni dal precedente che era un live, la compagnia messa in piedi da Neil Finn ritorna con
un doppio album in studio, che accanto ai nomi già
presenti allora (Johnny Marr, Ed O’Brien, Phil
Selway, Lisa Germano…) presenta una serie di
new entry, che vanno dai Wilco a KT Tunstall
e Liam Finn.
Il cuore del gruppo è sempre il neozelandese Finn,
artefice anche in proprio,
oltre che con gli storici Crowded House
di un artigianato pop di
alto livello. Qui coordina
e compartecipa, riuscendo a mantenere uno
standard di qualità e un
amalgama anche con i
nuovi entrati. Una messe di pezzi, che vedono tra gli
altri Jeff Tweedy e Johnny Marr in mood beatlesiano, anzi harrisoniano (You Never Know, Run In
The Dust), Finn tra R.E.M. e jingle jangle (All Comedians) e pop d’autore mostrando nel complesso una
buona tenuta a fronte di una certa lunghezza. Con
l’unica eccezione di Lisa Germano, che rispolvera la sua Reptile svogliatamente e senza mordente.
Proventi in beneficenza.(7/10)
Teresa Greco
?Alos - ricamatrici (Bar La Muerte,
Ottobre 2009)
G enere : A vant -R ock
Dopo la parentesi culinaria di Ricordi indelebili, sfociata nelle numerose performance che hanno visto
protagonista (ai fornelli) Stefania Pedretti sui palchi di mezza penisola, ?ALOS, alterego psicotico
della enigmatica artista lombarda, imbastisce una
sorta di concept-album sul taglio e cucito. Attività
ordinaria che si trasfigura, come sempre da queste
48
recensioni
parti, in esperienza surreale e, esercizio di socialità
i cui gesti e comportamenti altamente standardizzati si trasformano negli elementi primari di un universo autarchico e inclusivo fruibile solo da pochi
(selezionati) intimi. Ci si ritrova così catapultati in
situazioni e ambienti da teatro dell'assurdo, tra autistiche nenie alla Diamanda Galás (Ricami, Punto
Lacrima), deliziosi stacchetti da pianobar oltretombale (Un Giorno), ritratti sonori a pennellate ampie
di scenari post-atomici (Tulle) o, viceversa, di luoghi
confortevoli e familiari che tutto hanno perso in fatto di affabilità e calore umano.
Gli oggetti ordinari, le cui familiari movenze appaiono decontestualizzate nei deliziosi quadretti sonori che si alternano agli episodi più lunghi, finiscono
così per essere i veri protagonisti di un disco - di
una carriera artistica - che è un inno (stonato) alla
bellezza nascosta delle piccole cose.(6.3/10)
Vincenzo Santarcangelo
A.A. Bondy - When the devil's loose
(Fat Possum, Ottobre 2009)
G enere : (M is sis sipi ) F olk -R ock
August Arthur Bondy, insieme a talaltri quali Justin
Townes Earle, J. Tillman, Sam Amidon,
Phosporescent, Little Wings, appartiene a
quella generazione di musicisti che sono comparsi quando Will Oldham era già Bonnie “Prince”
Billy. Esordiva con American hearts, dopo lo scioglimento dei suoi Verbena (Dave Grohl produsse il
loro debutto nel 1999) facendosi portavoce di un
revival dylaniano della desolazione e ora tasferitosi
nel Mississipi, dopo una parentesi a New York, tenta
nuovamente la ricostruzione di un gruppo.
Registrato nella Water Valley, con l'intenzione di documentare il Sud, e richiamandosi al Mississipi come
vocazione, Bondy riprende il crooning dal fronte
senza manco sfiorare il South di Carson McCullers o Flannery O'Connor, quello di Richard
Buckner di The Hill. La sua Water Valley, a confronto con questi luoghi spettrali somiglia a Miami! Per uno strano scherzo del caso la sua voce ha qualcosa di Will Oldham, ma il songwriting è piatto
highlight
AA. VV. - Hyperdub 5: Five Years Of Hyperdub (Hyperdub Records,
Ottobre 2009)
G enere : compil ation dubstep ambientronica wonky
Sarà anche spocchioso con il suo nascondersi alla stampa, ma Kode 9 è indiscutibilmente un
talent scout e un produttore di valore. La sua Hyperdub è una delle etichette che ha contribuito
a diffondere il verbo dubstep e la sua mutazione wonky. E son già 5 anni che il nostro buon vecchio DJ cavalca l'onda. In questo doppio discone c'è un riassunto di tutto quello che è successo:
dalle paludi nere del dubstep (Burial e lo stesso Kode 9 con il suo
inno 9 Samurai) alle sale giochi del wonky-techno (Megadrive Generation di Martyn) o 8 bit (l'ormai imprescindibile Zomby o la nuova
leva Joker) che dir si voglia, dal ragga di The Bug (bello il feat. di
Warrior Queen su Money Honey) agli innesti post-tutto di Flying
Lotus (Disco Balls). E poi ancora l'ambient di King Midas Sound, il
post-banghra di Rustie nell'ormai classico Spliff Dub per Zomby e le
visioni acide di Quarta 330.
Riassumere in 30 tracce la scossa che stiamo ancora subendo non è
facile. In poco più di due ore ci si può fare un'idea di cosa si balla a East London ai party più nerd
del pianeta. Che sia poi una subcultura underground, chissenefrega. A noi piace così e anche se
non siamo lì fisicamente, grazie a questi documenti possiamo fare il punto della situazione e seguire l'onda. Keep on running, Hyperdub!(7.5/10)
Marco Braggion
e univoco e l'insieme del disco passatista e privo di
spunti interessanti.(5/10)
Salvatore Borrelli
AA. VV. - Rocksteady: The Roots Of
Reggae (Moll-Selekta, Settembre
2009)
G enere : rocksteady
Una storia un poco alla Buena Vista Social Club, quella
dietro il presente disco: Stascha Bader è un regista svizzero laureatosi in musica giamaicana che in
testa s’è messo l’idea meravigliosa di girare una pellicola sulla stagione fondamentale di passaggio tra
ska e reggae. Ovvero quel rocksteady che, complice
un’estate più torrida dell’usuale, finiva per rallentare
la frenetica battuta in levare mantenendo salde le
radici e l’influenza del rhythm & blues, nel frattempo allargando le tematiche dei testi al commento
sociale.Il peggiorare delle condizioni economiche
sull’isola e la coeva visita di Haile Selassie avrebbero poco dopo aumentato la coscienza in chiave
“roots” e condotto - tramite un secondo, più drastico rallentamento ritmico - al reggae.
Correva la seconda metà degli anni ’60, e la cosiddetta “class of 66-68” si è ritrovata quasi al completo nell’aprile del 2008 in uno studio di Kingston
a rileggere classici conclamati del genere intanto
che la cinepresa immortalava l’avvenimento. In attesa di poter un domani gustare le immagini, vede
la luce la relativa colonna sonora con i brani regirecensioni
49
strati sotto la supervisione di Ernest Ranglin e
gli arrangiamenti curati da Lynn Taitt. Quindici
canzoni che è scontato definire “storiche” e un’ora
di festa, da U-Roy che va di scioglilingua su Stop
That Train alle arcinote e giammai usurate You Don't
Love Me (No, No, No) e Rivers Of Babylon (rispettivamente: Dawn Penn e, per l’occasione, Hopeton
Lewis). Marcia Griffiths si riappropria di
quella Tide Is High che i
più ricorderanno successone dei Blondie e
ancora Lewis ci ricorda
che è una questione di
Sounds & Pressure.
Un piacere, poi, ritrovare
Ken Boothe in ottima
forma su Freedom Street e Shanty Town (007) e lo
stesso valga per Leroy Sibbles, alle prese con
la programmatica People Rocksteady e l’impegnata
Equal Rights. Roba che rende la più grigia delle giornate un rutilante caleidoscopio fin dai tempi in cui
apparve per la prima volta, figuriamoci oggi. Che,
nello specifico dell’operazione, lascia ammirati e
commossi.(7.2/10)
Giancarlo Turra
AA. VV. - I/D/V 01-I/D/V 02 (Unframed,
Maggio 2009)
G enere : drones
Due volumi, per la precisione due 7”, particolarmente curati per formato ed in edizione limitata. A
I/D/V 01 le sequenze più droniche, i microtoni e
i rumorismi, mentre a I/D/V 02 i barlumi d’elettroacustica.
Il tutto dato in pasto a dodici artisti, tre tracce per
ognuno e un paio di giradischi o una chitarra (dodici corde, acusita o elettrica) come unici strumenti
permessi. Annette Krebs, DIEB13, Giuseppe
Ielasi, e Koen Holtkamp i nomi più noti tra
quelli coninvolti e agli ultimi due sicuramente il meriti maggiori.
La soluzione all'estremità la trova Koen Holtkamp nella selezione di corde o Giuseppe
Ielasi nella sua dialettica di precisione tra nuance
elettroniche e pizzicato.
Tutto sta nel controllo, nel'approccio e nella conoscenza dello strumento ma nonostante queste poche astute prove d'elettroacustica il limite dell'operazione c'è e viene da sé: nel solo minuto concesso
a ogni traccia (e due di silenzio) e nel risultato che
50
recensioni
non può che soffire di una certa disorganicità e peggio casualità. D'accordo il concetto, ma ci vuole anche un po' di sostanza.(5.5/10)
Sara Bracco
AA. VV. - Warp 20 (Chosen) (Warp
Records, Ottobre 2009)
G enere : compil ation W arp
Per celebrare l'anniversario della label di Sheffield, i
capocchia hanno fatto le cose in grande. Nuovo sito,
nuovo negozio, nuova compilation. Ma cosa metterci
dentro? Invece d'optare per una compilazione dall'alto, si lascia decidere al popolo dei fan tramite il sito:
venticinque tracce per descrivere vent'anni d'attività.
Nella scatola i nomi classici a farla da padrone.
La trasfigurazione pop-soul (in chip e cuts) che da
solo potrebbe descrivere tutta l'attività Warp è
Windowlicker di Aphex Twin; poi c'è la mitologia
evil UFO dei Boards Of Canada (Roygbiv), l'incursione nel math-rock
dei recenti Battles
(Atlas), il bbreaking del
primo Squarepusher
(My Red Hot Car), la bleep and bass degli LFO
(nell'omonimo e per chi
scrive storico Leeds Warehouse Mix), il melo dei
Plaid (Eyen), lo houmor
kitch Kraftwerk virato aceeed della I Love Acid di
Luke Vibert, lo sfoggio hypertechno dei sempre
affascinanti snob Autechre (Gantz Graf), le bombe contro il rock dei !!! (Me And Giuliani Down By The
School Yard) e tanto altro.
Non sarà completa, magari a qualcuno non va giù
la scaletta, ma su un catalogo sterminato, bisognava
pur tagliare. E a noi sembra che l'idea di far scegliere
ai fan abbia premiato. Ah, non avevamo detto che di
compilation ce n'è pure un'altra, Warp 20 (Recreated)(7.5/10)
Marco Braggion
AA. VV. - Warp 20 (Recreated) (Warp
Records, Ottobre 2009)
G enere : compil ation remix W arp
Se con la scelta dei fan - nella compilation parallela
Warp 20 (Chosen) - i guru della Warp non si erano
più di tanto sbizzarriti, con quest'altra doppia provano a fare il botto. Chiamano una rappresentanza
più o meno giovane dal roaster e raccolgono dei
remix di pezzi del canone del suono electro inglese.
Operazione riuscita? Solo in parte, anche se l'idea
non è poi così peregrina. In fondo, ricostruire tutte
le facce del suono Warp è impresa ostica e perfettibile ad libitum.
Il limite è quindi insito nella compila, che va dal jazzfunk di Jimi Tenor al rock dei Maxïmo Park,
dal bel wonky di Rustie al bbreaking di Luke Vibert (che rifà in slo-mo l'inno LFO e con semplicità
ci apre una porta sull'origine della techno inglese),
dal d'n'b tiratissimo di Clark all'ambient di Mark
Pritchard, dal post dei Seefeel al folk di Bibio.
E altri ancora... Per i novizi un onore, per i vecchietti
un riconoscimento. Per i fan uno sfizio, per tutti gli
altri una curiosità.(6.5/10)
Marco Braggion
AA.VV. - Eric Clapton Salute: I Feel
Free (BHP Music, Giugno 2009)
G enere : bogus rock
Su Eric Clapton andrebbe infine fatta chiarezza: eterno santino per legioni di chitarristi della domenica
e improvvisati rokkettari provinciali, “manolenta”
ha dato il meglio con i Bluesbreakers, gli Yardbirds e Derek & The Dominoes. Già i Cream ponevano problemi: bravini quando si davano
alle canzoni stringate sbiancando il blues, restavano
al palo con le loro interminabili tirate strumentali
che annunciavano il prog. Volergli male fino in fondo
dunque non si può, ma il loro ruolo nelle enciclopedie del rock è da ridimensionare.
Degli inverecondi Blind Faith meglio non parlare,
e quanto al Clapton dei ’70, al pari di altri figure
coeve incarna per chi scrive quell’autocompiaciuto,
retrivo soft rock che il punk avrebbe giustamente
massacrato. Eppure, a fronte di un triste bagaglio di
sventure umane, finisce che dare addosso a costui è
come parlar male di Madre Teresa. Quando però il
business lo introduce tre volte nella “Rock And Roll
Hall Of Fame”, qualcosa di storto deve esserci; idem
se “Rolling Stone“ lo piazza quarto dei “100 Migliori
Chitarristi Di Sempre” e qualcuno gli tributa omaggi
come questo.
Che secondo logica è una prevedibile parata di virtuosi hi-fi tutti tecnica e zero comunicativa. Salvi
giusto un BB King del ’63 alle prese con How Blue
Can You Get, bonus track inserita per mostrare una
delle radici del suono claptoniano. Il resto sono immonde seghe di gentaglia da mettere al muro per
l’idea di musica che porta avanti. Che vita di m***a.
(2/10)
Giancarlo Turra
Air - Love 2 (EMI, Ottobre 2009)
G enere : electro pop
Quinto album per la (giustamente) premiata ditta
Godin & Dunckel, a quasi tre lustri da quegli esordi poi raccolti nel mai abbastanza celebrato Premiers Symptômes. Raccolta che vale la pena di
citare quale pietra di paragone con questo Love 2,
perché se gli elementi in gioco e la calligrafia denunciano una sostanziale continuità (al netto degli inevitabili assestamenti e sviluppi), è il mood, il respiro,
l'effetto che segna la differenza sostanziale. Se nei
primi lavori targati Air letteralmente ti perdevi, finivi
assorbito nel loro ventre amniotico fatto di nostalgie valvolari e vibrazioni terra-aria, in quel gioco di
memorie suadenti che stemperavano i limiti scodellandoti possibilità cosmiche tra le danze soffuse,
l'ultima fatica sembra invece una stanza dei giochi
anzi un "tappeto attività" come quello per i pargoli,
coi campanellini, gli anelli, gli ssqueak, gli specchietti,
le superfici ruvide e quelle soffici...
Ti ritrovi insomma in una zona franca ben delimitata, nella quale non avviene mai quella "sospensione
della finitezza" che invece per incanto pervadeva i
primi sintomi e gran parte del Moon Safari. E
dunque? Il buon artigianato con tanto di marchio di
fabbrica quale decorso ineluttabile dell'arte, che nel
tempo e col tempo esaurisce le scorte di poesia?
Sì, forse. In fin dei conti, ci
può stare. Ci si può stare.
I qui presenti undici pezzi compongono difatti e
comunque un buon passatempo per superfanciulli evoluti, a partire dal
singolo Sing Sang Sung che lalleggia docile come dei
Beatles neutralizzati da raggi gamma Lio, proseguendo poi tra languori esotici e febbrili, tra mischie
capricciose dove indovini i profili di Moroder e
Gainsbourg (Heaven's Light), per poi bazzicare
certi tribal funk che recuperano didascalizzandola
la lezione dei Talking Heads altezza Fear Of
Music (Night Hunter) e quindi rendere omaggio alla
vis cinematica del Jarre di Blade Runner (Tropical Disease, You Can Tell It To Everybody).
A rendere prezioso il manufatto contribuisce la versatilità della scaletta, nelle cui svolte conserva lucidità e arguzia, vedi con quale brillantezza passa dal
surf trasfigurato space-glam di Be A Bee (figuratevi
dei Daft Punk materializzati sul set di Tarantino
in una nebbiolina Visage) al passo funk vischioso,
recensioni
51
robotico e volatile di Missing The Light Of The Day
(che ci annusi evidenti influssi Japan), per poi svoltare dalle parti di un soul torrido e svampito tutto
synth e wah wah, essenziale sì ma deliziosamente
appiccicoso (So Light Is Her Footfall). Così, evitando
programmaticamente di cimentarsi in un disco epocale - eventualità sempre meno attuale, preso atto
della progressiva obsolescenza del concetto stesso
di album - gli Air ci consegnano un disco adattissimo
alla nostra epoca di adulti giocherelloni. Disperatamente votati ad ingannare il tempo e se stessi. Anche questa è (può essere) arte. No?(6.4/10)
Stefano Solventi
Albanopower - Maria's Day (42,
Maggio 2009)
G enere : indie psych - pop
Li abbiamo visti dal vivo a Ypsigrock 2009 e, vista
la performance, non ci poteva essere presentazione
migliore. Con consapevole colpevole ritardo andiamo adesso a recuperare il loro esordio su LP.
Gli Albanopower sono siciliani, di Siracusa, e
fanno praticamente pop psichedelico. Per declinare questo 'psichedelico' ci mettono dentro intrecci
chitarristici tra il ricordo folk e il post, certa new
wave (nel senso degli accordini funky) e certi modi
propriamente indie di trattare la forma canzone (c'è
forse qualcosina degli Yuppie Flu). Il tutto su una
solida base pop, con tutto quello che questo termine
si porta dietro quando si tratta di roba buona: solidità strutturale e cura dell'arrangiamento. La loro
vena melodica è sorprendentemente fresca (e Old
Tv per un nanosecondo ricorda Basket Case), forte
di influssi addirittura fifties (e vedii i fischiettii e i
battimani). Vena vivace ma non allegra a tutti i costi,
impregnata anzi di una melanconia che loro definiscono natalizia (e vedi la sinistra Santa's Elves), ma
che noi troviamo perfetta come settembrina: estate
che finisce e tramonti color miele e arancio.
Goiellino assoluto Merry Christmas Darling, un singolo come ne vorremmo sentire più spesso, con
quell'apertura dell'inciso da lacrime & sorrisi. Un
paio di riempitivi, quindi, glieli si perdonano alla
grande. Uno degli esordi italiani del 2009.(7.2/10)
Gabriele Marino
Alice In Chains - Black Gives Way
to Blue (Virgin, Ottobre 2009)
G enere : P ost -G runge
Bastano le prime strofe di All Secrets Known per saggiare il polso del ritorno dei Chains (Hope, / A new
52
recensioni
beginning / Time, / Time to start living / Like just before
we died), gruppo con gli “attributi” e branco di dive
riluttanti (o paranoiche) allora come oggi. E ci vuole
fegato per tornare dopo quattordici anni senza Layne Staley. Black gives
way to blue segna un
come back monolitico,
che concede alla melodia
la solita distanza e che
non ha nessuna intenzione di suonare grunge. E
tanta sicumera funziona,
anche per un William
Duvall chiamato a sostituire il compianto frontman
e messo a proprio agio da Jerry Cantrell che intrecciando le voci ha così amalgamato un sound credibile. E dietro il lungo silenzio si è anche mosso
qualcosa: A Looking In View è un mastondote di oltre
sette minuti farcito di un rifferama claustrofobico e
inseguimenti vocali. Un album per fan, ma anche una
tracklist rock fatta come si deve.(7.3/10)
Nicolas Campagnari
Amanda Blank - I Love You
(Downtown, Ottobre 2009)
G enere : H ip H op - E lectrocl ash
Messasi in luce rappando ospite nei dischi del giro
di Spank Rock e dintorni e finita persino in un
remix di Britney Spears, la rapper di Philadelphia giunge all'esordio solista chiamando dietro la
consolle gli amici Diplo & Switch, Dave Sitek
dei TV On The Radio e XXXchange dei suddetti Spank.
Come prevedibile abbiamo un hip hop virato Peaches, una via di mezzo tra (o una somma di) un
gangsta e la più sfacciata delle elettroclashers (vedi
ad es. Gimme What You Got e Someting Bigger, Something Better con tanto di urletti alla Jacko) e una
romanticona (nella title-track).
Tra i pezzi in cui canta tout court (la visita agli anni
'80 della blondiana DJ o l'eterea Leaving You Behind) e
quelli in cui sciorina fluida le rime (in particolare in
Make It Take It, con bpm rock'n'roll più che hip hop)
Amanda segna i suoi punti, ma ancora siamo lontani
da una via S.U.A....(6.6/10)
Giulio Pasquali
Amari - Poweri (Riot Maker,
Ottobre 2009)
G enere : amazing disco funk
Passata la vena intimista delle Scimmie d'amore
(disco insuperabile) gli Amari raccontano la generazione X dall'angolazione più cazzona dell'electrofunk
che ha sulle spalle gli occhialoni da sole di Giorgetto
Moroder, un senso pop trash da sempre marchio
dell'estetica di casa Riotmaker e il tocco hip-hop
dell'ingombrante e pervasivo Dargen D'Amico.
Quello che viene fuori da questo Poweri è la voglia di essere gruppo. Una cosa che ultimamente si
è persa nella fighetteria next big thing indie e che gli
Amari hanno saputo far crescere spaccandosi il culo
con il live. E quindi anche se c'è una leggerezza pop
che aleggia e in qualche punto incombe, i ragazzi
sono ancora lì che sanno quello che fanno. Stavolta
si divertono.
Sempre con lo stile che li contraddistingue: bbreak
punk citazionista (Girls On Vodka), poppettino con
synth 80 (Preservativi Ovunque, Acqua di Joe) e white
funk in levare (Gli anni dei monitor accesi). In più la
documentazione straniata del quotidiano (Dovresti
dormire, Un altro giro attorno a casa, il ricordo del manager nella nebbia in Cronaca Vera), le spolveratine
emo (Tiger) e gli sconfinamenti nell'uptempo funk
(bello il crescendo prog di Your Kisses). Non c'è da
strapparsi i capelli, non c'è il pezzone che sbanca, ma
probabilmente la ricetta per uscire dal tunnel degli
anni 00 è questa: un'amalgama che come nel miglior
Beck/Bugo ti lascia lì a goderti la musica. E basta.
(6.5/10)
Marco Braggion
Andrew Morgan - Please Kid,
Remember (Broken Horse Records,
Ottobre 2009)
G enere : C hamber pop
Please Kid, Remember è il ritorno del misconosciuto Andrew Morgan, songwriter e arrangiatore
chamber pop che i più attenti avranno conosciuto
con Misadventures in Radiology, pubblicato sei anni
orsono (e ristampato dall'etichetta di Sonic Boom
nel 2005).
E se sono passati anni da un esordio noto soprattutto per il contorno di tragedie che si portò appresso
(la morte del sostenitore Elliott Smith che gli
prestò il suo studio - il New Monkey a Los Angeles
- e un tornado che quasi si portò via lui e l’udito), le
vicessitudini che caratterizzano il sophomore di cui
vi parleremo non sono certo state lusinghiere. Altri
brutti fattacci hanno costellato la già triste biografia
del cantante: un’allergia che gli paralizza per tre mesi
le corde vocali (!), povertà, debiti, pene d’amore che
neppure li consideriamo problemi in confronto ad
altre morti che gli accadono (un amico si suicida) e
alla pazzia che nel frattempo gli cresce come l'acqua
sotto i piedi (un altro viene sbattuto in un istituto
stile Hugo di Lost).
Morgan rischia seriamente di non farcela. Le registrazioni dell'album, tra Chicago e Kansas, subiscono ritardi e fermi interminabili e una prima versione
delle tracks viene gettata alle ortiche. Troppi fantasmi nella testa e troppa l’ansia di non essere all’altezza del secondo capitolo di un opera sulla pazzia
che ad ogni modo vede la luce ora cogliendo tutti
di sorpresa.
Date le premesse, l'attesa per un nuovo Nick Drake, Tim Buckley e soprattutto Elliott Smith è sicuramente alta e il packaging che spinge al massimo
l'effetto reliquario va sicuramente a fomentare un
supposto capolavoro quale Please Kid non è e non
sarà.
Avere sfiga non significa partorire pietre miliari perché se ogni capolavoro sulla pazzia è fatto soprattutto di difetti, imperfezioni, discontinuità e sfaccettature anche infinitesimali (Daniel Johnston ti
amiamo per quello),Andrew di scoperchiare i propri
demoni proprio non ne vuol sentir parlare, anzi, imbottito di chissà quante pillole, canta ogni canzone
allo stesso modo, producendo in chi ascolta un’assuefazione tremenda. Immaginatevi un maelstrom di
chitarre 12 corde, bassi
di diversa accordatura,
piano, harpsichord, archi
e arpe, corni vari, timpani,
glockenspiel, harmonium
e ancora, chitarre elettriche, shackers, battiti di
mani, un coro femminile,
tamburelli e chi ne ha più
ne metta, rovinati da una
produzione tremendamente ovattata e cristallizzante, da una parte, e un cantare serafico, egocentrico,
dandy e nichilista che ti conduce ogni melodia con il
medesimo fare sussurrante e serafico dall'altra.
Presumibilmente convinto che il passato gli dia delle
licenze (impossibili), l'aspetto più irritante delle brevi composizioni è la pretesa di trasformare in oro
una medesima strategia canora/arrangiativa che da
sola già non si tiene e - peggio - non comunica arte
ma compiacimento.
E pare che il Nostro abbia già in mente il prossimo disco. Si chiamerà Grey Light of the Season. Se
una lucidità maggiore e un produttore di peso gli
porteranno consiglio, potremmo forse sperare in
recensioni
53
un disco di canzoni e non in un fantasmino di Elliott
Smith sotto formalina.(4.5/10)
Edoardo Bridda
Andrew WK - 55 Cadillac
(Skyscraper Music Maker,
Settembre 2009)
G enere : weird man cl as sical piano
Anni fa, su una rivista di musica per i giovani, avevamo beccato un servizione con foto splash-page di
pogo mitologici (legnate a mai finire ma tutti col
sorriso stampato in faccia) e intervista a questa
specie di guru del casinarismo che dichiarava cose
come: «Non importa se è sangue, sudore, piscio o
sperma: basta che alla fine della festa tu sia bagnato
fradicio!». Era Andrew WK, nella sua epifania più
classica di (finto) autolesionista hard-poppettaro
ottusissimo (musicalmente parlando). Era il 2001, e
lui presentava il suo debutto I Get Wet, due tonnellate di riff di chitarra, un po' di tastiera e melodie
tipo Aqua, un disco tanto brutto da essere un vero
spasso (e un culto): il fascino dell'orrido. Che se ci
fosse (più?) ironia sarebbe un gioiello del demenziale. Ci è, ci fa?
Andrew, negli anni, si è poi dimostrato tutto tranne
che ottuso, e guru lo è diventato sul serio: personaggio mediatico USA a 360 gradi e "motivatore"
new age, di quelli che fanno le serate nei teatri e ti
dicono «Tu ce la puoi fare!». Arriva adesso al quinto album (ma di dischi ne ha fatti molti di più, ad
esempio due di sole cover di pezzi giapponesi) e
inaugura una label tutta sua. Su vinile il disco glielo
stampa nientemeno che Thurston Moore, con
la sua Ecstatic Peace, e allora viene il dubbio. Saranno
le solite robe?
Andrew, che ha studiato il piano fin da piccolissimo,
ha fatto un disco piano solo. Composizioni estemporanee catturate in una session di due ore, ipnotizzato, dice lui, dalla somiglianza tra lo Steinway che
aveva sotto le dita e la Cadillac parcheggiata lì fuori,
sorta di totem notturno che lo ha ispirato, pezzo di
modernariato appartenuto, dice sempre lui, ad uno
degli "architetti" della Guerra Fredda. Espressione
perplessa. Ma rientra nel personaggio.
Sono pezzi per piano solo, introdotti da cicaleggi
(che fanno tanto notte nella suburbia) e rumori di
auto, e variano dall'iniziale sfogo in ondose iterazioni figlie del minimalismo (versante Charlemagne
Palestine), a incursioni nel rag, ballad-jazzie, pop
dei tempi che furono, notturni, ricordi di colonne
sonore e della classica che ha studiato, qualche toc54
recensioni
co free-casinista. Non si smentisce Andrew nel finale, non si trattiene, e ci appiccica sopra schitarrate
ed effettacci vari, chiudendo tutto con una specie di
"Cadillac-Om". Anche se non è impeccabile, Andrew
sa suonare, e ci sono momenti compiuti (altri invece
sono proprio incompiuti, troppo "di palo in frasca"),
altri ancora sono divertenti, altri semplicemente
piacevoli come sottofondo. Ma è proprio il senso
della cosa, almeno fuori dalla sua filosofia dello sfogo
a tutto i costi, soltanto declinata in maniera diversa
dal solito, che sfugge al non iniziato. Bravo per l'effetto sorpresa.(5.8/10)
Gabriele Marino
Antlers (The) - Hospice (Frenchkiss
Records, Settembre 2009)
G enere : indierock
Dietro gli Antlers e Hospice c'è una storia sofferta e strappalacrime, c'è il passaparola e soprattutto
c'è l'eco di Pitchfork. La cronaca è simile a quella di
Bon Iver: il giovane newyorkese Peter Silberman entra in crisi isolandosi dal mondo per poi
riemergere dalle tenebre con una manciata di canzoni catartiche. E con l'aiuto in fase di registrazione
di due fidi musicisti, prende così vita il debutto discografico degli Antlers.
Un concept album sui "dolori del giovane Silberman", che va a toccare temi difficili come la fragilità
della vita e la malattia terminale. Il paragone più vicino è quello con Funeral degli Arcade Fire, e
quando i volumi si alzano è ancora la band canadese
ad essere evocata anche
musicalmente. Perché la
maggior parte di queste
dieci tracce si muove invece sommessa e dilatata su riverberi shoegaze
e ambient, in cui la voce
plana eterea alla stregua
di un Antony spettrale
e nervoso. Dietro ogni
singolo episodio c'è sempre una tensione rumorosamente trattenuta a far da filigrana, che viene però
fatta rilucere dalle immancabili aperture pop vocali,
messe qua e là.
Questo è proprio il merito di Hospice: risultare
simultaneamente ostico e accessibile, sofferto e
conciliante. Non un disco perfetto, ma estremamente coraggioso che, a parte gli incensamenti eccessivi,
non si dimenticherà facilmente.(7.2/10)
Andrea Provinciali
highlight
Gianluca Petrella/Cosmic Band - Coming Tomorrow - Part One
(Egea, Ottobre 2009)
G enere : jazz cros sover
Non saranno dei mostri, non avranno il sacro fuoco, la radice black ereditata nella culla, però
spesso i jazzisti italiani possiedono quella certa irriverenza scentrata, entusiasta e avventata che
rende effervescente la loro proposta, qualità che spesso fa difetto a molti "mostri" nonché "sacri"
d'oltreoceano. Fabio Morgera, Giovanni Falzone e Luca Aquino, ad esempio, fanno
della tromba uno speculum per sbirciare negli anfratti, per risalire all'origine senza mai staccare
il jack dal juke box della contemporaneità. Sul versante così lontano così vicino del trombone,
Gianluca Petrella fa lo stesso. Anzi, di più.
Classe '75 da Bari, già pupillo di Enrico Rava e Franco D'Andrea, ha lavorato praticamente
con tutta la scena jazzistica nazionale e con una fetta considerevole di quella internazionale (solo
per fare qualche nome: Lester Bowie, Pat Metheny, Hamid Drake, Carla Bley, Greg
Osby...). Tra i suoi vari progetti, quello con gli Indigo ha sbrigliato in due fortunati album (Indigo 4 e Kaleido) tutta l'impudenza progressiva del Nostro, quel suo incontenibile e febbrile
istinto, come dire?, crossover. Nel caso del qui presente Coming Tomorrow - Part One,
Petrella si fa accompagnare dalla Cosmic Band, un nonetto esuberante e versatile che dirige
sulle tracce dell'immaginifico vate Sun Ra.
Quel che ne esce è una traiettoria onirica e ruspante, visionaria e turgida, sincopata e distesa.
Il Sun Ra di Petrella e compagni carbura sulle vampe di Ellington e col mantice Mingus,
strappa squarci di tradizione e le incastona tra ibridi afrofuturisti, accelera in punta di frenesia e rallenta il battito fino a livelli di melmoso
languore, ruggisce e squilla e spaccia cortine fumogene per proiezioni
folli in cui c'è sempre parecchia ragione (e viceversa). Sono quattro le
tracce estratte dal repertorio dell'uomo che venne da Saturno: il funk
aereo e mercuriale di Space Is The Place trova contraltare nella suadente circospezione di Saturn, mentre alla grazia arguta di Bassism fa eco
la tarantella gospel-psych di We Travel The Spaceways, dove impazza la
chitarra invereconda di Gabrio Baldacci.
I titoli appena citati coinciderebbero coi momenti migliori della scaletta, non fosse per quella Three Undisciplined Satellites capace d'incendiare hard-bop di frenesia drum'n'bass che è una scossa e
un piacere. In attesa della Part Two, godiamo di questa clamorosa dichiarazione di maturità anzi di
pienezza creativa di Petrella, il cui linguaggio jazz non conosce banalità né pigrizia. (7.8/10)
Stefano Solventi
At Swim Two Birds - Before You
Left (Vespertine & Son, Settembre
2009)
G enere : songwriting
Mai stato uno troppo solare Roger Quigley. Fin
dalle prima pubblicazioni a suo nome il cantautore di Manchester ha preferito indagare i luoghi più
oscuri e dolorosi dell'esistenza umana lasciando
ad altri il compito di dare luce a ciò che nella vita
d'ognuno - per merito o fortuna, a seconda dei punti di vista - lucente lo è già di suo. Così, dicevamo,
per i dischi autografi (due ep e un lp nella seconda
metà degli anni '90) e così per l'indie-pop sognante
dei Montgolfier Brothers, progetto condiviso
con Mark Tranmer che dal 1999 ad oggi ha partorito tre dischi (l'ultimo nel 2005), e di cui At Swim
Two Birds è la deviazione ancor più malinconica
e prostrante con Quigley di nuovo in solitaria.
recensioni
55
Before You Left, ci pare di capire, nasce da un fatto
biografico della vita dello stesso artista o di qualcuno vicino a lui: la morte di una persona amata e
il relativo, inevitabile resoconto di ciò che è stato
e non potrà più essere. Dieci le canzoni, essenziali
quando non ridotte all'osso (come nell'Intro iniziale,
con la voce a sussurrare solitaria nel vento «Before you left/ I told myself it is a good thing...»),
formate da poche note spesso reiterate di chitarra
e dal cello di Sophia Lockwood a sottolineare
i momenti più sofferti (I
must be losing you). Altrove invece appaiono in
secondo piano batteria,
tastiere e qualche luccichio elettronico (Let her
go, con Martin Rebeski dei Doves), ma la
sostanza rimane quella:
un songwriting dalle tonalità e dalle forme dimesse, fortemente influenzato
dalle vicende occorse, in positivo quando coglie nel
segno (No fear) meno quando costruisce strutture che richiederebbero trattamenti ben più sfarzosi - come nell'austera The march of the Kings, lunga
narrazione su un'andatura quasi da bolero di una
deprimente vicenda d'alcoolismo.
E anche i riferimenti - due su tutti: Nick Drake
e il David Sylvian di Blemish - sembrano piegarsi a ciò che sta dietro le canzoni. Se di carattere
involuto dobbiamo dunque parlare, lo facciamo tenendo presente il fine ultimo di questo lavoro, che
nella sua odierna laconicità cerca un futuro liberato
dalla pena.(6.3/10)
Luca Barachetti
Atlas Sound - Logos (4AD, Ottobre
2009)
G enere : P sych nuggets
Dopo la famosa svista che lo portò a diffondere erroneamente una prima versione dell'album tramite
mediafire, Bradford l'anoressico aveva dichiarato di
aver perso ogni volontà di completare il lavoro. In
verità, calato il sipario, ci aveva rimesso le zampe subito dopo continuando a lavorarci per tutto il tour
dei Deerhunter con lo spirito che inizialmente lo
aveva animato.
Spontaneità e concept d'insieme pensato a tavolino
erano, e sono rimaste, le parole chiave di una raccolta di polaroid per una personale nuggets-delia, magra
e impalpabile come lui ma nondimeno raffinatissima
56
recensioni
e intrigante, post shoegaze (lo scorso anno si diceva
ambient pop) e retrò. Contrariamente alle vie solitarie dell'esordio, questa volta a svoltare positivamente
il risultato troviamo ispiranti e ispirate amicizie. Cox
se le è coltivate con sapienza succhiando spirito e
sapori: la deliziosa vintage-delia di Walkabout è più
farina Panda Bear / Animal Collective che sua
(dell'amico anche l'idea del sample utilizzato, quello
dei misconosciuti Dovers), nondimeno il brano è riconoscibilmente bradfordiano. Idem per Quick Canal
che ospita Laetitia Sadier. Marca Stereolab le liriche e dell'ospite il dubbing vocale ma il gusto shoegazy sempre dalla parte di Cox.
Prezioso pure il violino di Sasha Vine dei Sian Alice Group in Attic Lights, altro brano significativo
di un album che differentemente dall'esordio lavora
sulla propria stessa inconsistenza per un pop subliminato e incavato nella memoria.(7.1/10)
Edoardo Bridda
Bad Lieutenant - Never Cry Another
Tear (V2 Music, Ottobre 2009)
G enere : pop wave
L'eredità dei New Order passa anche per questo progetto parallelo del cantante e chitarrista del
glorioso gruppo 80, Bernard Sumner. Le carte
che gioca son sempre là a cavallo tra quella wave
anni 80, quei synth e quella voce così pulita, il rimescolamento dei Suede che passa ancora per
Verve, Oasis e Ian Brown. Il riproporre ancora una volta un'idea musicale di pop ormai più che
digerita va bene solo per i nostalgici di quegli anni
strafatti a tinte pastello? Il segreto è il non porsi
questa domanda e ascoltare tutto come se non ci
fossero rimandi(/plagi?) infiniti, lasciarsi attraversare
dal brivido del riff e non criticare. Ma visto che di
critica cerchiamo di occuparci, anche tralasciando il
background non si può che esprimere un giudizio. Il
disco va?
Con una produzione che non insiste sulle tastiere e
si concentra sulla voce e sulle chitarre (Dynamo), con
degli arrangiamenti che puntano alla pulizia (Running
Out Of Luck), e con altri trucchetti si poteva confezionare un buon dischetto pop da top ten, invece
questo Never Cry Another Tear dopo un passaggio
è già nel dimenticatoio. Commerciali lo sono sempre stati i New Order, e va bene, solo che questa
volta gli uberammiccamenti non reggono. Solo per
completisti. Chissà cosa direbbe Curtis...(5/10)
Marco Braggion
Bad Love Experience - Rainy Days
(Inconsapevole, Ottobre 2009)
G enere : P ower pop
Dopo l'ottimo esordio omonimo di tre anni fa la
band livornese si conferma, migliorandosi, con
Rainy Days. Le differenze: l'aggiunta di un quarto
elemento (Claudio Laucci: piano, organo e cori)
al trio di base e una maggiore e spiccata propensione verso lidi sonori decisamente british. Ciò che
viene perso per strada è quel venticinque percento
punk che caratterizzava il debutto.
Nelle dieci tracce fresche e scattanti si respirano tanti Beatles, ma anche Who e Jam fino a
Last Shadow Puppets e Arctic Monkeys.
Un poco più di personalità e i Bad Love Experience potrebbero veramente ambire al titolo di "band
italiana più inglese" in circolazione. Da non perdere
il loro cameo nel nuovo film di Paolo Virzì, La prima
cosa bella, nei panni del gruppo rock beat Le Nuove
Dimensioni.(6.8/10)
Andrea Provinciali
Basement Jaxx - Scars (XL
Recordings, Settembre 2009)
G enere : post - disco
Credere nella disco è un rischio e chi se ne fa carico di solito sa quello che fa. E come negare che
il verbo è duro da professare in un periodo in cui i
generi si disgregano ed entrare in una nicchia è più
cool (e protettivo). Per chi produce musica è molto meno rischioso giocarsela al campetto piuttosto
che allo stadio e se i sottogeneri sono facilmente
malleabili è vero pure che la massa pop fa paura a
troppi. Del resto, cosa ti resta se hai un progetto
che va avanti da più di 10 anni? Sei obbligato a mostrarti.
Il suono Jaxx è ormai coniato, la loro è la postdisco 00 che guarda in giro e si mescola con i campioni del ritmo, siano essi provenienti dal pop-soul
(Kelis), dal mesh-up (Santogold), dalla house
più tamarra (Sam Sparro) o dalla storia (Yoko
Ono nella marcetta da urlo Day Of The Sunflowers).
Il gioco si fa interessante quando ai featuring aggiungi una produzione che rasenta la perfezione e
delle bombe che fanno muovere qualsiasi braga: il
camp stellare à la Empire Of The Sun del singolone Raindrops, il dancehall tirato di Saga con la
Santogold più in forma che mai, il baile pompato e
ciccione di Twerk (con il vocoderaggio delle Yo!
Majesty).
Non è poi tutto oro: ci son pure i lenti riempidisco,
ma alla fine Scars si lascia ascoltare. Basement Jaxx
marchio di fiducia.(6.9/10)
Marco Braggion
Bassekou Kouyate - I Speak Fula
(Outhere, Settembre 2009)
G enere : world
Si è preso il tempo necessario, il buon Bassekou, per
dare un seguito al già eccelso Segu Blue. Dopo aver
incassato la dovizia di un paio di premi di categoria della lungimirante BBC, il virtuoso del ngoni si
conferma astro lucente del panorama world. Lo fa
annodando con sicurezza il filo che lega la tradizione (il suo strumento
è fondamento della cultura griot) alla modernità
(i suoni, splendidamente
nitidi e la produzione
puntuale). In tal modo
predispone un prodigio
in grado di convogliare l’ipnotica potenza delle esibizioni dal vivo, coronando un percorso scintillante
benché appannaggio degli specialisti in materia. La
dice lunga la gavetta di Kouyate, allontanatosi dal
villaggio natale sulle rive del Niger per incrociare
gli strumenti con calibri come Youssou N’Dour,
Ali Farka Touré e Oumou Sangare.
Da tali esperienze - e senza dimenticare la presenza
giovanile nella leggendaria Rail Band di Bamako
- e dall’incessante vocazione a sperimentare (lui il
primo - negli anni ‘80 - a suonare lo ngoni stando in
piedi con fare “rockista”…) germoglia l’attualità degli Ngoni Ba, gruppo a tutti gli effetti qui impreziosito dagli interventi di Toumani Diabate e di un
Vieux Farka Touré che maneggia l’elettrica appartenuta al padre. Naturale dunque auspicare che
questi cinquantasei dorati minuti spediscano l’uomo
ancor più in alto, sulle ali di una solidità strumentale
e stilistica invidiabili (Torin Torin, Tineni) e di un preblues tanto asciutto quanto visionario (Falani, il sublime “traditional” Bambugu Blues); di una cantabilità
atavica che trattiene un senso di mistero (Jamana
Be Dia, Moustapha) e di cristalline, frenetiche cavalcate acide da far cascare la mascella per lo stupore
(Musow, Saro). Ponete I Speak Fula accanto ai Tinariwen: monopolizzerà lo stereo in men che non
si dica, mettendo per qualche ora da parte tutta la
vacuità con cui facciamo quotidianamente i conti.
(7.7/10)
Giancarlo Turra
recensioni
57
Beck - Record Club #1: The Velvet
Underground & Nico (Beck's
Record Club, Settembre 2009)
G enere : beck to the cl as sic s
Andate su beck.com.Video e dischi in streaming (per
adesso l'ultimo Modern Guilt e il classico Mellow Gold), la playlist con gli ascolti della settimana
(esce il nuovo degli Antipop Consortium? Lui
tira fuori Ping Pong da Arrythmia), weird dischi
trovati (il primo è di Uri Geller), interviste (la prima a Tom Waits, purtroppo solo in formato testo). Ma soprattutto, e arriviamo a noi, Record Club.
Beck sceglie un disco e, with a little help from his
friends, lo coverizza per intero (come facevano dal
vivo i Phish, cento anni
fa), in una sola tirata, senza troppe prove, buona
la prima o quasi. Il tutto
viene registrato e messo in streaming sul sito,
sotto forma di video b/n
finto lo-fi ultrapixelato,
un brano alla settimana.
A inaugurare la serie, il più classico dei classici, la
banana che tutti abbiamo sbucciato.
Ci sono, si scambiano gli strumenti (e cazzeggiano):
Nigel Godrich (che fa casino e canticchia), Joey
Waronker, Brian Lebarton e Bram Inscore (della crew beckiana), Giovanni Ribisi (l'attore), Chris Holmes (il chitarrista degli W.A.S.P.),
Thorunn Antonia Magnusdottir (cantante
Islandese, la Nico del caso) e un non meglio identificato Yo (lo si intravede a un certo punto sbadigliare). Beck precisa subito: «Non vogliamo aggiungere qualcosa agli originali né cercare di ricrearne la
forza. Vogliamo solo suonare e documentare quello
che succede». Insomma, clima casereccio, siamo tra
amici, tanto artigianato, voglia di divertirsi. Risultato? Nessun capolavoro, nessuna epifania beckiana,
nessuna nuova vita velvetiana, come pure nessun intento filologico (e neanche nessuna clonazione, che
pure da lui ci si poteva aspettare, alla Faithful di
Todd Rundgren), nessuna ostinata esplorazione
stilistica (alla Nouvelle Vague), neppure nessuna
iconoclastia. è quello che è, un piccolo estemporaneo omaggio alle canzoni affezionate.
Affiora il Beck-spirito più acustico e garagistico (nel
senso della sala prove). La parte musicale è strapazzata, ma non troppo e non sempre, diciamo un aggiornamento dello strapazzamento che già era degli
originali (Waiting For The Man scordata; Venus In Furs
58
recensioni
folk-ambient-noise; Heroin straparossistica, digrignata da Waronker). Poi, Run Run Run con tastierine
electro, There She Goes (che in origine strapazzata
non era) schiaffeggiata stra-stonata, quasi primissimi
Mothers Of Invention (ma anche qui, a occhio
e croce, nessuna iconoclastia, giusto il gusto della
trovataccia), Black Angel's Death Song per sola voce e
chitarra (quasi venisse dai demo dei Velvet), Europeran Son rallentata, e come sospesa, senza il famoso
deragliamento finale.
Chissà se a rifare i Velvet Underground fosse
stato qualcun altro, magari uno sconosciuto, chissà se avessimo dovuto pagare... Qui e ora, TUTTO
considerato, otto all'idea (e applauso alla parola
gratis) e sei, pieno, alla musica. Il remake a matita
della famosa copertina è opera dello stesso Beck.
Il 4 settembre è stato messo online il primo pezzo della nuova prova del Record Club: Suzanne, da
Songs Of Leonard Cohen, ospiti Devendra Banhart e componenti sparsi di MGMT, Wolfmother e Little Joy. Terzo arriverà, e non vediamo
l'ora, saremo già a novembre, un disco degli Ace
of Base.(7/10)
Gabriele Marino
Big Pink (The) - A Brief History Of
Love (4AD, Settembre 2009)
G enere : T ech - pop
Is The Big Pink the Next Big Thing? La risposta è no.
Però è abbastanza interessante il modo in cui Milo
Cordell e Robbie Furze, ovvero The Big Pink, ci
provino.
La prima mossa è mettere in chiaro tutte le carte:
la produzione innanzitutto, che fa sfoggio di sé con
risultati apprezzabili, vedi soprattutto Too Young To
Love. Lì dietro si nasconde l’insidia, quando la gran
quantità di escamotage di raffinamento produttivo/
arrangiativo non riesce a dissimulare la scarsità di
alcune melodie, che del resto sono le vere protagoniste dell’album, una su tutte quella di Dominos. In
generale A Brief History Of Love è un album di pop
tecnologico tirato a lucido, dove si possono isolare tecniche Interpol-iane (del basso soprattutto),
suoni non distanti da Trent Reznor, un’atmosfera cyber abbastanza diffusa (i due si sono conosciuti
a un rave e hanno fatto da opener per Alec Empire) e un piglio da Black Rebel.
Il mix crea manciate di secondi esaltanti (Frisk), e si
capisce che l’obiettivo immanente dei brani è fare
dell’oscurità e della decadenza uomo-macchinica
non un esercizio fine a se stesso ma un punto di
highlight
Helado Negro - Awe Owe (Asthmatic Kitty Records, Agosto 2009)
G enere : tropic - avant - indie
Vecchia come il mondo dell’indie e del rock (o quasi) è la commistione con tropicalismi e felici
o Tristi Tropici. Nessuna novità apparente allora nell’approcciare Awe Owe di Roberto Carlos
Lange, figlio di migranti ecuadoregni, in arrivo dalla Florida con il suo nuovo moniker Helado
Negro.
Lingua madre spagnolo, salsa, quel caldo e meditato infantilismo dei
ritmi da Sud- e Centro-America, piglio indie e pure tronico, costruzione avant, per Roberto Carlos - che conosciamo già per il progetto
Savath & Savalas dell’amico Guillermo Scott Herren. Come fosse
un Animal Collective più docile (da ballata in Espuma Negra, in
acustico con fiati in Time Aparts), il super-combo del gelato nero (che
comprende personaggi di provenienza Yeasayer, Guy Fantastico, ecc.) tocca quelle lande già approcciate anche da personaggi del
jazz misto-Brasile quali Nanà Vasconcelos (Dos Suenos), oppure, ancora una volta, dai soliti
nomi: Arthur Russell, Arto Lindsay (Santero), nonché Tom Zè e Os Mutantes.
Eppure, in tutto questo alto suonar di nomi, Lange riesce a trovare un piccolo spazio; è trasognato
e squisitamente arrangiativo in Dahum, sorta di mantra chill-out con pre-coda efficace di fiati e
conclusione vera in acrilica sfumatura; è pressoché perfetto nel ripetere l’estetica della ripetizione (il bisticcio di parole è voluto) di un tema su tessuto poliritmico in Awe, probabile perno
del disco. Le cose migliori nascono quando i synth incrociano quelle melodie cubane o brasiliane
andandole a raffreddare o a condire di quel tocco che Helado Negro fa suo, riuscendo a farli
passare dallo sfondo alla figura (I Wish).
In definitiva il punto è che anche i padri putativi vanno dietro le quinte, specie quando il lato B
matura i solchi oltre la metà; fatto che di per sé dà una cifra diversa dal solito per chi è cresciuto
nell’indie avant degli ultimi dieci anni.(7.2/10)
Gaspare Caliri
partenza per la costruzione melodica. E, ancora una
volta, eccolo il vero problema. Ciò che dovrebbe
reggere il passaggio finisce quasi sempre per rovinare con scimmiottamenti da fine Ottanta quello che
la costruzione musicale e l’innesto della produzione
hanno messo in scena per ogni brano (Golden Pendulum).
Se la storia si facesse coi se e coi ma, avremmo preferito un gioco di contrasti più accentuati. Una voce
che davvero si ergesse con personalità e senza ovvietà sul resto. Un contrasto tra idillio e condanna.
Anche senza se e senza ma, è la finale Countbackwards From Ten, e ancora prima la title-track, che ci
suggeriscono questa riflessione; specie quest’ultima,
con una voce femminile che affiora ad accompagnare quella maschile, un’incrinatura che però si basa
su un andamento da ballata pop standard. Con un
ma senza se, constatiamo che sono episodi isolati.
Peccato.(6/10)
Gaspare Caliri
Black Crowes - Before The Frost...
Until The Freeze (Silver Arrow,
Settembre 2009)
G enere : blues rock
I cari Black Crowes. Quasi non ci credi che stanno
per spengere le venti candeline di ruspante attività.
I problemi, il girare a vuoto, la fiacca dell'ispirazione,
ci sono stati e hanno lasciato il segno. Ed è un bene.
Perché tutto ciò li ha obbligati a prendere atto, a
riflettere. Ad accettarsi. è stato allora che sono ripartiti. Fisicamente e logisticamente dallo studio di
Levon Helm a Woodstock, dove hanno inspirato
spore di magia rock, hanno composto, provato, suorecensioni
59
nato e ancora suonato. Infine, durante cinque sabato
sera consecutivi, hanno inciso dal vivo venti nuove
canzoni di fronte ad un raccolto pubblico di soli fan.
Risultato: un disco caldo, turgido e disinvolto. E pure
doppio, acquistabile in vinile oppure in cd singolo
contenente il codice per scaricare il secondo volume direttamente dal loro sito. Un pezzo via l'altro
i fratelli Robinson e compagnia bella ci dicono che
non sono loro ad essersi spostati ma è il mondo
che non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno e cosa vogliamo farci?
Nulla, se non suonare col solito piglio tra il torrido
e lo strascicato, se possibile ancora più strascicato, cavando calore e ruvidezza da petto, stomaco
e cuore, ciondolando tra
black e southern come
se tra le strade percorribili fosse davvero la più
accogliente, non la più
breve né la più veloce.
Detto questo, i Crowes
tentano pure l'azzardo,
ma lo fanno divertendosi: con una I Ain’t Hiding che sculetta sulla cassa in
quattro, basso pulsante e wah wah come una nipotina screanzata del Rod Stewart danzereccio e
dei Rolling Stones di Emotional Rescue. Quindi si
concedono digressioni ispirate, come una What Is
Home profumata CSN, come l'impasto tra bretagna
e oriente di Aimless Peacock, come i Beatles versante McCartney di And The Band Played On.
Il tutto con la flemmatica irriverenza di chi non ha
più nulla da perdere, né da dimostrare. (7/10)
Stefano Solventi
Black Heart Procession - Six
(Temporary Residence, Ottobre
2009)
G enere : rock noir
C’è poco da fare. Ogni disco della combriccola dal
cuore nero è un tuffo al cuore. Dopo due estemporanee escursioni in titoli letterari si ritorna alla
numerazione progressiva che caratterizzava la prima tripletta di dischi e, sia chiaro da subito, l’album
numero 6 non sposta di molto la sostanza di una
musica appassionata e malinconica, oscura e tesa,
irrimediabilmente riconoscibile all’istante.
La cifra stilistica del quintetto capitanato dagli ex
Three Mile Pilot (curiosamente in uscita a breve anch’essi per Temporary Residence) Pall Jenkins
e Tobias Nathaniel è sempre sul crinale di un rock
60
recensioni
molto virato al nero, dal mood claudicante e darkish,
poetico e sognante. Six però si spinge un po’ più
in là, accentuando una delle peculiarità del combo,
quella emozionale, senza però perdere in vibrante
tensione.
Punta al cuore, Six, e colpisce il bersaglio. Con languide ballate a tinte noir alternate a pop-songs da
vaudeville, sghembe e al limite dell’ubriachezza, tanto che quando suonano pezzi come Forget My Heart
viene in mente una versione dark e rattrappita degli
Arcade Fire. Il paragone è gratuito, ovviamente,
perché l’universo BHP è molto più vasto e non è
difficile scorgere dietro le strutture da cabaret esistenzialista rimandi neanche troppo sfocati, ora ad
un’idea di folk orchestrato piuttosto doom (Liars
Ink), ora ad una forma di slowcore dark (Last Dance),
ora ad un catacombale indie-rock (Heaven And Hell).
Il tutto sempre impreziosito da un lirismo di livello
superiore, comme d’habitude, tanto che un capitolo
a parte lo meriterebbe quel catalizzatore dell’attenzione che è Jenkins. Insomma, passa il tempo, ma
non sembra affatto scalfire i BHP, entrati ormai di
diritto nell’olimpo dei classici.(7.5/10)
Stefano Pifferi
Breakestra - Dusk Till Dawn (Strut
Records, Ottobre 2009)
G enere : sunny funk
"Questo disco suona come se venisse fuori direttamente
dal 1972" - Ahmir "Questlove" Thompson.
Così lo sticker sulla copertina di Hit The Floor
(Ubiquity, 2005), primo vero album della Breakestra. Ma l'ad firmato dal cuore pulsante dei Roots
era solo parzialmente vero.
Se la devozione per il funk e la passione per la musica suonata sono infatti innegabili, il collettivo guidato da Miles Tackett sembra invece peccare,
ieri come oggi, di eccessiva pulizia ed eccessiva
compostezza per sembrare davvero figlio degli "anni
marroni". La Break non si decide a fare quel jump in
the mud cui pure allude in una canzone di questa seconda prova, e che in un certo senso le gioverebbe:
niente grassume funk insomma, ma un funk asciutto,
placido, solare.
Registriamo le novità di alcuni interventi di una
voce femminile e di un violino. Per il resto si tratta della solita (piacevolissima, sia chiaro) festa funk,
guidata dall'alternanza di una voce bianca (lo stesso Tackett) e di una nera (Mixmaster Wolf; che
mima spesso esplicitamente James Brown). Ieri
come oggi, preferiamo gli strumentali alle song, per-
ché più cesellati, più ricchi, più avvincenti. Rispetto
all'esordio, che poteva contare oltre che sul famoso effetto sorpresa anche su una manciata di pezzi
indovinatissimi come la lunga psichedelica How Do
You Really Feel? (esordio quindi una spanna sopra
questo Dusk, ci teniamo a esplicitare), prevale qui
lo stiracchiamento della formula. Simile in questo ai
Fat Freddy's Drop, la Break può dare molto ma
molto di più.(6.3/10)
Gabriele Marino
Califone - All My Friends Are
Funeral Singers (Dead Oceans,
Ottobre 2009)
G enere : post blues
Da intimo conoscitore dei misteri del blues, Tim
Rutili sa lasciarsi trasportare. Conosce bene il
modo per far sì che, talvolta, sia il caso a determinare le scelte. Nello specifico, il nuovo disco dei
Califone - che vede la luce tre anni e un cambio di
etichetta dopo l’ottimo Roots And Crowns - contiene
musica destinata ad accompagnare un omonimo film
scritto e diretto dal Nostro, che verrà presentato nei festival del cinema
il prossimo anno. A prescindere dall’avventura
dietro la cinepresa (sperando che se la cavi meglio di Neil Young…),
rileviamo quanto le tredici composizioni di All
My Friends Are My Funeral Singers si reggano in piedi
da sole pur percorrendo sentieri già noti.
Sai dunque cosa aspettarti da questa banda di spostati romantici: i Rolling Stones che impastavano zolfo e country all’altezza di Beggar’s Banquet
(Buñuel, Salt) e i Beatles dell’Album Bianco (spruzzati d’umori Byrds in Polish Girls); l’ondeggiare imbottito di codeina da prime ore del mattino (1928,
la scheggia westcoastiana Evidence) e le melodie
malinconiche ma finemente epiche (Krill, Ape-like).
Persino la sorpresa di un trip-hop splendidamente
zoppo ed eseguito con piglio rock come Giving Away
The Bride, piazzato in apertura a confondere le idee
e qualche episodio eccessivamente simile a cose già
proposte in passato.
Ritrovi comunque la cura per il dettaglio (i tappeti
percussivi fitti, tribali; le chitarre memorizzate dai
migliori Franklin Delano) e il pennino intinto
in folk e dodici battute allo scopo di trasfigurare
entrambe. Che poi è, in definitiva, ciò che accade
dai tempi di John Mayall e degli Animals: bianchi proletari che rileggono - appropriandosene - le
radici nere e vi trovano l’origine della sofferenza
umana, giustappunto quel blues che ci segue dalla
nascita. L’ennesimo mattone posato con stile oramai classico su una via infinita.(7.2/10)
Giancarlo Turra
Cave Singers (The) - Welcome Joy
(Matador, Agosto 2009)
G enere : new A mericana
Singolare come, per ogni gruppo d’oltreoceano,
scocchi presto o tardi l’ora di fare i conti con la
ricca tradizione sonora del proprio paese. Non che
sia una regola fissa ma, insomma, pochissimo ci manca: alla chilometrica lista che prese le mosse con la
svolta country rock dei Grateful Dead - ed è
giunta ai giorni nostri tra celebrità e mezze calzette
- si aggiunge, da un paio di anni in qua, l’ennesimo
nome. Derek Fudesco, che dei Cave Singers è
fondatore, militava infatti nei trascurabili e disciolti indie-wavers Pretty Girls Make Graves: in
compagnia dei carneadi Pete Quirk e Marty
Lund, lo adesso trovi alle prese con strumentazioni acustiche e atmosfere rurali.
Ne usciva un’opera prima, Invitation Songs, che si
abbeverava copiosamente alla fonte folk/blues dei
Bob Dylan e Woody Guthrie presentando
in cabina di regia Colin Stewart, già coi Black
Mountain. Confermato anche a questo giro, costui si porta dietro Amber e Ashley Webber
dai Lightning Dust a dar ulteriore sostegno.
Poco o nulla però cambia nel suono che elettrifica le radici con sicurezza e semplicità compositiva,
rilassatezza d’atmosfere ed esecuzione adeguata.
Bella forza: trattasi di gente che, a prescindere dal
percorso artistico intrapreso, vive e respira questa
musica sin dalla culla o quasi.
Che tra le canoniche - ma non per questo mediocri,
anzi… - I Don’t Mind, VV e Leap si facciano largo
un poco di distorsione modernista (At the Cut) o
momenti più cupi (Shrine), fa parte della maturazione di ognuno e, di nuovo, gli esempi si contano a
centinaia. Senza sconvolgimenti, Welcome Joy è un
dignitoso passo in avanti compiuto guardandosi indietro.(6.7/10)
Giancarlo Turra
recensioni
61
highlight
Hidden Cameras - Origin:Orphan (Arts & Crafts, Settembre 2009)
G enere : pop rock
Col quarto album vero e proprio, Joel Gibb e gli allegri compagni della "gay church folk music"
conducono la consueta calligrafia pastorale fino alle estreme conseguenze, ma allo stesso tempo
perseguono altre cause convergenti e parallele: da una parte certa wave-pop ora frizzante e ora
tenebrosa, dall'altra drammoni cameristici ad alto tasso emotivo. Senza mai farsi mancare quel
gusto per l'artefatto prezioso, per l'eccesso stilisticamente corretto e giammai barocco perché
figlio d'un citazionismo per nulla supino, anzi corroborato da indomito
entusiasmo, contagioso oggi come ai tempi di Ecce Homo.
Puoi quindi cogliere in Do I Belong? un passo algido alla Level 42 e
l'animo in subbuglio d'un Jackson Browne, sospetti che Underage sia un plausibile ibrido tra Housemartins e Limahl, intuisci
nell'impeto guizzante e stralunato di In The NA giochetti Xtc e tremori Magnetic Fields, scorgi in Kingdom Come le trepidazioni così
lontane così vicine di Morrissey e Michael Stype, infine lasci che
Silence Can Be A Headline sbrigli ingenui struggimenti sixties e vaghe
inquietudini contemporanee, diciamo tra Simon & Garfunkel e
Black Heart Procession via Jason Molina.
Però poi a sconcertarti davvero sono le ambizioni per nulla velleitarie calate sul piatto con Walk
On e Ratify The New, la fiera apprensione del canto, il mantice orchestrale e gli esotismi aciduli,
il brulicare elettrico ed elettronico, i cupi tremori e l'energica dolcezza del climax. Due passi rischiosi perché lunghi ma - questo è l'importante - non più della gamba, cosicché il capitombolo è
rimandato e semmai sfiorato in occasione della title track, nella quale l'austerità Ultravox altezza Lament va ad immischiarsi con una vibrante generosità Brian Wilson, riuscendo a salvarsi
in corner perché quando i momenti sono propizi non c'è nulla che possa andare davvero storto.
Intenso e catchy, festoso e malinconico, arrembante e dolciastro, è uno dei capolavori pop dell'anno. Ed è forse IL capoalvoro degli Hidden Cameras. (7.7/10)
Stefano Solventi
Chris Garneau - El Radio (Fargo,
Agosto 2009)
G enere : C hamber pop
Se il precedente Music For Tourists si chiudeva con
una cover di Eliott Smith, El Radio, il nuovo lavoro di Chris Garneau, inizia con qualcosa che
difficilmente può essere incasellato alla voce “mestizia”.
Subito il giudizio: Chris è più bravo non quando
rappresenta la depressione (che gli è estranea), ma
quando fa provare a se stesso e a chi lo ascolta i
piaceri di incastro ed equilibrio del chamber pop
(come negli archi finali di Pirates Reprise). E poi, altro
confronto, Chris perde un po’ di credibilità quando si destreggia con l’America (o l’Australia) delle
ballate arrangiate (Raw And Awake, Hometown Girls)
piuttosto che con l’Europa (Things She Said).
62
recensioni
È insomma nella giocosità compositiva (ben visibile
in Fireflies, scherzetto post-vaudeville) che Garneau eccelle, e che El Radio acquista valore. In questo contenitore senza tempo tutto è felicemente
costruito e bilanciato. Dodici tracce, le prime tre
dedicate alla - o fatte fiorire dalla - primavera, poi
tre all’estate e così via fino alle winter songs. Il simulacro di un anno che alterna alti e bassi come davvero accade, fuori dalle facili assimilazioni sole-felicità
/ freddo-tristezza (un esempio su tutti The Cats &
Kids, serenamente tardo-autunnale); ma anche una
via di fuga realista dalla simulazione, se pensiamo
che davvero questo disco è stato pensato e iniziato
a scrivere da Garneau e dai suoi amici in giro per il
New Hampshire, con gli strumenti nel van, nell’estate e autunno 2008, vivendo e suonando il passaggio
delle stagioni. Altra chiave per leggere questi soffi
di composizione: un avvicinamento e un allontanamento dalla vita privata di Chris, le cui canzoni non
si ispirano più alle vicende personali ma prendono
la forma di personaggi inventati (ancora una frizione
America-Europa); e che nonostante questo risentono positivamente del sofisticato vissuto del viaggio.
La sicurezza da cantautore e da arrangiatore fa
bella mostra di sé; ma si percepisce, in queste coppie di quasi-opposti, un’instabilità. Non è chiaro il
concept. E se, a questo proposito, il futuro di Chris
Garneau fosse un vero concept-album cantautoriale?(7.1/10)
Gaspare Caliri
Chromeo - DJ Kicks (!K7, Settembre
2009)
G enere : compil ation dance 80
Nell'intervista/promo per questa compila i due DJ
canadesi (P-Thugg e Dave 1) dicono che è stato
difficile trovare i detentori di copyright di alcune
tracce contenute nel mix. E ci crediamo pure noi
ascoltando questo memorabilia 80 pieno di funky
e di stile. Nomi sconosciuti ma proprio per questo
cool. In sostanza un breviario di synth retrofili, tante
paillettes e spalline filtrate da vocoder, orchestrine
di fiati, chitarre in uptempo funk e il crate digging
che oggi non è più (purtroppo) di moda.
L'ennesima uscita per la fortunata serie targata !K7
ci sta di brutto con lo zeitgeist del dancefloor di
questo 09 danzereccio e noi ci divertiamo ad ascoltare e a ballare questa tracklist che ci riporta indietro di secoli. Le atmosfere à la Gazebo di Lovelock (Maybe Tonight), la progressività d'obbligo di
Moroder innestata con i robot kraftwerkiani nei
pezzi di Chateau Marmont e Lifelike (Sequencer da panico ifeelloviano), la I Can't Tell You Why degli
Eagles remixata in esclusiva per il disco e per finire la botta di Alan Parsons Project (Pipeline).
Un disco imprescindibile per gli amanti del sound
di quegli anni di plastica e anche per chi crede che
Lindstrøm e Sebastien Tellier dicano qualcosa di nuovo. Sciccosissimi Chromeo.(7.3/10)
Marco Braggion
Circulatory System (The) - Signal
Morning (Cloud, Settembre 2009)
G enere : P sych wave
Dopo sette anni, William Cullen Hart dissotterra il
gemello oscuro dell'esperienza psych Olivia Tremor Control e lo fa rinnovandone la formula
dall'interno, incattivendola e marcendola come si
confà a certi venti underground attuali. In pratica Signal Morning sta all'omonimo che Pitchfork osannò nel 2001 come i Beatles stanno ai
Residents. E attenzione ai paragoni: dove il precedente era psych lo fi umorale (ma pur sempre
bucolico), la nuova corrente si porta dietro i Pink
Floyd degli Abbey Studios con giovamento della
formula complessiva garantito.
Sin dall'iniziale industrial garage di Woodpecker Greeting Worker Ant la sensazione è che la missiva sia
rivolta agli shit gazers in circolazione. Il messaggio
arriva potente: i Circulatory System sembrano
al distratto una prolifica ganga di promettenti esordienti e non la solita gongrega di navigati.
Sempre prodotto in libertà per la sua Cloud, disabilitante come un Brian Jones pre-piscina (This
Morning We Remembered
Everything) o un Syd
Barrett in combutta
Gong (Particle Parades),
il nuovo sforzo di Hart è
bello come i dischi indie
di culto che si rispettano:
un disco che odia gli allori dove ogni brano è un
collage diverso dal precedente e nel quale tutto torna sotto l'ombrello di
una psychedelia malata e putrida, salvo poi svelarti
qualche funghetto dalle spore deliziose come Round
Again, hard glam distortissima e indie tuned come dio
comanda.(7/10)
Edoardo Bridda
Clientele (The) - Bonfires On The
Heat (Merge, Ottobre 2009)
G enere : psych pop
I londinesi Clientele approdano al quinto album. Se
devo essere sincero, non mi aspettavo tanta longevità. Certo, con Suburban Light nel 2000 mi
stregarono letteralmente, tuttavia era chiaro quanto quell'ineffabile debutto su lunga distanza - in realtà una raccolta di singoli ed ep - poggiasse più su
un'intuizione sonico-ambientale che non su acclarate capacità di composizione, esecuzione ed interpretazione. C'era quella caligine spersa e sparsa, un
senso di sonnacchiosa psichedelia come retaggio di
sogni rannicchiati, tutta una scenografia teneramente nouvelle vague, misteriosamente pop, in ostinata
controtendenza rispetto all'integrazione electrorock, obliquo controcanto al NAM e alle nostalgie
erudite dei Belle and Sebastian.
recensioni
63
Insomma, Alasdair MacLean e soci si costruirono il
loro piccolo regno tra le nebbie spazio-temporali
dove piroettavano struggimenti asprigni e bucoliche
palpitazioni che avresti detto tanto Left Banke
quanto Galaxie 500, tanto Zombies quanto
Bee Gees. Negli anni sono stati bravi, più bravi di
quanto avrei mai potuto immaginare, a capitalizzare quell'intuizione. I successivi lavori hanno saputo
evitare d'incagliarsi grazie ad accorti, impercettibili spostamenti. Anche questo Bonfires On The
Heat ci riesce. Si sposta di poco, ma si sposta. Grazie ad una febbricola bossa/soul che condisce certe
situazioni (la disinvolta I Wonder Who We Are, la brividosa Never Saw Them Before, la funkeggiante Share
The Night) e ad una più marcata attitudine psych (gli
esotismi sciropposi di Harvest Time e Graven Wood, il
turgore errebì di Sketch).
Per il resto sono più o meno i soliti tremori pop in
differita da un Eden indolenzito, come Never Anyone
But You, la dolciastra Walking In The Park e la title
track. Un bel po' di quella meravigliosa caligine si è
dissolta, ma la musica dei Clientele riesce ancora a
sembrare un luogo a se stante. (6.6/10)
Stefano Solventi
Cornershop - Judy Sucks A Lemon
For Breakfast (Ample Play, Luglio
2009)
G enere : H indu meta - pop
Ad eccezione di un singolo - Wop the Groove - pubblicato in sordina nel 2006, era da ben sette anni
che dei Cornershop non si avevano più notizie di rilievo. Vittime forse dell’inevitabile turnover di inizio
millennio, volto inesorabilmente a spazzare via ogni
residuo ’90s? Piuttosto, di una politica discografica e
manageriale che, in seguito al successo planetario di
Brimful Of Asha (croce e
delizia per qualsiasi band,
una bomba pop di quella
caratura lì) li avrebbe irrimediabilmente danneggiati, tanto che oggi questo Judy Sucks A Lemon
For Breakfast preferiscono pubblicarselo da soli
tramite il loro sito web,
con l’appoggio del distributore internazionale Cargo nonché dei soliti amici del negozio Rough Trade
di Notting Hill. Segno dei tempi, diremmo, laddove al contrario la musica è rimasta sostanzialmente
la stessa - ed è una benedizione, perché la formu64
recensioni
la anglo-indiana di Tjinder Singh e i suoi continua
a suonare originale e frizzante esattamente come
dodici anni fa: soundtrack di una cultura favolosamente underground che miscela T. Rex, Kinks e
Stones con Bollywood (Who Fingered Rock’n Roll,
la title track, The Roll-Off Characteristics), in grado di
trattare un classico di Dylan (The Mighty Quinn) con
la stessa naturalezza del folk Punjabi (Free Love, impiastricciata di lounge) o del gospel (The Turned On
Truth), indugiando oggi come allora in tentazioni club
forse adesso un po’ datate (ma è solo questione di
tempo, e torneranno di moda anch’esse, vedrete);
insomma, l’usuale e adorabile frullatore meta-pop
alla Super Furry Animals, peraltro anch’essi
redivivi e anzi attivi più che mai. (7/10)
Antonio Puglia
Cosmetic - Non siamo di qui (La
Tempesta Records, Ottobre 2009)
G enere : shoegaze
Ammettiamolo: dichiararsi nelle note stampa estimatori e potenziali prosecutori della parabola artistica di formazioni come My Bloody Valentine
e Sonic Youth è un po' tirarsi la zappa sui piedi.
Anche perché si parla di esempi fulgidi di creatività
sopra le righe ed essere all'altezza delle aspettative
generate da accostamenti del genere potrebbe seriamente diventare un'arma a doppio taglio. A meno
che, naturalmente, non abbiate la personalità di un
Thurston Moore o il genio musicale di un Kevin Shields, ma non è il caso dei Cosmetic.
In Non siamo di qui i Nostri fanno il loro dovere
credendoci fino in fondo, collezionano qualche momento particolarmente riuscito - sopra a tutti Bolgia
celeste ma anche il punk-gaze di Via Maj -, lavorano
di buona lena su suoni espansi in bilico tra chitarre
rumorose e pop, psichedelia e melodie eteree. Eppure la sensazione è che manchi la zampata finale,
quel quid in più capace di farci pensare soltanto alla
band romagnola quando ascoltiamo un pezzo come
Sangue + sole e non a miriadi di formazioni meno
elettriche ma orecchiabili allo stesso modo.
Alla fine i pregi e i difetti di Non siamo di qui sono
più o meno gli stessi del disco d'esordio Sursum Corda, ma da quel disco sono passati due anni e la produzione, questa volta, sembra essere di quelle serie.
Il che ci fa pensare che in futuro, da queste parti,
grossi stravolgimenti non si vedranno.(6.6/10)
Fabrizio Zampighi
Cribs (The) - Ignore The Ignorant
(Wichita Recordings, Ottobre 2009)
G enere : I ndie - angul ar
Doppio poker per la band di Wakefield: quarto album e organico esteso a quattro grazie all'acquisto
di sua maestà Johnny Marr, in pausa (?) dai Modest Mouse.
L'arrivo dell'ex-Smiths però non basta a smuovere la formula del gruppo dalle secche pop-punk à la
Clash con ansia vocale Strokes / Bloc Party se
non in qualche dettaglio di arrangiamento, una morbidezza maggiore, qualche arpeggio e poco altro.
Le cose migliori, oltre ai testi e Victims of Mass Production, risultano quelle più Lloyd Cole, vedi Save
Your Secrets o l'alternanza morbidezze-esplosioni di
City Of Bugs, mentre la conclusiva Stick To Yr Guns
dovrebbe indicare strade future indirizzate alla jam
(ma solo nelle dichiarazioni del cantante).(6.2/10)
Giulio Pasquali
Crown City Rockers - The Day After
Forever (Gold Dust, Settembre
2009)
G enere : hip - hop
Terzo album per il gruppo di Oakland, a cinque anni
dall'ultimo. Approccio strumentale alla Roots, ma
solarità alla De La Soul, e modo di porgere la
traccia alla A Tribe Called Quest.Tutte influenze queste peraltro dichiarate. Hip hop con basi nella
funkerie, spesso molto piacevole, con inevitabili deviazioni rnb-soul-jazzy, all'insegna di una contaminazione che fa molto crossover Novanta. La voce, aperta
e non particolarissima nel timbro, appare spesso un
po' troppo caricata nella sua convenzionalità rap,
quando invece in certi momenti un ammorbidimento avrebbe giovato. Scanzonato, da marciapiede a ridosso della spiaggia, d'intrattenimento, senza picchi
particolarmente notevoli, anche se Soul, nell'inciso
al limite del Ninja Rap dei Vanilla Ice, e il discofunky di Kiss, già nell'EP che anticipava, sono assai
efficaci e assai ci piacciono.(6.4/10)
Gabriele Marino
Dam-Funk - Toeachizown Vol. 3: Life
(Stones Throw, Settembre 2009)
G enere : space - synth bl ack
Seguiamo Dam nella sua pentalogia. Siamo sui livelli
di Fly, ma con un (inevitabile?) serpeggiante sentore di auto-riciclo. Abbagliati dal primo capitolo,
LAtrik, eccezionale, ci aspettiamo qualcosa di più.
Stavolta la voce è spalmata su tutti i pezzi, per metà
dissolta dal vocoder.Tre pezzi ottimi, da soli valgono
il digital EP (6 dollari, 4 euro), e due trascurabili. La
batteria alla Neffa, tipo Il mondo nuovo, e i soliti giochini di synth, gestiti benissimo, della lunga Could I Be
Losing Another Love?; il soul e poi il rappato rilassatissimo di One Less Day; l'r'n'b di I Wanna Thank U, canzone semplice e diretta, senza trick, di cui Dam si
dichiara soddisfattissimo. E Dam, quando ci si mette,
ha un tocco, un gusto, un'atmosfera unici.(6.9/10)
Gabriele Marino
David Bazan - Curse Your Branches
(Barsuk, Settembre 2009)
G enere : F olk
Pedro, il nostro leone preferito, torna a ruggire malinconico. Erano altri tempi, infatti, quando David
Bazan dava alla luce album memorabili sotto la sigla
Pedro The Lion. Dismessa quella nel 2004, si è
occupato di altri progetti a tempo perso, per poi
firmare a proprio nome Fewer Moving Parts, ep edito
dalla Barsuk. Stessa etichetta per la quale esce
ora il suo primo album
vero e proprio.
Amore e fede cristiana sono sempre stati i
due temi base delle sue
liriche, e non fanno eccezione le dieci canzoni
contenute in Curse Your Branches. Ciò che invece
sembra variare, come già avvertimmo due anni fa
sull'ep, è l'approccio musicale: il suo folk si discosta
lievemente dall'indolenza slowcore per abbracciare
in alcuni episodi una solarità pop prima inaccessibili
(Please, Baby, Plese e When We Fell). Ma, nonostante
questa apertura, i migliori momenti dell'album sono
comunque quelli in cui i ritmi rallentano e la voce
ritrova quella calda e profonda cupezza dei bei tempi in grado di straziare ed emozionare all'ascolto,
come avviene nella title track, nella bellissima Lost
My Shape e in In Stitches posta in chiusura. Un album
nostalgico, che non riesce ad equiparare i livelli raggiunti con il leone, ma che comunque riscalda come
una comoda felpa in autunno, solo un poco più più
colorata.(6.9/10)
Andrea Provinciali
Deradoorian - Mind Raft (Lovepump
Records, Luglio 2009)
G enere : heavenly voices
Verrebbe da pensare che la curiosa storia della nascita di Angel Deradoorian riportata nella pressrecensioni
65
sheet - semi-strozzata dal cordone ombelicale e
salvata solo dal padre musicista che così le avrebbe
trasmesso l’amore per la stessa - sia stata inventata
per mettere un po’ di sale su questo esordio. Il fatto
è però che la 22enne americana non ne ha proprio
bisogno di storielle, né questo mini album d’esordio
necessita di aggiunte di sale visto che saporito lo è
già di suo.
Una voce celestiale quella di Angel, già collaboratrice
di Dirty Projectors. Una di quelle che, se non ci
fosse nessun altro strumento a circondarla, avrebbe
ragione d’esistere lo stesso. E infatti di strumenti ce
ne sono pochi - uno spruzzo di elettronica, qualche passaggio acustico di
chitarra, qualche battere
di percussioni - perché il
fulcro di tutto è la voce
di Angel. Qualcosa che
tratteggia paesaggi a
metà tra sognanti panorami 4AD e minimalismo
Heavenly Voices struggente e accorato, dimensione panica e folk da immaginario fantasy, con una
particolare inclinazione per malinconia e crepuscolari tensioni. Il tutto si manifesta al suo meglio nel
capolavoro finale Moon, vera e propria escursione
cosmica dal sapore mediorientale. Ottimo esordio,
peccato solo per la brevità.(7/10)
Stefano Pifferi
Devilrock Four (The) - First In Line
(Unconform, Ottobre 2009)
G enere : R ock
Olè! Siamo di nuovo negli anni '70, e chi vi scrive
(per l'occasione solamente) s'è infilato un bel paio
di calzoni e zampa di elefante e s'è fatto crescere un
due bei baffoni a manubrio. Dirty Little Secret, prima
di affondare nelle nebbie di un generic hard rock
molto radiofonico, parte con un tappeto di chitarre molto primi Black Oak Arkansas. Poi, però,
finisce lì. E i Devilrock Four nonostante il pedigree temibilissimo (provengono dall'Australia) non
graffiano come i Radio Birdman farebbero, né
fanno fuoco e fiamme come i fu Lime Spiders.
Né tantomeno stanno idealmente al passo con molti degli eroi ferocissimi che fecero grandi le musiche
da quelle parti. No, qui il piglio punky melodico e
aggressivo ci sarebbe anche, ma questi 'quattro del
rock del diavolo' si smosciano appena partiti, e si
sgonfiano in ritornelli melodici senza nerbo che ne66
recensioni
anche la peggior band Epitaph post-1996 oserebbe
far propri. Che dire infine degli splendidi intermezzi
elettrici Deniz Tek-style, che però si smosciano improvvisamente come soufflè bucati: proprio sul più
bello e lasciandoti l'acquolina in bocca(5.5/10)
Massimo Padalino
Did - Kumar Solarium (Foolica,
Ottobre 2009)
G enere : post - punk
Post punk urbano affilato, elettronica, ritmiche da
dancefloor. Come dire Torino - città di provenienza del gruppo - con i suoi sussulti sintetici da club
culture che incontra i Liars e in mente ha i Gang
Of Four. Dove sta' la novità? Nel sorriso mutante
che questi Did mostrano alle telecamere quando
sovrappongono distorsioni rovinose à la Sister Ray
a un battere immobile (Sex, Sometimes); nel fascino
discreto di un tropicalismo laptop da dejavù (Time
For Shopping); in una new wave quadrata ma anche
irrimediabilmente pop (Solarium).
Questione di pesi specifici e di particolari, insomma,
di equilibri sottili e di buona tecnica.
Perché non ci vuol niente ad annoiare quando fai
proclami in un idioma così inflazionato com'è oggi
il post-punk; perché per suonare pretenzioso e
indisponente basta poco, se traffichi con materiale proto-modaiolo come potrebbe essere quello
contenuto in Kumar Solarium. Eppure i Did
ci catturano con il loro mix attento - e furbo - di
cool e buone intenzioni. Arrivando a farci muovere
a tempo senza badare al nostro senso del ridicolo ma soprattutto riuscendo a tenerci appiccicati al lettore per tutti i 40 minuti di programma.
(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Drums (The) - Summertime EP / The
Drums EP (Moshi Moshi, Settembre
2009)
G enere : S miths pop
Con un bootleg divino come The Drums EP già da un
paio di mesi in giro per la rete, l'attesa per il vero
debutto della band si è fatta spasmodica. Summertime! il nuovo eppì è uscito negli USA per la Twenty
Seven il 15 settembre, mentre la release europea
(sotto Moshi Moshi) è prevista per ottobre.
Nel frattempo, il 28 esce il superbo singolo Let's Go
Surfing contenuto in entrambe le uscite, nonché manifesto per eccellenza dei ragazzi. Il sound è tra i più
ovvi, cesellato nel più istantaneo dei modi pop ma in
highlight
Lightning Bolt - Earthly Delights (Load Records, Ottobre 2009)
G enere : avant noise
L’attacco è devastante. Il basso ultradistorto svisa di effettistica varia
e la batteria martella a più non posso. Ma è lo stacco che precede le
urla belluine che segna da subito, dopo nemmeno un minuto, l’atteso
comeback dei Lightning Bolt. È pura incitazione all’headbanging e,
insieme, al trattenere il fiato prima di gettarsi da un ponte attaccati ad
un bungee-jumpy con l’elastico rotto.
Sangue e materia, sudore e devasto. Come al solito. Tanto che, arrivati
alla fine dell’opener Sound Guardians - guarda caso che titolo eh? - si
è stremati, sconvolti, totalmente in balia dei due Brian ma non per
questo appagati. La selvaggia liason col metallo pesante continua pure nella seguente Nation Of
Boar: furibonde scale ascendenti di basso in overdrive e mid-tempo hard-rock cafonissimo eppure
fatale, al punto che quando arriva la pseudo stasi di Colossus - abisso noise-dub come degli Om
messi in centrifuga - si accoglie come una liberazione. Oasi di pace effimera, in verità, perché
appena giunta al termine dei suoi 7, interminabili minuti The Sublime Freak riprende l’orgiastico
sabba tribal-rumoristico. Spettacolo al quale assistiamo senza noie né cedimenti di ispirazione da
un decennio buono e una cinquina scarsa di dischi/dvd.
Insomma, le delizie terrestri che i due imbandiscono sono come un concerto hardcore old
school suonato da 10 gruppi di noisers sotto speed in uno scenario da ecatombe PaperRadiana.
Coloratissimo e ferocissimo. Materico allo sfinimento. Come al solito, direte voi. Ma la coppia Gibson-Chippendale non mostra la corda, affatto. E anzi usa linguaggi forse inusuali o meno classici,
mantenendo intatto il furore primitivo e iconoclasta. La filastrocca pre-bomba H di Funny Farm ne
è esempio, così come le frantumazioni (ehm) melodiche sospirate in Rain On Lake I’m Swimming
In - acquosa e diluita come da titolo - o nel conclusivo tour de force post-kraut Transmissionary
che abbrutisce gli Oneida più incompromissori e psichedelici regalandoci l’ennesima gemma di
un rosario del rumore. Che il god of thunder garantisca lunga vita ai Lightning Bolt.(8/10)
Stefano Pifferi
49 minuti complessivi ti polverizza il catalogo Labrador recente. Per una volta NME e compagnia brit
assortita c'hanno visto giusto: il coraggio di crederci
in un sound abusatissimo ha ripagato: post punk milkshake Sarah Recs e la Factory sintetica più leggera.
Tutto esaltante perché se proprio la Factory si fece
sfuggire quella volta gli Smiths, da loro e dall'ugola
del Moz (e certi Cure infantili virati surf) che si
aggira il fenomeno post-eighties del 2009.
E c'è un neo in tutta questa celebrazione ed è il pasticcio Summertime!, un punto inferiore al bootleg perché se nel dischetto non manca la giocosità sixties di Submarine, lo spy-surf singolone Let's Go
Surfing e il lentone Down By The Water all'appello non
ci ritroviamo la Strokes-iana Me And The Moon,
l'irresistibile otto bit di I'll Never Drop My Sword e
soprattutto lei, la super smithsiana I Felt Stupid che
è roba per la quale i fan di Pete & The Pirates
potrebbero vendere la madre. Ok, c'è Saddest Summer, Robert Smith in spiaggia a Malibù sotto anfetamina, ma non è la stessa cosa.
Per comodità e, in attesa del debutto lungo, daremo un voto complessivo al materiale a disposizione
svelandovi pure che, nonostante l'ostentazione albionica, le due penne The Drums sono americane
e tutto il materiale è nato in Florida sfondando poi
nel giro di New York.
Eppure questi ragazzi sono nati a Manchester. Proprio non li distingui dai classici inglesi tristi che sognano di surfare nell'oceano con sottobraccio le
chitarre, la disperata allegria, il cuore pieno di nostalgia. Ancora una gemma dell'eppì unrealised Best
recensioni
67
Friend, 4 secondi di twee e il resto in giostra pop.
Strike totale.(7.5/10)
Edoardo Bridda
Eagle Twin - The Unkindness of
Crows (Southern Lord, Agosto
2009)
G enere : D oom /P ost - core
Gentry Densley non ha mai fatto dischi facili. Non
lo erano quelli degli Iceburn Collective e non
lo era neppure l’ominimo degli Ascend (con Greg
Anderson). The Unkindness of Crows, della sua nuova
creatura Eagle Twin, sembra navigare in territori
da principio conosciuti
e consueti per chi bazzica Southern Lord e
dintorni: voce cavernosa,
ritmi al ralenti, chitarra
poterosa e lungi drones. Eppure è soltanto
un miraggio di un album invero disorientante. Il doom metal di marca Cathedral si trasforma
in divagazioni post core di stampo Neurosis, qua
e là spuntano fantasmi Earth (Pentastar e Thones
and Dominions). Da tempo non ci capitava un disco
metal/post-core così “progressivo”, con continui
cambi di tempo e riff, cementato da una pensatezza
e un’oscurità che lo tiene saldamente aggangiato al
presente.
Non sbaglia chi lo definirà un superamento del
canone neurosiano, il disco gli Om non sono ancora riusciti a fare, o ancora, quello che avrebbero
potuto fare i citati Earth se solo avessero resistito
alle tentazioni post-country/rock. E ci piace che sia
uno come Gentry a sfornarlo, uno che tanto aveva
dato nei anni '90 e poco ci ha regalato in questi '00.
(7.5/10)
Nicolas Campagnari
Editors (The) - In This Light and
On This Evening (Kitchenware
Records, Ottobre 2009)
G enere : electro - pop riciclo
Inutile accanirsi troppo. Il problema degli Editors
non è che rifanno (siamo nel 2009!), ma che rifanno
male. E che sono autocompiaciuti e - incredibilmente - prolissi.Voce baritonale un po' Morrissey, ma
addolcita, e riciclo electro-pop ad oltranza. Musicalmente, si salva pochissimo, sempre e comunque
in un regime romantic new new wave stanchissimo. I
68
recensioni
testi invece è proprio meglio lasciarli stare. E poi,
l'inciso di tastiera di Bricks and Mortar è una specie
di plagio camuffato di quello di Hey Ya! degli Outkast. (5/10)
Gabriele Marino
Ethernet - 144 Pulsations Of Light
(Kranky, Ottobre 2009)
G enere : ambient
Classico prodotto di scaffale per Kranky. Ethernet è
il nome d’arte di Tim Gray, un altro (probabilmente
l’ennesimo) drone master che approda sull’etichetta
di Chicago. In un anno in cui il massimo nel genere
probabilmente è stato dato dalla coppia Darwinsbitch - Gregg Kowalsky, con una coppia di
lavori tanto all’avanguardia quanto difficile da decifrare, un disco come questo, con le sue pulsazioni
Seefeel che sanno di vecchio quanto un vecchio
nastro sony dimenticato in soffitta rischia di non
lasciare null’altro che un’oretta scarsa di comoda
ambient d’arredo di stampo elettro.
Il massimo dell’attualità che possiamo riscontrare
sta semmai nella gelida tachicardia elettronica virata
Roland Tr-808 che mima confusamente sia i boschi di
GAS che i gelidi panorami antartici Deepchord.
Poca cosa per uno che in fase di press release si
produce in siffatta mission: “L’intento dell’album è di
produrre un viaggio interiore che vada di pari passo con
la propria presa di coscienza, viaggiando verso nuovi
stati di consapevolezza”. Messo come disco di sottofondo va anche benissimo, ma un disco del genere
non ha comunque molto senso arrivati alla chiusura di un decennio che ha prodotto vagonate intere
di dischi analoghi anche più riusciti e interessanti.
Qualsiasi riferimento a Pan American o Stars
Of The Lid è voluto.(5/10)
Antonello Comunale
Evangelista - Prince Of Truth
(Constellation Records, Ottobre
2009)
G enere : apocalypse now
Di nuovo sul proscenio con il consueto carico di
livore, Carla Bozulich produce il suo terzo lavoro in
quel di Montreal. Un disco che ruota intorno all’ormai canonico standard a base di romanze blues fatte d’archi e d’apocalisse funzionando un po’ come
sintesi perfetta tra tutti i suoi lavori prodotti fin’ora.
La vera verità di Evangelista parte III è la discesa
inarrestabile negli inferi, sia pure con una smaliziato
sfoggio di maniera. In questo senso Prince Of Truth ti
da esattamente quello che ti aspetti, ma quello che
perde in sorpresa, lo acquista in disegno di insieme e
in compiutezza. Dopo pochi ascolti, il sospetto che
questo possa essere preso come il lavoro definitivo
della Bozulich in versione Evangelista non smette di
tormentarci, più o meno nella stessa maniera con
cui la plumbea nuvola d’archi d’umor di tenebra introduce il disco al suono di The Slayer.
Sulla produzione del disco, quello che è dato di sapere è che Carla per colpa di un’infezione alla gola
presto tramutatasi in polmonite, è costretta ad abbandonare le primissime sessions all’Hotel2Tango
con il resto della band impegnata a terminare da
sola le parti strumentali. Solo in un secondo momento arriva il suo intervento, con un abile metodo di taglia e cuci messo in atto grazie al supporto
della fidata Tara Burnes. Si spiega cosi forse l’intervento vocale quasi estraneo o meglio quel taglio
salmodiante di chi ragiona su un mondo che non
gli appartiene più. Stavolta il recitato di Carla sa di
radiodramma, di registrazioni sopravvissute a chissà
quale catastrofe. Nelle sue parole c’è una freddezza
terribile che stride con il furore tragico dei passati
dischi. La tempera in cui sono intinti i brani è comunque la più nera che è data di ascoltare di questi
tempi.
Gli umori thriller di The Slayer si stemperano
nell’arietta post orchestrale di Tremble Dragonfly
per poi diventare il fantasma di un country ormai diventato un ricordo preistorico in I Lay There in Front
Of Me Covered in Ice. Fin’anche le cadenze jazz nella
terra di mezzo composta da Iris Did’nt Spell e Crack
Teeth non riscaldano, semmai gettano un’ombra di
fatalismo ulteriore prima della apocalisse finale di
On The Captain’s Side. La quint’essenza della Bozulich. Più nero di così c’è solo la morte.(7.3/10)
Antonello Comunale
Factorymen - Shitman (Richie
Records, Ottobre 2009)
G enere : weird synth
È curioso vedere come due esperienze partite da
posizioni affini si siano sviluppate nel tempo in maniera assai diverse. Era l'inizio del 2008 quando la
My Mind's Eye pubblicava il primo, omonimo Ep dei
FactoryMen, side project di Steve Peffer degli Homostupids, e Mr. Mike Sniper (dei DC Snipers)
aveva anch'egli da poco intrapreso il suo progetto
- ora celeberrimo - Blank Dogs.
I due muovevano dall'attitudine garage-punk dei rispettivi gruppi di provenienza e ciò si sentiva nella
scarnezza ed immediatezza delle composizioni di
entrambi. Blank Dogs poi è stato preso sotto l'ala
della Sacred Bones ed è diventato l'inarrestabile
sfornatore di dischi in
vari formati e durate che
conosciamo bene. Ecco,
FactoryMen
avrebbe
potuto sostanzialmente
fare lo stesso ed invece
no; al posto di muovere verso un labor limae
in chiave pop dei propri
pezzi, Steve Peffer è stato
fermo dov'era, prendendosi il suo tempo per ''scrivere'' i nuovi brani per quest'album. Così si continua
sulle stesse coordinate del primo Ep: synth funerei
(Bark Like A Dog) e truci filastrocche rigonfie di malsana demenza elettronica (Alleyman) che ricordano
al pari Dark Day, Nervous Gender e Residents. Sul lato B si spinge ancor di più il pedale
della malattia mentale, con pezzi totalmente deliranti come Treblinka e Blank Dream. Talvolta la dose
di molesta stupidaggine impiegata può sembrare eccessiva e leziosa, ma questo e soprattutto questo è
FactoryMen.(6.9/10)
Andrea Napoli
Fat Freddy's Drop - Dr Boondigga &
The Big BW (The Drop, Giugno 2009)
G enere : reggae - dub - soul
Serata in un lounge-bar con un amico metallaro, a
un certo punto cominciamo a seguire la musica di
sottofondo. Andiamo a chiedere al barista di cosa si
tratta. Ci porge un digipack con una copertina a cartoon, un'enorme piovra che attacca una scialuppa. I
Fat Freddy di Based On A True Story. Un
morbido cocktail, jazzato non shakerato, a base di
rilassato reggae-dub e vocalità dalla pastosità soul,
molto curato nei suoni e negli arrangiamenti di fiati,
sicuramente ruffiano, ma perfetto come sottofondo
notturno.
Questo secondo long dei neozelandesi (delle star
in patria) resta fedele alla morbida formula, il cui
cuore è quella soul-inflection della voce (ribadita da
riprese live di un classico assoluto come la Dock
Of Bay di Otis Redding), vedi tutta una serie di
pezzi vellutatissimi a seguire l'iniziale, bellissima, Big
BW. Se dal vivo il gruppo si trasforma praticamente
in una jamband, il disco resta perfetto come sottofondo notturno, non nel senso della tappezzeria, ma
di una musica per un club dove non si balla ma ci si
recensioni
69
highlight
Luciano - Tribute To The Sun (Cadenza Records, Ottobre 2009)
G enere : etno - minimal
L'evoluzione dei mostri sacri della minimal. Da un lato Ricardo Villalobos sempre più eterogeneo e non catalogabile, dall'altro Bruno Pronsato che si cristallizza. L'altro vertice è Lucien Nicolet.
La sua sensibilità si sposta a sud. E il suo nuovo album è il manifesto
di un ritrovato sapore etnico che ha nelle vene il balearico tramonto
ibizenco (e i natali cileni dell'uomo). Un disco difficilmente catalogabile.
La minimal viene frullata in un composto di marimbe e balafon ancestrali (Hang For Bruno), l'Africa compare in una danza tribale con dei clap assassini e dei cori che
ti si stampano in testa e che non ti mollano più (Africa Sweat appunto), e per finire una fetta di
Sudamerica che riporta Luciano a casa (Los Niños De Fuera è l'incipit da panico). Non solo viaggi
comunque. La certezza del club è sempre lì in agguato e allora in conclusione l'uomo ci regala due
pezzi lunghissimi: Metodisma è un'incubo deep senza mezzi termini e Oenologue la classe targata
Cadenza che ti si attorciglia sulla spina dorsale e ti costringe a muovere il culo.
Il secondo disco (dopo 9 anni dal primo) di un boss che spazia e che nelle tasche ha solo assi.
Ne sentiremo sicuramente riparlare. Per chi scrive disco minimal dell'anno. Hands up for Luciano!(7.7/10)
Marco Braggion
muove sinuosi. E loro restano bravi nel riempire i
piccoli spazi di variazione che la formula riserva. Ma
potrebbero dare molto di più.(6.6/10)
Gabriele Marino
Filthy Dukes - Fabriclive 48 (Fabric,
Ottobre 2009)
G enere : compil ation electro fidget disco
Nella compilation dal vivo dei Filthy Dukes incontriamo il gotha now del dancefloor à la page. I nomi
ci sono tutti: si va dalla progressività retro di Phenomenal Handclap Band e di Who Made
Who al tiraggio fidget di Mr. Oizo e di Tiga. In
più gli immancabili classici targati Daft Punk (in
remix per Soulwax) e Aphex Twin. Un set che
parla di divertimento puro e che con gli inserti degli
stessi DJ londinesi (famosi per le notti del Kill Em
All a Camden) non stanca, anzi fa il punto della situazione in modo più che egregio. Se volete aggiornarvi
o semplicemente non avere pensieri alla consolle,
schiacciate il tasto play e ballate. (6.5/10)
Marco Braggion
70
recensioni
Fink - Sort Of Revolution (Ninja
Tune, Maggio 2009)
G enere : I ndie folk
Il terzo disco post-svolta di Fink porta la quasi rivoluzione del titolo, che consiste in realtà in una
messa a punto, una focalizzazione verso uno stile
che accentua il minimalismo e i toni sommessi, al
punto che le nuove canzoni riecheggiano lo Smog
meno rock, sia come timbro vocale che come mood
generale.
Ma non si tratta di passo indietro verso quel tipo di
canzoni presenti in Biscuits For Breakfast e quasi del
tutto abbandonate in Distance and Time a favore di
un folk-rock a modo suo classico, quanto invece di
un consolidamento della propria voce e della coerenza stilistica.
Gli altri strumenti, ancor più che nei due precedenti
capitoli, si limitano ad intervenire qua e là per accentuare o sottolineare (fanno eccezione Maker e il
piano di John Legend in Move On Me), lasciando
al centro la chitarra acustica e la batteria, le quali ora
assecondano le ballad ora ci giocano di contrasto
movimentandole ed evitando di finire in una versione slacker del lato B di Berlin: la prima con pennate
da Kaukonen solista (la title-track, Nothing Is Ever
Finished), la seconda suonando i sedicesimi come se
fossero quarti, con ritmi che mostrano qua e là il dj
che Fink fu.
Un gioco condotto sul filo del dettaglio e del particolare, con gusto e delicatezza di tocco che dà brio
anche al gospel senza fretta di Q & A e che fa sparire
la sutura tra le canzoni scritte e il modo di presentarle.(7.1/10)
Giulio Pasquali
Firekites - The Bowery (Own
Records, Settembre 2009)
G enere : folk post
Gioca a passare inosservato, questo The Bowery,
esordio per il combo australiano Firekites, un trio
espanso, per così dire, tanto che alla fine per contare i musicisti coinvolti ci vogliono le dita di due mani.
Così come dieci canzoni sono le canzoni in scaletta,
imperniate sull'arpeggio fervido e frugale di chitarre acustiche, sviluppandosi alla bisogna tra morbide emulsioni di moog e
l'accorta pressione del
basso. Gli archi che pettinano un malanimo che
diresti mitteleuropeo e
ricami sintetici mai troppo invasivi completano il
panorama strumentale,
mentre la scrittura ciondola tra inquietudini folktroniche, estasi post e digressioni latin-tinge.
Potrebbero sembrare i Kings Of Convenience che suonano un repertorio Notwist con la
produzione di Jim O'Rourke, oppure un morbido ibrido tra The Sea And Cake e American
Analogue Set, però quando alla voce c'è Jane
Tyrrell - interessante ugola da Melbourne - tempo
un attimo e ti ritrovi in mezzo a paturnie sintetiche
come una Feist in fregola Laika.
La mancanza di intuizioni forti, di espedienti ad effetto, rende la musica dei Firekites un ottimo lenitivo per le nostre teste piene di troppe cose. Ed è
anche quello che rischia di farla passare inosservata.
(7.1/10)
Stefano Solventi
Flaming Lips - Embryonic (Warner
Music Group, Ottobre 2009)
G enere : prove tecniche di jam psych
Zaireeka (con polarità invertita) + (strascichi di)
Christmas On Mars + (i quasi cinquantanni di) Wayne Coyne. Una possibile equazione per spiegare
questo attesissimo Embryonic.
Zaireeka era il "disco Ikea" da ricostruirsi come possibile ognuno a casa propria, un gioco all'alea aperta
pensato per l'ascoltatore. Mentre qui sono i Lips
a divertirsi, più del solito, jammando chiusi in studio, scambiandosi gli strumenti, abbondando in effettistica. Del film, manifesto filosofico dei nostri in
chiave enigma b-scifi, restano le suggestioni in tutti i
sensi nebulose (e gli abusatissimi dream chimes della OST), calate in un contesto più tradizionalmente
psichedelico, come piace ai nostri: tra canzoni poprock-psych (quelle dell'EP che anticipava e giusto un
paio d'altre) e brandelli ora garagistici (più un paio
di puntate nell'hard) ora dilatatissimi a creare una
sorta di spacey-lounge al rallentatore. Molto autoriciclo anche, sia filo (dal loro passato) che ontogenetico (il disco si autocita). Come suona la cosa?
Come dei Red Krayola passati prima nella candeggina e poi nel latte?
Wayne Coyne è un believer, si capisce dai testi (misticismo naturalisco, estasi e dolore risolti in
due frasi e anche meno) e dalle dichiarazioni nel
presentare il concept (Il portiere di notte della Cavani, autosuggestioni astrologiche) del disco. Che
è sicuramente divertito (vedi Coyne che ride nella
- pare - improvvisata I Can Be A Frog, con Karen
O degli Yeah Yeah Yeahs al telefono), ma alla
lunga stancante, perché stiracchiato, autoindulgente, come un passatempo da ricconi. I pezzi buoni e
i momenti carini ci sono perché sono i Flaming
Lips, ma manca la scrittura, e questo va bene viste
le premesse, ma manca pure la visionarietà che ci
si aspetta da un progetto del genere: se questa è
la loro idea di jam psych-impro, la delusione monta
ancora di più.
Settanta minuti spalmati a tutti i costi su due compact, insomma giusto per il gusto del doppio. Edizione limitata con copertina pelosa e litografia autografata. Accolto finora esageratamente bene dai
critici USA, che però hanno anche cannato tirando
fuori parole come "prog".(6.4/10)
Gabriele Marino
Fuck Buttons - Tarot Sport (ATP
Recordings, Ottobre 2009)
G enere : electro - noise
Un’immagine mi rimarrà in mente pensando ai
Fuck Buttons di Street Horrrrsing, al di là
de fatto che tra dieci anni li riascolterò o meno. È
recensioni
71
l’empatia e il trasporto del tutto psichedelico che
il loro concerto rumorista provocò negli sguardi e
negli animi delle persone presenti.
Una chiave sottovalutata forse all’inizio dell’anno
scorso, quando uscì l’LP di debutto del duo, fu proprio l’immobilismo. Quello dell’ascoltatore di fronte
alla capacità dei Buttons di fare quella musica rispettando i tempi e le aspettative di ogni crescendo, di
ogni sviluppo sintetico. La domanda è allora: ma se
Tarot Sport non fosse più un disco che lascia
immobili a fruire dell’esperienza Fuck Buttons?
Il primo disco era così d’impatto perché dopo tanto
cervello nell’elettronica, tornava a fare le cose più
semplici e meno intellettualmente stimolanti. Qui
c’è solo un capitolo che riprende la gloriosa ondata
cervellotica degli ultimi quindici anni: Phantom Limb
(di cui peraltro c’erano avvisaglie anche in Ribs Out).
Ma è ancora ammirabile il modo in cui i Fuck Buttons riportino il tutto, sul finale del brano, alle loro
atmosfere emotivamente rilevanti, basate su reiterazioni continue di arpeggi azzeccati. L’elemento minimo della loro strategia, e il più vincente.
Del resto l’elemento ritmico, la cassa dritta o altri
prestiti della techno, sono l’unico segnale di spostamento del suono da Street… Un pallido segnale, che
si unisce all’unico altro cambiamento che è la sparizione della voce catartica e rumorista che punteggiava i picchi dei crescendo dell’album precedente.
E quindi è anche per fare di necessità virtù che ci
siamo focalizzati su questo per recensire il seguito
di quel primo capitolo. Insomma, quasi tutto secondo copione. È sempre la cosa più prevedibile un secondo disco che segna, con le conseguenti discese
(più o meno ripide) di entusiasmo, una continuità
rispetto al primo.
La conclusione è però un’altra. Quando si inizia ad
ascoltare Tarot Sport si cercano le differenze dal convincente esordio del duo. Ma poi si capisce, che è un
proseguimento del primo. Non sposta nulla perché
forse i due sono fissi sulla formula come il pubblico
che li osserva; e non hanno bisogno di cambiarla.
(6.6/10)
Gaspare Caliri
Gong - 2032 (G-Wave, Settembre
2009)
G enere : P rog opera
Mamma mia che ritorno in pompa magna. Per celebrare il loro quartantesimo - nel frattempo diventato quarantunesimo - compleanno, Daevid
Allen, Steve Hillage i redivivi freakdelici Gilli
72
recensioni
Smyth e Didier Malherbe onorano la mitica
ragione sociale che generò la trilogia della teiera
aggiungendole un nuovo capitolo. La saga di Zero
The Hero - e del fanstastico pianeta alieno - continua
e attaccando con un ispirato We come from an Alien
Nation to the city of self fascination quei vecchiacci ci
racconteranno persino dell'incontro tra il pianeta
Gong e noi terrestri.
Testardi hippy. Non c'è di meglio per descrivere
la produzione ordinata e la buona approssimazione rock del nuovo sforzo. 2032 non cerca di
sfidare la creatività e
l'irriverenza degli album
giovanili, senz'altro più
rustici e imprevedibili,
piuttosto distilla l'originale concept in un prodotto per adulti bambini
e bambini tout court.
Pur nelle immancabili autocitazioni (The Year 2032)
e nella compiaciuta cosmologia freak, il canovaccio
è fatto bene, sprizza energia e voglia di suonare, humour e rap.
Sì, del rapping prima maniera e una serie di espedienti che ricordano più i Roxy Music (Digital
Girl) addomesticati che il viatico Gong ci convincono che i quattro hanno la zampata che serve.
Approvato il rock come linguaggio per la vita, How
To Stay Alive porta a segno il gioco di rime nerdnegroidi. E ti rendi conto che anche l'ugola felpata di
Allen-nonno-mago è una bella sorpresa. Quando il
rap nacque, la leggenda narra che il nostro era tassista nella grande mela e se ci senti la Sugar Hill
Gang in Dance With The Pixies non è una sorpresa.
E Hillage? Vecchiaggio da sballo pure lui: liberatorio
sentirlo ingranre la marcia sull'autobahn in Escape
Control Delete, omaggio a Neu! incluso nel prezzo
- e occhio alle citazioni Alan Parsons Project
(non adatte ai più freak). Smith agli aggeggi spaziali
non manca di sollevare gli animi ma è per il sax soprano, il duduk e il flauto del divino Malherbe che
il tempo sembra essersi fermato.
2032 è uno spasso, una bella fiaba ma quando t'accorgi che non sembra avere fine non ti resta che
maledirli quei quattro, che non hanno perso il vizio di suonartela fino alla morte (vero Mariposa
live?). Ad ogni buon conto chi non vorrebbe Daevid
in famiglia se lo senta in versione punk in Wacky
Baccy Banker. Sapevate che tirando per i capelli il
glam vengono fuori i Sex Pistols? Chiedeteglielo
a all'australiano classe '38, avrà una storia anche per
quello...(7/10)
Edoardo Bridda
Grand Archives - Keep in Mind
Frankenstein (Sub Pop, Settembre
2009)
G enere : I ndie P op
Gli ingredienti ci sono tutti, esposti con mestiere e
molto garbo: le melodie stropicciate e leggiadre, le
immancabili nostalgie sixties (ovvero la stucchevolezza Beach Boys e il country aromatizzato Crosby, Still & Nash), quell’immaginario periferico e
gentilmente tardoadolescenziale che li accomuna ai
molti colleghi di casa Sub Pop (The Shins, Postal
Service, Fruit Bats).
Il problema è che poi - a metterli insieme - può capitarti fra le mani un dischetto come questo Keep in
Mind Frankenstein, secondo capitolo della formazione
capitanata dall’ex Band of Horses Mat Brooke:
gradevole, certo, epperò vagamente anonimo, con
quel retrogusto di già sentito - si, ma dove? - che
non sai se affibbiare alla mancanza di ispirazione o al
citazionismo più o meno deliberato cui si abbevera
la scrittura del nostro.
In ogni caso, le belle canzoni - come pure le good
vibrations - non mancano: Silver Among The Gold, con
il suo incedere lieve fra praterie assolate e brezzoline Grandaddy, la mestizia in salsa agrodolce di
Oslo Novelist, o il lievitante impasto di trepidazione e
spensieratezza di Dig That Crazy Grave, sono ottimi
esercizi country-indie-pop alla maniera di Wilco e
Iron & Wine che carezzano l’orecchio e promettono di rendere meno gravoso il rientro in città.
(6.5/10)
Nunzio Tomasello
Health - Get Color (City Slang,
Ottobre 2009)
G enere : tribal - noise
I losangelini Health aumentano ancor di più, se possibile, lo spessore di suono e ritmo in occasione
dell’atteso comeback. E se il flirt col secondo si era
palesato nell’esordio omonimo per essere poi corroborato dal trip dancefloor-oriented del progetto laterale HEALTH // DISCO (con vari remix
di Crystal Castles, Pictureplane et similia), è
l’attenzione sui suoni a segnare lo scarto in questo
nuovo album. Non che all'epoca mancasse qualcosa,
solo che adesso i quattro spingono di brutto sulla stratificazione per confezionare un album forse
meno intransigente ma sicuramente più focalizzato.
Nessun timore, però; la direttrice percussiva che
tanto ce li aveva fatti amare resta sempre la linea
portante del suono: ossessiva, reiterata, grassa è la
vera spina dorsale, l’asse su cui si inseriscono le varie infiorettature con cui il quartetto stratifica un
suono eccitante ed eccitato. Sono però proprio i
suoni a subire uno scarto significativo, una sorta di
mybloodyvalentinizzazione
che ispessisce la grana
dell’art-rock (che questo
è, in definitiva) e ne aumenta a dismisura potenzialità e resa.
Severin, Eat Flesh, il singolo Die Slow, Death+ sono
tutte prove magistrali di
questo procedere, tanto
che le coordinate degli Health che conoscevamo
mutano verso una sorta di techno-rock deforme, innervato sì, di nevrosi post-punk e tribalismo muscolare e in perenne tensione, ma anche e soprattutto
di instancabile e onnivora fagocitazione dell’esistito
(dalla no-wave più ritmata all’industrial più devastato) e dell’esistente (la scena coagulatasi intorno allo
Smell di cui sono splendidi protagonisti).(7.5/10)
Stefano Pifferi
Helena Espvall/Masaki Batoh
- Overloaded Ark (Drag City,
Settembre 2009)
G enere : minimal folk
Attonito. Di fronte alla bellezza del secondo album
realizzato da Helena Espvall e Masaki Batoh
ancora per Drag City. La prima oltre ad un'eclettica carriera in solo può vantare una solida partnership con i grandissimi Espers di Philadelphia,
mentre il secondo è stato il luminare dei Ghost,
oltre che una delle eminenze grige dello psych-rock
nipponico. Coadiuvati questa volta in studio da Haruo Kondo (cornamusa, hurdy gurdy), Junzo Tateiwa (darbuka, frame drums e percussioni) e Kazuo
Ogino (registratore, piano) licenziano un album che
fonde istanze minimaliste con uno spurio approccio
alla world music, per nulla ingentilito dai crismi della
moderna produzione o dalle cartoline preconfezionate dalla grande industria del disco.
A differenza del debutto ci sono anche una manciata
di brani autografi, come il mantra percussivo di Overloaded Ark - che rilascia addirittura un sibilo sinistro
al secondo minuto - che muove tra chincaglierie
recensioni
73
acustiche e valzer da Est Europa. O la lunghissima
Until Tomorrow che sbaraglia con fare solenne tutta la
concorrenza freak folk, avallando un certo esotismo
figlio delle congetture minimaliste di Terry Riley.
In sostanza siamo di fronte ad un lavoro che potrebbe rapire i seguaci di Ben Chasny / Six Organs Of
Admittance, come i cultori della psichedelia turca e gli aficionados dei suoni sponsorizzati da una
label come Sublime Frequencies. Un ponte tra
modernità e tradizione, nella delicatezza di arrangiamenti soffici, in una prospettiva quasi lisergica. Ma
c'è dell'altro: lo chansonnier ante-litteram Pierre
Attaingnant rivisitato in Tourdion (materia che
risale addirittura al 16°
secolo) , la musica classica di Pro Peccatis Sua
Gentis/Nun Fanget An ed
una commovente Sueno Con Serpientes
del cubano Silvio Rodriguez (del collettivo musical/attivista Nueva Trova
Cubana).
Nove tappe per un percorso sostanzialmente svincolato dalle rigide tematiche del debutto, un affascinante sussidiario stilistico che già ora si candida tra le
pubblicazioni più genuine di questo 2009. (7.8/10)
Luca Collepiccolo
Hercules And Love Affair Sidetracked (Renaissance,
Settembre 2009)
G enere : disco house
Prima, quando volevi sapere le influenze o le guide
spirituali di un artista, andavi a leggerti le interviste,
oppure, nel caso si possedeva il disco, gli special
thanks a piè Packaging. Oggi, con l’avvento delle
compilation volte a svelare il background artistico
del solista o gruppo che sia, si è perso in poetica
guadagnandone in voyeurismo. Però, diciamocelo,
hanno il loro fascino, anche perché a compilarle
sono gli artisti stessi. Cambiano i tempi, si adeguano
le manie.
Riposta la romanzina di cui sopra, affrontiamo Sidetracked, nuova ed ennesima serie sul tema - che
si stia speculando sul fenomeno, tuttavia, non è un
mistero - inaugurata dal vissuto di Andy Butler,
ovvero Sig Hercules & Love Affair. Butler, da buon
dj - perché ricordiamoci che il Nostro, prima di dedicarsi alle questioni amorose di Ercole, è e rimane
tale - seleziona e missa, nel primo dei due cd in
74
recensioni
questione, classici che lo hanno forgiato quali Todd
Terry (presente sia nelle vesti di Sax per No Pares,
Don't Stop che in Project con Class Action), Gino
Soccio (Dream On, al solito trascinante), Dr. Buzzard's Original Savannah Band (I'll Play The Fool), Daniel Wang (Zola Has Landed) e In Flagranti (I Hadn't
Screwed Around Before) tra i tanti. Nel secondo cd
buona parte delle tracce le si trovano nella veste
originale e rimasterizzate per l’occasione.
Da segnalare un inedito di Hercules & Love Affair, I
Can't Wait (dal taglio ipnotico molto ’90), e la mancanza di Situation dei Yazoo, l’episodio che trasformò il piccolo Andy da provetto pianista a futuro agitatore sonico.(6.7/10)
Gianni Avella
Hope Sandoval & The Warm
Inventions - Through The Devil
Softly (Nettwerk Music Group,
Settembre 2009)
G enere : dream country rock
Capisci che ci sta di nuovo provando già leggendo il
titolo del disco… per non parlare poi dalla copertina. A ragion veduta si può anche convenire che
forse non è necessariamente lei che ci sta provando
ma tutti quelle che le gravitano intorno, a partire
da Colm O'Ciosoig che messi da parte i My Bloody
Valentine rispolvera per la seconda volta dall’oblio
la sensualità fatata e svenevole di Hope Sandoval. Il
precedente album, pubblicato ormai ben otto anni
fa, era evidentemente una serie di estratti possibili
di un mancato disco dei Mazzy Star.
Bavarian Fruit Bread proseguiva il discorso
interrotto con la band madre e sembrava che nulla
fosse cambiato, salvo forse avvertire - ma neanche
tanto - la mancanza della chitarra di David Roback.
Ora assistiamo al ritorno dell’assassino sul luogo
del delitto e il giochino ammiccante si fa davvero
troppo scoperto per anni iper smaliziati come questi. La presenza scenica è sempre la stessa, un mondo ombroso e vellutato quello di Hope che ha fatto
a suo modo epoca, salvo poi difficilmente spostarsi
dal modello costruito da Roback nel post Opal con
la classicissima Fade Into You. Quindi è sempre, anche
qui, il suono di un country rock notturno e atmosferico che discende tanto dalle Trinity Sessions
dei Cowboy Junkies quanto dagli esperimenti
di Kendra Smith risalenti già all’epoca dei Dream
Syndicate.
Il copione quindi è già noto e il disco si fa ascoltare
con facilità, proprio perché è come un film di cui si
highlight
Mountain Goats - The Life Of The World To Come (4AD, Ottobre
2009)
G enere : indie rock
La capacità di John Darnielle alias la mente pensante dei Mountain Goats, di ricavare canzoni brucianti dai più vari input ci ha sempre sorpreso. Uno dei più fervidi scrittori di liriche oggi
in circolazione, con alle spalle una carriera iniziata nei ‘90 come outsider lo-fi e poi proseguita in
modo più o meno normalizzato in seno alla 4AD, ha non a caso nel curriculum una serie di concept tra il nonsense e il surreale, sempre sorretti da una vena musicale
variamente ispirata.
Non fa eccezione quest’ultimo, che arriva a un anno e mezzo di distanza dal febbrile Heretic Pride. Ora il pretesto narrativo è costituito
dalla poetica e dalle immagini bibliche. Pretesto perché è strumentalmente un filo conduttore che permette all’autore di spaziare in lungo
e in largo nella psiche sua e collettiva, come da consuetudine, alla
ricerca di virtù e debolezze, con l’ attitudine che gli riconosciamo tra
il mesto e lo psicotico, una strana miscela davvero.
Musicalmente il tutto viene scarnificato, rispetto al precedente, lasciando più o meno l’essenziale; vale a dire ballad in acustico, uso di uptempo, una vena rock e indie
pop che fa incontrare Robyn Hitchcock e i R.E.M. con gli archi, ma in parsimonia (arrangia
Owen Pallet alias Final Fantasy), una buona dose di psych pop virato freak che ci ha ricordato il buon Daniel Johnston in più di un’occasione, e in generale una semplicità e un’asciuttezza che in genere è il risultato di anni di lavoro. Che hanno pagato evidentemente.(7.3/10)
Teresa Greco
conosce già la storia. Blanchard, il primo estratto dal
disco, è una tipica ballad country rock che gioca lo
stesso ruolo che nel precedente album era di Suzanne; Wild Roses si appoggia ad un arpeggio flebile
ed evocativo e For The Rest Of Your Life si alimenta ad
una calda psichedelia californiana tutta riverberi ed
echi. Tutto il resto del lavoro non si sposta di una
virgola da questa triade iniziale e il risultato a lungo
andare nuoce gravemente all’interesse nell’ascolto.
Dopo un ritorno del genere è abbastanza chiaro
che Hope Sandoval si pone come classico da antologia. Di quelli che il pubblico cerca proprio per il
suo essere sempre uguali a se stessi.(6/10)
Antonello Comunale
Hudson Mohawke - Butter (Warp
Records, Ottobre 2009)
G enere : ritmi / wonky hop - tronica
Hudson Mohawke (Hud Mo per gli amici del
collettivo di Glasgow LuckyMe, Ross Birchard
per la mamma), classe 87, è uno dei buzz più attesi
al varco tra elettronica, produzioni e ritmi. La Warp
l'ha accalappiato quando ancora non aveva prodotto niente di ufficiale e gli ha licenziato l'ottimo Polyfolk Dance EP.
Qui Hud esplicita ancora di più la sua passione hiphop, che nutre questo disco allo stesso modo in cui
nutre un Harmonic 313. Per dire, due pezzi sono
con Oliver Daysoul, e siamo tra Outkast e SaRa, e due sono con (mirabile dictu!) Dam-Funk, e
si sente (All Hot è anche uno dei pezzi migliori).
Necessariamente meno compatto del cesellatissimo EP, questo long mostra una grande tecnica e una
grande facilità di produzione (leggi anche 'eclettismo'), tanto che un paragone con Mochipet, pur
con le dovute differenze, non appare campato in
aria. Hud è più psichedelico, più visionario e più elegante, meno pasticcione e meno nerd a-tutti-i-costi
(sempre di nerd si tratta però), anche lui giocoso
ma non così deformante (Velvet Peel, nota già dall'EP;
il finale di Black'n'Red). E anche in lui, sopra una base
consapevolmente wonky (3.30), non immune da farecensioni
75
scinazioni J Dilla, troviamo videogiochini e breakbit, a cui si aggiungono post-post-rave, post-Aphex
Twin e tastierine coriandolose.
Niente di nuovissimo, ma è tutto cucinato bene e
porto frescamente, con un tocco già riconoscibile
(vedi soprattutto il trattamento e le dinamiche della
batteria, Trykk). Chissà se Hud deciderà di specializzarsi, e su cosa. I pezzi cantati, che non ci aspettavamo, sono forse ancora poco personali, ma non
sono affatto male. Per la serie strano ma vero: le
tastiere di Gluetooth sembrano le chitarre-synth di
Allan Holdsworth; le prima note di Fruit Touch
citano forse la Sagra della Primavera di Stravinsky.
(7.1/10)
Gabriele Marino
Io Monade Stanca - The Impossible
Story Of Bubu (Africantape,
Ottobre 2009)
G enere : math - noise
C’è un’altra fetta d’Italia, periferica anch’essa, che
brucia di sommovimenti intestini come le Marche
indagate tempo addietro. Gli scossoni che giungono
dal basso Piemonte però - questo il luogo d’origine geografica dei tre Io Monade Stanca - sono decisamente più tellurici e pesanti: coagulata intorno
alla Canalese Noise, piccola etichetta amante del
rumore e delle pratiche diy, sta crescendo infatti
una scena intera di grezzo post-hc mutante, urlato
e difforme.
Come ogni regola ha la sua eccezione ecco i qui
presenti Io Monade Stanca: geneticamente inclini alla variazione math e prevalentemente strumentali (la voce c’è ma è come uno strumento, a
volte) sembrano la controparte cerebrale alle sfuriate dei compagni di merende (Ruggine su tutti).
Il trio, però, sopperisce
alle dubbiose questioni
tipiche di questo genere (concettismo strumentale o fredda perizia
senz'anima) con grandi
dosi di follia e autoironia.
Così si spiega il minuto
iniziale dell’opener Abete
43211234, tributo al panzer-rock melvinsiano che si
sfibra subito in un arpeggio post-rock made in Chicago, per continuare poi a rifrangersi in mille direzioni nei 4 minuti del suo sviluppo. Proprio alla windy city guardano i tre, ma se ne fottono altamente di
reiterare le gesta ormai fattesi storia di quella città
76
recensioni
e quei suoni. E così si buttano a narrare - a colpi
di frasi musicali nervose, epilettiche e fuori sincrono - le patafisiche storie di bubu, che immaginiamo
essere il fratello schizoide, senza freni inibitori, scalcinato e umorale dell’Ubu di Jarry. Ne riparleremo
a breve, sicuro.(7/10)
Stefano Pifferi
Islands - Vapours (ANTI-,
Settembre 2009)
G enere : pop
Vapours, terzo album della formazione di Montreal, vede il ritorno del cofondatore batterista Jamie
Thompson, che aveva lasciato la band dopo l’esordio Return To The Sea (2006). Gli Islands si
erano allora rifondati attorno a Nick Diamonds,
producendo l’anno scorso il pop stratificato ricolmo d’archi di Arm’s Way. Ora si ritorna agli equilibri precedenti e si sente.
La parola d’ordine per Vapours è innanzitutto
un certo minimalismo che non passa inosservato,
se paragonato al barocco del precedente: via allora
le orchestrazioni massive e largo alle ritmiche, caratteristica del passato. Allora il (guitar) pop prettamente melodico viene accompagnato questa volta
da synth, drum machine, sequencers e quant’altro
serva a dare anche smalto dance alla produzione. Si
mantengono, è da dire, salde tutte le caratteristiche
della band, melodia innanzitutto, slanci alla Arcade Fire e Stars, cambi alla TV On The Radio,
e tutto l’ampio repertorio che abbiamo imparato
ad associare in questi anni al cosiddetto “Montreal Pop”. Nell’album convivono allora le due anime
del gruppo, in pezzi come On Foreigner, Switched On,
la title track, dove l’ampiezza della melodia si sposa
perfettamente alla ritmica, e momenti prettamente
elettronici (il singolo synthato No You Don’t di forte
sapore Ottanta così come il funk di Devout, e gli
esempi potrebbero continuare).
In sostanza con Vapours si riesce a raggiungere
un equilibrio apprezzabile tra le diverse componenti musicali, segnando, se questa formazione dovesse
stabilizzarsi a questa maniera, una svolta significativa
e un arricchimento del sound Islands.(7.2/10)
Teresa Greco
Jim O’Rourke - The Visitor (Drag
City, Settembre 2009)
G enere : A vant pop
Chissà quale giubilo nell'incontrare un proprio
idolo come Van Dyke Parks in occasione del-
le session che hanno portato al concepimento di
Ys, il disco-gioiello di Joanna Newsom dato alla
luce per Drag City nel 2006. Mai troppo riservato
nel riconoscere i propri modelli, e sempre equidistante dalla mera esaltazione come dalla più bieca
abnegazione, O' Rourke da avido e scientifico consumatore di musica che è, ha fatto sempre in modo
di filtrare le sue più radicate passioni attraverso la
logica dell'esperienza. The Visitor è l'album in studio
che pone fine ad un silenzio quasi quinquennale,
se vogliamo mettere da parte il discreto numero
di ristampe - di materiale prettamente ambient e le effimere collaborazioni con artisti off (si pensi
alla sortita con Carlos Giffoni e Merzbow per
etichetta No Fun a titolo Electric Dress) che hanno
interessato il nostro.
è un disco - The Visitor che si inserisce nel solco
di Bad Timing, non portando in dote le magniloquenti aperure pop di
Eureka, nè tanto meno le
risacche più palesemente
elettriche di Insignificance. è un album a tutti gli effetti solista, registrato
in quel di Tokyo, sua attuale dimora. Un lavoro che
semmai amplifica l'idea di one-man big band, tanta
è la carne messa al fuoco da Jim, che in una singola traccia di appena 38 minuti, costruisce e smonta
con fare stralunato castelli, o meglio ipotesi musicali. Che fioriscono genuinamente per poi appassire in
pochi avventurosi passaggi, quasi che il nostro voglia
offrire un bignami del suo arco produttivo. Pastorali
distese alternative-country che sfumano in supposte visioni minimaliste, pianismo neo-classico che
spesso elude i giochi acustici della sei corde, il tutto
in un'atmosfera rigidamente soffusa, come se i preludi strumentali volessero far presagire a qualcosa
di più compiuto. Si rimane invece alla dimensione
bozzetto, con decine di idee sublimi che per volontà
dello stesso artista non possono sfociare nella compiuta forma canzone.
è una visione più ampia, una camera più accogliente quella in cui alloggiare The Visitor, un disco non
certo barocco, ma spesso indeciso nel delineare i
suoi logici confini. è un O' Rourke austero, ma allo
stesso tempo volitivo, come al lavoro su di un libretto classico, eppure ancora offuscato dalle visioni di
una wild america come dalla risaputa ricerca sui
temi contemporanei. Non un disco di transizione,
nemmeno la rigida introduzione ad un avvincente
modus operandi, unicamente la testimonianza di un
musicista che certo non sente più il peso del disco
in quanto oggetto da commercializzare. Probabilmente inizieremo ad apprezzarlo un domani remoto. (6.5/10)
Luca Collepiccolo
Jimi Tenor/Tony Allen Inspiration/Information (Strut
Records, Ottobre 2009)
G enere : futuristic afro - funk
Nessuna sorpresa, il nuovo volume nella serie Inspiration Information è una collaborazione quasi annunciata. Sulla carta non poteva accadere diversamente.
Dimenticate le origini finniche di Jimi Tenor e la
sua elettronica retro-futurista per Warp, da qualche anno a questa parte il biondo poli-strumentista
batte la strada di una rivisitazione afro nueva, in combutta con la band multirazziale - di stanza in quel di
Germania - Kabu Kabu. Che Strut agevolasse
l'incontro con Tony Allen, motore degli Africa '70, era ipotesi più che plausibile, considerato
che l'uomo ha battuto di frequente le strade del
crossover stilistico nell'ultimo decennio. Ascoltate
il bell'esempio di Africa modernista in Black Voices,
l'intrigo pop terzomondista di The Good The
Bad And The Queen con Damon Albarn
dei Blur e Paul Simenon dei Clash o le recenti
sortite per Honest Jon's e World Circuit, che
comunque comportano un perenne aggiornamento
dei temi afro-funk.
Assecondato da Jimi Tenor, l'uomo distende il
suo incedere, al sincopato beat afro spesso si sostituiscono morbide interpretazioni jazz e accenni
ai ritmi in levare del dub. Esplicative in questo senso Path To Wisdom - modernissimo rare groove con
tanto di spoken word che avrebbe affatto sfigurato
in un album di remix della Flying Dutchman - e
Darker Side Of Night che oltre a presentare quella
coralità ibrida da sempre apprezzata nei lavori di
Tenor, in alcuni suoi tratti cede ai giochi di specchi della coscienza dub. C'è poi anche un flauto che
s'impenna discretamente, ricordandoci che il jazz
secondo Tenor è anche figlio dell'opera di un misconosciuto alchimista nordico come il batterista
Matti Oiling. I break fiatistici di Against The Wall
e Got My Egusi, tradiscono più di un legame con il
jazz spirituale dei seventies (diciamo anche Archie
Shepp?) mentre nella chiave percussiva di Cella's
Walk oltre ad imporsi un flavor etnico è l'onda lunga
della Blue Note - come le spirali egizie di Sun
recensioni
77
highlight
Om - God Is Good (Drag City, Ottobre 2009)
G enere : psichedelia minimale
Sono sempre stati in fissa con la spiritualità, gli Om, sin da quando, mille anni fa o giù di lì, si chiamavano Sleep, inneggiavano alla ganja, rivitalizzavano generi dati per morti e, così facendo, ricercavano la via della trascendenza dope-induced. Quando poi, più o meno un lustro fa, si ripresentarono al pubblico come duo basso/batteria ripulito dagli eccessi e con un nomen omen, a pervadere
le loro produzioni è stata dapprima una spiritualità di matrice pagana (Variations On A Theme) o al
limite panica (Conference Of The Birds), che poi, col passar del tempo, si è dimostrata essere pregna di religiosità fino al midollo. Prima col poco messo a fuoco Pilgrimage - percorso
nel sacro verso la redenzione, la cui unica pecca era l’indulgere troppo
in soluzioni già note - e ora con l’ottimo God Is Good. Gli angeli posti
in cover, dopotutto, lasciano poco spazio ai dubbi. Un pezzo monstre
come Thebes, 20 minuti in modalità minimal-psichedelica, nemmeno.
Il salmodiare lieve di Al Cisneros, sorta di bisbiglio dell’anima di un
santone solitario e schivo, si spinge a sorvolare antichi e nuovi testamenti, da Damasco a Tebe, mentre le sue dita scivolano ed impastano
il solito, lento, essiccato e orientaleggiante delirio mantrico. La batteria
del compare Emil Amos, regge vibrante il confronto senza risultare
invadente; gioca di piatti e spazzole, rispettoso della cerimonia pre-cristiana in atto e testimone
silenzioso dell’ascesa.
C’è odore di trascendenza in God Is Good, si sarà capito. E il mezzo per arrivarvi è un concentrico
scavare, anzi innalzarsi, lungo il crinale di 30 e passa anni di psichedelia.(7.5/10)
Stefano Pifferi
Ra - a farsi strada in maniera discreta.
C'è molta profondità nel disco aldilà dello spirito
da open-jam e - come sottotitolato dalla collana
stessa - una serie incredibile di informazioni. Non ci
avviciniamo agli apici dei moderni depositari del più
mutante spirito afro-funk - Budos Band, Nomo
ed Antibalas per rimanere nelle zone alte della
classifica - ma siamo certi di godere di questo matrimonio anche nei mesi a venire, sotto la buona
stella dell'inglese Strut, procacciatrice di talenti e
vecchi marpioni.(6.9/10)
Luca Collepiccolo
Joe Pernice - It Feels So Good
When I Stop (One Little Indian,
Ottobre 2009)
G enere : indie pop rock , cover
Novel soundtrack, questa la definizione dell’album,
che è la colonna sonora del libro omonimo di debutto - uscito lo scorso agosto - di Joe Pernice
dei Pernice Brothers. Pernice Brothers vale a
78
recensioni
dire Joe insieme al fratello Bob, Beatles-iani fino
al midollo, anzi per meglio dire Paul McCartneyiani. Non fa eccezione musicalmente questo It Feels So Good When I Stop, che vede non a caso
la partecipazione di Bob.
Ma non sono pezzi originali, come ci si potrebbe
aspettare, bensì cover; l’autore spiega che, pur non
essendo un libro sulla musica, dal momento che
sono citate alcune canzoni, le ha coverizzate come
commento al volume.
Inframmezzato da brevissimi reading relativi al libro ma anche alle song, le cover tutte subiscono
il trattamento Pernice, vale a dire melodizzazione
e suono alla Macca, ma anche gli inevitabili Beach
Boys, accenni folk Belle & Sebastian, jingle jangle R.E.M. e co. (la Tell Me When I’t’s Over di Steve Wynn - Dream Syndicate), XTC (citato
e coverizzato non a caso Todd Rundgren che li
aveva prodotti) northern soul e in generale un pop
rock di derivazione sixties, se vediamo alcuni pezzi
(Del Shannon), ma anche i più contemporanei Se-
badoh (Soul And Fire) e Plush (Found A Little Baby).
Essenzialmente un omaggio ad alcune canzoni, It Feels So Good When I Stop va visto allora più che altro
come compendio al libro vero e proprio, così trova
un senso compiuto.(6.7/10)
Teresa Greco
Joujoux D'Antan - Mi voglio
bene come un figlio (Kandinsky,
Settembre 2009)
G enere : indie
Una voce che è una via di mezzo tra Thom Yorke
e Kazu Makino dei Blonde Redhead - ma e di un
uomo, Marco Tonincelli - e una musica che dai
Blonde Redhead riprende le derive più malinconiche estremizzandole in passaggi onirici arrangiati,
grotteschi, talvolta inquietanti. Loro sono i Joujoux
D'Antan, in origine duo - al già citato Tonicelli si aggiunge Pietro Leali -, ora formazione allargata
(violoncello, contrabbasso, batteria, chitarra, pianoforte, synth, trombone) più qualche ospite illustre.
Nello specifico Yuka Honda e Sean Lennon.
Non una presenza occasionale quella dell' ex Cibo
Matto e del figliol prodigo del compianto John, visto
l'evidente trait d'union che lega la musica dei Nostri
a quella scena underground newyorkese di fine anni
novanta in cui le due personalità sono cresciute artisticamente.
Una parentela fatta di chiaroscuri obliqui, arrangiamenti sul filo, melodie minimali su orchestrazioni
classiche e in generale caratterizzata da un'evidente
necessità di uscire dai canoni tradizionali del rock.
A dimostrazione una Crono sospesa tra lirismo barocco e incedere bandistici quasi beatlesiani, una Nel
mio armadio vissuta tra sillabare di chitarre acustiche e ruvidezze elettriche, una Yom Kippur dai toni
angoscianti, una Plenilunio crepuscolare.
Evocativo più che descrittivo, dalla complessità
grammaticale insolita ma immediato nel mood generale, Mi voglio bene come un figlio è il tipico disco
fuori dagli schemi e dal respiro fortemente internazionale. Oltre che l'ottimo esordio di una formazione da tenere sotto stretta osservazione.(7.2/10)
Fabrizio Zampigh
Keelhaul - Triumphant Return To
Obscurity (Hydra Head, Agosto
2009)
G enere : math core sludge
I Keelhaul di Cleveland sono una di quelle band che
assorbono tutto e lo restituiscono in pieno volto.
Macinano riff con la facilità con cui si sforna il pane,
sparati uno di seguito all'altro: carrarmati sludge,
progressioni matematiche alla Don Caballero
fino a slayeriani temi trash. Come una sorta di circolo vizioso: via uno, dentro un altro, senza mai ripetersi. E quando si crede di aver beccato un ritmo
stabile, improvvisi cambi di velocità e controtempi
rendono inappropriato l'headbanging precedente.
Principalmente strumentali, la voce del bassista
Aaron Dallison viene fuori puntuale solo quando
il momento lo richiede, alla maniera dei compagni
d'etichetta Knut. Triumphant Return To
Obscurity è un nuovo contributo di Keelhaul alla
musica pesante. Una band che registra solo quando
ne sente la necessità (del 2003 il precedente terzo
album Subject To Change Without Notice).
E che come al solito non delude. Non sarà la musica più nuova del mondo, ma di sicuro sono onesti.
(7/10)
Leonardo Amico
Kings Of Convenience Declaration Of Dependence (EMI,
Ottobre 2009)
G enere : folk
Cinque anni son trascorsi dal sophomore Riot On
An Empty Street, una camera di decompressione - o decantazione, fate voi - più che ragguardevole, durante la quale il buon Erlend Øye si è dilettato coi suoi Whitest Boy Alive, dimostrando
così tanta convinzione che i Kings Of Convenience
sembravano oramai estinti assieme allo stemperarsi ineluttabile del NAM. Invece, rieccoli. Più soffici
e "quieti" che mai nel qui presente Declaration
Of Dependence (dipendenza l'uno dall'altro?
I KoC come patologia
artistica?), mossi da un
estro bossa cartilaginoso
(e in che altro modo te
l'aspetti la bossa in mano
a dei norvegesi?) scosso
al più da un sobrio sussulto swing (come nel
grazioso singolo Boat Behind). Quanto al resto, li
ritrovi più che altro dediti alla messinscena da nipotini minimali di Simon & Garfunkel (Second To
Numb è da flagranza di reato).
Dominano - ça va sans dire - le chitarre acustiche,
poi c'è il piano che ribatte quando occorre, un violino a scompigliare la bonaccia ritmico/armonica,
recensioni
79
ovviamente le due voci e: nient'altro. Un'essenzialità che possiede un suo speso specifico. Che tenta
di importi il proprio codice, t'invita a trascorrere
tre quarti d'ora a pane ed acqua ché non è il caso
scordarsi il sapore né dell'uno né dell'altra. è una
questione di particelle elementari. Di riappropriarsi
del cuore delle cose. Rallentare, quindi. Smorzare i
volumi.Togliersi l'armatura, il casco, il visore virtuale.
C'è la possibilità di un'isola, nel cul de sac emotivo
di questi anni sovraccarichi di tutto.
Proprio per questo senso di frattura e distacco dal
frastuono generale, per l'ostinazione con cui tentano di definire i contorni di una "nicchia mainstream" (in ossequio alla loro ben nota predilezione per
gli ossimori), e per come sembrano spogliarsi dal
desiderio di prima linea annidato nei precedenti lavori, Declaration Of Dependence potrebbe
essere il loro disco più rappresentativo. Peccato che
non azzecchino troppe belle canzoni: quattro sono
sopra la media (Rule My World, Me In You, 24-25, Riot
On An Empty Street) e poi tanta aura mediocritas.
(6.4/10)
Stefano Solventi
Kode 9 - Black Sun / 2 Far Gone
(Hyperdub Records, Maggio 2009)
G enere : dubstep
Due tracce per riportare l'attenzione sul dubstep
di classe, quello puro, senza troppe contaminazioni,
dosato e interessante. Kode 9 è la voce del padrone di casa Hyperdub, il luogo mentale dove Burial
ha sfondato e dove i dj vanno a pescare le chicche
per le serate al sapore di grime. Lui sforna questo
vinile, ristampato oggi dopo essere andato subito
in sold out, e le antenne di chi è ormai drogato di
dubstep non possono che drizzarsi. Le tracce sono
pulite, quasi calde, ormai senza accenni paranoici.
2 Far Gone è il glitch che si impossessa dello step
e plana dolcemente sul dancefloor, Black Sun è la
frustata nei denti dei teen post-E con i riempitivi
intelligent. La direzione va quindi verso l'essenza, il
minimalismo già professato da Benga nei suoi ultimi 12''. Come a dire lasciamo perdere gli innamoramenti passeggeri di troppi nerd e ributtiamoci a
bomba sul nostro suono, su quello che siamo. Steve
Goodman getta il macigno nello stagno. Lasciamoci
attraversare dalle sue onde sonore.(7/10)
Marco Braggion
80
recensioni
Koonda Holaa - 10 Acres Of The
Finest Sand (Bar La Muerte,
Settembre 2009)
G enere : psych blues
A leggere le note biografiche di un personaggio
così sembra di avere di nuovo di fronte Michael
Gira quando parla dei suoi anni giovani, perso tra
droghe, arresti e viaggi in mezzo mondo. Il personaggio in questione è Koonda Holaa ovvero Kamil
Krůta che come si capisce dal vero nome
è di evidenti origini boeme. A metà anni ’80 fa il
punk nella Cecoslovacchia d’epoca con gli F.P.B.
(Fourth Price Band). Nell’89 viene arrestato e
condannato a due anni per atti di vandalismo con
conseguente distruzione della statua del primo leader comunista del paese. In seguito si muove in
Germania, dove fonda l’Illegal Immigration, una
non meglio precisata comune musicale che si evolve
poi negli Pseudo Pseudo. Nel 1992 è invece in
California dove collabora con gentaccia come Linsa
Sibio, Jim Cent, Exene Cervenka, Mike Watt e Lydia
Lunch. Nel 1995 si unisce ai Residents con il Freak Show Live di Praga. E ancora eccolo negli Už
Jsme Doma con 80 concerti sul groppone prima
di tornare negli USA dove fonda Koonda Holaa And
The Beetchees ritiratosi a vivere in chissà quali circostanze nel deserto del Mojave.
Bar La Muerte si innamora di siffatto personaggio e
si incarica a questo punto di distribuire il nuovo disco con un mini tour italiano programmato in questi giorni. Con una simile biografia è normale allora
che il taglio musicale sia quanto meno cosmopolita
e apolide. La musica di Koonda Holaa è fondamentalmente blues alticcio e cabarettistico con evidenti influenze lisergiche. Si possono fare una pletora
di nomi che vengono alla mente dopo i soli primi
tre brani: Tom Waits, Moondog, Residents,
Flaming Lips, Captain Beefheart, Swans…
anche qualcosa di simile a Hexlove. La matrice è
sempre più o meno la stessa, una frase minimale di
chitarra elettrica a fare da architrave per una voce
che mima un cabaret scarnificato al sole del deserto. Non c’è niente di particolarmente originale in
tutto questo, ma l’effetto è assicurato.(6.5/10)
Antonello Comunale
Kurt Vile - Childish Prodigy
(Matador, Ottobre 2009)
G enere : indie - folk
Dopo essere stato consacrato dalla ristampa su
Woodsist del suo primo disco, il ragazzo prodigio
di Philadelphia approda nel roster della Matador
con quello che è, in ordine cronologico, il suo terzo
album. La sorpresa per l'effettiva qualità di Costant
Hitmaker era stata così grande che, al confronto, il
successivo God Is Saying This To You... e l'Ep
con i Violators The Hunchback erano apparsi
sfocati e privi di mordente.
In questo senso, quindi, con questa nuova uscita Vile
si gioca il tutto per tutto; e va detto che, benché
forse non si raggiungano gli apici toccati con le precedenti Freeway e Don't Get Cute, le nuove tracce
risultano essere quanto di meglio questo ragazzo
ha saputo comporre ad oggi, esclusione fatta per
quelle, appunto, del primo disco. Parte di quella
magia che per prima ci
aveva incantato la ritroviamo qui in brani come
Overnite Religion, Blackberry Song e in una Freak
Train che ricorda le evoluzione ritmiche dei Feelies di Crazy Rhythms;
la nuova versione, più dura, di The Hunchback poi,
qui posta come opener, fuga i dubbi che ci avevano assalito all'ascolto della precedente sull'omonimo Ep. Se dunque non si ripete, com'era d'altronde
ipotizzabile, il piccolo miracolo dello scorso anno,
va comunque riconosciuto a Kurt Vile il merito di
aver dato alle stampe un solido, degno, nuovo lavoro.(7.1/10)
Andrea Napoli
Lake - Let’s Build A Roof (K
Records, Ottobre 2009)
G enere : lo fi pop
Il collettivo Lake, composto da singoli songwriter
ed artisti gravitanti in area K Records, riflette anche
nell’ultimo album il nomadismo musicale e culturale
che li caratterizza, accomunati in questo al produttore del disco nonché loro amico Karl Blau.
Un compendio di pop sbilenco e non solo, è Let’s
Build A Roof, che va dagli influssi caraibici alla
canzone a bassa fedeltà, al dub, alla world, al dream
pop, alla chamber music con appena accenni di stratificazione. L’influsso delle melodie Beach Boys è
evidente, via Flaming Lips, così come una certa
derivazione d’impianto psych sixties e pop (Fletwood Mac), il tutto associato ad arrangiamenti snelli ed armonie leggere e mai sovrabbondanti.
Non dimenticando un preciso senso ritmico insito
nella band. Il valore aggiunto dei Lake è comunque
una certa leggerezza e leggiadria, sia nell’impianto
vocale che nella loro alternanza maschile/femminile,
insieme al mix composito di cui sopra che si tiene
bene. Solari.(7.1/10)
Teresa Greco
Legends (The) - Over and Over
(Labrador, Settembre 2009)
G enere : shoegaze
Dici Labrador e sai già cosa aspettarti: il solito (l’ennesimo) dischetto infarcito di melodie adolescenziali, psichedelia da cameretta e badilate di feedback
che farà la gioia degli indie rocker più nostalgici e
assorti. Segno di una cifra estetica prima ancora che
artistica oramai ampiamente canonizzata (a mò di
ripasso, andatevi a ripescare il monumentale cofanetto confezionato dalla label svedese a compendio dei primi dieci anni di attività), con tutti i pro
e i contro del caso, laddove - e capita spesso - si
ha l’impressione che il consueto dispiegamento di
mezzi si esaurisca in un grazioso giochino di citazionismi e rimandi.
Non fa eccezione questo nuovo capitolo - il quarto a nome The Legends, truppone - nove elementi in
tutto, impegnati a destreggiarsi fra organo, percussioni, tamburi, chitarre furenti e svolazzi vocali - messo
su dal patron di casa Johan Angergård (non bastassero Club 8, The Pallers, Acid House Kings
e qualcos’altro). Dodici brani in scaletta, equamente
ripartiti fra soavi reminescenze Sarah Records (la
new wave a tinte pastello
di Something Strange Will
Happen, il bel bozzetto
acustico di Jump o il saltellare twee di Monday To
Saturday) e le immancabili nostalgie shoegaze, e
del resto non è mai stata
un mistero l’ossessione
del Nostro (vedi il baccanale Loveless inscenato da
una costipatissima Dancefloor, o il turbinio di watt
e riverberi che strapazza la melodia smaccatamente
pop di Always The Same).
A fare la differenza, semmai, è l’efficacia di un songwriting che, per quanto derivativo, riesce a reggere
egregiamente il confronto con gli illustri maestri. In
attesa che quelli tornino in cattedra, ma tanto ormai
chi ci crede più.(6.7/10)
Nunzio Tomasello
recensioni
81
highlight
Paul White - The Strange Dreams of Paul White (One-Handed
Music, Agosto 2009)
G enere : lounge - hop
Ce lo immaginiamo Paul White, mentre si gira e rigira nel letto, incapace di un sogno tranquillamente percorso dall’inizio alla fine? L’ascolto di The Strange Dreams Of Paul White ce lo fa
immaginare, ma ci mostra anche il sorriso del Paul che non dà pace al suo Inconscio. Non di certo
l’inquietudine.
Dietro a Paul c’è tutta la cultura del frammento del solito Madlib, e con Madlib Paul condivide al
qualità elevata del prodotto e la capacità di insinuare tra le note altrui (o di tutti) il proprio tocco,
la propria firma; il miscelatore tocca inincondizionatamente il passaggio tra l’underground postpunk/post-no-wave/mutant della New York di fine Settanta e la nascita del rap/break beat/nuovi
impulsi black dell’inizio Ottanta. Pure momenti Wu Tang Clan, ovviamente. Ma in tutto questo
il tratto distintivo (il gusto) di Paul ricorda il lounge-soul raffinato e caldo di Flying Lotus (una
su tutti: Let Your Imagination Go), specie nell’estetica dei risultati dell’operazione di cut-up.
Piena California dunque (nonostante White sia londinese). Ma in un senso molto più stratificato
di quello che si pensa. Che dire per esempio di quando ci fa sobbalzare
dalla sedia mentre riconosciamo all’istante la voce di Captain Beefheart mentre patafisicamente pronuncia “Fast & Bulbous” (Alien
Nature)? Il mondo dei sogni di Paul White va molto più indietro nel
tempo, recupera pezzi di cultura musicale che semplicemente non ci
si aspetta, quasi fossero fuori contesto. Paul lancia una sfida continua
all’ascoltatore, costruisce una lotta di indizi, che depone come tracce
(in senso investigativo) nelle tracce (nel senso di pezzi musicali). La
voce di Byrne quasi subito, la lente up-tempo su 21st Century Schizoid
Man dei King Crimson in The Uprising Of The Insane, e subito dopo i Kraftwerk in Time
Wars… In Waiting For Time c’è persino Terry Riley.
Come Madlib c’è il frammento di una cultura intera, diversamente da Madlib quella cultura non è
affatto black-centrica. E la cosa davvero interessante è che in questo far baluginare in continuazione la propria enciclopedia musicale (e la discografia),White riconsegna sempre una comunanza di
mood. Il mondo dei sogni è esteso, ma Paul lo riconduce (ci riconduce) a sé.(7.3/10)
Gaspare Caliri
Leisure Society (The) - The Sleeper
(Wilkommen, Settembre 2009)
G enere : alt folk pop
Da Burton-upon-Trent, contea dello Staffordshire,
giunge questo combo allestito da Nick Hemming e
Christian Hardy, per entrambi già diverse esperienze in altre band della zona, da cui hanno pescato il
plotoncino di musicisti che figurano tra i credits di
questo eccellente The Sleeper. Undici tracce che
abbozzano una versione fervida del Jim O'Rourke
più frugale (altezza Halfway To A Threeway) con suggestioni alt-folk tra il bucolico ed il nostalgico che
chiamano altresì in causa il caro M. Ward (come
in Save It For Someone Who Cares) e certi rapimenti
82
recensioni
Andrew Bird (We Were Wasted, peraltro intrisa di
solennità Tim Buckley), quando non una chimica
dolciastra Belle And Sebastian (Come To Your
Senses).
Gli arrangiamenti imbastiscono un intreccio complesso ma immediato, sono preziosi ma strettamente funzionali. Svariate le chitarre che rispondono all'appello (banjo, ukulele, melodica, mandolino,
acustiche e pedal steel...), e anche le tastiere non
scherzano (pianoforti, organi, synth, rhodes...), col
sovrappiù di contrabbasso, violino, flauto, glockenspiel, clarinetto, harmonium ed il non piccolo contributo di cori e battimani. Il risultato è una sagra
assieme intima, palpitante e festosa, punteggiata da
vivide malinconie (la stupenda The Last Of The Melting Snow), letargici incanti folk-pop (una A Matter Of
Time come potrebbero i Polyphonic Spree in
fregola La's) e agresti mestizie (quella A Short Weekend Begins With Longing che stempera il pungolo
onirico Roy Orbison tra minimi termini Eels).
Un piccolo miracolo di equilibrio e intensità.
(7.3/10)
Stefano Solventi
Lisa Germano - Magic Neighbor
(Young God, Settembre 2009)
G enere : pop rock
Michael Gira stava già cominciando a disperarsi per
la mancanza di notizie da parte di Lisa, quand’ecco
un disco nuovo di zecca a fare capolinea tra i suoi
scaffali. Tempi di produzione e distribuzione e anche
a noi è dato di ascoltare il nuovo lavoro della nostra
amata lady Germano, ahimè invero assai deludente.
Magic Neigbor va preso un po’ come la terza
parte di una ideale trilogia post 4AD iniziata con
…Liquid Pig e proseguita con In The Maybe World. La
chiave di tutti e tre i lavori è il taglio melanconico del piano come architrave principale su cui
poggiare le composizioni, nella maggioranza dei
casi virate in minore nel
classico modus dell’artista. Magic Neighbor ha il
pregio di tentare di uscire dallo standard della Germano e quindi di provare
chiavi e accordi aperti, ma i tentativi rimangono a
metà strada, inconcludenti.
Stavolta Lisa apre le tende e fa entrare il sole, ma
i brani davvero non sono granché, sospesi come a
mezz’aria incerti se prendere una direzione piuttosto che un’altra. Quello che si ottiene così è un
lavoro che sa di incompiuto come lasciato andare
via prima di essere finito. Lisa si lascia irretire come
mai fino ad ora dalla struttura dei brani, incapace
di uscirne vittoriosa. Si avverte lontano un miglio
che cerca di trovare l’aria ficcante e melodiosa che
spesso ha fatto la differenza, ma non ci riesce se non
costringendosi ad un uso eccessivo e a tratti iper
barocco (anche se sempre di pregio) degli arrangiamenti. Si vedano i casi migliori come i vaneggiamenti
ai “beautiful days” di To The Mighty One o la romanza americana di The Prince Of Plati. Tutto sommato
esperimenti abbastanza in linea con il passato. Tutto
nella norma, ancorché sciatto come non mai. Del
tutto insulsi invece frammenti esenti da una sia pur
minima struttura verse chorus verse come Simple o
A Million Times.
Detto che nemmeno stavolta si lasciano perdere i
gatti, che aprono e chiudono il disco con Marypen
e Cocoon, l’entusiasmo trova davvero poco ossigeno
per svilupparsi e la noia si impadronisce dell’ascolto,
scossa solo qua e la, da dettagli anche minimi che
portano a galla il ricordo dei capolavori che furono: l’andamento classico e barocco di Kitty Train, il
refrain malinconico di piano della title track, il crescendo sfarzoso di Snow che d’un passo si tramuta
in un valzerino da sogno. Tracce di un passato indelebile che sembra andato via per sempre.
Lisa è invecchiata e come una donna che ha ormai
dato tutto quello che aveva da dare si è chiusa in se
stessa a mimare un teatrino di fantasmi e possibilità sfiorite. Siamo ormai arrivati all’album delle foto
ingiallite degli anni giovanili. Mettiamo il plaid sulle
coperte sperando di riscaldarci in qualche modo da
questa vecchiaia incipiente.(5.5/10)
Antonello Comunale
Lord Newborn & The Magic Skulls
- Lord Newborn & The Magic Skulls
(Ubiquity, Settembre 2009)
G enere : meticciato / funk - psych - lounge
Tre professionisti dell'artiginato musicale americano, Money Mark ("il tastierista dei Beastie
Boys", mille collaborazioni di livello), Shawn
Lee (dischi a nome proprio e come Ping Pong
Orchestra, musiche per film, anche una collaborazione con l'inafferrabile Clutchy Hopkins) e
Tommy Guerrero (carriera solista, musiche per
videogiochi, musiche per film) si chiudono per due
settimane nello studio del primo e jammano. Viene
fuori questo disco. In una parola: meticciato.
Quasi interamente strumentale, la voce come condimento o sporcatura, fortemente percussivo (legnoso e polveroso), sotto l'ombrellone del grassume
funk, la sensazione di una world music americocentrica.
Nel doppio senso. Miscela riuscita.
Funk che si insinua in: un pezzo cheap-disco, tocchi
di elettronicherie vintage, esotismi-terzomondismi
in dosi omeopatiche, frammenti più jazzati, puntate
più soulful, hip-hop, momenti tra colonna sonora e
lounge, pezzi minacciosi, altri molto solari.
Deserto fuzz-psichedelia Santana (il primo pezzo),
muddy-Mexico New Orleans-voodoo soundtrack (il serecensioni
83
condo), giù giù fino a western space hard (l'ultimo).
Il disco si perde un po' in rilassatezza (e piacevole
automatismo) a metà tracklist, ma ha numeri centratissimi e grippantissimi, da incorniciare.(7.1/10)
Gabriele Marino
Lou Barlow - Goodnight Unknown
(Merge, Ottobre 2009)
G enere : indie low fi
Ci risiamo: hai tra le mani un disco solista - il secondo, per di più - di uno che nelle band in cui ha militato
aveva un ruolo predominante o s’è rivelato più di un
gregario. Uno che, anche se negli anni Novanta era
un “indie nerd” per eccellenza, a un certo momento
(a una certa età?) capisce che è il caso di smetterla
coi paraventi. Che realizza come metterci il nome,
oltre alla faccia, non sia
così brutto. E al gesto
importante si accompagnano allora una serie di
decisioni, prima fra tutte
fare i conti col proprio
passato, ed ecco Barlow
affermare che questo lavoro somiglia a un incrocio tra Folk Implosion e Sebadoh.
Può darsi, nel senso che dei primi c’è una certa pulizia sonora in più e dei secondi lo spigolare distratto
fra generi ed epoche. C’entra inoltre poco e anzi
nulla il fatto che, nei quattro anni trascorsi da Emoh,
Lou sia tornato a far comunella con J. Mascis; più
significativo, per la ragione di cui sopra, aver curato le ristampe di tre dischi dei Sebadoh. Ne deriva
un gomitolo che entra in testa alla distanza ed è
piacevole sbrogliare: se volete dell’energico “college
rock” ecco l’apertura Sharing; se inseguite ballate
acustiche, Faith In Your Heartbeat, Too Much Freedom
e Take Advantage mostreranno uno speranzoso Elliot Smith.
Qualora vi interessasse il folk-rock quietamente visionario di scuola Flying Nun, ci sono la title-track e
The Right a spargere crema di Clean e Chills; a tenere alta la bandiera del folk senza aditivi basta The
One I Call, mentre la neo-psichedelia sotto sedativo
si sfoga in Gravitate e Don’t Apologize. La splendida
melodia di I’m Thinking… e una vibrante One Note
Tone faranno il resto, tranquilli.
L’etichetta informa di un LP inciso in fretta con ospiti Dale Crover e Lisa Germano e prendiamo
nota. Tuttavia, il punto non è chi ma cosa riempie
questi trentasette minuti. è una solidità che provie84
recensioni
ne dall’epoca in cui “indie rock” non era sinonimo
di faciloneria e presunzione.(7.1/10)
Giancarlo Turra
Lusine - A Certain Distance
(Ghostly International, Settembre
2009)
G enere : E lettronica , easy listening
Non mi stupirebbe ascoltare gli intrecci voce/beats
di Two Dots in uno spot pubblicitario di un brand alla
moda: messe da parte le velleità sperimentali che
avevano caratterizzato le ambientazioni di Language Barrier (Hymen, 2007) e le selezioni indovinate
della compilation Podgelism (Ghostly International,
2007), Jeff McIlwain abbraccia in pieno con A Certain
Distance l'idea di un'elettronica easy-listening dall'inflessione downtempo che in più occasioni finisce
per strizzare l'occhio al pop (nei brani cantati: Twilight sfiora la ruffianeria di una hit da classifica) e,
soprattutto, a certe rilassatezze da cocktail-bar che,
a scapito dell'inventiva del sound-designer (dopotutto il buon McIlwain vanta studi di sound design
presso la California Institute of Arts), faranno la fortuna del dj.(5.5/10)
Vincenzo Santarcangelo
Mantels (The) - Self Titled
(Siltbreeze Records, Settembre
2009)
G enere : garage folk
Uscita insolita per la cosa di Tom Lax, da ben due lustri dedita alla pubblicazione delle più truci e crude
proposte musicali del panorama più underground
internazionale; per una volta, infatti, la label di Philadelphia non ci consegna un ulteriore, oscuro gruppo latino (cosa che comunque continua a fare in
contemporanea), bensì una piccola gemma di garage
melodico e vagamente melanconico.
Forse non la più originale delle ricette, ma, come in
tutte le cose, c'è modo e modo di fare e i Mantels
hanno il loro know-how; episodi più energici ed accattivanti come What We Do Matters e James fanno
da contorno alle più frequenti ballate (Look Away,
Samantha, Don't Lie) che, con le loro melodie sixties,
stanno in perfetto equilibrio tra beat, folk e pop, il
tutto amalgamato nella giusta salsa garage made in
the Usa. Non una release imprescindibile, dunque,
né innovatrice, ma un buon disco di stampo classico;
e tra le tante cose deludenti che spesso si vedono in
giro è sempre una buona notizia.(7/10)
Andrea Napoli
Margaret/DK - Cromoliquido
(Venus, Ottobre 2009)
G enere : rock
Line up rinnovata, idee riassestate, i Margaret concedono un seguito al buon esordio Tra una pallida
calma del 2005. Se quello era prodotto da Amaury Cambuzat, che mise lo zampino nella dominante
scura del sound, qui i ragazzi si autoproducono perseguendo un impeto più energico, vitale, liberatorio
se vogliamo, anche se non propriamente "positivo".
In un certo senso sembrano rappresentare l'anello
di congiunzione tra il "marlenekunzismo" che ha segnato un'intera generazione di indie band e l'attuale
fregola emo che ribolle dai margini al centro. Il loro
merito principale sta nel curare arrangiamenti anche preziosi (agli incroci delle chitarre si aggiungono all'occorrenza piano, Rhodes e archi) ma sempre
al limite dell'incandescenza, resi febbrili dalla spinta
agile della sezione ritmica e tenuti sulla corda dalla
carica introspettiva dei testi.
Cavalcate soniche quindi (Frammenti di vetro, Nuova
abitudine), alternate a ballads nel cui caracollare inquieto affiora quanto mai palpabile l'influenza Godano (Alba, Commuove gli angeli, Finale). Capita anche
una Complice la notte benedetta dal tocco liquido
del chitarrista Giuseppe Scarpato che sposta il baricentro su una ruspante ancorché godibile china
hard-psych, ed è forse il momento più interessante
di un disco che si difende bene pur sfidando costantemente l'assedio del già udito.(6.7/10)
Mary Anne Hobbs - Wild Angels (Mu
Ziq, Settembre 2009)
G enere : compil ation wonky - step
La regina del dubstep è tornata su disco. E viste le
conoscenze derivate dal suo programmone su radio
BBC1 non può che trattarsi bene: prende il gotha del
bbreaking-step-wonky e ce lo (ri)propone in gran
spolvero. Basta guardare i nomi: Mark Pritchard,
Hudson Mohawke, Rustie, Applebim e altri
valvassini in ascesa. La direzione del suono wonky
l'abbiamo però ormai digerita: tastierine a 8 bit nerdy (Spotted), voci in elio (Knock Knock), ritmiche derivate dal d'n'b (Lhc), dal ragga (Discipline) o dalle
sperimentazioni di casa Warp (Red And Yellow Toys) e
altri trucchetti targati UK.
Peccato perché sposando l'eterodossia e tentando
di descrivere le infinite sfaccettature del now sound,
la Hobbs inforca la strada di una disomogeneità
congenita. Niente di nuovo per chi sguazza nelle acque nere del post-step e un tentativo (ovviamente?)
riuscito a metà per tutti gli altri (PS: Mary, potevi
almeno mixarceli i brani)(5.9/10)
Stefano Solventi
Marco Braggion
Marigold (The) - Tajga (Acid Cobra,
Settembre 2009)
G enere : post - rock / shoegaze / wave
è l'osservazione la chiave di lettura per questo terzo disco dei Marigold. Quel liquefarsi tra un postrock dagli accenti dark (Exemple De Violence) e certo shoegaze didascalico (Swallow); quel misurare la
temperatura dell'attenzione tra tribalismi invernali
ai confini con l'industrial (Eleven Years) e una wave
narcotica (Sin); quel farsi cullare da pianoforti sognanti (Degrees) e spaccati strumentali psichedelici
(Novole). Chi suona è preparato e sa esattamente
quali tasti premere per risvegliare certi microclimi
emozionali, tanto da chiamare Amaury Cambuzat (Ulan Bator) a ricoprire il ruolo di produttore.
E il risultato è tutto nei nove spaccati in bianco e
nero che vanno a comporre il disco.
Gli amanti dei toni riflessivi troveranno in Tajga un
buon companatico per passare un altro inverno cul-
Massimo Volume - Bologna Nov.
2008 (Mescal, Settembre 2009)
G enere : post - rock narrativo
Che la tensione - artistica, emozionale - accumulata
l'anno scorso durante il tour di reunion dei Massimo Volume dovesse sfociare in qualche progetto
tangibile, non v'era dubbio alcuno. Quello su cui ci
si interrogava era quale forma avrebbe preso nell'immediato tale
progetto, se quella di un
intero disco di inediti o
qualcosa di diverso. Detto, fatto, visto che abbiamo tra le mani il primo
disco dal vivo della storia
della formazione di Emidio Clementi, Vittoria
Burattini, Egle Sommacal e Stefano Pilia.
Un esperimento che se da un lato celebra un ritor-
lati dalla sempiterna malinconia; chi del senso pratico ha fatto una ragione di vita, invece, abbandonerà
il disco dopo i primi cinque minuti di programma.
Anche se in generale c'è di che gioire, dal momento
che suoni di una tale ricercatezza non si sentono
tutti i giorni.(6.9/10)
Fabrizio Zampighi
recensioni
85
no in pompa magna ricco di aspettative, dall'altro
saggia il terreno - di vendita - per una nuova uscita
già nell'aria da qualche tempo e a questo punto rimandata solo di qualche mese. Oltre a capitalizzare
un momento davvero positivo per la formazione
bolognese, capace di risvegliare le nostalgie di buona parte dei vecchi estimatori come di creare una
nuova base di pubblico tra i giovanissimi.
Undici i brani registrati in presa diretta il 07 novembre 2008 all'Estragon di Bologna, dieci proveniente
dalla discografia ufficiale del gruppo - tra i tanti, Atto
definitivo, Il primo Dio, Qualcosa sulla vita, Altri nomi, La
notte dell'11 ottobre - e un inedito: quell' Esercito di
santi risalente ai tempi di Da Qui ma mai pubblicato
fino ad ora. Per un disco che evita con grazia le
usuali secche imposte dal formato - ansia compilativa da best of e qualità dei suoni da demo tape proponendo invece una tracklist sensata e una cura
formale che poco ha a che vedere con i CD live
comunemente intesi.(7/10)
Fabrizio Zampighi
Massive Attack - Splitting The Atom
e.p. (Virgin, Ottobre 2009)
G enere : dopo trip - hop
La notizia è di quelle buone assai: dai primi di ottobre è in circolazione un nuovo e.p. dei Massive
Attack, benché solo in formato digitale. Ascolto
preceduto da certa trepidazione, giacché la versione “uomo solo al timone” dei bristoliani aveva convinto soltanto a sprazzi; troppo gelida e autoriferita,
la musica del solo Robert Del Naja per non far rimpiangere la geniale mistura di un tempo. Non che le
perplessità manchino anche qui, considerando che il
brano guida Splitting The Atom - ospite l’inossidabile
Horace Andy - risale torpido e notturno sino a
Protection con fare da discreta retroguardia.
Cosa che per fortuna non è l’ottima Pray For Rain
con Tunde Adebimpe di TV On The Radio, marcetta di krauta solennità e venature jazz come un
Robert Wyatt moderno alle prese con She Brings
The Rain dei Can. Colpi al cerchio e alla botte pure
dalle ancelle, remix di tracce destinate a comparire
sul disco “lungo”: poiché nulla ancora sappiamo degli originali, arduo capire quanto incidano Van Rivers
& The Subliminal Kid su Psyche (alla voce la rediviva
Martina Topley-Bird) e Christoff Berg su Bulletproof
Love; qui restituiscono bella malinconia pop l’una e
accozzare di dancefloor intelligente fine ’90, annoiato crooning e bizzarri squarci fiatistici l’altra. Segnali
di vita confusi mentre invochiamo chiarezza dall’al86
recensioni
bum, in uscita il prossimo febbraio.(7/10)
Giancarlo Turra
Mem1 - 1 (Interval Recordings,
Aprile 2009)
G enere : elettroacustica / glitch
Due le anime dietro al progetto dei Mem1, Laura e
Mark Cetilia e una miscela tutt'altro che accademica
di manipolazine digitali e d'improvvisazione intelligente. La loro è un'elettroacustica sinfonica e introversa per laptop e violoncello, quella raccontata già
ai tempi di Alexipharmaca (Interval,2007) ed
ora pronta a rimettersi in gioco per questa seconda
occasione con l'Interval Recordings.
Un cast d'eccezzione per 1, nove luminari nell'ambito dei microsuoni chiamati dai Mem1 a contribuire
alle loro fonti e ad esplorare le inflessioni più austere dello strumento.
Nessuna rigida impostazione di stile ma semplici
intuizioni, capaci prima di
captare e di identificarsi
nei differenti stimoli creativi, contribuendo poi al
suono con mutevoli dialettiche in riverberi, campionamenti, loop e droni.
Il benvenuto quindi: all'ambient plumbea per abrasioni ed occasionali field recordings di Jan Jelinek,
alle architetture liquide per Ido Govrin od abissali per RS-232, al culto dub di Frank Bretschneid, all'elettronica fluttuante e di segnale di Kadet Kuhne ed infine alle frenetiche dinamiche di
collage del maestro Steve Roden.
Ne rimarrete stregati e coinvolti da capo a coda,
per il numero infinto di forme che ogni traccia assume, per la malleabilità ed infine per il continuo.
(7.4/10)
Sara Bracco
Meth Teeth - Everything Went
Wrong (Woodsist, Settembre 2009)
G enere : country - gaze
Dopo il primo singolo del 2008 su Sweet Rot, arriva
al debutto anche questo altro gruppo di Portland,
Oregon, e lo fa per l'etichetta più chiaccherata di
questi ultimi mesi; ma se a qualcuno viene già da
storcere il naso, sappiate subito che questo non è
l'ennesimo gruppettino che piace ai newyorchesi
per qualche settimana e poi cade prontamente nel
dimenticatoio. Ancora una volta infatti la denomina-
zione d'origine vuol dire qualcosa, come già nel caso
dei concittadini Eat Skull e tanti altri.
Venendo alla musica, che è quello che poi ci interessa, i Meth Teeth mischiano un pizzico del piglio folknaif proprio del recente giro UnderWater People
(Real Estate & co.) con la ben più austera e duratura lezione dei Country Teasers di Ben Wallers. Proprio questi ultimi vengono spesso in mente
mentre si scorrono le tracce di questo primo album:
country drogato e dissonante che seppellisce le pur
piacevoli melodie sotto la giusta coltre di rumore e
sporcizia, in modo tale da valorizzare il ruolo di entrambi. E se il gruppo di Portland non può vantare
la voce afona ed inconfondibile di Wallers, esso si
distingue comunque nel marasma sempre più denso,
e talvolta asfittico, delle band che un anno fa avremmo chiamato ''shit-gaze'' e che oggi non sappiamo
più come definire, data la scarsa longevità che tale
termine ha dimostrato di avere.(7.1/10)
Andrea Napoli
Micah P. Hinson - All Dressed Up &
Smelling Of Strangers (Full Time
Hobby, Settembre 2009)
G enere : americana
Dura affrontare i maestri senza soccombere. Porsi
davanti a icone incontestabili dicendo la tua senza
uscirne con le costole fracassate. Se scampi e a testa alta, è perché della stessa pasta: quella del Bob
Dylan di cui rileggi vibrante The Times They Are AChangin’, del George Harrison personalizzato in
psico-blues al caramello di While My Guitar Gently
Weeps, del Leonard Cohen che regala una Suzanne mesta e bella.
Luci sfavillanti accanto a qualche ombra, ovvero una
My Way a tratti pressappochista, un discreto John
Denver (This Old Guitar) e la Sleepwalk che soltanto sottolinea la passione per gli anni ’50 evidente già
in And The Red Empire Orchestra. Ruolo che con ben
altra verve incarnano Running Scared (Roy Orbison: ligia), Stop The World (Patsy Cline: vigorosa)
e Are You Lonesome Tonight? (Elvis Presley: lynchiana). Quando poi scegli cantautori di una generazione che ha preceduto la tua e amava mascherarsi
come Not Forever Now di Centromatic e Slow And
Steady Wins The Race a firma Pedro The Lion, fai
sì che non sfigurino e ogni cosa è ancor più illuminata. Nel senso che la chiave sta nell’appropriarsi
dell’altrui calligrafia; nel trasfondervi la tua sensibilità partendo da altrui mondi, così che non si rimpiange Kurt Cobain per In The Pines, sepolta dalla
medesima colata di fragori chitarristici del sensazionale Buddy Holly di Listen To Me.
Mossa che persuade più che confondere, All Dressed
Up And Smelling Of Strangers. Impegnativa, anche,
però felicemente risolta
in due cd che mostrano
la maturità dell’Artista
piuttosto che fotografarlo (a proposito: un caso
che somigli sempre più
a un giovane Elvis Costello d’oltreoceano?)
mentre guadagna tempo progettando il domani.
Che non ha più niente da dimostrare, eccetto la
classe e l’intensità che camminano al suo fianco sin
dai primi giorni. E pazienza se non abbiamo tra le
mani un nuovo Kicking Against The Pricks: altri tempi,
quelli. A pensarci bene, nemmeno troppo distanti da
questo presente raro e prezioso.(7.4/10)
Giancarlo Turra
Mika Vainio - Black Telephone Of
Matter (Touch Music UK, Settembre
2009)
G enere : E lettroacustica
Ora che i Pan Sonic si sono sciolti, il più claustrofobico, intransigente e autenticamente complessato
dei due si firmerà nome e cognome quando vorrà
esprimere il lato più severo e antisociale del proprio approccio. E nulla cambia. Famoso per la propria stoicità, l'estetica elettroacustica da padri fondatori e l'assenza di beat totale (o quasi),Vainio non
si muove che di pochi millimetri che solo lui conosce. Forse qualche field recording potrà apportare
qualche piccola novità ai più attenti ma ai tanti cinici
(ai quali ci affianchiamo) il telefono nero non sarà
altro che il solito playground after death fatto di micro suoni Bernhard Gunter e silenzi, valanghe
di neve noise e ancora silenzi, modulazioni di test
tones da attacco di panico (care sin dall’infanzia dello zero barrato) e vuoti cosmici, short waves John
Duncan e il nulla universale e così via.
Più interessante, a questo punto della sua carriera,
domandarci se questi dischi abbiano veramente un
pubblico (o un futuro) oltre al gioco di penne che
provebialmente li ascolta e promuove. Mika - figuriamoci - attualmente pare non essere interessato
né a installazioni né a traiettorie particolari. Finché
glielo permetteranno continuerà. E se con Oleva abbiamo visto quanto sappia anche vendersi, che tu
recensioni
87
sia intellettuale, concettuale o romantico, negli album nei quali s'è espresso al maiuscolo non è mai
successo un granché di esaltante o significativo per
il mondo elettronico. Benineteso, non sono ingenui,
zeppi di torture acustiche e pasticci sonici quello sì,
e smessa la favola dei ghiacci e dell’artista incancrenito sulle proprie posizioni analogiche non c'è nulla
di veramente affascinate. Niente a che fare con uno,
di tutt'altra levatura, come John Duncan.(5/10)
Edoardo Bridda
Molotovs (The) - And The Heads Did
Roll (Fierce Panda UK, Settembre
2009)
G enere : pop - wave
Un disco breve per una band che non ha niente di
nuovo da dire ma alcune qualità da mostrare. L’ambientazione è tutta inglese, anzi, figlia del retaggio
wave-pop brit a cui da anni siamo abituati e, va detto, senza troppi entusiasmi. La produzione occhieggia gli Interpol più solari (City’s Guest) piuttosto
che la bagarre post-Strokes, del resto c’è un’altisonante primo piano della vocalità che a volte - e
specie nella finale One Up On Me, peraltro diretta
a passo d’Irlanda - richiama la personalità di Zach
Pennington dei Parenthetical Girls.
Nessuna pretesa. Probabile facilità di trovare un
pubblico abbastanza vasto e poca risonanza critica. And The Heads Did Roll dei londinesi Molotovs non veleggia certo per conquistare nuove isole.
Aspira a una crociera rassicurante.(6/10)
Gaspare Caliri
Monsters Of Folk - Monsters Of
Folk (Rough Trade, Settembre 2009)
G enere : rock , folk , A mericana
I “mostri del folk” sono Conor Oberst e Mike
Mogis (Bright Eyes), Jim James (My Morning Jacket) e M.Ward, insieme in questa formazione atipica sin dal 2004, quando si erano trovati per alcuni live. Qualcuno della crew li aveva
ribattezzati a questo modo e il nome è così rimasto.
Esordiscono ora con l’omonimo album, nel quale
tutti hanno suonato tutto come da ragione sociale
“supergruppo”. Definizione che in realtà sta stretta
al quartetto: si potrebbe invece parlare di quattro
individualità che si incontrano e si interscambiano
variamente la musica.
Si va allora dal soul profondo nell’iniziale Dear God
(Sincerely M.O.F.) di Jim James alle melodie beatlesiane del power pop della corale Say Please (tra
88
recensioni
C.S.N. & Young, Beatles e ELO), dalle armonizzazioni
Simon
& Garfunkel di Baby
Boomer, al puro Conor
Oberst - Johhny Cash
- The Band di Man Named True e al suo Messico (Temazcal) e al tenue
The Sandman, The Brakeman And Me di M.Ward. I
picchi si raggiungono con gli accorati pezzi di James
e di M.Ward, mentre Oberst risulta piuttosto altalenante.
è nei brani corali comunque che si nota veramente
il gruppo e il loro amalgama. Per cui belle le armonie insieme, che danno il senso dell’operazione. La
coralità viene fuori meglio in alcuni casi rispetto ad
altri, ma nel complesso giustifica l’esistenza di questa formazione.(7/10)
Teresa Greco
Muse - The Resistance (Warner
Music Group, Settembre 2009)
G enere : R ock operetta
Il solito buon vecchio gigantismo applicato alle altrettanto quotidiane apocalissi e redenzioni, intimismi lacerati, ecatombi e fede mai doma nelle ability
umane? Perché no, e questa volta il premio "sbroccati" glielo puntiamo al petto per quell'omaggio ai
Queen mamma-mia-let-me-go con la coda di Chopin.
E se la storia è severa con chi esagera dipende a chi
ti rivolgi. Con un target di mercato sotto i diciotto
e, di volta in volta, una generazione di maschietti
pronta per loro, i Muse dispensano da sempre album verbosi con buona dose di impegno e dispendio di mezzi. Ed è un peccato che i ragazzi non siano dei cinici, che il loro continuo gioco al rialzo sia
diventato una questione di sopravvivenza artistica e
non prettamente di ego.
Più in là della classica o delle saghe stellari difficilmente si andrà e cambiando la prosettiva, con Mark
“Spike” Stent in regia, e fatti i dovuti distinguo, i
Muse saranno per i 2000 ciò che gli Iron Maiden
furono negli Ottanta, e magari i Queen nei Settanta.
Fermandoci ai primi, aggiornate Powerslave al cyber
punk passando per Ok Computer, e magari costringete Thom Yorke a guardarsi con gli stecchini
tutta la filmografia di Brian Ferry (o se preferite
Gary Glitter). è probabile che The Resistance e altri
dieci centomila album uguali a questo saltino fuori.
highlight
Shafiq Hussein - En’ A-Free-Ka (Rapster, Settembre 2009)
G enere : new hip - soul
Meglio mettere subito le mani avanti: lo Shafiq all’esordio solista è un terzo dei Sa-Ra. La qual
cosa già basterebbe a solleticare un interesse non di circostanza, mentre critico e appassionato
vanno chiedendosi se costoro non vogliano seguire le orme del Wu-Tang Clan inondandoci
di opere soliste. Così fosse, non ci sarebbe nulla da lamentarsi, poiché si continua a respirare il
senso di sperimentazione e conoscenza della tradizione che ne fa l’ottima cosa che sono.
Da qui conviene partire, tenuto conto che a-free-ka è un antico termine egizio - ma non sarà
l’ennesima trovata cosmogonica in stile Sun Ra/George Clinton? - che significa “spirito”. E
che contiene un gioco di parole tra “Africa” e “free”, ovvero libero come il Nostro è artisticamente. Può del resto permetterselo, data l’esperienza accumulata nel tempo e, soprattutto, alla luce
dell’ultimo Capolavoro di Erykah Badu nel quale ha giocato un ruolo importante e si sente
forte e chiaro. Medesimo infatti l’impianto di un hip-hop gocciolante di soul, ricercatissimo negli
arrangiamenti - da manuale, batteria e percussioni - senza rimetterci forza comunicativa.
Che si dimostra abile a metter in crisi familiarità e attese allestendo panorami poco frequentati.
Traiettorie impazzite ovunque, allora, che siano i fiati jazz e le camere
d’eco di Nirvana e lo Sly Stone che rincorre gli Outkast dei bei
tempi in Changes; una The U.N. Plan che sposta l’asse ritmico verso
l’afrobeat infine sfondando muraglie electro e Major Heavy, omaggio
- testimoni gli Xtc in abiti da Duchi Stratosferici - dei Beatles più
estatici. Da non credersi, ma la bocca vieppiù si spalanca allorché camminiamo tra le lande ondulate e gassose dei kraut-funk Evil Man e The
Odd Is C, realizzando quanto sia magistrale la black meditativa però
complessa - che un tempo collocavi sullo scaffale bristoliano - allestita
in Lil’ Girl, Lost & Found e Dust & Kisses.
En’ A-free-ka punta allo stesso oltre il concetto di genere, e se non ci allarghiamo con la valutazione
è solo perché, in confidenza, siamo certi che quest’uomo possa fare ancor meglio mentre allestisce possibili futuri riassemblando passato e presente.(7.5/10)
Giancarlo Turra
Il problema non è il cattivo gusto di cui il rock si
nutre da sempre (e con successo), piuttosto è la Resistance a se stessi che proprio non s'affronta. Con
Bruce Dickinson e Mick Jagger ci si potrà sempre
fare una risata, con Bellamy ti viene il magone.
(5/10)
Edoardo Bridda
My Awesome Mixtape - How Could
A Village Turn Into A Town (42,
Ottobre 2009)
G enere : indierock for teens
Indie pop ed elettronica funky-hop-dancefloor
(sempre&comunque filtrata indie): questi i MAM
alla seconda prova, ovattati nella culla bolognese del
giro Settlefish, stra-hype-atissimi per l'esordio del
2007 (gente che si strappa i capelli e così via), cantatissimi ai concerti, insomma la nuova musica italiana.
Melodie a presa rapida sporcate di teenage melancholy, ricordi di certe atmosfere Subsonica. Cantato scandito e uso della ritmica che li avvicinano
invece agli Amari (gli attacchi di Bad Marks e Inner
City). Un insertino jazzy, un pezzo reggaeggiante, uno
dove emerge, negli archi e nei fiati, un certo gusto
per la melodia italiana anni Sessanta (Teenage Parties).
L'indizio più importante, però, è l'emo-tività da vena
ingrossata sul collo del ritornello di My Moon: siamo
a due passi anzi uno dai Linkin Park. Il target teenager, del resto, è dichiarato, comunque innegabile.
I motivetti sono efficaci, e sono arrangiati e prorecensioni
89
dotti con cura (vedi il finale della traccia conclusiva,
come uno Sting di Englishman In New York ripassato dal Ghost-Simon Williamson di From The
Beginning). Occhei: ma mancano i pezzi che scavalchino l'efficacia ruffiana dell'inciso che entra subito
in testa e altrettanto velocemente passa. Serpeggia
troppo questo spirito indie-coolness a tutti i costi,
pompatissimo, dove per una volta "indie", etichetta
per definizione musicalmente vuota, non è termine
passepartout ma fotografa anzi perfettamente la
cosa: più forma che sostanza, più contesto che testo. Vedi soprattutto il trattamento a bocca di pesce
dell'inglese, che per molti (e noi siamo lì sul filo)
può risultare fastidioso. Sintesi: un prodotto fatto
bene e bene indirizzato. Che non ci piace.(6.4/10)
Gabriele Marino
Nancy Elizabeth - Wrought Iron
(Leaf, Ottobre 2009)
G enere : english folk
Per la seconda prova Nancy Elizabeth deve aver pensato che less is more: si è liberata dello squadrone di
musicisti che reggevano le trame di Battle and
Victory e ha trovato rifugio in una casetta sperduta nel Nord-Est della Spagna. Isolata dal mondo e
senza corrente elettrica
ha raccolto le idee componendo undici tracce
più solitarie che mai,
dalla scrittura toccante
e raffinata. Ad aiutarla
un pianoforte che ha
una storia di duecento
anni, rinvenuto in una ex
scuola che è stata demolita poco tempo dopo.
Stavolta Miss. Cunliffe si è lasciata sedurre dal minimalismo di Arvo Part, dai cori di Steve Reich
(The Act e il singolo Feet of Courage) e da certe soluzioni armoniche care al maestro (le eleganti trombe
di Divining). D'altronde il retroterra d'origine è ancora presente, quel cantautorato folk di tradizione inglese delle già citate Vashti Bunyan e Judee Sill dell'album precedente, ma soprattutto di
Anne Briggs, quasi un'ugola gemella di Nancy. La
sorellanza con le coeve Sharron Kraus o Fern
Knight è invece ribadita in Canopy, le cui linee vocali regalano brividi psichedelici che salgono su su. Lasciando da parte le indiscusse filiazioni, Wrought
Iron è un'opera che brilla di luce propria, dove il
perfetto equilibrio delle parti (tradizione, coscienza
del presente e capacità di coinvolgere l'ascoltatore
90
recensioni
a più livelli) suscita un senso di intima condivisione.
Il piccolo swarovski di Winter, Baby, in chiusura, è
esemplare: un carillon ovattato che scivola morbido
negli angoli remoti dello spirito.
Disco pieno e lunare, Wrought Iron conferma Nancy
Elizabeth tra le migliori interpreti del cantautorato
folk anni '00.
(7.3/10)
Francesca Marongiu
Nathan Mayer - Why Won't You Let
Me Be Black? (Alive Naturalsound
Records, Agosto 2009)
G enere : raw rhythm & blues
Nome a lungo per intenditori e che pare destinato
a restare tale, quello di Nathaniel “Nay Dog” Meyer:
anche dopo un ritorno sulle scene in ambito “garage” all’inizio del corrente decennio e la dipartita
a causa di un infarto, passata inosservata o quasi,
avvenuta il 1 novembre 2008. Da sempre avvezzo a
un approccio ruvido, che seguisse le orme di Sam
Cooke, di James Brown o del suono Stax, era
fin troppo naturale che il nostro finisse per far comunella con quei bei tipi della Fat Possum, si facesse
rileggere da Detroit Cobras, Holly Golightly
e Gibson Brothers e, infine, ponesse mano a un
disco in compagnia di Dan Auerbach e membri
dei favolosi Dirtbombs. Affinità elettive, diceva
qualcuno secoli or sono e, scuotendo la testa in segno di assenso, sottoscriviamo appieno. è pertanto
dalle stesse sessioni che diedero vita all’ottimo Why
Don't You Give It To Me? che riparte questo album,
recuperando materiale rimasto nel cassetto e aggiungendo un paio di unplugged radiofonici.
Operazione condotta col cuore, lontanissima da intenti speculativi - ché si tratta pur sempre di un artista di culto… - e stilisticamente giocata tra torride,
chilometriche incursioni hendrixiane (Mr. Tax Man),
blues affatto canonici (She’s Bad) e vibranti cartoline
dai tardi ’50 (You Are The One, If You Would Be My Guide) che sarebbe stato un crimine non pubblicare. Faceva onore alla Detroit che ne vide i natali anche in
tarda età, Mayer, dandosi a dell’incisivo “black rock”
con un falsetto da Curtis Mayfield (The Girl Next
Door, Dreams Come True) arrochito dalla durezza
della vita al punto di raccontarsi prossimo a Howlin’ Wolf; cavalcando le sbavature e mandando a
quel paese le belle maniere, con un atteggiamento
assolutamente in linea col proprio passato.
Al di là di ogni dissertazione, comunque, queste
restano le ultime parole di un uomo e, in quanto
tali, sono da custodire con la massima cura. Perché lì dentro ci trovi nientemeno che la sua anima.
(7/10)
Giancarlo Turra
Navvy - Idyll Intangible (Angular
Recordings, Ottobre 2009)
G enere : art - punk
Già vi immagino strapparvi le proverbiali vesta solo
allo scorgere nel titolo una nuova puntata del giochetto “raddoppia la v nel nome della tua band”. E
invece vi sbagliate, perché il doppio misto Navvy
da Sheffield (letteralmente parlando, i “manovali” o
qualcosa del genere...) non hanno bisogno di puerili stratagemmi per attirare l’attenzione. Per quella
basterebbe il marchio sul retro del cd (Angular, garanzia di qualità) e l’estroso art-punk citazionista e
spastico che Claire (synth, percussioni, voce, urla),
Matt (chitarra), Marie (batteria e urla) e Keith (basso, voce).
I Fall meno riottosi cresciuti a pane e wave a colazione e synth-pop contorto a merenda. I Fire
Engines virati pseudosexy-techno-shit
alla
Klaxons ma con strafottenza e piglio punkish.
Un triangolare estivo a
45’ tra XTC, Devo e
Buzzcocks sul terreno del disco-punk tipicamente britannico. Quale
che sia l’immagine che
ognuna delle 13 potenziali hit-singles di Idyll Intangible evochi nella vostra mente non potrete
negare il fascino che certe nuove leve dell’underground inglese sanno trasmettere. Insomma, risentiti e masticati già a fondo da chi abbia alle spalle
un minimo di cultura musicale, ma molto, molto più
energici e attraenti di qualsiasi altra paccottiglia finto-wavey targata UK.(6.9/10)
Stefano Pifferi
Neo - Water Resistance
(Megasound, Luglio 2009)
G enere : jazz - core
È la stagione della rinascita del jazz-core romano,
senza dubbio. Il ritorno in trio degli Zu col devastante e materico Carboniferous, prima; il comeback
muscolare e corposo degli Squartet, poi; infine,
col nuovo disco dei Neo, che proprio con gli Squartet condividono il chitarrista e fino a poco tempo
fa pure l’etichetta, non può che confermare l’ottimo
stato di forma della scena romana e/o limitrofa.
Del trittico in questione, i Neo sono quelli più
schizzati e più filologicamente jazz-core. Inclini alla
frammentazione strutturale e alla schizofrenia freejazzistica alla maniera di un John Zorn altezza Naked City ma meno parossisticamente onnivoro,
hanno un ottimo tiro, capacità strumentali fuori dal
normale, visione d’insieme e attitudine demistificatoria. Roba che si traduce in pezzi elaborati e cervellotici, potentemente ritmati (ottimo il lavoro del
batterista Antonio Zitarelli) ma suonati sempre con
la clava del suffisso -core e con l’autoironia folle e
devastante di un Frank Zappa: un pezzo come The
Proliferator è perfetto esempio di questa insana passione per la frattura, tanto quanto Opus Reticolorum
lo è dell’ottovolante sonico messo in scena dal trio
laziale. Ottimo il booklet con le illustrazioni protagoniste della mostra che da il titolo all’album e
opera di molti tra i migliori illustratori indipendenti
italici (Ratigher, Maicol & Mirco, Karin Andersen…).
(7/10)
Stefano Pifferi
Nick Cave/Warren Ellis - White
Lunar (EMI, Settembre 2009)
G enere : soundtrack
Nick Cave, Warren Ellis, il cinema: quanto fertile fosse questa triangolazione lo avevamo intuito.
Questo doppio White Lunar arriva in un certo
senso a consolidare la sensazione, fornendole una
concretezza cui d'ora in avanti sarà difficile prescindere parlando della carriera dei due, pur importante quella di Ellis, pur imponente quella di Cave. Il
noir e il western. L'asciuttezza carnefice di Cormac
McCarthy. L'epos magniloquente di Leone. L'insidia
invitante e angosciosa di David Lynch. L'impronta
della vita sulla morte (e viceversa). Il romanticismo
pernicioso, distorto, smisurato, annichilito. Quello
che i Bad Seeds e i Dirty Three si raccontano
rimboccandosi le coperte la sera. Usando pochissime parole, il meno possibile, il necessario (quelle
sparute e impiastricciate di The Gun Thing, quelle accorate ma stoppose di The Rider Song...).
Ma le dimensioni consuete di Warren e Nick perdono consistenza, rimangono dietro lo schermo dove
vengono proiettati The Assassination of Jesse James,
The Proposition, The Girls Of Phnom Penh e The
English Surgeon, pellicole diverse, lontane per modi
e contenuti, tuttavia ben più che semplici pretesti.
Il coinvolgimento dei musicisti è palpabile, come la
recensioni
91
loro brama di metterci l'impronta, con pietosa insolenza. Spingendosi alla bisogna oltre i propri limiti estetici: il piano ed il violino sono affiancati da
droni, brume e scalpiccii sintetici, configurando un
"ambient-ghotic" saturo di concitata stasi emotiva,
come qualcosa sul punto di. è un gioco che accetta
di mostrare la corda, che talora soffre la mancanza
del supporto visivo (da buona soundtrack). Ma che
non manca mai di forza, di convinzione. (7/10)
Stefano Solventi
Oh No - Dr. No's Ethiopium (Stones
Throw, Novembre 2009)
G enere : basi hip - hop
Dr. No's Oxperiment e The Beat Konducta vol.3-4: In
India, luglio e agosto 2007, erano stati lo sfogo delle passioni terzo-quartomondiste dei due fratelli
Jackson. Il disco di Oh No era un discone (cosa
che invece non si può dire dell'India di Madlib)
e quindi l'attesa per questo seguito monotematico,
solo dischi 60-70 di musica etiope (dalla collezione
di Egon), era grande.
Grande delusione. Le tracce sono troppo scarne, e
non così particolari nel loro pauperismo, per funzionare. Prevale, sulle piccole idee annidate in ogni
pezzo, l'impressione dell'intermezzo. Michael si è
forse immerso così tanto nei materiali da perdere
di vista l'orecchio dell'ascoltatore.
Precisazione: abbiamo ascoltato la versione light
del tutto, diciotto mp3 tagliati di netto a due minuti; il disco su supporto uscirà solo a novembre,
in contemporanea con quella del caffè prodotto
dalla Stones Throw e opportunamente chiamato proprio Ethiopium. Se il rimpolpamento previsto per le
tracce dovesse spostare qualcosa, ci torneremo su.
Curiosità: se Timbaland era riuscito a fare dire
a Lucio Dalla "Indian Carpet", in un suo vecchio
pezzo, qui Oh No mette in bocca ad un vecchietto
lamentoso addirittura "Pussy".(6.2/10)
Gabriele Marino
Omar Rodriguez Lopez - El
Grupo Nuevo de - Cryptomnesia
(Konkurrent NL, Settembre 2009)
G enere : progres sive
Qualcuno dovrebbe fermare Omar Rodriguez Lopez. Non si sa più cosa dire: fa cadere le braccia, basisce, innervosisce. Ora è il momento de El Grupo
Nuevo, ennesima emanazione di un ego in crescita
preoccupante.
In pratica, una combine tra Mars Volta (oltre a
92
recensioni
Lopez, anche Cedric Bixler-Zavala) ed Hella (Zach
Hill alla batteria, Jonathan Hischke ai synth). Non
crediamo che ripetervi delle ennesime piroette balistiche, delle urla e degli incastri ritmici del chinano
e compari possano alimentare in voi chissà quale
libidine uditiva. A noi, in tutta sincerità, ha compromesso pure il sonno. Basta.(4.4/10)
Gianni Avella
OMO - The White Album (LoAF,
Ottobre 2009)
G enere : E lectro pop
Esordio lungo per il duo mezzo Londra mezzo Berlino composto dagli ex Karamasov David Muth e
Berit Immig (quest'ultima anche in The Chap). Che,
tastiere casio e strumenti acustici alla mano, si fanno autori di un glitch-pop iper-frammentato e ad
alta densità concettuale stile The Books. Ma qui, a
differenza che in de Jong/Zammuto, il frammento
è estrapolato da un corpo organico coeso piuttosto che da una Babele di fonti eterogenee. Quel
corpo organico è il punto di convergenza spaziotemporale tra post-punk
di basso profilo (minimale alla Young Marble
Giants) e synth-pop
puro: un crocevia all'appuntamento con il quale
Muth e Imming si fanno
trovare vestiti a festa o,
piuttosto, come dovessero presenziare a un vernissage.
Un atteggiamento arty, il loro, visibilissimo nell'utilizzo delle voci (gli sfasamenti di Oversized, i fischi
di The Break) e nei testi da poetica dell'ordinario di
un Charles Simic recitati (soprattutto dalla Imming)
con fare tutt'altro che declamatorio (ROV, in effetti,
mi fa tornare alla mente la meteora Meanwhile,
Back in Communist Russia). Ed è così che un
suono scambiabile dai più distratti per un omaggio
ai Lali Puna che furono (Her Body) si trasforma in
realtà in un oggetto dai confini sfocati, a conti fatti
ingestibile e da approcciare almeno con la stessa
quantità di joie de vivre che il duo impiega, mattone
per mattone, a edificarlo.(7.3/10)
Vincenzo Santarcangelo
Pan Sonic/Keiji Haino - Shall I
Download A Blackhole And Offer
It To You (Blast First Petite,
Settembre 2009)
G enere : industrial noise
è il 15 novembre 2007, allo Volksbühne vanno in
scena Mika Vainio, Ilpo Väisänen e Haino Keiji, per la
tappa berlinese di quello che a tutta l’aria di essere
un tour quanto meno unico e irripetibile. Personalità forti e scostanti con più di qualche similitudine nel modo distorto di concepire la musica e la
vita. I Pan Sonic erano da un lustro che manifestavano a più riprese l’ammirazione per il maestro
giapponese. Il tour che li vede protagonisti insieme
diventa più che altro un’occasione per concepire gli
arredi giusti entro cui far vivere la maligna creatività dell’artista nipponico. Quest’ultimo dal canto
suo ripaga con la medicina che gli è più consona:
un se stesso scarnificato
fino all’ossesso, un dio
carnivoro che mangia se
stesso come atto di penitenza per una umanità
condannata a chissà quale inferno.
Questo live berlinese
si incarica quindi di trasmettere ai posteri la
quintessenza di un tour senza eguali, come un documento storico destinato agli anni a venire. Se da un
lato i Pan Sonic allestiscono una scenografia come
sempre densa e magnetica è il canto disumano di
Haino a scoperchiare il vero vaso di pandora. Capace come pochi altri di passare in un attimo dall’anelito metafisico e trascendente della prima traccia,
all’orribile mimesi mostruosa della seconda. Come
se si passasse in un attimo da un film di Ozu ad uno
di Tsukamoto. Con una musica del genere c’è poco
da immedesimarsi. è un impasto avant di matrice
industrial-noise, a suo modo anche scostante, come
il teatrino no su partitura folk zen, che nelle tracce
7 e 9, mima un’estetica da sol levante quanto meno
sulle righe e degradata. I Pan Sonic dal canto loro
tentano di supportare il taglio noise della chitarra di
Haino, simulando brutali corridoi disumani alla Suicide, che non possono che deflagrare nel caos primordiale della traccia conclusiva. Stephen O’ Malley
impacchetta in lussuoso packaging un live che è già
fondamentale per le discografie di entrambi i nomi
sulla copertina.(7.5/10)
Antonello Comunale
Paolo Spaccamonti - Undici Pezzi
Facili (Bosco Rec, Luglio 2009)
G enere : cantautorato strumentale
Paolo Spaccamonti spacca molto più di ciò che indica il suo cognome. La routine dell’ascoltatore “per
professione” innanzitutto; o anche la quieta e monocorde solitudine di uno strano finale d’estate. Sia
come sia, l’esordiente torinese (per lo meno in solo,
visto il passato coi Cletus) imbastisce uno di quei
dischi inevitabilmente destinati all’attenzione carbonara, ma che come spesso accade si rivela essere
invece una piccola gemma.
Cantautore anomalo, privo di parole e armato solo
di chitarra (o poco più), Spaccamonti è artista dalla profonda sensibilità, capace di dispensare ganci
memorabili: folktronica evocativa in Camicia Gialla,
Cravatta Nera, sgranato rumorismo chitarristico in
Drones, slow-core emozionale in Fine Della Fiera,
astrattismi di solo-guitar + corde in Tex. Tutto sempre dotato di taglio personale e suonato col piglio
giusto.
Riecheggia spesso Torino nelle note di Undici Pezzi Facili, e forse si rischia la banalità nell’affermarlo.
Eppure è così; rivive nelle musiche di Spaccamonti
quell’aroma particolare, in chiaroscuro, agrodolce
e quieto, della motor-city italiana. Quel vago senso
di perenne incompiutezza che lascia spesso spazio
alla malinconia e che Spaccamonti ha sapientemente
reso su pentagramma.(7/10)
Stefano Pifferi
Pearl Jam - Backspacer
(Universal, Settembre 2009)
G enere : rock folk
Per il nono album di inediti in diciotto anni, i Pearl Jam recuperano l'antico compagno d'avventure
Brendan O'Brien - con cui collaborarono l'ultima
volta ai tempi di Yield (1998) - affidandogli la produzione di quello che, fin dal titolo, vorrebbe essere
un lavoro che torna sui passi compiuti. In effetti, si
respira un'aria diversa da quella invero pesantuccia
degli ultimi tre dischi.
Backspacer è sbrigliato e conciso, mediamente più ottimista del solito, un album di rock'n'roll
energico e appassionato di stampo abbastanza tradizionale per non dire generico, non troppo preoccupato di tutelare il Pearl Jam-sound (vedi anche
come si ricorre spesso al pianoforte, suonato dallo stesso O'Brien). Sono talmente navigati e coesi
questi cinque ex-esponenti di punta della scena di
Seattle, che sembrano in grado di poterti scrivere
recensioni
93
la ricetta, il perfetto dosaggio tra assalti up-tempo e
trepide ballate (forse le ballate sono un po' troppe,
ma tant'è...) per sfornare la scaletta perfetta.
Veniamo agli ingredienti: le scorribande sono tese,
però inevitabilmente (?) infarcite di già sentito. Ad
esempio, Gonna See My Friend apre con lo stesso impeto scomposto di Brain Of J (che a sua volta inaugurava - guarda un po' - il programma di Yield),
mentre Supersonic potrebbe essere Mankind - parimenti composta da Gossard - rifatta col piglio
garrulo e garbato di un
Huey Lewis (gosh!). Se
l'obiettivo era farti sbattere un po', tutto bene.
Non stiamo certo qui ad
accampare pretese. Però
che peccato quei bridge
senza nerbo né ragione, tristi come esercizi obbligatori.
Lo stesso sentore di prevedibilità, di binario percorso un milione di volte staziona nelle ballatone
come Speed Of Sound e Amongst The Waves, mentre
nelle più folk-oriented Just Breathe e The End spunta il Vedder versione bardo epico/bucolico di Into
The Wild, armato di chitarra acustica e spalleggiato dall'orchestra. Tutto sommato, questi ultimi sono
forse i pezzi migliori del lotto.
E quindi, e infine, cosa dovrei concludere, io che ho
amato le palpitazioni anarchiche, i misteri pulviscolari, la densità proteiforme di No Code, la bieca
ebbrezza di Vitalogy e di Vs. l'incandescente
rappresaglia? Ben poco, in verità. In calce a quella
ricettina di cui sopra Vedder e compagni dovrebbero aggiungere qualche notarella riguardo al nerbo, all'urgenza, all'additivo che rende un disco - per
come può - inevitabile. Per qualche motivo troppo
lungo da spiegare, un disco targato Pearl Jam che sia
soltanto divertente, non riesco a farmelo bastare. (5.5/10)
Stefano Solventi
Pete Molinari - Today, Tomorrow
And Forever (Damaged Goods,
Agosto 2009)
G enere : country / bluegras s
Sarà forse l'anno della riscoperta del country. O
Forse è solo una coincidenza. Fatto sta che dopo
i Phosphorescent impegnati a “coverizzare” Willie
Nelson nel notevole To Willie, anche il buon Pete
Molinari - neanche a dirlo, nostalgico d.o.c. - decide
94
recensioni
che è arrivato il momento di cimentarsi in qualche
rilettura sul genere. Il tempo di raccogliere armi e
bagagli, lasciare il Greenwich Village dei primi Sixties
e partire: destinazione Nashville 1950. Compagni di
viaggio quei Jordanaires già nel libro paga di Elvis
Preslely e di Patsy Cline, chiamati in questo caso
a dare profondità e autorevolezza ai quattro standards in scaletta (Today, Tomorrow And Forever, Satisfied Man, Guilty e Tennessee Waltz).
Tra steel guitars, cori gospel sullo sfondo e batterie
spazzolate di rigore ci si gode il Molinari crooner,
arrivando a fine programma in un batter d'occhio e
pure con una certa soddisfazione. Appagati ma anche consci del fatto di trovarsi di fronte a un divertissement in piena regola che ha il solo scopo di rinfrescare la memoria agli ascoltatori distratti, in attesa
che arrivi il successore di A Virtual Landslide. Per Today,Tomorrow And Forever è prevista una doppia uscita: un vinile che raccoglie le quattro cover e un CD
con lo stesso programma e in più tre b-sides degli
ultimi singoli pubblicati dal musicista.(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
Peter Kruder - Private Collection
Vol. 1 (G-stoned, Settembre 2009)
G enere : compil ation downtempo lounge
Il downtempo Peter Kruder lo incarna da anni.
Prima con l'amico Richard Dorfmeister (su
quello storico DJ Kicks), poi con la G-Stone e con
molti altri progetti paralleli. Tra alti e bassi la sua
Vienna è così diventata simbolo di lounge di classe.
E oggi il nostro ci riprova. Si ritira nel suo salotto
e se ne esce con delle tracce impolverate da vinili
nascosti sotto la pila. Ce lo immaginiamo davanti al
fuoco, pochi amici, un po' di fumo e una bottiglia di
vodka davanti al camino.
Lui che propone quelle tracce stupende ma dimenticate, sommerse dal nuovo che incombe e che dice
troppo poco.
La visione distensiva la trovi nei Talk Talk da brivido (l'opener The Rainbow in space western stellare), nelle chitarre e marimbe dei Tortoise (On The
Chin), nello smooth soul di Milt Jackson (Enchanted Lady), nei solchi vocali di Tom Waits (Clap
Hands) e di David Sylvian (Ghosts). O se non sei
contento e vuoi un po' di elettronica allora ti puoi
sparare l'autocelebrazione prog con la Peace Orchestra (Consequences) e anche qualche accenno
di world (Rokia Traoré in estasi con Mariama).
Scegliere la sequenza perfetta è un'arte e Kruder se
si impegna lo fa da dio. Senza spocchia stavolta ha
fatto il botto. Piccolo grande culto in loop dal primo
ascolto.(7.1/10)
Marco Braggion
Phish - Joy (Jemp, Settembre 2009)
G enere : psych pop
Li credevamo dissolti, spazzati via dalle ramazzate
della storia, invece tornano vivi come e più di prima
e sarebbe il caso di meditarci sopra. Ma anche no,
se preferite. In fondo questo Joy, quattordicesimo
titolo per la band di Trey Anastasio, prodotto dal
figliol prodigo Steve Lillywhite, non chiede altro che
di farsi suonare senza troppi orpelli teorici o retropensieri.
Fila liscio e guizzante con quelle melodie levigate,
tra l'impeto del pianoforte e gli assolo affilati, porgendo risposte chiare ed effervescenti ai bisognosi
di viaggi musicali, che siano gli orfani della psych andata o i giovinastri in cerca di distrazioni più coinvolgenti del solito indie rock. Lampanti i riferimenti
ai Grateful Dead del periodo Arista, quell'aria da
jam istituzionalizzata o se preferite da jazz-prog addomesticato (Stealing Time from the Faulty Plan) che
non disdegna altresì digressioni reggae (Sugar Shack
non è la nipotina garrula di Estimated Prophet?) o cavalcate turgide di stampo The Who (la suite Time
Turns Elastic).
Il gioco si svolge a carte scoperte, scopertissime.
Basta con le complicazioni. C'è bisogno di ripartire
da basi solide e chiare. Ad esempio dall'entusiasmo
dolceamaro di Backwards Down the Number Line,
dall'enfasi pettoruta di Twenty Years Later o dall'accorato sentimentalismo della title track. Che poi tutto
tornerà buono per sgranare la solita vecchia collana
di concerti interminabili.
Se poi volete escogitare parallelismi col più ampio
sentimento di ripartenza che sembra animare la
societa statunitense, anch'essa pervasa di energie
positive che sembrano riedizioni di vecchi cliché,
pantomime sì benintenzionate ma con uno strisciante sottofondo di disperazione, beh, fate pure.
(6.2/10)
Stefano Solventi
Piano Magic - Ovations (Make Mine
Music, Ottobre 2009)
G enere : M inimal wave
I Piano Magic sono diventati dei classici. Il respiro
delle loro composizioni - riuscite o meno che siano - è come cristallizzato sui gusti del proprio deus
ex machina: il chitarrista Glen Johnson. Una mistura
di Joy Division, primi New Order, Chamaleons, The Cure, Dead Can Dance, e poi spezie mediorientali, dall'Europa dell'est, dalla Penisola
Iberica: dulcimer, synth analogici, violoncelli, viole e
quant'altro. Detto questo, quanto resiste al confronto dei precedenti loro dischi (nonché del Johnson
solista) questo 10imo album in carriera?
Molto o molto poco, dipende dai punti di vista: è
come dibattere sul bicchiere mezzo pieno o
mezzo vuoto, a dire il
vero, senza accorgersi,
in questo caso, che comunque la bevanda di
quel benedetto bicchiere
(mezzo così o mezzo colì
che sia) ci sta dissetando
mica male. Questo accade con una canzone come
The Faint Horizon, con la sua coda strumentale in
crescendo. Irresistibile, sebbene poi, a ben pensarci
su, è il solito divino esercizio di stile dei nostri. Che
come i Chamaleons dei bei e medi Ottanta suonano davvero; basti dare un ascolto a The Blue Hour,
perfettamente in equilibrio fra i migliori Joy Division
'atmosferici' ed un melodismo decadente che come
muove e commuove.
Il disco è prodotto da Gareth Parton (The GoTeam, The Breeders, Pete & The Pirates), e
se la classe non è acqua, il mestiere nemmeno (qui
c'è e si sente). Disco risaputo, alla fin fine, quello
del gruppo anglo-francese? Risaputissimo! Eppure
ancora amabile appieno...(6/10)
Massimo Padalino
Pictureplane - Dark Rift (Lovepump
Records, Agosto 2009)
G enere : 8 bit fidget discopop 90
L'eredità dei Crystal Castles con quel trash
pompato è ancora fra noi. Oggi, ripulito dal noise
e filtrato dopo le bordate wonky, si ripresenta ai
teen che non rinunciano al vodka redbull. E allora il
mondo di Travis Egedy (direttamente da Denver
pure lui è un teen sbarbato) è sempre spiattellato là
nelle sale giochi al neon, nei sogni del dopo trance
truzzo (Trance Doll appunto), nel bbreaking un po'
sbavato dal fidget (Gang Signs, Goth Star) e nel dancey pop motorico in sintonia con La Roux (Cyclical Cyclical). Il tutto condito con quel sapore un po'
melo che fa wave, grazie anche a delle vocals bianche che già la gattina Miss Kittin aveva sfruttato
nel minimalismo con il buon vecchio The Hacker.
recensioni
95
highlight
Tune-Yards - BiRd-BrAiNs (Marriage, Ottobre 2009)
G enere : etno avant folk
Fine Duemila. Tutti che fanno il giro del mondo nella propria cameretta, pochi che fanno tesoro
e aprono le sinapsi. Pochissimi che dentro al melting pot ritrovano nient’altro che se stessi, che,
detto musicalmente parlando, vuol dire la propria penna. Merrill Garbus le ha spalancate, le sinapsi. E sono sinapsi solide, che non si lasciano dominare da un melange senza un centro, centripeto
o centrifugo che sia. Ha linee che l’attraversano ma anche nodi veri e
solidamente allacciati.
Chiamarsi tUnE YArdS è già di per sé una dichiarazione di intenti
e indipendenza lo-fi. Ma in BiRd-BrAiNs si riconosce anche la -tronica
folk e indie, roba elettro cut up stile Solex e pure quel tocco hip
hop che mai come in questi anni abbraccia la musica tutta, uscendo
dall’autoreferenzialità. In tutto questo Merrill sembra godere di una
libertà assoluta. Un ukulele in braccio (come i vari Patrick Wolf,
Jens Lekman) e le consuete tecnologie povere a contorno e il
risultato è qualcosa di totalmente suo. Si poggia un bel po’ su quel fare tropicale che va di moda
ora, ma anche su un’Africa assolutamente odierna (Hatari, una specie di strano break-beat fatto
con il “chitarrino”).
Prendete pezzi come Sunlight e Lions. Sono cantautoriali, pop, ma soprattutto spiazzanti, per la capacità di rifuggire la banalità e di sprigionare immediata affezione nell’ascoltatore. Lions si prende
dei rischi di melodia vocale che raramente si ha la statura e l’incoscienza cosciente e leggera di
affrontare. Lo stesso accade con quella sorta di yodel che le sue corde vocali spesso corteggiano.
Insolito, bizzarro, ma assolutamente personale. C’è insomma di base una capacità di mettere insieme delle perturbazioni armoniche che lascia a bocca spalancata, come in quel piccolo capolavoro
di salto di ottave (e falsetti quasi Police-iani) che è News, con uno stile che tanto ricorda i Ruby
Suns, progetto per nulla lontano da tUnE YArdS.
E se di fine Duemila ora parliamo, sono dischi come BiRd-BrAiNs che ritroveremo nelle classifiche
quando guarderemo indietro. Sempre che ci sia bisogno di rinfrescare la memoria.(7.5/10)
Gaspare Caliri
Cose già masticate e sperimentate che hanno però
nelle vene quella positività '90 (New Mind) da lacrimuccia per gli over 30. Un esordio che non sconvolge ma che verrà buono per futuri remix riempipista.
(6.2/10)
Marco Braggion
Poison Arrows - First Class, And
Forever (File 13, Ottobre 2009)
G enere : spacey math - rock
Parte male questo First Class, And Forever.
Anzi ad esser precisi più che male parte banale
come può esserlo un disco di post-rock strumentale giunto fuori tempo massimo. L’opener Future
Wine suona infatti come un qualsiasi pezzo prove96
recensioni
niente dalla Chicago di un decennio abbondante fa e
le cose non potrebbero andare diversamente visto
che nel terzetto a nome Poison Arrows, insieme al
batterista Adam Reach, ci sono ex di Atombombpocketknife (il cantante e chitarrista Justin Sinkovich) e di Don Caballero (il bassista Patrick
Morris).
Quando la catalogazione nel settore “antichità” sta
per scattare ecco che le cose si complicano; la linea
compositiva del trio chicagoano - sulle prime piatta
e inoffensivamente post-rock - cambia registro e si
inerpica in sentieri tortuosi e fuori mano. Le strutture dei pezzi si sciolgono, i suoni si liquefanno, le
suggestioni di dilatano fino a tratteggiare una sorta
di spacey math-rock; così First Class, And Fo-
rever acquista spessore, dimostrandosi non solo
in grado di mantenere un forte sapore chitarristico
o giocare con gli incastri strumentali cari alla migliore tradizione math, quanto anche di rivestire di un
alone di alterità le proprie sonorità. Come a dire,
un piede nel (proprio) passato e lo sguardo sempre
ben disposto vero il futuro. Il fatto che il trio si sia
rinchiuso negli Electrical Audio Studios di sua maestà Steve Albini per registrare non è che un ulteriore punto a proprio vantaggio.(6.8/10)
Stefano Pifferi
Port O’Brien - Threadbare (ATO,
Ottobre 2009)
G enere : I ndie R ock -F olk
Le vicende di Port O'Brien partono da Cambria Goodwin, residente in una piccola località
turistica sulla costa Pacifica che porta il suo stesso nome; e da Oakland, sede dell'altro membro del
gruppo Van Pierszalowski. I due però hanno
il cuore in Alaska, dove Van lavora come pescatore
sulla costa dell'isola di Kodiak. Il gruppo si è mosso
spesso in questi anni. Modest Mouse, Bright
Eyes, Herman Dune sono stati i compagni di
viaggio e M Ward un loro grande estimatore.
Dopo un primo disco per la misconosciuta American Dust nel 2007, e uno su City Slang, Threadbare
dovrebbe essere il terreno ideale per definire l'evoluzione del gruppo e saggiarne la sua importanza.
Il lavoro, segnato dalla morte del fratello della cantante, è il più cupo dei tre ma non scioglie le incertezze di All we could do was sing, semmai ne dipana
il disordine.
Manca la sottile inquietudine di Fionn Regan,
così come la complessa regia degli Acorn. Si respira invece la stessa patina eighties dei Crooked
Fingers così come la scrittura tersa e ruvida dei
Two Gallants. I registri sono variegati: si passa dal
Neil Young nostalgico (Calm me down), al revival
stile Pedro The Lion (Leap Year), all'occhieggiante Beatles (Love me through), fino a veri e propri
plagi da Echo & the Bunnymen (My will is good).
Il tutto è penalizzato da arrangiamenti piatti e scontati e dell'Alaska non si vede nemmeno l'ombra.
(5/10)
Salvatore Borrelli
Port Royal - Dying In Time (Debruit
De Silence, Ottobre 2009)
G enere : E lettronica
I Port-Royal, da quel di Genova, sembrerebbero
avviati alla conquista del mondo. L'ep Kraken, gli album Flares e Afraid To Dance ne erano la premessa:
questo nuovo disco è definitivamente oltre i post
del loro più recente passato. Post-rock, post-glitch,
post-shoegaze, post-ambient, post-lovely music. Hva
(Failed Revolutions) è forse il pezzo che gli Archive si
sognano la notte e che la 4AD vorrebbe da anni in
catalogo.
Il suono c'è: ed è una evoluzione accattivante, anche se non ancora perfettamente personale (forse),
di Brian Eno, Lovely Music, Stars Of The
Lid, Labradford ed elettronica a bordoni. Glie episodi meno convincenti sono proprio quelli nel solco dell'"ortodossia" (del tutto eterodossa) di certo
shoegaze primi anni '90, come la sognante Nights
In Kiev. Ancora: il suono c'è, ed è ammaliante. La
formula funziona e le alchimie d'assieme della band
pure.
Ma manca forse un'intima ragione a tutto questo
spreco di intuizioni, che non riescono a condensare
in pezzi 'definitivi', come la band meriterebbe. 11
pezzi (mediamente troppo lunghi) che per un po' ti
fanno viaggiare e sognare, poi solo sperare di ritrovare la strada verso casa, soprattutto quando certe
movenze dance qui e là fanno capolino.(6/10)
Massimo Padalino
Rachel Grimes - Book of leaves
(RuminanCe, Settembre 2009)
G enere : P iano & F ield R ecordings
Nonostante i limiti oggettivi, Systems/Layers fu
l'ultima ibridazione espressionistica dei Rachel's.
Un disco di chiaroscuri ed astrazioni arcane, una
sorta di limbo in cui gli strumenti rimanevano serrati dietro la massa ambientale e sovraesposta di
umori e field recordings. La loro musica diventava
narrazione, materia vivente.
Rachel Grimes prosegue proprio da queste premesse utilizzando il bozzetto esistenzialista, la brevità ed il frammento come nuova forma espressiva.
Ogni traccia è come se fotografasse un movimento, una direzione, accarezzando la sua esilità. Book
of Leaves è il suo racconto scritto su un taccuino
di foglie che si spezzano per la crudele fragilità dei
quattordici episodi composti per altrettanti piccoli
microfilm del videomaker Greg King. Essi riprendono spazi naturali dove la presenza umana sembra
essersi estinta per ritrovare una primordiale condizione di stupore e tremore.
Sono brani che vanno nella medesima direzione
delle poesie contenute in “Douve” di Yves Bonrecensioni
97
nefoy. Douve è quel non-luogo dove tutto si sfalda, tutto si allontana, creando immobilità e movimento, Douve è “il vero luogo” dove ogni creatura è
investita dalla morte. Long before us è un'istantanea
calligrafa dentro cui “Ti vedevo correre sulle terrazze,
Ti vedevo lottare contro il vento, Ti sanguinava il freddo
sulle labbra”, un'istantanea dove tutto diventa fermo
immagine di una vicenda, un movimento. Lo strumming notturno di “Every morning” si svuota come
una spirale in cavità interiori. “She was here” passa
per la nudità di un'alluvione e sotto la frenesia di
uccelli catturati insieme alle note del piano. Denis
Roche avrebbe adorato questa passione sonora, in
particolare “On the morrow”, così tersa e straziata
tra note che fanno spola con lunghe pause, e possono appartenere solo a delle mani in cerca di trascendenza.
C'è radicalità vivente in spazi macchiati di pause e
prolungamenti risonanti, e se ha un pregio formidabile Rachel Grimes, questo è l'azzeramento di
qualunque allusione alla contemporanea, ai tecnicismi. Stavolta la sensibilità è rivolta completamente
all'ascolto dell'invisibile, del vuoto, dell'assenza, e
senza manierismo. Rivive in ogni passaggio l'essere perpetuamente minacciati, l'opulenza delle stagioni, la contemplazione
lirico-ambientale ed il disco si chiude come Douve:
“Oh forza e gloria nostre, riuscirete a trapassare la muraglia di morti?”.(7.3/10)
Salvatore Borrelli
Radio Slave - Fabric 48 (Fabric,
Settembre 2009)
G enere : compil ation tribal deep
Su 13 tracce di questo nuovo Fabric, tre (+1 remix) sono a nome Radio Slave. La supponenza di
Matt Edwards è giustificabile dal peso dei suoi
stab e delle sciabolate che da anni ci inacidiscono il
dancefloor. Lui va al sodo con una cassa che punge
il cervello e che non molla il tiro: un po' spacey
in I Don't Need A Cure For This, un po' tribal in My
Time e nell'anthem da club DDB. Non solo schiavi
comunque. In più la deep di DJ Bola (Balada Redo)
e le incursioni nell'eterogeneità world con i pezzi di
Michel Cleis e di 2000 & One.
La lezione teorica di Villalobos e di Luciano è
ormai prassi consolidata. Basta con la minimal. Oggi
la parola d'ordine è tribal deep. Diffondete il verbo. (6.7/10)
Marco Braggion
Radiohead - These Are My Twisted
Words / Harry Patch (In Memory
Of) (Autoprodotto, Settembre 2009)
G enere : rock pop
Due nuovi pezzi per i Radiohead. Di cui non possiamo non parlare. Non fosse che per la dichiarazione rilasciata da Yorke al periodico culturale di San
Francisco The Believer, nella quale sostiene che la
band non avrebbe più intenzione, non a breve almeno, di mettersi all'opera su un intero album. Quindi,
forse, questa è il modo in cui recensiremo d'ora
in avanti la band di Oxford: un singolo alla volta, al
massimo un ep. Sarà davvero così?
Intanto, queste due canzoni uscite in download a
pagamento sul loro sito (una sterlina cadauna) ci
raccontano da due diversi punti di osservazione e
con diversi esiti lo stato delle cose. These Are My
Twisted Words è un ordito teso e scuro, battito
incessante, trafelato e
schivo, un funky strinito e motorizzato su cui
l'arpeggio
dark-psych
ricama un raga ipnotico,
acido, brumoso. Niente
voce di Mr. Yorke fino a
metà brano, ai due minuti e trenta, ed è un incedere abbastanza assorto, il lirismo sospeso tra inquietudine e apatia. Il risultato è interessante ma
non troppo, da rubricare senz'altro tra gli episodi
secondari del repertorio. Da sottolineare però la
"copertina consigliata", scaricabile assieme al brano.
L'altro pezzo è un'altra storia, altra musica: s'intitola Harry Patch (In Memory Of) ed è stato registrato
live in un'abbazia, con arrangiamento d'archi a cura
di Jonny Greenwood (sempre più capace, oserei dire). Dedicato alla memoria dell'ultimo reduce
inglese della prima guerra mondiale, morto recentemente alla veneranda età di 111 anni, è una commossa litania contro la guerra, pervasa da un impegno franco che sembra rielaborare le parole dello
stesso Patch, che Yorke conosceva personalmente
("Give your leaders each a gun and then let them fight
it out themselves"). Melodicamente può ricordare
Motion Picture Soundtrack, però come raddolcita in
un'estasi matura. Bella ancorché misurata l'interpretazione canora. Due canzoni che confermano la
versatilità delle testediradio, ce li fanno sentire vivi
pur senza farci gridare al capolavoro. Attendiamo
sviluppi. Come sempre.(6.8/10)
Stefano Solventi
98
recensioni
Rain Machine - Rain Machine (ANTI-,
Settembre 2009)
G enere : pop - folk
Se per Tunde Adebimpe, cantante e leader dei Tv
On The Radio, sono stati fatti un milione di riferimenti a Peter Gabriel, per Kyp Malone, chitarrista e controcanto nella band, quelli con Phil
Collins verrebbero più che naturali ascoltando i
suoi Rain Machine, qui all'esordio discografico. Parecchio simili le voci dei due e un attacco come
Give Blood porta diritti a un sound derivato anzichenò, eppure il giochetto delle associazioni finisce già alla terza traccia, assieme a ogni sentore di
un percorso calligrafico, o parallelo. Malone non è
il Collins pop del combo, semmai ne rappresenta
le attitudini più romantiche e freak, slanci che nel
gruppo di Sitek sono frenati sia dalla fisicità sia dal
'r'n'b di Tunde. Contrariamente Rain Machine è una
collezione di ballate o meglio di canovacci, scuse di
canzoni che a seconda del sentimento, acquistano
pieghe psych (dunque in
dilatazione, alla bisogna
mantra indiani), o direzioni più robustamente
Seventies con chitarre
slabbrate e cadenze più
ripetitive (e chiaramente umori più amari e
dolorosi). A spuntarla
sarà comunque e sempre l'anima free del Nostro
(a tratti può ricordare pure l'Uncle Meat Zappiano)
che libera e distende, lancia al cielo e ad esso si
riconduce.
Kyp è un inguaribile romantico e il tasso emotivo
è altissimo in tutto il disco. Merito del falsetto ma
anche di un registro più gracile e soprattutto nella
modulazione tra le anime in cui si gioca il fascino
narrativo dei testi. La forza è quella del folk eppure, ancora una volta, il legame al soul e alla wave è
ancora TV ma in modo così personale e intelligente
che non puoi che abbracciarlo questo mondo parallelo.
A mancare, in alcuni episodi, è un pizzico d'incisività
in scrittura, non tutto può essere mood e rantoli
del cuore. E viene voglia di andarselo a riscoprire
in seno al gruppo madre il Malone, con tutta la calma che queste tracce comandano naturalmente.
(7/10)
Edoardo Bridda
Richard Chartier - Untitled
(angle.1) (Line, Giugno 2009)
G enere : sculture sonore
Le strutture in microsuoni abili a comunicare con
il silenzio le abbiamo imparate ed amate con Richard Chartier, per intenderci quelle iniziate
con Series (Line,2000), rinnovate con Set Or
Performance (Line,2004) ed a oggi compiute
con indubbia poetica.
Un'arte coltivata da anni, tra devoto riduzionismo
ed esperienza fisica del suono, espressioni predominanti anche in quest'ultimo Untitled (angle.1),
progetto congiunto con l'artista visuale Linn Meyers. La collaborazione si basa su un'installazione
(presentata presso la Art Gallery dell’Università di
Maryland nel marzo di quest’anno) estesa per otto
canali, tracce d'inchiostro e due pareti e sull'interazione (resa possibile grazie ad alcuni trasduttori
audio applicati direttamente sulla superficie) tra la
componente acustica e quella visuale, elementi che
qui lavorano per sinestesia.
Ai confini come sempre le frequenze rasenti lo zero
di acustici e digitali micro-elementi (svincolati, ingranditi e poi negati), un linguaggio questo altamente evocativo che conserva sempre lo stretto legame
con spazio, tempo e forma.
A dar prova di una congiunta affinità tra suono ed
immagine è la superficie sonora, che dialoga con il
tratto e prende il posto alla grafite con droni e
riverberi sottili di rumore bianco.
L'insieme è espresso come nelle più eccellenti opere di shodo e qui, a tenere la penna, è uno dei migliori maestri.(7.5/10)
Sara Bracco
Richard Hawley - Truelove's Gutter
(Mute, Settembre 2009)
G enere : pop nostalgico
Richard Hawley esercita la difficile arte della calligrafia, che non è calco pedissequo ma bella
(ri)scrittura di archetipi fondanti una tradizione e
perciò innalzati al ruolo di classici. Nel suo caso il
miglior pop d'alta classe dei decenni '50-'60 e relative derivazioni, rimessi in circolo secondo minime
varianti formali che assecondano una curiosità musicofila molto più fervida di quanto possa apparire.
Ama tributare i grandi songwriters Tin Pan Alley ma
anche Elvis Presley e Scott Walker l'ex Pulp,
e lo fa giocando rispettosamente con quelle atmosfere anche in base agli umori del momento, che
qui iniettano ombre desolate e improvvisi spiragli di
recensioni
99
luce in otto brani perfetti per la stagione in corso.
Truelove's Gutter racconta infatti la parte crepuscolare dell'amore abbandonando del tutto i pizzichi spensierati del precedente Lady's Bridge
a favore di tempi e suoni dilatati. L'armamentario
si arricchisce di strumenti dalla grana inconsistente come l'acuofono e il crystal organ, i cui echi di
sirene lontane e placidi fantasmi fanno il paio con
slide guitar in rifrazione,
lividi synth ed improvvisi bagliori orchestrali. La
voce come sempre vellutata calca le sue zone più
scure, si appoggia su riverberi sottili che la rendono solitaria nel vuoto
(As the down breaks), e
trova il giusto punto di
equilibrio tra un Mark Lanegan lacrime agli occhi e un Jarvis Cocker nostalgico a fine serata
nei nove minuti ampi come una pianura autunnale di Remorse code. Al contrario Oper up your door
albeggia su tastiere cangianti prima che l'orchestra
risplenda in zona Frank Sinatra e Soldier on - il
brano migliore in scaletta - deflagra elettrica come i
Mercury Rev di “All is dream” dopo un'introduzione di tastierame inquieto e slide doverosamente
profonda.
Ma anche quando sta maggiormente nelle righe (il
vaporoso country-jazz di Ashes on the fire, il sarcasmo dolcificato del singolo For your lover give some
time) Hawley dimostra di saper maneggiare e non
subire una tradizione che lo vede oggi tra i pochi
possibili proseguitori. Ad altri dunque il compito di
stravolgere il passato per trovare chissà quale futuro; a lui invece quello di scaldarci i cuori accarezzandoli con malinconie senza tempo.
(7.3/10)
Luca Barachetti
Ronin - L'Ultimo Re (Ghost Records,
Ottobre 2009)
G enere : imaginary soundtrack
Le atmosfere cinematografiche hanno sempre rappresentato la spina dorsale dell’idea Ronin, naturale che il progetto dorelliano le abbracciasse ufficialmente in colonne sonore prima reali (quella del
film Vogliamo anche le rose di Alina Marrazzi e della
serie TV Non pensarci) e poi immaginarie (l’attuale
comeback).
L’Ultimo Re, oltre che una imaginary soundtrack, è
100
recensioni
anche un concept. Niente di meglio della frase riportata all’interno del booklet per coglierne l'essenza.
Fa "con le budella dell’ultimo prete impiccheremo l’ultimo re" ed è una frase recepita in tenera età dal Bruno che, come una ossessione dal passato, riecheggia
nella fantasia dell’autore in mille, diverse forme e
varianti nel corso degli anni, fino a quella (se non
conclusiva, per lo meno temporaneamente definita)
della composizione delle presenti 9 tracce.
Film senza immagini e poesia senza parole, L’Ultimo
Re è un disco elaborato in formazione a quattro
e completamente al maschile: Nicola Ratti alla chitarra, Chet Martino al basso e Enzo Rotondaro
alla batteria, più - graditi ospiti - il violino di Nicola Manzan, il basso tuba di Giordano Geronzi e i
field recordings di Ivan A. Rossi; supporti preziosi
nell’incastonare il mood generale in percorsi a volte
sghembi e/o laterali. Riecheggiano visioni di rivoluzione e resistenza, ribellione e liberazione trasfigurate attraverso la lente strumentale classica del progetto, ovvero desertiche atmosfere un po’ spaghetti
western morriconiani, un po’ malinconiche visioni
da mitteleuropa in disarmo. C’è molta polvere tra i
solchi, esattamente come quella che riempie la scena finale dell'ipotizzato film mentre una dissolvenza
incrociata indugia su due piedi a penzoloni. Quelli
della Morte Del Re.(7.5/10)
Stefano Pifferi
Rural Alberta Advantage Hometowns (Saddle Creek, Luglio
2009)
G enere : I ndie pop , post screamo
Combattuti tra un fare crudo à la Violent Femmes con reminescenze screamo (e se volete pure
Meat Puppets), e dei modi da tipica band indietronica filo tedesca che non ha paura dei quattro
quarti (e nemmeno dei campanellini), l'esordio di
questi schizofrenici canadesi non è niente di più che
la media delle fascinazioni che potete raccogliere, e
avete raccolto, da questi generi. è indie un po' copia
incolla, fatto con passione e cura ma che, d'altro
canto, bada ancora troppo ad unire le punte del foglio e non libera veramente il cuore.
Un ascolto, i fan dell'etichetta di Omaha dovrebbero darlo, senza tuttavia aspettarsi grandi sorprese
né canzoni memorabili. In pratica, vale quel che si
diceva per certi Tunng, pure loro un poco fregati
da questo star in bilico tra sintetico e folk. Genuinità sì, ma a che pro?(6/10)
Edoardo Bridda
Serengeti & Polyphonic Terradactyl (Anticon, Giugno 2009)
G enere : electro - hop intimista
Serengeti & Polyphonic sono David Cohn e
Will Freyman, rispettivamente rapper e produttore di stanza a Chicago. Entrambi hanno già qualche disco alle spalle quando si conoscono, un po'
per caso, nel 2005, e cominciano a collaborare. Il
disco intero arriva nel 2007, Don't Give Up, e gli
fa guadagnare un posto alla Anticon.
Serengeti rappa nella koinè spoken-paranoica dell'indie-hop Duemila, ma senza i picchi espressionisti,
quando non i veri e proprio assalti, di colleghi più
famosi come Buck 65, Sage Francis o lo stesso
Doseone. Sembra piuttosto seguire la strada di
un impressionismo scazzato. Le basi di Polyphonic
sono la parte più interessante della faccenda.
Suonano per certi versi
nuove, in un contesto del
genere. Un'elettronica
dai piccoli tocchi quasi giocattolosi, ma per niente
allegra, anzi decisamente sinistra, eppure divertente, un'elettronica glitch-percussiva, opportunamente (visto lo stile trattenuto del rapping), intimista,
ora vicina ad arpeggi alla Glass-rallentato, ora vicina a soluzioni quasi da film noir. Picchi di genialità
nell'uso delle corde pizzicate e della fisarmonica in
Patriotism. Interessante, ma, come dire, da sviluppare.
(6.9/10)
Gabriele Marino
Shannon Wright - Honeybee Girls
(Vicious Circle, Ottobre 2009)
G enere : indie folk
Sta nel rifarsi al disco omonimo concepito con
Yann Tiersen un lustro fa la chiave appropriata
per addentrarsi in questo settimo lavoro di Shannon Wright. La quale festeggia il decennio di attività in proprio da che, abbandonate le Crowsdell,
transitò dall’indie-rock a un folk-rock tormentato
che risentiva del “post” e contemporaneamente
mostrava una robusta conoscenza delle radici. Così
la ragazza è maturata ulteriormente lungo un percorso di tre album, giocati tra graffiare di elettrica
e pause pianistiche, un’ugola torturata e azzeccate
seduzioni teatrali e classicheggianti. Mantenendo
sempre la bussola e l’equilibrio, assieme alla consapevolezza che occorresse una svolta, prima o poi. La
quale è giunta, come si dice in apertura, sotto forma
di atmosfere più raccolte e trasparenti senza smarrire personalità né quel suo piglio severo, essenziale.
Che è, probabilmente, quanto le ha sinora impedito di allargare quella cerchia di intenditori “underground” in cui la Wright è relegata da sempre.
Chissà che non tocchi a Honeybee Girls fungere in
tal senso da giustiziere, col suo abbassare ulteriormente il volume trattenendo la profondità esecutiva e confinando l’elettricità a due tracce soltanto,
affidando il resto di ed emozioni a corde delicate,
oscurità di tasti e stridori collocati per lo più in sottotraccia. Pressappoco quanto accadeva due anni fa
nel predecessore Let In The Light con più continuità,
ma per favore che non si parli di un passo indietro.
Di un girare attorno, piuttosto, come attestano la
tesa Father e una controllata Tall Countryside, il girotondo alla P.J. Harvey Never Arrived e le amarezze zuccherine di Sympathy On Challen Avenue. Più
d’ogni altra cosa, dimostra la grandezza della Nostra
una Asleep sottratta per sempre agli Smiths levando la scorza drammatica e spedendo la melodia in
volo nel vento. Da restare senza fiato e applaudire
fino a spellarsi le mani per il coraggio e la maestria.
(7.4/10)
Giancarlo Turra
Simona Gretchen - Gretchen
pensa troppo forte (Disco Dada,
Novembre 2009)
G enere : indie - folk - rock
C'è della sostanza in questo esordio di Simona
Gretchen. Qualcosa di indefinito ma al tempo stesso
tangibile, terreno fertile per frutti acerbi e dai colori cangianti. Una comunicazione senza filtri mediata
solo in parte dal buon lavoro in fase di produzione
portato a termine da Gianluca Lo Presti e Lorenzo
Montanà, ma anche un flusso di parole che si appropria della musica ripiegandola e stropicciandola, per
farla rientrare nei limiti imposti dalla metrica.
Viene in mente Alessandro Grazian, quando in
Due apprendisti un'acustica suonata senza riguardo
si mescola a un immalinconirsi delle trame; si vorrebbe citare la Cristina Donà del disco d'esordio
ascoltando alcuni passaggi della mutevole Bianca in
fondo al mare. Eppure c'è anche dell'altro. Nell'approccio quasi progressivo - nel senso di estremamente variabile - della scrittura, nella estemporaneità degli umori, nella voglia di seguire il distendersi
delle parole senza grossi riguardi per la coerenza
delle geometrie. Elettricità e lirismo, dissonanze e
recensioni
101
melodia, fuse in una concezione di musica istintiva
e immediata.
In conclusione, da un lato si assiste a una dimostrazione di carattere non indifferente, dall'altro emerge forse la mancanza di una quadratura precisa che
indirizzi gli sforzi narrativi della Gretchen verso
un'estetica riconoscibile.(6.4/10)
Fabrizio Zampighi
Sondre Lerche - Heartbeat Radio
(DECCA, Ottobre 2009)
G enere : O rechestral pop
Quest'anno Sondre Lerche firma il sesto album
e c'è già qualcuno che lo paragona a Paul McCartney piuttosto che un amante dei Belle And
Sebastian particolarmente spigliato. Lui però
l'umiltà di farti la domanda che conta ce l'ha. Tell me
what you think about this song, chiede nell'omonima
Heartbeat Radio. E chiedendotelo inizia a cantare lasciandoti la sensazione che non se la faccia davvero.
Sondre e Robbie (Williams) hanno qualcosa in comune. Da sempre sanno d'essere dei talenti e forse
il loro vero problema è proprio quello.
Il ragazzo from Bergen se l'è sempre sentito quel
sangue da fottuto Michael J. Fox nelle vene. La commedia della canzone, l'epoca d'oro per eccellenza,
tutte le big band, i San Remo buoni e cattivi, i Sinatra
pop e quelli più jazz, gli swing e i twang.Tutti i mondi
in smoking sono suoi, e
lo sono sempre stati tanto che una soundtrack
come Dan In Real Life
(del 2007), manco a dirlo,
gli era venuta come bere
un caffè, quasi bella come
quella di About A Boy che
ci fece innamorare di
Badly Drawn Boy
(e dal quale abbiamo divorziato presto). E mentre
Robbie s'affossa (anche commercialmente), l'oggi ci
porta Heartbeat Radio servito ancora una volta caldo, dolce e con lo zucchero a velo sopra. Caria
i denti, ma è buono.
Peccato per la canzone omonima, anche singolo,
non all'altezza della Two Way Monologue che è poi
l’hit insuperato. Ma nel disco c’è di cui godere e
Like Lanzeby, vaudeville da tubetto dentrificio davanti allo specchio dedicata al James Bond più sfigato
della storia (quello scozzese che gli muore la moglie
per chi se lo fosse scordato) è proprio the track,
bella perché in quell’ironia sotto traccia c’è il di102
recensioni
stinguo col Take That. Controllando i suoni, l'ego e
la chitarrina da ritorno al futuro, Sondre surfa sul
mainstream senza fottersi.
Archi e fiati cinquanta style vanno alla grande in I
Guess It's Gonna Rain Today ma è If Only è il gioiello d'arrangiamento e melodia. Hip hop, soundtrack
007, dub, samba. Di tutto e di più in una coralità
limpida come davvero poco pop riesce. Al contrario, non manca l’essenzialità: Pioneer è quel che ci
vuole per i corretti paragoni con il baronetto. Infine
i difetti, non mancano sicuramente in quest'album:
pose disney (Words & Music) e quelle Ottanta (Almighty Moon) sanno di minestra bollita e del resto,
dai Cinquanta agli Ottanta (e ritorno) non si esce
vivi. Speriamo che per questa strada non si finisca
dalle parti di Quantum Leap (il telefilm).(7.1/10)
Edoardo Bridda
Soulsavers - Broken (V2 Music,
Agosto 2009)
G enere : electro rock blues
Metti Mark Lanegan a pasteggiare con una coppia di
transfughi trip hop (Rich Machin e Ian Glover). Metti che il suo fiero pasto faccia tremare le stoviglie e
persino le gambe del tavolo, al punto che di trip hop
non è quasi più il caso di parlare. Così oggi i Soulsavers sono soprattutto Lanegan (autore di tutti i
testi) ed un circondario sonico (elettrico, elettronico, cameristico) che tenta di ricollocarne il perno
espressivo ottenendo al più una lieve vibrazione dei
margini blues-rock (con qualche fregola gospel). Ché
ormai il caro Mark è icona monumentale, roccioso
pilastro piantato al valico tra antico e contemporaneo, con poca voglia di rimettere in discussione il
molto già conseguito. è questa la sua forza ed il suo
limite. Difficile attendersi nuove sottigliezze diaboliche, l'angelico rovello e l'estasi sanguigna dei primi
due lavori, sembrando anzi già lontanissimo persino
il frugale mistero di Field Songs.
Però ovviamente ci accontentiamo, perché l'autorevolezza generosa che pervade la trepida Can't Catch
The Train o la minaccia ingrugnita di Death Bells sono
situazioni più che degne. E ancor più la resa delle due cover in programma, Some Misunderstanding
di Gene Clark e You Will Miss Me When I Burn
di Will Oldham, quest'ultima cantata assieme
all'australiana Red Ghost, al secolo Rosa Agostino,
scoperta per l'occasione e apprezzata al punto da
affidarle per intero le ombrose Praying Ground e By
My Side. Le altre ugole impegnate a duettare con
Lanegan sono un bel parterre de roi del mainstre-
am alternativo: Jason Pierce degli Spacemen 3, il
grande Mike Patton (in quella Unbalanced Pieces
che sembra una outside dei Gutter Twins), persino i cari Gibby Haynes e Richard Hawley in diretta
dal pianeta Butthole Surfers.
Alla fine però il duetto più bello s'innesca tra il tenebroso Mark e la felpata Rosa in Rolling Sky, sette
minuti e oltre di caracollare torbido e disarticolato tra fatamorgane jazz
blues e cascami electro.
Ci sarebbe pure una agile
rilettura di Sunrise - strisciante ordigno risalente
all'epoca Whiskey For
The Holy Ghost - affidata al canto del principe Billy, ma è stata scelta
come singolo-antipasto e non è stata inclusa in scaletta. Peccato. Anzi, meglio così: di carne al fuoco ce
n'era già molta. Forse troppa.(6.8/10)
Stefano Solventi
Sparklehorse/Fennesz - In The
Fishtank 15 (Konkurrent NL,
Settembre 2009)
G enere : electro folk
è la quindicesima volta che capita. I pesci non perdono il vizio e la Konkurrent nemmeno. Stavolta
nell'acquario ci sono finiti Sparklehorse e Fennesz. Come sempre, accadono cose che noi animali
terrigni difficilmente potevamo prevedere. Difficile
infatti calcolare affinità, divergenze e sintesi tra due
specie tanto diverse eppure simili, così lontane così
vicine. In entrambe una brama di centralità combattuto dall'istinto dei margini, tra le acque trasparenti
ma rapide o le più quiete ma scure.
Inafferrabili, se vogliamo, ed eccoli impegnati in questa session del dicembre 2007 a sfiorarsi, a intrecciare fili di traiettorie impalpabili, a mangiucchiarsi
l'un l'altro la scia inseguendo quel microrganismo
che accenda il bagliore, che completi per un istante
il senso di tutto questo imprendibile guizzare.Astrazioni elettroniche, apocalissi angosciose, sospensioni frugali, fantasmi folk, palpitazioni tenui di cuori
affranti abitano queste sette tracce effimere e intense come mandala da un'altra dimensione. Quella
dell'acquario, appunto. Nella quale l'americano recupera con gli interessi quella delocalizzazione sonico/emotiva accennata ai tempi del magnifico Good
Morning Spider, mentre l'austriaco esperimenta
inauditi livelli di indolenzimento e batticuore. Risul-
tati non eclatanti, comunque bastevoli per l'ennesimo chapeau.(7.2/10)
Stefano Solventi
Squarepusher - Solo Electric Bass
1 (Warp Records, Agosto 2009)
G enere : as solo di bas so
Che il pusher quadrato fosse amante del basso lo
sapevamo già, ma dall'amore al disco ne passa. E invece lui si permette di riproporre sul supporto di
plastica una session in solitaria tenuta alla Cité de
la Musique di Parigi lo scorso settembre 2007. Una
cosa che la ascolti e senti la sua tecnica tra slap e
funk, tra arpeggi quasi chitarristici e svisate per gli
amanti di Pastorius. E poi? Poco o niente.
Più che un disco, uno sfoggio posh di conoscenza. Se
sei coraggioso e riesci ad arrivare alla fine, l'anima
non la vedi nemmeno col binocolo. Prescindibile anche (e soprattutto!) per i fan.(0.01/10)
Marco Braggion
Stardog - Oltre le nevi di
piazza Vetra (Frequenze Studio,
Settembre 2009)
G enere : wave - pop
Parte nel modo migliore Oltre le nevi di Piazza Vetri dei milanesi Stardog. Con una Quale Estate che
somma aromi Radiohead prima maniera a cadenze autoriali, una Canzone del dove imbrattata di
new wave elettrica tutta chitarre e crescendo, una
Gli addii di Anita sospesa tra Bluvertigo e degli
eightes robotici in stile Camerini. Poi un po' si
perde. O meglio, sceglie coscientemente di adottare
un approccio alla materia fin troppo “baustelliano”,
con quell'incedere in levare decodificato in bilico
tra elettronica, tastiere assortite e pop.
Se in Sai Carmelo l'esperimento tutto sommato riesce, in Tridimensionale già ci si chiede il perché di
tanta fedeltà a un modello formale che ha evidentemente fatto scuola ma che altrettanto chiaramente
odora di stantio quando non è nelle mani di chi l'ha
istituzionalizzato. La tentazione di confinare il disco
tra le produzioni non del tutto riuscite diventa poi
pressante nel momento in cui ci si imbatte in una
Come cani francamente prescindibile e solo un colpo
di coda finale del programma salva baracca e burattini da una sorte ingrata. Anche perché Il lamento di
Bardamu è uno spettacolare esperimento di clonazione in bilico tra jazz e crossover mentre L'avventura è l'ennesimo flashback Radiohead mitigato da
atmosfere malinconiche in stile chanson francese.
recensioni
103
Alla fine un'opera ambivalente, Oltre le nevi di piazza
Vetra, per una band che da un lato mostra di meritarsi la stima riservatale nell'ultimo periodo da addetti ai lavori e pubblico e dall'altro rivela di non
aver ancora concluso il proprio percorso di ricerca.(6.7/10)
Fabrizio Zampighi
Stephan Mathieu/Taylor Deupree
- Transcriptions (Spekk, Giugno
2009)
G enere : ambient / elettroacustica
Stephan Mathieu e Taylor Deupree ce
l'hanno nel sangue i droni e l'elettroacustica, che
per questa prima collaborazione in uscita Speek,
scorrono disinvolti e fluidi.
Mathieu ci mette le registrazioni e i marchingegni
(due grammofoni, una serie di 78 giri e cilindri di
cera, antenati dei conosciuti vinili), Deupree invece
una serie d'interventi acustici per chitarra e sintetizzatori.
A uno la fonte mentre all'altro le aggiunte in colore e luminosità ma
come vedremo, passati
i quarantotto minuti di
Transcriptions, per
raggiungere incantevoli formazioni d'insieme
l'uno è certo che ha
estremo bisogno dell'altro.
Ora, tutto il merito non sta nell'esperienza in sé ma
nel saperla mettere in gioco, tra monoliti in ambient
(Nocturne) e texture che galleggiano (Andante), illuminate in un divenire ora introverso (Genius) ora
idilliaco (Solitude of Spheres).
Quando poi ci si viene incontro e non vengono a
meno i principi (quelli del suono puro del Mathieu)
ma se ne prende cura il Deupree con movimenti di
superficie, non c'è certo bisogno di preoccuparsi a
scrivere grandi rivoluzioni.
Tanto basta quindi a presentare un'altra accoppiata in gara per il titolo della più bella dell'anno.
(7.3/10)
Sara Bracco
Steve Earle - Townes (New West,
Maggio 2009)
G enere : country in opposition
Un impegno toccante, l’album numero tredici di
Steve Earle, incombenza che piace immaginare
104
recensioni
in parte piacevole e in parte non poco amara. Mentore, compagno di vita maledetta e più d’ogni altra
cosa amico, il capostipite della gloriosa tradizione
dei “texan troubadour” Townes Van Zandt è
affrontato col cuore in mano pescando tra brani più
o meno celebri di una produzione con pochissimi
eguali nella canzone americana per valore storico e incontaminata bellezza. Capisci quanta sia la
profonda umanità profusa già da un titolo laconico
ma che più significativo non potrebbe essere, dalla
cura estrema e dai pochi ospiti - la consorte Allison
Moorer, il figlio di recente debutto Justin Townes
(eh…) e un sorprendente Tom Morello - aggiunti ai
fidi strumentisti.
Poco altro resta da dire oltre alla carica emotiva
sprigionata da questa quindicina di canzoni, anello di
una catena saldissima che conduce fino all’attualità
di una pregnanza che si estende ben oltre il “disco
tributo”. Per la semplice ragione che c’è un (grosso)
pezzo di vita dell’interprete e tanti brandelli dell’autore racchiusi in essa, ragion per cui le dissertazioni
stilistiche e oggettive di sorta possono, per una volta, andare a quel paese. Spazzate via dalla malinconia,
dalla rabbia, da un respiro romantico d’altre epoche
che oggi sono in pochi a possedere senza scadere
nella cartolina: prese quasi a caso, Pancho And Lefty
e Lungs, To Live Is To Fly e (Quicksilver Dreams Of) Maria rinascono come le altre compagne a nuova vita
semplicemente perché non sono mai morte.
Sono classiche, sempiterne increspature colate d’esistenza e virile poesia del Grande Paese. Di quando
nascondeva ancora un sogno da raggiungere prima
delle guerre insensate nel nome di diosacosa e prima
del crollo di un sistema economico frantumato da
se stesso. Solo Steve poteva degnamente omaggiare
l’uomo di Fort Worth, avendone raccolto - qualcosa
come venti anni or sono - il sofferto testimone, e
così è stato.(7.6/10)
Giancarlo Turra
Summer Cats - Songs For Tuesdays
(Slumberland, Agosto 2009)
G enere : indie - wave - pop
Il dubbio che nelle vene degli indie-popper più irriducibili questa musica possa scorrere rimane. Eppure in certi casi sottolineare come un pop leggero, nutrito a pane wave e Sixties, venato qui e là
di garage per timidi, possa decisamente annoiare è
doveroso. La pur amata Slumberland è andata a produrre una band australiana - al secolo Summer
Cats - il cui unico picco sembra essere la capacità
di infilare in Songs For Tuesdays esclusivamente dei
luoghi comuni.
Non che il pop per ragazzini debba necessariamente eccellere per originalità: l’estetica indie si alimenta del perenne procrastinamento di se stessa. Tanto
più in un contesto così pianeggiante però è cruciale
avere abilità, dosare le parti, saper scrivere. I Summer Cats puntano tutto su una tastiera giocattolovintage (non scomodiamo neanche le evidenti provenienze di questa scelta) e su una chitarra appena
appena ingrezzita e svelta nel sciorinare gli accordi.
Non si sente per nulla la passione per la scrittura.
Anzi i Cats riescono persino a rovinare l’ennesima mossa-carica-feedback alla Jesus And Mary
Chain di Paperweight, aggiungendo quel solito canto - la cosa che fa più innervosire del disco - squisitamente banale, immaturo, trascinato non si sa dove
e perché.
Non vogliamo fargliene troppo una colpa. Ma mettere in luce come la loro strategia, apparentemente
disimpegnata, sia in realtà chiarissima.(5/10)
Gaspare Caliri
Susanna - 3 (Rune Grammofon,
Ottobre 2009)
G enere : E motronic
Se il suffisso è fin troppo inflazionato, quell'emotronic che campeggia sul loro MySpace ben sintetizza
la cifra stilistica di Susanna Karolina Wallumrod e
Morten Qvenildi. 3 non si discosta di una virgola dai due precedenti
album: è la parte elettronica e avanguardistica degli arrangiamenti a far da contraltare all'approccio
puramente cantautorale e un poco pop di Susanna.
In alcuni episodi è solo il piano ad accompagnare
la splendida voce della Nostra (Another Day, cover
di Ray Harper) e sono ancora barlumi e intermittenze siderali ad essere evocati in queste dieci
canzoni. Il sublime è ancora il corrispettivo estetico
di un fluorescente cosmoviaggio. (7/10)
Andrea Provinciali
Swell Season (The) - Strict Joy
(ANTI-, Ottobre 2009)
G enere : folk soul pop
Baciati da repentina fama grazie al premio Oscar per
Once, pellicola nella quale Glen Hansard e Markéta
Irglovà hanno dato vita ad un docudrama più vero
del vero, tanto fragrante la vicenda dei due aspiranti
musicisti quanto riuscita la soundtrack che ne suggellò l'intesa. Questa clamorosa botta di celebrità ha
ovviamente riempito di carburante il serbatoio del
progetto, attivo dal 2006, anno che li vide debuttare
con un album omonimo. Non stiamo parlando quindi di una continuità della "finzione" cinematografica come accadde con The Committments nel
1991, glorioso film di Alan Parker nel quale Hansard
"interpretava" la parte di un chitarrista abbastanza
sfigato.
Ruolo che il buon Glen ebbe poi modo di ripudiare, preferendo dedicarsi
anema e core alla causa
dei suoi Frames. Questo Strict Joy va quindi visto come il nuovo
capitolo di una deviazione - battezzata The
Swell Season - nella
ormai lunga carriera di
Hansard, anche se rischia seriamente di trasformarsi nella sua esperienza più significativa. C'è da dire
che con la pianista, chitarrista e vocalist ceca combina una coppia ben assortita. I due giocano bene
le carte, conferiscono pathos tangibile alle canzoni,
non si limitano al compitino disimpegnandosi tra
soul di stampo Van Morrison (idolo dichiarato
di Hansard ed eclatante modello per la sanguigna
Low Rising) e folk più o meno corroborato "indie"
(l'estro traditonal addomesticato in Love The Conquers e Fantasy Man, un impeto struggente in High
Horses e The Rain).
Molto romanticismo quindi, intensità, orchestrazioni
preziose però mai eccessive, generosità e consapevolezza, i due sembrano a tratti un ibrido tra l'amico Damien Rice e i Counting Crows (vedi la
bella The Verb o Felleing The Pull), oppure i nipotini
segreti di Cat Stevens (Back Broke). La formula è
giusta, il successo - oserei dire - legittimo.(7/10)
Stefano Solventi
Themselves - Crownsdown
(Anticon, Ottobre 2009)
G enere : electro - hop d ' as salto
La Anticon ha vissuto una fase di stagnazione dopo i
fasti dei primi pionieristici anni Duemila. Da qualche
tempo, inaspettati, stanno giungendo - sempre però
tra alti e bassi - i primi segnali di una ripresa. Se non
altro ripresa della presenza sul mercato.
A fine 2008, lo stiloso disco di Tobacco; in questo
2009, il progetto, sulla carta interessante, all'ascolto
invece molto meno, di Buck 65 a nome Bike For
Three; una nuova buona prova pop di Why?; il
recensioni
105
riuscito atto secondo di Serengeti & Polyphonic; e, soprattutto, l'ottimo theFREEhoudini, preludio, nella forma programmatica del mixtape e del
crewalbum, a questo vero e proprio comeback dei
Themselves (che del mixone ripropone quattro
brani).
Di Doseone abbiamo già detto e tessuto le lodi,
col suo timbro acidamente roco, con picchi
alla Tom Waits, e un
ipercinetismo che, anche qui, in certi picchi,
ricorda addirittura il famoso scioglilingua greco
di Demetrio Stratos.
Fin qui tutto bello. Sarà
allora forse la monodia
del disco, rispetto alla varietà di houdini, a deludere.
Meglio, delude forse il modo un po' monocromo
che ha Jel di servire il solo Dose. Un massimalismo
alla lunga un po' stancante (vedi anche il trattamento
della voce, sempre stra-effettata), e che un po' mima
e un po' adotta certi microstilemi-macrobrutture nu.
L'effetto finale è quello di un frullatone electro-industrial un po' troppo indistinto e insistito. Peccato.
Forse siamo tornati in un'era da mixtape.(6.4/10)
Gabriele Marino
Tickley Feather - Hors D'oeuvres
(Carpark Records, Ottobre 2009)
G enere : lo fi
Vista col senno di poi, Tickley Feather la si potrebbe considerare madrina di Zola Jesus. E vuoi
vedere che non lo sia sul serio. Però, chi prima inizia,
pur essendo a metà dell’opera non ne è certo depositaria. Questione di talento, sempre e comunque.
Diciamo che la protetta degli Animal Collective
(l’esordio fu battezzato Paw Tracks. Oggi incide per
Carpark Records, ma la cricca è la stessa) compie
importanti passi in avanti rispetto allo sterile e confusionario debutto. Un Ariel Pink in tinte rosa
che muove tra territori out pop (Muscles, Trashy
Boys), saturazioni shitgaze (Buzzy) e dreamy andato
a male, tipo Cocteau Twins alticci (Fly Like An Eagle).
Conoscendola, ripetiamo, notevoli sono i miglioramenti. E poi, semmai si focalizzasse su quanto fatto
in Club Rhythm 96 And Cell Phone - indolenza da cameretta a là Death Cab For Cutie -, il prossimo
disco potrebbe anche stupire.(5.7/10)
Gianni Avella
106
recensioni
To Kill A Petty Bourgeoisie Marlone (Kranky, Settembre 2009)
G enere : shoegaze , ambient
A due anni di distanza da The Patron scatta
l'orologio biologico di Jehna Wilhelm, Mark
McGee e soci. Ancorati al passato come non mai,
i due si gingillano in un tributo agli Slowdive, alle
atmosfere slowcore e alle sonorità Kranky, senza dimenticare la 4ad. Rispetto ad un paio d'anni fa' hanno sacrificato trip hop e mantra industriali a favore
di un narcotico romance e di atmosfere ossessive,
collaudate dal prèt à porter batteristico di matrice
post rock. Niente di nuovo ieri e nemmeno oggi.
La noia incombe tranne che in un paio di casi: Villain
con una Jehna decisamente ispirata (o posseduta da David Tibet, chi lo sa, con tanto di violino clichettoso ma azzeccato) e I Hear You Coming
But You're Steps Are Too Loud che pur rispettando il
mood generale si eleva quel tanto che basta a ridestare l'attenzione dell'ascoltatore. Tutto un disco
così e sarebbe valso il discorso già intavolato per i
compagni d'etichetta Deerhunter (vedi SA n.48).
Invece i TKAPB hanno qualche problema di scrittura, non riescono ad essere originali quando aderiscono all'humus di riferimento e non convincono
nemmeno nel momento in cui tentano la strada del
pop (In People's Homes è il carosello più sgradevole
della storia dell'etichetta di Chicago).(6/10)
Francesca Marongiu
Twilight Sad (The) - Forget the
Night Ahead (Fat Cat, Settembre
2009)
G enere : P ost -P unk
Secondo album per gli scozzesi Twilight Sad la
cui differenza rispetto all'esordio Forget The Night
Ahead risiede nella brutta deriva emulativa Interpol barra Editors intrapresa. Ritmi cupi e dilatati,
scenari grigi e le solite pose che vi immaginate di
già.(5/10)
Andrea Provinciali
Van Cleef Continental - Red
Sisters (Casa Molloy, Settembre
2009)
G enere : rock
Hanno fatto le cose in grande i bresciani Van Cleef Continental per questo esordio lungo Red Sisters, distribuito già da qualche mese in USA dalla Steam Machine Records e infine anche in patria
grazie a Casa Molloy. L'album conferma quanto di
highlight
Zen Circus - Andate tutti affanculo (Unhip Records, Settembre
2009)
G enere : punk - folk d ' autore
La mutazione è completa. Il Circo Zen approda al cantautorato e all'italiano in un sol colpo, portando in dote il punk-rock elettro-acustico che da sempre identifica il gruppo. Primo disco completamente in lingua madre per i terzetto pisano coadiuvato dall'onnipresente Brian Ritchie
e naturale evoluzione del discorso lasciato in sospeso con quel Villa
inferno di un anno fa in cui già si assisteva a qualche cambiamento
importante. Allora c'erano tre episodi della statura di Figlio di puttana,
Vent'anni e Vana gloria a far ipotizzare una possibile coesistenza tra
estremi in apparenza inconciliabili - il rock sboccato/sincopato dei nostri e la lingua di Dante -, oggi c'è un disco senza compromessi come
Andate tutti affanculo a confermare le aspettative.
Un ricongiungersi con la tradizione del Belpaese? Anche, ma alla maniera di Appino, Ufo e Karim. Il che significa testi orgogliosamente proletari, sentenze senza appello contro una quotidianità italiana intasata di porcherie (su cui si sputa
volentieri) e un approccio alla scrittura che rimanda direttamente a certi anni Settanta ruvidi e
impegnati. Il tutto fuori dalla gratuità apparente di testi e titoli, dal momento che “punk” per Zen
Circus significa mescolare, attrarre gli opposti, estremizzare, ma al tempo stesso negare il no future a oltranza dei “Johnny Rotten” generalisti. Per far passare il messaggio, costi quel che costi.
Non si sacrifica nulla del passato, anzi lo si riconferma e si aggiunge. Lo stoner/noise all'atropina
di Gente di Merda, la ballata tossica e iconoclasta di Canzone di Natale, le primavere disilluse di
Amico Mio (sorta di Canzone per l'estate da bassifondi), l'anticlericalismo in salsa “ciellina” di We
Just Wanna Live, il cinismo accusatorio de L'egoista. Brani che mescolano un'indole quasi pop - nel
senso di popolare - a ruvidezze spietate; episodi che sommano una visione musicale lucida a velleità letterarie on the road.
La maggiore età per Zen Circus ha l'irriverenza dell'autonomia e il coraggio di un disco capace
di aspirare alle posizioni alte della top ten di fine anno. Quindi per favore, non chiamateli più i
“Violent Femmes italiani”.(7.7/10)
Fabrizio Zampighi
buono lasciava intuire quello Junior Bonner ep
che ospitammo lo scorso anno su We Are Demo,
aggiungendo un dominio del sound e una certa capacità di dilagare con grinta e criterio.
Se il Paisley Underground dei Thin White Rope
resta l'epicentro estetico di riferimento, magari tenuto a bada da un'enfasi accorata Willard Grant
Conspiracy (vedi la palpitante Dry Queens) e da
spasmi ombrosi Gun Club (nella travolgente Fire
In My Bones), con una Then She Said bazzicano con
disinvoltura territori Nick Cave (turbolenza percussiva, propulsione d'organo...), mentre con Skulls
azzardano splendide aperture melodiche degne dei
migliori Richmond Fontaine. C'è poi da dire
di una Moonlight Shadows che neppure ci pensavo
potesse essere quella di Mike Oldfield, invece è
proprio lei, tesa e flemmatica col pastrano nero e gli
stivali che non gli stanno neanche male.
Perfettamente in parte, cazzuti quanto basta, insomma: bravi. (7/10)
Stefano Solventi
Vegetable G - Calvino (Olivia
Records, Ottobre 2009)
G enere : pop - psichedelia
Dare per scontata la formula musicale propagandata da Giorgio Spada, Luciano D'Arienzo e
Maurizio Indolfi viene quasi naturale, vista l'aprecensioni
107
parente semplicità con cui si mescolano al suo interno psichedelia barrettiana, pop inglese, voci suadenti à la David Bowie e quant'altro capiti sotto
mano ai tre azionisti del progetto Vegetable G. Eppure quel confondersi di rhodes, chitarre elettriche,
synth, basso, batteria, rubato ai Novanta british e
analogico fino al midollo, è il risultato di un lavoro sapiente sui suoni e di una scrittura solida dalle
fondamenta. A ben pensarci, la stessa che caratterizzava il precedente Genealogy, segno di una maggiore età raggiunta e di una
personalità già formata. Sostenuta, in questo
caso, da un ingorgo di
contrappunti strumentali cresciuto a dismisura rispetto al passato e
surreale al pari di quelle
Cosmicomiche di Calvino
che fanno da collante tematico all'opera.
Il disco è tutto lì, nei controtempi vagamente Fiery
Furnaces di Arcade Lovers, negli incroci di sintetizzatore della title track, nelle irrequietezze Blur
di Saucerman, nell'effetto carillon in salsa As Tears Go
By di Satellite Song. Nessuna indiscrezione che faccia pensare a nuove “zone del crepuscolo” per il
rock contemporaneo, nessun colpo di teatro che
possa rendere felici gli indie-critici più intransigenti.
Ai Vegetable G basta l'autocoscienza di rappresentare l'ennesimo esperimento riuscito nel solco di
un pop autoctono ampiamente contestualizzato ma
nella pratica, quasi perfetto.(7.1/10)
Fabrizio Zampighi
Vic Chesnutt - At The Cut
(Constellation Records, Settembre
2009)
G enere : post songwriting
Come per ogni grande songwriter, anche la carriera di Vic Chesnutt è un gioco di maschere in
cui essere umano e artista sfuggono di continuo. In
modo più sottile rispetto ad altri casi, magari, e nondimeno le attese di chi ascolta sono sempre messe
in discussione nel momento in cui Vic ripensa se
stesso. Specialmente lungo l’ultimo e intenso biennio, allorché - dopo la reinvenzione post-rock della
propria cifra autoriale e un bel disco con gli Elf
Power, dopo la collaborazione col regista Jem Cohen qui già incensata e un appassionato tour ancora
in compagnia degli Elfi - la mossa è trasfigurare con
ulteriore profondità il suono di North Star Deserter.
108
recensioni
Se quell’opera meravigliosa poggiava salda su una
mutazione da Maestro, At The Cut ne conferma cast
di strumentisti (A Silver Mount Zion e Guy
Picciotto) ma guarda altrove, indagando speranzosa nell’animo e creando una mitologia interiore
valida per chiunque.
Come se, riemerso dalla constatazione della rovina
mondiale, Chesnutt fosse libero di perdersi in cento
brandelli chiedendoci di fare lo stesso. Dopo un paio
di brani è già accaduto, siamo nel pieno della calma
susseguente la tempesta e delle sue tracce indelebili
(Flirted With You All My Life è funk lento che nasconde
inquietudini; l’apocalittica apertura Coward inganna
arrivando dalla pellicola coheniana; Philip Guston
spezza la minaccia a colpi d’equilibrata epica). Logico, dunque, che per ritornare a una dimensione
rassicurante Chesnutt scelga gli abiti del suo Sud,
dondolandosi in calde oasi folk-blues come When
The Bottom Fell Out (voce e poco altro a inseguire
scie) e It Is What It Is (satirica ma sorridente di lirico
crescendo) e ballate saporose di jazz, screziato di
“dopo soul” in Chinaberry Tree e dell’essenza della
propria classicità per Chain.
Quando fanno il loro ingresso in scena l’abbacinante
Concord Country Jubilee e Granny, commiato spartano
affine agli inizi del Nostro e struggente come pochi
se ne sono sentiti in questo decennio, Vic rivela il
cuore del disco e la capacità di ripetere i miracoli.
Sempre uguali però diversi tra loro come del resto
l’artefice, trattenuto in questo mondo da una voce
che è soffio vitale.(7.7/10)
Giancarlo Turra
Vitalic - Flashmob (Pias, Settembre
2009)
G enere : P ost -F rench
Pascal Arbez-Nicolas dopo 4 anni. Dopo aver lanciato la moda electro assieme all'amico The Hacker.
Dopo quell'OK Cowboy che ha fatto strage. Il riciclo
di quelle idee è pronto e appena sfornato su questo
nuovo lavoro. E anche se il french touch è ormai
impolverato (vedi le debacle di Simian Mobile
Disco e di Digitalism) il buon vecchio uomo sa
cosa fare di quei cliché che più cliché non si può.
Il crescendo con gli sweep della titletrack, il basso
acido nel fidgeting di See The Sea (Red), la progressività un po' Giorgio un po' Air di Poison Lips, gli anni
80 conditi con i Bloody Beetroots in Terminateur Benelux, la malinconia dei vocoder e dei filtri in
aperture cosmiche di Second Lives (inno istantaneo),
il rimando ai Chromeo in Alain Delon e altre bom-
bette che fanno esplodere i neuroni.
Invece di sputar fuori singoli inutili, c'è ancora qualcuno (vedi alla voce Mr Oizo) che attende e pubblica con il giusto tempismo.Attenti Justice, Vitalic vi tallona. Primo disco dell'autunno danzereccio.
(7.3/10)
Marco Braggion
Vowels - The Pattern Prism (LoAF,
Settembre 2009)
G enere : K raut , free
Unire la classica metronomia Neu! a svolazzi di tastiere e giochini vintage di marca Stereolab è un
canovaccio che dà sempre belle soddisfazioni a chi
lo fa e a chi lo ascolta. I Vowels nella bella To Wires
si muovono idealmente proprio da questo terreno
per mostrarci cosa a loro piace. Peccato che, con
fare smooth jazz, il resto dell'album non farà che
smentirlo, tentando quasi una strada diversa ad ogni
traccia.
In Appendix si prenderanno una licenza free imbarcandosi poi in un una supernova tra Triosk e
Tortoise, in On Up! e Eh Uh faranno un botta e risposta con gli Oneida, mentre in Drums Gone Awry
proveranno strategie jazz-wave su basi dub e tribal.
Chi sono i Vowels? Sicuramente non una cosa sola. E
di identità nelle fervide nicchie neo neo kraut, psych e space, specie ascoltando la forza della citata
Eh Uh, ce ne vuole di più. Vero James Rutledge?(6/10)
Edoardo Bridda
White Rainbow - New Clouds
(Kranky, Ottobre 2009)
G enere : kraut boogie
Quello che di più tipico e particolare c'è nella musica di White Rainbow è quella marea ondeggiante
che pian piano si invigorisce e aumenta di ritmo e
intensità. Un esempio perfetto a questo giro è dato
dalla seconda traccia Major Spillage, che ha il pregio
anche di richiamare gli ultimi Boards Of Canada.
Quello di White Rainbow è il regno del ritmo, della
pulsazione che sa farsi anche pesante come il vecchio big beat anni ’90 o come il vecchio e sempre di
moda motorik kraut. New Clouds secondo disco su
Kranky di Adam Forkner non perde per strada nessuno degli elementi che avevano fatto di Prism Of
Eternal Now un disco degno di menzione, salvo
forse il senso della misura che questa volta va decisamente a farmi benedire, in favore di un approccio
maggiormente libero da costrizioni.
Questo significa che innanzitutto il minutaggio si
impenna e se la tracklist conta solo quatto brani,
questo è perché il più breve dei quattro dura dodici minuti. Non necessariamente un male, ma per
prendere il tiro giusto Forkner rispetto all’esordio
ci mette più tempo, o forse si prende più tempo.
Questo da un lato aiuta i suoi boogie woogie krautedelici a stendersi maestosi e coloratissimi come
non accadeva prima, si
veda tutto il lato B del
disco con i tribalismi di
All The Boogies In The Wold
che imperiosi e incessanti mimano una marcia di
ombre drogatissime verso il più classico degli
arcobaleni acidi per poi
stemperarsi anche troppo in una nube ambient che
spezza troppo il ritmo.
Ad un brano come Monday Boogies Forward Forever
certo non gli puoi chiedere il senso della misura,
ma arrivati a metà il sospetto che si stia girando un
po’ troppo su se stessi si impadronisce dell’ascolto.
Forkner rimane un piccolo mago del new kraut, con
la particolarità di prendersi poco sul serio e di avere
uno stile che balza all’orecchio dopo pochi secondi.
Questa volta si è fatto prendere un po’ la mano, ma
lui è uno di quelli che si fanno con il tempo.(7/10)
Antonello Comunale
Wicked Awesomes - Punk
Holograms (Psychic Handshake,
Settembre 2009)
G enere : punk - wave
A prima vista il Canada sembra aver avuto un ruolo
piuttosto marginale in quella che negli ultimi due
anni è stata la svolta della scena garage-punk americana verso i lidi della new wave; tuttavia ad un più
attento sguardo non possono sfuggire nomi come
Pink Noise, O Voids, Twin Crystals, Shearing Pinx, Mutators e, appunto, Wicked Awesomes i quali, dopo i soliti 7 pollici di rito, giungono
al primo LP per la neonata e conterranea Psychic
Handshake.
Qualche mese fa, recensendo l'album degli O Voids
su TroubleMan, dicemmo di come fosse un buon
disco, ma troppo strettamente ancorato ai suoni
del primo post-punk di fine '70/inizio '80; discorso analogo, ma con il dovuto cambio di coordinate
temporali, potremmo fare ora. Questo Punk Holograms è infatti un disco al cento-per-cento 2.0:
recensioni
109
tramuta strutture garage-punk in chiave synth-wave,
riverbera ed enfatizza gli echi, porta in minore gli
accordi senza rinunciare a qualche piccolo anthem
(Shit Time and Crystal Snot, Hens Teeth) o a qualche
refrain orecchiabile (80GB Ipod, Death Sunglasses).
Un lavoro assolutamente attuale, dunque, il cui limite forse risiede proprio in questa sua così precisa collocazione; quando, tra non moltissimo, la foga
per i riverberi wave sarà passata, questo dei Wicked
Awesomes sembrerà, non a torto, uno tra i tanti
dischi testimoni di un periodo. Non che non se ne
possa fruire oggi, dunque; al contrario: fruirne subito prima che il tempo ne acuisca e ne evidenzi i
limiti.(6.9/10)
Andrea Napoli
William Fitzsimmons - The Sparrow
And The Crow (Downtown, Aprile
2009)
G enere : american songwriting
Ti fa sentire in pace col mondo uno come Fitzsimmons. Perché concede oniriche canzoni non lontane
da un Nick Drake che, sconfitti i propri demoni,
si rifugia negli Appalachi, in una capanna di tronchi
vicina a quella di Neil Halstead. Ti informi e lo
scopri ultimo figlio di genitori non vedenti cresciuto
nei sobborghi di Pittsburgh, Pennsylvania, che comunica con papà e mamma attraverso i suoni; da
lì a far musica per passione il passo è breve. Magari mettendo le mani su
quell’organo che babbo
s’è costruito in casa e alternando musica sinfonica con Joni Mitchell e
Simon & Garfunkel
(che tornano spesso e in
I Don’t Feel It Anymore più
che altrove).
Chiaro che, quando arriva il momento di fare dischi
propri (questo il terzo),William cavi dal cilindro uno
stile sussurrato, raramente dato in consegna alla
solidità “roots” - quando accade, è all’insegna della
sobrietà: If You Would Come Back Home, Further From
You - e viceversa eseguito in punta di dita e plettri.
Canzoni che paiono messaggi stesi su una pergamena alla luce delle candele, insomma. Confessioni soffici e tuttavia partecipi, che rischiano però di
confondersi con mille altre se non sostenute dalla
scrittura. Fortuna vuole che la mano sia di vaglia,
come indicano - pur scontando qualche eccesso
di uniformità - Further From You e After Afterall, Even
110
recensioni
Now e Just Not Each Other. Fa pensare uno come
Fitzsimmons: al fatto che questo filone intimista fu
appannaggio dei pessimamente invecchiati James
Taylor o Cat Stevens e ora cammina su una
contemporaneità che ha sdoganato tutto e il suo
contrario. Tuttavia piace, finanche esalta nella struggente Find Me To Forgive. Ritroviamoci tra vent’anni,
William.(7.1/10)
Giancarlo Turra
Willie Nelson - American Classic
(Blue Note, Settembre 2009)
G enere : vocal jazz
Trenta anni son passati da quello Stardust che
guadagnò al country men Willie Nelson gli onori del
pubblico e i favori del botteghino. La formula era assieme geniale ed eretica: rileggere celebri standard
in una chiave ibrida country-jazz. Funzionò. Eccome,
se funzionò. Furono milioni le copie vendute, un exploit da cui il venerabile Nelson uscì consacrato e
col conto corrente (meritatamente) irrobustito.
Oggi, complice il passaggio alla Blue Note, eccolo
tornare sul luogo del delitto. American Classic
raccoglie altre dodici celebri perle dal Red Book e
le affida alla grazia spiegazzata di quest'uomo, che
per l'occasione ha riposto il country nella credenza e si è abbigliato jazz di tutto punto. è un crooner particolare, certo, nella cui voce gorgogliante e
asprigna indovini il peso delle cose, consapevolezze
di polvere e dolore, il rispetto per certi valori demodé quali - chessò - l'amore. Il risultato è buono,
molto buono. Eleganza trattenuta (la band fornita
da casa Blue Note è ovviamente di tutto rispetto) e
tremiti adulti sottopelle, cui gli interventi di Diana
Krall e Norah Jones (rispettivamente in If I Had
You e Baby It’s Cold Outside) aggiungono quel pizzico
di classe maliziosa. Basterebbe la sola I Miss You So a
far capire la differenza rispetto ad un Bublé qualsiasi:
all'incirca come tra un Lagavulin e un Glen Grant.
Il punto è quello che sei, che possiedi, che ci metti.
Bravo Willie.(7/10)
Stefano Solventi
Yacht - See Mistery Lights (DFA,
Ottobre 2009)
G enere : elettropop
Jona Bechtolt aveva la carriera in discesa e si sapeva. Già lo conoscevamo per il gusto per la ritmica
del pop elettronico e piacevolmente indie. E questo
ci aspettavamo dal nuovo lavoro: lo stato dell’arte
dell’elettro pop Pitchfork-proof. Un calendario intelligente di spunti ritmici da stanza dei bottoni e di
ancheggiamenti. Promessa sostanzialmente mantenuta. See Mistery Lights è un organismo che fin
dalle prime battute chiama a testimone chi del ritmo e del pop ha fatto professione (David Byrne,
per esempio?), ma anche che si presta benissimo
a uscire per la label che lo ha pubblicato, e cioè la
DFA. Per il suo quarto album Jona, aka Yacht (che
sta per Young Americans Challenging High Technology), si sceglie poi una voce femminile come compagna di viaggio. È l’ugola di Claire L. Evans, che
si rischia di confondere con quella della cantante
con cui Bechtolt condivideva il progetto The Blow,
e cioè Khaela Maricich. Ma attenzione, non è
una scelta casuale, se è vero che è quella voce che
riesce a far diventare pop anche un pezzo tendenzialmente ostico (sotto parecchi punti di vista: ritmico, strutturale, armonico) come I'm In Love With A
Ripper. Sembra che Jona conosca bene i propri rischi
ma li percorra lo stesso. Inserisce saggiamente delle
raffinatezze qua e là, come nel piccolo capolavoro
dell’impasto ritmico della seconda parte di The Afterlife, in odore - speziato, ovviamente - di Ultravox; getta esche pop, picchi di gusto indie, quando
la rete diventa per lui stesso difficile da sbrogliare,
arrivando a volte al limite del popolare e delle sue
regole (esemplare Don't Fight The Darkness, ancora
con la voce Blow-esca).
La seconda parte di It’s Borign/You Can Live Everywhere You Want segna poi un tentativo importante, cioè il
passaggio dall’electro alla scimmia house (obbligato,
vista la scuderia?); un brano che dopo aver trascinato un refrain per tot minuti, se ne sbarazza per una
chiusa (da scimmia, appunto) che cita evidentemente gli El Guapo più ispirati e tirati di Supersystem. Insomma, un altro colpo al cerchio mentre si
percuote la botte. Con la moglie ubriaca.
È come se per certi aspetti Yacht puntasse a diventare il New Order dei Duemila (sentite Summer
Song, pezzo che arriva alla DFA percorrendo i Liquid Liquid, con una melodia chiaramente derivabile da Love Song dei PIL, o I'm In Love With A Ripper
(Party Mix)), che peraltro stanno finendo. Il punto è
che, se i New Order partivano dalle cupe atmosfere
di Curtis, ora Yacht parte dalla placida leggerezza dei
Blow. Quindi percorso per così dire invertito. A fine
ascolto, la sua strada rimane spianata, ma bisogna
voltarsi per ritrovare qualcosa che generalmente si
apprezza nel pop: la freschezza.(6.9/10)
Zero 7 - Yeah Ghost (Atlantic
Records, Settembre 2009)
G enere : U p T empo R' n 'M ix
Hanno rischiato di beccarsi un grammy per quella
ciofeca chiamata The Garden dove ai più attenti non
sarà sfuggita la transizione dagli smalti AIR lounge
degli esordi a groove maggiormente up-tempo e
ad atmosfere più facilotte ed estive. Ora provano a
svoltare veramente diventando una sorta di brutta
copia dei Basement Jaxx, proprio dopo essersela presa in saccoccia con due esperimenti più di
nicchia come Ingrid Eto e Kling.
E se due indizi fanno una prova, Yeah Ghost, quarta
prova decisamente radio friendly dei ragazzi, non è
altro che la telecronaca del fallimento del progetto
mutaforma. Un disco che
già sta piacendo poco ai
fan dell’insuperato e salottiero Simple Things, e
che - fidatevi - piacerà
ancor meno agli eterni
nemici del loro sound
fin dalla chiacchierata
traccia dedicata a Zidane
(Everything Up (Zizou)) per la quale il duo ha tanto
dato da intendere. Già, in quel nulla-elettro-qualcosa
al canto c’è il non disprezzabile Henry Binns (metà
del duo al secondo tentativo canoro) e, per l’appunto, saranno uno stuolo di cantanti altre l’airbag per
le masse carstereofile.
La consueta Sia Furler ha lasciato il posto a una
cristallina e brava (senz’anima) Martha Tilston
(Pop Art Blue) e una brava e basta r'n'b come Eska
Mtungwazi (scoperta di Matthew Herbert di
un paio di anni fa) ne ha sosituito consistentemente
la presenza. Al canto in ben quattro tracce pare che
l'impegnata londoner sia stata riluttante alla feature
e che la collaborazione, dopo svariati tira e molla, si sia risolta in testi e parti vocali preparate in
un giorno. In pratica: timbrata di cartellino. E se a
un’obliterata ce ne aggiungi un’altra e non sei un
grande produttore ma semplicemente un musicista
senza idee, il risultato lo conosceiamo già (PS: che si
tengano pure il misterioso Jackie Daniels vododerizzato).(4.5/10)
Edoardo Bridda
Gaspare Caliri
recensioni
111
libri
La musica liberata - L uca C astelli (A rcana , 2009)
è un bel pezzo che Luca Castelli si occupa della complessa e fertile liaison tra musica e web sulle pagine del
Mucchio Selvaggio. Argomento dalle implicazioni spesso tortuose (tecnologiche, etiche, estetiche, poetiche,
legali...) che il Nostro si premura di annaffiare d'ironia e disincanto, ferma restando l'accuratezza e l'acume
delle analisi. Con questo libro, il suo "debutto su lunga distanza",
Castelli tira le somme del suo ormai decennale monitoraggio, una
visione d'insieme che gli consente sintesi di più ampia portata.
Dietro al piuttosto trionfalistico titolo La musica liberata, si
celano le godurie e i tormenti dell'onniutente (neologismo castelliano) alle prese con una goduriosa rivoluzione. Quella che
stiamo vivendo sulla nostra pelle anzi sui nostri timpani smerigliati dalla "deliziosa abbondanza" - per dirla con Cristina Donà
- apparecchiataci dall'avvento di mp3 e P2P. Un'epoca durante la
quale l'appassionato rock ha dovuto per così dire riposizionarsi.
E mica di poco. Come il rock stesso, del resto. Fine dell'imperialismo unidirezionale degli intermediari di musica: attraverso le sinapsi informatiche pulsano i segni di una nuova libertà, che finalmente - come sosteneva Gaber - è partecipazione, fare parte di
un discorso condiviso e globale, interattivo e orizzontale, dove
l'amore che prendi è (quasi) uguale a quello che dài.
Il desiderio e la sua soddisfazione non sono mai stati, dal punto di vista dell'informazione e della comunicazione (pop-rock
compreso anzi in primis), tanto contigui, legati da un reciproco
rapporto di causa-effetto. L'uno il carburante dell'altro. E questo, casomai non l'aveste capito, non significa certo che tutto sia
comodo, facile, disponibile: non per l'artista, non per l'appassionato. Il primo perché deve imparare nuovi percorsi, aggiornare
la mappa e - soprattutto - le mete. Il secondo perché le antiche
fonti sono diventate un oceano, nel quale deve imparare a nuotare, selezionare la rotta, razionare forze e
risorse. Per entrambi, il futuro si prospetta roseo, a patto di lanciare il cuore di là dalle macerie. Quanto
alle major, vabbè...
Il bello di questo libro è che mentre di tutto ciò (e molto altro) fornisce una cronaca puntuale, che poi è
uno dei tanti modi possibili di raccontare gli ultimi quindici anni della nostra esistenza, fa riaffiorare nel lettore ultratrentenne pezzi di memoria assopita. è un'esperienza strana perché parliamo dell'altro ieri, mica
di un secolo fa. Eppure, sembra di risvegliarsi a singhiozzo da una soffice ipnosi. E allora sono brividi, quando
realizzi come e quanto certe consuetudini, certe categorie del pensiero, certi automatismi dell'anima, siano
usciti stravolti, liquidati, vaporizzati nel giro di un paio di lustri appena.
Castelli, bontà sua, non si limita a questo, ma abbozza possibili sviluppi ed ipotetiche soluzioni. Con leggerezza e passione. Con entusiasmo bagnato di nostalgia: perché l'epoca della scarsità - quando ti arrabattavi
tra mitologici vinili, cassette carbonare e imperscrutabili cd - era sì "intensa e romantica", ma anche quella
presente - con le esperienze che s'intrecciano tra quotidiano e universale, tra intimo e globale - "non scherza". Stefano Solventi
112
recensioni
dvd
Giorgio Li Calzi - Aleksandr Nevskij (CNI, Settembre 2009)
Con Aleksandr Nevskij il grande regista sovietico Sergej Ejzenshtejn realizzò nel 1938 un solido film di
propaganda. Eppure, vuoi per la parossistica solennità delle inquadrature, per l'espressionismo impetuoso
delle interpretazioni, per l'imponenza e la plasticità delle scene, è un'opera emblematica che trascende
il contesto storico interno ed esterno che la informano. Simbolo di una rivalsa messianica che sorge dal
popolo obbedendo ad una nemesi vista come necessità, inevitabile algoritmo delle vicende umane e sovrumane, la vicenda di Nevskij procede con una veemenza trascendentale che abbaglia, scuote, soverchia tutto
il catafalco di pensieri deboli con cui può capitare d'affrontarlo, e tante grazie al morbo del politicamente
corretto.
è un linguaggio anomalo ma dalla potenza intatta, perciò attualizzabile, visto che ahinoi non mancano alla
contemporaneità situazioni di predominio cui ricondurlo, economico, politico, culturale o militare che sia.
Su questa pellicola, originariamente musicata da Prokof'ev, il jazzista
Giorgio Li Calzi ha imbastito una nuova soundtrack. Con risultati straordinari. Le elettroniche e la tromba di Li Calzi oppongono alla iperretorica di Ejzenshtejn un astrattismo futurista che disturba, lo precipita in un post-domani parallelo, incipiente, aggressivo per la sua carica
di avanguardia astrusa ma percepibile, in divenire anzi già avvenuta
sulle labbra di Miles Davis (da qualche parte tra In A Silent Way e
Aura), nelle partiture dei profeti minimal-ambient e nelle alcove della
electro sperimentale di casa Warp.
Aleksandr Nevskij diventa così un'esperienza nuova e primordiale,
uno iato vorace dove ribollono angosce presenti e vive.Vivissime. (7.5/10)
Stefano Solventi
recensioni
113
live report
Jesus Lizard
21 settembre , C ircolo D egli A rtisti (R oma )
“So dieci anni che v’aspettamo” grida con la solita
simpatia romanesca qualcuno accanto a noi, sintetizzando insieme l’ansia e l’attesa per il live del quartetto americano. Dal momento della notizia della
reunion e fomentati dai resoconti che giungevano
dai vari festival a cui, quest’estate, i quattro hanno
partecipato – non ultima, la strepitosa performance
al Primavera Sound di Barcellona – è stato un susseguirsi di scandagli online alla ricerca di qualche
data italiana. L’attesa alla fine è stata premiata e i
Jesus Lizard hanno toccato la penisola pronti a
rinverdire i fasti di un suono che nella prima metà
del 90s ha fatto proseliti e devastato audience in
mezzo mondo.
Aprono gli Edible Woman, compatti e metronomici come al solito, bravissimi nel creare vuoti
pneumatici e momenti di apparente stasi rotti da
sfuriate rumorosissime. Scaldano un pubblico al limite del sold-out con la loro formula ridotta all’osso basso+synth+batteria ma nell’aria c’è la tensione
tipica da grande evento. Pochi minuti e i chicagoani si presentano sul palco. Boato ed eccitazione ai
massimi livelli, tanto che David Yow si catapulta subito sul pubblico per il più classico dei crowd surfing.
È lui il fulcro dei Jesus Lizard. Lo sa lui e lo sanno
bene i suoi compagni che, praticamente immobili
per tutto il set, lasciano al mefistofelico cantante la
scena. Duane Denison, camicia da texano e capelli
bianchi, e David Sims, traccagnotto e nerovestito, ai
lati intarsiano un suono che tritura rock dei primordi e hard-rock sudista, blues del delta e lacerazioni noise; McNeilly dietro il suo drum-kit controlla
il tutto dall’alto mentre percuote le pelli come un
invasato. La chitarra di Denison è uno strumento
chirurgico, tagliente e affilata come uno stiletto; il
basso di Sims è invece un carrarmato rock: tondo e
distorto è insieme al drumming di McNeilly la vera
spina dorsale del suono Jesus Lizard, sulla quale Denison va ora di fioretto, ora di clava. I riflettori però
sono tutti per Yow. Uno che alla soglia del mezzo
secolo di vita sembra posseduto dai peggiori demoni del rock. Sputa, suda, impreca, si dimena; in grado
di passare una buona metà del set a rotolarsi su un
114
recensioni
pubblico in totale estasi senza perdere una battuta
del suo cantato. In possesso di una voce sporcata da decenni di abusi ma capace di reggere quasi
un’ora e mezza di puro delirio r’n’r. Con un fisico
da lanciatore di coriandoli sfatto da eccessi di ogni
tipo, regge la scena come pochi al mondo, mentre
si lancia (letteralmente) in quella che in apparenza è
una sorta di seduta psicanalitica a cuore aperto. Un
live memorabile che dimostra ancora una volta – se
ce ne fosse bisogno – la stoffa di chi col rock’n’roll
non ha solo dimestichezza, ma ne ha fatto uno stile
di vita.
Stefano Pifferi
Current 93/James Blackshaw
22 settembre ,T eatro A lfieri (T orino )
L'esoterica Torino e ben tre Festival in sinergia organizzativa (“MITO SettembreMusica”, “Torino Spiritualità” e “Il Sacro attraverso l'Ordinario”) per i
Current 93. L'esibizione del gruppo di David Tibet si inserisce in una due giorni che vedrà la sera
seguente sul palco del Teatro Alfieri Nurse With
Wound, Larsen, z'ev e Blind Cave Salamander, piccolo happening noise-psichdelico-apocalittico di cui
i Current sono l'attrazione principale e il pubblico
presente – numeroso, attento, devoto, alla fine entusiasta – ne è la prova. Apre James Blackshaw, tra
gli ultimi arrivati alla corte di Tibet, qui in veste solista
con il suo nitido fingerpicking che sottopone il suono
Tacoma a melodie dagli sviluppi rotondi e cinematici.
In soli due brani, entrambi alla dodici corde, il chitarrista inglese conferma quanto di buono fatto sentire
nei lavori pubblicati dal 2005 ad oggi (l'ultimo, The
Glass Bead Game, nei negozi per la Young God di
Michael Gira): peccato non si rivolga anche al pianoforte come nel precedente Litany of Echoes uscito l'anno scorso, ma la caratura del musicista emerge
comunque e un nuovo passaggio sui nostri palchi nel
futuro più prossimo è auspicabile se non doveroso.
Anticipati da una Afternoon Delight della Starland
Vocal Band sparata a volume sacrilego come sigla
d'apertura, i Current 93 si presentano con la nuova formazione che sta caratterizzando le sporadiche
esibizioni di questi mesi recenti. Oltre all'immancabile Baby Dee (piano e tastiera), in scena con Tibet
ci sono Alex Neilson alla batteria, Andrew Liles alle
macchine e i due nuovi chitarristi Blackshaw e Keith
Wood (entrambi all'elettrica) in sostituzione di Ben
Chasny e Michael Cashmore. Una line-up che letta
su carta lascia prevedere un suono acustico virato
massicciamente all'elettrico come nel recente Aleph
At Hallucinatory Mountain, ma che al contrario
su palco comporta una generale elettricizzazione del
tutto, con Liles ottimo protagonista di tante incursioni tra il rumorismo e la psichedelia d'ambiente e Dee
a prendersi l'onere di melodie cristalline e movimenti
caotici, quasi a sgravare il compito delle due newentry, una delle quali (Blackshaw) non del tutto a suo
agio tra pedali e feedback.
Fatte queste premesse ecco che trova un senso
anche la scaletta: tutti brani recenti e recentissimi,
cinque da Aleph..., i quattro dall'ep dell'anno scorso Birth Canal Blues e uno a testa da Black
Ships Ate The Sky (la title-track) e Sleep has
his house. I Current, Tibet compreso, ingranano a
diesel sull'apertura di Invocation of Almost per poi venire fuori davvero solo alla quarta traccia, una Not
because the fox barks giocata sulla linea di piano e
l'impronta monocroma della chitarra che lanciano
un crescendo pane per i denti del leader ora davvero spiritato. Ma gli arrangiamenti dei brani, e in
particolare il loro mood, necessitano di un maggior
rodaggio soprattutto quando ribaltano le carte in
tavola. è il caso proprio di Black Ships Ate The Sky,
ripresa in una versione quasi danzereccia dove la
ritmica quadrata e le continue bordate di organo
ed elettronica devono ancora trovare l'intesa giusta
con la voce massacrata nell'interpretazione. L'effetto è decisamente attutito e tirate le somme anche
l'intero set non colpisce come ci si attenderebbe.
Ciò vale almeno sino alla chiusura di The nylon lion
attacks as kingdom (straordinaria la tempra di Tibet
a quel punto infuocata) e Suddenly the living are dying
encore: due bolle di tensione e tragedia che dimostrano cosa siano in grado di fare i nuovi Current
93 al massimo delle loro potenzialità.
Luca Barachetti
Wildbirds & Peacedrums/Dente/Zu/
Massimo Volume/José Gonzáles/
Uzeda/Glasvegas…
4/5 settembre , S oundl abs F estival (T eramo )
Lo scorso anno proprio su queste pagine additammo il Soundlabs come potenziale miglior festival indie del Belpaese, grazie a quell’ottimale mix di
buona musica, sole e mare che aveva monopolizza-
to l’estate rosetana. Pur con presenza di pubblico
non massiccia. Costante registrata anche quest’anno, con lo slittamento di poco più di un mese della
programmazione (non più fine luglio ma inizio settembre).
Il Soundlabs 2009, esclusion fatta per José Gonzales, i cantori della working class scozzese Glasvegas e i Wildbirds & Peacedrums, è stato
di chiara matrice italiana con Massimo Volume,
Dente e soprattutto Uzeda e Zu a farla da padroni. Proprio i live set di queste ultime due band
hanno rappresentato i momenti migliori: i ritrovati
catanesi con il loro sonico post-rock avvolgente, i
romani con il loro mix di potenza, tensione e adrenalina alla stregua di una perfetta e oliata macchina
da guerra post-nucleare. Applausi. Mentre l’onnipresente Dente e i (non più) redivivi Massimo Volume si sono “semplicemente” confermati, in linea
con i loro recenti concerti: il primo candidandosi a
nuovo paroliere della canzone d’autore italiana; la
band bolognese – a parte piccoli inconvenienti tecnici – dimostrandosi perfetta ed emozionante come
sempre. Avremmo gradito solo qualche piccola novità in più.
Degno di nota il duo Wildbirds & Peacedrums:
avvalendosi soltanto di batteria e voce, sono risultati ipnotici, suadenti e contagiosi. Meno sorprendenti
i Glasvegas, headliner della prima serata, anche
se le loro fragorose melodie a presa rapida hanno
conquistato inevitabilmente la platea; da segnalare
la loro buona rilettura di Everybody’s Got To Learn
Sometimes dei Korgis. A proposito di cover, José
Gonzalez ha avuto l’onere di chiudere il festival e
naturalmente non ha perso l’occasione di presentare tutte le rivisitazioni di canzoni altrui (The Knife, Massive Attack, Joy Division, Kylie Minogue) che l’hanno fatto conoscere. In poco più di
un’ora, il musicista svedese mezzosangue argentino
è riuscito ad accarezzare e lenire le ferite inferte
poche ore prima dagli Zu. Armato solo di voce e
chitarra, a conferma di un talento innato. Il pubblico
presente, pochi ma buoni, ha apprezzato, resistendo
fino alla fine non dandola vinta alla pioggia.
Il Soundlabs si conferma allora un festival interessante e coraggioso, che in futuro forse dovrà ripensare a un ricollocamento, probabilmente non a
fine estate. Anche se il palco lo preferiremmo sulla
spiaggia, o nelle sue vicinanze, che non sul cemento
dello stadio.
Andrea Provinciali
recensioni
115
WE ARE DEMO
#40
I migliori demo giunti nelle nostre cassette postali. Assaggiati, soppesati, vagliati, giudicati
dai vostri devoluti redattori di S&A.Testo: Stefano Solventi, Fabrizio Zampighi.
Viti di Titanio - Il giro di vite (Autoprodotto, Luglio 2009)
G enere : folk rock
è un tumulto mediterraneo, desertico e balcanico, la musica delle Viti
di Titanio. Una febbre nata nel 2005 all'ombra del Vesuvio, dove i fratelli Maurizio e Marcello Vitale si misero in testa d'avviare quello che
oggi è un quartetto "aperto" di moderni cantastorie rock, tesi come
buskers reietti che non hanno mai messo da parte né la pietà né la
tenerezza. Consapevoli della forza della poesia, bisognosi del raglio
elettrico. In questo Il giro di vite, seconda prova che espande gli
ambiti dell'ep d'esordio Storie d’amanti e di demoni (2005), definiscono un sound ora solenne e brusco, ora convulso e misterioso
tra chitarre, flauto, synth e i folti palpiti di basso e percussioni.
Un sound stupendamente attagliato alle liriche che s'insinuano con basale austerità in certi crucci
cruciali dell'odierno vivere, cantate inseguendo vibrazioni terrigne che se ne sbattono di qualsivoglia impostazione e legnosamente medita, allude, riflette, sferza, sussurra, e via discorrendo. Le
prime due tracce sono da urlo: una mischia indocile tra Black Heart Procession, Vinicio
Capossela, Ulan Bator, certo caracolare bieco Cesare Basile, certe beffarde sordidezze
Afterhours... Per la cronaca, Calce spenta vede al banco di registrazione Paolo Messere (non c'è
bisogno di presentazioni, giusto?), mentre al missaggio di Naguine troviamo Rodolfo Calandrelli
(fonico per Markus Stockhausen tra gli altri).
Poi la tensione si allenta di qualche punto, non troppi, tra una ballata ben giocata sul filo di uno
sfuggente malanimo (Bambola di porcellana) e uno scherzetto serissimo con le trappole della contemporaneità (Nuove forme di chiusura). La cover di Amara terra mia, dolentissimo classico portato
al successo da Modugno (che lo compose, mentre il testo è di Enrica Bonaccorti), chiude la scaletta
stringendo l'obiettivo sul solo Marcello Vitale a voce e chitarra, conseguendo un'asciuttezza che
non significa lesinare sulle emozioni. La sensazione complessiva è di potenzialità altissime da ben
veicolare.
(7.4/10)
Stefano Solventi
116
recensioni
Chris Yan - Urban Mantra
(Autoprodotto, Ottobre 2009)
G enere : A mbient
Più che Fennesz John Carpenter, più che ambient
una sorta di post-rock cinematografico con qualche
deviazione psichedelico/jazz. L'avrete capito, Urban
Mantra è uno di quei dischi che dividono le masse:
chi lo definirà geniale e chi ne criticherà volentieri i
barocchismi etnici eccessivi e le velleità totalizzanti.
Di una cosa pero' siamo certi: un'asciugatina qua
e là non farebbe male a un programma che rischia
davvero di apparire imponente ai meno avvezzi.
Nonostante l'india fascinosa sullo sfondo e il buon
equilibrio dei suoni.
(6.4/10)
Fabrizio Zampighi
Demednes - Conturbanti pensieri
(Autoprodotto, Ottobre 2009)
G enere : rock
C'è da lavorare e parecchio dal punto di vista tecnico. Eppure i Demednes da Brescia riescono a catturare la nostra attenzione con un rock grezzo –
chitarra, batteria, basso e poco altro – e di buona
fattura. Dei Gun Club non ancora maggiorenni
miscelati a un'indolenza wave su testi in italiano, per
una musica d'impatto costruita su un paio di accordi
e, talvolta, dal sapore vagamente grunge. La strada
sembra essere quella giusta, con l'onere della verifica al prossimo intertempo.
(6.7/10)
Fabrizio Zampighi
Droptimes - Looking For The Sun
(Autoprodotto, Giugno 2009)
G enere : electro wave
Electro-wave scivolosa debitrice delle visioni moroderiane, più contagi jazz-prog e una febbricola
psych-pop nella calligrafia dei Droptimes, un duo
più che altro - Alessandro Maranesi canta e Alessio
Catozzi si occupa di tastiere e basso - però come
si suol dire aperto, visto che alla fine in questo Looking For The Sun si contano altri dieci collaboratori (tra batterie, ottoni e voci) senza contare il
coro di nove bambini che impreziosisce la trafelata
Wake Up.
La loro proposta è inusuale ma accattivante, vengono in mente un po' i dEUS e un po' i Moonshake in fregola drum'n'bass (The Crocodile), dei
Goldfrapp rapiti da alieni Depeche Mode (The
Wall's Family) o certe farragini folktroniche a metà
strada tra Mùm e Sigur Ros (When It Comes).
Per non dire di quella A Revenge come avrebbero
potuto i Kajagoogoo colti da foga electro-black.
Sarà forse il caso di eliminare qualche orpello, ma
questa generosa avventatezza mi piace.
(6.8/10)
Stefano Solventi
Giuda Matti - Lunedì EP - Martedì EP
(Autoprodotto, Luglio 2009)
G enere : avant psych pop
Non li fermerete mai nella loro missione di sbagliare musica con estro libero e saltellante, sciroccato
e - ebbene sì - obliquo porco cane. Continuano a
sfornare EP poco convenzionali, mettendosi pure in
testa di realizzarne una collana di sette. La quale, visto che i primi due si chiamano Lunedì e Martedì, ritengo saranno dedicati ai giorni della settimana.
E vivaddio.
Parlo dei modenesi Giuda Matti e della loro arguta
anarchia pop, che nel primo dei due volumetti chiama bellamente in causa un Morgan svampito Blur
(Stomaci contorti e Il colpo di tacco) mentre nell'altro
si ammanta di sciroccato intorpidimento psychprog, qualcosa tra dei più sordidi Afterhours in
Cassonetti, guardando piuttosto in direzione Maisie e Mariposa in Cronaca locale. Divertono e
disturbano, sanno regolare la manopola dei minimi
termini e dissimulare drammi con abilità. Sono meritevoli insomma del più vasto pubblico indie rock.
Glielo auguriamo.
(7.2/10)
Stefano Solventi
Meadow - Self Titled
(Autoprodotto, Ottobre 2009)
G enere : folk - indie - canzone d ' autore
Indie rock e melodia in un'ideale dialogo tra Sondre Lerche e Conor Oberst. In realtà le influenze sono disparate, ma il succo del discorso
rimane una musica semi-acustica suonata in punta
di plettro, jazzata, interessata all'articolazione della
melodia. I Meadow arrivano dalla Svizzera ma l'ispirazione confina con l'easy listening, il folk raffinato e
certo pop deviante. Per un EP ambizioso e di buono
spessore.
(6.8/10)
Fabrizio Zampighi
recensioni
117
Massive Attack
Know Your Roots
La prima bella notizia è che dal 2 ottobre è in circolazione un nuovo EP dei Massive
Attack. La seconda è che non è affatto male....
- Giancarlo Turra
118
rearview mirror
I n B ristol (W ithout
a
P istol )
Non ce ne voglia Matt Elliott, se ci appropriamo
- anzi: “campioniamo” - il titolo di un suo (polemico) brano rovesciandone il significato. Probabile che
apprezzi, considerando come anch’egli sia un illustre
figlio di una città salita agli onori delle cronache per
le solite ragioni sbagliate e superficiali. A nulla serve
fingersi smemorati, lasciar credere che in quel cuore
rovente dei Novanta fossimo da ben altra parte quando il “famigerato” trip-hop deflagrò, fino a diventare
- in un processo cui ormai s’è fatta l’abitudine - un
bene di consumo penetrato ovunque, dalla pubblicità alla tappezzeria sonora. Il problema era che la
sua natura ondivaga e rilassata si prestava benissimo
alla bisogna; tuttavia, se pargoli degeneri introducono
nefandezze sulla battuta funk/hip-hop, la colpa non è
dei Maestri. Sono i primi a valere poco oppure zero
e sui libri di Storia non ne troverete traccia. Tuttavia c’è stato un anno magico, l’ultima grande raccolta
sul serio fenomenale nel mondo del rock, quel 1991
così rivoluzionario da far strabuzzare gli occhi e dal
quale le cose han preso a correre velocissime, probabilmente troppo. In quell’annata magica, in mezzo
ai tanti muri che cadevano trovavi anche quelli che
separavano underground e mainstream, psichedelia e
noise, pista da ballo e marmaglia pogante.Tutti squassati dalle urla di un depresso biondo del nord-ovest
americano, dalle distorsioni ipnotiche di Loveless,
dai bassi profondi e le melodie stellari di Blue Lines. E,
certo, anche dalla matematica degli Slint e dall’Estasi
dei Primal Scream. Avvenimenti irripetibili, legati a doppio filo con dischi che lo sono altrettanto,
per la semplicissima ragione che le rivoluzioni si fanno
una volta nella vita. Le evoluzioni, invece sono materia
quotidiana. Sono affrontare i cambiamenti senza farsi schiacciare da loro o da un passato ingombrante
e immenso. Da molto tempo i Massive Attack sono
“classici” che hanno mostrato quanto solido fosse il
loro messaggio: ci insegnarono che si può essere un
fan di rock e di black purché la radice e le aspirazioni
- una musica “totale” e creativa, che travalica qualsiasi
limite - siano le stesse; che puoi godere di un solo di
chitarra come di un virtuosismo del giradischi; che
storture ambient e attitudine alla danza non sono
estremi incompatibili. Uno splendore che rintraccia
la spiegazione in una parola: “crossover”. O, se preferite, meticciato.
Facile respirarlo sin da bambino a Bristol, bellissima mulatta ad un certo punto così ricca e importante da essere considerata centro urbano più
importante d’Inghilterra dopo la capitale. Era la più
grande città fino alla rivoluzione industriale, avendo
elevato il suo prestigio sul commercio degli schiavi:
logico dunque che, una volta cancellata quella vergogna, rimanessero salde l’attitudine al commercio
e a far girare le novità provenenti da fuori dell’isola.
Tabacco o dischi reggae non fa differenza, specialmente se la comunità di colore è numerosa e pure
alcuni bianchi proprio “british” non sono (Del Naja
ha origini napoletane: così si capiscono meglio gli
Almamegretta, no?). Si va d’accordo o grossomodo, perché stare in provincia spinge a rispondere
creativamente al complesso d’inferiorità verso la
metropoli e pertanto, in tanta multiculturalità, hai
solo l’imbarazzo della scelta. Già l’apertura mentale di unire abrasività e free-jazz, dub e Captain
Beefheart con il mastice della militanza saltava
all’occhio nel Pop Group. Mentre costoro entrano nella storia e poi si dividono in decine di inebrianti rivoli, tra 1980 e l’85 fiorisce un’apprezzata
scena anarco-punk fatta di squat, ristoranti vegetariani/vegani, cooperative e gruppi d’azione politica.
Che sono gli stessi frequentati da chi poi incontri
dove suonano jazz d’ogni schiatta fino a notte fonda, nei locali dove si fanno le ossa Adrian Utley
dei Portishead e dove Roni Size raccoglie la
“viba” felicemente tradotta in chiave jungle. Ancora
non basta, però: bisogna far mente locale al vibrante e seguitissimo scenario reggae che decolla nei
Settanta e fa capo - con regolare corona DJ, gruppi
e soprattutto sound system - in locali come il Blue
Lagoon e il Malcolm X Centre. Movimento tanto
robusto da figliare almeno due formazioni di vaglia
come Black Roots e Talisman, ma più che altro per come getta i semi del fascino in levare tra
le generazioni più giovani, contribuendo con quanto
sopra a creare un gusto che invaderà il mondo (basti annotare che la gavetta Rob Smith - metà di
Smith And Mighty - fu come chitarrista reggae e
Dave McDonald, Portishead “nascosto”, apprenderà parecchi trucchi). Abbiamo parlato di sound
system, l’embrionale nocciolo della questione, un
alveo pulsante di ritmo che Dick Hebdige definisce
così: “Per una comunità circondata da discriminazione,
ostilità, sospetto e incomprensione, il sound-system finì
per rappresentare un prezioso angolo incontaminato.”
Quasi giusto, poiché è proprio nel momento in cui
il sound-system si apre ai visi pallidi che la contaminazione ha inizio e la Storia della musica cambia
per sempre. Mostrano la via i Clash che si avventurano per le vie di Brixton durante il carnevale e
se ne escono qualche anno dopo col caleidoscopico
rearview mirror
119
The wild Bunch
Sandinista!; tuttavia, quando leggi sulle riviste che
Sinead O’Connor si da al toasting nello stesso
contesto, Anno Domini 1991, capisci che qualcosa
sta cambiando. Avete fatto caso alla data, immaginiamo. Bene, ora torniamo a quella vita notturna di
Bristol così animata…
M akin ' H istory
C’è, tra i tanti collettivi musicali, anche uno dal
nome citazionista come The Wild Bunch, ovvero Il Mucchio Selvaggio, celeberrima pellicola western (alzi la mano chi ha pensato alla fissa di Lee
“Scratch” Perry per Sergio Leone…). è il 1983
quando cominciano ad aggregarsi nel sobborgo di
St. Paul e ad attrarre rapidamente folle sempre più
nutrite, scontrandosi amichevolmente coi colleghi
locali e arrivando persino a Londra. La loro abilità e
grandezza sta nella varietà degli sili proposti, caratteristica all’epoca tutt’altro che usuale: conta che la
battuta vada decelerando sempre più e nel frattempo copuli con un’elettronica non invasiva (un’idea
ve la potete fare ascoltando un cd della Strut uscito
nel 2002, The Wild Bunch: Story Of A Sound
System; 7,0/10). Sono un collettivo, inoltre, non
un “gruppo rock”; tutt’al più sono vicini al concetto
di posse mutuato dal rap, salvo evolversi ben presto
in una piccola però tenace unità produttiva di gen120
rearview mirror
te che fa musica anche se non sa suonare - grazie,
punk rock! - nel senso comunemente inteso. Fanno
in tempo a esser messi sotto contratto dalla 4th &
Broadway per un singolo, Friends And Countrymen, sul
quale fa bella mostra di sé la bacharachiana The Look
Of Love ed è l’ennesimo segnale, disossato palpitare
di basso, batteria e voce. Chiamalo, se vuoi, trip-hop.
Al Mucchio partecipano dei bei tipi: il graffitaro
Robert “3 D” Del Naja e i dj Grant “Daddy Gee” Marshall, Andrew “Mushroom”
Vowles, Nellee Hooper e Miles “Milo” Johnson. Se l’ultimo sparisce dopo il rompete le righe e Hooper si affermerà come produttore di notevole ingegno, tocca al terzetto proseguire l’attività
come Massive Attack dall’87. Facendosi precedere sul traguardo dell’LP dai Soul II Soul dello
stesso Nellee, che nell’estate di due anni più tardi
danno alle stampe il capolavoro Club Classics Vol.
One (Ten Records; 8,0/10), dissoluzione in un cocktail gradevolissimo di soul, hip-hop, trip-hop ancora da codificare e morbidezza a prova di carie. Non
durerà, ed è significativo assai che la loro brillantezza si affievolisca progressivamente mentre i Nostri guadagnano il proscenio. Nel frattempo hanno
inoltre preso a maneggaire strumenti veri e propri
integrandoli con l’armamentario “dance”, poggiando le parti vocali anche su alcuni amici di vecchia
data, tra cui Shara Nelson e Tricky. Pubblicano
un nuovo e dolce 12”, Any Love, prodotto da Smith
And Mighty che, chiusura del cerchio, tra ‘88 e ‘89
faranno uscire altre due cover di Bacharach/David
quel lustro buono in anticipo sul suo sdoganamento
critico. Si comincia a mormorare di un pop senza
più confini mentre esce un altro vinile un po’ meno
carbonaro, Daydreaming, frutto del contratto con la
Circa Records. Spetta ancora a una coppia di e.p.
soffiare sul fuoco delle attese e far invocare a grand
voce un 33 giri. Il quale finalmente vede la luce in
piena guerra del golfo, dopo che la formazione deve
scorciare la ragione sociale in Massive.
Un fulmine a cielo sereno, Blue Lines (Circa;
10/10), capace di armonizzare ipotetici contrasti
e conflitti proprio nel mentre il mondo ne iniziava
uno e con esso una nuova era, la nostra. Perché
non si era mai sentita una ritmica ipnotica che arriva a Blade Runner partendo da Billy Cobham (Safe
From Harm); il dub si era sì contaminato con panorami industriali ma mai in modo così filmico, teso
e sognante al contempo (One Love: canta la leggenda giamaicana Horace Andy e sarà così riscoperto). La cura del particolare racchiude l’ingegno
dei Grandi visionari della musica di ogni luogo ed
epoca, e modella la contemporaneità a suon di una
title-track che sulle ali di Isaac Hayes racchiude
tutto il sound morbido austriaco mentre spazza via
rimasugli acid-jazz. La cura del particolare lascia a
bocca aperta, così come le trovate d’arrangiamento e di scrittura, improntate a un’ibridare qualsiasi
cosa capiti a tiro: trasfigurazioni di poco note perle soul (Be Thankful For What You’ve Got) e lo stesso
valga per il reggae (Five Man Army); cantabilità assoluta resa stranita perché archi e ritmica viaggiano a
una velocità diversa (Unfinished Sympathy) o battito
e armonia sono così distanti da fondersi (Daydreaming); disco music ripresa sott’acqua o tra le pieghe
di un sogno drogato; dissonanze industriali in buccia
di struggente pop-soul. Una pietra miliare che nella
busta interna si dice ispirata da P.I.L. e Neville
Brothers, John Lennon e Herbie Hancock.
Filmico e vibrante, prodotto in modo scintillante assieme al recentemente scomparso Jonny Dollar,
è lavoro storico che traccia una via stilistica e attitudinale battuta da decine di successori, Portishead e
Neneh Cherry i più personali fra tutti in quanto
provenienti dallo stesso “humus”.
Devono tuttavia trascorrere tre stagioni - in mezzo la dipartite della Nelson e un remix fantastico per
rearview mirror
121
Nusrat Fateh Ali Khan - per essere rassicurati
da Protection (Circa, 1994; 8,5/10),che orienta il
suono verso una direzione meno vicina ai club. Mossa azzeccata e intento raggiunto con la spazialità degli archi arrangiati da Craig Armstrong, l’omonimo piovoso soul post-moderno con ospite Tracey
Thorn, il ciondolare arabeggiante e paranoico di
Karmacoma con un Tricky pronto a camminare da
solo, una Heat Miser da colona sonora, inquietante
di respiri e oscurità a stento squarciata. A rinsaldare
il legame col predecessore e prescindendo dalla deludente cover di Light My Fire, assapori Spying Glass
(ancora Andy a rimbalzare in catacombe d’echi) e
Better Things (da manuale la linea di basso giamaicana,
idem la Thorn che vi s’arrampica jazzy); apprezzi la
sensuale, melanconica imponenza di Sly e l’impronta Bilie Holiday della cantante Nicolette (che
torna, latineggiando, in Three), il pianoforte classico
ma pure da night club sparso su quello che adesso
chiami trip-hop per Weather Storm. Bellezza e coraggio che significano muoversi da un centro verso
altre direzioni senza smarrire la bussola, consapevoli
dei luoghi da cui si proviene. Un essere sempre diversi e insieme se stessi. Atteggiamento lucido che
spiega l’intuizione di far rileggere l’intero lavoro in
chiave “dubadelica” in No Protection: Massive
Attack Vs. Mad Professor (Gyroscope, 1995;
7,0/10). Un bello sparpagliare di carte per aria, e
ancor di più convincono il lungo tour successivo e
un quadriennio speso a remixare a destra e a manca lasciando sempre il segno, dai Garbage a Madonna. Ne consegue il terzo e difficile disco nella
primavera ’98, seguito di una trionfale apparizione a
Glastonbury dell’estate precedente.
In Mezzanine (Circa;8,5/10) sono citati per la
prima volta degli strumentisti a chitarre, bassi e batteria, mentre il trio nella foto interna è colto in un
torvo bianco e nero che riflette l’umore dell’album.
Cupo e azzeccato, sbianca in conseguenza di quanto
sopra le sonorità attraverso un (post) wave-rock pur
sempre negroide, peculiarmente contemporaneo allorché del trip-hop si spengono gli ultimi fuochi e si
avvia la farsa. Risposta orgogliosa da parte di Artisti
rispettosi di sé e del pubblico, che applaude e può
gioire del confermato Horace Andy nella meraviglia
Man Next Door (di suo pugno; già riletta dalle Slits e
attraversata da un campione di 10.15 Saturday Night
dei Cure, casomai non avessimo capito l’aria che
tira…) e della sorpresa Elizabeth Fraser nella
sognante Teardrop. Annichilisce il crescendo dell’iniziale, melodica però muscolare Angel e resta mirabile
122
rearview mirror
il suo spegnersi circolare; sono contorte le atmosfere di Risingson (qui il “sampling”, appena percettibile, è dei Velvet Underground!) e della tribale
Inertia Creeps. Sparge un po’ di sole Exchange, jazzato omaggio di classe agli amici Portishead, laddove
Dissolved Girl - forte del timbro fanciullesco di Sara
Jay - gioca a nascondere i nervosismi in impennate
hard. Compongono l’eccezionale resto una gommosa Black Milk, i minacciosi punti interrogativi della
title-track e l’escursione dalle tinte acid-soul Group
Four. Materiale perfetto per raccogliere il plauso di
critica e college americani, nonché da portare in
tournee, dopo la quale Mushroom sbatte la porta
per la piega sonica presa. 3 D e Daddy G tirano dritto ma il colpo è incassato duramente dal secondo, in
fuga sabbatica nella tranquillità famigliare.
Robert si affida dunque alle mani di Neil Davidge, già in Mezzanine: bene gliene incoglie solo
a sprazzi, essendo il difetto principale del dignitoso
100th Window (Virgin, 2003; 7,0/10) il mostrare
un uomo solo al comando dove la Grandezza era nella molteplicità del collettivo. E nel progredire, mente
qui per la prima volta si gira in tondo con una certa
freddezza. Non un flop, intendiamoci, tuttavia è lampante che l’ispirazione fosse prigioniera di una mente che tutto non poteva. E che si appoggia alla cura
per l’intarsio, all’inossidabile Horace nella valida Everywhen e in una gassosa Name Taken, convoca Sinead
O'Connor e nondimeno cade su alcune lungaggini. Si
fanno comunque ricordare la traslucida Future Proof
e una What Your Soul Sings che si guarda indietro con
giudizio, l’ondeggiare orientale di Butterfly Caught e il
folk manipolato A Prayer For England.
La colonna sonora di Danny The Dog (EMI,
2004; 6,5/10) non chiariva alcunché, diversivo passato per lo più ignorato e che sarebbe stato più saggio far uscire a nome del solo Del Naja. Dissolvenza.
Quando il senno suggeriva di archiviare la pratica
(Robert dedito ad altri commenti per il cinema),
ecco un nuovo e.p., recante la soffice Splitting The
Atom e la più articolata e persuasiva Pray For Rain
con Tunde Adebimpe di TV On The Radio.
Sarà una delle tante stelle presenti nel disco previsto per l’anno venturo, cosa che racconta la volontà
di riallacciare i contatti con il proprio background
(c’è Martina Topley-Bird in un pezzo) e nel
frattempo riscoprire il senso per la musica senza
limiti (incuriosiscono, Damon Albarn e Hope
Sandoval). Il futuro prossimo? Un’ipotesi che, si
spera, resti fedele a un ideale che ha plasmato la
Storia e ora celebra l’equilibrata mezza età.
rearview mirror
123
Ristampe
Brian Eno/Hans-Joachim Roedelius/
Moebius - After The Heat (Bureau-b,
Ottobre 2009)
G enere : krautrock
After The Heat, datato 1978, nato dalle medesime sedute di Cluster & Eno, è un disco diverso
dal precedente. Bipolare. Anzitutto sparisce la sigla
Cluster per far spazio all’intestazione Moebius e
Roedelius. Eno, pure alla voce solista, rimane intatto.
La forma guadagna spessore. La proto-ambient di
poco prima alterata (e alternata) dal groove. Le movenze si fanno fosche. Si annidano funk torbidi.
Foreign Affairs e Base & Apex, le sinistre Tzima N'arki (con take vocali, in reverse, presi da King’s Lead
Hat di Eno) e Broken Head - anticamera, tra le tante
cose, del Peter Gabriel di Intruder - muovono,
di contro alla passata sortita, verso forme art pop
prossime al Before After And Science che
l’inglese - con cameo di
Moebius e Roedelius rilasciava l’anno prima. È
un dono divino. The Belldog, il climax: sei minuti tra i più belli del ‘900
tutto. Ballad siderale e
visionaria, pregna di spleen cosmico nonché prova
monstre dei Nostri.
Qualche settimana dopo si materializzava Music
For Airports di Eno, ovvero la musica ambient al
debutto. E qui, in After The Heat, se ne ascoltano
124
rearview mirror
incipit (Luftschloss, The Shade, Old Land) e pregustano umori. Le loro strade si divisero di lì a poco: Moebius e Roedelius impegnati con Cluster e progetti
in proprio, e Brian Eno, tra una produzione qua e la
divulgazione della musica per ambienti là, che non
ebbe più un minuto libero. Alla pari di Cluster &
Eno: un gioiello prezioso, l’idillio perfetto
(8/10)
Gianni Avella
Cluster/Brian Eno - Self Titled
(Bureau-b, Ottobre 2009)
G enere : krautrock
Già ristampati nel 2005 dalla Water (in jewel box),
i due dischi che videro Brian Eno e Cluster in join
venture sonica ritornano sul mercato in formato
digipack e correlati dalle note interne – peculiarità
delle reissue Bureau B – di Asmus Tietchens.
Cluster & Eno, l’iniziazione. Anno di grazia, 1977. secondo Tietchens, il primo album ambient mai registrato in terra krauta. Discutibile presa di posizione;
ma se consideriamo il fenomeno come istituzionalizzato poi dall’ex Roxy Music nei seminali Music
For Airposts (cioè mutuato da Satie) e Music
For Films, e non stile Klaus Shulze (Irrlicht, datato 1972, è suonato con Wagner nel cuore), sì, il
disco in esame ha in nuce tanta ambient a venire.
Nello studio di Conny Plank (che produce) anche
Holger Czukay al basso e lo stesso Tietchens ai
synth. L’alchimia produce nove affreschi di muzak
cosmica; laddove Eno, interiorizzata e personalizzata
la poetica di Roedelius e
Moebius (vedi Another
Green World), muove
in simbiosi con il duo
come se si conoscessero
da sempre. Minimalismo
in miniatura (Ho Renomo,
Mit Simaen), meta-spleen
(Steinsame, Fur Luise, Vermut), meta-pop (Die Bunge)
e rilasci orientaleggianti (One) fanno di Cluster
& Eno un gioiello prezioso, l’idillio perfetto. Dalle stesse session verrà fuori un altro lavoro, After
The Heat, e molte cose cambieranno.
(8/10)
Gianni Avella
Damon & Naomi - Sub Pop Years
(20/20/20, Settembre 2009)
G enere : S lowcore -F olk
Dopo l'esperienza Galaxie 500, Damon & Naomi hanno proseguito verso uno slowcore raffinato e nostalgico, diventando un piccolo classico. La
loro musica “eterea” ha ispirato gruppi altrettanto
fondamentali: Mojave 3, Pale Saints, Mazzy
Star, Movietone, fino agli ultimi Beach House. Vicini alla musica dei Low, che sembra la loro
la parte maledetta, Damon & Naomi sono sempre
rimasti fedeli al centellinamento, raggiungendo
un'onesta emozionalità senza effetti speciali né colpi di scena in una discografia esigua, cosa assai rara
di questi tempi. Proprio per questo rigore, ci aspettavamo che i cosiddetti “classici” Sub Pop Years
venissero sottoposti a mastodontica celebrazione
tra sezioni d'archi e nuovi arrangiamenti, proprio
come quel Bonnie Prince Billy sings Greatest
Palace Music!
Ed invece niente di tutto ciò: questa è soltanto una
semplice compilazione di 15 traccie composte tra il
1995 ed il 2002. Dal momento che il gruppo gode
di ottima salute, ed è anche alle prese con un nuovo album, un'introduzione alla loro musica appare
quantomeno discutibile. Negli anni successivi alla
fine del contratto con la Sub Pop, Damon & Naomi collaborano con Bhob Rainey e Greg Kelley (in “The earth is blue”). Per Within these
walls coinvolgono Margaret Wienk (Valerie
Project, Fern Knight) Helena Espvall, Kyle
Brukemann. Pur subendo l'influenza di questi ed
altri ottimi collaboratori, la loro musica non è mai
cambiata di una virgola rispetto a quella degli albori.
E così parlare degli anni della Sub Pop induce ad
errore, perché il titolo sembrerebbe sussumere un
grappolo di anni come si trattasse di un momento
specifico della loro carriera, mentre Damon & Naomi sono sempre rimasti fedeli ad una linea indivisibile e coerente.Tra l'altro proprio di quegli anni di cui
si parla, viene troncato per intero il primo “More
sad hits” (del 1992) ristampato recentemente. Se
questa doveva essere una compilazione, bisognava
attingere soprattutto da lì.
Sarebbe stato meglio ristampare i dischi saccheggiati: Song To The Siren, The Wondrous World
Of Damon & Naomi, Playback Singers e Damon & Naomi with Ghost, piuttosto che passarli al setaccio (attenzione: si trovano tutti in stock tra
distributori e negozi, sebbene esauriti su Sub Pop).
Sub pop years odora semplicemente di denaro.
7 ai materiali, 5 all'operazione che ha il sapore di
sfruttamento.
(6/10)
Salvatore Borrelli
Donnas (The) - Greatest Hits vol.16
(Purple Feather, Ottobre 2009)
Genere: Rock
Brett Anderson, Allison Roberts, Maya Ford, Torry
Castellano: le Donnas. Non sono fashionable. Non
suonano roba d'attualità. Non fanno trend. Sono
pure un po' sfigatelle a dire il vero. Eppure questi
dinosauri in gonnella hanno salvato il punk rock dei
Ramones e ce lo hanno sparato in faccia dritto
dritto. Almeno agli inizi è stato così, quando le quattro ragazzine muovevano i loro primi passi musicali
in quel di Palo Alto (California) e sfornavano proiettili melodici e perforanti quali Let's Go Mano o I
Don't Wanna Go To School.
Kim Fowley e le Runaways? Certamente. Sex
Pistols e Motorhead? Come no! Di tutto hanno masticato queste donnacce, anche se è da tempo
che la macchina bubblegum sembrava essersi inceppata a favore di un hard rock meno coinvolgente.
Ora, dopo l'abbandono della major Atlantic e l'apertura della personale etichetta Purple Feather,
le Donnas decidono di
donarci un Greatest Hits
dove rileggono nuovamente alcuni loro classici (I Don't Want to Go to
School, Get You Alone, Get
Rid of That Girl, You Make
rearview mirror
125
Me Hot, High School Yum Yum) e dove stipano un paio
di b sides al fulmicotone (We Own The Night, She's
Out of Control), per un totale di 16 tracce (incluse le versioni alternative d'obbligo, un remix ed un
inedito di valore: Teenage Rules). Back to the basic.
Questo è rock'n'roll.
(7/10)
Massimo Padalino
Natural Yogurt Band (The) - Away
With Melancholy (Now Again,
Ottobre 2009)
G enere : jazzy - funk
Ristampa di un disco uscito per la Jazzman nel 2008
e presto andato fuori catalogo. Si tratta dell'esordio
di un misterioso duo inglese dedito ad un funk jazzato dal sapore artigianale, dominato dalle tastiere
(organi elettrici e piano), con forti influenze tropicali, latin e perfino un tocco di reggae. Nipotini
di campagna di Marc Moulin, cugini di provincia
di Catto e degli Heliocentrics. Piccola chicca
stra di genere, ma che regala momenti di vera goduria. Solo per cultori.Vinile-cd 1000 copie o digital
download dal sito della Stones Throw.
(7/10)
Gabriele Marino
Q-Tip - Kamaal/The Abstract
(Battery, Settembre 2009)
G enere : lounge - jazz soft - hop
Ancora (vedi il caso Large Professor) un ottimo disco di un classico dell'HH che riemerge da un
passato carbonaro e maltrattato. Ci sono voluti una
petizione dei fan e i soldi dello stesso Q-Tip (e
forse anche un cambio di look in senso "più figo")
per riscattare dagli archivi della Arista e vedere pubblicato questo The Abstract, registrato nel 2001,
programmato per il 2002, rinviato all'infinito causa
ridotto commercial potential.
Pare che nel progetto sia stato coinvolto attivamente J Dilla (non si capisce bene se come semplice
recorder, come tagliatore di selecta o come creatore di suoni), già al lavoro con Tip solista e prima
ancora con la sua Tribe. Il tutto sarebbe un tagliaecuci di jam in studio dei due bboyz affiancati da turnisti jazz di lusso.Vedremo cosa diranno i dillologi. Il
suo tocco si intravede forse in certi intarsi, come i
clap di A Million Times o il gusto wonky-analogico di
Abstractisms.
Restando sul dato fenomenologico della cosa, il disco è molto suonato, lunghe code strumentali, smo126
rearview mirror
oth jazz notturno, tastiere liquide e trombe fumose,
tocchi funky, le parti vocali che latitano il rap fino a
metà scaletta. Un ibrido all'epoca abbastanza sperimentale e per certi versi parallelo, anche cronologicamente, a quello brevettato da Mos Def (peraltro
anche Tip fa film), con risultati, se meno clamorosi di
quelli degli esordi di Def (Black On Both Sides),
meno dispersivi e pasticcioni di quelli delle sue ultime prove (The Ecstatic). Una vera piccola-grande
sorpresa, invecchiata molto bene.
(7.2/10)
Gabriele Marino
Radiohead - Kid A / Amnesiac / Hail
To The Thief (Parlophone, Agosto
2009)
G enere : electro rock
Dopo Pablo Honey, The Bends e Ok Computer, è tempo di Collectors Edition anche per gli ultimi tre album targati Parlophone dei Radiohead. In
effetti, se c'è una vicenda che merita - in pieno terzo millennio - un supporto fisico con tutti i crismi,
è proprio quella della band dell'Oxfordshire, che
un bel giorno del 2000 - il 2 di ottobre - decise di
completare l'outing abbozzato con Ok Computer, addentrandosi in
un territorio elettronico
e progressivo che ripensava in profondità il proprio discorso estetico e
poetico, trainando seco
un bel pezzo del contemporaneo indie rock. Kid A fu una svolta ribadita il 4 giugno dell'anno successivo da Amnesiac,
il gemello dichiarato, registrato quasi in contemporanea al predecessore rispetto al quale sottolineò
l'intenzione e la capacità di far collassare un songwriting tradizionale nel calderone sintetico della
post-modernità.
Di questi due momenti così lontani così vicini da
noi e tra di sé, le bonus track non aggiungono granché. Kid A presenta una sequela di buone performance live, essendo quel disco come è noto privo
di singoli e relative b-sides. Che invece non mancarono ad Amnesiac (Pyramid Song e Knives Out)
ed erano pure buoni, ma appunto ben noti e qui
semmai comodamente raccolti, con l'aggiunta di un
pugno di tracce live di cui la migliore è la stupenda
Like Spinning Plates, che però è quella contenuta in I
Might Be Wrong, e quindi... Comode e succulenti
highlight
Tim Buckley - Live At The Folklore Center (Tompkins Square,
Ottobre 2009)
G enere : songwriting
Colpaccio della benemerita Tompkins Square che con Live At The
Folklore Center rispolvera un documento eccezionale, che testimonia il set acustico suonato in un piccolissimo locale di NY da Tim
Buckley il 6 marzo ’67, con ben 6 inediti. L’atmosfera è raccolta e si
sente, intima (35 persone) e pressoché silenziosa, la tensione palpabile
e va da sé la magia dell’esibizione c’è tutta. Un musicista e la sua dodici
corde.
Siamo nel primo periodo della carriera di Buckley, quando tra il primo
e il secondo album si fa conoscere esibendosi per la maggior parte in piccoli club. Testimonianza
registrata dall’impresario folk Izzy Young e impreziosita da un’intervista del medesimo contenuta
nel booklet, il live è ulteriore prova del sublime e dell’assolutezza che raggiungeva una delle voci
più “aliene” e non ancora estreme allora. Esibizione pressoché perfetta e per niente editata, secondo le testimonianze, se non per rumori di fondo e poco altro.
Cos’altro aggiungere se non che il disco è da avere assolutamente, una delle uscite più preziose
di quest’anno.
(8/10)
Teresa Greco
dunque le nuove edizioni di questi due ottimi lavori
che hanno segnato l'alba degli anni zero, soprattutto
se consideriamo le versioni con DVD che propongono al solito gustose esibizioni televisive (al Top
Of The Pops e a Later… With Jools Holland) più gli
sconcertanti video d'animazione che accompagnarono Amnesiac.
Alla fine ad uscire maggiormente valorizzato
dall'operazione è Hail To The Thief, album
uscito nel giugno del 2003. Solito trattamento, più
o meno. Non parliamo cioè di inediti che gettano
luce, però la compresenza delle b-sides estratte dai
singoli There There e Go To Sleep e dei remixes
contenuti in 2+2=5, rafforzano la sensazione di una
fase di passaggio già parecchio avanzata verso asciutti lidi black (techno frugale strinita soul e funky capace di estatici rapimenti jazz) dissimulata sotto una
iperproduzione che ne normalizzò l'impatto. Che lo
step successivo fosse l'arguta e terrena trepidazione di In Rainbows, con quella fragranza sbrecciata
di suono suonato, appare insomma più naturale di
quanto non sia sembrato in real time.
Visti i prezzi (circa 21 euro, 25 le versioni con DVD)
se vi venisse la voglia di levarvi lo sfizio non sarebbe
così scandaloso. Magari regalando le vecchie copie a
qualche sprovveduto che vi sta parecchio a cuore. (6.9/10)
Stefano Solventi
Sunny Day Real Estate - Diary/Lp2
(Sub Pop, Ottobre 2009)
G enere : emocore
Ragazzi emotivi dal Nordovest. Da Seattle. Nella culla del grunge, la Sub Pop, e fuori nel 1994
mentre l’uomo che aveva permesso a Bruce Pavitt e
Jonathan Poneman di pagare finalmente le bollette
senza fiato sul collo, cioè Kurt Cobain, si toglieva
la vita. Ma non divaghiamo. Fu comunque in quella
stagione che i Sunny Day Real Estate, esordendo
con Diary, sancirono di fatto la nascita dell’emo
core di seconda generazione, passo successivo alle
gesta di Embrace, Rites Of Spring e Fugazi - va da
se' - nonché unica alternativa alla bellezza scultorea
dei Shudder To Think.
Scovati nel Maggio del 1993 da Poneman, invaghitosene dopo un concerto al Crocodile Café di Seattle, l’embrione dei SDRE crebbe prima come trio,
nel 1992, per poi evolversi a quartetto con l’innesto del vocalist Jeremy Enigk. Quindi: Dan Hoerner
(chitarra), William Goldsmith (batteria), Nate Menrearview mirror
127
highlight
Harmonia/Brian Eno - Tracks and Traces (Gronland Records,
Settembre 2009)
G enere : krautrock
Il disco lasciato nei cassetti, dimenticato, l’anello mancante. L’equivoco. Tracks and Traces, il
terzo rilascio degli Harmonia, per l’occasione noti come Harmonia '76. Un lavoro importante perché primo contatto in studio tra Brian Eno, Hans Joachim Roedelius e Dieter Moebius. C’era
anche Michael Rother, naturalmente. Oggetto fantasma, fuori postumo
nel 1997 via Sony - le registrazioni risalgono al 1976 - e rimosso dal
mercato subito dopo poiché pubblicato all’oscuro di Rother. Il perché
di tanta attesa, si dice, sia da ascrivere allo smarrimento dei master e
al conseguente ritrovamento, su per giù una ventina d’anni dopo, da
parte dello stesso Rother e Roedelius. Sul ritiro dal mercato, invece,
grava la questione che una volta rinvenuti i nastri, Roedelius, l’autore
del mastering del ’97, abbia agito senza interpellare i colleghi, che ritrovatisi un Tracks and Traces spersonificato risolsero drasticamente.
Litigi tra innamorati, verrebbe da dire, visto che la musica licenziata dal
combo (e mettiamoci pure Zuckerzeit dei Cluster, prodotto da Rother) nel biennio 1974/75
fu figlia di un rapporto incantato. Unico. Passionale per cui bizzoso. Per Brian Eno, che conobbe
Roedelius e Moebius nel 1975 dopo aver partecipato ad una data dei Cluster al Fabrik di Amburgo, gli Harmonia erano la band più importante del momento, e vedersi partecipe del progetto
fu motivo d’orgoglio e palestra spirituale. Al supergruppo kraut per antonomasia vi si aggiunse,
quindi, l’illuminato dell’art rock anglosassone. Poteva venire fuori qualcosa di scontato? Impossibile. Di indimenticabile? Nemmeno.Troppo Ingombranti gli spauracchi Musik Von Harmonia e
Deluxe, difficile eludere il raffronto. Si coglie l’animo melodico di Rother (Les Demoiselles, delizioso preludio alle sue prove soliste) e dell’Eno che verrà (Luneburg Heath, test generali di Before
After & Science), anche se la presenza di quest’ultimo, specie se vista in prospettiva Cluster &
Eno/After The Heat, è discreta e mai invasiva; la solita verve ipnotica (Vamos Companeros, una
Watussi col freno tirato), liquida (By The Riverside) e dolciastra (Almost).
Classe, insomma, ribadita e immacolata. A rendere più appetibile la ristampa, tre bonus track
inedite. Lavoro didascalico e filologico, d’importanza più storica che musicale. Ovviamente, da
avere.
(7/10)
Gianni Avella
del (basso) più lo stesso Enigk. Dietro al suono di
Diary, Brad Wood (Liz Phair, Smashing Pumpkins),
uomo dal tocco cristallino e ruvido allo stesso tempo, che da spessore alle chitarre e cuore alla voce.
Dentro, una sequela di inni alla nuova sensibilità. La
vena nervosa di Seven e Round, il pathos nelle note
di In Circles e 47 (con chitarra stile Alive dei Pearl
Jam), la psichedelica Grendel, il piano grave di Pheurton Skeurto e la straniante ballad Song About An Angel.
Un susseguirsi di vuoti/pieni puntellati da Jeremy
Enigk, ugola vellutata quanto scabra. Rapisce. Tutto
in Diary rapisce, grafica inclusa.
128
rearview mirror
Nel 1995 è la volta di Lp2, l’altrimenti noto come
Pink Album, lascito postumo di una band prossima
alla dipartita. Oggetto cinto d’aurea mitologica da
fan e storici del genere emo, il secondo SDRE riprende take risalenti alle sessioni di Diary (Rodeo
Jones) ed estratti da un antecedente 7” (8). Lo stile
si è fatto dogma: Friday, Theo B (con un funambolico Goldsmith), Red Elephant e 4 vanno dritte al
punto, cioè al cuore. Di lì a poco, a gruppo sfaldato,
Goldsmith e Mendel risponderanno alla chiamata di
Dave Grohl per i neonati Foo Fighters, mentre
Enigk, nel mentre convertitosi al cristianesimo, si av-
vierà in una breve quanto
sterile parentesi solista.
Si rincontreranno tutti, tranne il bassista, nel
1997, ma non sarà più la
stessa cosa.
Lavori pressoché identici,
Diary e Lp2, la cui unica differenza, forse, sta nel concepimento, laddove
il primo, decisamente più organico, vince di poco
sulla vaga discontinuità del secondo. Nelli presenti ristampe, con note redatte per l’occasione sia
dai membri del gruppo che da gente come Craig
Wedren degli stessi Shudder To Think (tutto torna…), oltre alle bonus track di rito vi troverete la
causa che ha spinto a suonare i vari Mineral, Elliott,
Last Days Of April e l’estetica Deep Elm tutta.
Emozioniamoci, ancora.
(8/10)
Gianni Avella
J Dilla - Dillanthology 3 - Dilla's
productions (Rapster, Ottobre
2009)
G enere : hip - hop
Terzo volume celebrativo della Rapster. è la volta
delle produzioni da solista, a nome Jay Dee o J
Dilla. Tre pezzi da Welcome 2 Detroit e tre da
The Shining, due da tutti gli altri, compresa la ven-
ture con Madlib a nome Jaylib e l'ultimissimo
Jay Stay Paid. è un Dilla meno chirurgicamente
concentrato rispetto alle gemme regalate agli altri,
ma è quello più visionario, istintivo (e cut-upistico),
più intenso e, perché no, sofferto, tutto trasudante
quell'anima soul, ora sopra le righe ora strappalacrime, anche quando fa rap.
Torniamo a dire: non era
meglio un confanetto,
o un dvd coi video dei
singoli (Drop di Spike Jonze, vedi volume
uno), invece del solito livello zero dell'anthology
(internet-era eccetera)?
Come rassegna stilistica
va bene, ma si poteva storicizzare di più, inserendo,
ad esempio, Fuck The Police, la prima solo-release del
nostro, anno 2001. Restano le riserve sull'operazione, ma restano per fortuna anche i pezzi di Dilla,
semplicemente uno più bello dell'altro. Otto ai materiali della trilogia, sette scarso al progetto editoriale, sette pieno ai due volumi precedenti. A questo
un pizzico di più, perché c'è sempre il rischio che il
"grande pubblico" (...) si perda qualcuna di queste
perle incastrata tra le spire di uno di quei dischi che
non sono Donuts.
(7.3/10)
Gabriele Marino
rearview mirror
129
(GI)Ant Steps #31
John Coltrane
A Love Supreme (Impulse!, Febbraio 1965)
Le classifiche dei migliori dischi e le discoteche di
base sono - pur necessarie - semplificazioni storiografiche che rischiano di cristallizzare un artista e
ridurlo ad una sola opera (il disco migliore, il più
rappresentativo, eccetera), falsandone la figura. A
Love Supreme è un'opera talmente potente da
rompere dall'interno questo meccanismo, questo
effetto collaterale della bignamizzazione della musica, riuscendo davvero a sintetizzare in sé le diverse
anime, o meglio l'unico animo dilaniato, del suo artefice.
Dopo il tirocinio con gente come Dizzy Gillespie, Miles Davis e soprattutto Thelonious
Monk, "Trane" entra nel canone jazz a cavallo
tra hard e post-bop, con due opere tanto programmatiche da essere percepite quasi come didattiche,
Giant Steps (1959; e come si chiama questa rubrica?) e My Favourite Things (1960). Trane diventa il riferimento primo per i saxofonisti di tutto il
mondo, scalzando addirittura il fondativo Charlie
Parker.
Tecnicamente perfetto, e per questo eternamente
destinato all'insoddisfazione, di una irrequietezza
che lo porta sempre a cercare di forzare i confini,
ostinato esploratore delle possibilità espressive del
sax tenore (e riscopritore di quello soprano), libero finalmente dalla schiavitù dell'eroina, Trane trova
rifugio in un misticismo panteistico che vede nella
musica il filo diretto con dio, un percorso musicale
che è percorso di vita, un percorso taumaturgico
che trova nella suite in quattro parti A Love Supreme il picco della propria parabola. Un rito sacro
che gli apre le porte per la santificazione fuori dal
mondo jazz e che sarà il preludio a quei veri bagni
130
rearview mirror
di purificazione nel magma del suono che saranno
opere-monstre come Ascension, Meditations
(1965) ed Expression (postumo, 1967), segnate
dal contributo fondamentale dell'allievo Pharoah
Sanders, sempre più calate nell'estetica free e intrise di suggestioni provenienti dalla musica orientale.
In questa messa per quartetto jazz, uno dei picchi
di intensità della storia della musica, viene messa in
scena la continua sofferta dialettica tra tensione e
distensione, dove la tecnica (l'estenuante esplorazione della modalità, della melodia oltre le gabbie
dell'armonia tradizionale) si fa carne, mantenendo
però un'eleganza formale che la rende fruibile anche
da chi non intende coglierne il caldo respiro umano.
Le opere successive porteranno questa ricerca alle
estreme conseguenze, verso una musica che sempre
più rincorre l'astrazione sublimando violentemente
la concretezza della materia sonora. Ma tutto parte
da qui, da quel colpo di gong, da quelle quattro note
di basso, dagli arzigogoli errabondi che ne seguono,
da quel mantra dal fascino sinistro e ipnotico.
Da avere la ristampa del 2002, con il bonus prezioso
dell'unica esecuzione live nota della suite, al festival
di Antibes, e della take del primo movimento con il
sax tenore di Archie Shepp.
Gabriele Marino
classic album rev
Gang Of Four
Entertainment (EMI, Gennaio 1979)
è il crepuscolo degli dei. Quella è la fine degli anni
'70 e quella che si intravede laggiù è l'Inghilterra alla
fine degli anni '70. Siamo a Leeds. C'è un vento che
spazza il sociale e lo fa a suon di musica. Musica
nuova. Una cosa chiamata New Wave. Scioperi interminabili, supermercati come covi di cospiratori
del consumismo di massa, il thatcherismo alle porte,
i sindacati che arrancano. A Leeds, come nel resto
del Regno Unito, queste sono colpe. E le colpe si
espiano. Ecco allora che la lontana Cina offre una
chance di rivoluzione ad un manipolo di studenti
di belle speranze. Loro sono i Gang Of Four, la
Banda dei Quattro (proprio come quella ai tempi di
Mao), e non sono i soli, in quel ritratto tutto angoscia sociale e rivolgimenti studenteschi che scuote
il '77 britannico, a volere di più.
Con loro (anzi: di fianco a loro) ci sono i concittadini Mekons e i Delta 5, per citare solo due
delle band dell'epoca. E Dave Allen (basso), Hugo
Burnham (batteria), Andy Gill (chitarra) e Jon King
(voce) non perdono la loro occasione di far vedere
di che stoffa son fatti; stoffa rude come cartavetrata:
vorrebbero suonare come una versione al vetriolo
di Stevie Wonder, ma ottengono un risultato
ancora più imprevedibile: il number one del funky (il
ritmo circolare su cui si regge la lezione di James
Brown) trasfigurato in una bomba d'anarchia e cinismo puro. Non a caso doti personali proprie del
quartetto (si pensi a Andy Gill e alle sue dichiarazioni senza peli sulla lingua). Non stupisce così che, la
loro prima uscita, il 'classico' e.p. Damaged Goods
(ottobre 1978, Fast Product) esploda inatteso per
le orecchie di molti (anche 'a venire'; ad esempio
Michael Stipe: "I Gang Of Four sì che sapevano come
suonare. Ho rubato molto da loro").
Ma è solo un antipasto, questo in formato minore, la bomba vera è il loro 33 giri d'esordio. Una
manciata di titoli, e Entertainment (EMI, 1979) è leggenda: Ether, Damaged Goods, Return The Gift, I Found
The Essence Rare. Tutte figlie della temibilissima e
paradigmatica - non meno delle altre citate, a livello
di liriche - At Home He's A Tourist, presente sull'e.p.
precedente (con versi come "He fills his head with
culture / He gives himself an ulcer"). Su tutte le canzoni lo spettro del punk aleggia: riverberi dub profondi e metallici, ansie blues a disperdersi, avvitamenti
funky della chitarra, una batteria mobile e stretta nei
suoi loop. Una lezione di sabotaggio di un genere
dall'interno. Meglio di così, all'epoca, sapranno fare
in pochi. E raramente meglio di così seppero fare,
nel seguito di carriera, gli stessi Gang Of Four, eroi
d'oltremanica di un suono bastardo e creativo.
Massimo Padalino
rearview mirror
131
3-D
Il 3-D che stiamo sperimentando non è altro che il punto non d'arrivo di una
vicenda che si è sviluppata insieme alla storia del cinema. Prima parte di uno
speciale dedicato alla bidimensionalità
- Costanza Salvi
132
la sera della prima
“Benvenuti nel mondo della profondità e dell’illusione,
dove le grotte si estendono in una profonda oscurità,
meteoriti sfrecciano dalle pagine (dei fumetti) e star
del cinema possono essere letteralmente abbracciate!”
(Hal Morgan e Dan Symmes, Amazing 3-D, 1982).
Eccolo qui il mondo del futuro: addio bi-dimensionalità, piattezza, figurazione! Benvenuta profondità!
Un mondo a 360º che mi circonda: la realtà! No,
un’illusione! Quanto mi piacerebbe potervi offrire
un paio di occhiali e qualche immagine in arancione
e blu per farvi provare l’ebbrezza del futuro… E
mi piace anche questa specie di corto circuito fra
le due visioni complementari di un cinema totale
(René Barjavel, Cinema Totale, 2001) quella degli anni
50 sul 3-D e quella attuale sul virtuale, rappresentata dai new media ma anche dai sistemi attuali di
cinema tridimensionale. Studiare il 3-D è come fare
uno scavo archeologico alla ricerca di tracce antichissime di UFO o di incursioni aliene avvenute in
un passato talmente arcaico da coincidere col futuro.
Il 3-D che stiamo ora sperimentando non è
nient’altro che il punto (non finale) di una vicenda che si è sviluppata insieme alla storia stessa del
cinema e che ha inizio già nel XIX secolo. L’evoluzione di questa scoperta durante tutto il XX secolo, poi, è passata attraverso albe e tramonti che
corrispondono esattamente ai momenti di declino
e recupero, rispettivamente, del pubblico nelle sale.
Inoltre siamo propensi a pensare al 3-D come una
“cosa insolita“, una specie di novità che cerca di rilanciare una moda degli anni 50, mentre in realtà le
visioni stereo possono vantare una tradizione lunga
e colorita che ci porta addirittura indietro all’antica
Grecia.
Fu Euclide a precisare per primo i principi della
visione binoculare dimostrando che l’occhio destro
e quello sinistro vedono due immagini leggermente
differenti dello stesso oggetto o scena e che è proprio la fusione di queste due immagini a creare la
percezione della profondità. Ma questa profondità
si perde con la lontananza dell’oggetto; gli oggetti
vicini ci appaiono dotati di una specie di rotondità
mentre quelli lontani perdono il loro volume ottico.
La posizione, forma e dimensione degli oggetti più
lontani, infatti, è dedotta da tutta un’altra serie di
informazioni che abbiamo sul reale piuttosto che
realmente appurata da input visivi. La stessa deduzione, a dire il vero, facciamo nel caso del cinema
bi-dimensionale. Nel film in 3-D, invece, l’immagine
stereo viene offerta agli occhi come una doppia immagine separata (mono) che poi verrà corretta dal
cervello attraverso l’uso di un dispositivo, i famosi
occhiali (viewers). Un film in 3-D viene ottenuto attraverso l’uso di due obbiettivi fotografici separati
che immortalano le scene producendo un’immagine
doppia, che appare, senza viewers, sfocata. La distanza fra i due obiettivi è calcolata sulla media della distanza fra le due pupille di un essere umano adulto.
I progressi successivi arrivarono nel 1838, quando Charles Wheatstone inventò lo stereoscopio
riflessivo (o a specchio), un complicato dispositivo
che sfruttava la visione stereoscopica. Il dispositivo
veniva usato per dare profondità a certe vedute ovvero semplici disegni che, con un sistema di specchi,
acquisivano profondità. L’introduzione del dagherrotipo nel 1839 diede un ulteriore impeto alle teorie sulla stereoscopia dal momento che l’obiettivo
principale era quello di ottenere un effetto di realtà
che fosse nello stesso tempo efficace, strabiliante
e fantasmagorico. La fotografia avrebbe rimpiazzato
il disegno nei dispositivi stereoscopici. Nel 1844 in
Scozia David Brewster inventò un dispositivo
più veloce e maneggevole di quello di Wheatstone
perché inseriva un sistema di lenti prismatiche che
permettevano di piazzare le figure direttamente
di fronte al dispositivo invece che all’esterno e di
fianco come nel meccanismo di Wheatstone. Prima
della guerra civile americana in molte case si diffusero questi dispositivi per la visione di fotografie
tridimensionali. Alcune erano prodotte da macchine fotografiche doppie, altre da camere dotate di
due lenti. Nel 1862 Oliver Wendell Holmes
Jr. e Joseph Bates cominciarono a proporre sul
mercato uno stereoscopio abbastanza economico.
In effetti, tutti i bambini, da allora, ne hanno tenuto
in mano una versione successiva almeno una volta
nella loro vita. Durante il decennio del 1870, lo stereoscopio e i suoi box-viewers crebbero moltissimo
in diffusione e in fama. Le vedute tridimensionali
portarono l’intero mondo all’interno delle case. In
particolare si trattava di visioni di luoghi del mondo famosi come le cattedrali europee, la frontiera,
le battaglie della guerra civile. Offrivano tour delle
grandi città, le piramidi dell’antico Egitto e le rovine
della Grecia antica.
Per quanto riguarda il cinema, nonostante una
certa confusione in quanto a date e a nomi, pare
certo che sia stato un inglese, William Friese-Greene, ad aver sviluppato la prima macchina da presa
che riprende immagini stereo destinate alla proiela sera della prima
133
zione. Qualche primo tentativo fu subito destinato
ai peep-show in cui brevi film in stereo potevano
essere visti solo attraverso una sorta di finestrella
da una sola persona per volta. La cosa più sconvolgente, però, è che il primo film ufficialmente in 3-D
mostrato ad un’esibizione pubblica sia stato L’arrivé du train dei fratelli Lumiére. Ovviamente
non si trattava di quello del 1895 ma di una sua
versione stereoscopica del 1903. A parte qualche
altra versione molto breve dei Lumiére nessun altro esperimento in 3-D si verificò nei primi anni,
almeno fino al 1915 quando la Famous Players Film
Company di New York (poi divenuta la Paramount)
girò qualche film di una sola bobina, sempre con
il sistema anaglifico. Cioè un unico film - una
sola striscia - sviluppato con il codice dei due colori per creare l’impressione stereo durante la proiezione. Se l’immagine è proiettata attraverso due
colori come l’arancione e il blu per esempio, il filtro
arancione del viewer permette di vedere solo l’immagine blu e quello blu solo l’immagine arancione
dando l’impressione della tridimensionalità. Questi
minifilm furono proiettati all’Astor Theatre a New
York il 10 giugno di quell’anno. Si trattava di immagini girate nello stato di New York e nel New Jersey grazie ad un dispositivo creato dal pioniere del
cinema e regista di The Great Train Robbery,
Edwin C. Porter e da William E. Waddell. Nessuno
di questi film era stato registrato e sembrano essere scomparsi.
Gli anni 20 sono i più prolifici in assoluto per
quanto riguarda le tecnica della proiezione dell’immagine stereo. Del resto furono anni prolifici per
le tecnologie in generale: nel 1929 apparve il primo
film sonoro. Il cinema è un mondo ancora tutto da
scoprire, è un prodigio della tecnica, quindi rappresenta una sfida sul futuro per i pionieri ma anche
una nuova forma di sfruttamento economico per
l’impresa dello spettacolo. Per lo spettatore, invece,
è soprattutto una specie di fantasmagorica esperienza di “visioni“. Non era importante il soggetto, la
narrazione, la fiction o, anche, l’aspirazione artistica:
il cinema era pura attrazione costruita sulle visioni.
Quello che attirava era il fatto di vivere esperienze
eccitanti e colorate (i primi film, contrariamente a
quanto generalmente si pensa non erano in bianco e nero ma colorati). Il movimento stesso era un
prodigio, una specie di attrazione prodotta dalla cinetica che costringeva allo stupore.
Ogni anno durante quel decennio, qualche spettacolo in 3-D veniva presentato nei maggiori teatri
di New York o Los Angeles: The Power of Love di
Harry K. Fairall che è stato perduto o il programma
Movies of the Future di Willliam Van Doren Kelly presentato al Rivoli Theatre di New York. Questo
show comprendeva due minimovie come Plasticons (che era una dimostrazione sul 3-D stesso) e
New York City, di cui alcune recensioni esaltavano
il potere illusorio di profondità creata dalle riprese
top-shot dalla cima dei grattacieli. Un altro film che
riscosse particolare successo fu Plastigrams (il
nome del processo tecnico inventato da Leventhal
e Ives e che in seguito venne battezzato Stereoscopiks) di Jacob F. Leventhal e Frederick Eugene
Ives che fu proiettato per vari mesi e viene ricordato come il primo film tri-dimensionale sonoro. Uno
dei più attraenti fra questi spettacoli fu Teleview
di Lawrence Hammond e William Cassidy, una sorta
di multimediale programma di presentazione della
nuova tecnica che durava 85 minuti, presentato al
teleview
134
la sera della prima
tru-view
Selwyn Theatre di New York. Una sorta di visore
con un otturatore rotante era montato di fronte ad
ogni poltrona del teatro ed era sincronizzato con il
proiettore. Lo spettatore guardando dentro questo
dispositivo, dotato dei filtri colorati, vedeva prima
con l’occhio destro uno dei due frame dell’immagine stereo poi l’altro con l’occhio sinistro ricevendo
la percezione del volume tri-dimensionale. Il dispositivo era dotato di un otturatore che, sincronizzato
alla stessa velocità del proiettore (24 f per secondo), copriva la vista di ora l’uno ora l’altro occhio.
In sostanza sfruttava la persistenza retinea con un
principio simile al fenakisticopio per eliminare il fastidio degli occhiali da mettere sul naso. Il programma includeva una sorta di stereoscopica danza delle
ombre, immagini fisse, un film documentario sugli indiani Hopi girato in Arizona e un film a soggetto che
raccontava un viaggio su Marte, tutto ovviamente in
3-D. Negli anni 20 addirittura Abel Gance decise
di girare alcune parti del suo epico Napoléon col
formato anaglifico dei due colori ma dovette desistere dall’intento e finì per scartare queste porzioni
di girato. Dopo il boom tecnologico degli anni 20,
in cui sperimentazioni sul 3-D si accompagnarono
a quelle sul sonoro e sul formato della pellicola, la
Grande Depressione si portò via tutto il desiderio
di tridimensionalità.
Gli anni 30 furono un periodo di relativa oscurità. L’interesse generale per le immagini stereo riguardò solo la commercializzazione di cataloghi di
vedute; compagnie come la Keystone View e
la Tru-Vue continuarono a mettere sul mercato
questo tipo di prodotti con viewers che non avevano cambiato di molto l’appeal e le caratteristiche
di quelli dei decenni precedenti. Era necessario un
salto tecnologico che potesse permettere nuovi stimoli. Un fatto alquanto deludente era, per esempio,
l’impossibilità di mantenere l’intera gamma dei colori e la loro fedeltà al soggetto originale. Il formato
anaglifico, infatti, comportava una distorsione dei
colori. Un passo in avanti in questo senso venne dal
laboratorio di Cambridge, in Massachusetts, dove
Edwin H. Land iniziò a sperimentare sulla luce
polarizzata. Land sperava di vendere il materiale
all’industria dell’automobile perché l’utilizzo di questa luce permetteva di ridurre il riverbero durante
la guida notturna. Ma già in altri posti del mondo
si cominciava ad applicare il materiale polarizzato
la sera della prima
135
view master
alla fotografia stereoscopica con la possibilità di
mantenere la fedeltà dei colori. Nel 1936 ci fu una
presentazione pubblica al Waldorf Astoria Hotel di
New York e il potere dei colori di aumentare la sensazione di profondità fu dimostrato con notevole
successo.
Intanto anche in Russia, in Italia (che pare essere
il paese dove avvenne la prima proiezione 3-D parlata: Nozze Vagabonde di Guido Brignone del
1936) e in Germania si diede inizio alla sperimentazione. In Germania, in particolare, un procedimento all’avanguardia e particolarmente efficace era
stato sviluppato da Zeiss-Ikon (Polaroid) chiamato Raumfilm-System che era stato utilizzato anche
136
la sera della prima
per le riprese delle Olimpiadi di Berlino del 1936.
Nel 1939, intanto, fu organizzata la New York
World’s Fair il cui tema era “Building the World
of Tomorrow“. Durante questa fiera le persone potevano sperimentare il Tru-Vue, salire e scendere
dalle strutture, entrare nello sferisterio e osservare
i film panoramici proiettati sulla superficie interna
(una sorta di precursore del cinerama costruito da
Fred Waller). Allo stand della Chrysler ogni giorno
le persone indossavano i loro occhiali a forma di
automobile con i due filtri colorati al posto dei fari
per vedere il loro primo film stereoscopico polarizzato. L’invenzione di Land trovò una delle sue prime
fortunate applicazioni. Si trattava di un film di John
Norling, Motor Rhythm: un documentario di 12
minuti che mostrava la costruzione di una Plymouth
con gli alberi motore che balzavano e sfrecciavano
verso gli spettatori e velocissime Plymouth che si
sporgevano fuori dallo schermo. La proiezione suscitò talmente tanto successo che nuovi corti furono prodotti anche per l’anno successivo sia per la
Chrysler che per la Petroleum Industries. Qualche
anno prima, peraltro, anche la MGM (che allora era
una delle majors più ricche e facoltose) venne coinvolta nel business del 3-D e produsse alcuni Audioscopiks, come vennero definiti cambiando termine
per l’ennesima volta (non avevano soggetto, erano
scene inanellate a caso della durata di otto minuti
circa ed erano qualitativamente abbastanza poveri).
L’ultimo film prima dello stop dovuto alla II guerra
mondiale fu prodotto dal dipartimento-soggetti della MGM guidato da Pete Smith, Third Dimensional Murder, un horror/comedy di 7 minuti e ½
del 1941 che era modellato sui film di Frankenstein.
Molti di questi film vennero poi rieditati negli anni
50 quando Hollywood si lanciò completamente nella terza dimensione.
Durante la fiera del 1939 al pubblico fu data la
possibilità di portarsi a casa un souvenir del 3-D, il
View Master. Si tratta di uno dei più venduti dispositivi di 3-D di tutti gli anni 40 e parte dei 50. Realizzato dalla Sawyer’s, questo dispositivo consentiva
di osservare scene di Bambi, Rin Tin Tin e del west
americano. Venivano venduti vari dischi contenenti
le bobine delle vedute al costo di 0.35 $ ciascuna. Le
prime versioni del dispositivo costavano, invece, 1.50
$. Ora, ovviamente, il valore è di molto aumentato
facendo la fortuna di chi abbia scelto di conservarlo.
Successivamente la varietà dei soggetti delle bobine
si moltiplicarono: Hansel e Gretel, Biancaneve, La
lampada di Aladino, 20.000 leghe sotto i mari, storie
bibliche e vedute realistiche ma dopo un po’ la sola
varietà dei soggetti non poteva essere di grande auspicio per aumentare le vendite.
In realtà in questo periodo (tutto il decennio
dei 40), a parte qualche sporadica sperimentazione
già citata, come per esempio il coinvolgimento della MGM, era molto difficile che qualcuno andasse
al cinema per vedere un film in 3-D. dal punto di
vista del pubblico, l’unica vasta diffusione fu assicurata dalle “vedute” e dalla successiva diffusione degli apparecchi fotografici stereo amatoriali. La fatica
dello spettatore e la necessità del dispositivo, infatti,
continuarono ad essere le “bestie nere” (Cherchi
Usai) del cinema in 3-D. Con l’avvento della tv e il
timore che la sua crescente popolarità portasse via
troppi spettatori e si sostituisse al cinema, il 3-D
ebbe nuovamente qualche chance di entrare nelle
sale. Era, infatti, un buon modo per rendere di nuovo indispensabile la loro frequentazione da parte
del pubblico. Ma, in effetti, il terreno doveva essere
preparato e per fare questo la fotografia amatoriale
in 3-D era un mezzo che poteva risultare davvero
utile.
Negli anni 40 oltre al View Master ci fu la diffusione di altri dispositivi come il Vectograph
della Polaroid. Questo aveva applicazione in ambito
militare: interi manuali di training e immagini di sorveglianza aerea venivano realizzate e usate tramite
questo dispositivo. Le immagini potevano essere distribuite insieme a libri che mostravano, per esempio, come smontare il fucile o il funzionamento di
certi macchinari, il tutto sempre osservato con i soliti occhialini. Per quanto riguarda la fotografia aerea
si trattava di una sorta di precedente del satellite
ovviamente solo per ciò che riguarda la sua utilità:
avere una visione il più possibile fedele dell’aerea
in cui agire. Addirittura i militari poterono contare
su immagini in 3-D della costa della Francia per lo
sbarco degli alleati in Normandia. Si trattava di un
dispositivo che funzionava a luce polarizzata e che
fu utilizzato per tutti gli anni della guerra, poi la Polaroid ripiegò sul più prolifico mercato delle foto
istantanee, sviluppate a partire dal 1947.
Intanto nel novembre del 1945 una pagina della
rivista American Photography annunciava il lancio
del nuovo Stereo Realist realizzato da Seton Rochwhite per la David White Company. La pubblicità
recitava: more natural, more excitingly real than you’ve
never taken! Qualche mese dopo s’insisteva sulle sue
possibilità entusiasmanti: thrill to your own pictures in
breath-taking third dimension, like alice trough the looking glass you’ll step into a vivid new world of vision…
decantando la profondità e i colori estremamente
realistici. I clienti che compravano questa macchina
(al costo di 162.50 $) scattavano la loro fotografia
usando lo Stereo Realist e una normale pellicola Kodak di 35 mm a colori. Questa veniva poi mandata
alla Kodak che la stampava e infine a Milwaukee (alla
David White Company) che la montava sul Viewer.
L’effetto finale era quello di avere foto in 3-D della
propria famiglia osservabili attraverso i visori. Tutti
gli oggetti tipici degli anni 40/50 finirono per essere
immortalati in 3-D. Molti altri fotografi cercarono di
dedicarsi a soggetti più seriosi come fiori ravvicinati,
notturni, fino a spingersi sul soggetto perfetto dei
la sera della prima
137
50, ovvero il nudo (fra cui quelli splendidi dell’attore
e regista del muto Harold Lloyd).
Nel 1950 nacque la prima Hollywood Stereoscopic Society a cui parteciparono lo stesso
Harold Lloyd, Dick Powell, Frank Capra, Walter
Houston, Cecil B. DeMille, Joan Crawford, Irene
Dunne e molti altri che cercavano di promuovere
anche commercialmente la Stereo Realist. Più avanti si aggiunsero Fred Astaire, Bob Hope, Virginia
Mayo, Gregory Peck, fotografati con le loro personali Stereo Realist. Ma l’apice si raggiunse quando
una foto di Dwaight Eisenhower venne stampata su Life. La foto riprendeva il Presidente intento
a scattare istantanee 3-D del suo viaggio a Istanbul
(circa 500 delle sue foto stereo sono ora conservate alla Eisenhower Library ad Abilene in Kansas).
Alla metà del 1952 la febbre del 3-D era alle stelle, così cominciarono i giochi al rialzo, esattamente
nello stesso modo in cui funziona oggi l’evoluzione
della tv digitale o satellitare e la novità del HD. Nacquero nuove trovate destinate a sfruttare al massimo l’interesse: proiettori per visioni di gruppo e
nuove e più sofisticate macchine si affacciarono sul
mercato (fra cui quelle tedesche) che abbassavano
sensibilmente il loro prezzo. Anche le vecchie società che operavano nel settore fin dagli anni 30
ritornarono a lanciarsi nel settore: la Tru-Vue, per
esempio, acquisita dalla Sawyer’s, ebbe la licenza di
produrre visioni dei personaggi della Disney. La View
Master rilanciò la sfida con Bugs Bunny e Chilly Willy e con i personaggi di Gene Autry, Lone Ranger e
Roy Rogers.
Intanto la Bolex Stereo, una stereo-camera
che permetteva di girare piccoli film amatoriali fu
introdotta nel 1952. La pubblicità diceva che presto
si sarebbero visti film in 3-D al cinema ma che fino
ad allora il pubblico avrebbe potuto far divertire i
propri amici con la cinepresa stereo. Infatti proprio
nel 1952 Hollywood rispose alla fame di 3-D che
era nata nelle persone grazie alla semplicità d’uso
delle macchine fotografiche con il famoso Bwana
Devil, che viene ricordato come il primo film del
periodo classico del 3-D. Ma nel 1960 l’amore del
pubblico per la tridimensionalità era già finito e cominciò il mercato della seconda mano.
Man mano che procedo nella storia del 3-D non
posso fare a meno di pensare continuamente alle affermazioni fatte nel 1944 da René Barjavel. Nella
parte intitolata “Il cinema in rilievo“, dopo aver citato i primi esperimenti sul fenakisticopio, dice: “Prima
ancora che il cinema fosse nato, nel mondo intero si
138
la sera della prima
cercava di crearlo in rilievo”; Barjavel immagina che
il volume possa avere la stessa storia, nel cinema,
del sonoro e del colore. Anzi il colore venne usato
all’inizio proprio per dare rilievo e forme alla grigia
bidimensionalità del bianco e nero. E dice ancora
che sempre nuovi scienziati stanno facendo ricerca
dappertutto e che colui che riuscirà, riuscirà per
caso. “Perché si tratta di trovare qualche cosa completamente nuova, e non di partire da invenzioni già esistenti
per perfezionarle ed adattarle“. Non importa, in realtà, che lui abbia o non abbia avuto ragione nelle sue
profezie sul 3-D o che le sue affermazioni possano
risultare semplicistiche e infantili. Contrariamente
a ciò che Barjavel pensava nel ’44 (il cinema non esiste ancora), noi, oggi, siamo costretti a pensare che
il cinema degli anni 40 non solo fosse già nato e
cresciuto ma, anzi, coi suoi capolavori, avesse già
raggiunto l’apice. Il cinema attuale, invece, ci appare come qualcosa d’irrimediabilmente perduto in
tutto ciò che cinema non è: new media, internet,
videogame, tv. Da puristi nostalgici pensiamo non
che il cinema non sia ancora stato inventato ma che
sia più che altro disperso e ibridato, morto. Per cui
ciò che ci dovrebbe affascinare di Barjavel è proprio
il suo entusiasmo di cinefilo che si affaccia sul nuovo, una specie di virale fiducia nel futuro con cui ci
dovremmo ‘contaminare’: l’estro di un’intelligenza che
ha sintetizzato il senso del cinema in un solo innamoramento, in un solo e sublime sguardo prospettico. In una
sola immaginazione (Abruzzese). Del resto, Abruzzese nell’introduzione esalta il potere anche rivoluzionario (cioè anti-istituzionale) di un progetto/
tesi che Barjavel poteva avere dalla sua privilegiata
condizione di moderno, all’oscuro delle evoluzioni
successive delle teorie e delle tecniche.
L’idea di cinema che Barjavel aveva in mente non
era legata solo al potere di escapismo dell’immagine. L’immagine, con il suo potere d’illusione sempre più forte, non doveva solo servire come oppio
del popolo ma doveva consentire una rivoluzione
del senso attraverso la rinnovata percezione di un
mondo ricreato. Non si tratta, quindi, solamente d’illusione ma anche di una sorta di redenzione
(comprensione e liberazione) rappresentata da un
cinema che ancora non aveva iniziato ad esistere
e che sarebbe certamente stato anche “in rilievo“,
appunto. Il problema, in realtà, è che il cinema è ancorato ad una narrazione: una storia, il racconto, il
soggetto, l’interpretazione, l’autore e che noi tendiamo a far coincidere l’idea dell’approfondimento e
della riflessione proprio a queste componenti. Cosa
che ad Abruzzese proprio non va giù e che, secondo lui, eliminerebbe il potere eversivo del cinema
come tecnologia che agisce sul corpo dello spettatore e che ne altera le percezioni, costruendo un
sapere alternativo a quello alfabetico e istituzionale.
La narrazione al cinema, la scrittura, le istituzioni
e il lavoro intellettuale (i valori dell’autore e i valori dell’arte) si sono portati via le forme emotive
e virali, non concettuali e il piacere del corpo che
il cinema aveva all’inizio, all’alba della sua scoperta,
quando ancora si poteva dire: il cinema non è nato.
Cherchi Usai nel suo intervento lo ribadisce: “Il
cinema in 3-D tende a privilegiare la sensazione sulla
riflessione, la componente figurativa su quella psicologica. Un film comico non ha bisogno del 3-D, una sto-
R iferimenti
ria d’amore non sa che farsene, ed è fin troppo facile
pensare ad altri generi che possono volentieri farne a
meno“. La stessa preoccupazione ce l’aveva Barjavel:
passata la prima emozione, con il mondo abituato a
questo nuovo giocattolo, occorrerà diventare seri.
Non è completamente certo di cosa voglia dire
serietà però è all’incirca qualcosa come: realismo,
storia, narrazione, autorialità. La terza dimensione
sembra, quindi, come dice Cherchi Usai, “non ancora necessaria allo spettatore“, nonostante i progressi
tecnologici attuali e il potere illusorio del cinema in
3-D digitale. Non c’è ancora una coscienza collettiva che possa stabilire un vero bisogno al quale il cinema stereoscopico possa rispondere. È un cinema
che non è ancora nato.
bibliografici
Hal Morgan e Dan Symmes, Amazing 3-D, Little Brown, Boston, 1982 è una delle mie due fonti
principali insieme a R. H. Hayes, 3-D Movies: A History and Filmography of Stereoscopic
Cinema, McFarland and Company, Jefferson, 1989.
Cherchi Usai ha scritto un saggio dal titolo “Vederci triplo” in ‘Segnocinema’, n. 158, luglio/agosto
2009. Il testo di René Barjavel si intitola Cinema totale. Saggio sulle forme future del
cinema, Editori Riuniti, Roma, 2001.
la sera della prima
139
L’anno scorso a
Marienbad
Alain Resnais (Francia, 1961)
- Aldo Romanelli
In un fitto bosco, un castello dava rifugio a quanti la notte aveva sorpreso in viaggio:
cavalieri e donne, cortei regali e semplici viandanti.
140
la sera della prima
L
’incipit è quello de Il castello dei destini incrociati,
di Italo Calvino, 1973, ma potrebbe essere altro, potrebbe essere la sinossi di un film. Il film in
questione è L’anno scorso a Marienbad (L’année dernière à Marienbad), 1961, di Alain Resnais.
Nel castello di Marienbad, ricostruito in tre diversi
luoghi della Baviera (Nymphenburg, Amalienburg e
Schleissheim) trovano luogo le vicende di una donna e di due uomini, di molte comparse senza nome
che si muovono come zombies all’interno di spazi
lussuosi e silenziosi. La donna, A, Delphine Seyrig
pare da subito scossa e debole, inspiegabilmente
fragile. L’uomo, X, Giorgio Albertazzi, è mostrato sin
dall’inizio sicuro e forte nel cercare di avvicinarsi ad
A, chiederle di ricordare qualcosa che li legherebbe
profondamente e che la donna non sembra riuscire
a riportare alla mente. Secondo l’uomo, infatti, l’anno prima i due si sarebbero incontrati, conosciuti e
amati in quello stesso posto, a Marienbad. La donna
gli avrebbe chiesto un anno di tempo per capire,
per rendersi conto dell’entità del suo sentimento
e ora, adempiuto l’impegno, X esige il premio della
sua pazienza. A non è sola, è accompagnata da M,
Sacha Pitoeff, che, freddo e distante, pare protettivo
come un padre e geloso come un marito che odora
il tradimento.
Sulle loro vicende ha ruolo preponderante il palazzo: i giardini, il labirinto e le statue; così come i
suoi interni, i saloni e i corridoi. Dice Resnais che
tutto il film può essere immaginato come un documentario su una statua e s’intuisce l’importanza di
questi monumenti perché molte volte la macchina
da presa li inquadrerà, si soffermerà lungamente su
di loro, quasi a chiedere aiuto, a cercare una soluzione al mistero, al peregrinare ostinato dei personaggi
che si muovono silenziosi lungo i corridoi barocchi,
su tappeti che assorbono il suono dei passi e rendono inudibili i rumori, segno di presenza umana.
Da una porta che si apre su un corridoio, si passa
a un salone e poi, di nuovo, a un altro corridoio
che porta allo stesso salone. Il labirinto non è solo
quello nel giardino, passatempo colto per gli abitanti
del palazzo: appare chiaro presto che tutto il film
è un labirinto, che tutto muta in ogni istante, perdendo logica. Ciò che mantiene una lucidità fredda
e implacabile è la volontà di X di portare via con
sé A, la sua risolutezza nel limare le certezze della
protagonista. Logico resta il gioco del Nim, passatempo mostrato da M a tutti gli ospiti che, basiti,
non capiscono.
L’anno scorso a Marienbad vince il Leone
d’Oro alla Mostra di Venezia. è il secondo lungometraggio del regista francese che, dopo alcuni documentari, trova la via per il cinema narrativo con
Hiroshima mon amour (id.), 1959. In una sorta
di trittico incentrato sul tema della memoria e composto dal film del ’59, dal film del ’61 e da Muriel,
il tempo di un ritorno (Muriel ou le temps d’un
retour), 1963, Resnais s’interroga sui meccanismi di
funzionamento del ricordo, sui modi in cui si decide
di salvare o tralasciare un avvenimento e si tende
inevitabilmente a modificarne i particolari nel tempo. Se gli altri due film del trittico lavorano sulla
rielaborazione dell’orrore proveniente dal passato
recente e sugli influssi di questo nel presente dei
protagonisti, L’anno scorso a Marienbad tratta della memoria intesa come mistero ed enigma
irrisolvibile. Diversamente dalle altre due opere, il
regista si cimenta qui con un film assolutamente
non lineare, narrativo ma con tutte le eccezioni che
confermano questa definizione. Attraverso una forma
borderline che passa continuamente dal thriller psicologico all’horror, Resnais cerca di mostrare com’è
fatta la memoria. Non rispettando nessun canone,
prende il via un viaggio onirico grazie ai numerosi
carrelli sui quali è posta la macchina da presa, travelling interrotti e, in seguito, ripresi in un altrove
la sera della prima
141
di Marienbad. Senza nome, i personaggi del film si
muovono come enti che il palazzo attrae a sé, magneticamente e senza via di fuga. Cercherà più volte
di allontanarsene A, ma senza riuscirci. La memoria
è ineludibile e si può sfuggirle solo apparentemente.
è un film difficile, molto: i tempi lunghi e gli ampi
movimenti di macchina si sposano alla perfezione
con gli arredamenti barocchi del palazzo che rendono il flusso d’immagini simile a una litania salmodiante e ipnotica. Questo ritmo è volto a immobilizzare
lo spettatore, a limitarne le capacità di opposizione,
richiedendogli il massimo dell’attenzione. La voce
over di X cerca di ipnotizzare chi guarda, di attrarlo a
sé, sin dai primi istanti del film. Si deve ascoltarla. Un
escamotage può servire come viatico a non soccombere nella difficoltà di visione: non si deve cercare
un senso, non è necessario cercare di capire chi è
chi e dove si trovi la verità, dare un’interpretazione
alle vicende o ai luoghi; ma abbandonarsi, proprio
come si fa con un salmo ridondante, alla sonorità
delle immagini, alle suggestioni create dal montaggio,
alla straordinaria capacità di mimare il ricordo nel
suo scorrere ed espandersi. Quasi fosse una litania
profana d’immagini e parole, il film chiede la totale
fedeltà di chi guarda, la sua completa disposizione
142
la sera della prima
a farsi stimolare i sensi. Questo diventa il film: rappresentazione visiva del ricordare, simulacro della
memoria e della polvere che il tempo lascia cadere
sui fatti, sulle parole e sui luoghi. Pura esperienza
sensoriale.
è stato definito un film inaccessibile, eccessivamente colto, con riferimenti manifesti solo a chi
conosce l’opera di Proust o di Joyce. è stato avvicinato a Otto e mezzo, 1963, di Federico Fellini e forse il confronto non aiuta nessuno dei due
film, opere difficili di due registi che non hanno mai
smesso di perdersi in alcuni sentieri dell’esperire
umano. Il tempo, senza dubbio, non è stato clemente
con Marienbad. Mai adeguatamente divulgato e
affidato esclusivamente a passaggi televisivi notturni, mai prima delle due di notte; non consono alle
velocità degli stacchi di montaggio e dei movimenti
di macchina del cinema e della televisione di oggi,
può apparire lento e ridondante. Quest’apparenza
è scalfita e infranta non appena ci si lascia andare al
suo ritmo, al flusso magmatico delle immagini e si
considerano alcuni fattori storici molto importanti.
Il montaggio di Colpi e Chasney è un punto di
rottura con quanto fatto prima in tutta la storia del
cinema: non si può più parlare di stacchi tra sequenze, né di raccordi o di ellissi perché con difficoltà
si possono riconoscere nel film episodi separati o
indipendenti l’uno dall’altro, momenti vicini o assimilabili.Tutto a Marienbad appare collegato e legato.
Tutto è unito, nello stesso modo in cui la memoria
non pone vincoli al suo fluire ma prosegue ininterrottamente attraverso i sensi. La massa del ricordo si scioglie lievemente in più punti, lascia passare
qualcosa, non fa passare altro. Nessun raccordo,
nessuna figura stilistica è conciliante con quella che
la precede, nessuna regola basilare del fare cinema
è rispettata e questa particolarità avvicina il film alla
temperie storica nella quale è, seppur sui generis, collocato. Siamo negli anni della Nouvelle Vague e
Resnais è parte attiva e particolare di quell’insieme
di cineasti e teorici che hanno reso celebre quegli
anni del cinema francese. Un film senza regole stilistiche alle quali obbedire, un regista che cerca di indagare, con la macchina da presa, l’insondabile della
mente umana e i suoi tempi misteriosi. Quanto di
più impensabile per il “cinema di papà” contro il
quali andavano i “giovani turchi” parigini.
Lo spettatore oggi ha perso la capacità di abbandonarsi al puro potere dell’immagine. Rapito dall’intreccio narrativo e fin troppo saldo nella volontà
di non essere sorpreso alla fine del film, mantiene
castamente una posizione di rigidità nei confronti di
quanto vede. Ne è prova il fatto che i maggiori successi di queste ultime stagioni sono film nei quali le
cose non sono mai ciò che sembrano ma rifrazioni,
deviazioni e aspetti parziali di una realtà più ampia
e scoperta solo alla fine. Ciò che attrae è, oggi, la
possibilità di mettersi alla prova, lo sfidare il film,
cercando di anticipare quanto accadrà o gli esiti che
gli eventi avranno. L’anno scorso a Marienbad
richiede un altro modo di porsi, forse questo sì passato, un altro canone di reazione all’immagine che
potrebbe essere utile conoscere, riconquistare. Il
film di Resnais deve essere libero di dipanarsi nel
sensibile di chi guarda, nel suo lato emozionale e
non nell’ambito razionale e logico. L’esperienza di
Marienbad è da affidare alla pancia, al flusso e al ritmo.
la sera della prima
143
Drag Me To Hell
di S am R aimi (USA, 2009)
Avvocato del Diavolo in rosa. Per la par condicio.
Così come il passaggio da New York a Los Angeles,
dallo studio legale agli uffici di una banca. Del resto
più che a qualche scandalo politico in tempo di crisi
globale, a far scalpore sono mutui, premi d’uscita ai
manager, speculazioni e titoli gonfiati come bicipiti
al metadone. Ma quella è un’altra Hollywood. Quella delle superproduzioni miliardarie.
Drag Me To Hell (Sam Raimi, 2009), presentato fuori concorso nella sezione delle proiezioni di mezzanotte a Cannes, invece è una produzione
low budget della Ghost House Picture di proprietà
del regista. Tutto fatto in casa: il sapore (sanguinolento) della tradizione, il gusto (macabro) di una
volta. Certo non siamo ai livelli di certi splatter che
solo Quentin Tarantino e compagni di merende potrebbero venerare, ma il portafogli dei fratelli Raimi
era indubbiamente meno gonfio rispetto alla saga di
Spiderman. Ed è un bene. Lo zio Sam del terrore
ritorna nella soffitta de La Casa (The Evil Dead,
1981) e riapre qualche vecchio baule. Come le migliori storie si tratta di bauli pieni d’oro. Un vecchio
racconto scritto con il fratello Ivan nel 1989 durante la lavorazione di Darkman, parte della troupe
utilizzata durante le riprese della trilogia de La Casa
– il supervisore agli effetti speciali per il make up
Greg Nicotero e il direttore della fotografia Peter
Deming - , il giusto mix di paura, disgusto e risate, un
titolo altisonante che tradisce ben presto il gigione
autocompiacimento di un vecchio maestro di genere. Non eccellente, ma decisamente ben architettato. Di genere ma allo stesso tempo d’autore.
L’orrore quotidiano di licenziamenti, casse integrazioni, prestiti a tasso variabile viene tradotto in
un horror che torna finalmente ad essere un genere
politico. È qui che si consuma la grande differenza
con il resto della brodaglia horror che infesta sale
e televisioni nei mesi estivi. Ed è anche per questo che l’uscita italiana arriva con un imbarazzante
ritardo sulla programmazione mondiale. Gli stessi
distributori che volevano tradurre il titolo in un più
autarchico Trascinami all’inferno, salvo poi rinsavire, hanno preferito distribuire prima l’immancabile
cianfrusaglia italiana dal titolo anglofono S.Darko
(Chris Fisher, 2009), per ricordarci che «Donnie Darko aveva una sorella». La paura è che i produttori
scoprano anche il resto dell’albero genealogico di
casa Darko per assicurare una lenta eutanasia ad un
cult. Non solo macinato grosso, pajata e bistecche
144
la sera della prima
al sangue. Quello di Raimi è un horror intelligente che cavalca l’onda delle produzioni destinate ad
adolescenti brufolosi cresciuti con i Piccoli Brividi di
R.L. Stine, strizza l’occhio ai seguaci della setta King,
di cui tra l’altro riprende e rielabora al femminile
il villain gitano di Thinner, da qualche buffetto agli
ortodossi del settore. Un horror che nonostante le
evidenti allusioni allo sconcertante attuale non rinuncia al retrogusto drive-in tutto popcorn e pepsi.
Quindi dentiere che volano, spillatrici usate come
arma, bare aperte come ovetti kinder, botte da orbi,
gatti sacrificati, santoni indiani, vecchiette che si dopano per armeggiare blocchi di cemento come se
fossero pezzi di polistirolo. Le streghe sono tornate.
Tremate, ma il clima che si respira in questo morality play di formazione si avvicina più a quello dei racconti dell’orrore di un campo scout che alle favole
dei Grimm, più alla collana Haunt Of Fear che ad
una riduzione del Necronomicon.
Di nuovo c’è ben poco, è tutta roba già vista, già
sentita, ma poco importa. Il pudding di casa Raimi è
più buono degli altri. Abbiamo la maledizione dello
zingaro come nel romanzo di King. Ma in questo
caso il ruolo del villain è affidato ad una decrepita
megera dell’Est Europa, la signora Ganush (Lorna
Raver), entrata a pieno titolo nell’olimpo dei cattivi assieme a Freddy Krueger. Frequentano già lo
stesso estetista (notevoli le unghie lignee) e lo stesso dentista. Non manca lo sprovveduto secchioncello di provincia che gioca a fare il duro come in
L’avvocato del diavolo (Taylor Hackford, 1997),
anche se in gonnella e sotto le candide sembianze
della bionda Alison Lohman. E il campionario prosegue con medium e sensitivi, psicologi razionali che
si prestano ad essere le vittime designate, demoni
cornuti e mazziati.Tutti elementi che erano presenti
nei primi film horror targati Universal negli anni della crisi del ’29. Ma 80 anni dopo il copione si ripete.
Ad essersi invece liberato dalle ragnatele è il regista
che, presa una pausa dalla saga dell’Uomo Ragno,
trova il tempo di ricordare anche alle generazioni
più giovani che i suoi migliori film non sono quelli
dedicati al nerd entomologo.
La trama è semplice, quasi banale. Christine
Browne (Alison Lohman) è una ragazza di provincia
che ha studiato economia sui libri e va nella grande
città per far carriera. Una di quelle province dove la
massima aspirazione è essere la reginetta del maiale, vincere un prosciutto crudo e un panino con la
porchetta insomma. Cresciuta però con le crostate
della nonna e le camicette pastellate della zia teresina la giovane si dimostra subito un pesce rosso in
una vasca di squali. Così, quando una bavosa vecchietta ungherese dalla dentatura di una contadina
colombiana le chiede una proroga sul mutuo della
casa, decide di pensare alla carriera e sacrificare un
evidente investimento a perdere. Del resto nel solo
2009 in America sono fallite più di 18 banche.
Aiutati che il ciel t’aiuta si sarà detta. Peccato
che, se il telefono di Dio è sempre spento o momentaneamente irraggiungibile, il call center infernale è sempre pronto a mandare qualcuno dei suoi
migliori agenti, come Lamia. Il demone se nell’anno
di Woodstock se la faceva con frikkettoni, hippies e
contadini messicani, a Pasadena, e aveva tempo da
sprecare per punire un marmocchio colpevole di
aver rubato una collana ad una zingara, dopo un master in economia della tortura cambia clientela. Nel
2009 è la società bene degli yuppie ad attrarlo. Prima della crisi, ricordiamo, c’è stato il riflusso. Buon
viaggio all’inferno. Paradossalmente con un cappotto nuovo di zecca. Rigorosamente azzurro cielo.
Il Grande sogno
di M ichele P l acido (I talia , 2009)
Michele Placido pesca tra i suoi ricordi per questo film o, meglio, così racconta. Non che non si creda al suo passato da questurino nella Roma del'68,
è un dato storico certo, ma non si vede sincerità
nel suo utilizzo del dato biografico. Nicola, alter-ego
di Placido, vive senza nessun trauma o scisma interiore la sua condizione di doppio in un mondo
in cui era necessario essere definiti e schierati. Allo
stesso modo, alla fine del film, Nicola perde l'amore
di Laura, allontanandosi così dall'epilogo più oscuro
e crudo delle rivolte cominciate nel 1968: la svolta
armata e il terrorismo. La sequenza conclusiva del
film racconta, attraverso didascalie, un paradossale happy end nel quale tutti hanno trovato la loro
strada, in primis Nicola che è diventato un attore,
poi Laura diventata madre e professoressa, i suoi
fratelli e, infine, Libero che vive in Francia dal 1972,
accusato di terrorismo. Proprio nella soluzione del
dramma si evince l'utilizzo del dato biografico a scopi promozionali e di marchio.
Astenendosi da ogni giudizio di tipo politico, da
ogni possibile scelta di campo, Placido non fa altro
che confermare quanto già si sa sul '68 italiano e
sull'analisi di questa data. Questo film è storicamen-
Luca Colnaghi
la sera della prima
145
te inutile e non muove di un millimetro l'opinione
in chi già ha scelto, dicotomicamente, da che parte
stare: tra il credere che quei giorni furono una rivoluzione dalla portata unica e il credere, invece, che
la letteratura al riguardo sia l'unica vera vincitrice
di quegli scontri verbali e fisici. Scegliendo di porre
il suo dato biografico a garanzia di tutto il narrato,
il regista mette insieme dati storici, dati personali
e dati di fantasia senza nessun filtro e presuppone
che chi guarda non veda nel film una mancata occasione per affrontare il tema storico, il più dibattuto
della Storia italiana, ma si accontenti della giovinezza
e della freschezza dei protagonisti, dei loro corpi
fusi in amplessi libertini e ormai molto poco rivoluzionari. Il regista racconta una storia che ha sullo
sfondo la Storia, credendo di poter giocare a nascondino con le implicazioni che Questa ha avuto e
ha sulla vita nazionale. Allontanando il suo epigono
dai fatti, alla fine del film, con la scelta di Laura di
andare con Libero, Placido sembra scusarsi di aver
preso parte a quei giorni, vissuti da poliziotto, e si
lava le mani dalle scelte compiute dai “compagni che
sbagliarono”, dalle P-38 e dalle gambizzazioni.
La promozione del film, già da prima della sua
presentazione alla 66' Mostra di Venezia, è stata incentrata sull'importanza storica dell'opera, sul
valore testimoniale e biografico, sulle prove di tre
brillanti attori italiani. Inutile dire che, di questi, l'unico aspetto effettivamente rinvenibile è quello che
riguarda la prova degli attori. Meritato è il premio
che la Biennale di Venezia ha riservato a Jasmine Trinca, convincente Riccardo Scamarcio
che recupera la sua primigenia dizione pugliese,
accorato Luca Argentero che, disperatamente alla
ricerca di una credibilità cinematografica, interpreta
un rivoluzionario più di nome che di fatto. Dialoghi
insussistenti vengono, però, incarnati da attori che
oltre a essere bravi sono anche molto belli, rendendo, in conclusione, un effetto stridente e di scarsa
credibilità. Se Placido vuole significare che i giovani
del '68 erano tutti belli non ci riesce, se intende dire
che chi era “nel giusto” era bello è tutta un'altra
storia che questo film non sostiene e difende per
una fondativa mancanza di coraggio.
Gli italiani sono pronti a vedere un film in cui,
per dirla con Pier Paolo Pasolini, i veri proletari
sono i poliziotti di Valle Giulia e non i bei rivoluzionari con eskimo e Vespa, ma forse l'industria
culturale mainstream non lo è e continua a
favorire rielaborazioni folcloristiche dei fatti più che
fedeli racconti delle idee che ad essi portarono. Se
146
la sera della prima
di '68 si deve parlare, che lo si faccia in modo coraggioso e sincero, altrimenti si fa inutile e anacronistico andare a dissotterrare eventi e personaggi di un
passato non conciliante né assimilato.
Aldo Romanelli
The Age Of Stupid
di F ranny A rmstrong (USA, 2009)
The Age Of Stupid, diretto dalla regista britannica Franny Armstrong, è il nuovo film-evento
appena uscito – il 22 settembre - nelle sale di oltre 40 paesi. Uno sguardo sul problema climatico
dal futuro, per invitare ad agire oggi. Arriva dopo
una première a New York, organizzata non a caso
in concomitanza con l’avvio degli incontri sul clima
al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite di NY e con
la Climate Week in New York City, una settimana di
azioni a supporto dell’ambiente.
La storia del film inizia nel 2055, anno in cui la
terra è devastata da una serie di catastrofi ambientali, con l’umanità sull’orlo dell’estinzione, ammassata nel nord del pianeta. In una torre al polo nord
l’Archivista, interpretato da Pete Postlethwaite
(I soliti sospetti), è custode di un archivio/arca di
Noè dove animali, opere d’arte e documenti, sono
preservati (per quali posteri, si chiede l’Archivista)
come memoria dell’umanità.
L’espediente narrativo è la ricostruzione operata dall’archivista tramite un sofisticato software di
montaggio – un’astuzia cinefila della regista Armstrong -, che avviene attraverso l’impiego di una
serie di spezzoni di filmati (veri documentari girati
dalla regista), animazioni (esilarante la satira sul consumismo sottolineata da I can’t get Enough dei Depeche Mode) e documenti d’archivio (la doppia
cassa heavy metal sulle immagini della guerra in Iraq
è un pugno nello stomaco). Lo scopo dell’Archivista è documentare l’incuranza di un’umanità stupida
che, sebbene sapesse, non ha fatto nulla per fermare
il disastro climatico. “In ogni epoca abbiamo lasciato
il mondo meglio di come lo avevamo trovato. Si chiama progresso. […] Non questa”, commenta l’Archivista, sottolineando la stupidità di quella che il film
condanna come l’ideologia sovrana, il consumismo.
"Avremmo potuto salvarci, ma non l’abbiamo fatto. Non
è incredibile? Cosa avevamo mentre avevamo l’estinzione davanti e ce ne siamo completamente disinteressati?”.
Franny Armstrong affida la parte documentale
alle voci di sei personaggi, nella parte di se stessi,
da tutto il mondo, che raccontano le sfide e i problemi di oggi. Un giovane imprenditore indiano di
una compagnia di voli low cost superinquinanti, due
orfani iracheni, fuggiaschi da una guerra per il petrolio e riparati ad Amman, l’alpinista ottantaduenne
Fernand Parau, che ha assistito durante la sua vita
al costante scioglimento dei ghiacciai delle Alpi, il
giovane inglese che cerca di costruire impianti eolici con continue opposizioni, la giovane dottoressa nigeriana in una terra insanguinata dalla sete di
risorse energetiche, il tecnico petrolifero di New
Orleans, sopravvissuto al disastro Katrina, una cui
frase da il titolo al film.
Il “docu-film-profezia” è un tentativo disperato
per svegliare le coscienze e riformulare la semantica
della questione del cambiamento climatico. Sembra
volerci dire: sta accadendo adesso, e non rimane altro che agire, fare altrimenti è da stupidi. Questa è
la sensazione che rimane dopo aver visto The Age
Of Stupid, che ha la doppia capacità di preoccupare in maniera salutare e spingere lo spettatore a
prendere una posizione, rimboccarsi le maniche e
darsi da fare. Rapidamente. Grazie al ritmo incalzante, che trova il suo climax nello spasmo del finale,
e a un uso alchemico di flashback, ellissi temporali,
tempi e temi musicali, il film riesce a generare un’urgenza quasi fisica in chi lo guarda, corrispondente a
quella necessaria di agire sulla questione climatica.
Per quello che per noi è una vita – pensiamo al 2050
– per la Terra sono gli ultimi secondi sul baratro,
l’istante prima della caduta.
Indicato da molti critici come uno dei film più
importanti del nostro tempo, The Age Of Stupid ha attirato l’attenzione di personaggi importanti, come Kofi Annan, Gillian Anderson e
Thom Yorke dei Radiohead, tutti presenti il
20 settembre alla première a New York. “L'ho visto
e mi è rimasto impresso” ha dichiarato Yorke – "specialmente nell'ottica del summit che si terrà a dicembre
a Copenhagen e in cui i nostri gloriosi leader decideranno come affrontare i cambiamenti climatici." La band
inglese ha chiuso ieri sera con uno show esclusivo
l’anteprima newyorkese, trasmessa in diretta satellitare da un tendone completamente alimentato da
energia solare. La regista, Franny Armstong, nota al
pubblico per il successo McLibel, il documentario censurato sul maxi-processo contro McDonald
Corp., ha inoltre voluto che la proiezione in cinema
di oltre 40 paesi, incluso il collegamento con l’Arctic
Sunrise, la nave di studi artici di Greenpeace, avvenga
via satellite per abbattere costi economici ed energetici delle proiezione. Una scelta appropriata visto
che l’intero film è stato girato limitando al massimo
le emissioni di Co2, tanto che nei titoli di coda è
possibile sapere in dettaglio le emissioni totali: i 105
membri della crew hanno consumato quello che 8
cittadini britannici o 4 americani consumano in un
solo anno, ovvero le emissioni di 1000 cittadini della
Tanzania.
Mentre scriviamo la proiezione del film in Italia
– distribuito da QMI – è stata confermata al Nuovo
Cinema Aquila di Roma, al Politeama di Frascati, al
Cineplex Porto Antico a Genova, al Cinecity Mantova, al Medusa di Rozzano (MI), al Nuovo di Abbiate Guazzane (Va), al Tiberio di Rimini e all’Ariston di
San Remo. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito ageofstupid.com
Emanuele Bompan
Il cattivo tenente – Ultima
chiamata New Orleans
di W erner H erzog (USA, 2009)
Remake: come indica la sua traduzione letterale dall' inglese è il rifacimento di un film esistente. Il remake può
essere più o meno fedele all'originale: si può cambiare
l'ambientazione, qualche personaggio, si può attualizzare la trama, o cambiarne qualcosa.Tutto ciò, ovviamente,
a seconda delle esigenze diverse da quelle del film origila sera della prima
147
nale. Solitamente maggiore è la distanza temporale tra
le due pellicole, maggiori sono le differenze(...) (Fonte:
Wikipedia)
Il cattivo tenente – Ultima chiamata New
Orleans, (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans,
2009), è l'ultimo film- o forse no, vedremo dopo- di
Werner Herzog. Atteso come uno degli eventi
clou della 66' Mostra del Cinema di Venezia, dove
partecipava alla competizione ufficiale, ha suscitato
un clamore atteso e voluto, una disanima accorata
e partecipata da tutti, o quasi, gli avventori del Lido.
Cinefili e “non” sono a conoscenza dell'esistenza di
un bellissimo film di Abel Ferrara intitolato Il
cattivo tenente (Bad Lieutenant, 1992), con uno
straordinario – forse il migliore - Harvey Keitel nei sofferenti panni di un anonimo tenente della polizia di New York, corrotto, tossicomane ed
erotomane, che si trova a indagare sullo stupro di
una suora. Essi sanno che Abel Ferrara è un regista
unico nel suo genere: travagliato e spesso borderline
nella vita come nella sua arte, in preda alle stesse
frustrazioni che crescono, film dopo film, sempre
alla ricerca di una redenzione a perdizioni estreme
e con un innato senso religioso di fede viscerale
e oscura. Cinefili e un po' meno “non” sanno che
148
la sera della prima
Werner Herzog è uno dei più autarchici e geniali
registi europei viventi e che ogni suo film costituisce un gradino successivo al film precedente nella
ricerca di un linguaggio cinematografico sempre più
funzionale all'affermare i valori principali dell'essere
umano, al definire la nostra civiltà. Il suo film qui
analizzato racconta la storia di un tenente di polizia
corrotto e tossicomane che svolge un'indagine su
un omicidio multiplo a New Orleans.
Qui entra in campo il concetto di fedeltà richiamato dalla definizione precedente: sic stantibus rebus
il film di Herzog è un remake, nel più ampio senso
suggerito da Wikipedia. Si cambia qualche personaggio, qualche elemento della trama e si ottiene
l'esempio più limpido di remake cinematografico.
Una piccola eccezione, però, va fatta se il regista del
secondo film riesce a elevarsi dal primo, dall'“originale” e creare un film che cammini da solo, che non
abbia bisogno di essere riferito al primo, che non
senta nessun legame con esso ma riesca a vivere
autonomo, sufficiente e bellissimo: è il caso del film
di Werner Herzog.
Il tenente Terence McDonagh, Nicholas Cage,
viene promosso dal grado di sergente per essersi
comportato egregiamente durante i terribili momenti dell'uragano Katrina, a New Orleans. Un
trauma alla schiena rimediato durante quegli atti lo
condanna a dolori costanti e all'utilizzo di potenti
analgesici ai quali lui aggiunge la frequentazione di
droghe sempre in maggior quantità. Ha una compagna, Frankie Donnenfeld, Eva Mendes, che fa la
prostituta d'alto bordo e lo ama, seguendolo lungo
il percorso discendente delle sue dipendenze. Tiene
in piedi una famiglia disgregata e stantia con un padre e una matrigna alcolizzati. Ha un caso al quale
pensare: la strage di un'intera famiglia causata dalla lotta per il controllo del mercato della droga. E
poi ha un'ironia innata. Questo è uno degli elementi
principali del film di Herzog: si tratta di una commedia estremamente drammatica. Al di là dell'ossimoro volutamente provocatorio, pare evidente che il
film racconti il declino mentale e fisico di un uomo
al quale le cose improvvisamente vanno male e poi,
altrettanto improvvisamente, si sistemano con una
velocità e una semplicità paradossale e quindi comica. Il suo perdersi nei meandri della dipendenza
e della frequentazione della malavita è raccontato
con una forza e un'unicità quasi naif. In alcune sequenze del film pare di trovarsi in Paura e delirio
a Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas, 1998),
di Terry Gilliam. Lo stato di alienazione che vive
il protagonista è tale da dissociarlo dalla realtà nella
quale vive e da spingerlo, in alcuni frangenti del film,
in una dimensione allucinatoria e demenziale.
Si tratta di due sequenze completamente divergenti dal resto del corpus del film, veri e propri momenti indipendenti. Nel primo caso, durante un'operazione di polizia, all'uscita da un bagno nel quale ha
sniffato cocaina, McDonagh raggiunge i suoi colleghi
pronti a dare inizio alle operazioni e vede, unico a
farlo, due iguane sul tavolo. Alla sua richiesta
su chi siano i proprietari dei due animali, i colleghi
gli rispondono, ovviamente, che non ci sono animali
nella stanza, Improvvisamente una canzone malinconica sale extra-diegeticamente e il primissimo piano
dei due animali sembra mostrarli cantare. Il poliziotto, con aria stralunata, li guarda e sorride beato. La
sequenza ha una durata rilevante e il pubblico in sala
non può fare altro che ridere di gusto.
La seconda sequenza da analizzare è quella dello
scontro tra i responsabili dell'assassinio multiplo sul
quale lavora il tenente e la banda alla quale deve
dei soldi. Girata al ralenti, con la colonna sonora di
un arpeggio country di armonica a bocca, racconta
una sparatoria alla Le iene (Reservoir Dogs, 1992),
di Quentin Tarantino, nella polvere di un chilo di cocaina sparso nell'aria, che riempie di nebbia
chimica la stanza. Tutto si conclude con McDonagh
che, divertito come un bambino, chiede di sparare ancora al capo degli avversari, già morto, perché
vede la sua anima danzare. Il controcampo
mostra un cadavere affiancato da un ballerino di
break dance che, sulle note dell'armonica a bocca,
danza forsennatamente. I sicari eseguono, uccidono
per la seconda volta il nemico e un'iguana si insinua
in primo piano nell'ilarità del protagonista e degli
spettatori in sala. Questi due momenti, a Venezia
accolti con applausi a scena aperta, ricordano per
cifra e lucida follia David Lynch e il suo modo di
operare ben lungi da quello di Herzog.
Su queste sequenze l'analisi deve farsi più precisa. Werner Herzog partecipava a Venezia con due
film, quello qui in analisi e uno a sorpresa, scoperto
nel giorno della presentazione pubblica del film con
Cage e Mendes. Unico nella storia del festival, il regista tedesco ha presentato due opere, entrambe
in concorso, la seconda delle quali è My Son My
Son, What Have Ye Done? (id, 2009), prodotto
da David Lynch e dalla sua Absurda film. Molti degli
attori del film con Cage sono presenti anche in questo, nel quale la partecipazione di Lynch è evidentemente non legata solo all'ambito produttivo ma
anche alla direzione di alcune sequenze e dell'andamento generale del film. Si tratta della ricostruzione
a flashback dei moventi di un matricidio operato da
un aspirante e alienato attore, Mike Shannon che, in
Bad Lieutenent: Port of Call New Orleans, interpreta il
poliziotto corrotto Mundt.
Ecco spiegato il mistero: è evidente che i due registi stanno collaborando e che l'influenza di Lynch,
chiara e inalienabile, marchia gli ultimi lavori di Herzog. Bisogna aspettare il prossimo lavoro di Lynch
per capire se il favore è stato ricambiato. Nel caso
di Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans questo
rapporto allontana ancora di più dal film di Ferrara
che resta un capolavoro di oscurità e perversione.
Ci sono aspetti simili presenti in entrambi i film sul
cattivo tenente ma le distinzioni sono macroscopiche e il gioco delle similitudini si fa presto sterile e
frivolo. Il film di Herzog è qualcos'altro: un remake per alcuni aspetti; il primo frutto di una storica
collaborazione tra geni per altri; un film buono, da
ricordare e con un Nicholas Cage da Coppa Volpi,
per chi scrive.
Aldo Romanelli
la sera della prima
149
i cosiddetti
contemporanei
Musica e Fascismo
"Siamo contro alla cosiddetta musica oggettiva che come tale non rappresenterebbe
che il suono preso a sè, senza l'espressione viva del soffio animatore che lo crea" (dal
manifesto fascista di Toni)
“CARO DUCE…”. I COMPOSITORI
ITALIANI E IL FASCISMO
Il rapporto intercorso tra i musicisti e i regimi totalitari rappresenta uno dei casi più controversi ed
estremi di relazione tra l’arte e le istituzioni. In maniere molto diverse fra loro, tutte le dittature del
XX secolo hanno perseguito lo stesso fine rispetto
alla creatività, assoggettandola all’ideologia. Insita nel
senso stesso delle politiche totalitarie, l’interferenza
dello Stato in tutti i settori della società si manifestò
anche nel campo delle arti.
Seppure in contesti completamente distinti, sia
nell’Unione Sovietica staliniana, sia nei regimi di ispirazione fascista come l’Italia e la Germania, venne
imposto un consenso incondizionato alla cultura
dominante. Ciò determinò la mortificazione di qualsiasi espressione radicale e dissidente, provocando,
negli anni tra il Primo e il Secondo Dopoguerra, una
frattura netta e incolmabile tra il neoclassicismo di
regime e le avanguardie storiche europee.
Il Paese ad aver infierito maggiormente sulle tendenze moderniste è stato senz’altro la Germania
nazista. Le politiche antisemite e razziste sulle quali
poggiava il potere di Hitler, costrinsero all’esilio
tutti gli artisti di origine ebraica, allontanando dalla
cultura tedesca grandi menti musicali del calibro di
Arnold Schoenberg e Kurt Weill. Di fatto,
a parte il servile adulatore Carl Orff, il trasformista Von Karajan (affrettatosi a tesserarsi sia
al partito austriaco che a quello tedesco) e l’ormai
vecchio Richard Strauss, la Germania degli anni
Trenta ha regalato alla storia forse soltanto il genio
150
contemporanei
di Furtwaengler, il cui nome spicca tra i più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi.
In Italia, nel corso del Ventennio fascista, le cose
andarono leggermente meglio. Qualche buon compositore, riconosciuto a livello internazionale, l’Italia
di Mussolini lo ha prodotto, ma quanto ad innovazioni stilistiche non ci si può certo entusiasmare.
Mentre nel resto d’Europa (e, in seguito alla migrazione degli artisti tedeschi, negli Stati Uniti) la musica usciva dalle gabbie ormai arrugginite del Tardo
Romanticismo annunciando a viva voce la morte del
sistema tonale, i musicisti italiani si guardavano indietro.
Scemato il vento innovatore del futurismo,
scomparvero presto dalla scena musicale italiana
due personaggi radicali, i quali, pur avendo aderito
al fascismo, non proseguiranno, durante il Ventennio,
nei loro esperimenti. Luigi Russolo, infatti, lasciò
cadere nel vuoto le sue invenzioni rumoriste (che
pure avevano riscosso l’interesse di Varèse) per
dedicarsi a tempo pieno alla pittura, mentre Francesco Balilla Pratella lasciò più spazio alle sue
ricerche etnomusicologiche che alla composizione
musicale. I due compositori futuristi rappresentano l’ultimo baluardo dell’avanguardia italiana, sparita
quasi del tutto durante tutto il fascismo.
Al tempo della Marcia su Roma, la vita musicale
italiana viveva ancora di ciò che restava del melodramma verista di fine secolo.I punti di riferimento erano ancora Puccini e Mascagni, entrambi
vecchi (nati rispettivamente nel 1958 e nel 1963)
e famosi. Ma mentre il primo, negli anni ’20 dava
l’ennesima dimostrazione della sua viva creatività, scrivendo Turandot, l’autore della Cavalleria Rusticana campava di rendita ormai quasi da
vent’anni.
Diverso è stato anche l’atteggiamento dei due
compositori nei confronti del fascismo. Pur essendo un conservatore affascinato dall’autoritarismo di
Bismarck, Puccini ha soltanto sfiorato la dittatura
del Ventennio (muore nel ’24), mentre Mascagni, subito dopo la presa di potere di Mussolini, dimostrò
una capacità trasformista senza precedenti. Definito
dalla destra un “socialista per stupidità”, il compositore livornese, più che prendere posizioni convinte,
si è sempre rivelato un opportunista, abile a cambiare bandiera ogni qualvolta lo ritenesse necessario.
Tanto che, divenuto uno dei più sfacciati adulatori
del Duce, riuscì ad ottenere posizioni di potere e
importanti riconoscimenti, pur non avendo composto una sola opera degna del suo passato glorioso,
fermo al 1890.
LA “GENERAZIONE DELL’OTTANTA”
Morti o ridotti a inoffensivi cimeli storici, i compositori della generazione precedente all’avvento del
fascismo (Puccini, Mascagni, Cilea e Giordano),
toccò alla nuova generazione, quella dei nati negli
anni ’80 dell’ Ottocento, rappresentare la “grandezza” di un’Italia che si preparava a scomodi paragoni
con l’Impero romano.
I compositori appartenenti alla cosiddetta “generazione dell’Ottanta” sono quelli che incarnano meglio la musica di quegli anni perché più direttamente
sono stati coinvolti nei cambiamenti dell’Italia fascista: “La creazione di uno stile moderno nostro è stato
il problema assillante della mia generazione. Quando
questa generazione cominciò a pensare, l’unica musica
tipicamente italiana era quella operistica ottocentesca e
verista piccolo borghese. Urgeva dunque scuotere a tutti
i costi questa idea angusta e antistorica e ricondurre i
musicisti prima e le masse più tardi a pensare che ben
altre, più profonde, più varie erano le fondamenta della
nostra musica”. Le parole di Alfredo Casella, il
più attivo sostenitore delle idee fasciste, sintetizzano bene lo scopo che si prefiggevano questi musicisti: “sprovincializzare” la musica italiana guardando
alla tradizione dei “classici” come all’unica soluzione
possibile per il superamento del melodramma verista. Tradotto in termini pratici, attingere al glorioso
passato come unica strategia possibile per affrancarsi dalla scomoda tradizione pucciniana.
Mossi da una forte spinta ideologica, questi ten-
alfredo casell a
tativi di dare vita ad un nuovo “rinascimento” fondato sul concetto di classicità, aderirono perfettamente al populismo mussoliniano. Come per artisti
del calibro di Tommaso Marinetti, Gabriele
D’Annunzio e Luigi Pirandello, anche per i
musicisti, l’adesione al fascismo si divise sostanzialmente tra due ragioni fondamentali: la convinzione
nell’ideologia e la necessità di sopravvivere. Ma nella
maggior parte dei casi queste due ragioni comparivano insieme, essendo difficilmente separabili l’una
dall’altra. In un regime totalitario, infatti, la sopravvivenza non può che essere garantita dall’adesione
alle regole e alle idee dettate dal potere.
Al di là del diverso rapporto con le autorità fasciste, tutti i compositori della “generazione
dell’Ottanta” a modo loro hanno cercato di esaltare gli ideali fascisti e la figura di Mussolini, ottenendone le sperate ricompense, tra cui l’ambita nomina
all’Accademia d’Italia. Il neoclassicismo italiano non
è certo paragonabile a quello stravinskiano, che si
proponeva l’arduo compito di tradurre nel linguaggio moderno gli stili di autori classici come Pergolesi (Pulcinella), né a quello elaborato negli stessi
anni da Prokofiev in Russia. Non sarebbe giusto,
in ogni caso, liquidare le opere di Pizzetti, Casella,
Respighi e Malipiero semplicemente bollandocontemporanei
151
le come l’espressione più conservatrice
della musica europea
tra le due Guerre.
Soprattutto
nelle
opere di Alfredo Casella, il più cosmopolita di formazione
(studia a Parigi), il linguaggio modernista
non rimane estraneo
all’operazione di recupero della tradizione, sia classica, sia
folklorica. “Il neoclassicismo e il folklorismo
caselliani […] non
hanno un carattere
nostalgico e oblivioso –come sostiene
Gianfranco Vinay- ma
estroverso, aggressivo,
imperativo: l’immagine
diatonica della classicità è integrata dal
sentimento di una salute e di un’esuberanza vitale impresse da
una luminosità solare
e mediterranea”.
Lo stesso vale per
Ottorino Respighi,
che attinge a piene
mani dal repertorio
sei-settecentesco in
un misto di lessico
moderno e sonorità
arcaiche. Già noto
prima del 1923, Respighi durante il Ventennio non fece altro
che conservare la propria posizione senza compromettersi troppo con il regime, pur accettandone i favori. Era l’unico compositore dell’epoca il cui nome
circolava regolarmente all’estero, a testimonianza di
un forte isolamento della musica italiana fuori dalle
mura domestiche. La sua trilogia di poemi sinfonici
dedicata a Roma (Le Fontane Di Roma (1916), I
Pini Di Roma (1924) e Feste Romane (1929))
sopravvive ancora nei repertori sinfonici delle orchestre europee. Questo successo, misto ad un na152
contemporanei
ildebrando pizzetti
turale accademismo di maniera, gli valse la stima di
Mussolini e la relativa tranquillità in Patria.
VERSO LA “NUOVA MUSICA”
Una partecipazione più attiva non solo alla vita, ma
anche agli ideali dell’Italia fascista, contraddistingue
invece Pizzetti e Malipiero. Rivali accaniti per la successione di Respighi alla direzione di Santa Cecilia
(assegnata poi al primo, più quotato all’epoca), i due
musicisti sono il classico esempio di vita quotidia-
na durante il regime. La loro è una
partecipazione dettata dalle circostanze, contraddittoria e probabilmente neanche troppo convinta.
Eppure, entrambi non misero mai
in discussione la propria adesione
al fascismo, neanche all’epoca delle
leggi razziali. Una fiducia incondizionata non sempre ripagata con
la stessa moneta. La Favola del
Figlio Cambiato (1934) di Malipiero, su testo di Pirandello, fu
bloccata dalla censura per un banale riferimento alle parole “Giustizia e Libertà”, secondo Mussolini un accostamento troppo
diretto al maggiore movimento di
opposizione alla sua dittatura. Una
storia simile a quella della Lady
Macbeth di Shostakovich,
abbattuta dalla scure zdanoviana
perché poco ortodossa.
Mentre il neoclassicismo di Pizzetti scava nel canto gregoriano
e nella vocalità del Cinquecento,
il barocco è il punto di partenza
della musica di Malipiero, il cui
Torneo Notturno (1929) rappresenta l’opera teatrale più nota. In una posizione un po’ defilata rispetto alla “generazione degli
Ottanta” si trova il napoletano Franco Alfano,
ricordato più che per le sue composizioni, per aver
avuto l’onore di terminare l’ultimo atto di Turandot,
lasciato incompiuto alla morte di Puccini.
L’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale, mette in crisi gli ideali del fascismo,
minando i suoi consensi. In campo culturale comincia una transizione che culminerà nella riapertura
degli orizzonti europei. Per la generazione di musicisti nati alle soglie del Novecento, che pure aveva
vissuto la fase di maggiore salute del regime, la fine
dell’autarchia coincide con una sorta di “riapertura
delle frontiere” musicali. Il graduale avvicinamento
alla dodecafonia e ad un linguaggio più astratto di
compositori come Ghedini, Dallapiccola e Petrassi rappresenta una fase di transazione verso
le avanguardie post-belliche, in cui l’abbandono del
neoclassicismo si compie attraverso la dissoluzione
del diatonismo.
Emblematica, in questo senso, la trasformazione stilistica di Goffredo Petrassi nel decennio tra il
ottorino respighi
1940 e il 1950. Se, infatti, il Magnificat (1940) utilizza una scrittura nettamente diatonica, il celebre
Coro dei Morti composto l’anno dopo e tratto
dalle Operette Morali di Leopardi, segna già
la svolta verso un maggior interesse timbrico e una
scrittura tendente alla “corrosione dei legami con
la tradizione” (Vinay), culminati in Noche Oscura
(1950-51).
Dietro l’angolo, però, ci sono già i giovani che
scalpitano. Ragazzi nati in piena epoca fascista, ma
che non ne hanno subito l’influenza, impregnandosi
degli ideali opposti. I vari Maderna, Berio, Nono,
rappresentano l’Italia della “nuova musica”. Un’Italia
ritornata alleata della Germania, ma per tutt’altri
scopi. A Darmstadt non ci si incontra per pianificare
strategie belliche o “soluzioni finali”, ma per provare
a cancellare il passato attraverso la musica, dando
vita a nuovi linguaggi. L’unico rimedio possibile per
superare la tragedia nazifascista sarà, infatti, distruggere per ricostruire.
Daniele Follero
contemporanei
153
www.sentireascoltare.com