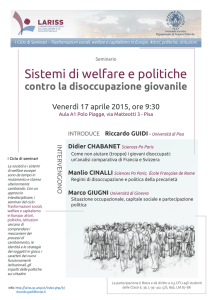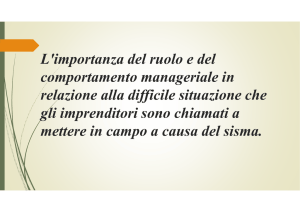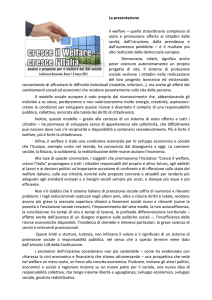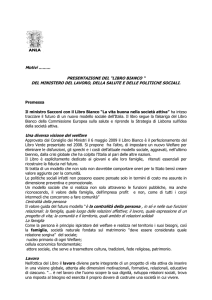Perché il “welfare community”?
Il welfare è sempre sul proscenio che si tratti di “salvarlo” o di applicare ad esso dolorosissimi tagli.
Forse è ancora un po’ presto per parlare di passaggio dal “welfare state” al welfare community”, ma
certamente esistono oggi, anche in questa fase di grave crisi, tutte le premesse necessarie per
avviare questa trasformazione epocale del nostro modello di “welfare”.
Il “welfare community” non fa parte dei “sacri” testi della dottrina ortodossa dei sistemi di welfare.
Anzi se ne discosta sensibilmente, poiché “secondo dottrina” il superamento del “welfare state” si
concretizza nel “welfare society”, che caratterizza la completa autonomia della società civile
“liberata” dal “giogo” o dalla "protezione", a seconda dei punti di vista, delle istituzioni pubbliche.
Altri, per contro, teorizzano un passaggio dal “welfare” al “workfare” una sorta di scorciatoia, per
così dire, che avallerebbe un consolidamento irreversibile della dominanza economica su quella
sociale; con la centralità del “lavoro”, come base della ricerca del benessere, privando di fatto di
ogni cittadinanza sociale i bambini, i giovanissimi, parte delle donne, gli anziani e tutti coloro in
fondo che, per finire, non sono attivamente e direttamente coinvolti nella sfera lavorativa.
Un modello quello del “workfare” che, vale la pena di sottolinearlo, esce di scena da solo nel
momento in cui viene a mancare lo stesso lavoro.
Ma che cosa è il “welfare community” e perché esso si distingue così sensibilmente dal “welfare
society” ed ancora, come mai nessuno parla di “welfare society”, un modello che pure calza così
bene a quella delle due ideologie in confronto che si vuole drasticamente liberale?
Il concetto di “welfare community” è nato nei laboratori del lavoro sociale della Fondazione Labos
sin dalla sua istituzione, nell’anno 1985, quando si affermava il concetto di esclusione sociale dietro
la spinta dell’emergenza dei nuovi bisogni relazionali e della caduta del legame comunitario.
I bisogni relazionali, che hanno come oggetto la ricerca di un rapporto umano significativo e di un
legame affettivo, esplodono già in quegli anni e rivelano tutta la loro "incompressibilità", nella
misura in cui si logorano i rapporti interpersonali all'interno della stessa famiglia, della società
civile e tra società civile e gruppi marginali.
Sono il disagio giovanile, l'abbandono dei minori, la solitudine degli anziani, la fragilità della
famiglia e delle giovani coppie, le aree di maggior concentrazione dei bisogni relazionali; ma
soprattutto i gruppi marginali, tradizionalmente depositari dei principali interventi di welfare,
acquistano in questa stagione maggiore complessità.
L'esigenza di ricostituire un significativo legame comunitario, spesso anche affettivo, si rivela, per i
portatori di handicap, per i senza tetto, per gli anziani non-autosufficienti, per i tossicodipendenti,
per gli immigrati e le altre fasce deboli, il bisogno sociale più impellente, anche più importante
spesso degli stessi bisogni materiali.
Già alla metà degli anni ottanta il vecchio concetto di povertà appariva statico, eccessivamente
fatalistico, del tutto ancorato ad un contenuto materiale dei bisogni e quindi non sufficientemente in
grado di interpretare la nuova fenomenologia delle situazioni di marginalità sociale.
Il nuovo concetto di esclusione sociale, per contro, prevalentemente legato alla qualità relazionale
dei nuovi bisogni sociali, si rivelava molto più dinamico e quindi fortemente operativo, con dei
contenuti immateriali oltre che materiali, niente affatto fatalistici, tali, cioè, da chiamare in causa
pesantemente istituzioni e società civile.
Non che le due definizioni di “povertà” ed “esclusione sociale” siano necessariamente alternative
tra loro, anzi possiamo dire che l’una rappresenta una condizione e l’altra il processo che porta a
quella condizione; ma è certo però che, ai fini della definizione di una strategia di intervento, il
concetto di esclusione sociale appare molto più proficuo ed addirittura rivoluzionario.
Se c’è infatti “esclusione sociale” vuol dire che esiste un “soggetto” che esclude e questa semplice
evidenza cambia drasticamente il volto del “welfare”, che non può più essere unicamente
concentrato nelle istituzioni, con un carattere “riparatorio” o di “tamponamento”; ma che deve,
invece, coinvolgere in prima persona la società civile, non solo in quanto "principale" responsabile
dell’esclusione sociale; ma soprattutto perché unico soggetto in grado di favorire e rendere possibile
l’inclusione e la reintegrazione sociale delle persone gravemente afflitte da bisogni di tipo
relazionale.
L’esclusione sociale, vissuta in termini di “non partecipazione” ai processi più significativi dello
sviluppo e quindi di “perdita” del valore di investimento delle proprie risorse umane, sembra inoltre
intrecciarsi con i ritmi esistenziali; al punto che, in una società, priva dei legami relazionali ed
affettivi essenziali, ognuno di noi rischia di doversi confrontare, nell’arco individuale della propria
esistenza, con situazioni di profondo disagio ed impotenza.
Tutti noi, cioè, saremo successivamente e nella maniera “più normale” immaginabile: minori,
giovani e giovani coppie, donne ed anziani, ma il rapporto di queste aree esistenziali con il nucleo
centrale dello sviluppo del nostro sistema sociale non sembra oggi sufficientemente armonico.
Esiste cioè di fatto all’interno della nostra società una spaccatura solo apparente tra “centro” e
“margini”; tra società “normale” e “gruppi marginali”; dove ,cioè, le situazioni di “marginalità”
non altro sono se non delle condizioni di “normalità”, particolarmente drammatizzate e lacerate a
causa di una forte esasperazione dei bisogni, del venir meno pesante della solidarietà parentale e di
vicinato, di una scarsa qualità o sensibilità istituzionale.
Esseri minori, adolescenti, giovani coppie, anziani a rischio di abbandono o esclusione sociale non è
poi così casuale.
Come dire, che il “centro” produce i suoi “margini:
-o trattando come “diversi” alcuni gruppi sociali, come i migranti, i tossicodipendenti, i
fragili di mente, i senza tetto, etc.;
-oppure semplicemente ignorando volutamente che alcune condizioni di “marginalità” sono
la semplice estensione delle condizioni di “normalità” di tutta la popolazione.
Vi è dunque una continuità tra “centro” e “margini” eppure l’identità principale di queste diverse
aree di marginalità sembra essere indifferente per un sistema di sviluppo sociale tutto centrato sulla
produzione economica ed il primato indiscusso dell’“economico” sul “sociale”.
Non è difficile, a questo punto, immaginare le difficoltà per un modello di welfare come quello
dello "stato sociale", tutto concentrato sui bisogni materiali ed intorno alle istituzioni, nel far fronte
a bisogni sociali chiaramente di tipo immateriale, la cui prevalenza si colloca dentro la società civile
e le cui origini hanno a che vedere soprattutto con il venir meno del legame comunitario e quindi
con la fragilità della stessa società civile.
Non è difficile vedere le difficoltà di uno “stato sociale”, abituato a misurare quantitativamente i
bisogni e distribuire “prestazioni” dover confrontarsi con bisogni qualitativi non misurabili e che
richiedono solo “processi esistenziali”.
D’altra parte una lacerazione così profonda di un tessuto sociale privo dei più elementari principi di
coesione sociale e di appartenenza comunitaria, rende fortemente improbabile, se non altamente
rischiosa, una transazione automatica e naturale verso un “welfare society”, capace di produrre
autonomamente e senza l’ausilio delle istituzioni il benessere di tutta la collettività.
E' quindi necessario un passaggio intermedio, una transazione più morbida, una sorta di
"correzione" dei "lavori in corso" verso nuovi approdi dei sistemi di welfare.
Ed è in questo contesto che si colloca il lavoro di ricerca della Fondazione Labos sin dalla sua
istituzione.
Il Labos inizia così a scavare le proprie radici nell’esigenza profonda di restituire alla società civile,
che aveva perso le sue connotazioni più profonde ed appariva oggettivamente abbastanza “incivile”,
una natura comunitaria fondata sui principi della solidarietà, della giustizia sociale e della
valorizzazione delle risorse umane di tutte le sue componenti
Il "welfare community", d'altra parte, non si colloca in termini di alternativa bensì di continuità
rispetto al "welfare state".
La lunga stagione del “welfare state”, con le sue funzioni di sicurezza e garanzia, ha di fatto
“concepito” persone, gruppi sociali e generazioni ricche di aspirazioni e di potenzialità orientate
verso una “nuova stagione” di protagonismo e di impegno attivo.
Il “welfare state”ha dunque nelle sue “corde” la vocazione del “welfare community”.
E’ difficile pensare, infatti, che i minori, i giovani, gli anziani e le giovani coppie non aspirino oggi
ad un forte legame comunitario ed è difficile non vedere la loro drammatica sofferenza legata ad
una vita “vuota di comunità” ad un "benessere senza comunità", all’impossibilità, cioè, di dare il
“meglio di sé stessi” nella vita sociale attraverso una valorizzazione delle proprie responsabilità e
risorse in quanto cittadini.
D'altra parte, anche i gruppi marginali, tradizionali depositari dell'intervento prevalente dello "stato
sociale", oggi non possono trovare risposte sufficienti alle loro esigenze esistenziali nel "chiuso"
delle istituzioni, ma aspirano a ricostituire quell'"incompressibile" legame relazionale ed affettivo
che è alla base della comunità.
E’ proprio il “welfare state”, e la sua fondamentale funzione di garanzia e di protezione ad essere,
quindi, all’origine della forte spinta che registriamo oggi verso la crescita delle aspirazioni
comunitarie della società civile.
Non si tratta quindi di sbarazzarci dello "stato sociale", quanto piuttosto di dare ad esso un senso
più compiuto sviluppando la vocazione autonoma ormai radicata della società civile verso una
maggiore responsabilizzazione e protagonismo.
Tocca allora alle stesse istituzioni dello "stato sociale", che hanno portato in grembo queste nuove
risorse e potenzialità, assolvere oggi ad una delicata funzione di “maternage” garantendo un
supporto determinante alla società civile; aiutandola cioè a ritrovare e realizzare la propria natura
più profonda, quella essenza di comunità che permetta a tutti i suoi componenti, a partire dai più
deboli, di realizzare una partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale.
Queste sono le “istituzioni maternage” ed esse rappresentano il primo passo che dobbiamo
compiere se vogliamo realizzare un “welfare community” che si avvalga concretamente delle
risorse di tutti i cittadini, trasformando questi cittadini in “costruttori di welfare”.
Claudio Calvaruso