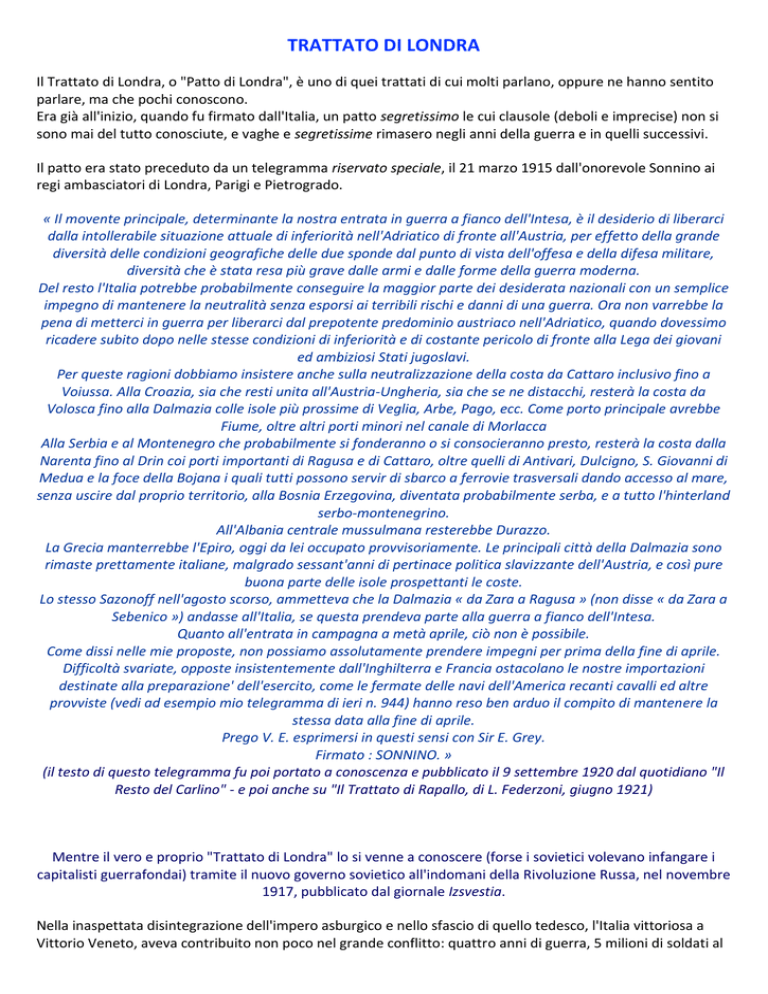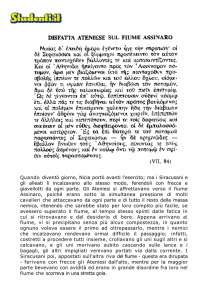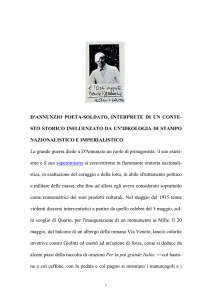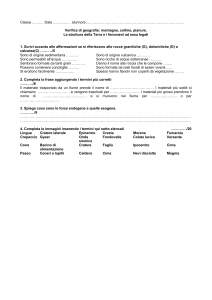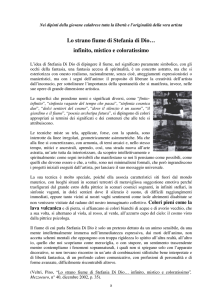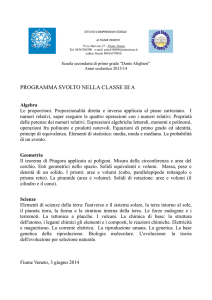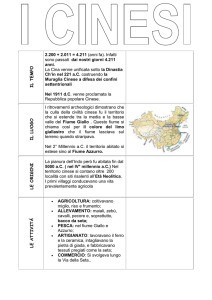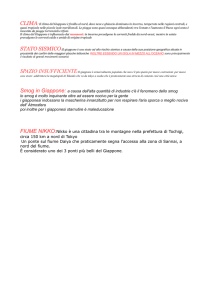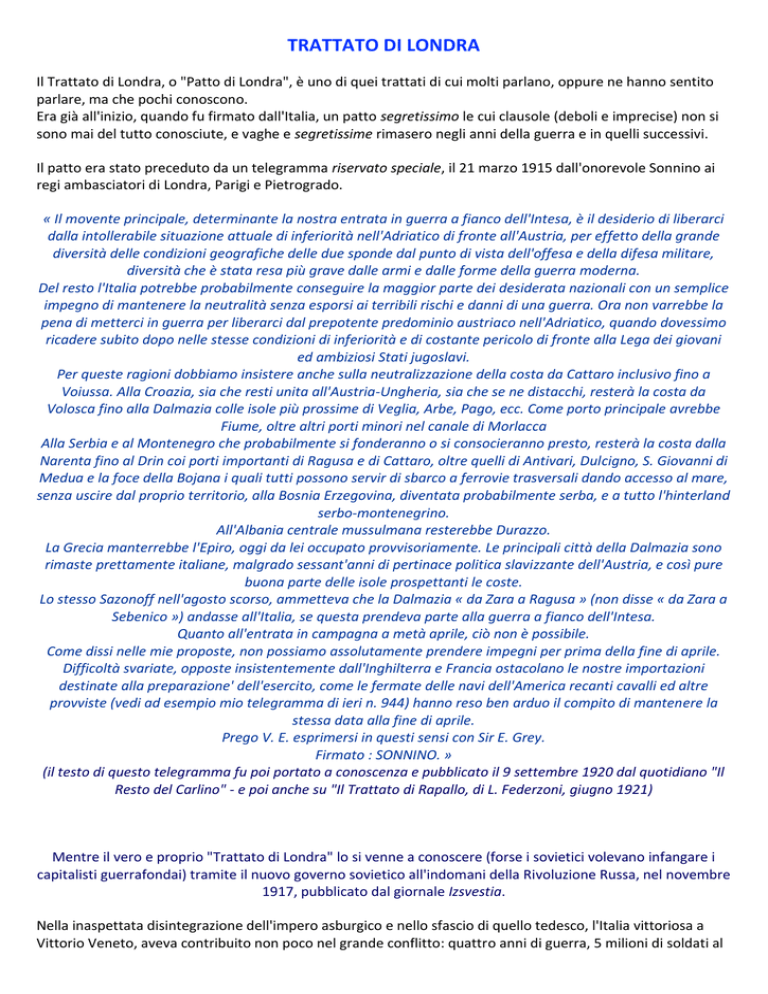
TRATTATO DI LONDRA
Il Trattato di Londra, o "Patto di Londra", è uno di quei trattati di cui molti parlano, oppure ne hanno sentito
parlare, ma che pochi conoscono.
Era già all'inizio, quando fu firmato dall'Italia, un patto segretissimo le cui clausole (deboli e imprecise) non si
sono mai del tutto conosciute, e vaghe e segretissime rimasero negli anni della guerra e in quelli successivi.
Il patto era stato preceduto da un telegramma riservato speciale, il 21 marzo 1915 dall'onorevole Sonnino ai
regi ambasciatori di Londra, Parigi e Pietrogrado.
« Il movente principale, determinante la nostra entrata in guerra a fianco dell'Intesa, è il desiderio di liberarci
dalla intollerabile situazione attuale di inferiorità nell'Adriatico di fronte all'Austria, per effetto della grande
diversità delle condizioni geografiche delle due sponde dal punto di vista dell'offesa e della difesa militare,
diversità che è stata resa più grave dalle armi e dalle forme della guerra moderna.
Del resto l'Italia potrebbe probabilmente conseguire la maggior parte dei desiderata nazionali con un semplice
impegno di mantenere la neutralità senza esporsi ai terribili rischi e danni di una guerra. Ora non varrebbe la
pena di metterci in guerra per liberarci dal prepotente predominio austriaco nell'Adriatico, quando dovessimo
ricadere subito dopo nelle stesse condizioni di inferiorità e di costante pericolo di fronte alla Lega dei giovani
ed ambiziosi Stati jugoslavi.
Per queste ragioni dobbiamo insistere anche sulla neutralizzazione della costa da Cattaro inclusivo fino a
Voiussa. Alla Croazia, sia che resti unita all'Austria-Ungheria, sia che se ne distacchi, resterà la costa da
Volosca fino alla Dalmazia colle isole più prossime di Veglia, Arbe, Pago, ecc. Come porto principale avrebbe
Fiume, oltre altri porti minori nel canale di Morlacca
Alla Serbia e al Montenegro che probabilmente si fonderanno o si consocieranno presto, resterà la costa dalla
Narenta fino al Drin coi porti importanti di Ragusa e di Cattaro, oltre quelli di Antivari, Dulcigno, S. Giovanni di
Medua e la foce della Bojana i quali tutti possono servir di sbarco a ferrovie trasversali dando accesso al mare,
senza uscire dal proprio territorio, alla Bosnia Erzegovina, diventata probabilmente serba, e a tutto l'hinterland
serbo-montenegrino.
All'Albania centrale mussulmana resterebbe Durazzo.
La Grecia manterrebbe l'Epiro, oggi da lei occupato provvisoriamente. Le principali città della Dalmazia sono
rimaste prettamente italiane, malgrado sessant'anni di pertinace politica slavizzante dell'Austria, e così pure
buona parte delle isole prospettanti le coste.
Lo stesso Sazonoff nell'agosto scorso, ammetteva che la Dalmazia « da Zara a Ragusa » (non disse « da Zara a
Sebenico ») andasse all'Italia, se questa prendeva parte alla guerra a fianco dell'Intesa.
Quanto all'entrata in campagna a metà aprile, ciò non è possibile.
Come dissi nelle mie proposte, non possiamo assolutamente prendere impegni per prima della fine di aprile.
Difficoltà svariate, opposte insistentemente dall'Inghilterra e Francia ostacolano le nostre importazioni
destinate alla preparazione' dell'esercito, come le fermate delle navi dell'America recanti cavalli ed altre
provviste (vedi ad esempio mio telegramma di ieri n. 944) hanno reso ben arduo il compito di mantenere la
stessa data alla fine di aprile.
Prego V. E. esprimersi in questi sensi con Sir E. Grey.
Firmato : SONNINO. »
(il testo di questo telegramma fu poi portato a conoscenza e pubblicato il 9 settembre 1920 dal quotidiano "Il
Resto del Carlino" - e poi anche su "Il Trattato di Rapallo, di L. Federzoni, giugno 1921)
Mentre il vero e proprio "Trattato di Londra" lo si venne a conoscere (forse i sovietici volevano infangare i
capitalisti guerrafondai) tramite il nuovo governo sovietico all'indomani della Rivoluzione Russa, nel novembre
1917, pubblicato dal giornale Izsvestia.
Nella inaspettata disintegrazione dell'impero asburgico e nello sfascio di quello tedesco, l'Italia vittoriosa a
Vittorio Veneto, aveva contribuito non poco nel grande conflitto: quattro anni di guerra, 5 milioni di soldati al
fronte, 600.000 morti, 900.000 mutilati, oltre i grandi danni economici e sociali.
Fu tuttavia quella italiana - anche se tardiva - una determinante partecipazione che oltre che procurare la
decisiva disfatta austriaca, accellerò quella tedesca. Una Germania che da qualche tempo le tre grandi
potenze europee temevano come una forte concorrente, economica, imperialista, colonialista. E se da una
parte, l'Impero Austro-Ungarico e la Germania per scatenare la guerra colsero l'occasione dal delitto di
Sarajevo, le altre tre potenze fin dal 1913 avevano elaborato un progetto di distruzione e smembramento
della potenza tedesca con la sua brama di dominio militare, politico ed economico. C'era la volontà nei tre di
raggiungere con la guerra loro fini particolari, specialmente nel campo territoriale, fini che prescindevano dal
diritto di autodecisione, dal rispetto delle nazionalità e dalla perfetta eguaglianza delle nazioni e si
proponevano il maggior danno possibile per il nemico. Si distinguevano in questo specialmente la Francia e la
Russia, sia per quello che richiedevano a proprio favore, sia per quello che volevano dare (poco) ai loro minori
alleati. E fra questi minori l'Italia che entrando in guerra era convinta che avrebbe ricevuto "parecchio" e non
"poco". Invece a Versailles anche con la vittoria determinante dell'Italia che pose fine al conflitto, la sofferta
vittoria valse poco, perchè le spartizioni da tempo erano state già fatte (fin dal 1913 !! )
( a questo diabolico progetto dedichiamo pagine a parte )
Eppure alcuni storici ritengono che l'intervento dell'Italia - pur in ritardo- fu determinante anche per la
Rivoluzione d'Ottobre, seguita poi dalla defezione della Russia dalla quadruplice intesa. Se l'Italia nei quasi tre
anni precedenti non avesse impegnato gli austro-ungarici nelle tre Venezie, tenendoli inchiodati sulle Alpi, i
Corpi d'Armata degli Imperi centrali, massicciamente utilizzati a est avrebbero provocato all'Armata zarista
russa un immane disastro, essa sarebbe stata schiacciata dai micidiali colpi dell'artiglieria tedesca e avrebbe
ripiegato in una precipitosa disfatta dalla quale la Russia non si sarebbe mai più riavuta.
Proprio per la defezione russa, disimpegnate le armate austro-tedesche a est, solo all'esercito italiano toccò di
sostenere l'urto offensivo impegnando sul Piave il nemico, impedendo così agli austro-ungarici di andare a
rafforzare le offensive di Ludendorff. Insomma l'Italia a Parigi (trattata come Cenerentola) avrebbe potuto
ricordare che fu la sua vittoria a Vittorio Veneto a decidere di parecchi mesi in anticipo la vittoria alleata.
E l'inizio della guerra? La stessa dichiarazione di neutralità dell'Italia (così tanto criticata da Inghilterra e
Francia ) diede proprio alla Francia la immediata e piena disponibilità, di tutte le sue truppe che erano state, o
avrebbero dovuto essere, dislocate nella frontiera italo-francese (quando la decisione dell'Italia di
abbandonare la Triplice Alleanza dopo Sarajevo, non era stata ancora presa). Il generale Meraviglia in
proposito scrisse: "Fu un inestimabile aiuto materiale e morale; che la Francia doveva il mese dopo, mettere in
valore sul campo della battaglia decisiva che impegnava sulla Marna, per salvare se stessa e, nello stesso
tempo, la causa dell'intesa".
Confermato poi anche da alcuni capi francesi. Infatti, Salandra scrisse (nel suo libro "La neutralità italiana" pag
186) che il 30 marzo 1919 stando a fianco del maresciallo Joffre, l'illustre condottiero ebbe a dirgli a proposito
del'Italia "…che la dichiarazione della neutralità italiana, reputata, come era, perfettamente sincera, gli era
valsa per quella campagna (Battaglia della Marna) la disponibilità di dieci divisioni destinate a presidiare il
confine italiano" (un settimo di tutte le forze francesi).
Ancora più chiaro sul "Figaro" di Parigi del 24 maggio 1927 BARRERE, ambasciatore francese a Roma all'epoca
dei fatidici giorni. "Mi luccicavano gli occhi quando ufficialmente appresi ufficialmente da Salandra la
neutralità dell'Italia (1-2 agosto 1914). Il mio Paese (la Francia) aveva schierato alla frontiera italiana più di
350.000 uomini. Con l'annuncio di Salandra, era evidente che l'azione italiana non poteva essere diretta contro
la Francia, perché tutta l'artiglieria pesante era stata mandata (nel corso della neutralità - Ndr) verso il confine
austriaco. Dopo la dichiarazione di guerra tedesca, io potevo avvisare il mio Governo che le nostre truppe al
confine italiano potevano recarsi a combattere i tedeschi sulla Marna. E da quel momento la vittoria della
Marna fu sicura e lo scacco della strategia tedesca assicurato. Sia la neutralità sia il successivo intervento
italiano a est divenne uno dei grandi fattori della vittoria degli Alleati".
La vittoria francese sulla Marna (5-9 settembre) era dunque una vittoria che moralmente apparteneva un po'
anche all'Italia. I Tedeschi se avessero vinto sulla Marna in pochi giorni sarebbero piombati su Parigi.
Eppure tutte queste considerazioni non ebbero alcun peso sul contegno di Clemenceau, Wilson e Lloyd
George, i quali furono ostili alle rivendicazioni italiane, e perciò resero acuto e insolubile il contrasto italojugoslavo.
Addirittura a Parigi, a Versailles, alla conferenza di Pace, l'Italia stava rischiando di non essere nemmeno
presente nel momento in cui avvenivano le spartizioni di quella Europa centrale andata in frantumi, ivi
comprese le colonie. Nè ebbe alcun valore il Patto di Londra quando fin dal 1915 erano state stabilite le
spartizioni.
Il Patto era stato sottoscritto a Londra il 26 aprile 1915 dall'Inghilterra, Francia, Russia e Italia. In base a esso
l'Italia (staccandosi dalla Triplice Alleanza) aderiva al blocco della quadruplice intesa, già sanzionato a Londra
da un altro Trattato segreto del 4-5 settembre 1914 (che troviamo citato nel documento stesso).
L'Italia dopo molti mesi in una posizione neutrale, inviando il telegramma che abbiamo letto sopra e siglando
poi questo patto del 26 aprile, si impegnava ad entrare in guerra contro le potenze centrali entro 30 giorni
dalla sua sigla (il 24 maggio infatti l'Italia entrò nel conflitto). L'Italia entrava in guerra non per rivendicare il
diritto internazionale e proteggere le nazioni più deboli dall'arroganza e dalla rapacità dei grandi imperi
coloniali, ma per un contratto che le assicurava vantaggi materiali, e non badava più di tanto alle ragioni
etniche ma solo a quelle strategiche. E il possesso della Dalmazia era strategico. Dare la Dalmazia e Fiume agli
Slavi era come offrire una porta aperta all'accesso delle coste venete. Era a quel punto inutile, avere dietro la
muraglia difensiva delle Alpi, per poi avere davanti il mare Adriatico aperto a tutti.
Inoltre si scoprì nel frattempo - riporta la notizia "Idea Nazionale" del 12 febbraio 1920 - che il nuovo governo
di Belgrado aveva iniziato il 30 settembre 1919, con il Governo di Parigi, trattative segrete (mai ufficialmente
smentite) per un'alleanza militare, convenzioni commerciali, accordi doganali, offrendo ai francesi tutte le basi
navali dell'Adriatico non più soggette a neutralizzazione, secondo il compromesso Lloyd George-Nitti. Il
governo francese rispose che "...il progetto è alquanto rudimentale, tuttavia esso dà senza dubbio dei
vantaggi alla Francia, in quanto le assicura, in caso di conflitti futuri (ma contro chi se non l'Italia? - Ndr.) un
solido appoggio sulle coste dalmate, e apre orizzonti più vasti all'espansione commerciale francese"
(Corrispondenza da Berna di Pio Mari, apparsa su Idea Nazinale il 12 febbraio 1920)
Fiume e la Dalmazia servivano un ampio retroterra comprendente la Croazia, l'Ungheria, la Transilvania e in
buona parte anche l'Austria e la Cecoslovacchia, quindi non doveva andare in mano italiana, per il timore che
essa avrebbe monopolizzato i commerci che passavano per quel porto. (vedi questa pagina con l'invio di una
missione francese a Fiume per agganciare subito aziende (comprese 800 italiane) interessate alle materie
prime coloniali francesi che sarebbero sbarcate nei porti della Dalmazia, che il nuovo governo Iugoslavo con
un trattato offerta segreta stava già offrendo alla Francia).
TORNIAMO AL PATTO - I negoziati, che erano già stati avviati dall'Italia agli inizi del marzo 1915, furono nei
due mesi di incontri, piuttosto laboriosi a causa degli interessi divergenti delle parti. L'ostacolo maggiore, che
venne poi superato (ma a parole), era quello della Russia zarista per ciò che concerneva la Dalmazia (che nei
preliminari del Patto di Londra questa spettava all'Italia). Sostenitrice degli interessi serbi, questi coincidevano
col programma zarista imperialista d'espansione verso i Balcani e verso il Mediterraneo. Forte di questo
appoggio (ma anche la Francia non voleva una Italia forte) gli Slavi non vollero cedere sul possesso di Fiume.
Che in verità nel Patto di Londra l'Italia aveva concesso proprio alla Croazia con una imperdonabile leggerezza.
Ma del resto i firmatari e con essi il governo italiano, lontanamente immaginavano una così clamorosa disfatta
e disintegrazione dell'Impero austro-ungarico. Nè avrebbero immaginato allora gli immani sacrifici che
sarebbero costati per infliggerla. Quindi un miglioramento delle sue frontiere poteva essere giustificato anche
se "l'Austria-Ungheria erano a pezzi e non potevano più costituire una minaccia militare per l'Italia" questo
dicevano a Versailles le nuove tre grandi potenze improvvisamente (!?) divenute tutte filo-slave.
Infatti, i Croati fin dal 1915 avevano costituito in Francia ed in Inghilterra i cosiddetti "Comitati jugoslavi".
Propagandando la liberazione delle "Nazionalità oppresse dall'Austria" svolsero un'abile azione presso le
Cancellerie di Londra, Parigi e in seguito a Washington, per convincere gli Alleati della necessità di creare quel
futuro Stato indipendente dei Serbi-Croati-Sloveni (S.H.S.) qualora l'Austria-Ungheria fosse stata sconfitta. Nel
nuovo Stato doveva esser compresa l'intera Dalmazia e ciò in contrasto con le aspettative dell'Italia, garantite
dal Patto segreto di Londra.
Così che a Versailles, nel 1919, non fu possibile addivenire ad alcuna intesa con l'Italia soprattutto per la
posizione filo-slava assunta dagli Stati Uniti. Ma anche per la scarsa abilità della condotta dell'Italia durante la
Conferenza della Pace oltre che essere sottoposta a continue pressioni diplomatiche.
Al patto di Londra seguirono alcune convenzioni militari firmate il 2, il 4 e.... il 21 maggio 1915 (Quattro giorni
prima dell'entrata in guerra dell'Italia)
Questi patti (per l'alleanza dell'Italia con la Quadruplice Intesa, e la sua entrata in guerra) concedevano a fine
conflitto all'Italia alcuni possessi territoriali, e venivano inoltre promessi altri compensi a spese dei tedeschi,
oltre a una parte dell'indennità di guerra "corrispondente ai suoi sforzi e ai suoi sacrifici". Articoli che in
seguito si rivelarono deboli, vaghi e imprecisi. E invece delle indennità l'Italia dovette assumersi una enorme
quantità di debiti nei confronti degli Stati Uniti, rimborsabili in oltre 60 anni("hanno avuto i soldi? e allora
che paghino!" - fu il commento di un Presidente degli Stati Uniti, quando l'Italia in seguito attanagliata da
una crisi, chiese magnanimità o al limite più lunghe dilazioni).
Il documento-patto che era segretissimo (anche se ad alcuni era già noto) fu -dopo tre anni di guerrapubblicato improvvisamente dal nuovo governo sovietico all'indomani della Rivoluzione Russa, nel novembre
1917 ( dal giornale Izsvestia).
Iniziò così ad essere il Patto al centro delle polemiche dei politici italiani e europei, per alcune contraddizioni
politiche, per le pressioni della Francia e soprattutto della Russia, per la disintegrazione dell'Austria (che
nessun ottimista aveva lontanamente previsto), e per l'intervento nell'ultimo anno di guerra degli Stati Uniti e
l'intervento del suo Presidente Wilson, che a Versailles non volle riconoscere al tavolo della pace il Patto
stesso.
Così che di fatto, dopo accese controversie - fino al punto che gli Italiani per protesta - come abbiamo già
ricordato- lasciarono Versailles, il Trattato alla ripresa dei negoziati dovette essere lasciato cadere dagli stessi
negoziatori italiani e dai loro sostenitori, con l'indegna accusa verso l'Italia di esserci trincerata per quasi un
anno nel neutralismo, e... perchè -assente a Versailles- il Patto stesso decadeva.
"Clemenceau: "Bisogna far sapere ai delegati italiani che se essi si ritirano violano il Patto di Londra e gli alleati
non sono più impegnati da esso". Wilson: "Bisogna far sapere che è l'Italia, e non la Francia e la Gran
Bretagna, che viola il Trattato" .
Tutto ciò era invece un pretesto, e si aggiunse la debolezza dei negoziatori italiani.
Infatti Clemanceau con il suo solito fare brutale aggiunse "La politica italiana evidentemente tende a condurre
le potenze alleate ed associate ad un punto tale che non possono fare una pace comune, perchè l'Inghilterra e
la Francia sono legate dal Trattato di Londra che il Presidente Wilson non può riconoscere. Noi dobbiamo far
sapere agli italiani in anticipo che non venendo a Versailles hanno rotto il Patto di Londra al quale avevano
aderito, e col quale si erano accordati di non fare pace separata. Noi dobbiamo mostrare che se essi
rompono il Patto di Londra noi non siamo più impegnati"(Lloyd George, The Truth about the Peace Treaties,
London 1938, II, pag. 859 e seg.)
Alla Camera, l'Onorevole Bevione, fece un'esposizione del Trattato (quello diffuso attraverso l'Isvestia), che
però ha lasciato molti sospetti per le alterazioni fatte a beneficio delle grandi potenze e soprattutto verso la
Russia. Alterazioni che furono messe sotto accusa da alcuni politici e da milioni di reduci che avevano
combattuto la tragica guerra. Fu appunto per questo detta "vittoria mutilata". L'Italia ottenne una zolla di
terra in più rispetto a ciò che si era vista offrire dall'Austria all' inizio del conflitto e anche durante il
conflitto.
Tutte le rivendicazioni italiane - dopo così tanti sacrifici umani ed economici - per una sorta di sudditanza
verso le grandi potenze, entrarono nel dimenticatoio; covando però rivalse (principalmente nel ventennale
Fascismo), che poi esplosero nella (tardiva) partecipazione alla sciagurata guerra di Hitler. Con i soliti tre che
invece avevano subito deciso di dare battaglia al dilagante nazismo (o meglio dire a quella Germania che era
tornata ad essere una potenza economica che stava facendo nuovamente tremare -come nel 1913- le loro
economie. E questa volta anche quelle degli Stati Uniti).
Oltre che questi fatti italiani a Versailles, furono infatti principali quelli inerenti la Germania (questi furono il
fulcro di tutta la Conferenza di Parigi) che costretta ad accettare dai vincitori le condizioni delle pesantissime
punizioni, queste favorirono successivamente in Germania la nascita del nazismo. E se grande fu a Versailles il
livore francese (memore del 1870) verso la Germania , non di meno furono le pretese degli Stati Uniti nel
volere il rimborso delle loro spese di guerra dagli Stati Europei vincitori e nel contempo libera navigazione
nelle acque europee e l'abbattimento delle barriere doganali - cose piuttosto sgradite agli Inglesi, ma anche
penalizzanti per tutti gli Stati europei, sia vincitori che vinti.
WILSON TRIONFANTE
Sbarcato in Francia il 13 dicembre1918, dopo una visita a Parigi, il 3 gennaio, il presidente degli Stati Uniti
WILSON fece un viaggio trionfale in Italia. A Roma ebbe accoglienze entusiastiche: sfilò in carrozza insieme a
VITTORIO EMANUELE III, e con lui andò al Parlamento sedendosi accanto al Sovrano; fu ricevuto in
Campidoglio e acclamato cittadino romano, si recò al Vaticano, fu ospite al Quirinale, festeggiato
all'Accademia dei Lincei.
Il 5 si recò a Genova, la cui università lo nominò dottore; lo stesso giorno si recò a Milano, dove con un'aria
messianica e istrionica, pronunciò (facendo quasi concorrenza ai miti della "rivoluzione proletaria" dei
socialisti massimalisti) un caldo discorso "inneggiante all'avvenire delle classi lavoratrici" e il 6 era a Torino,
anche qui acclamatissimo.
Queste dimostrazioni d'entusiasmo, erano più che altro emotive, un semplice segno d'adesione dell'opinione
pubblica al suo utopistico programma di pace. Il Presidente detto "il filosofo di Staunton" possedeva una
ottima dialettica. Un "evangelista" singolare; "Wilson credeva nell'umanità ma…diffidava di tutti gli esseri
umani" (Lloyd George, The Truth About the Peace Treaties, Vol I, p.234)
Il presidente del Nord America, così affrettatamente acclamato dagli italiani, che credevano di propiziarselo,
partendo poi per la Francia portava con sé, non il ricordo degli onori ricevuti, ma l'eco dei dissidi degli Italiani
sulla questione della pace, l'eco delle parole di Bissolati e la convinzione che l'Italia fosse animata da un
imperialismo esagerato, dannoso alla causa della "sua" pace. La voleva piccola piccola l'Italia; ma anche per i
Francesi che si stavano dando tanto tanto da fare a scapito della Germania a voler piccola la Francia era a sua
volta l'Inghilterra. Una Francia vittoriosa sull'Austria, se diventava grande e potente, era pericolosa; poteva
ricordare agli inglesi lo spettro napoleonico.
In Italia Wilson si era incontrato anche con ORLANDO; che gli anticipò le richieste che avrebbe fatto alla
prossima conferenza di Parigi (in programma il 18 gennaio) e il Presidente americano, in linea di massima
approvò l'estensione dei confini italiani dal Trentino fino al Brennero (per quanto abitato da popolazioni
tedesche - contraddicendo ciò che aveva spiegato in Senato a Washington prima di partire: cioè il punto IX che
affermava che "…le pretese italiane in Trentino dovrebbero essere soddisfatte, ma la parte settentrionale della
regione, abitata dai tedeschi, dovrebbe essere completamente autonoma" (Papers Relating to the Foreign
Relations of the United State, 1918: "Supplements I", Documents State Department, Washington 1933, vol. 1,
p. 410).
E se vogliamo dare credito a questa sue nuove "linee", entrava in contraddizione nel poi respingere le
rivendicazioni italiane relative all'ampliamento dei confini orientali (territori dalmati), perché "…quelli erano
abitati prevalentemente da iugoslavi e non da italiani". Due pesi e due misure.
Significava che l'Europa, straziata ancora da piaghe atroci, tormentata dalla persistente difficoltà degli
approvvigionamenti, sconvolta e lacerata dalle lotte fra le forze bolsceviche e quelle liberal-democratiche
anche se entrambe usavano solo parole; la prima incantava con le prime confuse e apologetiche notizie della
rivoluzione russa, e la seconda non era meno imbonitrice della prima: anche Wilson con il suo progetto di una
grande "internazionale borghese", aveva delle vaghe idee di fratellanza di popoli fra sconfitti e vinti, fra ricchi
e poveri. Secondo lui tutto questo era attuabile, sufficiente per eliminare la rivoluzione socialista, bastante per
superare le passioni nazionali e le questioni territoriali.
Chiacchiere, mentre tutta l'Europa presentava un quadro fosco d'ombre cupe, angosciose e di tragiche
incertezze.
In Italia continuando i forti dissensi nel Governo iniziati a fine 1918 con Bissolati che si era dimesso dalla carica
di ministro- i rapporti furono ancora di più aggravati dal famoso discorso proprio di Bissolati, pronunciato in
parte 1'11 gennaio alla Scala e pubblicato il 12.
Parallelo al discorso ci fu anche una combattiva dimostrazione di Nazionalisti. Ma c'erano pure i futuristi di
MARINETTI e gli ARDITI D'ITALIA ex combattenti dei battaglioni d'assalto che si erano costituiti in associazione
nel novembre del 1918, e che avevano iniziato a confluire nei gruppi nazionalisti. Fra gli organizzatori della
imponente manifestazione di protesta (a una settimana dalla visita di Wilson) vi era BENITO MUSSOLINI.
Di anomalo in questa manifestazione vi era la scarsa partecipazione degli interventisti democratici, i cui leader
erano proprio BISSOLATI e SALVEMINI spietatamente contestati.
Lo stesso giorno 12 gennaio, fu ancora e in misura più larga rimaneggiato il Gabinetto Orlando. Tutti i ministri
il 15 gennaio presentarono le dimissioni, ma furono soltanto accolte quelle degli onorevoli SACCHI (Grazia e
Giustizia), NITTI (Tesoro), ZUPELLI (Guerra), MILIANI (Agricoltura) e VILLA (Trasporti). Furono sostituiti dagli
onorevoli FACTA, STRINGHER, CAVIGLIA, RICCIO, DE NAVA e da GIUSEPPE GIRARDINI (Assistenza militare e
Pensioni di guerra - uno dei dirigenti del recente Fascio parlamentare). Fu inoltre deliberata 1'istituzione di un
ministero per la ricostituzione delle terre già invase e liberate; a quest' ufficio fu designato l'on. ANTONIO
FRADELETTO. L' on. VILLA fu nominato vicepresidente del Consiglio.
Il ministero italiano partecipò con gli onorevoli ORLANDO, SONNINO, SALANDRA e BARZILAI alla conferenza
della pace, che fu inaugurata alle ore 15 del 18 gennaio del 1919 a Parigi, nel grandioso palazzo del Ministero
degli Affari Esteri, posto lungo il "quai" d'Orsey.
Non si era mai vista, nel corso dei secoli, un'adunata così imponente di plenipotenziari convenuti da ogni
parte del mondo con un compito così arduo: quello di rifare la configurazione politica di quattro continenti.
Si incontravano i rappresentanti di 29 Stati e molti per la prima volta.
L'orgoglio francese era soddisfatto. La "Ville Lumiere" in questi giorni fu chiamata "il cervello del mondo". E
Wilson la riunione la definì il "Congresso del mondo".
Quelli che spiccavano con le loro caratteristiche figure dominatrici in mezzo a questa folla di artefici della
sorte dei popoli di ogni grandezza, erano tre:
WOODROW WILSON, 62enne Presidente degli USA, che era sbarcato in Europa il 13 dicembre e reduce da un
giro trionfale nei Paesi Alleati.
LLOYD GEORGE, 56enne convalidato al potere dalle elezioni avvenute nel Regno Unito subito dopo la resa
della Germania e quindi con assoluta precedenza sopra ogni altro Stato.
CLEMENCEAU 78enne, massiccio e fiero uomo politico che per la sua tenace azione politica gli valse il
soprannome di "Tigre". Lui l'artefice -si disse- delle ultime imprese guerresche, lui il "direttore d'orchestra" di
tutte le armate Alleate
Nel trio si mescolavano l'astuzia e l'intrigo, l'obliquità e la furberia, l'ingenuità e la frode, sopra un fondamento
di incapacità, d'impreparazione, d'ignoranza.("studi insufficienti sulla questione" lo ammise proprio Wilson nel
maggio del 1919 parlando con House - in Woodrow Wilson and World Settlement, di Ray Stannard Baker,
London, vol II, pp.144 e ss.)
Come tutte le vicende degli uomini, anche la grande tragedia eroica finiva in un basso mercato verboso,
intramezzato da molti banchetti golosi.
Per acclamazione, in seguito alla proposta di Wilson e di Lloyd George, Clemenceau fu nominato presidente
della Conferenza. Questa scelta e quella della sede lasciavano intravedere che cosa si trattava di imbastire:
una pace gallica.
Fra l'altro Wilson e Lloyg George non conoscevano il francese, e mentre Clemenceau li capiva perchè
conosceva l'inglese, gli italiani masticavano un po' di francese ma nessuno conosceva l'inglese. Gli italiani
ricorsero così sempre a degli interpreti.
Wilson invece aveva varcato l'oceano con quella che gli Americani stessi chiamarono la "Caravan navigante",
cioè con un numeroso seguito (circa 1200) di affermati competenti di geografia, di storia, di politica, di
economia, di etnografia, parecchi dei quali però possedevano soltanto cognizioni superficiali e generiche,
anche se si erano portati dietro migliaia di libri, perchè la lunga storia d'Europa nei libri statunitensi anche
nelle scuole superiori e nelle università è quasi del tutto assente oppure raccontata in due-tre righe. Dopo
questa preparazione affrettata su testi che questi "competenti" avevano creduto opportuno sottoporgli e su
statistiche sospette, il "Filosofo di Staunton" si giudicava da se medesimo di essere in grado di risolvere
questioni europee intorno alle quali statisti eminenti in secoli e secoli si erano affaticati per tutta la vita, senza
venirne a capo. Gli intrighi degli imperatori, dei re, dei principi, dei ministri e di tutta l'alta e bassa diplomazia
sono sempre stati smisurati, oscuri e complessi anche per gli stessi protagonisti europei, figuriamoci per
Wilson.
Del resto più che alle definizioni delle nuove frontiere, Wilson teneva al trionfo delle proprie utopie. Portava
il dono ideale della giovane America alla vecchia Europa mai stata in un così grave sfascio e in una così
improvvisa decadenza economica e di valori: la "Società delle Nazioni". Quest'aspirazione di Wilson verso un
migliore ordinamento della società internazionale aveva fatto correre un filo di speranza in tutti i popoli del
mondo stanchi di carneficine e di combattere. Ed anche un filo di speranza alla Germania sulle miti
applicazioni delle pesanti penalità imposte con il primo armistizio "esazioni che esorbitavano dalle possibilità
del popolo tedesco" (The Paris Peace Conferenze, 1919, vol, 3°, pag 417), e che invece alla "resa dei conti"
furono poi peggiori: requisizioni, blocchi alimentare, pagamento dei danni di guerra, sottrazione totale delle
Colonie, e quando la Francia avanzò pretese sull'Alsazia, Lorena e perfino sulla Renania, regno sorto mille anni
prima nel naufragio dell'impero di Carlomagno), molti capirono che la Francia "recitava" sul "palco" da "prima
attrice".
Mentre Wilson si sentiva il "Messia" della pacificazione universale; vedeva solo i vantaggi teorici del suo
Tribunale Supremo dei popoli, costituito allo scopo di risolvere le questioni mediante un giudizio demandato
ai rappresentanti dei Governi consociati, senza tener conto delle gravi manchevolezze pratiche, derivanti dal
fatto che il massimo Foro civile sarebbe divenuto strumento docile dei più potenti, incapace d'imporre il
rispetto alle proprie sentenze per mancanza di un potere esecutivo da esso dipendente.
Gli altri due al suo fianco erano due statisti consumati, maestri nell'arte sottile della doppiezza politica.
Dominati dalla considerazione del presente storico, attenti a trarre dalle circostanze i massimi profitti
possibili, realizzatori per eccellenza, Clemenceau e Lloyd George contrastavano fortemente il "Messia"
americano imbevuto di un avvenirismo nebuloso, estraniato dalla tragica realtà, proteso a miraggi assurdi (in
certi casi parlava come Lenin quando "inneggiava all'avvenire delle classi lavoratrici" ).
Nonostante il disaccordo delle persone, delle individualità, delle tendenze, tanto il premier londinese come il
suo collega parigino riuscirono abilmente a persuadere Wilson che il Regno Unito e la Francia non ambivano a
fare spartizioni evangeliche e nutrivano profondo disinteresse nell'avvento della giustizia internazionale.
Ma non erano per nulla disinteressate e non trovarono freno nell'opprimere i nemici, nel favorire se stesse e
gli amici a loro graditi.
Fin dalle prime riunioni, l'assemblea generale dei plenipotenziari si rivelò qual era: una Babele del Novecento
cui non mancava la confusione degli idiomi (lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: degli italiani nessuno
conosceva l'inglese, e gli americani erano del tutto carenti di francese).
Avviata lungo queste direttive, la Conferenza non riusciva a procedere nei propri lavori. Gli accordi imperniati
sul principio di togliere ai vinti, dopo le vesti, anche l'epidermide, veniva a mancare ….soprattutto quando si
trattava di ripartire le ricche e anche le misere spoglie. Inoltre ognuno dei negoziatori non voleva scoprire per
primo le proprie carte. Ognuno diffidava dell'altro, e tutti diffidavano di ognuno.
Poiché il protrarsi delle incertezze dovute ai vari armistizi - che bisognò rinnovare più volte- manteneva
l'Europa in preda ad agitazioni dannose per tutti, si riconobbe la necessità di giungere alle conclusioni. Fu
costituito un "Comitato dei Dieci", ma pure questo era troppo numeroso. Lo sostituì il "Comitato dei quattro".
Ne fecero parte Clemenceau, Wilson, Lloyd Gorge e Emanuele Orlando.
Il primo il 19 febbraio subì un attentato, una pistolettata al polmone, da un anarchico, un certo Emilio Collin,
che pochi giorni dopo fu condannato a morte. Anche questo fece subire un ritardo ai lavori. Nessun ritardo
invece provocò la partenza degli italiani, sdegnati per il trattamento indegno di cui parleremo più avanti.
L'azione che dovevano svolgere alla conferenza i delegati italiani era molto delicata, date le pretese degli
jugoslavi. Questi anzi si erano improvvisamente rivelati antagonisti dell'Italia e cercavano da una parte con gli
intrighi politici, dall'altra con le agitazioni e le violenze di giovare alla loro causa contro le aspirazioni italiane,
dimenticando gli appoggi ricevuti.
Violenze contro gli italiani furono commesse in Croazia e in Dalmazia, specie dopo che la delegazione italiana
rifiutò la proposta jugoslava (11 febbraio) di sottoporre all'arbitrato del presidente Wilson la controversia
territoriale; il 12 un treno di profughi italiani che tornavano in patria, transitando per Lubiana, fu assalito dagli
slavi; una settimana dopo il comando jugoslavo con vari pretesti ingiungeva a una commissione militare
italiana di lasciare Lubiana; il 23 gravi dimostrazioni croate avvenivano a Spalato contro gl'italiani; altre
violenze avvenivano negli stessi giorni a Ragusa e nei successivi a Traù e ancora a Spalato. A queste agitazioni
l'on. ORLANDO rispose con molta dignità, proclamando nella seduta alla Camera del 1° marzo, l' italianità di
Fiume, e presentando, l'11, alla conferenza, un lungo memorandum redatto da BARZILAI (l'irredentista
triestino) nel quale s'illustravano convenientemente le rivendicazioni italiane sulle Alpi e nell'Adriatico.
Memorandum sostenuto in modo irremovibile presso gli alleati dal ministro degli esteri SONNINO. (lo
riportiamo nelle "Appendici")
Si chiedeva il pieno rispetto del Patto di Londra sulla Dalmazia e si rivendicava inoltre Fiume. L'annessione
della città, popolata prevalentemente da italiani (questo però in città) e già appartenente al Regno di
Ungheria, in un punto del Patto era stata solo vagamente accennata come possesso della Croazia. Tuttavia
non ci furono prese di posizione di Sonnino per timore di compromettere le trattative con gli alleati. Orlando
invece se n'era fatto sostenitore in seguito all'imponente campagna nazionalistica svoltasi in Italia negli ultimi
mesi del 1918.
Riguardo ad altre richieste nel settore adriatico, alle quali Wilson si era già dichiarato contrario nei colloqui di
gennaio in Italia, troveranno opposizione anche da parte dell'Inghilterra e della Francia; in particolare
quest'ultima per impedire una futura (e concorrente) espansione dell'Italia.
Gli jugoslavi il 12 febbraio chiedendo l'annessione della Dalmazia con le isole, dell'Istria, di Trieste e di
Gorizia, presentarono pure loro un memoriale e abilmente proposero a Wilson di assumere l'arbitrato nelle
trattative fra Italia e Jugoslavia. Ottennero così con il presidente degli Stati Uniti un potente difensore.
Wilson credeva e fu convinto che l'Italia, reclamando Fiume oltre ciò che era stato scritto nei patti stipulati
a Londra, minacciasse la pace. Egli era disposto a riconoscere all'Italia le nuove frontiere alpine, Trieste, Pola
qualcosa dell'Istria, Valona, Lissa e qualche altra piccolo territorio, ma Fiume no perché, affermava, non era
"per ubicazione e per tutte le circostanze del suo sviluppo un porto italiano, ma internazionale".
"L'America - appoggiata dall'Inghilterra- insisteva sulle necessità che tutte le vie fossero aperte ai traffici e che
le merci americane e inglesi non incontrassero ostacolo per arrivare nell'Europa centrale. Per questo
Danzica era stata fatta "città libera" unita con un corridoio alla Polonia; per questo Fiume, che serviva un
ampio retroterra comprendente Croazia, Ungheria, Transilvania e in parte anche l'Austria e la Cecoslovacchia,
non doveva essere italiana, per timore che l'Italia ostacolasse il passaggio delle merci altrui e monopolizzasse
per conto suo il commercio che passava per quel porto" ("Versailles, Storia della conferenza della pace", A.
Torre, Ist.Studi Politica Internazionale, pag. 312).
Ma anche la Francia non restava a guardare. Di Trieste e Fiume voleva fare un suo porto per lo smistamento in
Italia delle merci provenienti dalle sue colonie.
(vedi qui un documento inedito)
E poiché OSSOINACH, inviato fiumano a Parigi, dimostrava l'avversione dei suoi concittadini per gli
jugoslavi, il presidente americano si mostrava disposto a fare anche Fiume "città libera", creando un piccolo
Stato, sotto il mandato della Società delle Nazioni.
Il 19 aprile Wilson, Clemenceau, Lloyd George e Orlando affrontarono finalmente la questione dei confini
italiani.
Lloyd George presentò un disegno, in cui proponeva di costituire sì Fiume "città libera", ma senza controllo né
mandato; ma quattro giorni dopo Wilson in un messaggio agli americani dichiarava decaduto con l'impero
austro-ungarico il Trattato di Londra; e affermava che Fiume doveva essere "l'egresso e l'ingresso per i
commerci ed i traffici, non dell'Italia, ma delle terre a settentrione e a nord-est di quel porto, dell'Ungheria,
della Boemia, della Romania e degli Stati del gruppo jugoslavo"; dichiarava che le aspirazioni italiane
contrastavano con i principi da lui formulati e accettati dalle Potenze alleate e sosteneva che tali aspirazioni,
consacrate dal patto di Londra dovevano essere ridotte, dato che, "finito l'impero absburgico, l'Italia (per
indorare l'amara pillola) non aveva più da temere il formidabile e secolare nemico".
Oltre il messaggio agli americani, Wilson pubblicò le sue argomentazioni di non concedere sia Fiume sia la
Dalmazia su un importante quotidiano Francese. Il risultato fu disastroso. Wilson per gli italiani diventò il
malvagio di turno; un notevole cambiamento rispetto all'adulazione che aveva ricevuto in Italia solo poche
settimane prima. Questo crollo del "wilsonismo" ebbe conseguenze importanti per la politica italiana:
distrusse la credibilità degli interventisti democratici insieme a quella degli Alleati. Gli interventisti, i
nazionalisti ma anche molti italiani fino allora agnostici, si risentirono molto per la bigotteria degli americani,
l'egoismo degli inglesi e francesi e per la debolezza del proprio governo; anche quando poi divenne presidente
del consiglio Francesco Saverio Nitti.
ORLANDO indignato, replicò con una messaggio agli italiani. Ricordando che "la civiltà e la giustizia non sono
privilegi di alcun uomo e che per tutti l'errore è sempre possibile". Orlando fece una calda difesa dei diritti
dell'Italia; negò che "...lo sfacelo dell'impero austro-ungarico significasse una riduzione delle aspirazioni
italiane" e sostenne essere quello adriatico "...il problema sostanziale da risolvere, problema in cui si
riassumeva tutto il diritto, antico e nuovo, d'Italia, tutto il suo martirio nei secoli, tutto il bene che essa era
destinata a recare nel consorzio internazionale". Disse che era "...inutile la muraglia difensiva delle Alpi se si
fosse lasciato aperto il fianco orientale e non si fosse portato il confine al Nevoso, dai Latini chiamato
"limen Italiane"; affermò che "...proprio in nome del principio wilsoniano dell'autodeterminazione dei
popoli, doveva essere riconosciuto a Fiume il diritto di decidere delle sue sorti, ed essa aveva già proclamata
la sua italianità prima che giungessero le navi italiane"; infine dichiarò che "...non poteva dirsi eccessiva
l'aspirazione italiana rispetto la costa dalmata che era stata nei secoli baluardo d'Italia, che era stata fatta
grande e nobile dal genio romano e dall'attività veneziana e che aveva resistito fieramente ad ogni sorta di
persecuzioni".
Ma l'ostinato agire di Wilson indignò talmente l'on. Orlando da indurlo a lasciare la conferenza. Il 24 Aprile,
insieme al generale Diaz e con i delegati Salvago-Raggi e Barzilai, lasciò Parigi. Durante il viaggio, alle stazioni
di Torino, Asti, Alessandria, Genova, ebbe applausi; a Roma, dove giunse il 26, fu accolto da un'immensa folla.
Poi con Diaz, Barzilai, e il sindaco Principe Colonna, rivolsero parole infuocate con cui stigmatizzava l'opera dei
nemici della nazione; poi la folla si recò al Quirinale e acclamò il Re, la Regina, il Duca di Genova, il Principe
ereditario, il gen. Diaz e l'on. Orlando, affacciatisi al balcone.
La dimostrazione si rinnovò il giorno dopo all'arrivo dell'on. Sonnino. Il 29 gennaio, alla Camera convocata in
seduta straordinaria, l'on. Orlando espose la situazione, disse fra l'altro che il 24, Lloyd George e Clemenceau
gli avevano dato assicurazione che avrebbero mantenuto gli impegni del Trattato di Londra, escludendo dalle
rivendicazioni italiane Fiume cui riconoscerebbero la condizione di città libera e indipendente, in virtù di
"compromesso e non già oltre ed a parte dell'integrale esecuzione dei patti del Trattato".
La Camera "tutrice della dignità ed interprete della volontà del popolo italiano"- come si esprimeva LUZZATTI
in un ordine del giorno messo ai voti, si dichiarò solidale con il Governo e con 382 voti contro 40, gli riaffermò
la propria fiducia affinché potesse "far valere i supremi diritti dell'Italia come condizione di una pace giusta e
durevole". Anche il Senato, qualche ora dopo, confermò la fiducia al Governo votando all'unanimità (191 voti)
un ordine del giorno di TITTONI simile a quello di Luzzatti.
L'atto di fierezza fu capito, fu pure compreso il risentimento, ma poi il governo non esitò a far riprendere ai
suoi delegati la via di Parigi il 5 maggio.
L'assenza della delegazione italiana non aveva fatto per nulla sospendere i lavori della conferenza e
ripresentatisi il 7 maggio, gli italiani furono accolti da una semplice indifferente acclamazione di Wilson, dal
sarcasmo appena dissimulato di Clemenceau e di Lloyd George, paternamente indulgenti verso i "capricci"
della giovane ed "ambiziosa" Italia.
Dimenticarono che il II Corpo d'Armata che andò a combattere in Francia non era un’ "ambizione" dell'Italia, e
che gli italiani sepolti nei cimiteri francesi, non erano andati in Francia solo per "capriccio" né per tornaconti
italiani. Lo dimenticarono!
E qui non dobbiamo dimenticare nemmeno l'inizio della guerra. La dichiarazione di neutralità dell'Italia diede
alla Francia la piena disponibilità, immediata, di tutte le sue truppe che erano state, o avrebbero dovuto
essere, dislocate nella frontiera italo-francese (quando la decisione dell'Italia di abbandonare la Triplice Intesa
dopo Sarajevo, non era stata ancora presa).
Lo scrittore militare generale Meraviglia scrisse: "Fu un inestimabile aiuto materiale e morale; che la Francia
doveva il mese dopo, mettere in valore sul campo della battaglia decisiva che impegnava sulla Marna, per
salvare se stessa e, nello stesso tempo, la causa dell'intesa".
Salandra invece scrisse (nel suo libro "La neutralità italiana" pag 186) che il 30 marzo 1919 stando a fianco del
maresciallo Joffre, l'illustre condottiero ebbe a dirgli a proposito del'Italia "…che la dichiarazione della
neutralità italiana, reputata, come era, perfettamente sincera, gli era valsa per quella campagna (Battaglia
della Marna) la disponibilità di dieci divisioni destinate a presidiare il confine italiano" (un settimo di tutte le
forse francesi).
Ma meglio di ogni altre testimonianza non di parte, fu l'articolo sul "Figaro" di Parigi del 24 maggio 1927 (nella
ricorrenza del giorno dell'entrata in guerra dell'Italia) scritto da BARRERE, ambasciatore francese a Roma
all'epoca dei fatidici giorni. Gli luccicarono gli occhi quando ufficialmente apprese ufficialmente da Salandra la
neutralità dell'Italia (1-2 agosto 1914).
"Il mio Paese (la Francia) aveva schierato alla frontiera italiana più di 350.000 uomini. Con l'annuncio di
Salandra, era evidente che l'azione italiana non poteva essere diretta contro la Francia, perché tutta
l'artiglieria pesante era stata mandata (nel corso della neutralità - Ndr) verso il confine austriaco. Dopo la
dichiarazione di guerra tedesca, io potevo avvisare il mio Governo che le nostre truppe al confine italiano
potevano recarsi a combattere sulla Marna.
Ma la neutralità dell'Italia in un nostro momento critico per le nostre armi ebbe ben altre conseguenze
militari. L'Italia abbandonò il fronte francese e portò le sue forze sulla frontiera dell'Austria-Ungheria. Questa
si convinse ben presto che l'attacco italiano era imminente e inevitabile; furono così portate al fronte italiano
le truppe che fronteggiavano l'Esercito Russo in Galizia. Ne venne di conseguenza che per non lasciare
scoperta la Slesia, lo Stato Maggiore Tedesco fu costretto a prelevare due corpi d'Armata sul fronte francese
ed a portarli in tutta fretta al fronte della Russia per proteggere Berlino.
Da quel momento la vittoria della Marna fu sicura e lo scacco della strategia tedesca fu pure assicurato.
Fu così che sia la neutralità sia il successivo intervento italiano divenne uno dei grandi fattori della vittoria
degli Alleati".
La vittoria francese sulla Marna (5-9 settembre) era dunque una vittoria che apparteneva un po' anche
all'Italia. L'arresto dei Tedeschi sulla Marna (già con l'eco dei bombardamenti che raggiungevano Parigi)
mandò a monte il piano della Germania di vincere in poche settimane la resistenza della Francia con una
poderosa manovra di accerchiamento. Con le due Armate in più, la Germania, che con azione ininterrotta dal
4 agosto al 4 settembre aveva già fatto ripiegare l'esercito Francese spingendolo oltre Parigi, non si sarebbe
arrestata sulla Marna, e il 10 settembre avrebbe potuto marciare tranquillamente verso la capitale francese
occupando Parigi.
Invece la dichiarazione di neutralità dell'Italia diede alla Francia la piena disponibilità, immediata, di tutte le
sue truppe.
Dunque, anche se non ci fosse stato l'intervento dell'Italia, e nessuna guerra di quaranta mesi all'Isonzo e al
Piave, l'Italia avrebbe comunque permesso all'Intesa la vittoria sugli Imperi Centrali.
Riprendiamo la nostra cronaca. Tornati i delegati a Parigi il 7 maggio, in quello stesso giorno all'"assise
mondiale" si stava svolgendo una breve cerimonia, quasi funerea. La delegazione tedesca, fino allora mai
invitata alla Conferenza (ed era una conferenza detta "della Pace"), riceveva il testo del trattato di pace "da
imporre" alla Germania dopo una lunga e travagliata elaborazione dei vincitori. I Tedeschi avevano quindici
giorni di tempo per accettarne le durissime condizioni. Questi si avvalsero di questi giorni per stendere un
memoriale con alcune osservazioni sul "pesante e umiliante resa dei conti" decisa pesantemente dai vincitori,
e avrebbero voluto almeno discuterle. Clemenceau non nascose la sua energica ostilità; acconsentiva a
ricevere osservazioni scritte, ma non ammetteva ai vinti discussione verbali.
I tedeschi nel memoriale reagivano all'accusa di essere stata la Germania la provocatrice del lungo conflitto,
osservando che la responsabilità non era amputabile ad un solo Stato, protestavano inoltre contro la "pace
della violenza" che si voleva imporle e presentavano alcune controproposte sulle condizioni formulate dagli
Alleati. Come risposta, ottennero l'ultimatum che intimava ai tedeschi che se non accettavano l'intero
contenuto del testo entro le ore 7 pomeridiane del 23 giugno, l'armistizio non avrebbe avuto più valore e il
conflitto sarebbe stato ripreso con l'invasione della Germania.
Posta di fronte all'ineluttabile, la Repubblica tedesca si trovò costretta a subire l'oneroso trattato.
La cerimonia della firma si svolse il 28 giugno nel castello di Versailles, in quella stessa Galleria degli Specchi
dove - il 18 gennaio del 1871- si era costituita, capolavoro di Bismarck la Confederazione germanica.
L'arrogante Guglielmo II, insofferente del grande statista, l'aveva poi messo alla porta Bismarck; ora alla porta
c'era l'intera Germania.
Rientrato da Parigi e reduce da Roma, il presidente del Consiglio riprese la questione dei confini e di Fiume e
fece di tutto pur di far trionfare la tesi italiana. Ma si arrivò a giugno senza che in questo campo le
conversazioni fossero riuscite a sgombrare il terreno delle difficoltà. Neppure il "Progetto TARDIEU" ebbe
buona accoglienza. Secondo questo, Fiume con Volosca, ma senza Sussak doveva formare uno Stato sotto il
controllo della Società delle Nazioni; le sorti dello Stato sarebbero poi state decise dopo 15 anni da un
plebiscito. L' Italia, rinunciando al retroterra dalmata e a una parte dell'Istria, guadagnava Zara, Sebenico, Lissa
e altre isole e riceveva il mandato sull'Albania. Wilson volle modificare il progetto, riducendo a 5 i 15 anni,
assegnando alla Jugoslavia la Dalmazia, meno alcune isole e Zara che diventava autonoma e dalla quale l'Italia
avrebbe avuta la rappresentanza diplomatica. E non accennò minimamente all'Albania.
Tutti capivano oramai che l'on. Orlando non sarebbe stato capace di vincere la partita a Versailles di fronte
agli intrighi, agli interessi, alle invidie, alle insidie e alle gelosie degli altri. Né, del resto, il ministero Orlando,
era capace di far fronte alla minacciosa situazione interna e di risolvere i grossi problemi del dopoguerra che si
stavano creando. Al primo posto dei problemi irrisolti era quello legato alla guerra, la "Vittoria Mutilata".
Questa situazione si faceva di giorno in giorno più minacciosa. Pareva che tutti coloro che non avevano voluto,
che avevano ostacolato e che non avevano fatto la guerra, ora che questa era finita con una vittoria da
inorgoglire qualsiasi esercito, volessero prendersi la rivincita e rifarsi dei torti che si volevano far subire dopo
aver speso lacrime e sangue.
Cominciava così -e andava assumendo proporzioni e atteggiamenti preoccupanti- l'ubriacatura bolscevica e,
proprio quando a Versailles volevano mutilare la vittoria italiana, proprio quando molti soldati erano ancora
sui confini, s'iniziava da quanti militavano nel socialismo e nel comunismo una lotta contro l'esercito, il
combattentismo, le glorie di guerra; insultando le bandiere, cantandosi sconce canzoni contro la patria,
sputando contro i distintivi delle ferite e i nastrini delle decorazioni, dileggiando i reduci, e continue
aggressioni contro i militari, ufficiali e soldati.
L'esercito non reagiva, dall'alto si consigliava prudenza, invitando perfino gli ufficiali (e questo era il colmo) a
non indossare in certi luoghi e in certe circostanze la divisa; non reagivano le associazioni dei combattenti e
dei mutilati e invalidi, le quali allora non erano altro, che spontanee società di mutuo soccorso; reagivano però
e con straordinaria violenza gli "Arditi", dei quali i congedati facevano capo ad una battagliera associazione,
sorta il 17 gennaio, che aveva la sezione più forte in Milano; quelli ancora sotto le armi e non mandati in Libia
erano concentrati intorno a Reggio Emilia.
Come gli arditi avevano iniziato sul Piave la riscossa di guerra dopo Caporetto, così, essi iniziarono la riscossa
nazionale. Tornati dalla guerra con l'anima amareggiata per lo scioglimento dei reparti d'assalto, accolti dalla
patria con segni evidenti di diffidenza, circondati di fosche leggende, creduti selvaggi e sanguinari, inetti al
lavoro e avanzi di galera, odiati dagli elementi sovversivi perché interventisti, volontari e guerrieri di bassi
istinti, temuti per la loro irrequietezza e la loro audacia, erano considerati ospiti indesiderabili dal paese che
invece pochi mesi prima nell'ora del pericolo li aveva stimati necessari e preziosi per la salvezza dell'Italia (vedi
i tanti encomi nei vari bollettini che abbiamo pubblicato nelle pagine precedenti).
Ostacolati nell'esplicazione della loro attività, rifiutati dalle officine e dagli uffici, diffamati vilmente dalla
stampa d'ogni colore, perseguitati dalla polizia, irritati dall'ingiusta ed inqualificabile ingratitudine della
nazione, gli arditi, e chi meglio di loro, si schierarono in "posizione di battaglia" contro la società borghese e i
partiti antinazionali per difendere se stessi, la propria fama, il proprio passato e il patrimonio eroico della
patria; per imporre il rispetto al sacrificio dei Caduti, valorizzare entro e fuori i confini la vittoria e svecchiare la
nazione spingendola arditamente su altre vie, che se erano pericolose, non lo erano di meno di quelle che in
Russia stavano cambiando l'intero Paese. Quindi anche loro con la violenza miravano alla dittatura.
Abbiamo detto rifiutati e diffamati dalla stampa di ogni colore; ma poi quando iniziarono a piombare sui
cortei, nei comizi, nelle gazzarre dei "rivoluzionari nostrani", sempre di più e in crescendo, e da parte degli
stessi denigratori, questi irrequieti elementi iniziarono a riscuotere l'approvazione e a cattivarsi le simpatie
anche di autorevoli personaggi. Ma in particolare e con le stesse inclinazioni (anche se alcuni diranno poi
"opportunistiche" per non sparire come esponenti del socialismo rivoluzionario, piuttosto in crisi) c'era un
uomo che dopo essere stato uno dei più cospicui fautori dell'intervento, ora quest'esuberante forza irrequieta
gli sarebbe stata utile per compiere un'altra sua metamorfosi; l'uomo era BENITO MUSSOLINI.
Il battagliero direttore del "Popolo d'Italia", pure lui un reduce, pure lui amareggiato, pure lui infuriato,
comprese che solo con uomini come gli arditi, era possibile salvare la vittoria e la nazione e degli arditi si giovò
e li utilizzò per la sua impresa che stava per iniziare. Aveva avuto già come preludio l'azione svolta l' 11
gennaio alla Scala di Milano un gruppo dei suoi arditi per impedire che Bissolati pronunciasse un discorso
contrario agli interessi d'Italia....
... mentre a Parigi si compravano e si vendevano Paesi e popoli, e si metteva in liquidazione l'Europa, in
cambio di una miniera, di un porto, o di una lingua di terra che interessava i nuovi predatori, mentre in Italia
ricominciavano intanto gli scioperi e le dimostrazioni socialiste. Nel febbraio ce ne fu uno a Milano, in cui
migliaia di socialisti con bandiere rosse gridarono "viva la rivoluzione"; "morte alle istituzioni e alla guerra".
Poi dal suo giornale Benito Mussolini ammonì: "Difenderemo i nostri morti: tutti i morti, anche a costo di
scavare le trincee nelle piazze e nelle strade delle nostre città".
Ma i morti e il patrimonio ideale della patria non si potevano difendere che chiamando a raccolta l'Italia
interventista e ovviamente il combattentismo. L'appello fu lanciato il 23 marzo con "…un invito ai collaboratori
e seguaci del Popolo d'Italia, ai combattenti, ex combattenti, cittadini e rappresentanti dei Fasci della Nuova
Italia e del resto della nazione".
Fu così costituito a Milano il primo dei Fasci Italiani di Combattimento, che facevano capo a Mussolini e che,
sotto la sua guida, tanto dovevano influire sui destini della nazione.
PARIGI: LIQUIDAZIONE EUROPA - LA QUESTIONE FIUME
GLI SCIOPERI PER IL CAROVITA - LA REAZIONE DEGLI ARDITI - LIQUIDAZIONE DELLA GERMANIA - SCAPA
FLOWW - LIQUIDAZIONE AUSTRIA, BULGARIA, UNGHERIA - L'ALBANIA E L'ITALIA - LA QUESTIONE FIUME BATTAGLIA DI RIBELLI E ADDIO ALBANIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------
al Mercato dei Popoli
Nell'aprile gli scioperi si fecero più frequenti e minacciosi; quello dei capotecnici metallurgici durò tutto il
mese e fece sospendere il lavoro a 40 mila operai; 50 mila contadini della Valtellina scioperarono per tre giorni
e riuscirono ad ottenere al posto delle 10-11 ore, le otto ore e notevoli aumenti di salario. Agli scioperi in
apparenza economici si aggiunsero quelli verso la classe politica. Il primo si ebbe a Roma in segno di protesta
contro il divieto di commemorare la settimana rossa di Berlino (la Spartachista - finita ingloriosamente,
annientata dai corpi franchi militaristi da… un governo "double face" socialista (!).
Quattro giorni dopo a Milano, durante un comizio socialista, scoppiò un conflitto fra i comizianti e la polizia. Si
deplorarono un morto e sette feriti; fu proclamato lo sciopero. Il 15 una colonna di diverse migliaia di rossi,
uscita dall'Arena e diretta in piazza del Duomo, fu caricata con estrema violenza da un gruppo di arditi e di
fascisti, fu rotta e messa in fuga. Nella mischia tre persone rimasero uccise e tre ferite; arditi e fascisti
assalirono e poi distrussero e incendiarono la sede dell'Avanti.
Nel maggio e nel giugno gli scioperi furono più frequenti: degni di nota quelli del personale delle ferrovie
secondarie e dei tranvieri, quello degli operai tessili del Biellese, quello dei camerieri e quello dei maestri
elementari. Più preoccupanti degli scioperi settoriali o politici furono le agitazioni contro il caroviveri, che si
svolsero con particolare violenza alla Spezia e a Genova. Sia gli scioperi come le dimostrazioni, valsero a
indebolire ancor più il prestigio del ministero, già minato dagli insuccessi di Parigi, e a determinarne la caduta.
Il 7 giugno -come già accennato sopra- Orlando era tornato a Parigi, per proseguire quello che era ormai un
totale fallimento della politica estera italiana. Pochi giorni dopo Orlando tornava a Roma.
Il 19 giugno riaperto il Parlamento, l'on. Orlando, dopo aver letto le comunicazioni del Governo, propose che
la Camera si riunisse in "comitato segreto" per discutere la politica estera; ma la sua proposta fu respinta con
262 voti contro 78, provocando le dimissioni del Gabinetto.
IL MINISTERO NITTI
LE PESANTI CONDIZIONI ALLA GERMANIA
La crisi di governo durò poco, due giorni. Il 21 giugno il Re affidò l'incarico per formare il nuovo ministero
all'economista FRANCESCO SAVERIO NITTI.
Il giorno 23 giugno il nuovo Ministero era già formato. NITTI, prese la presidenza del Consiglio e gli Interni e
affidò gli Esteri a TOMMASO TITTONI; alla Guerra e alla Marina furono messi ALBRICCI e SECHI, alla Giustizia
MORTARA, al Tesoro SCHANZER, all'Agricoltura VISOCCHI.
Il nuovo governo che comprende diversi ministri legati a GIOLITTI, esclude invece gli interventisti organizzati
nel Fascio parlamentare di difesa nazionale, che era stato costituito in concomitanza con il ministero Orlando.
(del ministero Nitti parleremo in una successiva puntata)
Nel frattempo a Parigi era rimasto come plenipotenziario il barone SONNINO, essendo imminente
l'accettazione da parte della Germania del Trattato di Versailles, che avvenne il 28 giugno, come già detto
sopra.
Per l' Italia sullo storico documento firmarono SONNINO, il marchese IMPERIALI e l'on. SILVIO CRESPI.
Si componeva di 435 articoli, dedicati i primi alla "creatura" di Wilson (La definizione della Società delle
Nazioni), gli altri a precisare gli oneri d'ogni genere imposti alla Germania vinta.
(Ne abbiamo una copia originale dell'epoca,
che pubblichiamo integralmente su Cronologia)
E se la prima parte parlava di pace, felicità nei popoli, autodeterminazioni, nella seconda alcuni già vedevano
un'altra guerra; e che le armi anche se tacevano prima o poi per la disperazione avrebbero di nuovo iniziato a
farsi sentire. E quando l'America, proprio lei che ne doveva essere la garante- volle rimanere fuori dalla
Società delle Nazioni, molti non ebbero dubbi.
Il fallimento della Società delle Nazioni pur concepita da Wilson fu ben presto dovuto proprio per l'assenza
degli Stati Uniti che l'avevano promossa. Il segretario di stato KELLOG respinse la formula bilaterale e il
principio delle sanzioni contro un eventuale stato europeo aggressore di un altro (Questo perchè volevano
seguitare a vendere indisturbati agli europei le merci, sia ai "cani" che ai "gatti" che si azzuffavano).
Se la dovevano sbrigare da soli gli europei. Ma senza la "forza" militare di dissuasione dell'America i litigiosi
stati europei tornarono alla tradizionale politica delle (ambigue) alleanze e dei (fragili) trattati difensivi (come
ai tempi di prima, durante e dopo Napoleone, e che erano solo carta straccia - vedi la Triplice intesa). Così fu
un susseguirsi di infrazioni al diritto, di fronte alle quali la "casareccia" Società delle Nazioni, o rimase apatica
o votò provvedimenti del tutto inadeguati. Fu così che ripartirono tutte quelle liti lasciate in sospeso nel primo
conflitto; in quello italo-etiopico - più tardi - addirittura la Società delle Nazioni finì nel ridicolo. Ma era quella
che era: una nullità.
E se già all'inizio c'era insofferenza per l'idea di conferire un certo potere ad un organo internazionale, quando
questo potere venne del tutto a mancare, l'era dei dittatori iniziava. L''inizio di un disastro pure.
Non va dimenticato che, per quanto possa sembrare assurdo, l'immagine della Russia prima leninista e poi
quella stalinista godeva di un diffuso "rispetto democratico" anche in America. Per anni fecero la corte ai
bolscevichi. E in funzione anti-inghilterra -che dopo il disastro economico del '29, tornò a chiudersi in se
stessa), nel 1933 gli stessi Stati Uniti (ovviamente per fare affari, facendo un grosso dispetto agli inglesi)
avevano riconosciuto l'U.R.S.S., e non furono pochi gli ambienti intellettuali americani disposti a concedere
credito e credibilità al regime dello "splendido georgiano".
Ma perchè meravigliarsi- I mezzi per capire c'erano. In un libro uscito in Italia nel 1921, Caracciolo, Bagliori di
Comunismo, Biblioteca di cultura storica, c'è un intervista di Losowski, presidente dei sindacati operai della
Russia soviettistica, e ai giornalisti occidentali (penne imperialiste) recatisi in Russia a studiare l'organizzazione
del regime comunista russo, affermava "Se la sperata rivoluzione europea non avviene, la rivoluzione
bolscevica russa è condannata a perire. Non possiamo sussistere se il comunismo non si propaga dappertutto,
Se rimarremo soli, fatalmente cadremo. Come si potranno conciliare nelle relazioni commerciali l'economia
comunista e quella borghese? Nella vita economica internazionale valgono le leggi dei vasi comunicante;
perciò, o noi saremo costretti ad accettare le vostre leggi, o voi le nostre, e ciò in un breve periodo di tempo.
Noi per guadagnare tempo dobbiamo utilizzare anche il più breve respiro, altrimenti è la morte!"
Chi leggeva in questi anni 1920, se voleva poteva anche capire qualcosa e antevedere il 1933, e anche... il
1990! Cioè il crollo, e l'apertura della Russia, all'economia di mercato occidentale; pardon... americana (con gli
europei che hanno fatto pochi affari).
Ora qui ci basta accennare alle clausole essenziali imposte alla Germania, per capire la sua costernazione e il
desiderio di rivalsa di tutto un popolo, con -fra breve- un capolale in testa:
La Germania doveva cedere: al Belgio, Eipen e Malmedy; alla Francia, l'Alsazia, la Lorena, la proprietà delle
miniere della Saar (il polmone carbonifero che alimentava la siderurgia tedesca); alla Danimarca, parte dello
Slesvig; alla Polonia, parte della Posnania, della Prussica Occidentale, della Prussica Orientale, dell'Alta Slesia.
Danzica col suo territorio e Memel col proprio, divenivano città libere, amministrate dalla Società delle
Nazioni.
La Renania era neutralizzata - al pari di una fascia larga cinquanta chilometri lungo la destra del Reno e n'era
prevista l'occupazione da parte degli Alleati per quindici anni.
Per quanto riguardava il bacino minerario della Saar anch'esso presidiato dagli Alleati (pronti ad invaderla), la
sua restituzione alla Germania era condizionata all'esito di un plebiscito da effettuarsi nel 1935. Qualora il
plebiscito stesso risultava favorevole alla Repubblica teutonica, la Francia avrebbe corrisposto in oro il valore
delle miniere.
La Francia, in barba ai principi enunciati da Wilson, era ben determinata a salvaguardarsi definitivamente dal
militarismo tedesco, e per fare ciò, al grido della parola d’ordine l’Allemagne paiera, chiedeva il controllo della
riva occidentale del Reno sotto forma di annessioni territoriali o con la creazione di uno stato cuscinetto, il
disarmo perpetuo della Germania e il pagamento di pesanti riparazioni. Tutto ciò in contrasto con altri
opinionisti, che ritenevano fosse più costruttivo per un futuro di pace una limitazione generale degli
armamenti e un atteggiamento meno mortificante contro i vinti; oltretutto, per le potenze occidentali
un’entità statale forte al centro dell’Europa sarebbe stata un ottimo baluardo contro il temuto dilagare del
fenomeno bolscevico.
Era fatto obbligo alla Germania: di non possedere più di 36 navi da guerra, con un effettivo massimo di 15 mila
marinai; di non mantenere alle armi più di 4 mila ufficiali e 100 mila soldati raccolti per mezzo del volontariato
con l'obbligo a 12 anni di ferma; di non possedere alcun aereo militare e neppure civile; di consentire il
controllo sulle proprie industrie cui era vietata la produzione di materiale bellico. La repubblica vinta
s'impegnava inoltre a corrispondere 1'importo dei danni causati dalla guerra nel Belgio, in Francia e sul mare.
Tutte indistintamente le floride Colonie tedesche furono affidate alle Potenze mandatarie; così ripartite: il 70
per cento alla Gran Bretagna, il 24 per cento alla Francia, il 5 per cento al Belgio; l'l per cento al Giappone.
All'Italia… la beffa e lo scorno. Ma il bello doveva ancora arrivare!
La Germania s'impegnava poi di firmare ed accettare senza riserve i futuri trattati di pace da imporre
all'Austria, all'Ungheria, alla Turchia, alla Bulgaria; rinunciava all'unione doganale con il Principato di
Lussemburgo, ricostruito com'era nel 1914, ed ai diritti acquisiti nel Marocco per mezzo degli accordi del
1906, del 1909, del 1911.
In attesa di conoscere l'ammontare del suo debito, da fissare ad accertamenti compiuti, la Repubblica vinta
era tenuta: in un primo anticipo di 25 miliardi di marchi-oro entro il 1 ° maggio 1921, ad un secondo anticipo
di 80 miliardi fra il 1921 ed il 1926, ad un terzo anticipo di 80 miliardi in data da fissarsi dalla Commissione
delle riparazioni.
Qualora la Germania avesse dimostrato la propria correttezza nella solvenza del debito, le truppe dell'Intesa si
sarebbero ritirate anzitempo dalla Renania.
Ma i tedeschi si chiedevano, se questi erano rate e si parlava solo di anticipi, quanto sarebbe mai stato allora il
conto finale?"
SCAPA FLOW
A dimostrare l'animo con il quale i Tedeschi accolsero le imposizioni dell'Intesa, basti ricordare quanto
avvenne a Scapa Flow il 21 giugno 1919 (pochi giorni prima della fatidica firma a Versailles).
Secondo gl'impegni assunti già con la firma dell'armistizio, la Germania doveva disarmare la propria
formidabile Flotta e acconsentire al suo internamento in uno scalo neutrale o appartenente agli Alleati.
Sia per lo scarso interessamento dell'Intesa a questo riguardo, sia perché i Paesi europei rimasti assenti
dall'immenso conflitto erano ben pochi, il porto neutrale non si trovò. Nel colloquio avvenuto il 15 novembre
fra sir Davide Beatty ed il contrammiraglio tedesco Meurer, restò pertanto convenuto, che la flotta imperiale
sarebbe stata ospitata dal Regno Unito nel suo Firth of Forth.
Gli equipaggi marittimi prussiani avevano abbracciato il Comunismo, tuttavia -invitandoli ad osservare che
ottemperando alle imposizioni dell'Intesa si sarebbero facilitate le trattative di pace - fu possibile far tornare a
bordo il personale sufficiente alla navigazione. Senza artiglierie, né siluri a bordo, piuttosto malconcia e a
rilento, la grande flotta tedesca salpò dalla rada di Shillig alle 2 pomeridiane del 19 novembre 1918. I marinai
avrebbero voluto innalzare la bandiera rossa, ma avvertiti che con quel vessillo, non compreso nelle tavole
delle insegne riconosciute dagli Alleati, sarebbero stati trattati da corsari e presi a cannonate - si
accontentarono di mettere un banale segnale scarlatto a prora.
Agli ordini del viceammiraglio von Reuter, la "Hochsee Flotte" muoveva alla volta del mare aperto. Ma non per
combattere i nemici della patria ma per offrire il pietoso e umiliante spettacolo della propria impotenza.
Durante la navigazione, nonostante le precauzioni prese, la torpediniera "V. 30" urtò contro una mina
micidiale che squarciò l'esile silurante, uccidendo due uomini e ferendone tre. Colata a picco l'equipaggio fu
salvato fino all'ultimo naufrago.
Alle 8 antimeridiane del 21 novembre 1918, la "Hochsee Flotte" incontrava la "Grand Fleet" nello specchio di
mare prestabilito, a cinquanta miglia dall'isola May.
Per quanto la giornata fosse nebbiosa, ogni nave scorgeva le altre navi. I marinai britannici videro così, dopo
cinquantadue mesi, le maestose "dreadnoughs", i superbi incrociatori di battaglia, gli incrociatori leggeri, le
numerosissime torpediniere, che avevano tanto a lungo pattugliato il bellico mare tempestoso, in mezzo al
turbinare sinistro dei venti, di giorno sotto il sole torrido, o nelle notti nei lividi raggi della luna.
Sorvolata dai dirigibili, preceduta e fiancheggiata dalle unità britanniche, la "Hochsee Flotte", raggiunse il Firth
of Forth, dove rimase fino al 25 novembre 1918.
Quel fatidico giorno, i Tedeschi salparono per l'ultima volta. Il 26, 1'Armata tedesca giungeva a Scapa Flow.
Per sette mesi i Prussiani, rimpatriati gli uomini eccedenti alla necessità del servizio, rimasero a bordo delle
loro navi internate nella base britannica. Furono sette mesi di clausura, durante i quali - salvo l'ammiraglio
Reuter- nessuno poteva scendere a terra, né passare da un'unità all'altra. A bordo, si verificavano attriti
frequentissimi fra i Consigli dei Marinai e gli ufficiali, mentre il rigore della censura ed il ritardo della
corrispondenza rendevano ancora più penoso l'isolamento assoluto in un angolo squallido del mondo in
mezzo ad un paesaggio selvagge e nudo d'acqua e di scogli.
Dal "Times" del 16 giugno 1919, l'ammiraglio Reuter venne a sapere che, in seguito alle condizioni di pace
presentate il 7 maggio, la Germania doveva cedere agli Alleati le navi internate a Scapa Flow. Sconvolto e
indignato, deliberò allora di affondare l'Armata che era ai suoi ordini.
Presi segreti accordi con i comandanti delle singole unità, poco dopo le ore 10 antimeridiane del 21 giugno
1919, faceva innalzare sulla propria nave il segnale convenuto che significava: - Affondate immediatamente!
Tutto era stato predisposto. A bordo di ogni nave, erano pronti gli sportelli trasversali e longitudinali sotto la
linea di galleggiamento, le porte dei corridoi, gli sportelli di comunicazione con le stive, le condutture di
ventilazione. Non restava che spalancarli all'acqua per finire in fondo al mare.
Mentre gli equipaggi, compiuto l'ultimo servizio, si mettevano in salvo sulle scialuppe, le belle navi
condannate s'immergevano una dietro l'altra nei flutti. La prima a colare a picco in pochi minuti, fu la super
corazzata "Friedrich der Grosse", alle ore 12,16. Ultimo a scomparire fu l'incrociatore di battaglia
"Hindenburg", alle 5 pomeridiane.
In quattr'ore e quarantaquattro minuti, 10 corazzate, 5 incrociatori di battaglia, 5 incrociatori leggeri, 32
torpediniere, andarono a coricarsi sui fondali di roccia che stanno intorno alle isole, alle isolette, agli scogli che
circondano la baia di Scapa Flow, diventando in breve la tomba dell'orgoglio marinaro della Germania vinta.
Bastarono quei 284 minuti perché si perdessero decenni di sacrifici, di fatiche, d'intesa geniale e operosità
costruttiva. Vanto dei tecnici, amore degli equipaggi, espressione della volontà ambiziosa di un grande popolo
ansioso del dominio oceanico; cinquantadue navi andarono distrutte senza sparare un colpo di cannone,
sconfitte senza gloria.
Furono invase dalle acque, ma non affondarono, la Baden, l'Emden II e la Frankfurt. Gli Inglesi spezzarono gli
ormeggi del "Nurnberg" e lo rimorchiarono, mentre altre 18 torpediniere, rimasero danneggiate, ma senza
inabissarsi.
Per quanto accusato di tradimento, l'ammiraglio Reuter se la cavò -al pari degli altri ufficiali e dei marinai-con
qualche mese di prigionia.
Quando, il 9 luglio del 1919, il Parlamento tedesco ratificava la pace, nel cuore del popolo vinto risuonava il
comandamento dell'ammiraglio Reuter: "Affondare, ma non cedere".
Fino all'ultimo, la Germania tenterà poi di sottrarsi agli impegni economici e morali sottoscritti a Versailles. Ma
a dire la verità, molti non credevano che quelle condizioni sarebbero state applicate con rigore. Inutilmente si
sperò nella magnanimità del nemico.
Liquidata la Repubblica tedesca, fu la volta dell'Austria.
LA LIQUIDAZIONE DELL'AUSTRIA
Il secondo trattato di pace conseguente alla grande guerra fu quello sottoscritto dall'Austria a Saint-Germainen-Laye il 10 settembre 1919. La cerimonia relativa, piuttosto breve, si svolse nel salone Luigi XIV dalle 10
antimeridiane alle 11,10. Un quarto d'ora dopo le 10 poneva la sua firma il cancelliere della Repubblica
austriaca RENNER.
In seguito ai patti di San Germano, facevano parte della nuova Repubblica: l'Alta Austria,la Stiria, la Carinzia, il
Burgenland, il Tirolo ed il Voralberg, la bassa Austria.
Alla vigilia della Prima guerra mondiale, l'Austria era un impero di 51 milioni di abitanti, esteso per 670.000
kmq. Ora era diventato un piccolo Paese di soli 83.000 kmq e circa 6.000.000 milioni di abitanti con capitale
Vienna con un quarto di tutta la popolazione; una grande metropoli che appariva e appare ancora oggi, una
città macroscopica rispetto al piccolo Paese che l'Austria era diventata e com'è attualmente. Nessuna città
europea possiede quei grandi monumentali palazzi e i "Ring" (= strade di una larghezza enorme), che conserva
ancora tutta la struttura creata sotto il dominio absburgico. Qui, da oltre un secolo, vi era tutta
l'organizzazione territoriale del Paese; ma in alcune regioni non bene accetta, criticata, osteggiata anche con
l'estremismo di un nazionalismo tedesco che tornava ( e tornerà più tardi) a farsi sentire; a torto o ragione,
questo è materia storica.
L'Austria si ritrovava composta da nove territori: Austria Inferiore, circa 1.480.000 abitanti Austria Superiore
1.340.000; Salisburgo 483.000; Tirolo 630.000; Vorarlberg 333.000; Carinzia 552.000; Stiria 1.184.000;
Burgenland 273.000.
L'84% della popolazione cattolica, il 16% protestante. La lingua il tedesco. Negli ultimi anni questo Paese era
stato soggetto a un'intensiva immigrazione di elementi di altre etnie; ma non era dovuto a un destino ma fu
una precisa scelta fatta da Vienna.
Si chiamava ai tempi di Carlo Magno Ost-mark (Marca ovest della Germania Carolingia), poi Deutchosterraich,
vale a dire Stato tedesco ovest; ma dopo Westfalia, perse il Deutch, e cessò di essere identificato in uno stato
germanico quando gli Asburgo nel 1648, dopo la guerra dei trent'anni, dovettero rinunciare all'egemonia sugli
stati germanici.
L'Austria si rinchiuse nel suo territorio ma si spaccò in due, in osterraich superiore e in osterraich inferiore, che
non significa in senso figurativo alto o basso, ma il primo è il territorio a sinistra di Linz, l'altro si trova a destra
di Linz: quest'ultimo sempre vissuto sotto la chioccia dello statalismo della corte di Vienna. Un imponente
apparato burocratico amministrativo concentrato in un piccolo territorio, che creò uno stato dentro lo stato.
L'Austria superiore aveva sempre guardato alla Germania (protestante, nazionalista, prussiana, creata da
Federico) l'Austria inferiore si era sempre invece appoggiata a Vienna, agli Asburgo (fanatici cattolici,
conservatori, con il sostegno e i consensi di una miriade di Principi o funzionari "viennesi" che dalla corte
erano stati sempre imposti nei territori assoggettati esercitandovi l'autorità imperiale ma anche quella
personale; e tutto questo in Paesi con una etnia non austriaca e tanto meno tedesca, cioè slavi, boemi,
italiani, cechi, magiari, croati, sloveni; e sempre senza concedere a loro nulla, neppure le tradizioni e le
espressioni culturali.
Una politica suicida e quindi -lo abbiamo visto- alla prima sua debolezza, non di mezzi, ma interni, intimi e
latenti, tutto iniziò a precipitare.
L'Austria dopo la firma non possedeva più una flotta, tanto meno quella subacquea, né aerei militari né civili. Il
suo esercito ridotto a 30 mila uomini con esclusivi compiti di polizia. Incombeva alla Repubblica l'obbligo di
risarcire i vincitori per i danni causati dalle sue truppe e dai sommergibili.
Il Trentino, l'Alto Adige, la Venezia Giulia, l'Istria, passavano all'Italia. Rimaneva insoluta la questione fiumana.
La Boemia e la Moravia costituivano uno Stato indipendente. La Polonia un tempo soggetta agli Absburgo si
univa alle terre polacche affrancate dal dominio della Russia e della Germania. La Croazia e la Slavonia furono
incorporate nella Jugoslavia.
Il principato di Lichtenstein cessava di fare parte dell'unione doganale austriaca per aggregarsi
economicamente alla Svizzera.
BULGARIA - Il 27 novembre 1919 fu firmato a Neuilly il trattato di pace imposto alla Bulgaria. Il piccolo Regno
balcanico perdeva la Tracia, passata alla Grecia, e qualche lembo del territorio sullo Stenmitza e sul Timok,
ceduto alla Jugoslavia. Con la Romania tornavano in vigore le frontiere del 1914.
La Bulgaria perdeva inoltre tutta la sua flotta di guerra, s'impegnava a non tenere alle armi più di 20 mila,
uomini, incominciava a versare ratealmente un contributo di guerra di 2 miliardi e 250 milioni.
UNGHERIA - Un quarto d'ora dopo le quattro pomeridiane del 4 giugno del 1919 si svolse, nel salone del
Castello del Grand Trianon, la cerimonia della firma del trattato di pace imposto alla Repubblica ungherese.
Erano presenti i delegati di ventidue Stati. Dimessosi fin dal 19 maggio il conte APPONYI, primo presidente
della Commissione magiara per la pace, 1'Ungheria era rappresentata dal ministro del Lavoro BENÀRD e
dall'inviato straordinario DRASCHE-LÀZÀR.
Bernàrd firmò per primo. Dopo di lui, tutti gli altri. Non furono pronunciati discorsi. I due magiari dopo la firma
in un silenzio tombale lasciarono il salone e la riunione si sciolse.
Il 15 novembre del 1920, l'Assemblea Nazionale magiara ratificava gl'impegni assunti il 4 giugno dell'anno
prima, fra solenni manifestazioni di lutto.
Il trattato del Trianon - terzo e penultimo -fu ricalcato su quello di San Germano. Anch'esso incominciava con il
solito preambolo di 26 articoli concernente la Società delle Nazioni. Seguivano altri 238 articoli, con numerosi
annessi.
L'Ungheria cedeva: il Burgenland all'Austria; alla Jugoslavia, la regione della Backa, i territori alla sinistra della
Drava, la parte meridionale del Banato; alla Romania, il restante del Banato, salvo un piccolo lembo, e tutta la
Transilvania; alla Cecoslovacchia, tutta la Slovacchia.
L'articolo 53 del trattato riportava: "L'Ungheria rinuncia ad ogni diritto e titolo su Fiume e sui territori
adiacenti appartenenti all'antico Regno d'Ungheria e compresi fra i confini che saranno stabiliti in seguito.
L'Ungheria s'impegna a riconoscere le stipulazioni contenute, relativamente a questi territori, specie per
quanto concerne la cittadinanza degli abitanti, nei trattati destinati a completare il presente assetto".
La questione fiumana rimaneva, dunque, tuttavia insoluta.
Entro tre mesi dalla firma del trattato, la Repubblica magiara doveva smobilitare le proprie forze armata,
riducendo il suo esercito a 35 mila uomini impegnati ad una ferma non inferiore ai 12 anni consecutivi. Le era
vietata il possesso di aerei militari e navi belliche.
Al pari della Germania e dell'Austria, anche l'Ungheria s'impegnava a risarcire i danni di guerra.
Il 10 agosto del 1920, infine, fu sottoscritto a Sèvres, l'ultimo trattato di pace. Con questo, la Turchia cedeva
alla Grecia la Tracia e Smirne col suo territorio. La Siria fu posta sotto il protettorato della Francia; la Palestina
e la Mesopotamia cadevano in potere del Regno Unito; i Sultanati d'Arabia soggetti un tempo al Governo di
Costantinopoli acquistavano la propria indipendenza.
Nonostante gli impegni solennemente assunti verso di noi -a San Giovanni di Moriana -da Parigi e da Londra,
l'Italia nulla otteneva dallo smembramento dell'Impero Ottomano: né Smirne, né Adalia.
Il giorno stesso della firma del trattato di Sèvres incominciava la guerra della Turchia contro la Grecia, finita
con perdita da parte del Regno Ellenico, divenuto Repubblica in seguito alla rivoluzione provocata dai disastri
militari, della Tracia e di Smirne, tornate agli Ottomani.
Il trattato di Sèvres comprendeva anche un regolamento il quale fu risolto -almeno in via provvisoria -la
secolare questione relativa al transito attraverso gli Stretti.
L'ALBANIA A L'ITALIA
Modesto compenso alle delusioni atroci sofferte a Parigi avrebbe potuto essere per l'Italia l'assegnazione
dell'Albania, d'indubbio valore, almeno strategico.
Alla data dell'armistizio di Villa Giusti, il Paese degli Schipetari - come abbiamo già visto nelle precedenti
puntate, completamente occupato dalle truppe grigioverdi agli ordini del generale PIACENTINI - sembrava
apparentemente pacificato e pronto ad iniziare la marcia verso la rinascita civile.
Si trattava di costituire un Governo locale autorevole e amico dell'Italia.
Il problema non fu risolto. In breve, ricomparvero le bande fornite di armi e di munizioni di provenienza
sconosciuta, largamente provviste di oro, accese di odio fanatico contro gl'Italiani il cui sangue era corso per
assicurare all'Albania l'integrità, l'unità, l'indipendenza.
Tranquillo e ordinato pochi mesi prima, il popolo di Giorgio Castriota cadde nell'anarchia. Il Paese cadde in
potere delle orde ribelli che si davano ai massacri, agl'incendi, alle devastazioni. Avvicinandosi l'estate del
1920, la situazione si fece critica; prima preoccupante, disperata poi per le truppe che presidiavano il campo
trincerato di Vallona, troppo scarse contro le turbe avversarie.
Il Generale Piacentini chiese nuovi contingenti. La risposta fu questo telegramma del Ministro della Guerra
"Condizioni interne del Paese non consentono prelevamento truppe per l'Albania; tentativo invio rinforzi
provocherebbe sciopero generale, dimostrazioni popolari, con grave nocumento della stessa compagine
dell'Esercito che non occorre mettere a dura prova".
Abbandonati a se stessi, i difensori del campo trincerato di Vallona sostennero aspri combattimenti.
Presidiavano le posizioni più avanzate piccoli reparti staccati del 72° Fanteria, comandato da ENRICO GOTTI.
Promosso generale, uno dei valorosi che non volle abbandonare i suoi Fanti.
Il 6 giugno, le avanguardie italiane furono assalite da forze quindici volte superiori. Il Gotti fu l'animatore che
diresse la prodigiosa resistenza, durata ben dieci ore, molto efficace, tale da causare perfino ai nemici perdite
enormi. Alla fine, i Fanti si trovarono senza munizioni, senz'acqua, senza il concorso dei due soli pezzi
d'artiglieria di cui disponevano, inutilizzati dal fuoco avversario.
GOTTI dispose allora affinché fossero posti in salvo la bandiera e i fondi del Reggimento. Quindi, pronto al
sacrificio estremo purché i suoi avessero tempo e modo di ripiegare, si avviò a trattare con i ribelli, ma lo
uccise a tradimento un capo albanese.
Alla memoria di Enrico Gotti fu decretata la medaglia d'oro.
Fra i valorosi combattenti d'Albania dobbiamo qui ricordare il popolarissimo, amato ed ammirato da tutti,
VITTORIO MONTIGLIO un ufficiale appena adolescente.
A quattordici anni, era giunto in Italia dal lontano Cile - dove risiedeva - per partecipare alla guerra. Con la sua
possente prestanza fisica, nascose l'età immatura, e ottenne di far parte prima in un reparto territoriale delle
truppe combattenti poi per le sue gesta fu promosso Sottotenente del 7° Alpini (aveva 15 anni) e comandò gli
Arditi del Battaglione Feltre, seguitando ad offrire prove di valore. Promosso Tenente (aveva 16 anni), passò
con il suo reparto in Albania. In seguito ai nuovi atti d'eroismo compiuti, gli fu decretata la medaglia d'oro, mai
tributa prima ad un combattente di così giovane età (ma solo dopo si scoprì la sua vera età).
Poiché, nonostante il proprio valore, i Grigioverdi si trovarono ridotti dal numero degli avversari in grave
pericolo, il Governo vinse le proprie riluttanze e si accinse ad inviare soccorsi.
Ma la rivolta popolare scoppiata ad Ancona (di cui abbiamo già menzionato in altre pagine dell'anno 1920)
impedì la partenza dei Bersaglieri ammutinati, mentre la Sinistra parlamentare levava il grido: "Via
dall'Albania!", "Basta le guerre!"
Si rinnovò la vergogna di Adua. Vittoriosa nel massimo conflitto della storia, per la debolezza dei suoi politici,
per l'aberrazione delle irrazionali folle, l'Italia cedeva senza dignità e senza rivincita alle orde remunerate dal
soldo straniero.
Il 3 agosto 1920 l'Italia sottoscriveva a Tirana l'impegno di sgomberare Vallona, conservando soltanto l'isolotto
di Saseno. In seguito fu ritirato anche il presidio rimasto a Durazzo.
E VENIAMO A FIUME
Durante la discussione svoltasi in seno alla conferenza della Pace per la definizione del trattato da imporre all'
Ungheria, il delegato americano POLK, strenuamente sostenuto da Clemenceau, perorò la cessione di Fiume
alla Jugoslavia. Si oppose con forza, passione e argomentazioni il delegato italiano SCIALOJA, ma mancato
l'accordo, si giunse alla compilazione dell'art. 53 che abbiamo già citato.
La questione fiumana rimaneva aperta. Per risolverla, i delegati italiani e quelli jugoslavi si riunirono il 12
novembre 1920 a villa Spinola, tra Rapallo e Santa Margherita. Le odiose pressioni fatte dalle Potenze
straniere al Governo italiano debole oltre l'immaginabile, indusse l'Italia a sottoscrivere un trattato (da molti
italiani dichiarato indegno, il primo infuriato fu D'Annunzio) per cui l'Italia s'impegnava a sgombrare tutta la
Dalmazia, salvo Zara; a cedere tutte le isole della Dalmazia, tranne Cherso, Lussino, Unie, Sàntego, Lagosta e
Cazza; a riconoscere l'indipendenza (città detta "libera") di Fiume con il suo piccolo territorio.
Lo sgombro della Dalmazia poté avvenire pacificamente perché 1'ammiraglio MILLO - Governatore di quel
territorio dal 12 novembre 1918 - non tenne fede alla promessa, fatta a Gabriele D'Annunzio cui aveva
dichiarato: "Mi no mollo".
Ritirate le truppe Grigioverdi, partite le belle navi giunte all'altra sponda quando all'indomani del 4 novembre
splendeva sull'Adriatico la luce della Vittoria italiana, Traù, Spalato, Sebenico: le belle città, una volta venete,
ancora tradite nella lunga attesa, caddero in potere dei nuovi "padroni".
Non fu così a Fiume.
Fin dal 12 settembre del 1919, la città che gli Alleati intendevano sottomettere al proprio governo - era stata
occupata di sorpresa da Gabriele D'Annunzio e dai Granatieri (ne parleremo ancora nelle pagine dedicate). In
sintesi per non provocare spargimento di sangue, Francesi, Inglesi e Jugoslavi erano stati costretti ad
andarsene, lasciando Fiume al Poeta ed ai suoi Legionari.
Questi animati da un nazionalismo estremo, non intendevano piegarsi all'infamia di Rapallo. Dopo inutili
trattative, il Governo italiano inviò contro Fiume il generale CAVIGLIA le cui truppe, fra il 24 ed il 31 dicembre,
1920 (nel giorno poi definito "Natale di Sangue"), vinta la fiera resistenza dei Legionari, s'impadronivano della
città.
Presidiata dai Grigioverdi, Fiume attese il compimento del suo destino che fu decretato molto molto più tardi.
Era infatti il 25 gennaio 1924, quando giungevano a Palazzo Chigi i ministri Jugoslavi PASIC e UNCIC, invitati da
Benito Mussolini, che il 30 ottobre di due anni prima (nel '22) aveva già assunto il potere. L'accordo presto
concluso riconosceva all'Italia il diritto di annettersi Fiume ed il suo territorio.
Il 17 marzo, sciogliendo il voto secolare, la città ospitava Vittorio Emanuele III giunto a rendere più solenne
con la sua presenza augusta la cerimonia per cui la gemma del Carnaro era congiunta per sempre alla Madre
Patria.
L'articolo 13° del Patto di Londra riconosceva all'Italia -come sappiamo - il diritto di chiedere compensi nel
caso di un'estensione dei possedimenti coloniali francesi ed inglesi in Africa a spese della Germania.
Tale estensione era avvenuta con l'assegnazione dell'Africa Orientale e Occidentale Tedesca alla Gran
Bretagna, del Togo e del Camerun alla Francia.
Mentre i Governi precedenti non erano riusciti a far valere nemmeno quest'altro diritto italiano, Mussolini
faceva presente a Londra l'opportunità di addivenire al definitivo assetto dell'Africa equatoriale mediante la
cessione dell'Oltregiuba promessa quale ben meritato compenso.
Di pieno accordo reciproco, il XXIV maggio 1924, ricorrendo il IX anniversario dell'intervento italiano, la
bandiera britannica fu ammainata a Chisimaio e sostituita dal tricolore.
"Le richieste italiane all'Inghilterra - disse Mussolini -per la cessione del territorio del Giubaland rimontano al
maggio 1919 e da quell'anno in poi, furono proseguite, senza alcun risultato positivo, trattative con il Governo
britannico che incontravano seri ostacoli tanto di ordine politico quanto di ordine tecnico locale, per le
difficoltà di risolvere delicati problemi inerenti sopra tutto alla sistemazione delle popolazioni nomadi delle
regioni poste in prossimità delle nuove frontiere". Il Governo nazionale riuscì felicemente superare gli ostacoli
di ordine politico che avevano fino allora ritardato la conclusione dell'accordo. Una volta chiarita la situazione,
anche le difficoltà di ordine tecnico furono eliminate, giungendo così alla stipulazione di un accordo che
teneva in maggior conto possibile gli interessi delle Altre Parti contraenti e delle popolazioni locali.
Il territorio acquistato all'Italia misurava un'estensione di 91.122 Kmq, abitati da circa 150.000 indigeni, su un
territorio principalmente desertico, anche se lungo i fiumi, si stendono ampie vallate che potevano avere un
avvenire agricolo
Gli accordi preventivi furono definitivamente codificati nella Convenzione di Londra del 15 luglio 1924.
Fu questo l'ultimo documento che contemplava vantaggi territoriali derivati all'Italia per la sua partecipazione
alla grande guerra.
Ma torniamo indietro. Conclusa la pace fra gli Alleati e i singoli Paesi che costituivano la Quadruplice,
permaneva lo stato di Guerra fra la Confederazione Stellata, la Germania, l'Austria, l'Ungheria. Esso cessò in
seguito ai trattati di Vienna, stipulato il 23 agosto 1921; di Berlino, sottoscritto due giorni dopo; e di Budapest.
Gli Stati Uniti si disinteressavano delle variazioni territoriali avvenute, limitando la loro competenza alle
clausole economiche.
Incominciò poi il lavorio lungo e lento delle Commissioni incaricate di tracciare i confini sul terreno. E'
notevole il fatto che la Conferenza degli Ambasciatori, fissando - nel luglio del 1922 - le nuove frontiere fra la
Jugoslavia e l'Albania, non tenne conto alcuno del Montenegro. Il piccolo Regno fu soppresso ed il suo
territorio incorporato nella coalizione quanto mai eterogenea che aveva come capitale Belgrado.
A molti non sembrò nemmeno possibile, che uno Stato europeo si potesse cancellare dalla carta politica del
Continente con un procedimento così tanto sbrigativo e da alcuni ritenuto irregolare.
Così, ogni nuova unità etnico-politico-economica in cui fu diviso il mondo ebbe i suoi termini precisi. Le
occupazioni militari temporanee cessarono, salvo per il bacino della Saar (in sospeso, in attesa della totale
capitolazione della Germania- già sopra ricordata).
Mentre in Oriente fin dal 1919 e poi nel corso del 1920, l'Intesa aveva iniziato a ritirare le proprie truppe della
Manciuria e della Siberia, lasciando la Russia al suo destino.
Rispettivamente il 27 agosto 1919 ed il 2 aprile 1920 giungevano a Torino e a Napoli i reparti Grigioverdi, che
in Murmania e nell'Estremo Oriente avevano portato in quelle lontane contrade la bandiera italiana.
Erano i giorni in cui l'Italia, militarmente, mise definitivamente fine alla Prima Guerra Mondiale.
I Continenti mutarono la propria configurazione politica; gli Stati, i loro confini; i Governi, la propria forma; i
Popoli, le aspirazioni e i convincimenti. La Grande Guerra aveva cambiato il volto dell'Europa, e ne era uscita
una nuova, con piccoli e grandi Stati che faticavano a trovare un proprio equilibrio stabile e s'incepparono
nella faticosa marcia pure quelle che seguitavano a considerarsi Potenze, due in particolar modo, Francia e
Inghilterra.
Tutto questo perché la "costruzione" della nuova Europa (solo minimamente fatta dagli europei) non era stata
perfetta.
Del resto le architetture umane non resistono ai decenni perché o che si fondano sulle sabbie mobili o sulle
chiacchiere dei principi mutevoli, anzi su interpretazioni pratiche dei principi astratti, ancor più che variabili.
Se qualcuno sognò all'inizio di abolire, oppressori e oppressi, o di applicare il principio di nazionalità, creduto
un giusto diritto, questo si è poi dimostrato un mito teoretico, perché i popoli tendono a congiungersi e a
disgiungersi secondo le necessità insoddisfatte dalle ripartizioni etniche. Né le genti si contengono entro
confini definiti, per cui l'appartenenza delle zone unite ma mescolate è causa di altri soprusi e questi
lentamente accendono rancori pieni di pericoli.
La guerra segnò la fine di un'era. Le grandi dinastie dell'Europa centrale ed orientale - i Romanov, gli Asburgo
e Hohenzollern - furono spazzate via. Il conflitto segnò così la fine del dominio dell'Europa sulla scena
mondiale e l'inizio della politica globale. Aprì la strada alla dissoluzione degli imperi coloniali, al trionfo del
comunismo in Russia, e all'ingresso degli Stati Uniti sulla scena mondiale come grande potenza.
Crollarono tre imperi storici, dallo sfacelo nacquero nuovi stati, risorsero vecchie nazioni, ma da un altro
punto di vista tutti i belligeranti europei nell'incapacità di mettersi d'accordo, uscirono dal conflitto tutti
sconfitti, in quanto la guerra segnò - se non la causò direttamente - uno spostamento della potenza
internazionale dall'Europa all'America da un lato, alla Russia sovietica dall'altro. Per rimanere da questo
momento in avanti (i 2 blocchi) padroni assoluti dell'Europa. Quanto alla seconda guerra mondiale, questa fu
null'altro che la prosecuzione della prima; e che rafforzarono ancora di più i due blocchi.
Retorici, poeti, romanzieri, o semplici giornalisti dalle colonne dei loro giornali, dissero a fine guerra che gli
eroi non erano caduti invano, che l'umanità si era inebriata di luce raggiante dell'avvenire e che il futuro
sarebbe stato migliore. Purtroppo l'attesa di questo futuro sereno tardava a venire, anzi all'orizzonte di questa
nuova alba già si stavano formando nubi minacciose.
A vedere certi sguardi dei "biscazzieri" di Versailles, a loro importava poco il tanto sangue versato, il mare di
lacrime di tanti pianti, quello che interessava era una catalogazione di crediti, il possesso di un bacino
minerario, una serie di privilegi doganali, una flotta marina o aerea. E ogni cosa aveva un costo.
Uno di loro, SHUTS delle Nazioni Unite, a Wersailles, fece un'amara constatazione "l'intera Europa, oggi, sta
per essere liquidata per 2 miliardi di sterline". Insomma l'Europa era stata messa in vendita.
Ed anche Sir GEORGE (inglese) fece il suo commento: "Ho la sensazione crescente che gli USA si stiano
comportando da prepotenti".
E fu profeta quando scrisse: "Non riesco ad immaginare più grave motivo di una guerra futura se non il fatto
che il popolo tedesco, che si è dimostrato uno dei più forti e potenti del mondo, possa trovarsi circondato da
tanti piccoli stati formati per lo più da popoli che non abbiano mai avuto prima un governo stabile, ma che
comprendono un gran numero di tedeschi desiderosi di riunirsi con la madre patria" ( Lloyd George, "The Truth
About the Peace Treaties", Vol I, p.622").
Mentre lo diceva un arrabbiato caporale austro-tedesco, stava già maledicendo la mano di chi aveva firmato la
pace, ed entrava nel Partito Arbeitpartei; il caporale era Adolf Hitler, e con lui nei primi iscritti il generale
Lundendoff, il decorato Hermann Goring, i fratelli socialisti Otto e Gregor Strasse, Alfred Rosemberg, Rudolf
Hesse, Julius Streicher, l'anno dopo Joseph Goebbels. Vogliono loro risolvere i problemi della Germania.
IL PESANTE "CLIMA" POLITICO IN ITALIA
Nel frattempo anche in Italia erano iniziati altri più gravosi e complessi problemi di carattere politico,
economico, di ordine pubblico e, soprattutto, di carattere sociale. Tutto era diventato vecchio, la classe
politica, l'Italia liberale, la borghesia, e dopo quattro anni o di trincea o di sacrifici, erano diventati "vecchi"
anche gli italiani; e perfino quelle ventate di sano socialismo dei primi anni del secolo erano diventate
antiquate, o almeno per gli italiani che al fronte si erano ormai emancipati, acculturati, e molti avevano
imparato perfino a leggere o a udire cos'era il sindacalismo, i partiti e di conseguenza anche "a credere alle
utopie" (lo dirà Nenni, più avanti).
Il Paese, finita la guerra, per tutta una serie di questi motivi, non era solo inquieto, ma per molte altre ragioni,
pur sempre legate a quelli; era nel disordine e stava vivendo un clima quasi insurrezionale, facendo così
sperare ad una compagine politica la "Rivoluzione del proletariato", e ad un'altra una "Rivoluzione dei borghesi
o piccolo-borghesi ", o come si iniziò a dire della "classe media" o "ceto medio emergente", cioè piccoli
borghesi aggressivi, che pure loro in trincea avevano imparato qualcosa: a reagire aggredendo. E li avevano
pure premiati.
Noi dobbiamo ora appunto ritornare al 23 giugno 1919, cioè all'esordio del Gabinetto NITTI e seguire i lavori di
questo primo governo di pace, che però preannunziava guerra e ben altre battaglie.
LA QUESTIONE DI FIUME
1919 - Concluso il 1° Conflitto mondiale, il progetto del trattato di pace prevedeva il
passaggio della città istriana alla Jugoslavia.
Il Poeta-Soldato dalle smanie eroiche la occupò con un centinaio di legionari improvvisati.
Provocando un pasticcio politico-diplomatico a livello internazionale
di PAOLO DEOTTO
La vicenda di Fiume italiana, dal colpo di mano di D'Annunzio del 12 settembre 1919 fino al Natale di sangue
dell'anno successivo (quando i legionari dannunziani vennero sloggiati dalle truppe regolari italiane) occupa in
genere nei testi di storia poche e frettolose righe.
Certo, è facile obiettare che in quegli anni, gli anni della delusione e del disordine del dopoguerra, l'Italia era
immersa in problemi enormi, guidata da una classe politica vecchia ed inetta, che avrebbe spianato la strada
al fascismo. Ed è vero che la vicenda di Fiume, creatura e al tempo stesso vittima dello straripante
protagonismo di D'Annunzio, non contribuì in sé stessa a mutare il corso degli avvenimenti nazionali,
procurando semmai qualche guaio in più ed aumentando una confusione che già era ben sopra i livelli di
guardia.
Ma se invece leggiamo la vicenda di Fiume sotto un'altra ottica ci accorgiamo di come essa sia, al di là delle
sue limitate dimensioni, di estremo interesse per comprendere meglio l'Italia di allora e in genere il Vecchio
Mondo, immersi in una serie di problemi che la Grande Guerra aveva solo rimandato e in buona parte
aggravato.
L'avventura di Fiume non sarebbe esistita senza D'Annunzio, ma D'Annunzio non avrebbe potuto
intraprenderla se non avesse avuto da cavalcare un clima spirituale, sociale, politico che la rese possibile.
Gabriele D'Annunzio, pescarese, classe 1863, allo scoppio della Grande Guerra aveva già dato il meglio di sé
come poeta, scrittore, drammaturgo.
Il suo nome era famoso anche fuori Italia, non solo come letterato, ma anche come tombeur de femmes e
come produttore instancabile di debiti: un lungo soggiorno in Francia (durante il quale compose opere in
italiano e in francese, una delle quali, Canzoni delle gesta d'oltremare, in celebrazione della guerra libica) fu
una fuga da un numero eccessivo di creditori, che ottennero dal Tribunale il sequestro della villa che il poeta
possedeva a Settignano e la vendita all'asta della mobilia.
Nel conflitto tra interventisti e neutralisti, D'Annunzio si schiera senza esitazioni coi primi e durante la Grande
Guerra (riuscì ad arruolarsi nonostante fosse ormai ultracinquantenne), diventa protagonista di imprese
clamorose per mare (la beffa di Buccari) come nel cielo, col clamoroso volo su Vienna. Perde un occhio in
battaglia e alla fine delle ostilità è ormai una gloria nazionale indiscutibile, il poeta-soldato, Medaglia d'Oro,
modello di vita oltre che di arte, messaggero di vita inimitabile. In pace come in guerra, nell'alcova come nei
rapporti finanziari, ha sempre vissuto in modo unico, ha sempre cercato i gesti e gli atteggiamenti che lo
distinguessero, come da giovane deputato poco più che trentenne, quando passò con irruenza da un'estrema
all'altra dello schieramento politico, senza peraltro mai aver espresso una linea politica definita. La sua arte è
indiscutibile come il suo ingegno; ma anch'egli è un uomo, e anch'egli ha contratto in guerra una malattia
molto diffusa: quello strano morbo per cui si diventa reduci, con tutte le conseguenze che questo comporta.
Fiume, affacciata sul golfo omonimo nell'Adriatico settentrionale, era una delle più floride città dell'impero
austro - ungarico.
Centro principale del sistema ferroviario che serviva Praga, Budapest, Belgrado e Zagabria, costituiva lo sbocco
naturale del commercio che si svolgeva tra queste città e l'Occidente. Attualmente Fiume fa parte del
territorio della Croazia, ma dal XVIII secolo la città era sotto controllo ungherese, e prese così a sviluppare una
certa indipendenza, data la lontananza dei governatori ungheresi. Peraltro il conflitto tra croati e magiari per il
predominio fu la costante di Fiume; i suoi abitanti, forti anche della costituzione in porto franco della città,
decisa nel 1717 dall'imperatore Carlo VI, si adoperarono per ottenere un proprio stato giuridico speciale.
Alla fine del secolo XVIII l'imperatrice Maria Teresa concedeva a Fiume lo status speciale di corpus separatum.
La particolare posizione geografica e lo speciale stato giuridico favorirono lo sviluppo di Fiume non solo come
centro commerciale, ma pure come città cosmopolita, grazie anche al blando controllo esercitato dalle
autorità ungheresi, che non volevano imporsi ai fiumani, preferendo sfruttarne la crescente prosperità
finanziaria. Da parte croata invece era costante il tentativo di integrare Fiume nelle tradizioni slave, con
l'intenzione palese di annettere la città alla nazione croata. L'accesa rivalità tra i due gruppi indusse gli
ungheresi, nella seconda metà del XIX secolo, ad iniziare un'intensa propaganda per attirare nella città gli
uomini d'affari italiani, con lo scopo di procurarsi alleati occidentali e di costituire una forte borghesia che si
sarebbe impegnata nella difesa di Fiume contro gli slavi.
La comunità italiana di Fiume crebbe rapidamente, divenendo ben presto il gruppo più importante e vivace,
costituito fondamentalmente da ricca borghesia, opposta ad una classe lavoratrice composta per lo più da
croati e aggiungendo così un antagonismo di classe alle tradizionali tensioni politiche ed etniche tra i due
gruppi originari. L'alleanza italo - ungherese (che aveva il controllo del municipio) in funzione anti-croata andò
però via via deteriorandosi col manifestarsi delle tendenze scioviniste in seno alla comunità italiana. Quando
l'impero austro - ungarico si decompose alla fine della Grande Guerra e la città venne occupata dalle truppe
iugoslave, gli irredentisti insorsero, accampando il fatto che Fiume era un centro etnicamente italiano.
In realtà, su 50.000 abitanti, erano di lingua italiana circa la metà; ma costituivano la parte più attiva e infatti
istituirono subito un Consiglio Nazionale, che all'indomani di Vittorio Veneto proclamò l'annessione all'Italia,
inviando emissari a Roma, dal primo ministro Orlando, per perorare la causa. Fiume non faceva parte del
pacchetto delle rivendicazioni italiane presentate a Londra nel 1915, e accettate dagli alleati, quando l'Italia
decise l'entrata in guerra contro gli imperi centrali.
Il pacchetto prevedeva l'assegnazione all'Italia del Trentino fino al Brennero, di Trieste e le Alpi Giulie, di tutta
l'Istria, di quasi tutta la Dalmazia, Valona e il suo entroterra albanese e il Dodecanneso.
A Fiume nessuno aveva pensato, anche perché la comunità italiana di quella città aveva ben pochi legami con
la madrepatria; ma l'occupazione della città da parte delle truppe slave, con tutta la minaccia di integrazione
forzata che questo comportava, aveva indotto gli italiani di Fiume a formulare l'appello, di cui dicevamo sopra,
al primo ministro Orlando.
Fiume si faceva forte del suo antico stato giuridico speciale e reclamava il proprio diritto alla
autodeterminazione. Resta un dato di fatto inconfutabile, e cioè che la maggioranza, seppur risicata, di Fiume
città era etnicamente italiana (Al censimento del 1910, su 50.000 abitanti in Fiume città, 24.000 erano italiani,
15.000 croati e il resto di altre nazionalità, con una predominanza di quella ungherese). Ma è altrettanto vero
che se il sobborgo croato di Sussak (di fatto il quartiere operaio di Fiume), dove vivevano circa 15.000
persone, fosse stato considerato parte integrante del territorio municipale, la maggioranza sarebbe stata dei
croati, contando questi ultimi, come abbiamo visto, altri 15.000 abitanti tra i 50.000 che costituivano la
popolazione di Fiume città.
Orlando e il suo ministro degli esteri, Sonnino, ricevettero l'appello del Consiglio Nazionale di Fiume in un
momento delicato: la conferenza della pace di Versailles doveva fare i conti con l'intransigenza del presidente
americano Wilson, che non accettava le clausole del Patto di Londra (al quale non aveva partecipato). Wilson
riconosceva il diritto dell'Italia al Brennero come sua "frontiera naturale", ma non ammetteva che un milione
di slavi della Dalmazia fossero trasferiti "come un gregge" entro i confini italiani; infine il presidente americano
considerava Fiume più necessaria alla neonata Iugoslavia che all'Italia. Mestiere dei diplomatici è trattare, e le
conferenze si fanno proprio per trovare un accordo tra posizioni diverse.
Ma Sonnino ed Orlando si sentivano pressati da un'opinione pubblica che dava segni di pericolosa agitazione:
l'Italia di Vittorio Veneto, sbolliti gli entusiasmi per la vittoria, fatti i tristi conti delle perdite (600.000 morti ed
oltre mezzo milione di mutilati), con un costo della vita quadruplicato e un disavanzo salito a 23 miliardi (del
1919!) tuonava contro la vittoria mutilata imposta dal presidente americano. Come sempre nella Storia,
tuonava una minoranza, ma era una minoranza forte e aggressiva, composta principalmente dai reduci (molti
dei quali riuniti nei Fasci di Combattimento fondati da Mussolini) che, dopo anni di sacrifici e di sangue,
reclamavano il diritto di intervenire nelle decisioni; e la voce più illustre che guidava questa protesta era
quella del poeta - soldato.
E come sempre, una protesta sui problemi meno immediati ma più carichi di tensione emotiva aiutava a
dimenticare l'incombenza di altri problemi più seri, primo tra i quali la crisi che gravava sulle industrie,
patologicamente gonfiate dai consumi di guerra, e che avrebbe causato un aumento vertiginoso dei
disoccupati. Orlando, suggestionato da questo clima e preoccupato che potessero nascere moti insurrezionali,
anziché cercare un compromesso, restò fermo nelle pretese sulla Dalmazia ed aggiunse la richiesta di
annessione di Fiume all'Italia, ordinando anche, in risposta all'appello del Consiglio Nazionale, lo sbarco di
alcuni reparti militari a Fiume.
A Versailles le discussioni diventarono così dei testa - testa senza vie d'uscita, mentre a Fiume la situazione si
faceva esplosiva, col rischio di scontri tra le truppe italiane e quelle iugoslave, e del riesplodere dei conflitti
etnici, tanto che si decise l'intervento delle altre Potenze, ponendo la città sotto il controllo di una guarnigione
militare interalleata, ma al comando del generale italiano Grazioli.
Intanto Wilson, con delicatezza tutta americana, faceva appello direttamente al popolo italiano, invitandolo
alla moderazione e al rispetto dei diritti delle altre nazionalità. Di fronte a questa palese scorrettezza Orlando
e Sonnino, dimentichi del fatto che in politica gli assenti hanno sempre torto, abbandonarono per protesta la
Conferenza, tornando però precipitosamente il 5 maggio, quando si resero conto che gli alleati andavano
avanti anche senza di loro e stavano spartendosi i resti delle colonie tedesche in Africa, di cui l'Italia riuscì a
raccogliere gli spiccioli.
Umiliato e scoraggiato Orlando tornò a Roma e il 19 giugno (siamo nel 1919) una Camera ostile lo sfiduciò a
larga maggioranza. Il suo successore, Francesco Saverio Nitti si trovò così tra le mani la patata bollente di
Fiume, la cui situazione strideva col proposito espresso dal neo primo ministro di trarre l'Italia dalle sabbie
mobili in cui si era ficcata a Versailles con le impennate di orgoglio e di puntiglio. E prima di passare alla
cronaca dell'impresa dannunziana di Fiume, cerchiamo di fare un attimo il punto sulla situazione nazionale al
momento dello scambio di consegne tra Orlando e Nitti.
L'Italia viveva un momento delicatissimo perché alla crisi economica causata dal conflitto si sommava la crisi
(ben più grave) delle coscienze, strascico inevitabile di tutte le guerre. Parlando di D'Annunzio sottolineavamo
come anche lui fosse un reduce; e, con tutto il rispetto per chi in guerra soffrì, il reducismo è una malattia
grave, e i fatti lo dimostrano. Anni di guerra impediscono a molti di ritrovare la dimensione della pace, di
accettare la fatica di affrontare i problemi con calma e ponderatezza; l'abitudine alla violenza, vissuta per anni
come norma quotidiana e come risolutrice del problema bellico immediato (la distruzione del nemico), è dura
da perdere. Non a caso i più violenti nella violenza generalizzata della guerra, gli Arditi, costituirono il più
cospicuo serbatoio di uomini sia per le squadre fasciste che per le legioni di D'Annunzio.
A ciò si aggiunga quel clima di sbandamento culturale che l'Europa viveva dall'inizio del secolo; i messaggi
futuristi di Marinetti, con l'esaltazione dell'azione fine a sé stessa, con la proclamazione della bellezza della
guerra trovavano facile presa soprattutto tra i giovani, che vivevano indubbiamente un momento di
smarrimento, perché il XX secolo, nella sua ansia di creare nuovi valori, nella sua sconfinata fiducia nel
progresso, aveva in verità creato un grande vuoto. E contro la paura, contro lo smarrimento, è bello essere in
tanti, essere pieni di energia, vivere la vita come una sfida continua.
Fa impressione, leggendo le opere di D'Annunzio, la contrapposizione tra un'eleganza formale squisita unita a
una capacità unica di costruire il linguaggio e l'assoluta mancanza di veri contenuti e valori, salvo che si
vogliano considerare come tali l'esaltazione della vita eroica, la concezione dell'uomo superiore capace di
cogliere una sorta di completezza di sensazioni, anche e soprattutto esasperate, che siano di godimento o di
dolore, di dominio o di sacrificio.
Tutto ciò pare, a nostro avviso, piuttosto come espressione di un qualcosa che ci sentiremmo di definire
onanismo intellettuale assurto a modello letterario.
D'Annunzio, come dicevamo, tuonava sulle piazze contro la vittoria mutilata e intanto gli avvenimenti a Fiume
precipitavano. Il 6 luglio 1919, in uno dei tanti scontri che a Fiume si verificavano tra irredentisti e truppe
alleate, nove soldati francesi vennero linciati e Nitti si trovò costretto ad accettare una commissione
d'inchiesta che, dopo le indagini, chiese lo scioglimento del Consiglio Nazionale, l'allontanamento del generale
Grazioli e la costituzione di un corpo di polizia alleata sotto controllo inglese. Host Venturi, capitano degli
Arditi, capo delle organizzazioni irredentiste dell'Istria e della Dalmazia, mobilitò la legione fiumana, un corpo
paramilitare, e inviò un messaggio a D'Annunzio, invitandolo ad assumere il patronato della causa di Fiume
italiana.
Host Venturi sfondava una porta aperta, perché D'Annunzio era chiaramente bramoso di azione; del resto
l'idea di un'azione armata per liberare Fiume, cacciandone le truppe alleate e costringendo il governo italiano
a dichiarare l'annessione della città all'Italia serpeggiava già da mesi, ma non aveva ancora preso corpo e
soprattutto mancava di un Capo. La scelta di Host Venturi fu, come dimostreranno gli avvenimenti, felice,
perché la popolarità del poeta soldato era tale da poter fare da catalizzatore delle forze più disparate, come
infatti avvenne.
Dicevamo in apertura che la vicenda di Fiume ci aiuta a capire meglio il clima in cui viveva il paese in quel
travagliato dopoguerra. Il primo dato che salta all'occhio è indubbiamente l'assenza, di fatto, di un'autorità. E'
vero che esisteva un governo, presieduto da Nitti. E' vero che questo governo poteva contare sulle forze
dell'ordine e che tardava anche a smobilitare l'esercito, mantenendo in servizio trecentomila uomini oltre al
normale personale di leva. In teoria il governo era fortissimo, in pratica non sapeva quanto e come quella
massa di armati potesse essere affidabile o diventare un boomerang.
Mentre l'Italia era già teatro degli scontri tra squadre fasciste e socialisti (che a loro volta costituirono le
squadre di Arditi del Popolo), gli uomini di punta dell'irredentismo fiumano (Giovanni Giuriati, presidente
dell'associazione Trento-Trieste, Oscar Sinigaglia, Eugenio Coselschi, oltre al già citato Host Venturi) potevano
tranquillamente fare pubblica propaganda per l'arruolamento nella Legione Fiumana, in ciò coadiuvati anche
dai Fasci di combattimento, iniziando il concentramento di uomini a Trieste e comunicando con la massima
naturalezza a Badoglio, sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, l'intenzione di prendere Fiume con un colpo
di forza. Una volta tanto l'esercito però non aderì a un programma nazionalista, e Badoglio ordinò alle truppe
poste alla frontiera fiumana di aumentare la sorveglianza.
Ma di lì a poco si sarebbe visto quanto quegli ordini venissero presi alla lettera. Il precipitare degli eventi in
seguito agli episodi sanguinosi del 6 luglio 1919 non fece quindi che dare l'ultimo colpo di acceleratore ad un
processo già in corso. Il 12 settembre 1919 D'Annunzio era a Ronchi, una cittadina a pochi chilometri da
Trieste, con un seguito di poche centinaia di uomini; ma ad essi si unirono i legionari di Venturi e buona parte
dei Granatieri di Sardegna, che avevano da pochi giorni smobilitato da Fiume per decisione della commissione
d'inchiesta. Sulla strada per Fiume si aggiunsero gli Arditi del generale Zoppi e una compagnia di fanteria. Alle
porte della città contesa gli uomini al seguito di D'Annunzio erano oltre duemila, tra granatieri, arditi e fanti. Il
generale Pittaluga, successore del generale Grazioli, avrebbe dovuto obbedire agli ordini del suo superiore
Badoglio e fermare con le armi questo esercito privato, formato, aldilà del rispetto per i motivi ideali che
animarono molti, da disertori e comandato da un uomo che palesemente si poneva in rotta col governo.
Ma al gesto teatrale di D'Annunzio, che aprì il pastrano mostrando la medaglia d'oro e proclamando "Lei non
ha che a far tirare su di me, Generale!", Pittaluga rispose abbracciando il poeta ed entrando con lui in Fiume,
dove nel frattempo il Consiglio Nazionale aveva preparato una manifestazione che vide in strada, ad
acclamare i liberatori, praticamente tutta la parte italiana della città. Nitti a Roma dovette accorgersi
finalmente dell'affidabilità delle forze armate; ma il proposito immediato, ossia schiacciare con la forza la
sedizione, non si realizzava non solo perché non era ben chiaro quale forza avrebbe obbedito, ma anche
perché il golpe fiumano suscitò nel paese anche le simpatie delle masse popolari che, guidate da un partito
socialista tanto barricadiero quanto inconcludente, vedevano in quel gesto di forza, seguito da entusiastiche
manifestazioni, il prodromo della rivoluzione proletaria.
Questa imprevista collusione fra nazionalisti e sinistre non fu che il primo degli elementi di confusione causati
dalla vicenda di Fiume, che a sua volta visse l'anno di governo dannunziano in una confusione quasi eretta a
modello esistenziale. D'Annunzio non aveva mai avuto una collocazione politica precisa, o meglio, gli si poteva
attribuire qualsiasi collocazione, perché la politica, intesa come progetto di una società, e quindi fondata su
basi teoriche economiche e sociali, ma capace anche di modulare queste basi teoriche sugli sviluppi storici, la
politica, dicevamo, esulava dai suoi interessi. Da subito Fiume registrò il primo fallimento politico, perché
D'Annunzio era convinto che la sua marcia avrebbe messo in crisi il Governo presieduto dall'odiato e
rinunciatario Nitti, da lui ribattezzato Cagoia. Ma Nitti, dopo un tempestoso dibattito alla Camera, ottenne
ancora la fiducia e subito dopo indisse nuove elezioni, fissandole per il mese di novembre. Le truppe alleate
(inglesi, francesi e americane) presenti a Fiume smobilitarono nell'arco di una settimana; i rispettivi governi
erano ben contenti di lasciare in mano al governo italiano la patata bollente, e D'Annunzio ne trasse il
vantaggio di trovarsi a disposizione i magazzini colmi di rifornimenti e scorte.
Nitti inviò alla frontiera di Fiume il generale Badoglio, che assunse direttamente il comando delle truppe
lealiste e che non mancò di far notare al governo tutte le difficoltà insite in un'azione armata, visto che si
poteva contare poco sulla lealtà dei lealisti: le defezioni a favore di D'Annunzio erano frequenti, tant'è che fin
dai primi giorni dell'occupazione di Fiume il poeta si trovò a dover rifiutare l'arrivo di ulteriori volontari (o
disertori, questione di punti di vista), perché "non sapeva più dove alloggiarli".
Se l'esercito era in queste condizioni, la Marina non stava meglio, e se ne accorse l'ammiraglio Casanuova che,
recatosi a Fiume con l'ordine di Nitti di far salpare le navi italiane, semplicemente non poté eseguire l'ordine,
perché le navi erano vigilate dagli Arditi, ma anche gli equipaggi manifestavano l'intenzione di restare a Fiume,
agli ordini di D'Annunzio.
C'era insomma il serio rischio di un contagio a tutte le forze armate, e Nitti scelse una tattica attendista,
attuando su Fiume un blocco dei rifornimenti, peraltro molto elastico e cercando di fomentare all'interno
della città una divisione tra il Consiglio Nazionale e Il Comandante, come ormai era da tutti definito
D'Annunzio.
Se volessimo qui riferire tutta l'attività frenetica di D'Annunzio nei quattordici mesi dell'avventura fiumana,
dovremmo chiedere al direttore un centinaio di pagine in più.
Piuttosto consigliamo agli amici lettori che vogliano approfondire l'argomento due libri che citiamo in
bibliografia, quello di Ledeen e quello di Gerra. Seppur quest'ultimo sia quasi fastidiosamente apologetico, è
tuttavia ricco di dati e documenti di grande interesse. Piuttosto ci interessa notare come da subito l'incapacità
non solo politica ma anche pratica di D'Annunzio si palesò nei primi contrasti con il Consiglio Nazionale.
Passati infatti i primi giorni di entusiasmo, Fiume si trovava di fronte ai problemi concreti di una città
sottoposta ad un blocco; con un passaggio di poteri alquanto fumoso, al Comandante era stato attribuito il
diritto di veto sulle decisioni del Consiglio; ma di fatto era quest'ultimo a doversi sobbarcare tutte le questioni
pratiche, perché D'Annunzio era piuttosto preoccupato di creare quel clima che avrebbe dovuto fare di Fiume,
città-olocausto, il faro di una ripresa nazionale all'insegna di valori in verità non bene precisati, ma che
avevano come denominatore comune l'azione bella ed eroica. Il poeta presentava sé stesso e i suoi seguaci
come i rappresentanti della vera Italia, incarnazione di una forza spirituale superiore, e i suoi soldati come i
genuini rappresentanti delle forze armate, quelli che non avevano mai smobilitato, e che non accettavano
nessuna mutilazione della Patria.
In questo senso da subito D'Annunzio espresse il rifiuto a qualsiasi negoziato con Cagoia: l'unica cosa che il
governo italiano poteva fare per riscattarsi era dichiarare l'annessione di Fiume. Su questi toni e con questi
temi erano le adunate di popolo, praticamente quotidiane, che furono in pratica l'unica forma di governo
esercitata da D'Annunzio. Il popolo, guidato dal poeta, detentore dell'ideale e della bellezza, diveniva al tempo
stesso protagonista e strumento degli eventi. E mentre il Consiglio Nazionale cercava una via d'uscita
trattando di fatto con Nitti per il tramite di Badoglio, le quotidiane orazioni del poeta incitavano il popolo a
non cedere, a voler tutto, nella convinzione che una santa causa non possa perdere se non per l'ignavia degli
uomini. E' significativo, per capire lo stile che D'Annunzio aveva verso le cose pratiche della vita, l'appoggio
che egli diede ad uno dei suoi più scatenati seguaci, Guido Keller. Questi aveva organizzato un ufficio colpi di
mano, la cui sezione marittima altro non faceva che atti di pirateria, catturando navi mercantili e portandone i
carichi a Fiume.
E naturalmente ad ogni cattura seguiva un discorso pubblico del Comandante, che lodava i suoi "belli
uscocchi, (i pirati medievali dell'Adriatico - N. d. A.), dai volti freschi e puliti come il sole di Vittorio Veneto". In
questo clima, con le giornate impegnate in adunanze di piazza e le notti in feste collettive, si realizzava quello
che sarebbe stato poi l'inganno costante della politica dei paesi totalitari: l'illusione della partecipazione,
l'utilizzo del popolo come cassa di risonanza di decisioni già prese dal vertice, scavalcando quegli organi
rappresentativi che sono alla base di ogni vera democrazia. In D'Annunzio non c'era di certo un intento
studiato di potere: il popolo era per lui piuttosto la platea necessaria, Fiume era il laboratorio dove tutto era
possibile, purché incanalato nelle concezioni estetiche del poeta.
Non a caso a Fiume conversero nazionalisti, che furono comunque i primi protagonisti dell'impresa, ma in
seguito anche anarchici e sindacalisti. La Costituzione di Fiume, tanto avanzata quanto irrealistica per l'epoca
e che comunque non trovò mai pratica attuazione, fu scritta a quattro mani con quell'Alceste De Ambris,
eminente anarco-sindacalista, i cui precedenti politici nulla avrebbero avuto da spartire coi motivi che
spinsero i primi legionari a marciare sulla città. Se D'Annunzio non inseguiva progetti di potere, inteso almeno
nel senso tradizionale del termine, c'era nel paese un altro uomo che invece sapeva far politica e che
inseguiva progetti di potere, inteso nel senso più assoluto del termine. I rapporti tra D'Annunzio e Mussolini
non furono mai cordiali, perché il futuro Duce, che in quegli anni iniziava la sua scalata, ma si rendeva conto
del fatto che il movimento fascista era ancora troppo debole per un'azione di forza, mantenne sempre un
atteggiamento di fatto prudente nei confronti dell'impresa fiumana, anche se abbiamo visto che i Fasci di
combattimento parteciparono agli arruolamenti nella Legione fiumana; ma non scordiamoci che all'epoca i
Fasci erano ancora una serie di organismi abbastanza autonomi, e uno dei problemi di Mussolini era proprio
quello di dare un'unitarietà di direzione al neonato movimento fascista.
Mussolini vedeva l'approssimazione politica di D'Annunzio, di cui pur subiva il fascino, e concretamente, aldilà
di accesi articoli, anch'egli stava a vedere cosa sarebbe successo, per decidere se e su quale cavallo saltare,
tanto da provocare una violenta lettera di D'Annunzio che gli ingiungeva di "svegliarsi, o lo farò io quando avrò
consolidato qui il mio potere..."
Mussolini rispose indicendo, sul Popolo d'Italia, una sottoscrizione pubblica a favore di Fiume; raccolse una
cifra considerevole, sopra il milione, e subito iniziarono le voci sulle strade che di preciso presero quei soldi.
Nitti nel frattempo era chiaramente in crisi; le elezioni da lui stesso volute avevano cambiato il panorama
politico alla Camera, con una maggioranza relativa ai socialisti, una forte componente dei popolari di Don
Sturzo e circa la metà dei seggi frazionati in un pulviscolo di liberali, radicali, democratici, repubblicani,
eccetera. Il rifiuto dei socialisti di partecipare al governo obbligò Nitti ad una precaria alleanza coi popolari e
coi gruppuscoli, in una situazione di instabilità permanente, aggravata da una piazza tenuta in continua
ebollizione dalle sinistre, col solo risultato di rinforzare i ranghi delle squadre fasciste.
Nel giugno del 1920 tornò al potere Giovanni Giolitti, appoggiato anche dai nazionalisti e da Mussolini, che
vedevano in lui l'unico uomo in grado di far uscire il paese dal caos.
E Giolitti fu l'uomo che seppe liquidare Fiume; ma si assicurò l'appoggio di Mussolini, pronto a scaricare il
poeta ora che l'avventura fiumana, non avendo di fatto risolto nulla, stava per ripiegarsi su sé stessa.
Mentre in Italia accadevano queste cose, D'Annunzio vedeva crescere il suo isolamento in una città ormai
stanca del clima sagraiolo e afflitta dai seri problemi di un'economia dissestata. Una spedizione a Zara,
insieme a tanto numerosi quanto fumosi progetti di esportare il modello fiumano non solo nel resto dell'Italia,
ma addirittura nel mondo, "a difesa di tutti i popoli oppressi" non erano che ulteriori espressioni di
un'esperienza che non aveva prodotto nulla di concreto ma non sapeva rassegnarsi a fare qualcosa di
concreto.
Mentre personaggi come Riccardo Zanella, capo del partito autonomista, premevano per una soluzione
negoziale col governo, e mentre a Versailles gli alleati decidevano che Italia e Iugoslavia risolvessero
direttamente le reciproche questioni, D'Annunzio restava fermo nell'accettare solo ed unicamente
l'annessione all'Italia del territorio di Fiume. L'ultimo atto politico rilevante del poeta fu la costituzione della
Reggenza, a significare che il potere veniva comunque esercitato in nome del Re d'Italia. Ma intanto gli
avvenimenti superavano i sogni: col trattato di Rapallo Giolitti ottenne la fissazione del confine lungo la linea
di displuvio alpina, più un'esile striscia di territorio per collegarla a Fiume, che però sarebbe rimasta città
libera.
L'Italia rinunciava alla Dalmazia, con l'eccezione di Zara. Non era l'annessione, ma comunque Fiume veniva
sottratta alle pretese slave. A questo punto nulla più poteva giustificare che il governo tollerasse la presenza a
Fiume dei legionari e di D'Annunzio. Quest'ultimo, visto che anche i suoi consiglieri più intimi lo spingevano ad
accettare il trattato di Rapallo, si chiuse sempre più in sé stesso, lanciando accuse di tradimento, convinto tra
l'altro che l'Italia non avrebbe mai osato attaccare Fiume.
Nel Natale del 1920 le truppe regolari entrarono in Fiume, dopo che una cannonata, sparata da una corazzata,
aveva colpito la stessa residenza del Comandante.
Dopo il "Natale di sangue" i legionari, che avevano perso una cinquantina di uomini, abbandonarono Fiume
indisturbati; D'Annunzio si trattenne ancora per poche settimane e poi se ne andò, indisturbato anche lui.
Mussolini dalle colonne del Popolo deprecò "l'atto fratricida", ma sostenne anche che il trattato di Rapallo era
l'unica soluzione possibile, e che il merito di aver sottratto Fiume alle mire slave andava comunque al poeta e
ai suoi valorosi.
Il futuro Duce teneva fede ai patti stipulati con Giolitti e se il Fascismo al potere avrebbe poi esaltato la figura
del poeta soldato (che nel 1925 ricevette il titolo di Principe di Monte Nevoso e nel 37 la presidenza
dell'Accademia d'Italia), è curioso notare come nei testi storici scritti in periodo fascista sull'impresa fiumana si
glissi molto velocemente.
Si è detto spesso che D'Annunzio fu l'ispiratore di Mussolini; è un giudizio grossolano, non foss'altro perché
entrambi i personaggi non avevano una linea politica.
Il Poeta perché non gli interessava, il Duce perché la sua politica fu sempre e solo quella brutale e realistica
della conquista, prima, e della conservazione, poi, del potere.
Mussolini era del tutto lontano dagli svolazzi dannunziani e, come vedevamo, seguì l'avventura fiumana solo
per saggiarne la consistenza e valutarne l'eventuale utilità. Ma di sicuro D'Annunzio gettò un seme pericoloso
con un metodo, che per lui fu patologico bisogno di platea, ma per altri fu uno strumento di potere.
Ci riferiamo allo stile delle adunate oceaniche, della folla che si riconosce nel Capo, della fusione delle
coscienze verso un fine ideale comune. E', a ben guardare, il massacro del contraddittorio, ossia di una delle
garanzie fondamentali di libertà.
Le formazioni volontarie dalmate nel primo dopoguerra
di Orazio Ferrara
Quando dopo la prima guerra mondiale scoppiò la “questione fiumana”, artefice il poeta-soldato Gabriele
D’Annunzio, la maggioranza degli italiani si accorse con stupore che, all’interno di essa, ne esisteva un’altra
ancora più intricata e spinosa, quella dalmata. Capofila dell’irredentismo dalmata era la città di Zara, da
sempre all’ombra del leone alato di San Marco. In quei mesi di travolgente passione nazionalista, Zara
rappresentò per la Dalmazia quello che Fiume fu per l’Istria.
Il 4 novembre 1918 la regia torpediniera 55 AS, comandata dal capitano di corvetta De Boccard, attraccò a
Zara e ne prese possesso in nome dell’Italia. Per la popolazione in delirio sembrava che il più fosse fatto. Ma
non era così. I nostri vecchi alleati la pensavano diversamente e consideravano il Patto di Londra, che in caso
di vittoria prevedeva l’assegnazione dell’Istria e della Dalmazia all’Italia, una cosa del tutto superata dagli
eventi.
Quando il 18 gennaio 1919 iniziò in Francia, a Versailles, la conferenza di pace, si capì subito che l’americano
presidente Wilson parteggiava spudoratamente per gli slavi, a tutto danno delle nostre legittime
rivendicazioni. Wilson era appoggiato in questo suo odioso comportamento dalla diplomazia francese,
invidiosa che l’Italia assurgesse al rango di grande potenza, e da quella inglese, che non le pareva vero farci
impelagare in quella querelle e distrarci così dalla spartizione delle ex colonie tedesche in Africa, come poi
effettivamente accadde senza di noi. La nostra diplomazia, provinciale e sprovveduta, faceva il resto. Così tra
le timide proteste dei nostri rappresentanti, che furono costretti anche ad abbandonare per qualche tempo la
conferenza a causa delle offese ricevute, le cose cominciarono ad andare male per gli italiani.
Intanto a Fiume il contingente francese, colà stanziato, provocava di continuo la popolazione, favorendo
apertamente le rivendicazioni degli slavi. Tale situazione era pertanto fonte di continui incidenti tra i soldati
alleati e i fiumani, i quali ultimi per ovvi motivi avevano sempre la peggio. Ciò era intollerabile per il
contingente italiano, che cominciò pertanto ad intervenire in difesa dei propri connazionali. La tensione iniziò
a salire e il 6 luglio 1919 ci furono gravissimi scontri, con morti e feriti, tra i francesi, unitamente ai loro
coloniali annamiti, e i marinai italiani delle navi “Emanuele Filiberto”, “Dante Alighieri” e “San Marco”, alla
fonda nel porto. Fu necessario istituire una commissione d’inchiesta interalleata. Ma ormai la situazione era
degenerata e fuori da ogni controllo.
Il 12 settembre 1919, vista anche la piega presa dalla conferenza di pace, Gabriele D’Annunzio decise di
rompere gli indugi e a capo di una colonna di volontari, per lo più ex arditi, entrò in Fiume, dove i suoi furono
accolti dalla popolazione entusiasta e letteralmente coperti di fiori e di serti di alloro. Nei giorni successivi le
truppe francesi, inglesi e americane abbandonarono la città e per Fiume iniziarono i giorni della splendida
“avventura” della Reggenza dannunziana.
Dopo aver consolidato militarmente la sua posizione in Fiume, D’Annunzio pensò subito di dare un segnale
“forte” anche ai fratelli dalmati, che lo supplicavano di essere il vindice anche delle loro aspirazioni
irredentiste. In un consiglio di guerra, tenutosi il 13 novembre, D’Annunzio aveva concluso il suo intervento,
dicendo: “Bisogna perciò dimostrare che Fiume e la Dalmazia costituiscono due aspetti di un unico problema.
Bisogna andare a Zara!”.
Il 14 novembre 1919 iniziò quella che fu poi chiamata “l’impresa di Zara”. Quella notte, nel porto di Fiume, in
tutta segretezza furono imbarcate diverse formazioni di volontari sulla R. N. “Cortellazzo”. Fungeva da scorta il
cacciatorpediniere “Nullo”, su cui era lo stesso D’Annunzio. Completavano il convoglio la torpediniera 66 PN e
il mitico MAS 22, l’affondatore della corazzata austriaca Santo Stefano. In pratica era tutta la minuscola flotta
legionaria che prendeva il mare, al comando del capitano di corvetta Castruccio Castracane. Partecipava
all’impresa la due volte medaglia d’oro Luigi Rizzo. Durante la notte, navigando a luci spente, si riuscì ad
eludere l’occhiuta sorveglianza della flotta italiana. Alle prime luci dell’alba il convoglio fu però scoperto da
una squadra navale, composta da un incrociatore, un caccia e due siluranti. Ma fortunatamente Zara era in
vista e si riuscì ad arrivare in porto indenni. Era il 15 novembre 1919.
Tutte le campane della città cominciarono a suonare a distesa, come per l‘arrivo di un liberatore. Le scene che
si svolsero, nel ricordo unanime dei testimoni che ne scrissero, furono sì di grandissima commozione, ma
anche di grandissima esultanza. La gente sembrava veramente impazzita, dappertutto un continuo lancio di
fiori e un risuonare di canti legionari. Tutta Zara marciava con D’Annunzio, che si recava a colloquio con
l’ammiraglio Millo. Nel primo pomeriggio il poeta soldato volle recarsi al palazzo municipale, dal cui balcone
poi parlò ad una folla strabocchevole, che intanto si era radunata nella piazza antistante.
Alla folla mostrò una bandiera tricolore, era quella che aveva avvolto il corpo dell’eroe del Timavo, Giovanni
Randaccio, poi soggiunse: “… al morente avevo promesso di issarla a San Giusto. Ma l’ho mostrata in
Campidoglio al popolo di Roma ed avevo promesso allora di portarla anche a Fiume. L’ho portata, ed oggi la
porto qui a Zara, per Zara e ancora più oltre”. Ed il popolo con un unico immenso boato rispose “ A Spalato”.
Intanto il sindaco Ziliotto faceva affiggere sulle cantonate della città un manifesto, che diceva “ Concittadini,
Gabriele D’Annunzio è qui! Nessuna parola: continuate a piangere di gioia. La Dalmazia resta per sempre
all’Italia”.
Nella stessa giornata del 15 D’Annunzio lasciò Zara, dando però ordine ai volontari dalmati che lo avevano
seguito nella recente impresa di restare nella città quale presidio armato. Quest’ultimo, della forza di circa
due terzi di un battaglione, andò a costituire la “Legione del Carnaro”, che si acquartierò nella caserma San
Domenico. Lo stesso D’Annunzio affidò il comando in capo di questa unità al maggiore Giovanni Giuriati.
Formavano la “Legione del Carnaro” la compagnia “Arditi di Sernaglia” dalle divise con la camicia nera e lo
scudetto da braccio con il gladio circondato dal serto di alloro, la compagnia “Bersaglieri di Fiume”,
caratterizzata dall’avere il copricapo dei fanti piumati, e la compagnia “Randaccio”.
Lo stato maggiore della Legione, oltre al comandante Giuriati, era formato dal tenente Nicola Malizia, aiutante
maggiore, e dal tenente Ugo Busatti, capo dell’Ufficio Propaganda. Gli ufficiali degli “Arditi di Sernaglia” erano
il capitano Giuseppe Vianello, preposto al comando, i tenenti Domenico Gotta, Mario Allegri, Angelo
Sommuer, Gustavo Orlandini, e i sottotenenti Guido Narbona, Ettore Vesentini, Umberto Klinger. La
compagnia dei “Bersaglieri di Fiume” era al comando del capitano Luigi Corrado, altri ufficiali erano i tenenti
Renato Ricci, Mario Marini, e i sottotenenti
Giuseppe Maritati, Mario Balzarini, Gaetano Basso, Melchiorre Melchiorri. Comandava la compagnia
“Randaccio” il capitano Egone Blatt, coadiuvato dai tenenti Pietro Del Zoppo, Antonio Cortese, Arturo Avolio,
e dai sottotenenti Enrico Colombo e Luigi Ronchi.
Dopo appena quattro giorni il maggiore Giuriati fu richiamato a Fiume da D’Annunzio, che gli affidò una
missione diplomatica segreta, pertanto la “Legione del Carnaro” passò sotto il comando del capitano Luigi
Corrado.
La venuta del comandante D’Annunzio, nonché le sue infiammate parole e il suo esempio, avevano convinto
gli zaratini che ormai il dado era tratto e che era giunto il momento dell’azione. Già subito dopo la fine del
conflitto a Zara si era ricostituita la vecchia e gloriosa associazione “Juventus Jadertina”, che dietro l’innocente
maschera sportiva nascondeva in realtà una formazione volontaria paramilitare. Subito vi furono centinaia di
adesioni, soprattutto da parte di giovani e giovanissimi. Erano ammessi a farne parte tutti i maschi dai 17 anni
in poi. Anche le donne potevano partecipare in qualità di affiliate. Istruttori dell’addestramento ginnico, ma in
realtà militare, erano gli ufficiali zaratini già volontari nella Grande Guerra. In un protocollo riservato dello
Statuto, era scritto esplicitamente “Il vero scopo militare della Juventus Jadertina è di organizzare la resistenza
armata per difendere le rivendicazioni d’Italia su questa sponda… Il corpo in divisa ha quindi il compito di
allenare tutti i volontari all’eventuale cimento… A tale scopo la Juventus Jadertina favorirà l’accasermamento
di volontari…”.
Il 23 settembre 1919 al Teatro Verdi di Zara, in un’imponente manifestazione e in un clima di esaltante
patriottismo, ben 932 volontari della Juventus Jadertina giurarono sul Tricolore di portare a compimento la
redenzione della Dalmazia, anche a costo della propria vita.
Da questo gruppo di coraggiosi prenderà poi vita, nei giorni che seguono, il glorioso battaglione di volontari
“Francesco Rismondo”, che sarà una vera e propria guardia nazionale della città fino ai tragici giorni di fine
dicembre 1920.
Il battaglione di circa 1.000 uomini, al comando del capitano Buono Bonvicini, con in sottordine il capitano
Turrina e il tenente Diana, era articolato su 4 compagnie, che prendevano il nome da altrettanti martiri
irredentisti: Oberdan, Sauro, Battisti e Filzi, più un Nucleo Mitraglieri intitolato a Pier Fortunato Calvi, al
comando del tenente Viola. La divisa era quella della Juventus Jadertina con il caratteristico cappello portato,
in quei giorni, da D’Annunzio nell’impresa fiumana e che ricordava molto quello degli alpini. Una peculiarità di
questo reparto era poi l’uso di un simbolismo raffigurante delle fiamme azzurre, già peraltro usate dai reparti
dalmati nel recente conflitto mondiale. L’armamento ordinario era quello della fanteria italiana, con
l’immancabile moschetto 91 e la sua micidiale baionetta, oltre a quello di preda bellica preso agli Austriaci.
I reparti della “Legione del Carnaro” e del battaglione “Francesco Rismondo” usavano come bandiera, insieme
al tricolore, anche il vecchio vessillo dalmata: di azzurro con le tre teste di leopardo d’oro, poste 2 e 1, e
tutt’intorno una frangia d’oro. In qualche reparto era in uso anche un vessillo rosso con 7 stelle d’oro.
D’altronde le due bandiere, quella azzurra con le teste di leopardo e quella rossa con le stelle, sventolavano
ambedue presso la sede della Legazione della Reggenza a Parigi, in rue Frederic Bastiat. La Legazione, guidata
da Tom Antongino, seppure non ufficializzata, rivestiva una funzione estremamente importante e delicata
nella capitale francese, dove i grandi delle potenze vincitrici stavano decidendo del futuro di intere
popolazioni, tra cui quelle dalmate e fiumane.
Il simbolismo delle 7 stelle (ad indicare le principali città dalmate) appariva anche nella xilografia del “quis
contra nos?”, che ornava l’intestazione delle carte della Reggenza del Carnaro, e nel diploma di concessione
della medaglia della Marcia di Ronchi.
Quasi sempre i vessilli dei legionari dalmati, compresa la bandiera nazionale, portavano una fascia nera, a
ricordo di quanto aveva giurato D’Annunzio a Roma, in Campidoglio, nel discorso del 6 maggio 1919: “Io voglio
abbrunare la mia bandiera… finché Fiume non sia nostra, finché la Dalmazia non sia nostra”. E la bandiera, su
cui era avvenuto quel giuramento, era quella stessa che poi il poeta aveva portato con se a Fiume e a Zara .
Altra caratteristica di quei reparti era l’uso della Croce Dalmata. Una croce di una particolare forma patente,
sovrastata dal leone alato di San Marco e caricata di un cerchio, con inscritto uno scudetto azzurro con le tre
teste di leopardo d’oro. In circolo la scritta “Nu con ti, ti con nu”. Quest’ultimo motto non era che il vecchio
grido di battaglia delle genti dalmate, adottato da tutti i legionari, compresi quelli fiumani, accanto a quello
nuovo, ma al tempo stesso antichissimo perché risalente alle legioni di Roma, di “Eja eja alalà”, riscoperto e
rilanciato da D’Annunzio a contrastare quello barbaro di origine anglo-sassone di “Hip hip hurrà”.
Le divise, i vessilli, i fregi, i motti, insomma lo stile di vita militare adottato dai legionari di Zara sarà così
contagioso che, nel giorno dell’Epifania del 1920, il pur immaginifico Gabriele D’Annunzio, quale suo dono
personale, autorizzò “i combattenti in Fiume d’Italia” a portare i distintivi della Dalmazia e “le fiamme
azzurre”.
Quando il 28 febbraio 1920 partì da Zara, per rientrare a Fiume, la compagnia “Arditi di Sernaglia” della
Legione del Carnaro, tutta la popolazione si riversò nelle strade, a salutare quegli “sfegatati dalla camicia
nera”.
Il 18 marzo, in occasione dell’onomastico del comandante D’Annunzio, nella piazza d’armi di Zara ebbe luogo
una rivista militare, con la sfilata del battaglione volontari “Francesco Rismondo” del capitano Bonvicini e della
Legione del Carnaro del capitano Corrado. Anche così si manifestava agli slavi e ai governi alleati, nonché a
quello italiano, che non si aveva alcuna volontà di mollare.
Il Sabato Santo di quel 1920 D’Annunzio si rivolse con un particolare ed affettuoso messaggio alle “fiamme
azzurre” del battaglione Rismondo. Il 7 aprile aveva scritto a Giovanni Lubin, patriota dalmata di Traù, una
lettera, che terminava con queste parole “… Bisogna credere nel miracolo. Si salva chi crede nel miracolo. Dite
ai nostri fratelli che io credo, e che non muterò mai. La bestia non può prevalere. Non prevarrà. Abbiate pronte
le armi. Se non avete armi, acuminate i sassi. E non mi aspetterete invano. Gabriele D’Annunzio”.
Il 24 maggio, a Roma, un’affollata e pacifica manifestazione studentesca pro Fiume e Dalmazia ebbe un tragico
epilogo di morti e feriti, per l’incomposta reazione della Guardia Regia che sparò sulla folla inerme. Con un
violentissimo discorso, tenuto in Fiume, D’Annunzio inchiodò alle sue gravissime responsabilità il governo
italiano, alle cui direttive si doveva l’insano comportamento della Guardia Regia. Purtroppo l’accaduto
disvelava chiaramente le aberranti linee guide, lungo cui intendeva muoversi, nel prossimo futuro, il governo
per ciò che riguardava la questione fiumana e dalmata. D’Annunzio intuì subito che, da quel momento, doveva
prepararsi al peggio.
L’11 luglio 1920 rapida si sparse una ferale notizia. A Spalato una folla di manifestanti slavi aveva trucidato
barbaramente il comandante Gulli e il motorista Rossi della Regia Nave “Puglia”. La notizia turbò
profondamente tutti gli irredentisti, anche per l’assoluta mancanza del benché minimo cenno di reazione da
parte del governo italiano.
Ad agosto D’Annunzio concepì le linee fondamentali di quella Carta del Carnaro, che fu poi approvata
plebiscitariamente dal popolo fiumano nel successivo settembre. La Carta, pur risentendo in parte
dell’influenza del De Ambris, capo dell’ala sinistra del movimento legionario, riusciva in certo qual modo a
superare e comporre le antitesi tra le istanze nazionali e sociali, che in quel tempo cominciavano a dividere
profondamente l’Italia. Poteva benissimo rappresentare un punto di partenza di discussione comune per
socialisti e fascisti. Ma non fu così e la Storia prese altre strade. Intanto che ambedue le fazioni, accecate dalla
loro stessa faziosità, guardavano con malcelata inimicizia a D’Annunzio. Come sempre, nulla di nuovo sotto il
cielo d’Italia.
Il 12 novembre 1920 veniva firmato il Trattato di Rapallo. Di tutta la Dalmazia, promessa all’Italia dagli accordi
del Patto di Londra del 26 aprile 1915, le sole isole di Cherso, Lussino, Lagosta, Pelagosa e la città di Zara, con
uno striminzito territorio circostante, venivano a far parte del territorio nazionale italiano. Fiume veniva
riconosciuta come stato libero, ma senza un adeguato retroterra, anzi si raggiungeva l’assurdo di mutilarla di
una parte dello stesso porto. Era ormai chiaro a tutti che il Patto di Londra non era stato che carta straccia e
che i nostri antichi alleati erano stati dei perfidi spergiuri. Gli imbelli governanti italiani erano stati giocati
ancora una volta. S’incorporavano, con somma gioia dei francesi, alcuni territori a maggioranza di lingua
tedesca, fonte certa di futuri guai, e si abbandonavano agli slavi terre italianissime. Quel poco che si era
strappato, il pugno di isole e la città di Zara, nonché lo Stato Libero di Fiume, non si doveva certo alla nostra
diplomazia, ma a D’Annunzio e alle sue formazioni militari di volontari, che in armi presidiavano sia Fiume che
Zara. Ad onor del vero anche al coraggio di molti ufficiali e soldati del Regio Esercito, che rischiando di divenire
anch’essi dei “soldati perduti”, appoggiarono e sostennero in tutti i modi le formazioni legionarie.
La sera stessa del 12 D’Annunzio, a nome della Reggenza del Carnaro, dichiarò di non riconoscere la legittimità
del Trattato di Rapallo.
A Zara si costituì immediatamente un Comitato di Salute Pubblica, con l’espresso mandato di elaborare un
piano d’azione per un diretto intervento nella Dalmazia sacrificata, e quindi assicurarla ad ogni costo all’Italia.
Mentre a Sebenico si formava la compagnia volontari dalmati “Nicolò Tommaseo”, intanto che nella locale
sede del Circolo Italiano di quella della Società Operaia si raccoglievano armi e munizioni per il momento
dell’azione.
Con la sua dura presa di posizione Gabriele D’Annunzio diveniva di fatto un personaggio ingombrante e
scomodo per tutti. Per la Corona, per i vertici militari, per la maggioranza di governo, per l’opposizione. Per lo
stesso Mussolini. Per non parlare degli slavi e degli ex alleati, soprattutto i francesi. E forse non tanto per la
sua caparbia tenacia nel rivendicare l’italianità di Fiume e dell’intera Dalmazia, come d’altronde pacificamente
riconosciuto da tutti nel patto sottoscritto prima dell’entrata in guerra. Ma per quella sua peculiarità di essere
riuscito, unico nella storia (e né ve ne saranno altri dopo di lui), a portare “l’immaginazione al potere”.
Plasmava per la sua comunità, giorno per giorno, un nuovo stile di vita che seppur moderno e spregiudicato,
sapeva di antico. E poi quel suo modo di magnetizzare le masse. Fiume era, come abbiamo già accennato, un
crogiuolo di un enorme laboratorio politico, in cui il rosso e il nero, allora appena agli inizi della loro ascesa, si
amalgamavano in arditi futuristici progetti di rinascita nazionale e sociale, quali la promulgazione degli Statuti,
un disegno costituzionale veramente d’avanguardia per quei tempi. Era un rivoluzionario nel senso più puro
della parola. Forse questi i veri reconditi motivi per cui bisognava liberarsi di D’Annunzio una buona volta.
Uno dei pochi ad accorgersi della sua statura di rivoluzionario fu, ironia della sorte, Lenin che da Mosca
proclamò “ D’Annunzio, l’unico rivoluzionario che ci sia in Italia”. E Lenin di rivoluzioni se ne intendeva.
Quando nell’ultimo incontro con l’ammiraglio Millo, quest’ultimo lo scongiurò di non intraprendere alcuna
azione militare e di recedere dalla sua intransigenza, il poeta-soldato rispose doloroso: “…non fare nulla per la
Dalmazia… mi è impossibile. Mancherei all’onore. Si può per lo meno morire…”. E’ assai probabile che in quel
momento D’Annunzio, amareggiato, fosse veramente deciso a chiudere in bellezza la sua vita straordinaria,
con la morte cercata e trovata in un’ultima disperata, ma bella battaglia. Chi conosce le sue innumerevoli e
temerarie azioni di guerra, sa benissimo che era uomo da non temere assolutamente la morte e che quindi la
risposta all’ammiraglio Millo non era per niente retorica. Ma anche l’animo dell’ammiraglio era turbatissimo,
schiacciato tra il dovere e il sentimento, scriverà qualche giorno più tardi al re “…preferirei morire sul campo
che vivere queste giornate…”.
I proiettili, sparati dai cannoni della corazzata “Andrea Doria” nel tragico Natale di sangue, che colpirono in
pieno il Palazzo del Governo e in particolare la stanza di D’Annunzio, poco mancarono che non esaudissero i
desideri del poeta. Gli avrebbero risparmiato di sopravvivere a se stesso per altri 18 lunghi crudeli anni. Invece
solo alcune ferite da schegge. Fu l’unica beffa del destino nei confronti di un uomo, cui per lungo tempo era
stato assai largo di favori.
A dicembre il giro di vite finale. Il governo italiano decise di far rispettare il Trattato di Rapallo a qualunque
costo, anche se questo comportava lo spargimento di sangue fraterno, come in effetti accadrà. Il 2 dicembre
1920, a Zara, una folla che cercava di impedire la partenza di una nave di soldati italiani congedanti, che in
larghissima maggioranza simpatizzavano con gli irredentisti, veniva brutalmente caricata dai carabinieri.
Numerosi e gravi i feriti, soprattutto tra le donne. Nei giorni successivi, sempre a Zara, fu sciolto con la forza il
Comitato di Salute Pubblica, il quale però continuerà ad operare nella clandestinità. Fu pure ordinato lo
scioglimento e il disarmo di tutte le formazioni legionarie che erano in città. La repressione fu durissima. Tanti
però si rifiutarono e si rifugiarono nelle loro caserme. Cominciò così un braccio di ferro tra le autorità italiane,
che minacciavano di ricorrere all’uso delle armi, e quei volontari, in gran parte giovanissimi, che non ne
volevano sapere di arrendersi.
Il 15 dicembre D’Annunzio inviò in segreto il capitano Caliceti a Zara, con l’incarico di assumere il comando di
quel che restava di quella forza legionaria e riorganizzarla. Il 21 dicembre, alla vigilia dell’attacco a Fiume, il
comando legionario di questa città ordinò a tutti i volontari dalmati di lasciare Fiume, raggiungere Zara e
combattere così per la propria terra. Il reparto, forte di circa un centinaio di uomini comandati dal capitano
Calavalle, s’imbarcò sulla torpediniera PN 68, che navigando sotto costa eluse il blocco navale italiano. Questi
volontari furono sbarcati a Castel Venier, distante una trentina di chilometri da Zara. Solo la perfetta
conoscenza dei luoghi, permise di forzare il rigido blocco delle truppe governative, tant’è che il grosso la sera
del 22 era già nella caserma Rismondo. Si lamentava però la perdita del capitano Aurelio e del suo gruppo, i
quali erano stati catturati e portati nelle carceri di Sebenico. Con l’arrivo di questi rinforzi si costituì, agli ordini
del capitano Caliceti, la “Legione di Zara”, composta dal battaglione “Carnaro” (legionari fiumani) comandato
dal tenente Del Zoppo, dal battaglione “Rismondo” (volontari zaratini) del tenente Tonacci, e dal battaglione
“Sebenico” (volontari dalmati) al comando del capitano Calavalle. In vista di un prevedibile attacco, si
cominciò ad organizzare la difesa, scavando un camminamento sotterraneo tra la caserma “Rismondo” e
quella del “Carnaro”, in modo di evitare lo spostamento degli uomini allo scoperto.
Purtroppo le due caserme si trovavano in una posizione infelice, in quanto erano dominate dall’alto
dall’imponente mole della caserma “Vittorio Veneto”, in mano alle forze regolari e che l’avevano trasformata
in un vero fortilizio, irto di nidi di mitragliatrici. Dalla “Vittorio Veneto” si potevano guardare la “Carnaro” e la
“Rismondo” “come in un cortile interno di una casa”, come scrisse con felice espressione un legionario.
Dunque una difesa decente era praticamente impossibile, malgrado ciò il 25 dicembre i legionari respinsero
l’ultimatum di resa.
Intanto a Sebenico, il tenente Lunardi con un gruppo di coraggiosi volontari irruppe, armi alla mano, nel locale
carcere e liberò il capitano Aurelio e i legionari, precedentemente catturati. Sempre a Sebenico, non ebbe
invece successo il tentativo di sette marinai di impadronirsi di un cacciatorpediniere all’ancora nel porto.
L’insuccesso costrinse i sette a disertare e a nascondersi poi nel Circolo Italiano.
La mattina del giorno di Natale, giunsero a Zara notizie del violento bombardamento da parte della flotta
italiana contro Fiume. In quella città, già da qualche giorno, si contavano le prime vittime legionarie per mano
di altri italiani. Ora toccava a Zara, anche perché i volontari, asserragliati nelle caserme, avevano
sdegnosamente ignorato l’invito alla resa. Si cercò quindi di prendere tempo, cercando di intavolare delle
trattative, in quanto il Comitato clandestino di Salute Pubblica aveva elaborato un suo piano. Semplice e
audace ad un tempo, il piano consisteva nell’impadronirsi dell’esploratore “Marsala”, alla fonda nel canale di
Zara. Complici alcuni sottocapi devoti alla causa dalmata: Maina, Rangone, Boni e Riccio.
Poi, con la minaccia dei cannoni della nave catturata, obbligare i regolari italiani a lasciare libero passo ai
legionari delle due caserme, imbarcare quest’ultimi e infine dirigere a tutta forza su Sebenico. Qui sbarcare e
dar man forte a quei pochi coraggiosi, che si preparavano a contrastare con le armi l’entrata in città degli slavi.
Si sarebbe così creato un nuovo centro legionario di resistenza, com’era nella strategia indicata da
D’Annunzio.
La prima parte del piano si svolse senza intoppi. La notte tra il 25 e il 26, trenta legionari, guidati dal capitano
Calavalle e dal tenente Grossi, riuscirono effettivamente ad impadronirsi del “Marsala”. Ma i cannoni erano
inservibili, per mancanza di otturatori, e le macchine, per difficoltà tecniche, non poterono essere messe in
pressione. Nel frattempo era scattato l’allarme, e subito i caccia “Alfieri” e “Missori” si affiancarono minacciosi
al “Marsala”. A questo punto la resa diventò inevitabile.
A Zara la mattina del 26 dicembre i legionari delle due caserme accerchiate, vista la mancanza dei segnali
convenuti, capirono che il piano era fallito e si prepararono a contrastare con le armi l’inevitabile attacco.
Anche a Zara dunque, come a Fiume, si sarebbe sparso sangue fraterno. E l’ingrato terribile compito, anche
qui, sarebbe toccato per la maggior parte ai reparti di alpini. Cominciò così un intenso fuoco di mitragliatrici e
di fucileria, rotto ogni tanto dal cupo rumore delle bombe a mano. Dopo parecchie ore di combattimento,
viste le dolorose perdite e al fine di salvaguardare la vita dei più giovani tra i volontari, il comando della
Legione di Zara ordinò la resa.
Erano le ore 15 e 30 del 26 dicembre 1920. Tra i feriti gravi, si notò un legionario sedicenne con una gamba
spappolata da una raffica di mitragliatrice. Quel legionario si chiamava Riccardo Vucassovich ed era uno
studente italiano di Spalato. Si era arruolato l’anno prima, ad appena quindici anni, forse mentendo sull’età.
Dopo aver subito con stoica fermezza l’amputazione della gamba, morirà dopo diciotto giorni di atroce agonia.
Zara la Santa, come amava chiamarla D’Annunzio, aveva in Riccardo Vucassovich il suo purissimo eroe.
VERSAILLES
IL DURISSIMO TRATTATO DI PACE CON LA GERMANIA
( era già stato scritto 6 anni prima )
Già prima che scoppiasse la guerra, quindi prima dei tragici fatti di Sarajevo, la volontà di alcune potenze era
di scatenare una guerra per raggiungere loro fini particolari, specialmente nel campo territoriale; fini che
prescindevano dal diritto di autodecisione, dal rispetto delle nazionalità e anche dalla perfetta uguaglianza
delle nazioni, e si proponevano il maggior danno possibile per il nemico, che in definitiva era poi uno solo:
l'impero tedesco. Si distinguevano in questi proponimenti specialmente la Francia e la Russia, sia per quello
che richiedevano a proprio favore, sia per quello che non volevano dare ai loro minori alleati.
Ad assecondare Francia e Russia, vi era la Gran Bretagna spinta dalla volontà di mantenere i suoi commerci e il
suo dominio sui mari (da qualche tempo minacciati dai tedeschi).
(La Reichsverband tedesca (una specie di Confindustria) fin dal 1870 era già potente! Il primo cartello
carbonifero in Germania, sorse a Dortmund nel 1879. Nel 1905, dieci anni prima che la guerra mondiale
scoppiasse, in Germania si contavano già sessantadue (62!) cartelli metallurgici. C'era un cartello della potassa
nel 1904, un cartello dello zucchero nel 1903, e dieci cartelli nell'industria vetraria).
Infatti alla conferenza di Parigi i timori furono chiaramente espressi e a proposito dell'utopia di Wilson e della
sua Lega, il giovane ministro della Marina Winston Churchill fu anche sarcastico "Una Lega delle Nazioni non è
il sostituto della supremazia della flotta inglese"; e il Times dell'11 dicembre aggiunse chiaramente quali erano
stati gli scopi della Gran Bretagna nella guerra "Una cosa è chiara: questa guerra non è stata vinta per la civiltà
ma per il dominio inglese dei mari. Perciò per quanto riguarda questo paese, non può esser messa in
discussione l'eventualità di spuntare l'arma che in questa guerra ci ha dato la vittoria". (Qui ricordiamo che
l'imponente flotta tedesca si trovava internata nel porto britannico di Scapa Flow: consistente in 27 fra navi e
incrociatori da battaglia, 19 incrociatori leggeri, 101 fra cacciatoperdiniere e torpediniere e 135 sommergibili.
Flotta che si voleva distruggere, ma poi la Francia ne pretese una parte per rinnovare la sua flotta, che però
doveva essere proporzionata a quella inglese, secondo i dettami di Wilson e della sua Lega delle Nazioni.
Un'idea che non piaceva proprio all'Inghilterra).
E come la Francia anche la Gran Bretagna invocava "il pericolo speciale". Gilbert Murray scriveva "Noi non
possiamo abbandonare la nostra superiorità navale, perchè noi siamo un isola e se fossimo sconfitti in mare e
bloccati, noi tutti saremmo condannati a morire di fame o alla resa in poche settimane" (Baker, op. cit, pag.
381). Ma questo avveniva nel 1918-19, mentre molto tempo prima - fin dal novembre 1914 - erano già stati
fatti i programmi.
"Noi non rimetteremo nel fodero la spada che non abbiamo tratto fuori alla leggera finchè il Belgio non avrà in
pieno tutto quello che esso ha sacrificato, finchè la Francia non sarà adeguatamente assicurata contro la
minaccia di aggressione, finchè i diritti delle piccole nazioni dell'Europa non saranno posti su una base
tangibile e finchè la dominazione militare della Prussia non sarà completamente e definitivamente distrutta".
Questo il discorso alla Guilhall del 9 novembre 1914. (Lloyd George, The Truth about the Peace Treaties,
London, 1938, I, p. 23). A queste dichiarazioni si associava anche il capo del governo francese, Viviani, il quale
aggiungeva che la Francia avrebbe combattuto "finchè non fossero tornate per sempre le province che le erano
state strappate" (Ib. p. 24).
Gli scopi degli alleati promulgati al principio della guerra possono essere così riassunti:
" 1) Rivendicazione del diritto internazionale contro la tirannia della forza adoperata come strumento non di
giustizia ma di arroganza, di avidità e di oppressione nazionale; 2) Completo ristabilimento dell'indipendenza
nazionale e dell'integrità del Belgio e della Serbia; 3) Disfatta e distruzione del militarismo prussiano come una
minaccia alla pace del mondo; 4) Instaurazione del principio del diritto internazionale su basi solide, tali che
fosse garantita una protezione delle nazioni piccole e deboli contro l'aggressività delle grandi; 5) Restituzione,
per quanto riguarda la Francia, delle perdute province dell'Alsazia-Lorena". (Ib. p. 25)
La guerra era appena iniziata, ma fin dai primi giorni fra le tre potenze (Gran Bretagna, Francia e Russia)
nacquero le divergenze sui fini di quella guerra che andavano insieme ad iniziare, anche se questi fini erano
rivestiti da quelli che saranno poi in seguito gli utopistici principi wilsoniani. Proprio Wilson ancora un anno
prima che scendesse in campo con l'esercito americano (e dopo due anni che in Europa si combatteva) il 18
dicembre 1916, chiese alle tre potenze quali fossero i loro scopi di guerra. Lui e i suoi consiglieri poco
sapevano della lunga e complessa Storia d'Europa, quasi sempre fatta e scritta da intricanti personaggi dentro
quelle corti impregnate di reciproci atavici rancori di ogni genere, compresi quelli dei falliti matrimoni
dinastici.
Era insomma un programma sorto negli Stati Uniti che, protetti da due mari e senza potenti pericolosi vicini,
provvisti di tutte le risorse economiche, senza aspirazioni territoriali, credevano possibile la pace eterna e la
desideravano per poter sviluppare la loro produzione e il loro commercio con tutto il mondo. Ma non era un
programma che si adattasse alle condizioni storiche dell'Europa, il cui assetto era frutto di secoli di contrasti e
di guerre, dove la popolazione si addensava in uno spazio ristretto, di cui sfruttava al massimo le risorse e
inoltre doveva approvvigionarsi di ingenti quantità di materie dagli altri continenti, e dove ogni nazione
vedeva la sicurezza e la pace nella maggior quantità di garanzie d'ogni genere contro un attacco esterno. Una
di queste nazioni era la Francia che intendeva creare una zona di protezione di fronte a una nuova eventuale
minaccia tedesca, da ottenersi con l'indebolimento politico ed economico della Germania.
Wilson invece partiva dal presupposto che dalla vita delle nazioni, come da quelle degli individui, fosse
possibile eliminare i contrasti; mentre gli altri li ritenevano inevitabili, quindi volevano esser in grado di
affrontarli nelle migliori condizioni possibili.
E le divergenze erano che l'Inghilterra secondo i francesi non nutriva abbastanza rancore verso la Germania.
Ma di motivi gli inglesi ne avevano diversi per comportarsi così. Mettendo da parte quelli atavici, il primo
motivo era che la Germania nella sua disperazione potesse cadere nelle accoglienti braccia della Russia
bolscevica; secondo motivo - essendo questa la loro attività principale - volevano riprendere i commerci con
la Germania, lasciando da parte i rancori, perchè "gli affari sono affari". Volevano insomma ridare un po' di
fiducia ai tedeschi, riabilitarli. Non spingerli troppo sul baratro del lesionismo o autolesionismo. Se i tedeschi
lo avessero fatto non avevano nulla da perdere, più in basso di così non potevano mica andare. E questo li
poteva indurre a tentare pericolose "avventure" rivoluzionarie. Alcune c'erano già state (quella degli
spartachisti) e altre di tipo militare erano in quei giorni parigini già nell'aria.
Il 17 gennaio 1917 i "tre" avevano risposto alla ingenua domanda di Wilson che si "associavano al suo
progetto d'una Lega delle Nazioni per assicurare la pace e la giustizia del mondo; riconoscendo negli ideali
wilsoniani tutti i vantaggi che per la causa dell'umanità e della civiltà avrebbe presentato il fissare dei
regolamenti internazionali destinati ad evitare conflitti violenti fra le nazioni; regolamenti che avrebbero
dovuto comportare le sanzioni necessarie per assicurare l'esecuzione e per evitare in tal modo che una
sicurezza apparente servisse soltanto a facilitare nuove agressioni". E con candore aggiungevano "...di non
combattere per interessi egoistici, ma soprattutto per la salvaguardia dell'indipendenza dei popoli, del diritto e
dell'umanità" (Ib. p. 53).
Ma il 30 gennaio Clemenceau aveva detto "La Francia è la vicina immediata della Germania, e in ogni
momento potrebbe essere attaccata improvvisamente come lo è stato in passato...La Francia si rende conto
che la Gran Bretagna ha impegni in tutte le parti del mondo e non potrebbe venire subito in aiuto della
Francia. Se si vuole stabilere la Lega delle Nazioni e la pace nel mondo non si deve cominciare col porre la
Francia in una posizione pericolosa. L'America è protetta da tutta l'estensione dell'Oceano, e la Gran Bretagna
dalla sua flotta" (Baker, op. cit., I, pp 426).
A quel punto il testo concordato fu il seguente: "Il Consiglio, tenendo conto della situazione geografica e delle
circostanze di ciascun Stato, dovrà formulare i piani della riduzione degli armamenti. Parimenti dovrà
sottomettere all'esame di ciascun governo la giusta e ragionevole proporzione degli armamenti corrispondenti
alla quantità delle forze stabilite nel programma di disarmo".
Era la prima soddifazione delle Francia che tramite Bourgeois affermava che "il diritto e la giustizia dovevano
essere la base del regolamento di tutti i conflitti, di tutte le divergenze internazionali" (Bourgeois, Le Pacte de
1919 et la Societè des Nations, Paris 1919, I, p. 367) ma più avanti (a pag. 43) aveva scritto, condividendo
l'opinione di Ribot, che "il diritto senza la forza non è altro che l'umiliazione della giustizia oppressa dalla
violenza".
Il progetto idealistico di Wilson, quando si trattò di fare accordi con le due potenze europee (nel frattempo
era uscita di scena la Russia) e fare le future proposte di pace, e stabilire un criterio del disarmo, quindi
passare al concreto, gli scopi perseguiti dal primo non trovavano concordanza con i secondi. I 14 punti di
Wilson alla conferenza interalleata di Parigi del dicembre 1917 i vari punti di vista rivelarono subito le
divergenze e quali in realtà erano stati i veri scopi della guerra. Che non erano nuovi, ma di vecchia data.
Sarajevo era stata solo la miccia. E l'immediata partecipazione della Germania accanto all'Austria era in
sostanza un guerra preventiva della Germania contro le altre potenze che o per invidia della sua economia o
per vecchi rancori, già da tempo tramavano per distruggerla.
Già prima della guerra,
nel 1913 a Pietroburgo, si erano avute conversazioni fra il ministro degli Esteri russo, Sazonoff e
l'ambasciatore francese DELCASSE (nella foto di apertura). "La partecipazione di quest'ultimo ai colloqui è
sufficiente ad indicarne la loro indole" (Fr. Stieve, Iswolski im Weltkrieg, Berlin, 1925, n.225).
Come ministro degli esteri dal 1898 al 1905 Delcasse aveva lavorato tenacemente ad assicurare alla Francia le
amicizie necessarie per il "giorno della rivincita". Rivincita per tutto quello che la Francia aveva perduto in
seguito alla guerra del 1870-71, il che significava riavere l'Alsazia-Lorena e, nel quasi cinquantennale rancore
nutrito verso i tedeschi, primo obiettivo era quello di distruggere quell'impero nato proprio con quella guerra.
Questa aspirazione era così tanto radicate nella natura di Delcassè che ancora nel 1919 a Versailles egli voleva
ancor più lo smembramento della Germania, e il giorno in cui alla Camera francese venne approvato il Trattato
di Pace con la Germania, egli si astenne dal voto perchè quel trattato "manteneva l'unità della Germania"
(Henry Leyret, Delcassè parle ... in "Revue des Deux Mon des", 15 sett, 1937, p. 381).
Quindi Sazonoff quando il 14 settembre 1914 riprese le conversazioni con gli ambasciatori inglese e francese,
non rivelava un argomento completamente nuovo. Dopo aver notato che era necessario "elaborare un
progetto" Sazonoff esponeva ai suoi interlocutori le linee generali del nuovo assetto europeo (anche se come
notiamo al punto 8, nè lui né tantomeno le altre tre potenze prevedevano la totale sconfitta e la conseguente
disintegrazione dell'Impero Austro-Ungarico. Il principale pensiero Francese, Inglese e Russo era rivolto
unicamente alla Germania).
Dobbiamo subito dire che per quanto il programma fosse uscito dalla mente fervida di Sazonoff e non
impegnasse ancora i suoi alleati, tuttavia era un indice delle idee che circolavano in proposito nei mesi
precedenti e nei primi giorni di una guerra che era ancora tutta da fare (la Francia aveva dichiarato guerra
all'Austria l'11 agosto, la Gran Bretagna il 12, ma già il 3 e 4 agosto l'avevano dichiarata alla Germania, che a
sua volta l'aveva dichiarata il 1° agosto alla Russia e il 2 agosto a Francia e Gran Bretagna).
Possibile che i francesi erano vissuti per quarant'anni nell'attesa e nella speranza della Revanche ("rivincita")? .
E' quasi unanimemente accettata. L'idea era promossa da una certa pubblicistica, da letterati e uomini politici
e godeva di popolarità. L'8 agosto (!!) del 1814, Albert de Mun scriveva suul"Echo de Paris": "la Revanche!
Parola che accende emozioni, così a lungo respinta nei nostri cuori e che ci è stato proibito di gridare con tutta
la nostra voce". E non per nulla era stato già votato l'anno prima dalla Camera dei Deputati il 19 luglio e dal
Senato il 5 agosto 1913, il progetto di riportare da due a tre anni la durata del servizio militare.
Con il programma di Sazonoff si mirava solo a soddisfare i desideri dei futuri vincitori senza tener conto della
volontà delle popolazioni. Era quindi fin dall'inizio un programma contrario ai principi di nazionalità e di
autodecisione che andrà poi a propugnare Wilson (prima in America l'8 gennaio e il 4 luglio 1918, poi a
Versailles, prima ancora di iniziare i tanto attesi trattati di pace con gli sconfitti).
Ecco il programma dei tre alleati
(concepito nel 1913, preso in considerazione nel 1914, diventato realtà nel 1919.
Dal "Die internationalen Beziehunghen im Zetailter del Imperialismous, VI, p.I, n. 256).
1) L'oggetto principale dei tre alleati deve essere quello di rompere la potenza tedesca e la sua pretesa di
dominio militare e politico;
2) Le modificazioni territoriali devono essere determinate secondo i principi di nazionalità.
3) La Russia si annetterà il corso inferiore del Niemen e la parte orientale della Galizia. Unirà al regno di
Polonia la Posnania orientale, la Slesia.... (qui mancano parole) e la parte occidentale della Galizia.
4) La Francia si riprenderà l'Alsazia-Lorena, aggiungendovi a suo piacere una parte della -Prussia renana e del
Palatinato.
5) II Belgio otterrà in... ...... ......(mancano più parole) un aumento importante di territorio.
6) Il territorio dello Schleswig-Holstein sarà restituito alla Danimarca.
7) Il regno di Hannover sarà ristabilito.
8) L'Austria sarà formata da una monarchia tripartita, composta dell'impero d'Austria, del regno di Boemia e
del regno di Ungheria. L'impero d'Austria avrà unicamente le province ereditarie. Il regno di Boemia si
estenderà alla Boemia attuale e alla Slovacchia. Il regno di Ungheria dovrà intendersi con la Romania a
proposito della Transilvania.
9) La Serbia avrà la Bosnia, l'Erzegovina, la Dalmazia e il nord dell'Albania.
10) La Bulgaria riceverà un compenso dalla Serbia in Macedonia.
11) La Grecia si annetterà l'Albania meridionale, ad eccezione di Valona destinata all'Italia.
12) L'Inghilterra, la Francia e il Giappone si divideranno le colonie tedesche.
13) La Germania e l'Austria pagherà una indennità di guerra»
(All'incirca è ciò che figurerà nel Trattato di Pace con la Germania scritto a Versailles)
Intanto Sazonoff incaricava gli ambasciatori a Londra e a Parigi di informarsi sulle richieste francesi ed inglesi
(Stieve, Op. Cit., n. 219). L'ambasciatore russo a Londra, Benckendorff, dopo aver parlato con ministri e con
influenti rappresentanti del partito conservatore, riferiva a Pietroburgo le conclusione delle sue indagini. Il
programma inglese - secondo lui - comportava l'acquisto delle colonie tedesche; la neutralizzazione del canale
di Kiel; la consegna di tutta la parte migliore della flotta tedesca; la sistemazione della Schelda con possibile
rettifica di confine a favore del Belgio; l'eventuale unione del Lussemburgo al Belgio; l'annessione all'Olanda
della Frisia tedesca; le riparazioni di guerra; il crollo della Prussia e la conseguente rinuncia alla sua egemonia
in Germania. Anzi lo scopo principale dell'Inghiltera era proprio il crollo della potenza militare e marittima
della Germania, e su ciò - secondo Benckendorff - era d'accordo anche il Re (Die internationalen Beziehungen,
cit., n. 278).
Passando poi a parlare degli alleati, la Francia avrebbe riavuto l'Alsazia-Lorena e le colonie, la Russia tutte le
province polacche con la speranza che per queste province mantenesse le promesse del proclama del
Granduca. Oltre alle province polacche, alla Transilvania, alla Bosnia-Erzegovina e al litorale adriatico destinate
alla Romania, agli Stati slavi e all'Italia, l'Austria avrebbe perduto anche il Trentino. Tutto questo nel caso di un
intervento dell'Italia e della Romania. In ogni modo l'intera simpatia inglese era a favore di un miglioramento
della carta europea su basi etniche a spese soprattutto dell'Austria. Però « la forza intera del sentimento
nazionale britannico era diretta contro la Germania » (Die internationalen Beziehungen, cit., n. 329.).
In questi scopi inglesi troviamo molte somiglianze con quelli russi, ma non dimentichiamo che l'esposizione di
essi è fatta da Benckendorff, quindi bisogna accoglierli con cautela.
Anche l'ambasciatore a Parigi cercò di ottenere le informazioni richieste dal suo ministro e il 13 ottobre riferì a
Pietroburgo quanto aveva appreso dai suoi colloqui con Delcassé, allora ministro degli Esteri. Questi, pur
riconoscendo che era ancora presto « per spartirsi le pelle dell'orso», tuttavia esprimeva la sua opinione
personale, secondo la quale la Francia « non aspirava ad alcun acquisto territoriale in Europa, salvo ben inteso,
il ritorno dell'Alsazia e Lorena. Parimenti non aspirava a nuovi acquisti territoriali in Africa ». Il suo
« scopo principale era la distruzione dell'impero tedesco e il maggior indebolimento possibile della potenza
militare e politica della Prussia". Dichiarava che non si sarebbe opposto alle richieste inglesi di un Hannover
indipendente, al ritorno alla Danimarca dello Schleswig-Holstein, agli ingrandimenti coloniali inglesi, alle
richieste territoriali russe. Meno categorico fu a proposito dell'Austria, a causa delle simpatie tradizionali
francesi verso questo Stato (Die internationalen Beziehungen, cit., nn. 385, 386).
Anche per le condizioni francesi, come per quelle inglesi, occorre ripetere che non si trattava ancora di
richieste ufficiali, anche se questa volta venivano dallo stesso ministro degli Esteri.
L'argomento venne ripreso da Nicola II in un colloquio che egli ebbe il 21 novembre 1914 con l'ambasciatore
francese Paléologue. Anzitutto lo Zar ripeté quello che abbiamo già sentito e cioè la necessità della
«distruzione del militarismo tedesco, cioè la fine dell'incubo nel quale la Germania ci fa vivere da più di
quarant'anni. Bisogna togliere al popolo tedesco ogni possibilità di rivincita. Se ci lasciamo impietosire sarà
una nuova guerra a breve scadenza». Poi spiegando una grande carta d'Europa, indicò i mutamenti territoriali
a favore della Russia, della Serbia e della Grecia che erano già stati indicati da Sazonoff; e anche per la sorte
dell'Austria rimase fedele all'esposto del suo ministro. Poi indicò che l'Armenia non doveva più rimanere sotto
i Turchi, era però ancora incerto se annetterla alla Russia o farne uno Stato autonomo. Approvava in anticipo
le richieste francesi ed inglesi.
«Ma è in Germania - continuò - che si produrranno i cambiamenti più grandi. Come ho già detto, la Russia si
annetterà i territori dell'antica Polonia e una parte della Prussia orientale. La Francia riprenderà certamente
l'Alsazia-Lorena e si estenderà forse anche sulle province renane. Il Belgio dovrà ricevere nella regione di
Aquisgrana un importante aumento di territorio: se lo è ben meritato! Quanto alle colonie tedesche, la Francia
e l'Inghilterra se le divideranno, a loro volontà. Desidero infine che lo Schleswig compresa la zona del canale di
Kiel sia restituito alla Danimarca. E l'Hannover? Non converrà ricostituirlo? Interponendo un piccolo Stato
libero fra la Prussia e l'Olanda, noi consolideremo molto la pace futura. Perchè questo deve essere il nostro
pensiero direttivo. La nostra opera non sarà giustificata davanti a Dio e davanti alla storia se non è dominata
da un'idea morale, dalla volontà di assicurare per molto tempo la pace del mondo».
E parlando di «idea morale» lo Zar era certamente sincero, però non vedeva che l'"idea morale" non si
conciliava con le sue conquiste a spese della Germania. Per «idea morale» intendeva soprattutto assicurare la
pace, ma non prima di aver fatto una guerra di "conquiste".
Paléologue si limitò ad ascoltare senza esporre i fini francesi. Fece un'eccezione per la Palestina e la Siria dove
la Francia possedeva « un prezioso patrimonio di ricordi storici, di interessi morali e materiali" e quindi chiese
l'assenso, subito promesso, alle misure che il suo governo avrebbe ritenute necessarie per la loro difesa ( M.
PALÉOLOGUE, La Russie des Tsars pendant la grande guerre, Paris, 1921, I, pp. 197-202.).
Qualche mese più tardi, in un colloquio del 3 marzo 1915, lo Zar ritornò sull'argomento e, mentre domandava
per la Russia il possesso di Costantinopoli e degli Stretti, per le richieste francesi dichiarò: «Desidero che la
Francia esca da questa guerra il più che sia possibile grande e forte. Io sottoscrivo in anticipo tutto quello che il
vostro governo può desiderare. Prendete la riva sinistra del Reno, prendete Magonza, prendete Colonia,
andate anche più in là se lo ritenete utile. Io ne sarò felice e fiero per voi » (PALÉOLOGUE, Op. cit., p. 33;
POINCARÉ, Au service de la France: Les Tranchées, Paris, 1930, p. 90). Più che una strategia, c'era il livore per i
tedeschi.
In un telegramma dell'8 marzo 1916 ad Iswolski Sazonoff riconfermava che la Russia « era pronta ad
accordare alla Francia ed all'Inghilterra piena libertà nel fissare i confini occidentali della Germania», in
cambio si attendeva altrettanta libertà nello stabilire quelli tedeschi ad est (E. ADAMOW, Die europàische
Màchte und die Turkei wàhrend des Weltkrieges: Kostantinopel und die Meereugen, Dresden, 1930, II, n. 106.).
Insomma il Trattato di Pace (cioè le condizioni) con la Germania a fine guerra, era già stato scritto prima della
guerra. Prima ancora che morissero 10 milioni di soldati. Quella poi di Versailles fu soltanto una sceneggiata e
il patto della Lega delle Nazioni null'altro che carta straccia.
A dire il vero, a non contribuire a rendere sereni e facili i dibattiti di Parigi, e a dar ragione e quindi a
preoccupare la Francia, erano le notizie che venivano dalla Germania: vi era lentezza nella smobilitazione;
c'era il rifiuto di consegnare la flotta; non venivano ritirate le truppe concentrate contro la Polonia; c'era la
resistenza degli ambienti militari a deporre le armi; i giornali riferivano che il maresciallo Hinderburg stava
organizzando un esercito di 600 volontari evocando la rivolta; quella spartachiana era stata appena domata
ma si temeva che il nuovo esercito potesse diventare strumento dei reazionari tedeschi e finisse col marciare
contro Berlino e contro le truppe alleate di occupazione.
Infine il 19 febbraio si aggiunse anche l'attentato a Clemenceau che venne ferito e quindi sospesa la
Conferenza. Ci fu così un ritardo nella prosecuzione dei lavori. Ma quando ripresero anche se l'opera di pace si
concluse, lasciò insoluti i problemi riguardanti una gran parte dell'Europa.
Tutte le critiche fatte al sistema creato a Versailles partono dal presupposto che non solo si sarebbe dovuto,
ma si sarebbe potuto fare meglio. Ma questo era possibile?
Rispose molti anno dopo House "nessuno può dire con certezza se si sarebbe potuto fare meglio in quel
momento in cui si svolgeva il lavoro. Noi ci trovammo in presenza di una situazione gravida di difficoltà,
situazione che non poteva essere affrontata che con uno spirito pieno d'idealismo e spoglio di egoismo. Ora
questo spirito mancava quasi completamente, e sarebbe stato troppo domandarlo ad uomini riuniti in un
momento simile e per un simile scopo" (House, Papiers intimes publieè par, Parigi 1931, IV, p. 530)
In conclusione a Versailles i trattati non stabilirono la pace ma una tregua. Quanto alla Lega delle Nazioni che
doveva evitare future aggressioni non le vennero dati i mezzi per adempiere il suo compito. Perciò in
mancanza di una forza materiale propria, con la quale far rispettare le leggi internazionali, tutta la sua
efficacia dipendeva dalle forze morali.
Ora pensare che queste potessero arrestare i conflitti era un attendersi troppo dalla natura umana.