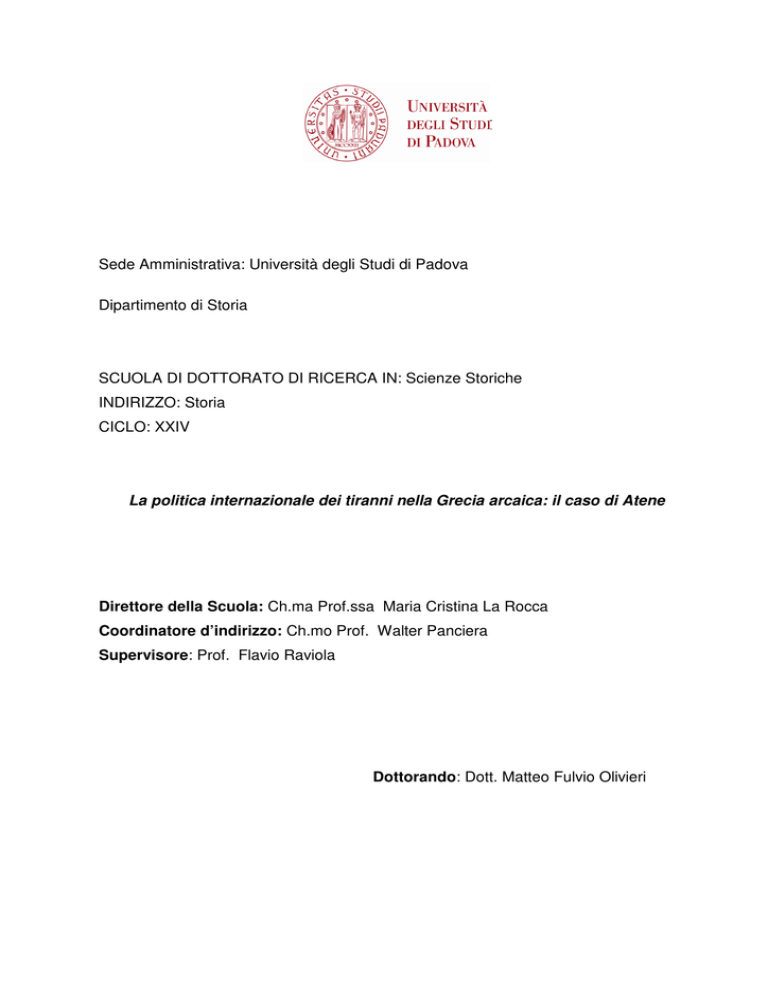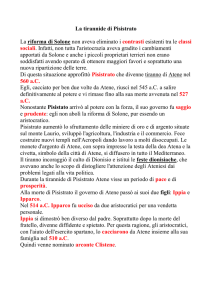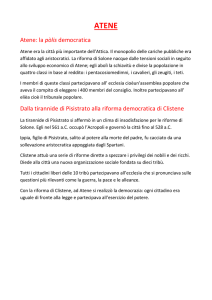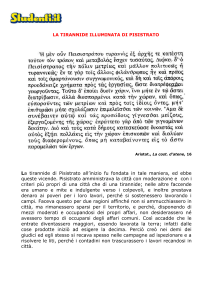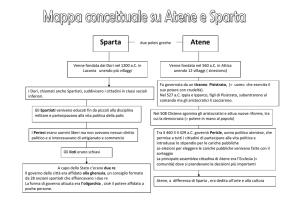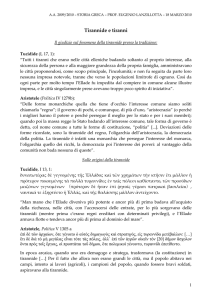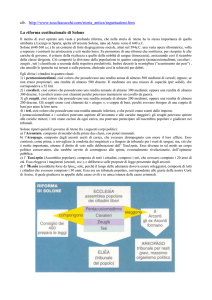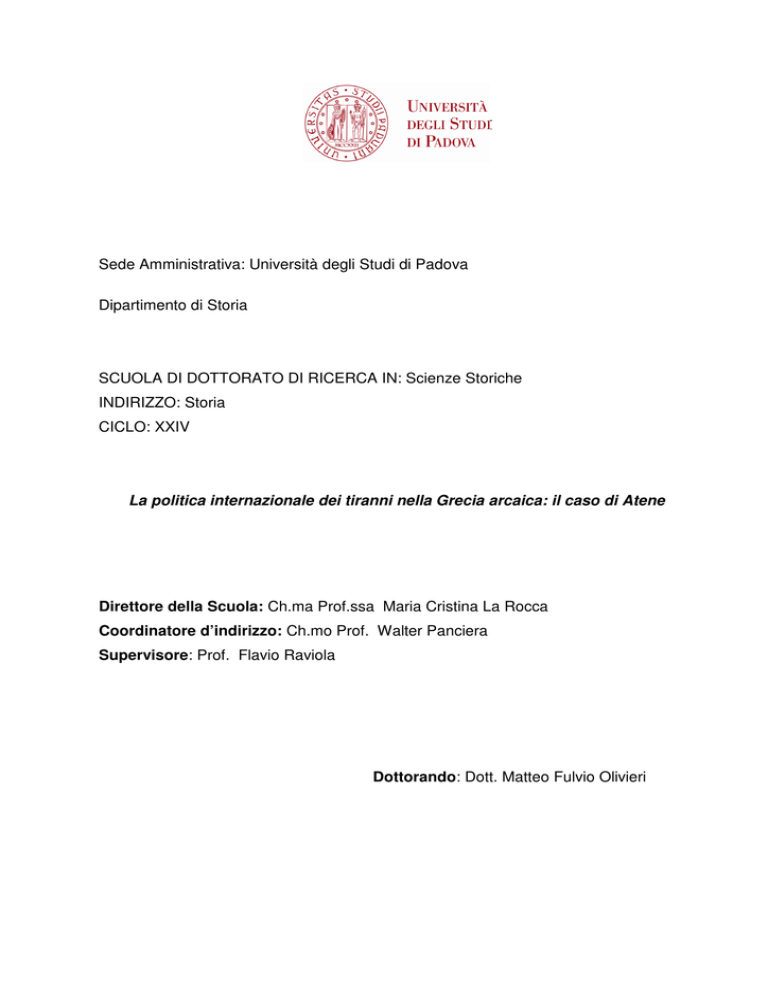
Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Storia
SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN: Scienze Storiche
INDIRIZZO: Storia
CICLO: XXIV
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Direttore della Scuola: Ch.ma Prof.ssa Maria Cristina La Rocca
Coordinatore d’indirizzo: Ch.mo Prof. Walter Panciera
Supervisore: Prof. Flavio Raviola
Dottorando: Dott. Matteo Fulvio Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA DELLA TESI IN LINGUA ITALIANA
La ricerca traccia la storia delle attività sul piano internazionale dei tiranni e delle
principali famiglie aristocratiche di Atene, dalla fine del VII all’inizio del V secolo a.C. Prese in
esame sono sia la sfera privata, ovvero le iniziative e i contatti internazionali di natura
interpersonale e familiare, sia la sfera pubblica, ovvero la conduzione della politica estera e
della diplomazia interstatale di Atene sotto l’influenza della tirannide. L’analisi verifica la
posizione e i moventi tanto dei tiranni, quanto di ogni controparte non-ateniese coinvolta nei
contatti: emerge così un quadro delle reti di alleanze, degli ambiti d’interesse e dei centri di
potere internazionali, dunque una campione significativo del sistema internazionale della
Grecia arcaica.
Nel più antico tentativo tirannico di Cilone e in seguito nelle prime attività di Pisistrato si
identificano istanze della contesa fra Atene e Megara per il controllo di Salamina.
Le prime attestazioni relative a Pisistrato rivelano la rete di contatti e iniziative familiari
che gli assicurarono la presa del potere ad Atene; alla tirannide pisistratide si attribuisce una
strategia marittima che indirizzò Atene verso il controllo delle Cicladi e dell’Ellesponto. Dopo
la morte del padre nel 528/7 a.C. Ippia fu coinvolto nella gestione dei mutamenti e dei tentativi
egemonici che interessarono il sistema interstatale e regionale dell’Attica, della Beozia e della
Tessaglia.
Nel penultimo decennio del VI secolo a.C. l’ostilità fra il tiranno e gli aristocratici ateniesi
divenne critica: furono allora attivate le rispettive reti di alleanze personali dei Pisistratidi e
degli Alcmeonidi loro avversari; in questa situazione emerge la funzionalità dei tradizionali
rapporti fra gli Alcmeonidi e il santuario panellenico di Delfi.
La ricerca ripercorre inoltre la storia della tirannide tenuta nel Chersoneso Tracico dalla
famiglia aristocratica ateniese dei Filaidi. Fra questi e i tiranni pisistratidi esistette un’intesa
interfamiliare volta alla tutela degli interessi strategici internazionali di Atene nell’accesso alla
navigazione dell’Ellesponto.
La parte finale della sequenza cronologica presa in esame è segnata dall’espansione
dell’impero persiano in Europa che sconvolse gli assetti del potere internazionale: i Filaidi
reagirono assumendo una posizione antipersiana; invece i Pisistratidi si associarono
gradualmente alla Persia.
Le conclusioni portano a riflettere sull’indeterminatezza della distinzione fra sfera
pubblica e sfera privata nell’operato dei tiranni; in una prospettiva storica di lungo corso si apre
infine una questione in merito all’individuazione di fenomeni di continuità fra gli obiettivi della
tirannide e gli interessi strategici internazionali dell’Atene democratica nel successivo V secolo
a.C.
International Politics of Archaic Greek Tyrants: the Case of Athens
ENGLISH RÉSUMÉ OF THE THESIS
The research traces the history of the activities of the tyrants and of the major aristocratic
families of Athens on the international level, from the end of the VII to the early V century B.C.
Examined are both the private sphere, thus international initiatives and contacts of interpersonal
and familial nature, and the public sphere, that is the conduction of the foreign policy and
interstate diplomacy of Athens under the influence of the tyranny. The analysis centers upon the
position and motives both of the tyrants as well as of each non-Athenian counterpart involved
in the contacts: in this way a depiction the international alliance networks, areas of interest and
centers of influence takes form, essentially providing a history a case in point for the
international system of archaic age Greece.
In the most ancient tyrannical attempt by Cylon and later in the early activities of
Peisistratus we may identify instances of the clash between Athens and Megara for control over
the island of Salamis. The first attestations relative to Peisistratus reveal the network of
international private contacts and initiatives that ensured his power in Athens; the tyranny of
Peisistratus is attributed with a maritime strategy directed Athens towards control of the
Cyclades and the Hellespont. After the death of his father in 528/7 B.C. Hippias was involved
in the changes and hegemonic attempts that took place within the interstate regional system of
Attica, Boeotia and Thessaly.
From the second last decade of the VI century B.C. hostility between the tyrant and the
Athenian aristocracy came to a critical phase: then the respective personal alliance networks of
the Peisistratids and of their opponents, the Alcmaeonids, were activated; in this context
emerges the functional character of the traditional relations between the Alcmaeonids and the
Panhellenic sanctuary of Delphi.
The research furthermore traces the history of the tyranny held in the Thracian Chersonese
by the Athenian aristocratic family of the Philaids. Between these and the Peisistratid tyrants
there was an interfamily agreement aimed at safekeeping the international strategic interests of
Athens in accessing navigation of the Hellespont.
The final part of the chronological sequence examines the expansion of the Persian
Empire in Europe that revolutionized the assents of international power: the Philaids reacted by
assuming an anti-Persian policy; differently the Peisistratids gradually associated themselves to
Persia.
The conclusions encourage contemplating the undetermined nature of the distinction
between public and private sphere in the tyrants’ activities; a logn term historical perspective
finally unlocks a discussion over the possibility of identifying phenomena of continuity binding
the objectives pursued by the tyranny and the international strategic interests of democratic
Athens in the following V century B.C.
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
LA POLITICA INTERNAZIONALE DEI TIRANNI
NELLA GRECIA ARCAICA:
IL CASO DI ATENE
1
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
2
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
INDICE
INTRODUZIONE
17
Il progetto di ricerca............................................................................................................. 18
Le scelte inclusive ed esclusive nella selezione dei temi .................................................... 19
Metodologia........................................................................................................................... 20
Le fonti
20
L’analisi delle fonti e la contestualizzazione storica
21
La ricostruzione dei fatti
21
I contenuti della tesi ............................................................................................................. 22
PARTE I: ATENE PRIMA DEI PISISTRATIDI
27
I.1. Cilone (636 a.C.)............................................................................................................. 27
Il tentativo di tirannide e il suo fallimento
27
La vittoria olimpica e l’appoggio di Delfi
28
Il matrimonio con la figlia di Teagene di Megara
30
La guerra fra Atene e Megara per il controllo di Salamina
31
Il legame fra aspetti privati e ambito pubblico nel caso di Cilone
33
I.2. Ippocrate, padre di Pisistrato ....................................................................................... 34
Lo spartano Chilone e la profezia sul nascituro Pisistrato
34
La presenza di Ippocrate ad Olimpia
36
La datazione di Chilone
37
L’incontro tra Ippocrate e Chilone
40
La xenìa tra Pisistratidi e Sparta
41
3
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
PARTE II: ATENE E L’ASCESA DI PISISTRATO
45
II.1. Pisistrato: il periodo pre-tirannico e la prima tirannide.......................................... 45
La conquista della prima tirannide
45
Le imprese contro Megara e la conquista di Nisea
46
La conclusione della guerra contro Megara e l’arbitrato dei Lacedemoni: problemi di
datazione
47
L’attacco contro Megara nel quadro delle fazioni politiche ateniesi
54
Pisistrato e la guerra contro Megara nella politica estera filo-corinzia di lungo periodo
56
Il problema della datazione delle tirannidi e degli esìli di Pisistrato
61
La prima tirannide di Pisistrato e il matrimonio con Timonassa di Argo
64
Il matrimonio con Timonassa nel quadro dei gruppi parentelari panellenici
67
II.2. Il primo esilio di Pisistrato .......................................................................................... 70
II.3. La seconda tirannide di Pisistrato .............................................................................. 71
II.4. La politica matrimoniale di Pisistrato e le cause del primo esilio, della seconda
tirannide e del secondo esilio............................................................................................... 72
II.5. Il secondo esilio di Pisistrato ....................................................................................... 74
II.6. Gli insediamenti di Pisistrato in Tracia, a Rhaikelos e sullo Strimone................... 74
La natura para-coloniale dell’insediamento a Rhaikelos
76
Gli obiettivi e le conseguenze dell’insediamento pisistratide in Tracia
78
L’insediamento pisistratide in Tracia alla luce delle relazioni internazionali
79
II.7. La battaglia di Pallene e la lista degli alleati di Pisistrato (546) .............................. 84
Il consiglio tenuto da Pisistrato e i figli e la scelta di rientrare in Atene
84
La lista degli alleati di Pisistrato
87
Eretria
90
Tebe
92
Ligdami di Nasso
94
Argo
96
Altri alleati
100
Corinto
100
Sparta
101
I Macedoni
101
4
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
I Tessali
102
I mercenari traci
103
La questione dello status e della cronologia di Egesistrato
103
PARTE III: GLI ALCMEONIDI, OPPOSITORI DEI PISISTRATIDI
111
III.1. Gli Alcmeonidi contro Cilone e la condanna della famiglia ................................. 111
III.2. L’inizio dei rapporti favorevoli con il santuario di Delfi ...................................... 113
Gli Alcmeonidi e il santuario di Delfi: la svolta della Prima Guerra Sacra (595-591)113
Gli Alcmeonidi come intermediari presso Delfi per i sovrani di Lidia
114
III.3. Il matrimonio di Megacle II con Agariste di Sicione............................................. 117
III.4. Le relazioni fra Alcmeonidi e Pisistratidi ............................................................... 119
Megacle II avversario di Pisistrato: l’alleanza matrimoniale disconosciuta
119
La tirannide di Pisistrato e l’esilio degli Alcmeonidi
126
La lista degli arconti ateniesi: indice di forme di concertazione
131
Il modello storico di un esilio moderato e variabile
133
III.5. La rete delle relazioni internazionali degli Alcmeonidi......................................... 137
PARTE IV: PISISTRATO TIRANNO
141
IV.1. Strategia e diplomazia nelle Cicladi: la conquista di Nasso e la tirannide di
Ligdami................................................................................................................................ 141
La cronologia dell’attacco a Nasso
141
L’accordo tra Pisistrato e Ligdami
142
Ligdami tiranno protettore del popolo
144
Ricostruzione della vicenda, dei moventi politici e della tradizione storiografica
145
Nasso nella strategia internazionale di Pisistrato
148
IV.2. La politica culturale nelle Cicladi: La purificazione di Delo (545 ca.)................. 150
La datazione e le fonti relative alla purificazione di Delo da parte di Pisistrato
150
Il ruolo di Nasso nel controllo di Delo
152
5
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
Il significato ideologico dell’intervento a Delo
153
La scelta dei Pisistratidi di onorare l’Apollo di Delo
155
IV.3. La colonizzazione di Sigeo in Troade...................................................................... 158
Il conflitto di lungo periodo fra Atene e Mitilene per il controllo di Sigeo
159
La data e il contesto storico dell’iniziativa di Pisistrato
161
La storia della condizione politica dell’insediamento di Sigeo
163
La strategia di accesso alle rotte marittime verso la Propontide
168
IV.4. La tradizione sulla conduzione della politica interna da parte dei Pisistratidi (540527) ...................................................................................................................................... 174
IV.5. Le risorse economiche e militari del Pangeo nel mantenimento del potere di
Pisistrato ............................................................................................................................. 175
IV.6. L’esilio e il rientro di Cimone filaide e la proclamazione olimpionica di Pisistrato
(532) ..................................................................................................................................... 177
IV.7. I figli durante la tirannide di Pisistrato .................................................................. 179
Il consiglio ad Eretria in vista del rientro ad Atene (546)
PARTE V: I FILAIDI
180
183
V.1. I Filaidi: la posizione della famiglia nella diplomazia internazionale ................... 183
La prestigiosa parentela dei Filaidi con i Cipselidi di Corinto
183
L’alleanza matrimoniale fra Filaidi e Cipselidi nel contesto internazionale
185
Le vittorie olimpiche di Milziade e Cimone
186
L’intesa fra Filaidi e Pisistratidi
190
Critica della storicità delle notizie sull’assassinio di Cimone
193
V.2. La tirannide dei Filaidi in Chersoneso Tracico ....................................................... 196
Milziade I, la spedizione in Chersoneso e la realizzazione della tirannide secondo Erodoto
196
La data della spedizione in Chersoneso Tracico: 558 ca.
198
L’intesa con i Traci Dolonci e la difesa contro i Traci Apsinti
200
La guerra contro Lampsaco
201
L’intercessione di Creso di Lidia nella guerra fra Milziade e Lampsaco
203
6
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
V.3. Il significato della tirannide di Milziade I in Chersoneso Tracico ......................... 208
La spedizione in Chersoneso Tracico: una fondazione coloniale
208
Lo scenario geo-politico del Chersoneso Tracico
210
Milziade I ecista, tiranno e alleato dei Pisistratidi e la politica estera ateniese per il
controllo dell’Ellesponto
213
V.4. Stesagora, la seconda generazione della tirannide del Chersoneso Tracico (525-520
ca.) ........................................................................................................................................ 218
Continuità dinastica della tirannide e natura del conflitto fra il Chersoneso Tracico e
Lampsaco
220
L’internazionalismo dei Filaidi
221
V.5. Milziade II figlio di Cimone....................................................................................... 223
V.5.1. La carriera di Milziade II e l’assunzione della tirannide in Chersoneso Tracico
.............................................................................................................................................. 223
L’intesa interfamiliare fra Pisistratidi e Filaidi nella generazione di Ippia e Milziade 224
V.5.2. Milziade II e il conflitto con i dinasti del Chersoneso .......................................... 228
Situazione politico-sociale del Chersoneso Tracico nel 520 ca.: poleis e dinasti locali229
L’opposizione aristocratica ellenica locale e l’involuzione autocratica della tirannide di
Milziade II
230
Stesagora tiranno indesiderato
234
V.5.3. Il matrimonio con Egesipyle e l’alleanza con Oloro re dei Traci (516-510)....... 236
La datazione della sequenza di eventi: 520-515 ca.
238
L’intesa politica fra Milziade II e Oloro re dei Traci
239
I Filaidi come interpreti delle necessità strategiche internazionali della comunità ateniese
in Tracia
240
V.5.4. Imperi orientali e Greci d’Asia Minore: poleis e tiranni ellenici
nell’amministrazione persiana .......................................................................................... 243
Casi di relazione fra sovrani persiani e tiranni greci
246
La spedizione scitica di Dario (513-512)
247
L’assemblea dei Greci all’Istro: i tiranni filo-persiani e le poleis anti-tiranniche
249
I tiranni favoriti da Dario I
251
La conquista persiana della Tracia (513-512)
253
7
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
Otane e la riconquista delle poleis elleniche anti-persiane (512-511)
254
Il nuovo sistema internazionale dell’egemonia persiana: il contesto per le scelte di Ippia e
Milziade II nell’ultimo quarto del VI secolo
255
V.5.5. Milziade II alleato di Dario durante la Spedizione Scitica (513) ........................ 257
Esiti svantaggiosi per i Filaidi nella fine del regno di Lidia dei Mermnadi
257
Un’ipotesi per l’istituzione dei contatti fra Milziade II e Dario
258
Obiezioni alla storicità dei discorsi all’Istro
260
Ricostruzione della storicità dei fatti dell’Istro
261
Le ragioni della posizione antipersiana di Milziade II
264
V.5.6. La strategia antipersiana di Milziade II (512-493)............................................... 266
Interpretazione di Erodoto VI, 40 sulla fuga dal Chersoneso Tracico
267
L’occupazione discontinua del Chersoneso Tracico da parte di Milziade II
269
La ritorsione persiana a seguito della sedizione di Milziade II all’Istro
269
L’alleanza di Milziade II con i Traci
270
La fuga dal Chersoneso Tracico come scelta di mobilità strategica
271
V.5.7. Il corno di Amaltea dedicato ad Olimpia da un Milziade e i suoi soldati .......... 272
L’attribuzione di Pausania a Milziade I
273
Attribuzione a Milziade II e a i suoi mercenari
274
La fortezza di Arato: insediamento di Traci ostili
276
La data, le circostanze e il significato della dedica di Olimpia
276
V.5.8. La conquista di Lemno e Imbro da parte di Milziade II (500 ca.)...................... 277
Le mire internazionali su Lemno nella rievocazione storiografica
278
Testimonianze epigrafiche ed archeologiche del popolamento ateniese di Lemno
280
La questione della datazione della conquista di Milziade II
280
La conquista di Lemno da parte di Milziade II entro la storia del sistema internazionale
282
Il significato politico della conquista di Lemno e i moventi dei soggetti coinvolti
283
La natura della collaborazione fra Milziade II e la polis di Atene
285
Strumentalizzazione della mito-storia dei Pelasgi da parte di Milziade II
287
La conquista di Imbro insieme a Lemno
287
V.5.9. La repressione della rivolta ionica e la fine della tirannide filaide in Chersoneso
Tracico (493) ....................................................................................................................... 289
8
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
Il movente dei Persiani: il coinvolgimento di Milziade II nella rivolta ionica
289
La posizione strategica di Cardia
291
V.6. La cattura di Metioco e la sua naturalizzazione in Persia (493) ............................ 291
Ipotetica parentela di Metioco con Ippia
292
Metioco come ostaggio di riguardo
293
Metioco entro l’élite achemenide
294
PARTE VI: LA TIRANNIDE DI IPPIA (527-510; 510-490)
295
VI.1. Il rapporto storico fra le tirannidi di Pisistrato e Ippia ........................................ 295
VI.2. La tirannide di Ippia alla morte di Pisistrato (528/7) ............................................ 296
VI.3. La politica culturale internazionale di Ipparco..................................................... 297
Simonide e Anacreonte alla corte dei Pisistratidi
297
VI.4. L’insediamento pisistratide sul fiume Strimone in Tracia durante la tirannide di
Ippia (558-513 ca.) .............................................................................................................. 301
VI.5. L’esclusione dei Pisistratidi dalle Cicladi ............................................................... 304
La talassocrazia di Policrate di Samo
304
L’alleanza fra Ligdami e Policrate
306
Policrate nuovo prostàtes di Delo
309
La tirannide di Ippia: l’abbandono delle Cicladi
310
La spedizione spartana nelle Cicladi e a Samo e l’astensione di Ippia (525-524)
312
Il rientro degli esuli da Nasso
314
Diffusione della ceramica attica a figure rosse e della ceramica samia
315
VI.6. L’invio di Milziade II in Chersoneso Tracico (520 ca.) ......................................... 316
L’intesa interfamiliare fra Pisistratidi e Filaidi nella generazione di Ippia e MilziadeII 317
Il controllo del Chersoneso Tracico: interessi familiari e interessi pubblici
319
VI.7. Ippia nelle relazioni internazionali con la Beozia e i Tessali................................. 320
La datazione dell’alleanza fra Atene e Platea: 519 contra 509
322
La relazione istituita fra Atene e Platea: un’alleanza con egemonia ateniese
325
L’altare dei Dodici Dei e il ruolo dei Pisistratidi nell’alleanza fra Atene e Platea
330
Le istanze autonomistiche nelle ragioni di Platea
337
9
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
Le ragioni di Ippia e Atene: l’opposizione a Tebe e la politica filo-tessala
340
VI.8. La dedica di Ipparco presso il santuario di Apollo Ptoios in Beozia (520 ca.) .... 345
Il santuario di Apollo Ptoios in Beozia
345
La dedica di Ipparco come controparte della politica di Ippia
347
La dedica di Alcmeonide figlio di Alcmeone al santuario di Apollo Ptoios
348
VI.9. Il tirannicidio di Ipparco (514) e la crisi del rapporto con l’aristocrazia ateniese
.............................................................................................................................................. 349
La tradizione sull’esilio degli Alcmeonidi e le relazioni della tirannide con gli
aristocratici
350
Il tirannicidio nel 514 e l’espulsione degli Alcmeonidi
351
VI.10. Il tentativo di rientro degli esuli e degli Alcmeonidi a Leipsydrion (513) ......... 353
Gli ospiti degli esuli ateniesi: Delfi e la Beozia filo-tebana
354
I motivi della sconfitta e il segno della nuova strategia diplomatica degli Alcmeonidi 355
VI.11. L’alleanza matrimoniale di Ippia con i tiranni di Lampsaco (513 ca.) ............. 356
La ricerca di alleati e di un asilo in ambito internazionale
357
L’intesa politica fra Ippia e Ippoclo di Lampsaco
359
Ippoclo favorito presso il Gran Re Dario I
360
Le ragioni di Ippia nell’alleanza con Ippoclo di Lampsaco
361
Le ragioni di Ippoclo ed Eantide
362
L’alleanza matrimoniale nella strategia internazionale dei tiranni di Lampsaco
363
L’alleanza di Ippia con Lampsaco nel quadro dell’espansione persiana in Europa
363
VI.12. La rottura dell’alleanza familiare fra Pisistratidi e Filaidi: opposte strategie nei
confronti dell’impero persiano ......................................................................................... 366
L’espansione persiana e i vantaggi acquisiti dai nemici dei Pisistratidi e di Atene
368
Il matrimonio di Archedice con Eantide come reazione al matrimonio di Milziade II con la
Trace Egesipyle
369
VI.13. L’appoggio del santuario di Delfi agli Alcmeonidi contro la tirannide di Ippia
(513) ..................................................................................................................................... 370
La tradizione delle fonti sul ruolo degli Alcmeonidi, di Delfi e di Sparta
370
La critica della tradizione sviluppo diacronico degli eventi e ricerca dei nessi causali
373
Delfi come autorità morale e centro di attività internazionale per gli Alcmeonidi
10
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
376
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
VI.14. Gli interventi di Sparta contro Ippia e l’espulsione della tirannide da Atene (513510)....................................................................................................................................... 377
L’intesa fra Sparta, gli esuli ateniesi e Delfi
379
La data dell’intervento di Anchimolo
381
L’alleanza dei Pisistratidi con Argo come causa dell’intervento spartano
382
VI.15. La xenìa fra Pisistratidi e Sparta ........................................................................... 384
Un’alleanza interstatale per Sparta
384
L’istituzione della xenìa al tempo dell’incontro fra Ippocrate e Chilone
386
La strumentalizzazione della tradizione ai fini della politica attica di Cleomene
387
VI.16. L’espulsione dei Pisistratidi da Atene e la continuazione della tirannide a Sigeo
(510) ..................................................................................................................................... 389
Ippia tiranno al Sigeo
391
Le ragioni dell’alleanza di Atene con la Persia (507)
391
VI.17. La politica internazionale egemonica di Sparta: l’utilitarismo negli interventi
contro Atene ........................................................................................................................ 393
La potenza di Sparta nell’Ellade e nel Mediterraneo
393
Le spedizioni spartane in favore di Isagora (508-507)
395
VI.18. Gli obiettivi di Sparta nel propugnare il ritorno di Ippia ad Atene (504 ca.) ... 397
La localizzazione dei Pisistratidi a Sigeo
398
Il rientro ad Atene nelle prospettive di Ippia
399
VI.19. La strategia di Sparta nei confronti di Atene: l’insediamento di un governo filospartano ............................................................................................................................... 400
VI.20. L’intervento dei Tessali in difesa di Ippia ............................................................ 405
La symmachìa fra Ippia e il koinòn dei Tessali
405
Questioni di carattere strategico in merito alla presenza dei Tessali in Attica
407
VI.21. La concessione di Iolco ad Ippia esule da parte dei Tessali (504 ca.)................. 409
L’offerta di Iolco: la tirannide o la dynastèia sull’insediamento
410
VI.22. Le relazioni internazionali fra Pisistratidi e Tessali sul lungo periodo.............. 412
La preesistente alleanza di Pisistrato con i Tessali (560-546)
412
11
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
Da Pisistrato ad Ippia: la rifunzionalizzazione anti-beotica dell’intesa con i Tessali 413
L’offerta di Iolco
415
L’intesa strutturale fra Tessali e Pisistratidi
416
VI.23. L’offerta di Antemunte ad Ippia esule da parte del sovrano macedone Aminta
(504 ca.) ............................................................................................................................... 417
L’offerta della tirannide entro il legame di fedeltà alla dinastia macedone
417
Antemunte: storia e status geopolitico
418
Le ragioni di Aminta e di Ippia nell’offerta di Antemunte
420
L’intesa fra Ippia e Aminta alla luce della storia dei precedenti contatti fra Pisistratidi e
Argeadi
421
L’affinità tra Argeadi e Pisistratidi nella scelta di medizzare
424
VI.24. I Pisistratidi rimasti ad Atene dopo l’espulsione della tirannide (510-487) ...... 425
Il modello storico dell’esilio moderato
426
L’ambasceria ateniese ad Artafrene (507): intervento filo-persiano dei Pisistratidi rimasti
ad Atene
426
L’allontanamento dei Pisistratidi ateniesi dopo la Prima Guerra Persiana
427
PARTE VII: I PISISTRATIDI E L’IMPERO PERSIANO
429
VII.1. Il ricollocamento di Ippia e dei Pisistratidi nelle relazioni internazionali con
l’impero persiano (514-490) .............................................................................................. 429
Le attestazioni dei contatti fra Ippia e l’impero persiano e la loro datazione (514-490)
430
VII.1.1. Fase I dei contatti dei Pisistratidi con la Persia: l’espansione persiana in
Ellesponto e gli interessi regionali di Sigeo (514-510)..................................................... 434
Il ruolo di Sigeo entro l’impero persiano e l’estraneità dei Pisistratidi rispetto all’élite
filo-persiana
435
L’alleanza con i tiranni di Lampsaco: interessi regionali di Sigeo
436
VII.1.2. Fase II dei contatti dei Pisistratidi con la Persia: la nuova tirannide di Ippia a
Sigeo (510-504).................................................................................................................... 436
L’alleanza fra Atene e la Persia (507 ca.)
437
Le ancora deboli relazioni di Ippia con gli Achemenidi
438
12
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
Le alleanze nella Grecia continentale nei progetti di Ippia
439
VII.1.3. Fase III dei contatti dei Pisistratidi con la Persia: Ippia associato al satrapo di
Sardi (504-500).................................................................................................................... 440
Dai progetti di alleanza in Ellade all’alleanza con la Persia
441
L’associazione con la Persia: un tiranno hýparchos degli Achemenidi ad Atene
442
La rottura dell’intesa fra Atene e la Persia
444
VII.1.4. Fase IV dei contatti dei Pisistratidi con la Persia: la rivolta ionica (500-493) 445
Ipotesi sull’estraneità di Sigeo alla rivolta ionica
445
Cause di attrito fra Atene e la Persia
446
La rivolta ionica
448
VII.1.5. Fase V dei contatti dei Pisistratidi con la Persia: la prima guerra persiana per
la conquista di Atene e il tentativo di ripristino della tirannide di Ippia (490) ............ 448
La conquista di Atene nei progetti persiani e nei consigli di Ippia
449
Il ruolo di Ippia durante la spedizione
450
La prospettiva di una conquista pacifica
451
VII.2. I Pisistratidi della generazione successiva a Ippia alla corte di Serse durante la
seconda guerra persiana (486-480) ................................................................................... 452
I Pisistratidi presso Serse nell’eziologia della seconda guerra persiana (486)
454
I Pisistratidi con Serse durante la seconda guerra persiana (480)
456
CONCLUSIONE
459
Il modello storico della tirannide: ambito privato e ambito pubblico........................... 459
Le istituzioni della politica internazionale del tiranno.................................................... 461
L’ambito regionale: caratteri strategici e politici peculiari fra livello locale e livello
internazionale...................................................................................................................... 463
Continuità e discontinuità nella storia della tirannide e nel passaggio alla polis di V
secolo.................................................................................................................................... 465
BIBLIOGRAFIA
469
13
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice
APPENDICE: ENGLISH ABSTRACT
499
INTERNATIONAL POLITICS OF ARCHAIC GREEK TYRANTS: THE CASE OF ATHENS ........ 499
The research project .......................................................................................................... 500
Inclusive and exclusive choices in the selection of issues................................................ 501
Methodology ....................................................................................................................... 502
The sources
502
Source analysis and historical contextualisation
503
Reconstructing the events
503
Contents of the Thesis........................................................................................................ 505
Part I: Athens before the Peisistratids
505
Part II: Athens and the Rise of Peisistratus
506
Part III: the Alcmaeonids, opponents of the Peisistratids
510
Part IV: The Tyranny of Peisistratus
514
Part V: the Philaids
517
Part VI: the Tyranny of Hippias
522
Part VII: Peisistratids and the Persian Empire
527
Conclusions
530
14
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Indice delle illustrazioni
INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI
Fig. 1: il Golfo Saronico, Atene, Megara e Salamina
p. 33
Fig. 2: gli alleati e le risorse di Pisistrato in occasione della battaglia di Pallene
(546)
p. 90
Fig. 3: Atene, Samo e lo scenario delle Cicladi
p. 150
Fig. 4: genealogia dei Filaidi secondo la ricostruzione degli eventi proposta in
questo scritto
p. 186
Fig. 5: il Chersoneso Tracico, le poleis e le fondazioni interessate dall’attività dei
Filaidi
p. 222
Fig. 6: trireme Olympias varata dalla marina militare greca nel 1987
<http://www.hellenicnavy.gr>
p. 227
Fig. 7: le poleis elleniche che fornirono la flotta per la spedizione scitica di Dario I
p. 249
Fig. 8: Persepoli, rilievo dell’Apadana, probabile processione dei Traci
<www.livius.org>
p. 254
Fig. 9: Ricostruzione della struttura di V secolo dell’altare dei Dodici Dei (CAMP
2003, p. 3)
p. 332
Fig. 10: l’Agora di Atene: in evidenza il perimetro dell’altare dei Dodici Dei e il
percorso della Via Panatenaica (CAMP 2003, p. 3)
p. 334
Fig. 11: la Beozia e la regione del confine attico-beotico, con indicazione delle
località discusse
p. 340
Le carte sono state realizzate dall’autore con l’ausilio del software Google Earth; lo schema in fig. 4 è stato
realizzato dall’autore; le fonti delle immagini sono indicate in didascalia.
15
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
16
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
INTRODUZIONE
La tirannide costituisce uno dei fenomeni più notevoli dell’epoca arcaica; nello sviluppo
della storia della Grecia e delle poleis l’operato dei tiranni segna un momento di discontinuità.
La preservazione dello status quo era stata una delle caratteristiche della politica dei governi
aristocratici, nella concertazione del potere fra gli esponenti politici, nelle suddivisioni sociali
ed economiche, nella vita politica interna come nella proiezione della polis sul piano
internazionale. Il tiranno scardinò la concertata e condivisa conduzione della politica perché
sbilanciò l’equilibrio del potere accentrando su di sé e sulla propria famiglia la direzione della
polis.
La discontinuità che la tirannide segna nella storia della polis si riconosce nel nuovo
dinamismo che la sua direzione politica impartisce a vari livelli della politica e della società. Il
carattere intraprendente dell’azione dei tiranni emerge tanto nella gestione delle rispettive
poleis quanto nella loro autoaffermazione entro il sistema internazionale della Grecità. Emerge
per tutte le tirannidi una profonda attenzione all’ambito internazionale, nello stringere contatti
personali o interpersonali con altri soggetti rilevanti, oppure nell’indirizzare la politica estera
delle rispettive poleis1.
Le ragioni del dinamismo con cui il tiranno si affacciò al di fuori della propria polis
devono essenzialmente ricondursi alla forma del suo potere autocratico. Il tiranno afferma il
proprio potere politico personale a scapito dell’aristocrazia locale: è perciò generalmente
preclusa al tiranno la costruzione di intese affidabili con i concittadini aristocratici suoi pari; al
contrario le famiglie aristocratiche locali unendo le proprie forze contro la sua autorità. Diviene
dunque essenziale per il tiranno appoggiarsi ad una rete di contatti e alleanze con soggetti di
pari levatura, potere e capacità al di fuori della sua polis, sul piano internazionale: alleati
internazionali disinteressati ad acquisire potere personale nella sua polis possono garantire
strumenti necessari a preservare la sua posizione di comando, intervenendo dall’esterno,
fornendo le risorse di volta in volta necessarie, oppure offrendo ospitalità e rifugio sicuri. Per
altro verso l’autoaffermazione del tiranno entro l’élite panellenica costituisce un motivo di
prestigio e legittimazione parimenti fra i Greci e fra i suoi concittadini. Altra causa dello
speciale attivismo dei tiranni sul piano internazionale si riconduce al fatto che questi sono in
1
URE 1922; WHITE 1955; ANDREWES 1958, pp. 7-19; BERVE 1967, pp. 3-122; MOSSÉ 1969, pp. 3-10; SNODGRASS
1980, pp. 90-116; HAMMOND 1982 b, pp. 341-359; MCGLEW 1994; MURRAY 1996, pp. 169-194; CAWKWELL
1995; DE LIBERO 1996, pp. 389-417; STEIN HÖLKESKAMP 1996; MORGAN 2003; MUSTI 2006, pp. 160-178, 233251; PARKER 2007, pp. 13-39; STEIN HÖLKESKAMP 2009, pp. 100-116.
17
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
grado di esercitare sulla polis un controllo centralizzante, pervasivo e soprattutto continuativo:
ciò consente di impiegare le risorse del tiranno medesimo e insieme della comunità secondo
direttrici strategiche chiare, anno dopo anno, da una generazione a quella successiva ed
omogeneamente in tutti gli ambiti, diplomatici, militari o strategici in cui il tiranno e i suoi
affiliati godono di libertà di azione2.
Il nuovo dinamismo delle relazioni internazionali di cui sono protagonisti i tiranni trova
anche una causa strutturale e storica nell’espansione stessa della Grecità in epoca arcaica: cioè
da un lato nella colonizzazione e d’altro lato nel contatto con le civiltà orientali3. Nel momento
dunque in cui i Greci assunsero una più coerente coscienza della propria identità culturale (tò
Hellenikòn) si diede anche nuova propulsione alla costruzione dei contatti fra poleis e poleis e
fra Greci e Barbari e su areali più ampi4. La consolidata tradizione diplomatica delle civiltà
orientali poté fornire utili modelli alla messa a punto delle necessarie istituzioni5. Questa
riflessione si innestò a sua volta su una tradizione antropologica di contatti interfamiliari e
interpersonali aristocratici e di solide istituzioni di reciprocità testimoniata già precocemente
dalla diplomazia dei basiléis omerici6.
I tiranni giunti al potere nelle poleis elleniche da subito proiettano le proprie personalità e
le proprie poleis sul piano internazionale, seguendo i fermenti della loro epoca e perseguendo
tanto il proprio vantaggio personale e dei loro affiliati, quanto quello delle proprie poleis e dei
propri concittadini. L’ampia diffusione della tirannide nelle poleis greche, le reti di molteplici
contatti personali e pubblici costruite dai tiranni e contemporaneamente il riconfigurarsi di una
nuova mappa della Grecità nell’epoca arcaica fondano in conclusione il presupposto secondo
cui lo studio della politica internazionale dei tiranni arcaici finisce col fornire de facto una
ricostruzione dell’intero sistema internazionale della Grecia e del Mediterraneo.
Il progetto di ricerca
L’obiettivo della ricerca è quello di fornire una raccolta e uno studio di tutte le attestazioni
di contatti e di attività condotte dai tiranni di Atene al di fuori della polis nell’epoca arcaica.
2
ROBINSON 1936, pp. 68-71; DEN BOER 1969; MOSSÉ 1969, pp. 87-90; DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 92-116;
GERNET 1983, pp. 277-285; HERMAN 1987, pp. 28-29, 73-106; DE LIBERO 1996, pp. 389-413; MURRAY 1996, pp.
169-178; NIPPEL 1996, pp. 168-169; STEIN HÖLKESKAMP 1996, pp. 653-679; HARRIS 1997, pp. 58s.; LAVELLE
1997; MITCHELL 1997, pp. 46-51; SALMON 1997, pp. 195-229; BERENT 2000, p. 260-280; WILSON 2000, pp. 640641; ANDERSON 2005; MUSTI 2006, pp. 160-178; HALL 2007, pp. 138-145; MAZZARINO 2007, p. 27; STEIN
HÖLKESKAMP 2009, pp. 114-115.
3
WHITE 1961, pp. 450-454; NENCI 1981; CAMASSA 1996, pp. 565-567; MURRAY 1996, pp. 129-154
4
PHILLIPSON 1911, pp. 27-64; CALABI 1953; SNODGRASS 1980, pp. 49-84; CAMASSA 1996, soprattutto pp. 565567; DAVERIO ROCCHI 1999, pp. 19-66; MORRIS 2009, pp. 64-80.
5
NENCI 1981; BURKERT 1992; MURRAY 1996, pp. 105-128; NIPPEL 1996, p. 166;
6
MITCHELL 1997, pp. 23-51; JONES 1999, pp. 13s.; BERENT 2000.
18
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
I soggetti presi in esame sono in primo luogo gli individui e le famiglie tiranniche: Cilone,
tutte le generazioni dei Pisistratidi, i Filaidi che tennero una tirannide nel Chersoneso Tracico.
Riceve trattazione anche la famiglia degli Alcmeonidi nonostante non fossero tiranni: anch’essi
nondimeno sono al centro di un’attiva rete di alleanze internazionali la cui ricostruzione
fornisce, per difetto, il quadro degli ambiti preclusi all’iniziativa dei Pisistratidi. Insieme ai
soggetti ateniesi la ricerca ha considerato con altrettanta attenzione lo studio delle loro
controparti nei contatti al di fuori di Atene: altri tiranni o altre famiglie aristocratiche, poleis,
èthne, sovrani e re, santuari, comunità e unità sociali non solo entro la Grecia, ma anche popoli
anellenici quali Lidi, Traci, Persiani e le loro eventuali istituzioni entrate in azione.
Il criterio per la selezione delle attività è ampiamente inclusivo: si esamina qualunque
forma di contatto, iniziativa, o attività che esuli dal territorio di Atene, in cui ebbero un ruolo i
soggetti tirannici o para-tirannici ateniesi. Rientrano nella ricerca i contatti interpersonali e
familiari: forme di reciprocità, philìa, xenìa, matrimonio, adozione, aiuto nella forma di
trasferimento di risorse o di pressione diplomatica, attività presso i santuari. Altrettanto però le
attività internazionali dei tiranni riguardano la politica estera di Atene: perciò nella casistica
presa in esame si riscontrano anche alleanze e trattati, symmachìa, xenìa metapoleica, guerra,
sinecismi e forme di sympolitèia, fondazioni coloniali, attività commerciale o navale.
L’obiettivo primario della ricerca è di ricostruire una storia diacronica delle attività extrapoleiche dei tiranni di Atene e in senso lato delle famiglie ad essi associate o avverse, nonché
della conduzione della politica estera di Atene durante il governo di tali soggetti. Risultato
complementare è quello di fornire il quadro storico di un segmento del sistema internazionale
della Grecia e del Mediterraneo in epoca arcaica.
Le scelte inclusive ed esclusive nella selezione dei temi
L’ampiezza degli obiettivi e dei temi inclusi nella ricerca impone le scelte terminologiche
compiute nel titolo al fine di conservare il carattere inclusivo dell’approccio adoperato. Si è
scelto di individuare il soggetto della ricerca nella “politica internazionale”, piuttosto che
definirlo come “relazioni internazionali”, oppure “contatti internazionali”. La scelta compiuta
lascia aperto riferimento sia alle iniziative private del tiranno che alla sua gestione “pubblica”
della polis. In entrambi gli ambiti l’attività e gli obiettivi del tiranno furono essenzialmente
politici: orientati alla preservazione del suo potere oppure della posizione della propria polis.
Si è scelto l’aggettivo apparentemente anacronistico di “internazionale”, piuttosto che
definire il tema con le locuzioni “politica interfamiliare”, “politica interpoleica”, oppure
“interstatale”. Le alternative limiterebbero la definizione ad una o più categorie di interlocutori
19
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
dei tiranni, oppure ad un ambito specifico delle loro iniziative in senso politico o in senso
culturale. Per preservare la varietà e l’ampiezza politica, sociale e culturale delle interazioni e
dell’attività dei tiranni, “politica internazionale” pare dunque essere la definizione più inclusiva.
La ricerca è incentrata sulla storia della polis di Atene e dei soggetti con essa entrati in
contatto: una serie di ragioni metodologiche e pratiche fondano questa scelta. Fin dall’analisi
preliminare delle fonti questa polis ha dimostrato rispetto alle altre una sproporzionata
ricchezza di documentazione utile; ad Atene afferiscono numerosi individui tirannici e
altrettante personalità anti- o para-tiranniche, quando si considerino tutti i membri dei
Pisistratidi, dei Filaidi e degli Alcmeonidi e le loro reti di affiliati. Le famiglie tiranniche
ateniesi e la polis di Atene forniscono una serie di istanze di attività internazionali
particolarmente numerosa; inoltre questi soggetti spinsero quelle attività su un esteso areale
geopolitico. In questo senso dunque la narrazione storica incentrata su Atene, insieme all’analisi
attenta delle controparti internazionali, fornisce la traccia per fare luce su molte delle
circostanze e dei fenomeni che formano il più ampio sistema internazionale della Grecità e
dell’Egeo nella seconda metà del VI secolo.
Metodologia
Le fonti
Il lavoro di ricerca è iniziato, come è ovvio, da uno spoglio delle fonti storiografiche e più
in generale letterarie, tra cui campeggiano Erodoto, Tucidide, l’Aristotele dell’Athenàion
Politèia e Plutarco; obiettivo preliminare è stato quello di compilare una raccolta delle
attestazioni delle attività extra-poleiche dei tiranni; si sono prese in considerazione buona parte
delle poleis tiranniche arcaiche che pure non sono confluite nell’esposizione, ma hanno
d’altronde fornito un bacino di testimonianze importante per disporre di termini di paragone per
l’analisi delle tirannidi ateniesi.
L’esposizione di ciascun caso di studio prende dunque l’avvio dalle notizie reperite
tramite lo spoglio della documentazione letteraria; questa, quando possibile, viene in ogni caso
integrata con i dati forniti dall’epigrafia, dall’archeologia e a volte dalla numismatica. La
definizione inclusiva che si è adottata della politica internazionale tirannica rende conto del
fatto che il tiranno non solo era impegnato nella costruzione dei contatti interpersonali e
familiari, ma altrettanto egli era l’esponente sul piano internazionale dei propri concittadini
nelle questioni interstatali e soprattutto era uno dei principali soggetti coinvolti nella scelta e
nella conduzione della politica estera della polis. In questo senso dunque nella storia
dell’attività internazionale dei tiranni ateniesi vengono coinvolti fenomeni economici e sociali
20
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
di portata appunto pubblica e civica, per i quali le fonti materiali costituiscono testimonianze
importanti. Fonti epigrafiche ed archeologiche e le strategie economiche e sociali su cui
informano, costituiscono altresì un termine per verificare la storicità, l’efficacia oppure la
ricaduta civica delle iniziative internazionali attribuite al tiranno.
L’analisi delle fonti e la contestualizzazione storica
In ogni caso di studio in cui si introduce una nuova testimonianza storiografica si procede
sempre ad una critica di ciascuna fonte: sia con una riflessione sui propositi politici e storici
dell’autore, sia con l’analisi narratologica del passo in sé e della sua funzione nel progetto
dell’opera. La presente ricerca fonda i propri presupposti anche sulla definizione delle
istituzioni e delle forme di contatto che furono gli strumenti della politica internazionale
tirannica; d’altro canto la ricostruzione della storia dell’epoca arcaica risente sempre del divario
temporale fra gli eventi e le fonti storiografiche che ne tramandarono la storia: nella critica delle
fonti si presta dunque attenzione speciale all’analisi del lessico istituzionale sia per identificare
la portata politica dei contatti, sia per escludere la possibilità di interpretazioni anacronistiche.
Questa rilettura critica preliminare dei dati e delle fonti mira in conclusione a verificare la
storicità delle informazioni pervenute e dunque infine a ricomporre una più sicura ricostruzione
degli eventi.
Tale ricostruzione storica si combina in ciascun caso ad un lavoro sulla collocazione
cronologica degli eventi, relativa oppure assoluta. In merito alla cronologia, la ricerca moderna
su molti eventi dell’epoca arcaica dimostra spesso una varietà di posizioni e la difficoltà di
disporre di una communis opinio incontestabile; proprio l’approccio internazionale, mettendo in
contatto soggetti e poleis fra loro distanti, ha qualche volta fornito nuovi termini di confronto
cronologico.
La ricostruzione dei fatti
Si apre a questo punto la via alla discussione storica, alla ricerca causale, all’analisi vera e
propria del contatto o dell’iniziativa tirannica. Una necessità imprescindibile è quella di
individuare in maniera precisa e critica gli attori coinvolti: definire cioè il valore, il peso e la
rappresentatività politica delle controparti attive nel contatto. In questa fase si verifica se e in
che misura il tiranno e la controparte agiscono a titolo personale o pubblico.
Chiariti i soggetti, si discute sempre della forma in cui avviene il contatto o l’intervento
extra-poleico: ci si chiede insomma quali strumenti diplomatici vengono di volta in volta
adoperati. In questa discussione riemerge l’utilità dell’analisi testuale e lessicale preliminare.
21
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
Una comprensione appropriata degli strumenti messi in atto porta alla luce il valore più o meno
vincolante delle relazioni in esame.
Questa sezione analitica dell’esposizione richiede sempre una contestualizzazione degli
eventi. La contestualizzazione è politica, geografica e storica e riguarda sempre entrambe le
controparti dei termini dei contatti presi in esame.
Fulcro dell’analisi è la comprensione dei nessi causali, dei moventi e degli obiettivi
inerenti alle scelte dei tiranni e dei loro interlocutori nella conduzione della politica
internazionale. Si riscontra spesso l’opportunità di esporre i moventi dei tiranni entro molteplici
livelli: gli obietti perseguiti rispondono infatti quasi sempre sia a interessi personali che a quelli
della famiglia, sia agli interessi della rete di alleati che alle necessità della polis.
In ultima istanza, oppure in capitoli specifici, la ricostruzione che ha preso forma viene
inserita in una prospettiva diacronica sia, specificamente, dell’attività internazionale del tiranno
e della sua famiglia, sia dello sviluppo del sistema internazionale, in senso lato. Si cercano cioè
le premesse storiche che condussero alle circostanze del caso; per converso si indaga sullo
sviluppo successivo degli eventi messi in moto dall’intervento del tiranno. Questo tipo di analisi
ha, in molti casi, approfondito i nessi causali e le origini del caso di studio. Il risultato di questa
verifica è di comprendere come il tiranno si inserisce in una tradizione di famiglia oppure entro
la politica estera di lungo corso, ovvero strutturale, della propria polis. In altri termini dunque si
vuole mettere in evidenza il significato storico del tiranno e della sua politica internazionale.
In conclusione si ritiene che il metodo analitico seguito giunga a ricostruire la politica
internazionale dei tiranni sia nelle circostanze immediate, sia nelle cause profonde e di lungo
corso; si mettono in luce le premesse, le connessioni e le ricadute delle attività extra-poleiche
entro gli obiettivi di potere del tiranno stesso così come nella storia della polis. L’approccio è
inclusivo: in tutti i passaggi cioè si dedica all’oggetto o alla controparte dell’attività del tiranno
al di fuori di Atene la medesima attenzione che si dedica al tiranno stesso. Solo con questo
approccio ritengo si possa conseguire l’obiettivo non solo di narrare la storia della politica
internazionale delle tirannidi di Atene, ma in senso lato di fornire anche una ricostruzione
organica del sistema internazionale della Grecia arcaica.
I contenuti della tesi
Criterio fondamentale per l’esposizione dei risultati è quello cronologico; in alcune
sezioni si è scelto di mantenere un’unità tematica seguendo lungo una serie di eventi un
medesimo soggetto, ovvero un tiranno oppure una famiglia aristocratica o tirannica.
22
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
La macrosezione I è dedicata alle vicende antecedenti l’attività di Pisistrato; vi compare il
tentativo tirannico di Cilone: più antica testimonianza di tirannide per Atene. A riprova
dell’aspetto pervasivo delle relazioni internazionali nella tirannide, già questo primissimo caso
dimostra completa afferenza alla questioni del sistema internazionale. Nella parte I si colloca
una verifica delle prime attestazioni di relazioni internazionali dei Pisistratidi nella generazione
precedente l’omonimo tiranno.
La parte II introduce la tirannide di Pisistrato nel periodo della sua ascesa al potere, negli
anni confusi della prima tirannide, del primo esilio, della seconda tirannide e del secondo esilio:
ovvero prima dell’affermazione definitiva e duratura della tirannide. Proprio questo periodo di
mobilità costituisce un caso paradigmatico per il problema delle relazioni internazionali e della
collocazione politica e geografica dei Pisistratidi nel sistema internazionale. Chiude la sezione
la notizia della presa definitiva della tirannide: non solo un caposaldo cronologico, ma anche
una notizia essenziale per la conoscenza della rete di alleati esterni che consentirono la sua
affermazione.
La macrosezione III interrompe il discorso su Pisistrato per fornire un quadro completo
dei suoi avversari: la famiglia aristocratica ateniese degli Alcmeonidi. Di questo gènos si
ricostruisce per intero la storia della rete di contatti internazionali che operarono contro la
tirannide dei Pisistratidi. Di particolare interesse è il duraturo legame degli Alcmeonidi con il
santuario di Delfi.
La parte IV riprende la narrazione dalla terza e definitiva tirannide di Pisistrato. Questo
periodo segna l’ampiezza dei progetti che Pisistrato perseguì per sé e insieme per Atene. Tema
centrale si riconosce nella politica marittima verso le Cicladi e verso l’Ellesponto. Si
ricostruisce inoltre il caposaldo economico e strategico che l’insediamento familiare presso il
mt. Pangeo rappresentò sul lungo termine.
Nella parte V di nuovo la storia della tirannide pisistratide deve essere interrotta per
condurre l’esplorazione diacronica delle vicende internazionali della famiglia dei Filaidi, tiranni
essi stessi in Chersoneso Tracico. La narrazione e l’origine stessa della tirannide filaide si lega
alla politica marittima di Pisistrato sopramenzionata. Per chiarezza narrativa si è preferito
seguire dall’origine l’intero arco cronologico della tirannide dei Filaidi. L’integrazione fra la
storia della politica internazionale dei Pisistratidi e quella dei Filaidi mette in luce un’intesa sia
interfamiliare sia funzionale agli interessi della polis. Nel giungere agli ultimi anni della
tirannide del Chersoneso la ricerca incorre nella necessità di un ampio excursus sui
cambiamenti epocali nel sistema internazionale che seguirono all’espansione dell’impero
persiano: queste vicende interessarono sia la tirannide dei Filaidi e dei Pisistratidi nello
23
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
specifico, sia gli interessi internazionali della polis di Atene, sia l’evoluzione storica del
fenomeno stesso della tirannide.
La macrosezione VI riprende definitivamente la narrazione della tirannide dei Pisistratidi
seguendo lo sviluppo degli interessi internazionali della famiglia nella seconda generazione di
Ippia, Ipparco ed Egesistrato; specificamente viene tracciato il quadro completo della tirannide
di Ippia. Il tirannicidio di Ipparco segna uno spartiacque drammatico nella conduzione delle
relazioni internazionali di Ippia; ciononostante la parte VI continua il resoconto diacronico della
tirannide di Ippia fino alla sua espulsione da Atene. Il filo narrativo che parte da Pisistrato,
passa ai figli, poi a Ippia e attraverso il tirannicidio fino all’espulsione offre rilevanti
considerazioni sulla questione della continuità e discontinuità storica, considerazioni che
verranno riprese nella conclusione della tesi.
L’ultima e VII parte segue Ippia e i Pisistratidi anche negli anni successivi alla fine della
tirannide ad Atene. La tirannide è in questi anni non più ateniese ma localizzata nondimeno a
Sigeo. Tema centrale di questa parte e di questo periodo è lo slittamento dei Pisistratidi entro
l’orbita del sistema internazionale governato dal potere dell’impero persiano. Questa
macrosezione è a sua volta suddivisa in una serie di ampi capitoli per marcare le fasi dinamiche
dell’avvicinamento di Ippia alla Persia e parallelamente il sorgere delle circostanze che
condussero alla prima guerra persiana: ovvero il coronamento e al contempo la fine del ruolo
internazionale di Ippia. Chiudono lo scritto le ultime vicende, in ordine cronologico, in cui si
riconosce l’intervento della famiglia dei Pisistratidi.
Nell’analisi dei singoli casi si è di volta in volta fornita un’ampia contestualizzazione
degli eventi, conclusioni sulle cause circostanziali e sulle cause profonde e una ricerca sulle
implicazioni a breve e lungo corso: dunque gli obiettivi e le conclusioni generali della ricerca,
ovvero la stesura di una storia della politica internazionale delle tirannidi ateniesi e la
formulazione del quadro più ampio del sistema internazionale in cui quei tiranni operarono,
trovano già espressione nel corpo stesso dell’esposizione. Si è perciò colta l’opportunità di
affrontare nella conclusione del lavoro alcune considerazioni piuttosto di natura metodologica
volte a chiarire quali modelli storici interpretativi risultino validi per la comprensione del
fenomeno storico della tirannide e della politica internazionale nell’epoca arcaica.
Si riconferma la difficoltà di tracciare il discrimine fra ambito privato e ambito pubblico
nella gestione del potere da parte del tiranno; nell’ambito della politica internazionale tirannica
ne consegue una altrettanto problematica categorizzazione nel distinguere fra contatti
interaristocratici e diplomazia interstatale, essenzialmente strumenti di un unico attivismo del
tiranno al di fuori della polis. A fondamento della ricerca si è posto il binomio fra ambito locale
24
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
e ambito internazionale: uno sguardo retrospettivo sui molteplici casi studiati porta alla luce la
necessità di aggiungere a quel binomio la categoria specifica dell’ambito regionale. Infine si
presta a una riflessione l’evidente fenomeno della continuità degli interessi internazionali dei
tiranni e della polis, sia dal punto di vista sincronico e politico, sia dal punto di vista diacronico
e storico: in questa direzione si apre la via a nuovi percorsi di ricerca che travalicano il soggetto
stesso della storia della tirannide.
Tutte le date menzionate in questo scritto sono da intendersi a.C., quando non
diversamente specificato. Nelle citazioni degli autori antichi e delle opere si è adottata la lista
delle abbreviazioni usata in Montanari 2004, con alcuni scostamenti per rendere il
riconoscimento più semplice. A questi criteri si aggiunga la convenzione di citare CANCIK H. –
SCHNEIDER H. – LANDFESTER M. – SALAZAR C.F. – ORTON D.E. (a cura di), Brill's New Pauly:
Encyclopaedia of the Ancient World, Boston – Leiden 2007 con la sigla BNP e la convenzione
di citare WORTHINGTON I. et alii (a cura di), Brill's New Jacoby, Leiden 2007 con la sigla BNJ.
25
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Introduzione
26
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
PARTE I: ATENE PRIMA DEI PISISTRATIDI
I.1. Cilone (636 a.C.)
Il tentativo di tirannide e il suo fallimento
Nella seconda metà del VII secolo ebbe luogo il primo tentativo di instaurazione di una
tirannide ad Atene da parte del nobile Cilone; malgrado l’iniziativa si sia risolta in un
fallimento, rimane ad ogni conto un elemento significativo per questa ricerca. In primo luogo
può essere considerato come il primo evento della storia politica ateniese che la storiografia può
ricostruire con un certo grado di precisione e storicità1: l’analisi di questa vicenda fornisce
l’occasione di verificare la posizione di Atene e della sua aristocrazia nello scenario
internazionale dell’epoca arcaica. Soprattutto il caso di Cilone mostra con chiarezza i modi in
cui le tirannidi operarono nello sviluppo e nel mantenimento del proprio potere, combinando
politica interna e politica estera.
La prima notizia storica in merito a Cilone lo identifica come un membro della nobiltà
ateniese (εὐγενής τε καὶ δυνατός) e come un vincitore olimpico nella gara del dìaulos, in
occasione della 35a Olimpiade, nel 6402. Più di una fonte ci informa del fatto che Cilone fu
genero del tiranno di Megara Teagene, avendone sposato la figlia3. Secondo la notizia fornita da
Tucidide, prima di procedere al tentativo tirannico, Cilone consultò l’oracolo di Delfi,
ricevendone l’approvazione per via di un responso favorevole4.
Sulla base della data tramandata per la vittoria olimpica di Cilone e sulla base del racconto
tucidideo che lega la scelta di Cilone all’attività agonistica, la ricostruzione più diffusa colloca
il tentativo tirannico all’Olimpiade successiva, dunque nel 636. Alcuni studiosi associano la
data ad una Olimpiade, ma non necessariamente a quella immediatamente successiva,
abbassandola dunque al 632, o poco più tardi; senz’altro il tentativo va collocato prima della
legislazione di Draconte del 6245.
1
ANDREWES 1982 a, p. 368. Estrema cautela critica nell’accettare i dati forniti dalle fonti relative a Cilone in LANG
1967.
2
Hdt. V 71; Thuc. I 126.3; Euseb. Chron. arm. pp. 287s. Aucher. MORETTI 1957, n. 56.
3
Thuc. I 126.3; Paus. I 28.1, 40.1.
4
Thuc. I 126.4. ANDREWES 1982 a, p. 369.
5
BERVE 1967, pp. 41-47. Sulla datazione del tentativo ciloniano vd. RHODES 1981, P. 81s.; contra DUPLOUY 2006,
p. 85 in cui la vittoria agonistica è datata al 598 e il tentativo tirannico al 597/6. Alla discussione è aggiunto un
prospetto delle datazioni proposte dalla critica in WRIGHT 1892, pp. 10-13; PRANDI 2000, p. 9; NENCI 2006, pp.
262s. Sulla relazione cronologica con la legislazione di Draconte vd. JACOBY 1949, p. 366, n. 77; BERVE 1967, pp.
42-47.
27
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
Ad Atene Cilone agì con l’appoggio di una eteria, o di un gruppo di philòi6, e con un
corpo di spedizione militare fornitogli dal suocero Teagene. I Ciloniani volsero alla conquista
dell’Acropoli decisi a impadronirsi del potere politico. Secondo il breve resoconto di Erodoto,
gli attentatori non riuscirono ad occupare la roccaforte e furono subito sconfitti7. Pare più
fededegna8 d’altronde una seconda versione, fornita da Tucidide e corroborata dalle notizie di
Plutarco secondo la quale i Ciloniani riuscirono effettivamente ad occupare l’acropoli, ma
furono presto sottoposti ad un lungo assedio. La popolazione ateniese accorse infatti dai campi,
e si oppose ai Ciloniani; l’assedio si protrasse a lungo e dunque l’iniziativa fu demandata ai
magistrati cittadini; infine gli attentatori cedettero per fame9.
Tutte le fonti dunque riportano una conclusione fallimentare per il tentativo di Cilone e
contengono le notorie informazioni sul sacrilegio compiuto dagli Alcmeonidi contro i Ciloniani.
I Ciloniani accettarono di arrendersi, ponendosi come supplici presso le aree sacre della polis, al
fine di avere salva la vita10. Gli arconti che erano incaricati dell’assedio e della risoluzione del
conflitto ruppero i vincoli sacri che proteggevano i Ciloniani e il gruppo fu massacrato.
Secondo la tradizione, Megacle I del gènos degli Alcmeonidi era alla testa del gruppo di
magistrati e sulla famiglia ricadde dunque la responsabilità della decisione di trasgredire le
leggi sacre che garantivano l’incolumità di Cilone e dei suoi. Per questo motivo il gènos fu
ritenuto sacrilego, processato e condannato all’esilio11. La tradizione preservata da Tucidide
registra la fuga di Cilone e del fratello senza però dare ulteriori informazioni12 e concorda con
questo quadro di continuità la notizia di Plutarco secondo cui le fazioni dei Ciloniani e degli
associati di Megacle rimasero in seguito acerrime nemiche13.
La vittoria olimpica e l’appoggio di Delfi
È evidente dal resoconto fornito che, malgrado Cilone non sia giunto mai ad esercitare la
tirannide, il personaggio rimane di grande interesse al fine di questa ricerca, considerando il suo
6
Hdt. V 71.1 tramanda che Cilone agì con l’aiuto di una eterìa di coetanei (δὲ ἑταιρηίην τῶν ἡλικιωτέων); invece
Thuc. I 126.5 ritiene che Cilone persuase all’azione i propri phìloi (τοὺς φίλους ἀναπείσας).
7
Hdt. V 71.
8
Opinione contraria è espressa in LANG 1967, pp. 143s., 147.
9
Thuc. I 126; Plut. Sol. 12.1s.
10
Hdt. V 70s.; Thuc. I 126.11; Plut. Sol. 12.1. Le fonti collocano il luogo della supplica alla divinità presso
differenti luoghi cultuali del tessuto urbano ateniese, altari, statue o santuari, ma condividono il fulcro narrativo.
Secondo Erodoto Cilone trovò rifugio nell’inviolabilità sacra della supplica alla divinità presso la statua di Atena
sull’Acropoli. Le versioni di Tucidide e di Plutarco sostanzialmente collimano sulla geografia della supplica e
dell’assassinio dei Ciloniani nel collocare i Ciloniani come supplici dapprima presso l’altare dell’Acropoli e in un
secondo momento, presso il santuario e gli altari delle Erenni, o Eumenidi, fra l’Acropoli e l’Areopago. MORRIS
1891, ad Thuc. I 126; CARTWRIGHT-WARNER 1977, p. 81; JOHNSTON 2010, s.v. “Erinys”.
11
Thuc. I 126.12; Heracl. Lemb. Exc. Polit. F. 2; Plut. Sol. 12.1-3. WRIGHT 1892, pp. 11, 13-18, 24, 28-36;
CADOUX 1948, p. 91 ; RAAFLAUB 1996, pp. 1048s. sulla memoria storica del sacrilegio.
12
Thuc. I 126.12.
13
Plut. Sol. 12.2.
28
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
profilo sociale, il comportamento politico ad Atene e l’esercizio della diplomazia interpersonale
extra-poleica.
Le fonti concordano nell’attribuire a Cilone un’ascendenza nobile e la vittoria
nell’Olimpiade del 64014. L’associazione fra l’attività agonistica panellenica e l’affermazione di
prestigio politico era una pratica consolidata presso l’élite aristocratica greca, in grado
maggiore per l’epoca arcaica15. Anche nella breve nota cronografica di Eusebio i due eventi
della vittoria olimpica e della tirannide vengono menzionati insieme16. La vittoria nella gara del
dìaulos alla Olimpiade XXXV contribuisce peraltro a chiarire il prosieguo della vicenda di
Cilone e le scelte che egli operò. Secondo il resoconto di Tucidide, Cilone interpellò l’oracolo
di Delfi ricercandone l’approvazione al suo progetto tirannico: il responso, inequivocabilmente
positivo, incoraggiava Cilone ad occupare l’acropoli “durante la più grande festa di Zeus” e
Cilone interpretò le parole come un riferimento alle Olimpiadi. Se consideriamo la fama e il
prestigio internazionali che derivavano dalle vittorie olimpiche, fu naturale per il clero di Delfi
e per Cilone considerare la festività panellenica come un momento propizio e strategico per la
sua presa di potere: un momento in cui Cilone avrebbe potuto fare leva sulla sua fama di
olimpionico per godere di un più ampio appoggio interno e di un inequivocabile riconoscimento
internazionale. Lo stesso testo tucidideo attribuisce esplicitamente a Cilone questa associazione
fra vittoria agonistica e successo politico17. La scelta del momento delle feste olimpiche
avrebbe a mio avviso assicurato anche un vantaggio circostanziale oltre che di prestigio: in quel
momento alcuni degli aristocratici ateniesi più influenti si trovavano probabilmente ad Olimpia
per partecipare agli agoni e non avrebbero potuto opporsi dunque all’iniziativa di Cilone ad
Atene. La critica ha proposto numerose date, alla fine del VII secolo e successive alla
Olimpiade XXXV, in cui collocare l’iniziativa di Cilone18; tuttavia, sulla base delle riflessioni
ora esposte, mi pare assuma maggiore cogenza l’ipotesi che gli eventi si siano verificati in un
arco di tempo ristretto e in prossimità temporale alla vittoria olimpica: perciò ritengo accettabile
datare il tentativo tirannico di Cilone al 636.
Tucidide offre un’analisi del responso delfico secondo la quale Cilone interpretò male le
parole della Pizia che si riferivano non alla massima festa panellenica di Zeus, quanto piuttosto
alla maggiore festa ateniese di questa divinità, e dunque alle Dionisie attiche in onore di Zeus
14
Hdt. V 71; Thuc. I 126.3; Euseb. Chron. arm. pp. 287s. Aucher.
Una simile associazione fra festività religiose e acquisizione della tirannide viene tramandata anche per Policrate
di Samo: Polyaen. I 23.
16
Euseb. Chron. arm. pp. 287s. Aucher.
17
Thuc. I 126.3-5. ANDREWES 1982 a, p. 369.
18
La lista delle diverse date proposte dalla critica moderna inizia con la Olimpiade XXV, del 640, e tutte le
successive fino alla XLVI, nel 596: WRIGHT 1892; NENCI 2006, pp. 262-266.
15
29
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
Meilichio19. Questa interpretazione è evidentemente una congettura post eventum dello storico o
delle sue fonti; si tratta forse una versione messa in circolazione dalla propaganda delfica negli
anni successivi alla Guerra Sacra, per dissociarsi dai Ciloniani e costruire relazioni positive con
gli Alcmeonidi loro avversari e vincitori del conflitto contro Crisa. È evidente che il santuario
appoggiò invece Cilone e il progetto di tirannide, in linea con una tendenza filo-tirannica
dimostrata anche nei responsi a Cipselo e a Solone20.
Il matrimonio con la figlia di Teagene di Megara
I centri cultuali panellenici e la visibilità pubblica derivata dalla partecipazione e dalla
vittoria agli agoni costituirono momenti utili per l’affermazione personale degli aristocratici
ellenici e uno strumento per l’ampliamento delle proprie reti di contatti internazionali. La fama
internazionale guadagnata con la vittoria olimpica può avere costituito dunque il movente e
l’occasione per Cilone per stabilire relazioni personali con Teagene, tiranno di Megara.
Tucidide e Pausania menzionano il fatto che Cilone avesse sposato la figlia di Teagene, allora
tiranno di Megara21. La pratica di istituire relazioni personali al di fuori della polis è una
caratteristica fondamentale della diplomazia tirannica e aristocratica in genere. Il legame
familiare assicurato dal matrimonio costituiva testimonianza di compatibilità e intesa fra la
posizioni nello scenario internazionale di Cilone e Teagene e la garanzia di appoggio reciproco
fra i due nei rispettivi progetti politici e nell’ampliamento delle loro capacità di azione
internazionale22.
Sulla base di questo rapporto inter-familiare, Cilone poté fare affidamento su una forza
armata (dýnamis) fornita dal suocero Teagene, quando procedette alla conquista dell’acropoli
ateniese. Gli armati procedenti da Megara si andarono ad aggiungere alla fazione politica
ateniese di Cilone, a cui le fonti fanno riferimento nei termini di hetàiroi o di philòi. L’esercizio
della violenza fu uno dei fattori costanti della gestione della politica da parte delle aristocrazie
arcaiche. I tiranni si distinsero per la capacità di disporre non solo dei propri partigiani politici,
ma anche di contingenti armati provenienti dall’esterno della polis23.
Si è detto che la diplomazia inter-personale dei tiranni si fondava sul costante principio
della reciprocità: è necessario dunque verificare quali moventi politici, locali e internazionali,
soggiacevano all’intesa fra Cilone e Teagene e alla generosità di quest’ultimo nel fornire i
propri armati al genero. Per Cilone l’alleanza matrimoniale trova una giustificazione evidente: i
19
Thuc. I 126.5s.. SHAPIRO 1989, pp. 112s.
FORREST 1956, pp. 39-42.
21
Thuc. I 126.3; Paus. I 40.1. BERVE 1967, pp. 33s.
22
PRANDI 2000, p. 10.
23
BERVE 1967, p. 33s.
20
30
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
soldati di Teagene avrebbero garantito un margine di superiorità militare che avrebbe permesso
di sconfiggere le fazioni avversarie ad Atene, conquistare l’acropoli e mantenere poi il potere
personale.
La guerra fra Atene e Megara per il controllo di Salamina
La posizione di Teagene trova invece una giustificazione nel quadro della contesa armata
fra Atene e Megara: un conflitto che segnò i rapporti fra le due poleis e le rispettive posizioni
nello scenario internazionale ellenico per buona parte dell’epoca arcaica24. La biografia
plutarchea di Solone fornisce le informazioni più utili al fine di ricostruire questo conflitto e al
fine di metterlo in relazione con il tentativo tirannico di Cilone25; tuttavia la ricostruzione
storica di questo conflitto è piuttosto ardua e non giova all’analisi che qui si vuole condurre26.
Le prime attestazioni risalgono all’attività di Solone prima del suo arcontato nel 594 e trovano
testimonianza negli stessi frammenti del legislatore arcaico27; il conflitto si prolungò fino alla
metà del VI secolo quando vi prese parte Pisistrato, prima della tirannide28, e pare si sia stato
concluso da un arbitrato di giudici spartani che alcuni studiosi collocano addirittura alla fine del
VI secolo29. Già all’epoca di Solone, Ateniesi e Megaresi entrambi rivendicavano diritti su
Salamina sulla base delle tradizioni omeriche e delle prove archeologiche. Indipendentemente
dall’affidabilità delle fonti e dalla veridicità delle giustificazioni archeologiche, questi elementi
attestano a mio avviso un’occupazione contestata di Salamina da parte delle due poleis risalente
epoca molto antica. Salamina si trova in una posizione dominante nel Golfo Saronico ed
equidistante da Megara e Atene; il possesso di quest’isola avrebbe assicurato il dominio delle
rotte da e verso il golfo e la possibilità di accedere ai mercati cerealicoli internazionali in caso
di necessità alimentari: conseguentemente la polis perdente avrebbe dovuto ripiegare su una
politica cerealicola autarchica e sui mercati vicini30.
In questa prospettiva, Cilone va interpretato come un esponente della classe dirigente
ateniese che non era interessata all’ampliamento del commercio navale e che respingeva la
prosecuzione di una politica militare offensiva nelle relazioni con Megara. L’esistenza di una
simile linea politica mi pare comprovata dalle prime notizie conservate sull’attività politica di
Solone, da collocarsi appunto negli anni tra il tentativo ciloniano e l’arcontato del 594: in quel
periodo Solone dovette impegnarsi con ardore oratorio per persuadere i concittadini a
24
FRENCH 1957; STAHL 1987, pp. 204-210; NOUSSIA 2001, pp. 223-228; ANDREWES 1982 a, pp. 372-374.
Plut. Sol. 8.1-10.4. BERVE 1967, pp. 47s.
26
ANDREWES 1982 a, pp. 372-374.
27
Sol. fr. 2. Sulla datazione dell’arcontato di Solone: LEVY 1973, pp. 90s.
28
Hdt. I 59.
29
PICCIRILLI 1973, n. 10.
30
WRIGHT 1892, pp. 55s.; FRENCH 1957; STAHL 1987, pp. 204-210.
25
31
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
riprendere la guerra per la conquista di Salamina, andando contro un decreto che ne aveva
proibito la prosecuzione e addirittura la discussione in sede pubblica.
Qualora Cilone avesse avuto successo nell’impossessarsi di Atene, Teagene avrebbe visto
automaticamente risolto il contenzioso con quella polis e questo avrebbe messo al sicuro i
traffici navali di Megara. Megara fu una polis di ampia attività coloniale fin dall’inizio del VII
secolo31, indirizzando la propria area di controllo verso il Bosforo; questa politica si spiega con
la perdita di ampie aree coltivabili della propria chora orientale a favore di Corinto, da datarsi
al più tardi al 70032. Anche per Megara dunque l’accesso al commercio navale assicurava la
possibilità di ricorrere a risorse cerealicole necessarie per integrare quelle provenienti dalla
propria ridotta produzione33.
Le fonti forniscono informazioni poco affidabili e confuse sul bilancio di potere fra Atene
e Megara in quel giro di anni e rimangono mute in merito alla configurazione dell’intesa
familiare fra Cilone e Teagene, oltre alla notizia del matrimonio. Alcuni studiosi vedono nelle
scelte di Teagene il progetto di stabilire un controllo di Megara su Atene34. Dal punto di vista
militare e strategico però, alla fine del VII secolo Atene poteva vantare una flotta e una capacità
di azione marittima significativa, in grado evidentemente di opporsi per lungo tempo alla rivale
Megara e di consentire l’impresa di occupazione del Sigeo, in Troade, da datarsi al 607 secondo
i dati ricavabili dalla cronaca di Eusebio35. D’altro canto la capacità di affermazione militare e
politica di Cilone dipendevano dal contingente militare fornito dal suocero megarese: le fonti
conservano la nozione che la popolazione ateniese non appoggiò il colpo di mano di Cilone, a
differenza di quanto si verificò nel caso di altre tirannidi: perciò, oltre al gruppo dei suoi
coetanei fedeli, la risorsa politico-militare cruciale di Cilone fu il contingente di soldati
megaresi36. Questo avrebbe costituito un fattore di soggezione del governante di Atene rispetto
alle decisioni di Teagene. Contro questa prospettiva, viceversa la possibilità di Teagene di
influire sulla politica internazionale di Atene sarebbe dipesa dal genero Cilone. Considerando
questo insieme di fattori, mi pare dunque preferibile e naturale ravvisare in questa vicenda il
tentativo di creare un’intesa inter-familiare reciproca più o meno equilibrata, volta in primo
luogo alla risoluzione pacifica del contenzioso per Salamina; sul lungo termine l’intesa era
31
WRIGHT 1892, p. 61.
HAMMOND 1982 b, pp. 334s.
33
FREITAG 2011, s.v. ‘Megara’ in BNP.
34
WRIGHT 1892, p. 61. DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 186-194 fornisce un inquadramento del conflitto di frontiera
fra Atene e Megara per il controllo della hierà orgàs afferente ad Eleusi e ricorda la possibilità di inserire le
relazioni fra Cilone e Teagene entro quelle contingenze.
35
Hdt V 95; Diog. Laert I 74; Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 173 g Helm. WRIGHT 1892, pp. 55s.
36
MCGLEW 1993, pp. 76s.; PRANDI 2000, pp. 11s.
32
32
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
volta a consentire ad entrambe le città la libera navigazione nel Golfo Saronico e
conseguentemente un facile accesso alla navigazione nell’Egeo: questo avrebbe, in ultimo,
assicurato reciprocamente alle due poleis una scappatoia in caso crisi di alimentari, sia di
portata locale che più ampia37.
Fig. 1: il Golfo Saronico, Atene, Megara e Salamina
Il legame fra aspetti privati e ambito pubblico nel caso di Cilone
Il tentativo di Cilone fallì e con esso fallì la possibilità di un’intesa pacifica riguardo al
possesso di Salamina. Nonostante il massacro dei congiurati, la fazione associata a Cilone e alla
sua famiglia sopravvisse ad Atene poiché Plutarco riferisce dell’aspra opposizione fra Ciloniani
superstiti e Alcmeonidi negli anni successivi38. Questi scontri politico-sociali dovettero essere
uno dei motivi che spinsero Solone a persuadere gli Alcmeonidi a sottostare ad un processo, per
giudicarli della loro azione sacrilega nella risoluzione dell’iniziativa di Cilone39; a seguito del
processo gli Alcmeonidi, o più probabilmente parte di loro, furono esiliati e il gènos perse per
un periodo prestigio e incisività politica. Questo insieme di fatti mise Atene in una posizione
debole nel conflitto per Salamina e, pur tenendo in considerazione le grandi incertezze ed
imprecisioni delle fonti, è evidente che Megara sfruttò il confuso contesto politico interno ad
37
STAHL 1987, pp. 204-210; DUPLOUY 2006, p. 85 utilizza il criterio analitico qui esposto ma preferisce
interpretare l’intesa come volta far riconosce le pretese di Megara su Salamina, piuttosto che a una
compartecipazione paritaria alla navigazione.
38
Plut. Sol. 12.1. Vd. infra, pp. 27ss.
39
PRANDI 2000, pp. 14-20.
33
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
Atene per riconquistare Salamina, in un periodo da collocarsi dopo il tentativo di Cilone nel 636
e prima del processo agli Alcmeonidi tenutosi poco prima dell’arcontato di Solone nel 59440.
La vicenda di Cilone attesta due caratteristiche fondamentali delle relazioni internazionali
tiranniche: l’importanza delle alleanze familiari e personali e la stretta interdipendenza fra
politica interna e politica estera. L’alleanza personale tra Teagene e Cilone fu sancita dal
matrimonio di quest’ultimo con la figlia del tiranno megarese, ma questo legame familiare
trovò la propria applicazione oltre la sfera privata, risolvendosi in un contributo armato alla
presa della tirannide ad Atene. L’aspetto a mio avviso più significativo del tentativo ciloniano è
la relazione che l’analisi storica può stabilire con la guerra per il controllo di Salamina: in
questa chiave di lettura diviene evidente come la tradizionale contrapposizione tra gène
aristocratici ateniesi per il controllo delle istituzioni fu traslata al livello delle scelte di politica
estera nei confronti di Megara41.
I.2. Ippocrate, padre di Pisistrato
Lo spartano Chilone e la profezia sul nascituro Pisistrato
La prima attestazione di attività extra-poleica della famiglia dei Pisistratidi risale alla
notizia fornita da Erodoto relativa ad Ippocrate, padre del futuro tiranno ateniese. Ippocrate si
trovava ad Olimpia per assistere alle festività agonistiche e nell’ambito delle celebrazioni il
nobile ateniese offrì un sacrificio; compiuto il sacrificio e allestiti i lebeti per cucinare le carni,
avvenne un portento: l’acqua incominciò a bollire e tracimare senza che fosse stato acceso il
fuoco. Lo spartano Chilone si trovava presente e poté dare una spiegazione dello sfavorevole
prodigio a Ippocrate: gli consigliò di non sposarsi, o di ripudiare la moglie che aveva, di non
avere mai figli o disconoscere quelli che avesse già. Ippocrate non ascoltò il consiglio di
Chilone e perciò nacque Pisistrato42.
È in primo luogo doveroso ammettere il carattere marcatamente letterario e favolistico
della notizia e tenere in considerazione la sua attestazione unicamente in Erodoto43. La celata
profezia fornita da Chilone è evidentemente post eventum, volta a rimandare allusivamente il
lettore ai mali che il nascituro tiranno avrebbe portato alla comunità e alla proverbiale politica
40
Plut. Sol. 12.2s. WRIGHT 1892, pp. 42-56; SANDYS 1912, pp. 55-56; HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 59;
ANDREWES 1982 a, pp. 369-275; NOUSSIA 2001, ad Sol. fr. 2 G.-P.2 (1-3 W.2), pp. 223-225.
41
PRANDI 2000, pp. 19s. esprime scetticismo sulla validità delle ricostruzioni storiche dei fatti del tentativo
ciloniano in virtù della condizione delle dismogenee fonti.
42
Hdt. I 59.
43
Hdt. I 59; citato in Diog. Laert I 68s. Sulla base di queste caratteristiche B.M. Lavelle ne esclude infatti in
assoluto l’utilità storica: LAVELLE 2005, pp. 13-15, 29s., 68, 91, 191-193.
34
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
antitirannica laconica. La manifestazione di portenti, sogni premonitori ed eventi soprannaturali
costituisce un tòpos nelle narrazioni della nascita di personaggi eccezionali, come ad esempio il
caso di Ciro il Grande, Cipselo o Pericle44. Non è questo peraltro l’unico fatto soprannaturale
associato alla vita di Pisistrato e ai Pisistratidi nell’opera erodotea45: considerando il pubblico
ateniese a cui Erodoto si rivolgeva, lo scopo di questo racconto doveva essere quello di
giustificare gli antichi cittadini ateniesi per avere accettato il governo di Pisistrato, presentando
la tirannide ateniese come un fatto inevitabile e predestinato46. Sempre la prospettiva
dell’analisi narrativa di questo passo fornisce un’ulteriore giustificazione della presenza di
Chilone nella vicenda: il personaggio ricopre infatti qui la funzione narrativa del consigliere
tragico, o consigliere saggio, che la critica moderna ha notato costituire uno degli strumenti
interpretativi di ampio utilizzo e di maggiore successo fra gli espedienti narrativi di Erodoto47.
Nella medesima direzione di quest’ultima caratteristica letteraria di Chilone, non è superfluo
considerare che il saggio lacedemone fu annoverato nel gruppo dei Sette Sapienti della Grecia
arcaica fin dalle più antiche attestazioni48. Seppure la tradizione dei Sette Sapienti abbia preso
forma nella letteratura e nel pensiero greco solo con il IV secolo, mi pare esistano tuttavia i
presupposti per individuare già all’epoca di Erodoto e nella sua opera una serie di attribuzioni e
di notizie relative a filosofi e statisti arcaici che nel secolo successivo fungeranno appunto da
fondamento per lo sviluppo della tradizione filosofico-letteraria sui Sette Sapienti come è a noi
giunta; già nell’opera di Erodoto proprio Chilone è aggettivato con la forma superlativa del
termine sophòs, con cui vennero poi individuati appunto i Sette Sapienti49. Cosicché emerge un
44
ASHERI 1988, p. 302. Ciro: Hdt. I 107; Cipselo: Hdt. V 92; Pericle: Hdt. VI 131.
Pisistrato è accompagnato sull’acropoli da una ragazza vestita come la dea Atena: Hdt. I, 60; l’indovino Anfilito
predice la vittoria di Pallene: Hdt. I 62s.; Ipparco ha un sogno premonitore la notte prima del suo assassinio: Hdt.
V 55s.; Ippia ha un sogno premonitore la notte precedente Maratona: Hdt. VI 102s.
46
LAVELLE 2005, pp. 9-11, 29s., 70.
47
LATTIMORE 1939, specificamente su Chilone pp. 24-26, 33s.; ASHERI 1988, p. 302; GRAY 2002, pp. 299-302;
RAAFLAUB 2002, pp. 171-173; SAÏD 2002, pp. 122-124.
48
Plat. Prot. 343a.; Diog. Laert. I 9s., 40-42.
49
Molti di quei pensatori, studiosi e legislatori ellenici che nel pensiero greco del IV secolo entrarono poi a fare
parte del gruppo dei Sette Sapienti già nelle Storie di Erodoto rispondono chiaramente alle caratteristiche di
saggezza, sagacia ed esperienza pratica e politica che li distinguono; a titolo esemplificativo propongo a seguito
alcuni passi, oltre a quello qui oggetto di discussione (Hdt. I 59) relativo a Chilone ed Ipparco. Biante di Priene
fornisce utili interpretazioni strategiche a Creso e il sovrano giudica che egli abbia parlato a proposito (προσφυέως
γὰρ δόξαι λέγειν: Hdt. I 27.5); su questa vicenda Erodoto stesso informa il lettore che esisteva una versione
alternativa che attribuiva il ruolo di saggio piuttosto a Pittaco di Mitilene: Hdt. I 26s. Alla corte di Creso a Sardi
giungono tutti i sapienti che vivevano in Grecia a quel tempo (oi pàntes ek tès Hellàdos sophistài), fra i quali anche
Solone che chiarisce al sovrano i principi della felicità; questo passo anticipa dunque la notizia fornita da Eforo nel
IV secolo: Hdt. I 29; Ephor. FGrHist 70 F 181 (ap. Diog. Laert. I 40). Talete prevede l’eclissi di sole del 585 e
consiglia gli Ioni in materia di ordinamento statale: Hdt. I 74, 170. Demarato, parlando con Serse, cita il
connazionale Chilone definendolo l’uomo più saggio vissuto fra i Greci (sophòtatos superl. di sophòs): Hdt. VII
235. Sull’origine di quest’ultimo episodio vd. MACAN 1908, pp. 346s. La cronografia inoltre colloca l’attività dei
Sette Sapienti all’inizio del VI secolo: Diog. Laert. I 22; Euseb. Chron. arm. p. 290 Aucher; Euseb. Chron. ap.
Hieron. p. 179e Helm. Concordano nell’alzare la data di formazione dell’ideale dei Sette Sapienti HOW-WELLS
45
35
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
ulteriore movente di natura filosofico-letteraria, piuttosto che effettivamente storica, che
avrebbe incoraggiato Erodoto a costruire la vicenda di Chilone e Ipparco e ad attribuire a
Chilone il ruolo narrativo di saggio ed esperto, seppur inascoltato, consigliere.
L’operato di Chilone in qualità di eforo è associato, in un papiro frammentario del II
a.C.50, alla conduzione della politica anti-tirannica per cui fu conosciuta Sparta e che contribuì,
secondo la tradizione e la critica, alla caduta di numerose tirannidi alla metà del VI secolo; la
critica accetta e contestualizza l’attribuzione a Chilone di questo indirizzo di politica estera per
quell’epoca51. Se anche Erodoto fosse stato già a conoscenza di questa tradizione storiograficopolitica su Chilone, sarebbe stata una scelta narrativa logica attribuire l’autorità della profezia
negativa sulla nascita della tirannide ateniese alla saggezza di quel medesimo politico spartano
che si era adoperato nel suo eforato a debellare proprio quella forma politica maligna: si tratta
di un modello narrativo che risponde al criterio della circolarità e che è evidente nell’opera
erodotea e nella cultura letteraria greca52.
Nonostante le cautele finora espresse sull’utilizzo di questo passo53, ritengo infine sia
necessario prenderlo comunque in considerazione al fine di verificarne le possibili, se pur labili,
implicazioni storiche, sia in merito alla storia della famiglia dei Pisistratidi antecedentemente
alle vicende dei suoi membri più celebri, sia per chiarire alcuni punti degli sviluppi della
diplomazia di questi tiranni alla fine del VI secolo.
La presenza di Ippocrate ad Olimpia
I Pisistratidi erano una famiglia ateniese aristocratica, appartenente agli Eupatridi e dotata
di risorse economiche54; Erodoto fornisce la loro ascendenza patrilineare legandoli ai re
1928, ad Hdt. I 27, I 29; MOSSHAMMER 1976, soprattutto p. 172; JOHANNES 2010, s.v. “Seven Sages” in BNP.
Sulla transazione culturale che nel VI secolo portò all’ascesa del modello culturale del “sapiente” (sophòs) vd.
MIRALLES 1996, pp. 867-879.
50
Pap. Ryl. 18 Hunt (FGrHist 105 F 1). HUNT 1919, pp. 29-32 per l’edizione, datazione e commento di questo
papiro; CARTLEDGE 1979, p. 120 ipotizza che il papiro tramandi un frammento di Eforo. Sull’interpretazione che la
critica offre del documento e dei dati sulla tradizione antitirannica di Sparta ivi contenuta: WILL 1955, pp. 513516; vd. infra, n. 75 pp. 36ss., pp. 395ss.
51
Thuc. I 18; Aristot. Pol. 1312a; Pap. Ryl. 18 Hunt (FGrHist 105 F 1); Plut. Mor. 859 c-d. L’interpretazione del
risulta d’altronde problematica: in primo luogo Chilone è associato al sovrano spartano Anassandrida, il quale
tuttavia regnò nella seconda metà del VI secolo; soprattutto però il papiro menziona la caduta della tirannide di
Eschine a Sicione, che è da collocarsi alla metà del VI secolo, ma anche della tirannide di Ippia che, se identificato
con il successore di Pisistrato ad Atene, costituirebbe un’ulteriore discrepanza cronologica. WILL 1955, pp. 374377; HAMMOND 1982 b, pp. 354s.; ASHERI 1988, p. 302; SALMON 1996, pp. 857-864; WELWEI 2010, s.v. “Chilon”
in BNP. Vd. infra, n. 75 pp. 36ss., pp. 395ss.
52
HUNT 1919, p. 30; WILL 1955, pp. 374-377. Sulla circolarità della narrazione in Erodoto: DE JONG 2002, pp.
250s.
53
LAVELLE 2005, pp. 13-15, 29s.
54
DAVIES 1971, p. 445.
36
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
mitologici di Pilo e di Atene55; è conosciuto un Pisistrato che fu arconte ateniese nel 669/8,
sebbene il solo nome potrebbe non considerarsi sufficiente dei legami di parentela con la
famiglia di Ippocrate e dei Pisistratidi56. Il nome stesso di Ippocrate, nonché di altri membri dei
Pisistratidi57, associa la famiglia ad aristocratiche e dispendiose attività ippotrofiche58. Sulla
figura storica di Ippocrate non è pervenuta alcuna notizia ad esclusione del racconto folklorico
fornito da Erodoto sopra discusso59. In questo testo lo storico precisa che Ippocrate si trovava
ad Olimpia in qualità di cittadino privato (idiòtes): questa qualifica non contraddice lo status
elevato del personaggio, al contrario dimostra che la presenza presso il santuario
peloponnesiaco e l’offerta del sacrificio dipendevano dall’iniziativa e dalle risorse finanziarie
della sola famiglia; si tratta in effetti di una pratica in linea con le forme di affermazione di
prestigio familiare delle aristocrazie arcaiche elleniche. Se accettiamo le informazioni del passo
erodoteo, pur disconoscendo l’episodio soprannaturale, dobbiamo attribuire ai Pisistratidi la
capacità economica e diplomatica di viaggiare al di fuori dell’Attica, di frequentare un centro
cultuale panellenico quale quello di Olimpia e di realizzare offerte sacrificali; soprattutto
dobbiamo far risalire la frequentazione dei luoghi di incontro panellenici già alla generazione
precedente la tirannide di Pisistrato. La notizia dell’incontro fra Ippocrate e Chilone, in
occasione delle celebrazioni Olimpiche, rientra nelle dinamiche sociali aristocratiche che
facevano dei santuari panellenici dei luoghi di incontro, comunicazione ed intesa fra le élites di
poleis diverse; se accettata la notizia proverebbe l’intento dei Pisistratidi di costruire relazioni
amichevoli extra-poleiche, prima ancora dell’assunzione della tirannide60.
La datazione di Chilone
Si impone una critica di questa notizia erodotea sulla base dei problemi cronologici
relativi alla datazione della figura dello spartano Chilone e conseguentemente della possibilità
storica di un incontro fra questi e Ippocrate. Sulla base della cronologia fornita dalle fonti per la
vita e le tirannidi di Pisistrato, siamo portati a collocare con sicurezza la nascita del tiranno e
l’akmé dell’attività del padre Ippocrate intorno agli ultimi anni del VII secolo61; considerando
55
Hdt. V 63. MANFREDINI-PICCIRILLI 1998, pp. 111s. Sul significato e sulla storicità di questa genealogia vd.
LAVELLE 2005, pp. 18-30.
56
CADOUX 1949, p. 90; DAVIES 1971, n. 11793, p. 444.
57
Oltre ad Ippocrate, si pensi ai figli di Pisistrato: Ippia ed Ipparco.
58
LAVELLE 2005, pp. 182s. Un’analisi storico-linguistica dell’onomastica ippotrofica greca in DUBOIS 2000.
59
LAVELLE 2005, pp. 191-193.
60
Sul ruolo dei santuari come centri di comunicazione interpersonale: DAVERIO ROCCHI 1999, pp. 31s., 58-60
Contro questa interpretazione, sulla base delle scarse notizie pervenute B.M. Lavelle sostiene che il gènos
pisistratide fosse perlopiù sconosciuto prima dell’intervento di Pisistrato a Nisea nel periodo 570-565: LAVELLE
2005, p. 29; vd. infra, pp. 45ss.
61
DICKINS 1912, pp. 19s.; DAVIES 1971, pp. 444s.
37
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
che il racconto di Erodoto è ambientato in occasione delle feste olimpiche, D. Asheri propone
nel suo commento la data del 608 o del 60462, G. Dickins sceglie il 60063.
La figura di Chilone può collocarsi con certezza alla metà del VI secolo: egli ricoprì
l’eforato nel 556 e in quella carica gli viene attribuita una riforma politica che rafforzò il ruolo
degli efori a scapito dei poteri dei re64. La biografia di Chilone fornita da Diogene Laerzio è
coerente con una collocazione di questo personaggio all’inizio del VI secolo e dunque con lo
svolgimento di attività politiche nel corso di tutta la prima metà di quel secolo. Cosicché
sarebbe giustificata la cronologia di un suo incontro con Ippocrate. Oltre a fornire la data
dell’eforato, nel 560 o 556, Diogene osserva infatti che Chilone era già un uomo anziano
(géron) nel 57265. Quest’opera riporta inoltre una lettera di Chilone indirizzata a Periandro,
tiranno di Corinto nel 626-586: pur mantenendo la necessaria cautela nei confronti di uno
scritto di interesse sapienziale e filosofico, K.W. Welwei giudica autentica la missiva sulla base
della qualità del dialetto dorico in cui si presenta stilata66. Si è infine già menzionato come un
filone della tradizione identifichi in Chilone uno dei Sette Sapienti, la attività dei quali risale al
più tardi alla prima metà del VI secolo e i cui nomi furono selezionati nel 580, secondo la
cronologia di Eusebio67.
L’accettazione di queste informazioni biografiche e cronologiche e l’inserimento di
Chilone nella tradizione filosofico-sapienziale dei Sette Sapienti non escludono d’altronde di
necessità l’indagine sugli aspetti relativi all’attività politica e all’eforato attribuiti alla metà del
VI secolo. Il Papiro Rylands, risalente al II sec. a.C., già sopra menzionato fa riferimento
all’eforo Chilone e al sovrano lacedemone Anassandrida: in questa fonte i due compaiono
insieme come i responsabili della deposizione delle tirannidi in Grecia e il testo prosegue con la
menzione specifica di Eschine a Sicione e, sembrerebbe, di Ippia ad Atene68. Questa fonte
conferma dunque e si inserisce nella tradizione storiografica che attribuiva una politica estera
anti-tirannica alla città lacedemone; le notizie preservate da Plutarco sembrerebbero completare
la lista preservata nel papiro ma interrotta dal carattere frammentario del testo69. La menzione
62
ASHERI 1988, p. 302; giudizio simile espresso in: LAVELLE 2005, pp. 191-193.
DICKINS 1912, pp. 14s..
64
Mar. Par. FGrHist 239 A 41; Diog. Laert. I 68 (= Sosicrates FHG IV p. 502; Pamphila Epidauria FHG III p.
520); Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 181i Helm. DICKINS 1912, pp. 4, 14-26; CADOUX 1948, p. 40; CARTLEDGE
1979, p. 120; ASHERI 1988, p. 302; CAWKWELL 1993, p. 371; WELWEI 2010, s.v. “Chilon” in BNP. Cautela sulla
possibilità di valutare con precisione il contributo politico dell’eforato di Chilone in HODKINSON 1997, pp. 46, 49.
65
Diog. Laert. I 68-73.
66
WELWEI 2010, s.v. “Chilon” in BNP.
67
Diog. Laert. I 9, 14, 68-73; Euseb. Chron. arm. p. 290 Aucher. Vd. supra, pp. 35ss.
68
Pap. Ryl. 18 Hunt (FGrHist 105 F 1). Vd. supra, pp. 36ss., infra pp. 395ss.
69
Fonti di natura e di epoca anche piuttosto disparate preservano la tradizione della politica anti-tirannica di Sparta
durante il VI secolo e finanche l’esistenza di una lista delle tirannidi che furono destituite dall’intervento dei
63
38
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
di Anassandrida non esclude la datazione finora ricostruita per la vita di Chilone. Questo
sovrano fu in carica infatti nel periodo 560-520 e condusse la spinta espansiva spartana verso
nord, contro Tegea70: è perciò evidente che l’eforo e il re appartennero a due generazioni
distinte, ma non per questo è necessario rifiutare la storicità di una loro collaborazione politica a
metà del VI secolo. La menzione della deposizione della tirannide di Ippia ad Atene costituisce
però un problema cronologico e un anacronismo. La caduta della tirannide ad Atene risale al
510, molto dopo la vita di Chilone e persino dopo il regno di Anassandrida: Erodoto narra con
chiarezza e completezza come la cacciata di Ippia e della tirannide pisistratide da Atene fu
opera dell’intervento armato dell’esercito spartano al comando di Cleomene, figlio e successore
di Anassandrida71. La critica ritiene dunque che l’inserimento di Ippia nell’elenco delle
tirannidi sia da considerarsi un errore, o più probabilmente un ampliamento cronologico
indebito della tradizione anti-tirannica attribuita a Chilone; cosicché si dovrebbe conservare
come storica l’attribuzione a Chilone e Anassandrida della deposizione di Eschine dalla
tirannide a Sicione, avvenuta effettivamente a metà del VI secolo, ma ovviamente non la caduta
di Ippia; l’inaugurazione della politica anti-tirannica spartana sarebbe inoltre da attribuirsi a
Chilone oppure all’opera congiunta di quest’eforo e del sovrano Anassandrida72. Il papiro qui
discusso dunque, sebbene di grande interesse, non può essere un argomento valido per
abbassare la datazione di Chilone che si dovrà considerare senz’altro attivo a partire dall’inizio
fino alla metà del VI secolo; il papiro d’altronde conferma la tradizione anti-tirannica di Sparta
e associa l’avvio di quell’indirizzo di politica estera alla metà del VI secolo, con la deposizione
di Eschine, e all’operato di Chilone. Si noti infine che è pure probabile che i dati relativi
all’azione politica di Chilone, all’intervento cioè nella regolazione dei poteri dell’eforato e dei
due re e alla conduzione della politica estera anti-tirannica, risentano fortemente di una
elaborazione tarda73.
Lacedemoni: Thuc. I 18.1; Aristot. Pol. V 10 (1310b-1311b); Pap. Ryl. 18 Hunt (FGrHist 105 F 1); Plut. De Her.
Mal. 21 (Mor. 859b-859d). Nella forma delle accuse che Socle di Corinto rivolge ai Lacedemoni che stanno
appoggiando la causa di Ippia, E. Will riconosce un dato a riprova del fatto che anche Erodoto sarebbe stato a
conoscenza di tale lista: Hdt. V 92.1, a1s. Plutarco è la testimonianza più estesa dell’esistenza della lista dei tiranni
destituiti da Sparta: egli menziona i Cipselidi a Corinto e ad Ambracia, Ligdami a Nasso, i Pisistratidi ad Atene,
Eschine a Sicione, Symmachus a Taso, Aule a Focea, Aristogene a Mileto, inoltre la dinastia dei Tessali. Le
similitudini con il Papiro Rylands 18, risalente al II sec. a.C., dai frammenti del quale si recupera con chiarezza la
menzione della destituzione di Eschine a Sicione e di Ippia pisistratide ad Atene, possono interpretarsi come dati a
favore dell’antichità e della validità delle informazioni preservate in modo più completo da Plutarco. HUNT 1911,
n. 18 pp. 29-32; DICKINS 1912; WILL 1955, p. 374-376; LEAHY 1957; CARTLEDGE 1979, p. 120; HAMMOND 1982
b, p. 354; BUCKLEY 1996, p. 61; SALMON 1996, pp. 857-864.
70
WILL 1955, pp. 374-379; DAVERIO ROCCHI 1988, p. 199; WELWEI 2010, s.v. “Chilon” in BNP.
71
Hdt. V 64s.
72
DICKINS 1912, pp. 4, 25s.; HUNT 1919, pp. 29-32; WILL 1955, pp. 374-379; CAWKWELL 1993, p. 372; SALMON
1996, p. 857; WELWEI 2010, s.v. “Chilon” in BNP.
73
SALMON 1996, p. 857; WELWEI 2010, s.v. “Chilon” in BNP.
39
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
Sulla base di queste considerazioni non mi pare corretto, perlomeno in via cronologica,
rifiutare la storicità dell’incontro tra Chilone e Ippocrate74. È necessario evidentemente
escludere dalla ricostruzione storica quegli elementi favolistici relativi al portento e alla
implicita profezia anti-tirannica, che pure costituiscono il principale nucleo narrativo del passo
di Erodoto; rimane d’altronde di interesse per questa ricerca una considerazione delle
implicazioni sociali, politiche e storiche dell’incontro tra i due ad Olimpia negli anni intorno al
600.
L’incontro tra Ippocrate e Chilone
L’eforato e la tradizione relativa alle riforme del ruolo dei sovrani fanno di Chilone un
personaggio di significativo peso politico nella storia di Sparta; le notizie relative al suo
coinvolgimento nella conduzione della politica estera spartana nel Peloponneso, l’inserimento
nel gruppo dei Sette Sapienti e il richiamo internazionale in occasione del suo funerale ad
Olimpia75 sono elementi che collocano Chilone fra le personalità di prestigio panellenico, sia
sul piano politico che culturale. L’associazione fra Chilone e Ippocrate, se accettata,
contribuisce ad elevare la considerazione dello status della famiglia dei Pisistratidi all’inizio del
VI secolo; in questa prospettiva appare di conseguenza maggiormente giustificata l’aspirazione
di Pisistrato al potere tirannico; soprattutto il quadro dell’ampia rete di relazioni internazionali
dimostrato dai Pisistratidi nella seconda metà del VI secolo potrebbe trovare una spiegazione
entro una più lunga tradizione familiare di visibilità internazionale e di capacità politiche e
diplomatiche.
La scelta di Olimpia rientra, come si è detto, nelle modalità e nei luoghi di incontro delle
élites panelleniche76. Il legame fra Chilone e il santuario di Olimpia si può trovare reiterato
nella tradizione letteraria. È ad Olimpia che vennero scelti e nominati i Sette Sapienti
dell’Ellade77, fra i quali figurava appunto Chilone; è sempre ad Olimpia che il figlio di Chilone
vinse la gara di pugilato, il saggio padre morì per la gioia e tutti i concorrenti gli tributarono i
massimi onori durante le esequie78.
Anche le modalità dell’incontro tra Chilone e Ippocrate meritano alcune considerazioni.
Dal racconto di Erodoto si evince che Chilone, per potersi esprimere sul portento verificatosi al
momento della cottura delle carni della vittima, dovette assistere e partecipare al sacrificio
74
Al contrario D. Asheri restringe la collocazione cronologica di Chilone alla metà del VI secolo, sulla base delle
informazioni relative alla data dell’eforato di Chilone e al regno di Anassandrida: perciò giudica l’incontro fra
Chilone e Ippocrate una impossibilità cronologica: ASHERI 1988, p. 302.
75
Diog. Laert. I 72s.
76
Una discussione sull’affinità fra xenìa e luoghi sacrali in DOPICO CAINZOS 1997, p. 530.
77
Euseb. Chron. arm. p. 290 Aucher.
78
Diog. Laert. I 72s.
40
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
compiuto da Ippocrate. L’Ateniese compiva la cerimonia a titolo privato e i partecipanti alle
fasi cultuali e al banchetto (thysia) non potevano che essere persone vicine alla famiglia di
Ippocrate, o al più suoi concittadini, senz’altro comunque persone con cui Ippocrate nutriva un
grado di conoscenza reciproca o di intimità. La critica ha evidenziato come la partecipazione
comune ai sacrifici e alla consumazione delle vittime contribuissero a creare e consolidare un
senso di comunanza e affinità nel gruppo degli astanti e a comunicare la loro unione entro la
società e agli occhi della divinità79.
La xenìa tra Pisistratidi e Sparta
Alla luce di queste considerazioni e partendo dal presupposto che l’incontro e il legame
fra Ippocrate e Chilone siano storicamente accertati, è possibile ora suggerire un’interpretazione
di un punto a mio avviso problematico della diplomazia internazionale dei Pisistratidi della fine
del VI secolo. Gli Alcmeonidi in esilio da Atene durante la tirannide dei Pisistratidi avevano
stretto favorevoli relazioni con il santuario di Delfi, tanto da sobillare l’oracolo a fornire
responsi loro utili; così ogni volta che gli Spartani interrogavano la Pizia ricevevano sempre il
medesimo incoraggiamento a scacciare da Atene i tiranni pisistratidi. Di conseguenza, nel
51180, Sparta mandò un corpo d’armata via mare, al comando di Anchimolio, ma questa prima
spedizione finì miseramente per i Lacedemoni81. Sia Erodoto che Aristotele chiariscono che
Anchimolo e gli Spartani, attaccando i tiranni ateniesi, contravvenivano scientemente ad
vincolo reciproco di ospitalità (xenìa) che legava Lacedemoni e Pisistratidi82. Erodoto giustifica
l’iniziativa sulla base del maggiore riguardo dei Lacedemoni nei confronti dei diritti degli dèi,
dunque in osservanza degli oracoli pitici83; Aristotele individua invece il movente nell’alleanza
fra i Pisistratidi ed Argo84. Entrambe le fonti dimostrano dunque la necessità di trovare un
movente alla scelta di Sparta: per entrambe l’attacco fu una scelta ingiusta e segnò il tradimento
di una alleanza.
La xenìa consisteva in una relazione fra due individui di poleis diverse, in virtù della
quale i due erano ospiti uno dell’altro; la facoltà di godere di ospitalità e protezione al di fuori
della propria comunità era un vantaggio significativo nel contesto storico-politico arcaico in cui
79
MIKALSON 1983, p. 101; BRUIT ZAIDMAN – SCHMITT PANTEL 1992, p. 25; DOPICO CAINZOS 1997, p. 530;
GOLDHILL 1998, in particolare pp. 105-109; BURKERT 2003, pp. 218-223;
80
WADE-GERY 1951, p. 216.
81
Hdt. V 62s.; Aristot. Ath. Pol. 19.4s.
82
Erodoto definisce Pisistratidi e Lacedemoni come xénoi ta màlista: “ospiti e amici in massimo grado”. Una
riflessione sulla xenìa interpoleica e sull’applicazione di questo superlativo in RAVIOLA 2005.
83
Anche Aristotele tramanda notizia degli oracoli ricevuti dai Lacedemoni (Aristot. Ath. Pol. 19.2,4), ma aggiunge
anche che gli Alcmeonidi li avevano pagati perché intervenissero (Aristot. Ath. Pol. 19.4).
84
Aristot. Ath. Pol. 19.4. Il commento di W.W. How e J. Wells ad Erodoto riprende questa considerazione di
natura politico-strategica: HOW-WELLS 1928, ad Hdt. V 63.
41
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
non esistevano autorità sovrastatali in grado di garantire diritti individuali sul piano
internazionale. La xenìa era siglata da uno scambio di doni simbolici e di giuramenti reciproci e
a volte da un sacrificio e dalla consumazione delle carni; si esprimeva materialmente nello
scambio continuativo di doni fra i due contraenti e nella disponibilità all’ospitalità e all’aiuto;
questo scambio poteva dare poi origine ad un legame virtuoso in cui le controparti giungevano
a disporre di una alleanza strategica in una polis straniera, offrendosi vicendevolmente supporto
reciproco e amicizia. La xenìa comprendeva tutti i beni e le risorse dei contraenti e perciò era
normalmente allargata alle due famiglie. Si trattava di un legame ereditario e automaticamente
trasmesso ai figli; non si poteva rompere la xenìa, se non attraverso rari e complessi rituali di
rinuncia ai doni simbolici che avevano inizialmente avviato l’alleanza; è vero d’altronde che
poteva darsi la situazione in cui la relazione poteva non risultare più utile e veniva lentamente
trascurata dalle due parti fino a venire dimenticata o considerata come una eredità d’altri
tempi85.
Nel 511 i Lacedemoni ruppero dunque una xenìa che doveva essere antecedente e che
poteva risalire anche a generazioni prima; nondimeno l’unica attestazione che mi pare si possa
rintracciare nelle fonti, che attesti una qualche relazione fra la famiglia ateniese e la città
lacedemone, consiste appunto nella notizia qui discussa dell’incontro fra Ippocrate e Chilone.
Dunque mi pare si possa dedurre che la xenìa fra Pisistratidi e Sparta sia da ricondurre alle
relazioni tenutesi fra Ippocrate e Chilone sullo scorcio fra VII e VI secolo ad Olimpia. Le
circostanze del sacrificio, della preparazione di un banchetto e della partecipazione dei due
notabili a quel momento cultuale e sociale ben si ascrivono alle cerimonie che sancivano la
conclusione della stipula di una xenìa86. Il prestigio di Chilone e i vantaggi derivanti dalla
costruzione di una rete di relazioni personali e familiari poterono costituire un motivo valido
perché Ippocrate stringesse quell’alleanza con l’ospite spartano; inoltre mi pare si possa
ipotizzare che, tramite quell’accordo pur di natura interfamiliare, l’aristocratico ateniese, in
qualità di eupatride ed esponente politico, stesse adoperandosi sul piano delle relazioni
interstatali nella ricerca di un alleato peloponnesiaco favorevole ad Atene che potesse piegare le
sorti dello scontro che allora la polis sosteneva e subiva contro Megara per il possesso di
Salamina. Se gli iniziatori della xenìa erano stati proprio Ippocrate e Chilone, allora la rottura
dei giuramenti che Sparta provocò nel 511 con l’attacco ad Ippia sarebbe in parte giustificata in
considerazione del fatto che erano ormai trascorse due generazioni e il legame poteva aver
perso di forza; Gli Spartani potevano anzi forse ritenere in torto i Pisistratidi nei confronti della
85
86
HERMAN 1987, pp. 10-30, 69-72.
DOPICO CAINZOS 1997, p. 530.
42
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
reciproca alleanza perché, dal 560 ca., Pisistrato aveva stretto un’alleanza matrimoniale con
Argo, nemica di Sparta. Per meglio capire il senso della rottura della xenìa fra Pisistratidi e
Lacedemoni bisogna pure considerare che la xenìa era un legame reciproco individuale e
familiare, non una alleanza interstatale. Per i Pisistratidi la differenza era di facile soluzione
perché, governando la polis a titolo personale, potevano assimilare i propri rapporti familiari
alla politica internazionale dello stato. Dal punto di vista di Sparta invece vigeva una relazione
di natura familiare fra Chilone e i discendenti di Pisistrato, mentre nei rapporti interstatali
poteva ben valere un’altra serie di obblighi morali nei confronti dell’interesse collettivo dei
Lacedemoni87.
Le allusioni onomastiche possono costituire un indicatore dell’esistenza di alleanze
familiari di lunga durata, ma non mi pare corretto utilizzare in questo senso i pur ricorrenti
nomi attestati nel Peloponneso congrui a quelli di alcuni dei membri dei Pisistratidi, in virtù
della facilità di diffusione dei nomi ippotrofici88; tuttavia mi pare interessante rilevare invece le
attestazioni del nome non-ippotrofico ‘Pisistrato’ in ambiente lacedemone riscontrate in una
notizia miti-storica dello Pseudo-Plutarco, in cui si tramanda l’esistenza di un Pisistrato
Lacedemone89, e a tutt’altro estremo temporale in una epigrafe di II/I secolo in cui è nominato a
Sparta un Pisistrato figlio di Aristippo90. Gli studi sulla xenìa e sull’onomastica greca hanno
rilevato la pratica diffusa di dare ad un figlio il nome del proprio xènos: tale nome poteva poi
venire tramandato nella linea famigliare secondo l’altra pratica onomastica ellenica di
riassegnare un medesimo nome ad intervalli di due generazioni91. A ridimensionare il peso di
una analisi onomastica di questo genere tuttavia B.M. Lavelle nota che anche ‘Pisistrato’ poteva
non essere un nome di monopolio della famiglia dei tiranni, in virtù della sua presenza nella
poesia omerica e del legame con la mitica casa del sovrano di Pilo92.
87
Non mi pare il caso di affrontare ora l’analisi della conduzione della politica estera di Sparta, complicata peraltro
dalla rilevanza all’interno del suo sistema politico delle figure istituzionali e militari dei due diarchi. A titolo
esemplificativo vorrei citare l’episodio risalente al 394, in cui il re Agesilao subì le critiche del satrapo persiano per
avere attaccato i suoi possedimenti, contravvenendo agli obblighi della philìa che li legava: il Lacedemone si
giustificò sulla base della ragione di stato che imponeva agli uomini di lottare per la madrepatria, anche contro i
propri xènoi: Xen. Hell. IV 1.34s.; HERMAN 1987, pp. 1-3. Da un saggio delle fonti sembra peraltro che la
diplomazia interstatale di Sparta, nel periodo di nostro interesse, si svolgesse in sede assembleare e che le ragioni
dei magistrati, degli efori o dei diarchi non valessero a decidere in quel contesto se non in circostanze eccezionali:
sull’alleanza fra Sparta e Creso vd. Hdt. I 69s.; sulle relazioni di Sparta con i Greci di Ionia e contro Ciro vd. Hdt. I
151s. Per un’analisi della xenìa nello slittamento dalla sua forma privata ad una pubblica vd. RAVIOLA 2005. Sul
valore sia privato che pubblico, ovvero sia interpersonale che interstatale della xenìa vd. DOPICO CAINZOS 1997, p.
532.
88
DOUBOIS 2000.
89
Ps. Plut. De fluviis 10.2.
90
IG V 1, 126.
91
HERMAN 1987, pp. 7, 19-25; HERMAN 1990, pp. 351-355.
92
LAVELLE 2005, pp. 193s.
43
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte I: Atene prima dei Pisistratidi
44
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
PARTE II: ATENE E L’ASCESA DI PISISTRATO
II.1. Pisistrato: il periodo pre-tirannico e la prima tirannide
La conquista della prima tirannide
Le manovre che nel 561/601 permisero a Pisistrato di imporre la sua prima tirannide ad
Atene (6 anni, nel periodo 561/60-555/4) rientrano esclusivamente nel contesto della politica
locale, furono cioè espressione della contesa fra famiglie aristocratiche della polis e non
coinvolsero soggetti o risorse al di fuori di Atene. Raccogliendo una propria base di consenso
regionale, Pisistrato si inserì nel quadro socio-politico delle tradizionali fazioni: Megacle (II)2,
del nobile gènos degli Alcmeonidi, capeggiava gli abitanti della costa, nelle regioni meridionali
e orientali dell’Attica (i paràlioi, nelle fonti); Licurgo, anch’egli un aristocratico, rappresentava
gli interessi dell’aristocrazia terriera tradizionale e godeva dell’appoggio degli abitanti della
pianura centrale dell’Attica (il pédion); Pisistrato pare abbia organizzato una fascia sociale
anteriormente ignorata, dando origine ad una nuova fazione politica (hyperàkrioi in Erodoto,
diàkrioi in Aristotele) localizzata nelle regioni meno pianeggianti ed economicamente sfavorite
dell’area nord-orientale dell’Attica3.
La storiografia moderna ha affinato il modello interpretativo di queste notizie chiarendo
che questi gruppi non sono da considerarsi come le rispettive basi sociali di consenso politico
dei tre personaggi, ma piuttosto vanno visti come l’espressione allargata a strati più ampi del
démos delle più arcaiche eterie aristocratiche regionali: non si tratterebbe dunque di un
appoggio da intendere nel senso politico moderno, ma piuttosto di una forma di dipendenza o
fedeltà di gruppi di Ateniesi ad esponenti aristocratici, sulla base di vincoli personali e di
prossimità geografica. È incontestabile d’altronde che Pisistrato, come molti tiranni, ebbe
successo proprio perché uscì da questa concezione politica antiquata riuscendo così a riscuotere
l’appoggio di strati più ampi della cittadinanza, delle classi popolari o perlomeno di quella parte
della popolazione che non condivideva gli interessi delle antiche aristocrazie detentrici dei
privilegi politici e di ampie aree agricole4. Questa interpretazione ha il merito di conciliare il
1
Mar. Par. A 40. SANDYS 1912, pp. 56s. La data dell’instaurazione della prima tirannide è fissata con buona
sicurezza, pur oscillando fra il 561/560 e il 560/559.
2
Nipote di quel Megacle I che nel 636 era stato responsabile dell’eccidio dei Ciloniani e che aveva procurato alla
famiglia l’accusa di sacrilegio.
3
Hdt. I 59.3; Aristot. Ath. Pol. 13.4. BERVE 1967, pp. 41-46. Per un’analisi della possibile consistenza socioeconomica di questi tre gruppi politici vd. WADE-GERY 1931, p. 80; ANDREWES 1958, pp. 100-115; ANDREWES
1982 b, pp. 392-398; MOSSÉ 2009, pp. 10-13.
4
ANDREWES 1958, pp. 111-115; MCGLEW 1993, pp. 74-78; MOSSÉ 2009, pp. 10-13.
45
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
contesto storico-sociale dell’arcaismo con la politica sociale dimostrata dal tiranno nelle sue
iniziative e con la definizione di demotikòtatos che Aristotele gli riservò alla fine dell’epoca
classica5.
La tradizione conserva la notizia secondo cui Pisistrato usò lo stratagemma di ferirsi di
nascosto e di presentarsi in agorà accusando gli oppositori politici di averlo assalito: così
ottenne dai propri concittadini la concessione di scegliere fra loro una guardia del corpo
(phylaké) composta di 300 mazzieri e con questa forza armata si impossessò dell’acropoli e
conseguentemente del potere6.
Le imprese contro Megara e la conquista di Nisea
L’attività di Pisistrato nella politica estera ateniese ebbe però inizio ancora prima del
conseguimento della tirannide: quando Pisistrato si appellò alla decisione dei propri concittadini
per ottenere il corpo di guardia, egli fece valere i propri precedenti meriti pubblici nella
conduzione delle imprese militari di Atene. Stando ad Erodoto e ad Aristotele, Pisistrato aveva
comandato i propri concittadini nella conquistata di Nisea, l’importante porto meridionale di
Megara, e aveva realizzato altre grandi imprese militari7. L’opinione comune, e anche più
logica, associa questa notizia alla ripresa della guerra per il possesso di Salamina e alla vittoria
di Atene8. La biografia plutarchea di Solone associa invece in molti passaggi Pisistrato alle
vicende relative al legislatore di Atene e i due sono presentati come co-fautori della guerra
contro Megara e della conquista di Salamina9; per questa fonte tuttavia si pone il problema
dell’assenza, quando non della confusione10, di riferimenti cronologici e la storiografia moderna
ha definitivamente messo in luce un diffuso fenomeno di duplicazione delle iniziative e imprese
fra quei due personaggi chiave della storia arcaica ateniese11.
La ricostruzione storica che si impone vede senz’altro il lungo conflitto fra Atene e
Megara per il possesso di Salamina continuare dalla fine del VII alla metà del VI secolo. Come
5
Aristot. Ath. Pol. 14.1: demotikòtatos; Aristot. Pol. V 5 (=1305a).
Hdt. I 59; Aristot. Ath. Pol. 13.4-14.1; Plut. Sol. 19.1-30.3; Polyaen. I 21.3.
7
Hdt. I 59; Aristot. Ath. Pol. 14.1, 17.2. Aristotele usa il verbo strategèin che sembrerebbe doversi associare al
comando esercitato dallo strategòs; tuttavia affermare che Pisistrato fu stratego ateniese potrebbe essere una
interpretazione anacronistica poiché quella magistratura è attesta solo a partire dalle riforme di Clistene: HOWWELLS 1928, ad Hdt. I 59; RHODES 2010, s.v. “strategos” in BNP. Se Pisistrato ricoprì un’effettiva magistratura
della polis nella guerra contro Megara dovette essere quella di polèmarchos, una istituzione di chiara superiorità e
antichità rispetto allo strategòs: Hdt. VI 109s.; Aristot. Ath Pol. 3.2. Altri tiranni assursero peraltro al potere
personale a seguito o tramite il polemarcato: Cipselo a Corinto, vd. Nic. Dam. FGrHist 90 F 57; Ortagora a
Sicione, vd. POxy. XI 1365 (= FGrHist 105 F 2). RHODES 2010, s.v. “Polemarchos” in BNP.
8
STAHL 1987, pp. 204-210; NOUSSIA 2001, ad Sol. fr. 2 G.-P.2 (1-3 W.2), pp. 223-233.
9
Plut. Sol. 8.3s., 31.1-3.
10
MANFREDINI-P ICCIRILLI 1998, p. XXXVIs., ad Plut. Sol. 10.26-28, pp. 142s.
11
Sul fenomeno di assimilazione di Solone e Pisistrato nelle fonti, vd. MANFREDINI-P ICCIRILLI 1998, p. 115. Fonti
tarde attribuiscono a Pisistrato la conquista dell’isola, piuttosto che a Solone, vd. NOUSSIA 2001, pp. 224s..
6
46
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
si è visto, con il fallimento del tentativo tirannico di Cilone, svanì anche la possibilità di un
compromesso pacifico fra i governanti delle due poleis, cosicché Megara condusse un decisivo
attacco e conquistò Salamina, poco dopo il 636; Atene sembra ritirò allora le proprie
ambizioni12. Il coinvolgimento di Solone nella ripresa e continuazione del conflitto è
ampiamente attestato: la tradizione conserva le tracce di una serie di iniziative politiche e di
interventi bellici legati a Solone che sembra abbiano riportato Salamina nell’orbita ateniese13.
Tuttavia la critica moderna è divisa sulla storicità degli interventi militari attribuiti all’arconte e
legislatore ateniese e sulla solidità delle conquiste ateniesi sotto il suo comando all’inizio del VI
secolo: è sicuro, se non altro, che Megara non si dette per vinta e che il conflitto continuò14. Le
non specificate imprese di Pisistrato e la sua cattura del porto megarese di Nisea vanno ascritte
ad un lungo strascico del conflitto dall’epoca di Solone o ad una rinnovata iniziativa bellica
intrapresa dalla comunità ateniese degli anni ‘70-‘60 del VI secolo che pose fine al conflitto in
favore di Atene15.
L’attività militare di Pisistrato e la cattura da parte sua del porto megarese di Nisea sono
da porsi negli anni 570-565: prima della tirannide del 560, ma non troppo distante nel tempo
perché i concittadini dimenticassero i suoi meriti e in un momento in cui Pisistrato era
sufficientemente maturo per esercitare un ruolo di comando16.
La conclusione della guerra contro Megara e l’arbitrato dei Lacedemoni: problemi di
datazione
Secondo la tradizione, la contesa fra Atene e Megara per il possesso di Salamina si
concluse definitivamente con l’arbitrato che le due parti affidarono ad un consesso di cinque
12
Plut. Sol. 12.3.
Sol. fr. 2 G.-P.2 (= 1-3 W.2); Plut. Sol. 8.1-10.4; Ael. Var. Hist. VII 19; Diog. Laert. I 46. MANFREDINIPICICIRILLI 1998, p. 130.
14
Plut. Sol. 10.1. NOUSSIA 2001, pp. 224s.
15
La ricostruzione della storia del conflitto per Salamina e del ruolo di Solone e poi Pisistrato qui presentata non è
universalmente accettata, pur essendo la più seguita e quella che concilia le notizie di diverse tradizioni. Favorevoli
all’ipotesi di due conflitti separati, uno al tempo di Solone nel 600 ca. e una seconda guerra contro Megara al
tempo di Pisistrato nel 570 ca.: SANDYS 1912, pp. 55s.; HOW-WELLS 1928, ad. Hdt. I 59; LEGON 1981, p. 137;
ANDREWES 1982 a, pp. 372-375. Al contrario, J.H. Wright utilizza alla lettera il passo di Aristot. Ath. Pol. 17.2 per
accettare l’esistenza di un solo conflitto fra Atene e Megara, promosso da Solone all’inizio del VI secolo, al quale
Pisistrato partecipò quando era in giovane età, vd. WRIGHT 1892, pp. 71-74. Tutte le ipotesi di collaborazione fra
Solone e Pisistrato durante il conflitto sono cronologicamente impossibili e dovette trattarsi di due separati conflitti
avvenuti in tempi diversi, vd. MANFREDINI-PICCIRILLI 1998, pp. XXXVIs., 132s. M. Noussia si esprime
attribuendo un ruolo decisivo agli interventi di Solone e avanzando invece dubbi sulla storicità delle notizie
relative a Pisistrato, sul presupposto della duplicazione di elementi del primo nella biografia del secondo, vd.
NOUSSIA 2001, p. 225. Sulla base del medesimo procedimento di trasferimento all’interno della tradizione, si
potrebbe accettare invece la veridicità delle notizie su Pisistrato e considerare al contrario le notizie su Solone una
rielaborazione fittizia, vd. ANDREWES 1982 a, pp. 372-375. Il commento erodoteo di W. How e J. Wells appoggia
la ricostruzione che ho scelto in questo elaborato e fornisce un quadro delle posizioni critiche più significative, vd.
HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 59.
16
HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 59.
13
47
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
arbitri spartani17. La sanzione spartana dovette avere la funzione di suggellare la situazione
militare de facto, creatasi a seguito dei successi di Pisistrato, con un pronunciamento di valore
diplomatico e di mettere a tacere le eventuali rivendicazioni delle due parti18.
Non tutte le fonti tuttavia conoscono la notizia dell’arbitrato spartano e questo pone un
problema storiografico in quanto, come si è già fatto notare, le notizie relative alle biografie di
Solone e di Pisistrato rimangono insolubilmente aperte al dubbio. Soprattutto persiste una
incertezza cronologica relativamente alla data da assegnare all’arbitrato spartano. Nella
biografia di Plutarco la notizia dell’arbitrato è associata all’attività politica di Solone, ma il
medesimo autore tramanda i nomi dei cinque giudici spartani, fra i quali compare il celebre
sovrano lacedemone Cleomene. La notizia è dunque contraddittoria poiché il primo dato
impone per l’arbitrato un terminus ante quem al 560, mentre il regno di Cleomene ebbe inizio
solo nel 520. La critica moderna si è perciò divisa sulla collocazione cronologica dell’arbitrato
e dunque della conclusione della guerra megarese: alcuni rispettano la concordanza con
l’attività militare di Pisistrato poco prima della tirannide e con l’ultima parte della vita di
Solone, negli anni intorno al 570-565, fino al 550; altri ritengono più significativa l’attribuzione
dell’arbitrato all’attività del re spartano Cleomene e collocano perciò l’arbitrato intorno al 519/8
o più tardi19. Entrambe le ipotesi trovano una giustificazione nel proprio contesto storicopolitico ed entrambe sono significative per la storia delle relazioni internazionali della tirannide
pisistratide: per questo si impone una analisi in questa sede.
Personalmente concordo con quegli storici che ritengono impossibile non accettare la
storicità dell’intervento di Pisistrato nella guerra contro Megara e nella conquista del porto di
Nisea. La notizia delle imprese di Pisistrato giunge infatti attraverso Erodoto, il quale a sua
volta non poté che registrarle da fonti locali ateniesi conservate in ambienti di sicura tendenza
anti-tirannica e filo-alcmeonide: che dunque ad Atene non si tacessero le storie dei successi
militari di Pisistrato è segno della loro riconosciuta storicità20.
Dal punto di vista strategico, la perdita di Nisea, suo principale porto, dovette segnare per
Megara la fine delle proprie capacità navali e la possibilità di continuare il conflitto. È dunque
plausibile che le parti abbiano preferito ricorrere nel 570-565 all’arbitrato spartano per giungere
17
Plut. Sol. 10.1-4. PICCIRILLI 1973, n. 10.
Le fonti non esplicitano in effetti a quale delle due parti l’arbitrato diede ragione ma, dallo sviluppo del testo di
Plutarco, l’esito appare di lampante interpretazione poiché la mediazione avrebbe procurato a Solone grande fama:
Plut. Sol. 10.1–11.1. LEGON 1981, pp. 136-140.
19
BELOCH 1913, vol. I.2, pp. 311-314; HICKS-HILL 1901, p. 6s.; TREVER 1925, pp. 120-125; NILSSON 1938, pp.
385-387; MERITT 1941, pp. 301-305; WILL 1955, p. 643; MILLER 1971, pp. 34s.; SEALEY 1976 a, pp. 146s.;
LEGON 1981, pp. 136-140; ANDREWES 1982 a, pp. 372-375; MANFREDINI-PICCIRILLI 1995, pp. 136s.; NOUSSIA
2001, p. 224; LAVELLE 2005, pp. 59-64, 272s. n. 173.
20
ADCOCK 1924, pp. 176-179; WATERS 1971, pp. 22-24; LAVELLE 2005, pp. 30s.
18
48
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
ad una conclusione definitiva: Atene si ritrovava a godere di un vantaggio militare significativo
che avrebbe pesato a suo favore nel giudizio dei Lacedemoni; Megara era in posizione
militarmente svantaggiata e avrebbe trovato più avveduto concludere il conflitto tramite una
soluzione diplomatica. A favore di Megara pare inoltre evidente che i successi di Pisistrato,
nonostante fossero stati significativi, non avevano portato ad una conquista sicura dell’isola
contesa: in caso contrario le fonti non avrebbero tralasciato una notizia di tale peso; perciò
Megara poteva ancora vantare le proprie pretese in sede arbitrale21. Potremmo dunque
considerare la situazione come essenzialmente bilanciata, pur con una tendenza in favore di
Atene.
Una ricostruzione proposta da più di uno studioso ritiene che gli arbitri spartani abbiano
disposto lo scambio fra le due località strategiche: Nisea tornò dunque sotto la completa autorità
megarese, mentre ad Atene fu definitivamente concessa Salamina22. La soluzione pare congrua
sotto molteplici aspetti. In questo modo l’arbitrato ripristinava lo status quo ante bellum, poiché
riconsegnava a Megara il porto di Nisea, rispettando peraltro così l’integrità della chòra
cittadina. La perdita di Nisea avrebbe d’altronde segnato la fine dell’economia di Megara e un
destino di incertezza alimentare e soggezione politica ai propri vicini, Atene o Corinto:
raramente la diplomazia greca accettò soluzioni di una tale gravità, perlomeno fino alla fine
dell’epoca classica. La mancata restituzione di Nisea avrebbe infine messo Megara in
condizione di non poter rispettare l’arbitrato e avrebbe inficiato la durata della pace e la qualità
del giudizio politico-strategico dei Lacedemoni. Per altro verso la concessione di Salamina ad
Atene rispettava i diritti di conquista militare di questa polis e ne premiava l’evidente
condizione di superiorità strategica. La scelta di uno scambio fra postazioni di recente conquista
e aree di più antico insediamento è in linea con le pratiche di arbitrato interstatale attestate
anche in altri casi23. La collocazione cronologica dell’arbitrato in coda alle conquiste di
Pisistrato negli anni 570-565 ha il pregio dunque di legare l’intervento diplomatico direttamente
alla presa di Nisea da parte di Pisistrato, cioè a quella circostanza strategico-militare che rese
21
Contro questo scenario B.M. Lavelle ritiene che l’attacco contro Nisea si sarebbe potuto condurre soltanto via
mare, ma questo implicherebbe il controllo completo di Salamina; perciò le imprese non specificate sulle quali
Erodoto non si esprime sarebbero da interpretarsi appunto come la traccia storiografica della conquista dell’isola
da parte di Pisistrato: LAVELLE 2005, pp. 49-51. Sebbene l’ipotesi sia in linea con l’analisi storiografica su
Erodoto, non si vede il movente per cui, avendo ottenuto il possesso dell’isola contesa, gli Ateniesi avrebbero
ritenuto utile proseguire la guerra in una missione contro il territorio megarese.
22
LEGON 1981, pp. 136-140; ANDREWES 1982 a, pp. 372-374; ANDREWES 1982 b, p. 397.
23
Una soluzione in tutto simile fu presa da Periandro nell’arbitrato fra Atene e Mitilene per il possesso del Sigeo:
Hdt. V 94s.
49
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
l’arbitrato un intervento urgente per Megara24. Questa data alta infine preserva la storicità
dell’intervento di Solone, se pure in una età avanzata25.
Una diversa tradizione interpretativa colloca l’arbitrato lacedemone al 519/18. Il
presupposto è quello di accettare la storicità della presenza del sovrano spartano Cleomene nel
consesso dei giudici e viceversa di respingere la storicità della presenza di Solone in quegli
eventi; il regno di Cleomene viene infatti datato agli anni 520-490. Non è difficile comprendere
le argomentazioni contro l’intervento di Solone nel giudizio arbitrale: si è già fatta notare la
tendenza delle fonti ad associare indebitamente questo personaggio di cruciale importanza a
significativi eventi della storia di Atene26. Questa ipotesi cronologica si avvale, come la
precedente, anche di un’analisi del contesto politico-strategico internazionale. È stato infatti
argomentato che la posizione di Sparta nello scenario internazionale e nei confronti dei vicini
nel Peloponneso non avrebbe permesso ai suoi giudici di imporre la propria autorità arbitrale in
una data alta27. L’alleanza con Tegea e Corinto, perciò la loro entrata nella Lega del
Peloponneso, fu siglata non prima del 540: senza l’approvazione di queste poleis il cammino
attraverso il Peloponneso e l’Istmo rimaneva precluso al raggio di azione internazionale di
Sparta. Un altro fattore ancora più importante per le possibilità di Sparta di agire al di fuori del
Peloponneso fu la sconfitta di Argo, alla battaglia di Sepeia, avvenuta nel 520-519. Sparta non
avrebbe potuto esercitare un ruolo di primo piano nella politica internazionale finché la vicina
Argo fosse rimasta un attore strategico indipendente e potenzialmente ostile. La vittoria nella
battaglia di Sepeia fu peraltro proprio l’evento che procurò a Cleomene, all’inizio del suo
regno28, la visibilità e il prestigio internazionale che gli avrebbero potuto assicurare un ruolo
credibile fra i giudici dell’arbitrato fra Atene e Megara29.
Le due ipotesi cronologiche qui esposte risentono dunque entrambe di contraddizioni
storiografiche e cronologiche che impongono di accettare o rifiutare parte delle notizie fornite
dalle fonti ed entrambe si avvalgono di una valida contestualizzazione geo-politica. L’analisi
delle relazioni interstatali della tirannide dei Pisistratidi fornisce a mio avviso alcuni motivi per
preferire la prima e più alta collocazione cronologica per la conclusione della guerra megarica e
conseguentemente per l’arbitrato di Sparta. Nel 511 Sparta dimostrò di perseguire un’aperta
politica anti-pisistratide e filo-alcmeonide quando acconsentì alle richieste di Delfi e dei
fuoriusciti aristocratici ateniesi intraprendendo la prima spedizione armata contro Ippia, col fine
24
ANDREWES 1982 a, p. 373; LAVELLE 2005, pp. 30-51.
LEGON 1981, pp. 138s.
26
PICCIRILLI 1973, n. 10. Vd. supra, pp. 46s.
27
BELOCH 1913, p. 312.
28
Paus. III 4.1. WELLS 1905, pp. 193-196, 201.
29
PICCIRILLI 1973, n. 10.
25
50
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
di esautorare i Pisistratidi dal potere tirannico. È del tutto plausibile leggere nelle prolungate
insistenze della Pizia nei propri responsi a Sparta un’opera diplomatica del santuario stesso e
degli Alcmeonidi che era iniziata senz’altro alcuni anni prima della decisione presa da Sparta
nel 511. Se si vuole attribuire agli arbitri spartani una minima lungimiranza nella conduzione
della politica estera della propria polis, è del tutto contraddittoria e incomprensibile la scelta di
favorire Atene concedendole il possesso di Salamina in occasione dell’arbitrato con Megara,
nel presupposto di collocare la data dell’arbitrato al 519/18, o più tardi.
Le rispettive relazioni dei Pisistratidi e di Sparta con Argo potrebbero costituire un altro
fattore utile per inquadrare la cronologia dell’arbitrato. Relazioni familiari fra i Pisistratidi e
l’élite di Argo sono attestate già per il 560 in occasione del matrimonio di Pisistrato con
Timonassa, figlia di Archino, e successivamente in occasione della battaglia di Platea nel 546,
quando da Argo giunsero 1.000 mercenari opliti che si aggiunsero alle forze pisistratidi30. Le
relazioni fra Sparta e Argo si inasprirono nel 546, a partire cioè dalla cosiddetta Battaglia dei
Campioni a seguito della quale Argo fu sconfitta e rinunciò alla Tireatide; nel 520 è attestato un
nuovo intervento militare spartano, al comando del re Cleomene, nella battaglia di Sepeia31.
Posto dunque un legame fra gli interessi dei Pisistratidi e quelli di Argo, per il tramite della
moglie Timonassa, collocare l’arbitrato qui discusso nel 519/18 renderebbe la politica estera
spartana contraddittoria: la soluzione presa dai giudici Lacedemoni avrebbe infatti favorito una
famiglia alleata della loro nemica peloponnesiaca, Argo32. Viceversa Pisistrato, nel 519/8,
difficilmente avrebbe acconsentito ad affidare le sorti dei propri sforzi bellici al giudizio dei
Lacedemoni, nemici della madrepatria e residenza di sua moglie Timonassa.
Un’analisi della prosopografia greca e peloponnesiaca permette di constatare un ampio
numero di attestazioni e una ampia diffusione del nome Kleome/nhj: vi sono associate
ottantatrè attestazioni, di cui diciannove in area dorica, sette specificamente a Sparta, cinque
delle quali riguardano sovrani lacedemoni o personaggi associati al governo di Sparta. La
diffusione di questo nome impone di non identificare di necessità l’arbitro del contenzioso fra
Atene e Megara, che operò nel 570-565, con l’omonimo re di Sparta attivo nel periodo 520-490
ca.: è più che possibile che siano vissuti, a distanza di una generazione uno dall’altro, due
individui con quel medesimo nome33. Su questi presupposti non vi è dunque alcuna necessità di
30
Hdt. V 94.1; Aristot. Ath. Pol. 17.3s.
WELLS 1905, pp. 193-196, 201; ANDREWES 1982 b, p. 402; HAMMOND 1982 b, pp. 356s.; DAVERIO ROCCHI
1988, pp. 61s., 201-203; BALTRUSCH 2002, pp. 41-44.
32
ANDREWES 182 a, pp. 373s.; ANDREWES 1982 b, pp. 397s, 402s.
33
LGPN, vol. III A, s.v. Kleome/nhj. ANDREWES 1982 a, p. 373; PORALLA 1985, soprattutto nn. 435, 437;
WELWEI 2011, s.v. “Cleomenes” in BNP; LAVELLE 2005, pp. 59-64, 272s. n. 173.
31
51
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
abbassare la data dell’arbitrato spartano per farla rientrare entro il periodo del regno del re
Cleomene.
Datare l’arbitrato spartano al 519/18 contraddice dunque il quadro politico internazionale
di quel periodo; al contrario, la collocazione cronologica dell’arbitrato nel periodo
immediatamente successivo alla vittoria di Nisea, nel 570-565, si inserisce adeguatamente nella
storia delle relazioni internazionali dei Pisistratidi34. La politica di alleanza familiare di
Pisistrato con l’aristocrazia argiva ebbe inizio non prima del 56035: perciò prima di quella data,
e all’epoca della collocazione più alta dell’arbitrato fra Atene e Megara, Sparta non avrebbe
avuto motivo di temere di favorire una o l’altra delle parti. Negli anni 570-565 Sparta era
ancora lontana dalla politica estera anti-tirannica e anti-pisistratica dimostrata con l’attacco del
511 contro Ippia; a metà del VI secolo, nei confronti di Pisistrato poteva anzi ancora avere
pregnanza quella xenìa che si è precedente ipotizzata risalire alle relazioni di Ippocrate con
Sparta e che Cleomene deciderà di rompere.
Una stele frammentaria rinvenuta nell’Agorà ateniese merita una discussione in questa
sede poiché la sua datazione e il suo contenuto si legano alla questione del controllo ateniese di
Salamina. Si tratta del più antico decreto ateniese su epigrafe a noi pervenuto; il testo
frammentario esprime le decisioni dello stato ateniese relativamente all’organizzazione degli
abitanti di Salamina in materia di gestione finanziaria della proprietà terriera, degli obblighi
tributari e di quelli militari. L’epigrafe può datarsi esclusivamente secondo il criterio della
forma delle lettere e dell’organizzazione del testo e deve essere fatta risalire al periodo 520-480,
senza poter pretendere maggiore precisione36.
È stata avanzata l’ipotesi che il reperto attesti l’istituzione della prima cleruchia ateniese
sul suolo salaminio37, tuttavia gli specialisti notano la frammentarietà del testo e la difficoltà di
emendarne con sicurezza porzioni significative: rimane perciò aperta al dubbio proprio la
ricostruzione dei referenti interessati dalle disposizioni ed è probabile che il decreto non sia
riferito ai cleruchi ateniesi di Salamina, ma piuttosto soltanto agli abitanti dell’isola; tantomeno
è evidente se le disposizioni riguardassero i cittadini ateniesi che vivevano su Salamina, o i
Salaminii autoctoni o entrambi38. Le ricostruzioni storiche relative alle circostanze, agli autori e
ai referenti del decreto sono dunque molteplici. Alcuni studiosi hanno ritenuto che il decreto sia
stato prodotto al fine di sancire il comportamento degli autoctoni salaminii dopo la conquista
34
ANDREWES 1982 a, pp. 372-375.
Aristot. Ath. Pol. 17.4.
36
IG I2 1. HICKS-HILL 1901, n. 4, pp. 6s.; MEIGGS-LEWIS 1989, n. 14, pp. 25-27.
37
NILSSON 1938, pp. 386-387; ANDREWES 1982 a, p. 373; MEIGGS-LEWIS 1989, n. 14, pp. 25-27.
38
HICKS-HILL 1901, n. 4, pp. 6s.; MERITT 1941, pp. 301-307; WADE-GERY 1946, pp. 101-104.
35
52
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
ateniese dell’isola a metà del VI secolo39, ma il decreto è senz’altro più tardo rispetto a questa
cronologia e la ricostruzione va dunque, a mio avviso, scartata. In linea invece con l’effettiva
datazione epigrafica del decreto, altre interpretazioni accettano la cronologia poc’anzi discussa,
che colloca l’arbitrato spartano ad epoca clistenica, considerano l’epigrafe come una
testimonianza dell’arbitrato stesso e ritiengono che con esso si sia sancita anche la concessione
di una cleruchia ateniese su Salamina oppure altrimenti e più cautamente che l’arbitrato e il
decreto sancissero in forma ufficiale, nel 508 ca., il controllo che Atene aveva esercitato de
facto fin dalla conquista del 570/6540.
Concluderei dunque che l’epigrafe in questione non è da associarsi alla storia della
politica internazionale di Pisistrato e nemmeno all’arbitrato spartano la cui collocazione a metà
del VI secolo mi pare in definitiva più appropriata. Piuttosto ritengo che il decreto sia una
testimonianza di quel periodo di riorganizzazione socio-politica che ebbe luogo ad Atene con il
nuovo governo isonomico di Clistene. Salamina aveva senz’altro accolto cittadini ateniesi dopo
la conquista di Pisistrato e dopo l’assegnazione dell’isola ad Atene a seguito dell’arbitrato
spartano e quei cittadini avevano ottenuto delle proprietà terriere, stando al testo del decreto. Mi
pare del tutto logico che appunto nel momento in cui il governo e lo stato ateniese ebbero una
nuova forma, con l’iniziativa legislativa di Clistene, si sia reso necessario ridiscutere e
determinare lo status, gli obblighi e i diritti di quegli Ateniesi di Salamina41. La stele può, a mio
avviso, fornire una parziale minima conferma della storicità e della datazione della conquista di
Salamina a seguito delle operazioni di Pisistrato. Si è detto infatti che un dato sicuro che si può
estrarre dal testo e dagli argomenti dell’epigrafe è che viveva a Salamina un gruppo di famiglie
che afferivano alla cittadinanza ateniese e la cui posizione e il cui status si ritenne di dover
istituzionalizzare nell’ultimo decennio del VI secolo; si trattava altresì di possessori di terreni
estesi a sufficienza da potersi affittare ed erano individui sufficientemente benestanti da potersi
permettere l’armamento oplitico42: si potrebbe inferire dunque che lo status socio-economico
dei referenti del decreto era consolidato e che essi erano giunti a Salamina ben prima
dell’emissione del decreto, probabilmente cioè negli anni successivi alla conquista di Pisistrato
e dell’arbitrato spartano, nel 570-565.
39
BUSOLT 1885, pp. 548-551; HICKS-HILL 1901, n. 4, pp. 6s.
NILSSON 1938, pp. 386-387; MERITT 1941, pp. 301-307; ANDREWES 1982 a, p. 373; MEIGGS-LEWIS 1989, n. 14,
pp. 25-27.
41
MEIGGS-LEWIS 1989, n. 14, pp. 25-27.
42
WADE-GERY 1946, p. 103.
40
53
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
L’attacco contro Megara nel quadro delle fazioni politiche ateniesi
L’attività militare di Pisistrato nel conflitto con Megara, pur non ricadendo ancora nel
periodo della sua tirannide, può fornire già lo spunto per alcune considerazioni, a mio avviso
significative, sia per la comprensione della posizione di Pisistrato nella politica interna ateniese
in vista dell’assunzione della tirannide, sia per la lettura dei moventi strutturali nelle relazioni
interstatali fra Atene e le poleis dell’Istmo e del Peloponneso, nonché della costruzione della
rete di relazioni familiari dei Pisistratidi.
Nel discutere il tentativo tirannico di Cilone, questi è stato identificato come l’esponente
politico di una corrente della classe dirigente ateniese che vedeva favorevolmente la ricerca di
una intesa con Megara, che non era interessata a prolungare le azioni militari e che non riteneva
vantaggioso ampliare le capacità marittime di Atene. L’accesso ai porti e alla navigazione
nell’Egeo e nel Mediterraneo erano una necessità per la maggior parte delle poleis greche in
relazione alla scarsità di suolo fertile e alla connessa sovrappopolazione; era fondamentale per
le poleis poter fare affidamento su mercati cerealicoli regionali o internazionali per supplire alle
esigenze della popolazione in crescita e alle eventuali fortuite emergenze alimentari. Il Golfo
Saronico costituiva il miglior accesso marittimo per Megara e Atene e il controllo di Salamina
comportava la possibilità di decidere del traffico da e per i porti attici e istmici. La via
marittima che faceva capo al Golfo Saronico era indirizzata ad accedere agli ampi mercati
cerealicoli internazionali, sulle rotte per la Tracia e verso lo stretto dell’Ellesponto, nonché
verso le aree cerealicole affacciate sul Ponto Eusino43.
Secondo l’analisi geo-economica condotta dalla storiografia moderna, è evidente
d’altronde come esistesse una rotta marittima regionale alternativa che Atene poteva sfruttare
per le proprie esigenze alimentari: uscendo dagli antichi porti affacciati sulle coste nordorientali dell’Attica, quali il porto di Prasiae o quello Maratona, gli Ateniesi potevano navigare
verso settentrione lungo le coste dell’Eubea per così raggiungere la Tessaglia ed eventualmente
più a nord la Macedonia. Pur non eguagliando la produzione delle aree pontiche, la Tessaglia
poteva contare su una pianura fertile e di ampie proporzioni, al paragone con gli usuali
parametri greci; oltre a cereali in grandi quantità, la Tessaglia contava anche su grandi
allevamenti di mandrie e greggi44. Scegliere la via pacifica nei rapporti con Megara avrebbe
significato indirizzare Atene su questa tradizionale via marittima e su di una politica economica
di raggio più limitato, orientata prevalentemente all’autarchia45. Questa direttrice politico43
STAHL 1987, pp. 204-210.
GEHRKE 1996, pp. 981s.
45
FRENCH 1957.
44
54
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
economica era dunque quella perseguita da Cilone e dai suoi sostenitori che dovremo
identificare nell’aristocrazia di possessori di ampi terreni coltivabili; questa classe sociale non
aveva interesse ad accedere a mercati più ampi e a ulteriori risorse cerealicole, al contrario
trovava più vantaggioso limitare la disponibilità di risorse alimentari al proprio surplus. È
questa opinione politico-economica quella che prevalse quando ad Atene fu approvata la legge
contro la discussione pubblica della ripresa della guerra contro Megara. Cilone nondimeno non
godette affatto di ampio consenso: alla notizia della sua iniziativa, la popolazione di Atene
accorse dai campi e assediò l’acropoli e incaricò gli arconti, tra cui erano presenti alcuni
Alcmeonidi, di continuare poi l’assedio. È evidente che la maggior parte del demos ateniese,
composto di piccoli e piccolissimi proprietari terrieri, era più esposta ai rovesci delle cattive
annate e approvava la possibilità di aumentare la portata dei commerci di Atene. Della stessa
opinione potevano essere quelle famiglie aristocratiche più aperte alla conduzione di commerci
e iniziative sul piano internazionale; fra queste, come esponenti e rappresentanti di rilievo,
dobbiamo contare gli Alcmeonidi, i quali si opposero dunque con acredine al tentativo di
Cilone non solamente in difesa delle libertà politiche di Atene, ma con buona probabilità anche
perché era nei contatti con l’estero che risiedeva l’origine della ricchezza della famiglia46.
Se riteniamo valida questa contestualizzazione socio-economica del conflitto contro
Megara, allora Pisistrato è da collocarsi nella fazione militarista e ‘marittima’. Nell’ottica della
presa della tirannide che avvenne entro pochi anni dalle imprese militari, possiamo ricostruire
gli intenti politici di Pisistrato soggiacenti alle sue iniziative: Pisistrato si adoperò attivamente
nella guerra megarica con lo scopo di essere identificato dall’opinione politica e pubblica
ateniese come un campione del dèmos, protettore degli interessi delle classi nonaristocratiche47. Oltre a queste considerazioni socio-politiche, dovette influire anche un fattore
di prestigio sociale e di fama nella scelta di Pisistrato di partecipare attivamente alla guerra per
Salamina: gli studiosi hanno notato come il successo militare abbia garantito l’appoggio
popolare a quasi tutti i tiranni greci48; le operazioni militari portarono Pisistrato vicino alla
classe oplitica; la vittoria militare fu una dimostrazione di capacità e di favore divino. In base a
queste considerazioni assume cogenza l’ipotesi che Pisistrato si adoperasse per l’assunzione
della tirannide fin dal 57049.
46
WRIGHT 1892, pp. 42-57; FRENCH 1957, p. 241. Agli Alcmeonidi è attribuita l’amicizia con i sovrani di Lidia:
Hdt. VI 125.
47
FRENCH 1957, pp. 241s.; STAHL 1987, pp. 204-210.
48
ANDREWES 1958, pp. 17-19, 31-38; MCGLEW 1993, pp. 2s.; LAVELLE 1994.
49
STAHL 1987, pp. 76s.; GOUŠCHIN 1999, pp. 16-19, 22s.
55
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Pisistrato e la guerra contro Megara nella politica estera filo-corinzia di lungo periodo
A partire dal VII secolo Megara ebbe come naturale avversaria, oltre ad Atene, Corinto.
Dal 700 Corinto aveva conquistato ampie porzioni di terreni coltivabili che appartenevano in
precedenza a Megara, la quale poté d’altro canto pur sempre vantare il controllo della via di
transito terrestre attraverso l’Istmo; le relazioni fra Megara e Corinto vanno considerate
nell’ottica di una naturale tensione fra poleis confinanti50. Questo rapporto disarmonico fra le
due poleis è verificabile negli eventi storici finora esposti. Nell’arbitrato che io ho preferito
collocare al 560 ca., gli Spartani ebbero un motivo ulteriore per favorire Atene nelle pressioni
politiche che dovette esercitare Corinto a favore di Atene medesima: ci sono infatti buoni
motivi per pensare che a metà del VI esistesse già una forma embrionale di quell’accordo
bilaterale fra Sparta e Corinto che fu all’origine della Lega del Peloponneso. Quando, nel 546
ca., giunsero a Sparta i messi inviati da Creso di Lidia, pare che gli Spartani occupassero già
una posizione egemonica nell’Ellade e dunque certo nel Peloponneso51; questa notizia potrebbe
senz’altro essere un anacronismo dello storico che avrebbe deciso di retro-datare ad epoche più
antiche la formazione del potere diplomatico lacedemone; eppure, se Sparta accettò l’alleanza
con Creso e si impegnò ad un’eventuale azione Asia Minore, è perché poteva contare sulle
capacità militari e sul trasporto marittimo che avrebbe fornito Corinto con la sua poderosa
flotta: perciò è probabile che almeno nel 546 Corinto e Sparta avessero già stretto un accordo
bilaterale nel quadro della Lega del Peloponneso52. È pure possibile che Corinto e Sparta non
godessero ancora di un’alleanza diplomatica nel 560, all’epoca dell’arbitrato per la questione di
Salamina, ma senz’altro Corinto doveva già costituire una potenza politica verso cui Sparta
guardava con rispetto53 e in quella occasione Corinto potrebbe avere promosso la soluzione
favorevole ad Atene, in virtù della comune opposizione a Megara54.
L’arbitrato lacedemone su Salamina fa parte di un insieme numeroso di elementi che
concorrono a delineare l’esistenza di una intesa strutturale di lungo periodo fra Corinto e Atene
in funzione anti-megarica. L’archeologia ha rilevato la diffusione di ceramica attica a figure
nere ad incominciare dal primo quarto del VI secolo, in aree quali l’Occidente e il Ponto ove
pochi anni prima era presente solo ceramica corinzia55; il dato è giustificato assumendo che le
navi che trasportavano la ceramica attica continuassero ad essere quelle corinzie e che la
50
TREVER 1925, p. 117; HAMMOND 1982 b, pp. 334-337; KOROMILA 1991, pp. 55-59; SCOTT 2000.
Hdt. I 69.2. SALMON 1996, pp. 851-864; BALTRUSCH 2002, pp. 40-44.
52
CAWKWELL 1993, pp. 367-372; SALMON 1996, pp. 240-252.
53
Il peso di Corinto si evince dal fatto che, negli anni successivi, la polis dell’Istmo fu spesso in grado decidere
della politica internazionale di Sparta e della Lega del Peloponneso: Hdt. V 75.1, 92.1, h5.
54
MANFREDINI-P ICCIRILLI 1998, pp. 142s.
55
FRENCH 1957, pp. 239s.; WILL 1955, pp. 415-420; SALMON 1997, pp. 101-116.
51
56
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
tendenza politico-economica di Corinto fosse di permettere ad Atene di accedere alle sue aree
di influenza commerciale. Le fonti associano all’opera riformatrice di Solone anche una
modifica dei pesi, delle misure e dei valori monetari; le informazioni sulla riforma ponderale
soloniana sono assai poco chiare e vanno dunque trattate con grande cautela; nondimeno mi
pare si possa accettare una ricostruzione di massima che veda lo spostamento dei riferimenti
ponderali ateniesi dal cosiddetto sistema “eginetico” verso quello “euboico”, lo stesso in corso
anche a Corinto56. Questi dati di natura archeologica ed economica, attestano, a mio avviso, per
il primo quarto del VI secolo, una tendenza alla solidarietà fra Atene e Corinto; nondimeno è
possibile consolidare il quadro di questa intesa interstatale prendendo in considerazione i dati
sparsi relativi alle relazioni diplomatiche fra Corinto e Atene e a quelle personali fra le grandi
famiglie aristocratiche e tiranniche di spicco delle due poleis.
L’atteggiamento favorevole di Corinto e dei Cipselidi verso Atene é evidente nelle
circostanze della guerra fra Atene e Mitilene, per il possesso di Sigeo, in Troade, iniziato nel
620 ca.; il contenzioso si protrasse lungamente finchè, nel primo decennio del VI secolo, il
tiranno di Corinto Periandro fu chiamato, di comune accordo fra le due poleis, ad agire in
qualità di arbitro: la sua decisione assegnò Sigeo ad Atene57.
È attestato che nel 636 Teagene di Megara e Cilone di Atene si legarono tramite il
matrimonio della figlia del tiranno con l’Ateniese: di questa alleanza familiare si sono già
analizzate le ricadute politiche e strategiche. Significativamente, nel medesimo periodo i
Filaidi, un’altra famiglia aristocratica ateniese di spicco, strinsero una simile alleanza
matrimoniale con Cipselo, il tiranno di Corinto58. Queste scelte di politica familiare possono
dunque ricevere un’interpretazione in chiave politica e sono da inserirsi nella prospettiva di
quella divisione nella classe politica ateniese in merito all’indirizzo di politica estera da
adottarsi nei confronti di Megara e al contenzioso per Salamina, di cui ho avuto modo di
discutere sopra. I Ciloniani dunque si associarono al tiranno di Megara, politicamente
perseguirono l’intesa interstatale con quella polis e conseguentemente la rinuncia all’attivismo
navale nel Golfo Saronico; contemporaneamente i Filaidi si legarono agli interessi dei Cipselidi
56
Aristot. Ath. Pol. 10.1; Plut. Sol. 15.4s. FRENCH 1957, p. 239; MUSTI 2006, pp. 261-265; KROLL 2008, pp. 1417.
57
Hdt. V 94s.; Strab. XIII 1.38; Diog. Laert. I 74. WILL 1955, pp. 369s., 381-391, 450s., 546, 558-562.
58
Hdt. VI 34, 128. ANDREWES 1958, pp. 105s.; BERVE 1967, pp. 33s.; MEIGGS-LEWIS 1989, n. 6, pp. 9-12.
Malgrado le fonti non parlino esplicitamente di un matrimonio interdinastico, Erodoto ricorda che il Filaide
Ippoclide godeva di una parentela con i Cipselidi di Corinto. È possibile d’altronde che il passaggio del nome del
tiranno corinzio nella famiglia ateniese si debba piuttosto all’istituzione di una xenìa: HERMAN 1990, pp. 352s. Vd.
infra, pp. 183ss.
57
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
di Corinto, avversari di Megara, e si schierarono con quella parte degli Ateniesi che aspirava a
rendere Atene una potenza navale.
Il legame familiare fra Filaidi e Cipselidi sembra costituire un elemento di decisionalità
ancora nel 570 ca., in occasione del matrimonio di Agariste, figlia di Clistene, tiranno di
Sicione59: fra i pretendenti eccelleva infatti l’ateniese Filaide Ippoclide, ma Clistene preferì un
altro aristocratico di Atene; Erodoto fornisce un colorito resoconto a spiegazione del
cambiamento di opinione del padre della sposa, ma nella scelta dovettero pesare alcune
considerazioni politiche. È noto infatti il rapporto conflittuale e di soggezione che Sicione
aveva subito nei confronti di Corinto e dei Cipselidi; malgrado all’epoca del matrimonio di
Agariste (575 ca.) la dinastia di quei tiranni fosse caduta già da una dozzina di anni, fu naturale
per Clistene rifiutare di legarsi ad una famiglia ateniese imparentata con i Cipselidi. È
significativo peraltro che Clistene scelse di concedere la figlia in sposa all’ateniese Megacle,
della stirpe degli Alcmeonidi, legando così le proprie sorti ad una famiglia che costituì in Atene
un avversario politico dei Pisistratidi, a loro volta alleati con i Filaidi60.
Per il tramite dei Filaidi, ritengo che anche i Pisistratidi vadano inseriti in questo quadro
di schieramenti politico-familiari61. Gli studiosi accettano infatti quasi unanimemente
l’esistenza di un accordo politico fra i Pisistratidi e i Filaidi62, sulla base delle vicende che nella
seconda metà del VI secolo portarono Milziade I a condurre l’impresa coloniale nel Chersoneso
Tracico, con l’avallo del governo di Pisistrato63. La collaborazione fra Pisistratidi e Filaidi può
già, a mio avviso, rintracciarsi nel 566, all’epoca della rifondazione della festività delle Grandi
Panatenee ad Atene: le fonti, pur frammentarie, attribuiscono l’arcontato in quell’anno al filaide
Ippoclide, eppure la rifondazione della festa e degli agoni associati è d’altro canto attribuita al
tiranno Pisistrato. È possibile dunque ricostruire l’esistenza di una convergenza già allora in
materia di politica religiosa interna e nella spartizione del potere ad Atene64. Il perido
cronologico della rifondazione delle Grandi Panatenee conicide peraltro con quello dell’attività
di Pisistrato nella conduzione della guerra di Atene contro Megara; l’attacco di Pisistrato contro
59
Hdt. VI 126-130.
L’alleanza fra Pisistratidi e Filaidi è comprovata dalle scelte di politica internazionale di Pisistrato, vd.
ANDREWES 1958, pp. 105-110, 112; GREENHALGH 1972 sulle forme di alleanza matrimoniale interaristocratica;
vd. infra, pp. 117ss., 189ss.
61
WILL 1955, p. 546, 556-562.
62
ANDREWES 1958, pp. 105-110, 112.
63
Hdt. VI 35, 39. WILL 1955, p. 556, cita il lavoro di MAZZARINO 1939.
64
Vd infra, pp. 190ss. Pherec. FGrHist 3 F 2 (ap. Marcell. Vit. Thuc. 2-4); Schol. Aristid. Panath. p. 189.4 (=3.323
Dindorf; Aristot. Peplos F 637 Rose): ta\ de\ mega/la Peisi/stratoj e)poi/hse; Harp. s.v. “Panathenaia”;
Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 181c Helm. CADOUX 1948, p. 104; DAVISON 1958, pp. 26-29; BRELICH 1969, p. 319320; PARKE 1986, pp. 34s.; KYLE 1987, pp. 15-31; SHAPIRO 1989, pp. 19-21, 40-47; BRUIT ZAIDMAN – SCHMITT
PANTEL 1992, pp. 84-86 ; DAVERIO ROCCHI 1993, pp. 151-153 ; FROST 1994, pp. 51-59; CALAME 1996, pp. 471476 ; PARKER 1996, pp. 67-71; RAAFLAUB 1996, pp. 1071-1081; HURWIT 1999, pp. 23-24, 30-31, 117-121.
60
58
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Megara e la spedizione del Filaide Milziade in Chersoneso dimostrano fattivamente che le due
famiglie condividevano una politica di espansione marittima che portava inevitabilmente allo
scontro con Megara.
Per un verso è tuttavia necessario porre un distinguo fra gli eventi e le alleanze familiari
della fine del VII secolo e del primo decennio del VI e le iniziative militari e politiche dei
Pisistratidi della metà del VI secolo. Fra queste due fasi cronologiche, nel 583, fu espulso da
Corinto l’ultimo dinasta della famiglia dei Cipselidi e la tirannide cadde: nel quadro che si sta
ricostruendo, questo evento potrebbe costituire un fattore di drastica discontinuità. Le iniziative
militari di Pisistrato, gli interessi espansionistici dei Filaidi e l’intesa politica fra le due famiglie
denotano tuttavia che quella intesa anti-megarese e la tendenza filo-corinzia in questa parte
della opinione politica ateniese persistettero malgrado il cambiamento politico avvenuto a
Corinto.
D’altronde è possibile interpretare una delle relazioni familiari di Pisistrato come una
affermazione di lealtà filo-cipselide, nonostante il cambiamento politico a Corinto e le sfortune
dei Cipselidi65. Nel periodo 561-550 ca. Pisistrato sposò l’aristocratica di Argo Timonassa,
figlia di Gorgilo e vedova di Archino di Ambracia, della stirpe dei Cipselidi66. Le ragioni di
parentela di Timonassa certo non furono un fattore cruciale e non possono sopravvalutarsi per
tre motivi fondamentali: in primo luogo il precedente marito era ormai morto, i Cipselidi erano
una famiglia in estinzione il cui potere era, al tempo, scomparso; inoltre, se questo matrimonio
avesse avuto il senso di un avvicinamento di Pisistrato ai Cipselidi, sarebbe stato senz’altro
interpretato dal governo aristocratico post-tirannico di Corinto come un tradimento di quella
tendenza filo-corinzia dimostrata in precedenza e che perdurò, come vedremo, anche in seguito;
infine, secondo il costume greco, il matrimonio di Timonassa con Pisistrato avrebbe avuto per
la sposa l’effetto legale di annullare qualunque legame con la famiglia paterna e tanto più con la
famiglia del marito defunto. Nondimeno, non credo sia per caso che Pisistrato scelse proprio
questa famiglia fra gli aristocratici di Argo per istituire una relazione politico-familiare in
questa polis: è possibile, propongo, che siano stati i Filaidi a costituire un primo tramite per
Pisistrato per entrare in contatto con Gorgilo, in virtù della parentela che le due famiglie
condividevano con i Cipselidi67.
65
WILL 1955, pp. 546-562; DAVERIO ROCCHI 1973.
Aristot. Ath. Pol. 17.4. Aristotele esplicita: “secondo alcuni avvenne durante la prima tirannide, secondo altri
durante il primo esilio”. La datazione del primo esilio è questione di dibattito fra gli studiosi, ma i termini estremi
per l’intervallo menzionato da Aristotele sono le date 561-544. SANDYS 1912, p. 70.
67
WILL 1955, pp. 546-562; ANDREWES 1958, pp. 105s.
66
59
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Nella seconda metà del VI secolo, l’oligarchia che prese il posto dei Cipselidi nel governo
di Corinto seguì, nei confronti di Atene e dei Pisistratidi, quella medesima tendenza filoateniese che aveva caratterizzato in precedenza i legami familiari dei tiranni con Atene e i
Filaidi. Nel 519 Corinto fu chiamata ad arbitrare nel conflitto di confine fra Tebe e la piccola
Platea, alleata e protetta di Atene, e il verdetto fu favorevole a quest’ultima68. Nel 508 lo
spartano Cleomene attaccò Atene col fine di instaurare Isagora al governo della città e l’anno
seguente l’attacco fu ripetuto sotto la conduzione di Cleomene e Demarato, ma in entrambi i
casi le spedizioni furono interrotte dall’opposizione di Corinto che ritirò il proprio esercito dalla
missione lacedemone69. Nel 506 ca. Sparta si volse ad appoggiare i Pisistratidi e convocò a
consesso gli alleati della Lega del Peloponneso per decidere l’attacco contro Atene, col fine
questa volta di riportare Ippia, figlio di Pisistrato, alla tirannide. Corinto anche in quella
occasione si oppose all’intervento e portò anche gli altri alleati a rifiutare l’appoggio a Sparta70.
Quest’ultimo episodio dimostra come a Corinto si sia mantenuta una politica estera filo-ateniese
per tutto il VI secolo, pur attraverso il passaggio dal governo tirannico dei Cipselidi
all’oligarchia e pur a fronte, ad Atene, del passaggio dal governo dei Pisistratidi a quello della
nuova classe politica isonomica.
Dunque mi pare si possa constatare l’esistenza di una intesa fra Atene e Corinto, nata in
funzione anti-megarese71 e mantenutasi anche dopo la sconfitta di Megara e lo stabilirsi
dell’autorità ateniese su Salamina; questo accordo implicito si fondava a mio avviso sulla
spartizione pacifica del controllo della navigazione nel Golfo Saronico. Si tratta di una intesa di
appoggio reciproco di natura strutturale, creata dalle circostanze strategico-geografiche,
dall’esistenza di comuni nemici, piuttosto che da veri e propri sforzi diplomatici; pure l’accordo
fra le due poleis trovò espressione in momenti e forme diverse nel corso del tempo, travalicando
le generazioni e i governi: nelle alleanze familiari tra Filaidi e Cipselidi, nella politica estera di
Pisistrato, nelle decisioni arbitrali dei tiranni e poi del governo di Corinto e infine nella gestione
del proprio ruolo che Corinto esercitò in seno alla Lega del Peloponneso. È nella rottura di
questo accordo che dobbiamo infine ricercare uno dei punti di svolta epocali che il V secolo
rappresentò per il mondo greco.
68
Hdt. VI 108. PICCIRILLI 1973, n. 9; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 28-31, 61-64, 180-184, 225-240.
Hdt. V 74-76.
70
Hdt. V 92.
71
ANDREWES 1958, p. 48-53. Anche Egina, forse più che Megara, costituì un comune nemico per Corinto e Atene,
e un movente per questa intesa strutturale.
69
60
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Il problema della datazione delle tirannidi e degli esìli di Pisistrato
La cronologia delle tirannidi e degli esilii di Pisistrato è un problema assai ampiamente
dibattuto e di ardua soluzione poiché, nonostante esista una condivisa narrazione degli eventi, le
fonti offrono riferimenti cronologici insolubilmente contraddittori, sia fra una fonte e l’altra che
all’interno delle informazioni fornite da un medesimo storico72. Non gioverebbe all’analisi che
si sta qui conducendo passare in rassegna lo stato dell’arte su questo problema o allungare lo
scritto con una disamina dei dati tramandati nel tentativo di fornire un’ulteriore ricostruzione
cronologica oltre a quelle già prodotte dalla moderna storiografia73. Per altro verso si impone
necessariamente una presa di posizione in merito a questo problema perché la ricostruzione
della politica estera di Pisistrato e dei Pisistratidi dipende strettamente da elementi specifici
quali i periodi di governo, gli esìli e i conflitti armati, la datazione dei quali contribuisce dunque
di riflesso a stabilire la cronologia e la durata delle relazioni internazionali di questa famiglia
tirannica. Dunque la scelta di una determinata sequenza cronologica impone a talune dinamiche
qui considerate degli specifici significati e nessi causali; viceversa, credo che alcune
osservazioni proposte in questo scritto possano fornire qualche elemento ulteriore alla soluzione
del problema della cronologia pisistratide.
La narrazione della biografia di Pisistrato pervenuta nelle fonti attribuisce l’istituzione di una
prima tirannide nel 560. Pisistrato si mise a capo di una propria fazione in opposizione alle due
già esistenti, capeggiate da aristocratici di spicco: Licurgo a capo degli abitanti della ricca
pianura attica e Megacle, dell’antica famiglia degli Alcmeonidi, a capo degli abitanti della costa
meridionale e orientale dell’Attica74. Le fonti concordano sul fatto che il primo periodo di regno
di Pisistrato fu di breve durata e che il tiranno non ebbe modo di instaurare saldamente il
proprio potere perché i partigiani di Licurgo e Megacle, di fronte al successo di Pisistrato,
misero da parte le proprie divergenze e si allearono per scacciare Pisistrato dal potere e da
Atene75. Senza il pericolo rappresentato dal tiranno, fra gli altri due gruppi politici rimasti
rinacquero le antiche ostilità; temendo i tumulti e le violenze che andavano creandosi,
l’alcmeonide Megacle richiamò Pisistrato ad Atene. Pisistrato tornò in controllo della polis, con
l’appoggio e il consenso di Megacle: in cambio egli sposò la figlia di Megacle76. Quel
matrimonio tuttavia non andò a buon fine poiché Pisistrato non volle discendenti dalla moglie
72
Hdt. I 59-64, V 94s.; Aristot. Ath. Pol. 14.1-17.4.
SANDYS 1912, pp. 57-68; BELOCH 1913, p. 292; ADCOCK 1924; ADCOCK 1926, p. 65; HOW-WELLS 1928, ad
Hdt. I 62; COHEN-GLOTZ 1938, p. 448; JACOBY 1949, pp. 152-196; LANG 1954; SUMNER 1961, pp. 37-48; BERVE
1967, pp. 41-62; DAVIES 1971, n. 11793, pp. 444-450; HIND 1974; LAVELLE 2005, pp. 210-219.
74
Hdt. I 59; Aristot. Ath. Pol. 13.4-5
75
Hdt. I 60; Aristot. Ath. Pol. 14.3.
76
Aristot. Ath. Pol. 14.4.
73
61
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
alcmeonide, cosicché Megacle considerò interrotto l’accordo e si adoperò per riconsolidare il
proprio potere personale. Temendo per la propria incolumità Pisistrato lasciò Atene, nel
secondo esilio registrato dalle fonti, per un lungo decennio. Sono questi primi eventi a costituire
la fase più incerta e contraddittoria per la cronologia della tirannide ateniese, eventi per i quali
le fonti forniscono dati imprecisi e la moderna storiografia ha proposto svariate ricostruzioni.
Durante la sua assenza da Atene, Pisistrato intraprese una significativa iniziativa coloniale sulle
coste egee della Tracia e fu in grado di raccogliere attorno a sé un’ampia e solida rete di
relazioni personali con individui e comunità in tutto il mondo greco. Grazie a questa
schiacciante superiorità economica, militare e politica, Pisistrato fece ritorno in Attica e
sconfisse in battaglia gli oppositori politici. La battaglia di Pallene segna l’instaurazione della
terza e definitiva tirannide di Pisistrato, a seguito della quale egli e poi i suoi figli governarono
Atene ininterrottamente fino all’espulsione ad opera dell’esercito spartano nel 511/10.
Come si è detto, la concordanza fra le fonti permette di non avere gravi incertezze per il
quadro narrativo sopra riassunto, ad eccezione della scarsità di informazioni che
contraddistingue la prima tirannide, il primo esilio e la seconda tirannide. Le fonti associano
alla narrazione dei riferimenti cronologici che devono necessariamente subire un’analisi e una
cernita: le fonti principali sono Erodoto ed Aristotele, ma i due autori non forniscono le
medesime cifre; Aristotele stesso offre dati differenti in due sue diverse opere; infine Aristotele
lega la propria datazione alla cronologia ateniese della lista degli arconti, ma questo porta a
contraddizioni cronologiche e logiche. Mi pare onesto dunque esplicitare quale modello
cronologico ho scelto di adottare in questa ricerca e darne giustificazione. La data della prima
tirannide è universalmente accettata essere il 560: né le fonti storiografiche né la critica
moderna se ne discostano77. Una serie di date certe è rappresentata dalla morte di Pisistrato,
dalla durata del regno del figlio Ippia e dunque dalla fine della tirannide ad opera dei
Lacedemoni. Pisistrato morì nel 528/778 e il figlio Ippia rimase al governo per 17 anni, fino al
511/10 quando i Pisistratidi lasciarono Atene. Erodoto e Aristotele asseriscono che la tirannide
dei Pisistratidi durò per 36 anni79. Io preferisco considerare questo dato come riferito al governo
ininterrotto della famiglia dunque, a partire dunque dalla vittoria a Pallene, alla terza e
definitiva tirannide di Pisistrato e al successivo regno di Ippia: questo porta a collocare la
battaglia di Pallene al 54680. Esiste una lettura alternativa di questa cifra secondo cui sarebbe da
77
Aristot. Ath. Pol. 14.1; Mar. Par. FGrHist 239 A 40; Plut. Sol. 32.3. ANDREWES 1958, pp. 100s.
Aristot. Ath. Pol. 17.1.
79
Secondo Erodoto furono 36 anni, mentre secondo Aristotele furono 35: Hdt. V 65; Aristot. Pol. V 12 (1315b).
80
ADCOCK 1924, pp. 176-181; JACOBY 1949, pp. 188-196; HAMMOND 1955, p. 389; ANDREWES 1958, pp. 100107; ELIOT 1967, pp. 283s. n. 24; LAVELLE 2005, pp. 209-218.
78
62
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
riferirsi al totale degli anni di regno di cui godette Pisistrato nella prima, seconda e terza
tirannide, sommato agli anni di regno del figlio: questo computo rispetta alcune date fornite da
Aristotele e abbassa la vittoria di Pallene e l’instaurazione della terza tirannide a pochi anni
prima della morte di Pisistrato81. Io non condivido questa lettura che, pure congrua con le cifre
di Aristotele, non tiene contro dell’importanza storica, politica e sociale che dovette avere
l’evento di Pallene; secondo la narrazione Pallene fu un evento militare in terra attica, che vide
poi l’entrata vittoriosa di Pisistrato entro la cinta di Atene, e ne sancì il potere. Mi pare logico
che la memoria collettiva e storica di Atene abbia preso come punto di riferimento questo
evento e che a questo evento abbia agganciato i dati cronologici preservati. Le fonti sono
piuttosto esplicite nel descrivere come malcerti e brevi i due precedenti periodi di tirannide e
questo non si accorda con la scelta di questi eventi come punti di riferimento cronologici.
Uno dei pochi riferimenti cronologici forniti da Erodoto è anche una delle poche occasioni
di concordanza con i dati di Aristotele e asserisce che il secondo esilio, che precedette la
battaglia di Pallene, durò 10 anni82. Risalendo nel computo dunque, l’inizio del secondo esilio è
da collocarsi al 556.
Secondo il calcolo finora seguito, si dovrà infine dare conto del periodo dal 560 al 556: in
quel breve periodo di anni, secondo la narrazione, si succedettero la prima tirannide, il primo
esilio e la seconda tirannide di Pisistrato. Questa cronologia contraddice quella fornita da
Aristotele nell’Athenaion Politeia, che calcola piuttosto un totale di 22 anni per queste tre fasi
della storia pisistratide: Artistotele attribuisce infatti una durata di 5 anni alla prima tirannide e
di 11 anni al primo esilio, poi una durata di 6 anni alla seconda tirannide e infine di 10 anni al
secondo esilio83. L’incongruenza fra la cronologia aristotelica e la ricostruzione che si propone
è, a mio avviso, correttamente risolta dall’analisi di F.E. Adcock, il quale ritiene che Aristotele
avrebbe utilizzato in maniera scorretta due diverse atthìdes, cioè non comparandole fra loro, ma
piuttosto mettendole insieme e dunque allungando fallacemente la propria cronologia84. La
cronologia che attribuisce la prima tirannide, il primo esilio e la seconda tirannide al breve
periodo dal 560 al 556 è d’altronde giustificata dalla narrazione delle fonti stesse che
descrivono le prime due tirannidi come periodi brevi in cui Pisistrato non ebbe il tempo per
81
SUMNER 1961, pp. 37-48.
Hdt. I 62; Aristot. Ath. Pol. 15.2.
83
Aristot. Ath. Pol. 14.3s., 15.1.
84
ADCOCK 1924; seguito poi da: JACOBY 1949, pp. 152-196; DAVIES 1971, n. 11793, pp. 444-450; HIND 1974,;
LAVELLE 2005, pp. 191-221.
82
63
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
consolidare il proprio potere e il primo esilio come un periodo quasi del tutto scevro di eventi,
sia nella biografia di Pisistrato che nella storia di Atene85.
La prima tirannide di Pisistrato e il matrimonio con Timonassa di Argo
Le fonti non forniscono notizie di sorta sulla prima tirannide di Pisistrato, ad eccezione
degli eventi che portarono alla presa del potere e di un generale giudizio particolarmente
positivo in merito alle modalità di governo, avveduto e consono alla pace sociale86. Aristotele
tramanda tuttavia che intorno a questo primo periodo di potere Pisistrato sposò una donna di
nobile famiglia di Argo, di nome Timonassa; in altre fonti si riscontrano ulteriori cenni a questa
unione e ai figli che ne nacquero87.
È noto che Pisistrato, prima di questo matrimonio, aveva già preso una moglie ateniese, di
cui non ci è dato sapere nulla se non che aveva dato al tiranno due figli, Ippia e Ipparco88.
Essendo nati da genitori ateniesi e godendo di una naturale precedenza, questi, il primogenito
Ippia in particolare, furono gli indiscussi figli legittimi e destinati alla successione al potere del
padre ad Atene; non è necessario tuttavia supporre che questa donna ateniese fosse morta
perché Pisistrato potesse contrarre matrimonio con Timonassa. Nell’epoca arcaica il
matrimonio giocò un ruolo chiave come strumento diplomatico nella gestione delle reti di
alleanze dei tiranni e dei gène aristocratici; la letteratura omerica accetta esplicitamente la
poligamia maschile e fino all’istituzione della partecipazione politica allargata nella polis, in
epoca classica, la distinzione fra mogli legittime e donne diversamente associate al
capofamiglia non fu affatto marcata. In quest’ottica, e in questo periodo storico, la questione
della legittimità dei figli ateniesi o dell’illegittimità di quelli argivi è un anacronismo delle fonti
a noi pervenute che non potevano comprendere la questione se non entro i parametri socioculturali di epoca classica: in quell’epoca la poligamia aristocratica arcaica aveva perso la
propria ragione d’essere dato che i gène aristocratici non potevano più esercitare il monopolio
della decisionalità nella gestione della polis e di conseguenza le relazioni interfamiliari avevano
perso la loro funzionalità politica. È opinione condivisa dalla critica, e legittimata dal corso
degli eventi storici della tirannide dei Pisistratidi, che Timonassa e la famiglia argiva
85
Hdt. I 60.
Hdt. I 59; Thuc. VI 54.5s.; Aristot. Ath. Pol. 14.3, 16.1-17.1; Aristot. Pol. V 10-23 (1314a-1316a).
HORNBLOWER 2008, ad. Thuc. VI 54.5. Sul rispetto delle istituzioni ateniesi da parte dei Pisistratidi e sulla
gestione della politica interna ed edilizia: STAHL-UWE 2009, pp. 149-151; AMPOLO 1973.
87
Hdt V 94; Thuc. I 20.2, VI 55.1; Aristot. Ath. Pol. 17.3s., 18.2; Plut. Cat. Mai. 14.8. SANDYS 1912, p. 70; HOWWELLS 1928, ad Hdt. V 94. Breve ma specifica prosopografia in: LAVELLE 2005, pp. 203-209.
88
LAVELLE 2005, pp. 198-203 è fra i pochi che fa giustamente notare che conosciamo tanto poco che la donna
potrebbe persino non essere ateniese.
86
64
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
rimanessero stanziati ad Argo89: dunque non si crearono nemmeno le circostanze per un
conflitto di interessi fra i due rami, ateniese ed argivo, della famiglia di Pisistrato e gli interessi
di preminenza della moglie ateniese e dei suoi figli non furono mai in discussione90.
Prima di andare in sposa al tiranno di Atene, Timonassa di Argo, figlia di Gorgilo, era
stata la moglie di Archino di Ambracia, della famiglia dei Cipselidi, tiranni di Corinto91.
Possiamo immaginare con sicurezza che Gorgilo combinò il secondo matrimonio a causa della
morte del precedente marito; malgrado le fonti non esplicitino il fatto, la storiografia moderna
condivide universalmente questo presupposto: non si vede perché Timonassa avrebbe altrimenti
dovuto lasciare un consorte di una famiglia di prestigio internazionale, se pure decaduta dal
potere a Corinto dal 58392, egli stesso tiranno in una delle colonie che i Cipselidi avevano
stabilito nel Mar Ionio93. È possibile anche dedurre che viceversa la famiglia di Gorgilo fosse di
alta levatura, aristocratica e certamente politicamente influente, se la giovane Timonassa ebbe
l’occasione di venire accettata in quella prestigiosa famiglia tirannica. Per Gorgilo dunque il
matrimonio della figlia con Pisistrato dovette offrire la possibilità di rimaritare Timonassa, pur
dopo un primo matrimonio ed in una età probabilmente non giovanissima, con un personaggio
dalle capacità e dell’influenza pari al precedente marito. In base a questo ragionamento
possiamo dunque correggere l’incertezza della cronologia nel passo aristotelico: Aristotele
infatti informa il lettore che alcuni dicevano che il matrimonio fosse avvenuto durante il primo
esilio, altri quando Pisistrato era al potere94. Gorgilo dovette ritenere Pisistrato un pretendente
desiderabile per la figlia, nel momento in cui era a capo di Atene e presentava garanzie di
influenza, utilità politica e vantaggio economico, pari o superiori a quelle del Cipselide defunto;
Pisistrato non avrebbe potuto costituire una scelta altrettanto vantaggiosa durante il primo
esilio, quando era stato appena estromesso dalla propria città e dal potere tirannico.
89
Contra: KELLY 1976, p. 160, in cui si suppone che Timonassa e i figli risedettero ad Atene per la breve durata
della prima tirannide, per poi tornare ad Argo.
90
In questa direzione volge l’opinione espressa da K.J. Beloch, secondo cui i figli argivi di Pisistrato non erano
affatto illegittimi, nòthoi, in virtù del rango aristocratico della madre: BELOCH 1913, pp. 298s.
91
Aristot. Ath. Pol. 17.4.
92
WILL 1955, pp. 363-365; HAMMOND 1982 b, p. 354; SALMON 1997, pp. 229s.
93
Le fonti non definiscono effettivamente Archino come un tiranno, ma ne indicano solo la provenienza con
l’aggettivo Ambrakiòtes: Aristot. Ath. Pol. 17.4. Ambracia era una delle colonie che il tiranno di Corinto Cipselo
aveva fondato nel Mar Ionio, al fine di stringere contatti con le aree dell’Illiria; la sua fondazione può collocarsi al
612. Della storia di Ambracia si conosce la tirannide del cipselide Periandro, figlio di Gorgo, probabilmente un
fratello di Periandro: Aristot. Pol. V 4 (1304a, 30-33). WILL 1955, pp. 517-526; VIANO 2002, pp. 414s. Alcuni
studiosi suppongono che i Cipselidi che governavano le colonie corinzie siano stati espulsi dal potere nello stesso
momento in cui cadde la tirannide in madrepatria: se così fosse si imporrebbe una rivalutazione peggiorativa del
prestigio dei Cipselidi di Ambracia a metà del VI secolo e della posizione di Archino nel matrimonio con
Timonassa, vd. CLINTON 1834, pp. 214-216; SANDYS 1912, p. 70.
94
Aristot. Ath. Pol. 17.4.
65
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Il vantaggio per Gorgilo e Timonassa fu perciò di poter agganciare la propria famiglia ad un
potente tiranno, che aveva peraltro appena assicurato ad Atene il controllo di parte del Golfo
Saronico. La necessità per questa famiglia argiva era tanto più impellente in quanto i Cipselidi,
con cui erano alleati, dal 583 erano ormai decaduti da un importante ruolo storico, erano stati
esclusi dal controllo della madrepatria Corinto e i discendenti che ancora controllavano le
colonie istituite da Cipselo e Periandro andavano necessariamente estinguendosi, per cause
naturali o per rivolgimenti politici95.
Anche dal punto di vista di Pisistrato il matrimonio con Timonassa, discendente di una
famiglia notabile di Argo alleata con tiranni di antica data, assicurò uno balzo in avanti del
prestigio internazionale della sua famiglia. Non credo sia da escludere che Pisistrato abbia
subito il fascino, per il collegamento con la tirannide dei Cipselidi e con il mito della loro
potenza, che Timonassa portava con sé, soprattutto in un momento in cui egli stesso aspirava a
rendersi autorità tirannica nella propria polis. Iniziative di valore simbolico facevano peraltro
parte del linguaggio politico arcaico, come dimostrò solo pochi anni più tardi il rientro di
Pisistrato ad Atene a bordo di un cocchio e accompagnato da una ragazza che impersonava la
dea Atena96.
Oltre a queste considerazioni preliminari e circostanziali, ritengo sia utile inserire il
matrimonio di Pisistrato e Timonassa nel quadro geo-politico internazionale della Grecia della
metà del VI secolo, evidenziandone una serie di moventi e conseguenze sul piano politico, sia
internazionale che locale, e mettendo dunque in evidenza il valore dell’alleanza matrimoniale
come strumento diplomatico. Nel clima politico vigente ad Atene dopo l’instaurazione della
tirannide, è evidente che Pisistrato non poteva confidare nel consenso, e tantomeno
nell’appoggio, di alcuno degli altri esponenti politici; la breve durata della prima tirannide, per
l’intervento di Megacle e Licurgo, fornisce un metro di giudizio per valutare l’opposizione che
il tiranno fronteggiava. Fu dunque una pratica del tutto logica per Pisistrato allora, e
ampiamente diffusa fra le tirannidi, quella di cercare alleati e risorse politico-strategiche
all’esterno della propria polis, fra quella élite tirannico-aristocratica con cui condividevano
rango e cultura, ma fra la quale difficilmente avrebbero trovato soggetti interessati a scalzarli
dal potere che avevano assunto nella loro polis97.
95
WILL 1955, pp. 363-365; HAMMOND 1982 b, p. 354; SALMON 1997, pp. 229s.
Hdt. I 60; Aristot. Ath. Pol. 14.5. Pisistrato entrò in Atene su un carro accompagnato da un’alta ragazza che
impersonava la dea Atena; per un’analisi dell’episodio: HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 60; BOARDMAN 1972 per una
analisi del legame tra questa iniziativa e la coeva decorazione ceramica attica; CONNOR 1987, pp. 42-47; DEACY
2008, pp. 98-101; ANGIOLILLO 2009 per una revisione delle tesi di BOARDMAN 1972.
97
STAHL 1987, pp. 94-99.
96
66
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Il matrimonio con Timonassa nel quadro dei gruppi parentelari panellenici
Vale la pena discutere alcune delle circostanze che spinsero Pisistrato a guardare a
Timonassa e ad Argo nella ricerca di una alleanza inter-familiare extra-poleica. Ho già avuto
modo di collocare Pisistrato entro la dialettica delle due opposte strategie in merito alla
conduzione della politica estera di Atene nel periodo dalla fine del VII secolo alla metà del VI,
in particolare nei confronti della contesa con Megara. Il partito che caldeggiava l’affermazione
marittima internazionale di Atene era naturalmente a favore dello scontro con Megara e della
neutralizzazione di quel vicino pericoloso e concorrente; questo medesimo partito trovò un
naturale alleato nella polis di Corinto, anch’essa nemica di Megara per natura e collocazione
geografica. Pisistrato è dunque da collocarsi in questa fazione politica anti-megarica e filocorinzia; all’epoca in cui la polis dell’Istmo era governata da Cipselo e dai sui discendenti,
questa fazione fu filo-cipselide, poi, alla caduta della tirannide nel 583, condivise i propri
interessi strategici con la polis corinzia, piuttosto che con la vecchia famiglia dei tiranni. Entro
questa prospettiva, nella seconda metà del VII secolo un membro, non nominato, della famiglia
aristocratica ateniese dei Filaidi strinse un’alleanza matrimoniale con il tiranno corinzio Cipselo
e il figlio di quella unione ebbe anch’egli nome Cipselo; i figli di questo Cipselo ateniese
furono Cimone, Milziade e Ippoclide, coetanei di Pisistrato e individui di spicco della società e
della storia politica di Atene, nella seconda metà del VI secolo.
Quella dei Filaidi sembra essere stata l’unica famiglia ateniese con cui i Pisistratidi
giunsero a sostenere un accordo duraturo, più o meno esplicito, per l’appoggio reciproco e la
condivisione del potere98. Durante la prima tirannide di Pisistrato, Miliziade condusse una
missione coloniale nel Chersoneso Tracico, al fine di assicurare ad Atene una posizione nel
controllo dell’imbocco dell’Ellesponto; l’iniziativa ebbe inizio e fu poi continuata con
l’approvazione e il sostegno dei tiranni ateniesi, di Pisistrato prima e dei figli poi. Altre tracce
di questa intesa familiare possono forse emergere dalla constatazione che l’importante
celebrazione delle Grandi Panatenee sembra fosse stata re-istituita ad opera di Pisistrato, ma
durante l’arcontato del filaide Ippoclide nel 566 e dunque con il consenso di quest’ultimo99.
Posta dunque questa intesa reciproca fra Pisistratidi e Filaidi, è, a mio avviso, proprio per il
98
WADE-GERY 1951, pp. 217-220; ANDREWES 1958, pp. 100-113; GREENHALGH 1972; KEEN 2000, pp. 66s.
Vd. infra, pp. 188ss. Pherec. FGrHist 3 F 2 (ap. Marcell. Vit. Thuc. 2-4); Schol. Aristid. Panath. p. 189.4
(=3.323 Dindorf; Aristot. Peplos F 637 Rose): ta\ de\ mega/la Peisi/stratoj e)poi/hse; Harp. s.v.
“Panathenaia”; Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 181c Helm. CADOUX 1948, p. 104; DAVISON 1958, pp. 26-29;
BRELICH 1969, p. 319-320; DAVIES 1971, n. 8429 [II], pp. 293-295; PARKE 1986, pp. 34s.; KYLE 1987, pp. 15-31;
SHAPIRO 1989, pp. 19-21, 40-47; BRUIT ZAIDMAN – SCHMITT PANTEL 1992, pp. 84-86 ; DAVERIO ROCCHI 1993,
pp. 151-153 ; FROST 1994, pp. 51-59; CALAME 1996, pp. 471-476; PARKER 1996, pp. 67-71; RAAFLAUB 1996, pp.
1071-1081.
99
67
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
tramite dei Filaidi che la scelta di politica coniugale di Pisistrato fu indirizzata su Timonassa. I
Filaidi erano infatti imparentati con i Cipselidi100: all’epoca di Pisistrato il legame risaliva a due
generazioni prima; come si è detto infatti Milziade e i fratelli erano i nipoti materni di Cipselo
che era stato il fondatore della tirannide a Corinto; i Filaidi dovettero senz’altro mantenere
aperti i canali di relazioni personali con i discendenti e i parenti dei Cipselidi e delle famiglie
associate, indipendentemente dalla caduta della tirannide a Corinto nel 583. Non
necessariamente il nuovo allineamento strategico-politico della diplomazia dello stato ateniese
in funzione filo-corinzia, nel corso del VI secolo, comportò la rottura dei legami inter-familiari
dei Filaidi con i Cipselidi: questi legami poterono certamente perdere la loro funzionalità
politica e anche la loro importanza, ma poterono d’altronde persistere nel loro significato interpersonale e nel loro valore di prestigio sociale.
Nel 560 uno dei due oppositori di Pisistrato fu Megacle, in quel momento l’esponente di
spicco della prestigiosa famiglia aristocratica ateniese degli Alcmeonidi; lo stesso Megacle, nel
576, aveva sposato Agariste, la figlia del tiranno di Sicione, Clistene, costruendo dunque
un’alleanza inter-familiare tra gli Alcmeonidi ateniesi e gli Ortagoridi che comandavano a
Sicione101. Salito al potere ad Atene, Pisistrato cercò un’alleanza matrimoniale che gli
guadagnasse un appoggio strategico fidato al di fuori della polis, per fronteggiare l’opposizione
politica interna di Megacle e Licurgo, ma al contempo la sua decisione fu guidata anche dal
tentativo di eguagliare il gruppo degli Alcmeonidi-Ortagoridi sul piano del prestigio familiare e
sociale panellenico e dalla prospettiva di legare la sua figura di nuovo sovrano dello stato ad
una casata di potere tirannico. Questi fattori che legavano l’opposizione politica interna ad
Atene con aspetti del prestigio della parentela panellenica costituiscono a mio avviso un
movente sufficiente perché Pisistrato fosse portato a cercare un legame familiare con il gruppo
allargato dei tiranni cipselidi102.
Dunque è possibile ricostruire un quadro in cui i Filaidi, che probabilmente già nel 560
godevano di un’intesa con i Pisistratidi, avrebbero messo a frutto la propria parentela con i
Cipselidi per assicurare a Pisistrato una alleanza matrimoniale, certo non con l’antica famiglia
dei tiranni di Corinto poiché questi erano scomparsi dalla scena con la caduta della tirannide nel
583, ma perlomeno con la famiglia di Argo che ai Cipselidi era stata recentemente associata. Il
contributo all’espansione della rete di relazioni parentelari di Pisistrato, nel campo d’influenza
di lungo corso dei Cipselidi, avrebbe potuto costituire una occasione per i Filaidi di
100
ANDREWES 1958, pp. 105s.
Hdt. VI 126-131. MCGREGOR 1941, pp. 268-279, 287; PARKER 1994, pp. 412s., 416s., 421.
102
DAVERIO ROCCHI 1973.
101
68
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
riattualizzare e rinvigorire il proprio ruolo nell’élite panellenica e di ribadire il proprio legame
con quell’antica casata tirannica; è evidente poi che, nel gioco della politica interna ateniese, il
matrimonio di Pisistrato con Timonassa forniva, di riflesso, qualche garanzia in più anche agli
alleati del tiranno.
Se questa serie di considerazioni furono dunque nella mente di Pisistrato nel momento in
cui prese Timonassa in moglie, credo sia possibile far luce su alcuni aspetti della mentalità di
questo personaggio. In un periodo in cui le grandi tirannidi arcaiche nella Grecia continentale
stavano ormai diventando un fenomeno del passato, come era successo a quella dei Cipselidi e
come sarebbe di lì a poco successo anche quella degli Ortagoridi, Pisistrato dimostra l’adesione
ad una serie di valori aristocratici, di prestigio familiare e di senso della discendenza, ossia
dimostra di ricercare non solo il proprio interesse politico locale, ma anche l’inserimento in una
élite di potere sovrano trans-generazionale103. Forse questo atteggiamento può imputarsi ad un
certo grado di inesperienza, poiché il matrimonio con Timonassa non gli assicurò la tirannide e
le iniziative diplomatiche internazionali che portarono alla vittoria di Pallene del 546 ebbero
effetti strategici, militari ed economici più decisivi. Confrontando la notizia qui discussa con lo
scenario geo-politico dell’epoca emerge la constatazione che l’alleanza matrimoniale argiva di
Pisistrato non rispondeva a moventi strategici relativi alla posizione di Atene o di Argo nella
politica interstatale della Grecia: il matrimonio argivo fu funzionale esclusivamente alla
strategia di affermazione personale e familiare di Pisistrato; per meglio comprendere questo
aspetto mi pare necessario considerare che, quando Pisistrato sposò Timonassa, egli aveva
appena conquistato la tirannide e si trovava a guardarsi dalle mosse degli avversari Licurgo e
Megacle e a difendere una posizione di potere ancora malcerta. In questa condizione perciò le
iniziative risalenti a quel periodo dovettero in primo luogo fungere da strumenti di affermazione
del suo potere personale entro la polis, a vantaggio proprio e della sua famiglia, mentre
considerazioni di natura strategica e nei confronti della polis, che pure egli era chiamato ad
amministrare, possono avere avuto una importanza soltanto secondaria e dovettero rientrare in
progetti di lungo termine.
Lo scenario internazionale del 560 vede Atene in possesso di Salamina e in definitiva
posizione di superiorità nei confronti dell’antica avversaria Megara. Grazie alle capacità militari
di Pisistrato nel comando militare Atene aveva assicurato la propria navigazione nell’area
orientale del Golfo Saronico e conseguentemente la propria capacità di condurre una politica
marittima di ampio respiro; in questa linea di politica estera si spiegano, nei periodi successivi,
103
ANDREWES 1958, pp. 108s.; DEN BOER 1969; MOSSÉ 1969, pp. 43s.; GERNET 1983, pp. 157-159, 287-299; DE
LIBERO 1996, pp. 389-413; STEIN HÖLKESKAMP 2009, pp. 114s.
69
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
l’attacco di Pisistrato volto a conquistare il Sigeo, in Troade, e la colonizzazione del
Chersoneso Tracico da parte di Milziade. Non esistevano dunque interessi ateniesi in
Peloponneso; a Sparta i Pisistratidi godevano di una xenìa invero datata e mai sfruttata; la
possibilità di creare un ulteriore alleato personale ad Argo doveva risultare di ridotto interesse
per la collettività ateniese. Queste considerazioni ben si accordano con l’assoluta scarsità di
ceramica attica, in questo periodo, che l’archeologia ha mostrato negli scavi dell’Heraion di
Argo104.
La critica ha spesso notato come non ci siano state altre conseguenze derivate da questa
alleanza matrimoniale, ad eccezione dell’aiuto pervenuto a Pisistrato da Argo in occasione dei
fatidici eventi della battaglia di Pallene, nel 546105; questo evento bellico, come anche le
successive iniziative di Pisistrato al Sigeo, si lega alla figura del figlio argivo Egesistrato.
II.2. Il primo esilio di Pisistrato
Come si è sopra discusso relativamente alla cronologia delle tirannidi di Pisistrato106, sono
reticente ad accettare le cifre proposte da Aristotele perché male si accordano con le
informazioni delle due narrazioni pervenuteci secondo cui Pisistrato fu scacciato dal potere
“dopo poco tempo”, “quando il suo potere non era ancora ben radicato”107. Questo primo esilio
avvenne qualche tempo dopo il 560 e qualche tempo prima del 556 e fu di breve durata poiché
prima del 556 Pisistrato poté godere di un secondo periodo di governo personale prima di
subire il più decisivo esilio decennale.
I sostenitori di Megacle e quelli di Licurgo vennero ad un accordo e, unendo le forze,
espulsero Pisistrato108. Di questo esilio non sappiamo nulla; si potrebbe, a mio avviso, lanciare
l’ipotesi che Pisistrato abbia trovato rifugio temporaneo ad Argo. Esiste la possibilità che il
tiranno avesse rinunciato ad intervenire nella politica e nella vita di Atene senza però lasciare
l’Attica: a questo proposito la critica identifica nell’Attica sudorientale, intorno a Brauron, che
pare fosse la zona di provenienza della famiglia dei Pisistratidi109. Secondo il computo
104
HOPPIN-WALDSTEIN 1898; DUNBABIN 1937, pp. 83s.
Hdt. I 61.
106
Vd. supra, pp. 61ss.
107
Hdt. I 60; Aristot. Ath. Pol. 14.3.
108
Erodoto usa il termine exelàuno, col senso di “mandare fuori, espellere, spingere fuori”: Hdt. I 60.1. Aristotele
usa ekbàllo, che ha il significato affine di “mandare fuori, buttare fuori, deporre, far cadere”: Aristot. Ath. Pol.
14.3.
109
Plat. Hipparch. 228b; Plut. Sol. 10.3. WADE-GERY 1951, p. 219; ANDREWES 1958, pp. 102s.; KINZL 2011, s.v.
“Peisistratids”, in BNP.
105
70
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
aristotelico l’esilio sarebbe durato 10 anni110; come ho già avuto modo di notare, ritengo questo
dato un errore della fonte: è un dato che contraddice la narrazione e il computo fondato sulle
successive date più sicure. Non da ultimo, mi pare significativo rilevare che, se questo primo
esilio fosse durato 10 anni, Pisistrato non sarebbe potuto rientrare nella lotta politica con la
facilità con cui organizzò l’alleanza matrimoniale con Megacle, come dimostra per converso
l’impegno profuso nel migliorare la propria posizione durante l’effettivo decennio del secondo
esilio che portò alla battaglia di Pallene. Megacle non avrebbe avuto alcuna necessità di
richiamare Pisistrato in patria dopo 10 anni di esilio. Se nel periodo 560-556 vogliamo
collocare le fasi delle prime due tirannidi intervallate da tale esilio, questo primo
allontanamento dalla politica ateniese non fu dunque più lungo di qualche anno.
II.3. La seconda tirannide di Pisistrato
Poco dopo l’allontanamento di Pisistrato, Megacle ritenne di essere in pericolo nel clima
delle lotte politiche che non si placavano e ritenne più sicuro e vantaggioso richiamare
Pisistrato per stringere con lui un patto di condivisione del potere. Queste dinamiche non
dovrebbero interessare il lavoro di questa ricerca perché concernono aspetti prettamente relativi
alla lotta politica interna alla polis di Atene; sarà sufficiente prendere in considerazione
brevemente i moventi per questo cambio di indirizzo politico di Megacle. Senz’altro Megacle si
rese conto dell’ascendente sociale e politico di cui il tiranno godeva nei confronti del demos. È
interessante notare il linguaggio diplomatico con cui Erodoto descrive le relazioni fra Pisistrato
e Megacle. Nel contattare l’esiliato, Megacle invia un araldo: epikerykéuomai, cioè “mando un
messaggio tramite araldo, mando un araldo per trattare o per fare una proposta”. L’invio di un
kéryx, un araldo, era una pratica usata nella diplomazia interstatale, fra entità politiche: se
dunque Erodoto non sta forzando la situazione e il lessico, queste notizie fanno luce su come le
famiglie e i gène aristocratici consideravano sé e i propri interlocutori politici e sulla
consistenza politica e para-statale dei gruppi di aristocratici e di stasiòtai che gestivano lo stato
in epoca arcaica111. Le conseguenze di questa forma mentis riguardano anche il contesto
internazionale: secondo questi principi, infatti, una famiglia tirannica, anche nei periodi di
esilio, di sradicamento e dunque di inattività nella gestione dello stato, poteva considerarsi
come una entità politica, con una propria identità, anche se non geografica, con propri obiettivi,
alleati e avversari politici. Questo atteggiamento contribuisce a spiegare i ripetuti ritorni di
110
111
Aristot. Ath. Pol. 14.4.
DAVERIO ROCCHI 1973, soprattutto pp. 92-95.
71
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Pisistrato ad Atene. L’accordo fra Pisistrato e Megacle prese la forma familiare dell’alleanza
matrimoniale: Pisistrato sarebbe ritornato ad Atene, avrebbe ripreso la tirannide e, in cambio,
avrebbe preso in sposa (gyné: la sposa legittima)112 la figlia di Megacle113.
Nonostante questo accordo anche la seconda tirannide di Pisistrato ebbe termine in breve,
come si è avuto modo di calcolare, nel 556. Secondo le fonti il matrimonio con la figlia di
Megacle fu annullato perché Pisistrato si rifiutò di generare dei figli con la giovane
Alcmeonide114; Aristotele semplifica la notizia dichiarando che Pisistrato rifiutò del tutto
l’accordo matrimoniale115.
II.4. La politica matrimoniale di Pisistrato e le cause del primo esilio, della seconda
tirannide e del secondo esilio
Mi pare significativo rilevare la scarsità di iniziative politiche o strategiche che
contraddistinse i primi due periodi di tirannide di Pisistrato; la presa di potere, l’opposizione
aristocratica e l’esilio si configurano come dinamiche eminentemente interne alla politica e alla
società di Atene. Unici fattori di nota rilevati dalle fonti in questo periodo sono i due matrimoni
di Pisistrato, entro ed al di fuori di Atene, ed è dunque su questi presupposti che l’analisi deve a
mio avviso muovere per individuare il significato della politica matrimoniale del tiranno, per
mettere in luce le cause dell’esilio e per collocare eventualmente queste considerazioni entro il
quadro della sua politica estera. Motivo ulteriore per legare fra loro questa serie di eventi è il
loro susseguirsi entro il breve giro di 4 anni, nel periodo 560-556.
Il matrimonio con Timonassa è l’unico evento che le fonti tramandano per la prima breve
tirannide di Pisistrato; si è già avuto modo di valorizzare il significato ideologico e sociale,
piuttosto che strategico-politico, di questa alleanza familiare116. Si potrebbe congetturare che
questa iniziativa possa d’altronde avere avuto un legame causale con la reazione di Megacle e
Licurgo che portò all’esclusione di Pisistrato; la ricerca di alleati aristocratici e filo-tirannici al
di fuori di Atene potrebbe essere stato un motivo sufficiente, per i due avversari, per temere una
svolta di Pisistrato verso un regime di più stretto controllo della polis e dunque verso una loro
più marcata esclusione.
112
Si considerino d’altronde le precauzioni da adottarsi in merito ai termini e ai concetti di “sposa legittima” nel
contesto dell’epoca arcaica: VERNANT 1973.
113
Hdt. I 59.
114
Hdt. I 61.
115
Aristot. Ath. Pol. 15.1.
116
Vd. supra., pp. 64ss.
72
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Il matrimonio con Timonassa sembra essere stato dunque, fra le cause della prima
espulsione di Pisistrato; d’altro canto le fonti sono esplicite nell’identificare la soluzione della
crisi aperta fra Pisistrato e l’aristocrazia ateniese nel matrimonio fra Pisistrato e la figlia di
Megacle. L’effetto di questa relazione doveva essere quello di assicurare la condivisione del
potere su Atene fra le due famiglie dei Pisistratidi e degli Alcmeonidi: la prima una famiglia di
fama relativamente recente, ma dall’ampio appoggio presso il demos e dalle evidenti capacità
militari; la seconda una famiglia di antica tradizione, significativi contatti internazionali e
ampia ricchezza, ma tuttavia segnata dal sacrilegio ciloniano117. Pisistrato avrebbe guadagnato
un alleato decisivo per acquietare l’opposizione politica aristocratica al suo governo; viceversa
Megacle avrebbe guadagnato l’accesso indiretto al potere politico in Atene grazie
all’associazione familiare stabilita col tiranno, il quale sarebbe divenuto cioè suo genero118.
Pisistrato ruppe però le proprie obbligazioni con Megacle proprio perché non volle privare i
figli ateniesi e quelli argivi della preminenza nella famiglia e nella spartizione del potere119.
Non mi pare un fattore secondario l’inserimento di queste dinamiche inter-familiari nel
più ampio scenario delle associazioni familiari panelleniche di lungo periodo, di cui ho già
avuto modo di parlare. Megacle aveva legato la famiglia degli Alcmeonidi al gènos degli
Ortagoridi, tiranni di Sicione, quando nel 575 ca. aveva preso in moglie Agariste, la figlia di
Clistene120. Dobbiamo dunque concludere che la figlia che Megacle andava ora proponendo a
Pisistrato era probabilmente una discendente per parte materna degli Ortagoridi. Pisistrato era
invece legato al gruppo internazionale della famiglia dei Cipselidi e agli interessi filo-corinzi,
sia per la sua impostazione di politica marittima, sia tramite la sua intesa con i Filaidi, sia
tramite il matrimonio con Timonassa.
Se, come credo, queste considerazioni agivano a
plasmare le affiliazioni familiari e le decisioni nella conduzione della politica estera della polis,
possiamo meglio comprendere perché Pisistrato lasciò fallire l’intesa matrimoniale con gli
Alcmeonidi, che pure gli avrebbe procurato un decisivo sostegno nel mantenimento del potere
ad Atene.
117
RAAFLAUB 1996, pp. 1048s. sull’importanza storica del sacrilegio.
Meccanismo affine regolò la relazione fra Teagene di Megara e l’Ateniese Cilone che tentò di prendere la
tirannide: Hdt. V 70s.; Thuc. VI 126. Vd. supra, pp. 30ss.
119
DUPLOUY 2006, pp. 90-93.
120
Hdt. VI 130.
118
73
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
II.5. Il secondo esilio di Pisistrato
L’alleanza matrimoniale tra Pisistratidi e Alcmeonidi fu dunque di brevissima durata e
Megacle reagì riconciliandosi con gli stasiòtai, i partigiani, di Licurgo; prima ancora di
incorrere in situazioni pericolose, Pisistrato scelse la via dell’esilio e lasciò la patria (chòra).
Come si è visto, le fonti concordano sul fatto che questo esilio fu di durata decennale. Questa
estromissione da Atene interessò non solo il tiranno ma tutta la famiglia dei Pisistratidi e li colpì
sia nelle loro capacità politiche che economiche: si configurò infatti come un effettivo esilio
legale (atimìa) poiché abbiamo notizia del fatto che i beni dei Pisistratidi furono banditi all’asta
e acquistati da Callia, un coraggioso cittadino di tendenze anti-tiranniche121. A differenza di
quanto si è notato per il primo breve esilio, per questa fase della vita di Pisistrato conosciamo o
possiamo ricostruire una intensa serie di iniziative di varia natura; questa constatazione ci
permette di capire, da un lato, la gravità della situazione in cui versavano i Pisistratidi, per altro
verso, l’importanza che la strategia extra-poleica ebbe per la successiva instaurazione della
tirannide.
II.6. Gli insediamenti di Pisistrato in Tracia, a Rhaikelos e sullo Strimone
Le fonti concordano nell’attribuire a Pisistrato, in questo periodo, una spedizione
nell’Egeo settentrionale, sulle coste della Tracia. Aristotele fornisce notizie precise al riguardo:
Pisistrato colonizzò (synoikìzo) Rhaikelos presso il golfo Termaico. Poi, da qui, si trasferì nella
regione del Pangeo, dove si arricchì (chrematìzo) e assoldò mercenari (misthòi stratiòtas)122.
Anche Erodoto conosceva questa attività in Tracia, sebbene identificasse le medesime località
tramite toponimi diversi asserendo che i mercenari e le ingenti ricchezze (epìkouroi kai
chrèmata) che assicuravano il potere di Pisistrato, una volta insediato, provenivano dal fiume
Strimone, oltre che dall’Attica123. È stato notato che la figura del peltasta trace fece la sua
apparizione nell’iconografia della ceramica attica a partire dalla metà del VI secolo ca.: si
direbbe dunque che questa innovazione artistica si leghi cronologicamente alle ricadute in
campo culturale dei contatti dei Pisistratidi, e poi dei Filaidi, con popolazione tracie e
soprattutto alla presenza in Atene, dopo il 546, dei mercenari barbari impiegati dal tiranno124.
121
Hdt. VI 121. DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 108s. È significativo che il tiranno Ippia prese in sposa Mirsine, figlia
di Callia. Le diverse informazioni genealogiche sui due personaggi lascerebbero pensare ad un caso di omonimia,
ma, se così non fosse, l’apparentemente lodevole coraggio civico di Callia altro non sarebbe che un espediente per
cui i Pisistratidi mantennero il controllo delle proprie ricchezze: Thuc. VI 55.
122
Aristot. Ath. Pol. 15.2. Sulla localizzazione di Rhaikelos: RHODES 1981, pp. 207s.
123
Hdt. I 64. STAHL 1987, pp. 201, 227s.
124
BEST 1969, pp. 5-7; PEMBERTON 1988, pp. 230s.; LAVELLE 1991, p. 320.
74
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
La Tracia fu una regione di grande interesse per i Greci e fu oggetto di molteplici e
ripetuti tentativi di colonizzazione. La regione fu strategica per via della sua collocazione sulla
via di transito che conduceva dalla Grecia continentale verso l’Ellesponto e il Ponto Eusino;
altra caratteristica non di secondo ordine fu la ricchezza delle risorse naturali: in primo luogo le
miniere di oro e argento, ma anche la relativa ricchezza delle aree a coltivazione cerealicola e
l’abbondante legname di cui la Grecia era invece povera e che pure era essenziale per la
costruzione delle imbarcazioni. Le risorse militari ed economiche dello Strimone furono uno
dei mezzi tramite cui Pisistrato conservò il proprio potere tirannico ad Atene, perlomeno nel
primo periodo125. La critica ha raccolto e commentato un’ampia documentazione in merito alla
ricchezza e all’importanza delle miniere della Tracia per le strategie dei Greci126. A partire dal
VII secolo i Greci fondarono sulle coste dell’Egeo settentrionale una settantina di colonie127.
Entro il quadro dell’ampia politica coloniale di Corinto, il tiranno Periandro all’inizio del VI
secolo fondò la colonia di Potidea, nella penisola Calcidica, affidandone la tirannide al figlio
Evagora128. Anche le poleis euboiche di Calcide ed Eretria stabilirono colonie nella penisola
Calcidica. Nel 545 coloni della polis micrasiatica di Teo fondarono Abdera, collocata più a est
dell’area di cui si sta ora discutendo e nell’estremità orientale di questa regione spiccano le
colonie di Taso e Samotracia129. L’insediamento pisistratide costituisce la prima attestazione ad
Atene di un tentativo di inserire la Tracia nelle strategie di politica estera; verrà poi seguito a
distanza di pochi anni dalla colonizzazione di Milziade I e dei Filaidi nel Chersoneso Tracico;
sul lungo periodo, gli interessi ateniesi rimasero legati alla navigazione lungo le coste traciche
come è attestato dalle vicende relative a Lemno e Imbro, all’inizio del V secolo. Atene fondò
poi soltanto nel 437/6 una propria colonia in Tracia, ma mi pare significativo che Anfipoli sia
sorta proprio sulla foce dello Strimone130. Nel periodo 500-496 la Tracia funse da luogo di
colonizzazione e poi di fuga anche per i tiranni di Mileto, Aristagora e Istieo: l’iniziativa
coloniale personale di Istieo fu anch’essa presso il fiume Strimone, a Mircino; Aristagora, nella
sua fuga dal Gran Re durante la rivolta ionica, cercò scampo prima a Taso e poi a Mircino131.
125
Hdt. I 64.
Hdt. V 17, 23, VI 46; Thuc. VI 105; Strab. VII 6.4. DESBOROUGH COOLEY – LARCHER 1844, vol. I, p. 69;
HOPPER 1961, pp. 141-146.
127
Specificamente su questo tema vd. ISAAC 1986.
128
Nic. Dam. FGrHist 90 F 59.1. WILL 1955, pp. 517-539.
129
GEHRKE 1996, pp. 982-985.
130
Thuc. VI 102. MUSTI 2006, p. 333.
131
Hdt. V 11, 23; Thuc. IV 102. TOZZI 1978, pp. 148, 164s., 190; ISAAC 1986, pp. 7, 15-24; LURAGHI 1998, pp.
29s., n. 26.
126
75
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
La natura para-coloniale dell’insediamento a Rhaikelos
Gli studiosi moderni sono reticenti a determinare con precisione la natura
dell’insediamento e dei possedimenti dei Pisistratidi prima a Rhaikelos e poi sullo Strimone. Il
linguaggio utilizzato da Aristotele pare fare riferimento ad un fenomeno di colonizzazione, ma
gran parte della critica moderna riconosce nelle circostanze l’impossibilità di una fondazione
ateniese, poiché Pisistrato si muoveva chiaramente di propria iniziativa, senza l’avallo o la
partecipazione della comunità ateniese, ma con l’intervento esclusivo del gruppo familiare
allargato dei Pisistratidi e di un gruppo degli stasiòtai del tiranno. È stato notato che la tendenza
prevalente dei Greci nello stabilire insediamenti in Tracia e nel Ponto Eusino fu sempre di
tentare dapprima di assicurarsi il commercio con gli autoctoni attraverso la formazione di
piccoli empori, che risultavano anche più facilmente accettati dai locali Traci132: è possibile che
i Pisistratidi abbiano seguito questo modello poco intrusivo nel decennio di esilio, integrandolo
senz’altro però con forme di sfruttamento minerario o quanto meno di accesso indiretto o
mediato alle risorse di metalli preziosi del Pangeo.
Per approfondire questo argomento, merita d’altronde prendere in considerazione le
notizie riguardo all’intesa esistente fra Pisistrato e la polis euboica di Eretria, allo scopo di
interpretare lo stanziamento pisistratide in Tracia entro il complesso delle relazioni
internazionali del tiranno ed entro le dinamiche della colonizzazione greca133. Principali punti
di appoggio durante il decennio di esilio furono infatti per Pisistrato l’insediamento al Pangeo e
l’alleanza con Eretria. Aristotele dispone in sequenza: l’esilio da Atene, la colonizzazione a
Rhaikelos, il trasferimento al Pangeo; infine, nell’undicesimo anno, Pisistrato si sarebbe recato
ad Eretria, ove raccolse le proprie risorse e i propri alleati e da dove prese il via la spedizione
contro Atene nel 546. D’altro canto Erodoto, se pure dà prova di conoscere i possedimenti traci
di Pisistrato, non menziona la missione nell’Egeo settentrionale, ma colloca Pisistrato rifugiato
ad Eretria subito dopo la sua fuga da Atene. Vorrei lasciare ad altro momento la discussione
approfondita delle relazioni fra Pisistrato, Eretria ed il suo ceto dirigente: è sufficiente ora
prendere atto dello stretto legame fra l’ateniese e l’oligarchia della polis euboica ricordando
alcuni dati di fatto: ad Eretria, in un momento del loro esilio, i Pisistratidi trovarono un luogo
ospitale e sicuro dove poter organizzare le proprie forze; ad Eretria Pisistrato prese moglie134; i
cavalieri (hippéis) che governavano Eretria furono in battaglia al fianco di Pisistrato a
132
ISAAC 1986, p. -; GEHRKE 1996, pp. 990s.
Specificamente sull’argomento vd. VIVIERS 1987.
134
LAVELLE 2005, pp. 134-136.
133
76
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Pallene135. L’area della penisola Calcidica, e in particolare le due penisole più occidentali di
Pallene e Sitonia, accolsero la colonizzazione di origine appunto euboica, da Caldide ed
Eretria136. Non è a mio avviso una coincidenza che il primo insediamento di Pisistrato
nell’Egeo settentrionale fosse stato individuato proprio a Rhaikelos, nella penisola Calcidica,
affacciato sul Golfo Termaico. L’alleanza fra i Pisistratidi ed Eretria, indipendentemente dalle
incertezze nelle fonti, deve essere
infatti fatta risalire al secondo esilio e dunque fu
contemporanea alle attività di colonizzazione e sfruttamento minerario dei Pisistratidi in
Tracia137.
Si potrebbe perciò ricostruire una sequenza secondo cui Pisistrato, in fuga da Atene, prima
di dirigersi a Rhaikelos senza alcuna preparazione, avrebbe fatto invece tappa in Eubea. Ad
Eretria i Pisistratidi avrebbero ottenuto l’avallo ad iniziare un proprio insediamento in
Calcidica, poiché si trattava di un’area di interesse e preminenza euboica e una simile intesa o
autorizzazione sarebbe stata senz’altro necessaria per non incorrere in incidenti con le colonie o
con la loro madrepatria. Eretria inoltre avrebbe fornito a Pisistrato un numero più consistente di
volontari per l’impresa che si accingeva a compiere, poiché i familiari e gli stasiótai del tiranno
costituivano un gruppo troppo esiguo per tentare l’insediamento in un’area di non facile
gestione, sia per le preesistenti colonie con cui si sarebbero potuti scontrare, sia per la pressione
dei bellicosi barbari traci locali, sia per le possibilità di ingerenza del vicino regno macedone.
Sulla base di queste considerazioni, si può concludere che non necessariamente la terminologia
usata da Aristotele per descrivere l’insediamento pisistratide a Rhaikelos è da considerarsi
sbagliata (synoikízo) poiché potrebbe essersi trattato effettivamente di una forma di
stanziamento coloniale, più consistente dunque di un insediamento familiare, condivisa fra
Pisistratidi, partigiani esuli dei tiranni e membri dell’aristocrazia di Eretria138. È vero d’altronde
che non si hanno ulteriori notizie relative a questo insediamento para-coloniale e questo
significa che non dovette certamente raggiungere grandi dimensioni, indipendentemente dal
contributo degli Euboici; le fonti confermano che i Pisistratidi abbandonarono presto Rhaikelos
a favore dell’occupazione delle aree minerarie presso il Pangeo, un centinaio di chilometri più a
est lungo la costa settentrionale dell’Egeo. Senz’altro dobbiamo considerare l’insediamento
tracico come un rifugio relativamente sicuro per il tiranno esiliato, per poco meno di un
decennio, prima che egli facesse vela verso Eretria, ante 546, come poi si discuterà.
135
Aristot. Ath. Pol. 15.2. VIVIERS 1987, p. 194; LAVELLE 1991, pp. 319s.; ANDERSON 2005, pp. 191s.; WALKER
2006, p. 181.
136
BRADEEN 1952, specificamente sull’origine e la cronologia della colonizzazione euboica nella penisola
calcidica; GEHRKE 1996, p. 983; WALKER 2006, pp. 149-152.
137
GRAHAM 1964, pp. 16-19, VIVIERS 1987; WALKER 2006, pp. 149s., 163
138
VIVIERS 1987; WALKER 2006, pp. 149s.
77
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Gli obiettivi e le conseguenze dell’insediamento pisistratide in Tracia
Sulla base delle fonti a nostra disposizione e dell’analisi del contesto geografico e
culturale della Tracia, si può affermare con sicurezza che l’obiettivo e i risultati
dell’insediamento a Rhaikelos e sullo Strimone furono l’acquisizione di ricchezze,
principalmente tramite i metalli preziosi, e, tramite queste, l’arruolamento di milizie mercenarie
personali fra le popolazioni tracie locali139. La possibilità di disporre di una forza armata
personale nella polis è un fattore assolutamente da tenere in considerazione nella comprensione
della capacità di governo e comando della tirannide. In epoca arcaica la capacità di un
aristocratico di esercitare influenza politica dipendeva dall’ampiezza del suo òikos e dalla
consistenza della sua base sociale presso il dèmos: questi garantivano senz’altro un fattore di
consenso politico su cui l’individuo poteva fare leva nelle decisioni assembleari; nondimeno, in
caso di lotta intestina (stàsis), era da questo gruppo che la fazione politica reclutava le proprie
forze armate e su cui faceva affidamento per esercitare o minacciare la violenza politica. La
polis non contò mai su una forza armata per il mantenimento dell’ordine pubblico, se non in
epoca più tarda, e le preoccupazioni dei pensatori politici per i fenomeni di stàsis (di disordine
politico) furono particolarmente gravi proprio perché la lotta politica poteva spesso legarsi a
fenomeni di violenza intra-comunitaria140. In buona parte dei casi, il tiranno si distinse, rispetto
ai suoi concorrenti aristocratici, per l’accesso ad una più ampia e soverchiante forza armata, che
ne costituì effettivamente lo strumento di affermazione politica e di repressione del dissenso. In
questo senso vanno interpretati dunque i mercenari grazie ai quali Pisistrato rafforzò il proprio
potere dopo avere imposto la tirannide nel 546. In questo senso si devono comprendere tutte le
attestazioni di concessione di guardie del corpo cittadine, come nel caso pure di Pisistrato, nel
560, o nel caso di Periandro a Corinto. La riflessione politica di epoca classica comprese
l’affinità fra i due strumenti nell’ottica appunto dell’esercizio della violenza politica o, in altri
termini, dell’azione di polizia e del mantenimento della giustizia141; la critica moderna ha
compreso l’importanza di questi corpi armati personali nel contesto dei meccanismi decisionali
della politica di epoca arcaica.
Alcuni critici hanno espresso dei dubbi sul fatto che Pisistrato abbia mai effettivamente
posseduto delle miniere presso il Pangeo, fondandosi fra l’altro sul fatto che queste non
vengono mai esplicitamente menzionate nelle fonti, mentre nella narrazione della spedizione
139
Hdt. I 64, V 23. DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 95-97; COLE 1975, pp. 42-44; VENEDIKOV 1977; ISAAC 1986, pp.
3s., 13-43; GEHRKE 1996, p. 985; BRAUND 2001, pp. 9-11.
140
BERENT 2000.
141
MCGLEW 1993, pp. 52-86.
78
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
persiana in Tracia le attività estrattive sono identificate come possesso dei Traci142.
Personalmente ritengo invece che la caratterizzazione mineraria della regione del Pangeo, nelle
fonti e nella critica, sia un elemento che non lascia dubbi circa l’obiettivo di Pisistrato143; il
tiranno avrebbe inoltre potuto attingere a queste risorse non necessariamente impegnandosi
personalmente nell’estrazione, ma piuttosto inserendosi nelle dinamiche degli scambi e dei
contatti con le popolazioni locali. In questo medesimo filone critico, si è anche accettato il ruolo
che le ricchezze e i mercenari di provenienza tracica poterono avere in occasione della presa
della tirannide, ma si sono mosse delle obiezioni contro la sopravvalutazione della loro
funzione sul lungo termine e nel mantenimento del potere dopo il primo critico momento della
battaglia di Pallene; la scarsità delle coniazioni attribuite a Pisistrato fra le cosiddette
Wappenmunzen contribuirebbe a ridimensionare l’importanza economica dell’argento del
Pangeo144. A queste obiezioni, è stato risposto notando che l’armata mercenaria dovette essere
uno dei capisaldi del potere della tirannide di Pisistrato e di conseguenza i proventi delle
miniere del Pangeo dovettero anch’essi rimanere uno strumento chiave nella strategia del
tiranno145.
Personalmente condivido l’impostazione di chi accetta l’importanza del ruolo delle truppe
mercenarie nel mantenimento del potere tirannico e dunque la necessità per il tiranno di poter
disporre di ricchezze monetali o para-monetali in metalli preziosi per garantirne il pagamento.
Per altro verso si potrà ridimensionare la necessità per la tirannide di una forza armata
mercenaria di provenienza esterna proporzionalmente al crescere dell’appoggio politico e
popolare che il tiranno acquisiva tramite la sua politica sociale e le numerose opere di edilizia
pubblica, dopo la definitiva presa del potere nel 546146.
L’insediamento pisistratide in Tracia alla luce delle relazioni internazionali
Si sono finora analizzate le cause e i moventi della scelta di Pisistrato di cercare rifugio a
Rhaikelos e poi sulle rive dello Strimone, nel decennale esilio da Atene. Questa strategia
apparirà più chiara se si vorrà contestualizzare l’analisi entro la rete delle relazioni familiari del
tiranno. Ribadisco dunque ora quanto ho accennato in merito alle relazioni di Pisistrato con
l’aristocrazia di Eretria: nel momento in cui il tiranno lasciò l’Attica, trovò un primo sostegno
nell’ospitalità di Eretria; questa ricostruzione è attestata nelle fonti, sebbene con certezza solo
142
Hdt. VII 112.
HOPPER 1961, pp. 141-146.
144
LAVELLE 1997.
145
HOPPER 1961, pp. 141-146; COLE 1975, pp. 42-44; VIVIERS 1987, p. 194; LAVELLE 1991, pp. 319s.; DE LIBERO
1996, pp. 59s., 81-84; DE LIBERO 1998.
146
Sulla politica edilizia di Pisistrato e le differenze con quella seguita da Ippia vd. AMPOLO 1973.
143
79
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
per il periodo immediatamente precedente alla battaglia di Pallene147. È sicuro però che i
contatti con la polis euboica ebbero inizio dal momento della fuga da Atene e della decisione e
pianificazione dell’impresa nell’Egeo settentrionale. Pisistrato, soprattutto nella posizione di
debolezza in cui la sua famiglia versava in quel momento, non avrebbe potuto infatti imporre la
propria presenza a Rhaikelos senza previamente essersi assicurato l’avallo e l’appoggio delle
colonie già presenti nella penisola Calcidica ed erano appunto le euboiche Eretria e Calcide a
detenere un primato territoriale nella zona occidentale della Calcidica: perciò dobbiamo
ricostruire che nel suo primo approccio ad Eretria, da datarsi già al 556, Pisistrato raggiunse un
accordo con l’aristocrazia di quella polis per ottenere il nulla osta alla propria iniziativa e
organizzare una colonia di ridotte dimensioni con la sua collaborazione148.
La
compartecipazione in quella iniziativa fu poi il fondamento per il rafforzamento dell’alleanza
dei Pisistratidi con Eretria al termine del decennio di esilio, come si discuterà in altra sezione di
questo scritto.
Eretria non fu l’unico soggetto politico a stanziare colonie nella penisola Calcidica.
Durante la tirannide di Periandro a Corinto anche i Cipselidi avevano istituito una colonia a
Potidea e al in controllo della colonia Periandro impose il figlio Evagora; sappiamo peraltro che
questi morì quando il padre era un uomo anziano149. Nel 583 tuttavia la tirannide dei Cipselidi
lasciò il posto ad un’oligarchia a Corinto; non siamo a conoscenza delle ripercussioni che la
caduta della tirannide nella madrepatria ebbe nelle colonie corizio-cipselidi, ma mi pare si possa
facilmente ricostruire come anche là la tradizione di dominio cipselide avesse perduto le proprie
posizioni a favore dei governi cittadini e della fedeltà al nuovo governo oligarchico di Corinto.
A favore di questa ricostruzione si pongono le morti di alcuni dei Cipselidi che governavano le
colonie, come Archino ad Ambracia ed Evagora proprio a Potidea. Anche la politica di
riappropriazione in senso pubblico, da parte di Corinto, nei confronti dei centri di potere
familiare che erano stati dei Cipselidi è significativa: sappiamo infatti che il tesoro di Cipselo a
Delfi fu reclamato con successo dalla comunità e rinominato come “tesoro dei Corinzi”. Si è già
fatto notare che, malgrado i Cipselidi avessero perso senz’altro il proprio potere all’epoca di
Pisistrato, il tiranno ateniese perseguì una politica di alleanze familiari che agganciava i
Pisistratidi al prestigio e alla tradizione dei Cipselidi; contemporaneamente le scelte di
Pisistrato rientravano in un atteggiamento di intesa filo-corinzia di lungo termine, condiviso
non solo dai Pisistratidi, ma anche da una parte dell’aristocrazia ateniese politicamente attiva,
147
STAHL 1987, p. 63; VIVIERS 1987.
COLE 1975; VIVIERS 1987; WALKER 2006, pp. 149s.
149
Nic. Dam. FGrHist 90 F 59.1.
148
80
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
che aveva trasferito con successo la propria adesione dagli interessi strategici dei tiranni
all’intesa con il governo oligarchico di Corinto, dopo il 583. In questo senso, ricordo, vanno
interpretate le azioni militari di Pisistrato contro Megara, l’alleanza familiare con Gorgilo di
Argo e viceversa il rifiuto dell’intesa matrimoniale con l’alcmeonide Megacle. Su queste
premesse si può concludere perciò che, nel caso della fondazione coloniale a Rhaikelos,
Pisistrato poté mettere a frutto questa rete di relazioni personali, facendo leva su una tradizione
di prestigio familiare che lo legava agli antichi sovrani di Corinto e di Potidea e, per altro verso,
facendo leva sul suo comportamento in ambito strategico-internazionale che forniva al governo
di Potidea garanzie della sua buona fede e dell’intesa della sua parte politica con la madrepatria
di quella. Questi fattori contribuirono a fornire un’ulteriore elemento di approvazione e
appoggio da parte degli occupanti ellenici della Calcidica nei confronti dell’insediamento
pisistratide a Rhaikelos150.
In questa fase della storia dei tiranni pisistratidi possiamo a mio avviso collocare l’inizio
dei contatti fra i tiranni ateniesi e i sovrani argeadi di Macedonia. All’epoca in cui Pisistrato si
stanziò a Rhaikelos, la Penisola Calcidica era sede di colonie euboiche e di Traci autoctoni;
nondimeno proprio in quel periodo si colloca la spinta espansiva dei Macedoni che sul lungo
periodo finirono per espellere i Traci dalla Calcidica spingendoli oltre il fiume Strimone e
assestando lì il vero confine nel corso del V secolo. La prima effettiva attestazione storiografica
di relazioni interfamiliari fra gli Argeadi e i Pisistratidi risale nondimeno al 504 ca., quando
Ippia si decise ad abbandonare i propositi di trovare alleati in Grecia per il proprio rientro ad
Atene: fra le numerose offerte di aiuto e ospitalità pervenne infatti anche quella del sovrano di
Macedonia Aminta, il quale gli offrì in concessione (di/dwmi) Antemunte151.
Il VI secolo fu un periodo decisivo per l’affermazione del potere e del controllo
territoriale dei Macedoni: solo nel secolo precedente il potere della tribù dei Macedoni si era
consolidato nella aree interne della Bassa Macedonia; all’inizio del VI secolo il confine
orientale della Macedonia si era assestato sulla riva del fiume Axios, che sfocia nel Golfo di
Terme, ma ancora alla fine del VI secolo, quando Aminta fece la sua offerta a Ippia, le fonti
consideravano la zona ad est del fiume Axios come abitata dai Traci152. La storia
dell’espansione verso oriente della Macedonia coincide con le campagne militari dei sovrani
150
DAVERIO ROCCHI 1973, p. 98.
Hdt. V 94.1. CASSON 1926, pp. 117s.; ROBINSON 1945, pp. 246s.; SORDI 1958, pp. 54-84; BORZA 1990, pp.
117s.; NENCI 2006, ad Hdt. V 17.
152
Hecat. FGrHist 1 FF 148s.
151
81
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
argeadi contro le preesistenti popolazioni di Traci che, secondo le tradizioni, controllavano
buona parte della Macedonia in epoche remote153.
Una “buona azione” (euergesìa) come quella che il macedone Aminta compì nei confronti
di Ippia nel 504 doveva senz’altro fare parte di una catena di relazioni consolidate, di uno
scambio vicendevole di azioni benefiche e amichevoli fra i sovrani macedoni e la famiglia dei
Pisistratidi, già avviate da tempo: Aminta non avrebbe avuto alcun giovamento ad avviare
gratuitamente e per primo le relazioni con i Pisistratidi proprio nel momento della fuga da
Atene che ne segnava la disfatta e probabilmente l’inutilità politica. L’euergesìa di Aminta nel
504 andava senz’altro a ripagare, come contro-dono, una precedente offerta o liberalità che a
sua volta egli aveva ricevuto dai Pisistratidi. Alla ricerca di una spiegazione degli eventi del 504
e di un precedente contatto pisistratide-argeade possiamo imbatterci solo nell’insediamento di
Pisistrato a Rhaikelos nel 556 e nel suo successivo abbandono in favore dell’area del Pangeo: in
quelle circostanze dovettero instaurarsi delle relazioni diplomatiche fra Pisistrato e il sovrano
argeade in quel momento al trono, Alceta I154. Il movente sulla base del quale Pisistrato e
Alceta poterono trovare un campo di intesa, un obiettivo comune, rientrava nella politica di
espansione e consolidamento territoriale dei Macedoni nella delicata zona di confine del fiume
Axios155. Pisistrato mantenne certamente buone relazioni con i propri vicini ellenici delle
colonie, come si è sopra comprovato, ma nei confronti delle popolazioni locali possono essere
insorti degli attriti di cui le fonti raramente trasmisero notizia forse perché considerati un luogo
comune: dunque anche forse nei rapporti con i bellicosi Traci, Pisistrato e Alceta ebbero modo
di fornire aiuto uno all’altro. Un’ipotesi opposta è che Pisistrato potrebbe avere offerto un
contributo, non militare, ma piuttosto diplomatico nella gestione pacifica delle relazioni fra
Macedoni e Traci favorendo lo spostamento dei Traci dall’area del golfo di Terme verso la
regione circostante il Pangeo; questa ricostruzione è in effetti rinforzata dal trasferimento di
Pisistrato sulle rive dello Strimone, ove furono sospinti i Traci stessi. Sappiamo che Pisistrato
lasciò Rhaikelos, ma di quell’insediamento non si hanno più notizie, né tracce156.
È onesto ammettere che la ricostruzione che vede Pisistrato inserirsi in qualità di
diplomatico nelle relazioni fra Macedoni e Traci nella Calcidica è un’ipotesi: si fonda
sull’attestazione di relazioni costruttive fra Pisistratidi e Argeadi nella generazione successiva,
ma non può contare su alcuna notizia relativamente alle relazioni che esistettero fra i due
insediamenti di Pisistrato e i Traci autoctoni. È indubitabile d’altronde che Pisistrato e il gruppo
153
CASSON 1926, p. 165; BORZA 1990, pp. 45s., 88s.; GEHRKE 1996, pp. 991s.; HAMMOND 1982 a, pp. 273-285.
Euseb. Chron. arm. p. 342 Aucher.
155
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 51s. sul fiume come segno confinario.
156
COLE 1975; BORZA 1990, pp. 117s.
154
82
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
che lo accompagnava siano entrati in contatto con i Traci, con buona probabilità già a
Rhaikelos, sicuramente nel prendere sede al Pangeo, e mi pare dunque corretto interrogarsi
sulla natura di queste relazioni inter-culturali. Si è puntualizzato che l’insediamento pisistratide
non fu di grandi dimensioni, comprendendo solo i membri della famiglia e probabilmente
alcuni dei suoi sostenitori; probabilmente alla fondazione di Rhaikelos contribuirono volontari
euboici. In quelle condizioni Pisistrato non poteva infatti costituire una forza armata di grande
entità e fu necessario per lui cercare di inserirsi in Tracia secondo modi pacifici e di intesa con
gli autoctoni; una reazione violenta da parte dei Greci o dei Traci limitrofi avrebbe messo in
pericolo l’esistenza stessa della famiglia che non avrebbe avuto altro riparo e che non poteva
fare ritorno, nel caso, alla madrepatria. In questo senso si sono già spiegate le relazioni di
Pisistrato con Eretria, le colonie calcidiche e con i Macedoni. Altro elemento che indirizza
verso la ricostruzione di relazioni pacifiche con i Traci è l’intento di Pisistrato, fra i principali
della missione tracica, di reclutare truppe mercenarie che gli avrebbero assicurato il rientro ad
Atene: senz’altro l’accordo con i mercenari traci, pure fondato su un rapporto economico,
dovette avvenire tramite contatti pacifici, costruttivi e di intesa.
Gli studiosi che hanno approfondito la comprensione dei fenomeni di mercenariato hanno
messo in evidenza come sia un errore interpretare queste forme di impiego di combattenti nella
prospettiva esclusivamente economica, del reclutamento e pagamento di bande armate o
eserciti: soprattutto nell’epoca arcaica i mercenari erano combattenti esperti, provenienti dai
ranghi dell’aristocrazia ellenica, oppure dagli stessi compagni (hetàiroi) dei sovrani barbarici;
erano membri dell’élite che indirizzavano la pratica della ricerca dell’eccellenza (areté),
caratteristica dell’ideologia aristocratica, verso quelle componenti della prodezza in battaglia e
della capacità fisica, piuttosto che nel successo politico o agonistico. Questa assimilazione dei
mercenari ad un contesto sociale di élite internazionale si può bene riscontrare anche presso i
Traci, per l’epoca classica, nelle vicende descritte da Senofonte nell’Anabasi, nelle quali gli
accordi dell’esercito ellenico con i Traci passarono per la creazione di vincoli di xenìa e di
euergesìa fra i comandanti greci e il sovrano tracio e si fondarono in sostanza sulla
condivisione di comuni valori aristocratici fondati sulla morale del dono e contro-dono e
sull’obbligo della reciprocità157. Più in generale la critica ha messo in evidenza l’esistenza di
una solida tradizione di collaborazione fra Greci e Traci al livello delle élites158. La morale del
dono, e con essa l’obbligo del contro-dono, può individuarsi come un tratto di grande antichità
157
MITCHELL 1997, pp. 134-142.
PICCIRILLI 1973, p. 30; ISAAC 1986, pp. xi-xiv, 40-51; GEHRKE 1996, p. 985; MITCHELL 1997, pp. 85-109, 134147; BRAUND 2001, pp. 9-24.
158
83
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
e costanza presso le classi elevate non solo della cultura ellenica, ma anche orientale e tracia: su
questi aspetti inter-culturali comuni i Greci poterono fondare relazioni costruttive con i Traci159.
Con il fondamento delle pur poche notizie dettagliate sull’insediamento di Pisistrato in
Tracia e con la contestualizzazione storico-culturale qui condotta, mi pare una ricostruzione
valida quella che vede Pisistrato non soltanto come un avventuriero o un intruso nell’Egeo
Settentrionale, ma piuttosto come un aristocratico esule, attivo nel rafforzamento della propria
posizione anche se al di fuori della madrepatria, capace di inserirsi con gli appropriati mezzi
diplomatici entro un contesto nuovo e articolato come quello della Tracia, in modo costruttivo e
pacifico160
II.7. La battaglia di Pallene e la lista degli alleati di Pisistrato (546)
Il consiglio tenuto da Pisistrato e i figli e la scelta di rientrare in Atene
Nell’undicesimo anno di esilio i Pisistratidi organizzarono il loro ritorno ad Atene; in un
primo momento dalla Tracia fecero ritorno ad Eretria in Eubea dove raccolsero le risorse
economiche e militari necessarie per rientrare con la forza in Attica e impossessarsi poi del
potere politico ad Atene161. Erodoto narra che ad Eretria Pisistrato tenne un consiglio
(e)bouleu/eto) con i figli per decidere il da farsi e che fu l’opinione del figlio maggiore Ippia a
sembrare la migliore: Ippia suggerì che era necessario riconquistare con la forza la tirannide e
che i mezzi necessari a quello scopo sarebbero stati recuperati raccogliendo doni (dwti=nai)
dalle città che avevano degli obblighi (proaide/ato) verso la loro famiglia. Si possono
giustamente sollevare dei dubbi sulla storicità della narrazione erodotea, particolarmente sulla
possibilità che lo storico potesse conoscere lo svolgimento e i discorsi tenuti in quella che, nelle
sue stesse parole, fu una riunione interna al nucleo familiare pisistratide in merito a delicate
scelte politiche. Si tratta questo di un problema ineludibile delle nostre fonti storiografiche e mi
pare necessario, in questi casi, trattare la notizia come una ricostruzione, cioè un’ipotesi
storiografica, di Erodoto stesso, piuttosto che come una notizia storica. Per altro verso non è
possibile esimersi per questo motivo dall’analisi e dall’utilizzo di questo passo, al fine di
ricavare alcune nozioni che aiutino a contestualizzare meglio la ricostruzione storica che si
tenta in questa ricerca.
159
Thuc. II 97. NENCI 1981, pp. 67-68; GERNET 1983, pp. 143s.; HERMAN 1987, pp. 31-34; MITCHELL 1997, pp.
11-155; BRAUND 2001, pp. 7-24; GAZZANO 2002, 10-20; MAZZARINO 2007, pp. 278-281.
160
STAHL 1987, pp. 201, 227s.
161
Hdt. I 61s.; Aristot. Ath. Pol. 15.2; Polyaen. I 21.1. VIVIERS 1987.
84
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Erodoto accettò come del tutto plausibile la tradizione relativa alla riunione di un
consiglio familiare nel quale Pisistrato condivise le scelte politiche e strategiche con i propri
figli e probabilmente dunque anche con un entourage ristretto di associati di fiducia. Le
narrazioni pervenute nelle fonti identificano solitamente la tirannide nella persona stessa del
tiranno, tuttavia questo passo permette di intravedere che effettivamente la tirannide operava
come un gruppo organico di governo: questo gruppo era fondato innanzitutto sul nucleo
familiare del tiranno, comprendendo le relazioni parentelari dei componenti; ad un ulteriore
livello il gruppo era allargato agli individui e ai gruppi politici che con la famiglia godevano di
una stretta compartecipazione di interessi, ne erano i principali sostenitori e che potevano
costituire, all’occorrenza, uno strumento di lotta armata (gli stasiòtai); inoltre il gruppo
tirannico rispondeva alla necessità di mantenere una base di consenso sociale e politico entro il
corpo cittadino più ampio. L’organizzazione della gestione e del controllo della cosa pubblica e
dello stato, nell’epoca arcaica e durante la fase storica del cosiddetto “governo aristocratico”, fu
fondamentalmente pre-politica, fondata cioè sulla capacità organizzativa delle famiglie
aristocratiche e su forme irregolari di consenso sociale. In questo contesto la tirannide è da
intendersi come un organismo para-statale che aspirava ed era effettivamente in grado di
rendersi garante e gestore degli interessi collettivi. Esempi significativi delle proprietà
organizzative e politiche della famiglia tirannica possono riscontrarsi nei casi esaminati delle
alleanze matrimoniali intese come garanzie di comportamenti nella politica estera, oppure le
particolari forme di comunicazione fra Pisistrato e Megacle durante il primo esilio. Queste
considerazioni rimandano all’ambiguità fra privato e pubblico caratteristica della politica dei
tiranni162.
In sede deliberativa familiare l’opinione di Ippia vinse (nikh/santoj), imponendosi
sopra altre proposte espresse: Erodoto lascia intendere che la riconquista violenta del potere
sovrano ad Atene non era l’unica strategia che si apriva in quel momento ai Pisistratidi.
Alternativamente alla via proposta da Ippia si pose probabilmente la possibilità di rientrare in
Atene e reclamare più pacificamente un posto entro le forme tradizionali della conduzione
politica, ricercare cioè una intesa con altre forze socio-politiche aristocratiche e accedere alla
spartizione, più o meno paritaria e concordata, del controllo politico. La lenta reazione ateniese
di fronte allo sbarco in Attica delle forze dei Pisistratidi avalla l’esistenza di questa alternativa
politica che faceva affidamento su una posizione conciliatoria degli aristocratici; il tentato
accordo matrimoniale fra Pisistrato e Megacle che aveva avviato la precedente seconda
162
Hdt. I 62.1. LINTOTT 1982, pp. 1-31; ANDERSON 2005; DUPLOUY 2006, pp. 251-264.
85
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
tirannide di Pisistrato è un esempio ulteriore a favore di questa strategia. È possibile d’altronde
che durante il consiglio dei Pisistratidi si fosse presa in considerazione la prospettiva di
escludere l’Attica dai progetti per il futuro della famiglia: se accettiamo, come si è proposto,
che durante il secondo esilio la famiglia sia stata colpita con un effettivo procedimento di
atimìa e considerando inoltre la lunga durata dell’assenza dei Pisisitratidi da Atene, potrebbe
non essere sembrata affatto sicura la possibilità che la famiglia riuscisse a recuperare le
posizioni perdute nella società aristocratica e nella politica ateniese. Pisistrato aveva peraltro
costruito una rete di relazioni diplomatiche e familiari che gli avrebbe consentito di trovare con
una certa facilità una nuova sede e di assumere un ruolo significativo in altre località: ad Argo,
ad Eretria, presso le comunità coloniali calcidiche, probabilmente in Macedonia, forse già in
Tessaglia. È probabile che nel 546 anche l’area dell’Egeo nordorientale facesse parte dei
progetti e delle conoscenze dei Pisistratidi, come è testimoniato dalle imprese condotte o
organizzate di lì a poco al Sigeo e precedentemente nel Chersoneso Tracico dall’alleato
Milziade I. Testimonianza delle possibilità e capacità di ricollocazione internazionale dei
Pisistratidi si offre in occasione del definitivo ritiro al Sigeo nel 504: Ippia fu approcciato dai
Tessali e dai Macedoni che offrirono ospitalità, nonostante ciò egli decise di insediarsi in Asia
Minore al Sigeo e in seguito si legò alla corte persiana163.
D’altro canto, si consideri che il rientro ad Atene costituì pur sempre la soluzione più
logica e auspicata per i Pisistratidi e i loro partigiani ed è evidente che questo fu sempre il loro
principale progetto a lungo termine164. Oltre a queste considerazioni ideologiche o affettive,
circostanze di più stringente contingenza possono avere incoraggiato a seguire la strategia del
rientro armato e della conquista della tirannide, attribuita ad Ippia: le risorse di cui i Pisistratidi
disponevano in quel particolare momento meglio si adattavano infatti a quello scopo e a
quell’indirizzo d’azione. L’investimento decennale nello sforzo di assicurare risorse monetarie
e militari in Tracia imponeva cioè la strategia proposta da Ippia.
I Pisistratidi dunque raccolsero le proprie ricchezze e i propri alleati e per fare ciò Ippia
suggerì di richiedere doni a coloro che erano in debito verso la famiglia. Questa iniziativa
esprime un meccanismo di relazioni inter-aristocratiche fondato sulla morale della reciprocità e
163
Hdt. V 94-96, VI 102.
Il rientro in patria è d’altronde il fondamento delle passioni e del comportamento di numerosi casi affini di
aristocratici espulsi. Poeti elegiaci che dovettero lasciare le proprie poleis rendono conto dei propri pensieri nelle
loro opere: Alceo di Mitilene (Alc. Fr. 69 Loeb), Archiloco (Archil. Frr. 22, 27 West). Pisistrato dovette lasciare
Atene due volte e fece sempre ritorno. Gli Alcmeonidi si adoperarono sempre per rientrare ad Atene dopo le
espulsioni imposte da Pisistrato nel 546 e ancor più attivamente dopo quelle imposte loro da Ippia nel 514: Aristot.
Ath. Pol. 19.3. La politica internazionale di Ippia, dopo il 510 e fino alla sua morte, ebbe come obiettivo cardinale
il ripristino del suo potere ad Atene. FORSDYKE 2005, pp. 115-130.
164
86
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
sulla pratica e la ritualità dello scambio di doni, il concetto cioè che l’accettazione di un bene,
un dono (dotìne) o un’azione favorevole (euergesìa), lega il ricevente in una condizione di
debito, ad un obbligo appunto, nei confronti del donatore; lo scambio di un dono impegna nella
pratica ad un’alleanza, in base alla quale in futuro si vorrà ricambiare il dono ricevuto. Inoltre,
in virtù della morale aristocratica della ricerca dell’eccellenza e dell’autoaffermazione, la
tendenza era d’altronde quella di corrispondere ad un dono ricevuto restituendo beni e servizi in
maniera uguale o superiore: così si instaurava un meccanismo accrescitivo che contribuiva a
cementare il rituale scambio di doni trasferendo la pratica ad un’alleanza di reciprocità fra gli
individui, perpetuando di volta in volta lo scambio con beni e servizi sempre più significativi e
impegnativi e creando col tempo una fiducia, una dipendenza e un’intesa reciproca sempre più
strette. Nel riferirsi a “doni” dunque, Ippia non parla necessariamente di una richiesta di
liberalità in beni preziosi o in denaro, anche se questi erano spesso previsti ed erano tipicamente
lo strumento rituale delle alleanze: lo scambio di obbligazioni fra aristocratici poteva prendere
forme diverse ed esprimersi tramite l’ospitalità, la concessione di materie prime e vivande,
iniziative di appoggio politico o strategico, aiuto militare; chi offriva il proprio contributo lo
faceva nel campo e nei termini in cui egli godeva di un qualche vantaggio o surplus e viceversa
in un bene o favore di cui il ricevente necessitava165. In questo senso la critica ha messo in
evidenza un aspetto economico e ‘di mercato’, anche se non necessariamente monetario, di
queste relazioni fondate sul dono. Cosicché nel 546 i Pisistratidi fecero appello a tutte le poleis
e i gruppi familiari che nel decennio di esilio essi avevano in qualche modo favorito, con cui
avevano avuto relazioni positive e verso i quali avevano mostrato generosità, verso cui
potevano far valere degli obblighi per via di aspetti che potevano andare dal debito monetario al
legame familiare. È in base a questo meccanismo che dovremo cercare di comprendere la
notizia relativa agli alleati di Pisistrato a Pallene e il contributo da loro offerto.
La lista degli alleati di Pisistrato
Questa parte della narrazione fornisce un preziosissimo elenco degli alleati internazionali di
Pisistrato che nel 546 furono in grado di fornire un contributo, militare o finanziario166. Le fonti
permettono facilmente di ricostruire questo prospetto:
- Eretria offrì ospitalità e un luogo dove organizzare la spedizione; l’aiuto venne dai cavalieri
(hippèis) che governavano Eretria167.
- Tebe offrì ricchezze (chrèmata) con speciale generosità.
165
GERNET 1983, pp. 143s .; HERMAN 1987; MITCHELL 1997.
Hdt. I 61; Aristot. Ath. Pol. 15.2. BERVE 1967, pp. 41-62; STAHL 1987, pp. 60-66.
167
Aristot. Ath. Pol. 15.2. VIVIERS 1987.
166
87
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
- Da Argo vennero 1.000 mercenari (misthotòi), condotti da Egesistrato, il figlio argivo di
Pisistrato168.
- Un uomo di nome Ligdami venne da Nasso offrendo denaro e milizie (chrèmata kai àndras).
- Numerose altre città non specificate offrirono un contributo economico (chrèmata).
- A livello locale Pisistrato poté contare, una volta sbarcato in Attica, sul contributo e
sull’appoggio di numerosi sostenitori (stasiòtai) che vennero ad ingrossare le sue fila,
provenienti sia dall’area urbana, sia dai villaggi attici.
- Pisistrato portò ricchezze e mercenari dal proprio insediamento in Tracia169.
La lista è composta sulla base dalle narrazioni poco diverse fra loro di Erodoto e Aristotele: i
due storici condividono i dati relativi a Tebe, Argo, Nasso e la menzione di “altri alleati” non
meglio specificati. Erodoto trasmette il dato relativo ai sostenitori locali di Pisistrato che
affluirono da Atene e dall’Attica presso Maratona, dopo lo sbarco delle forze pisistratidi170.
Aristotele esplicita il contributo della classe di cavalieri al governo di Eretria, mentre Erodoto
preserva la presenza della polis euboica nella sua narrazione, ma non ne specifica l’intervento
in vista di Pallene171. Erodoto sembra dunque più attento al contesto ateniese, a come si svolse
la breve campagna militare di Pisistrato in Attica, preserva notizie sulla reazione e sul
comportamento dell’aristocrazia al governo di Atene e aiuta a comprendere il quadro sociale e
l’appoggio della cittadinanza al tiranno; conosce l’alleanza matrimoniale fra Pisistrato e Argo e
la parentela fra l’ateniese ed Egesistrato; eppure, nella narrazione su Pallene, il ruolo di questi
legami non è considerato, al punto che gli Argivi sono definiti soltanto mercenari. Aristotele
invece è più attento alle relazioni internazionali implicate nella preparazione di Pallene ed
individua con maggiore chiarezza i singoli o i gruppi coinvolti.
Entrambi gli autori descrivono il contributo degli alleati, esplicitamente o implicitamente,
come un impegno finanziario più che come una effettiva messa in campo di forze armate; unica
eccezione, esplicitata dalle scelte lessicali dei testi, sono i 1.000 soldati venuti da Argo e gli
“uomini” forniti da Ligdami di Nasso. Sulla base del testo dobbiamo considerare dunque che il
contributo di Tebe, Eretria e delle altre poleis o degli altri individui non specificati fosse nella
forma dei chrèmata. Queste ricchezze avevano lo scopo di pagare la campagna militare,
stipendiare i soldati, assicurare i mezzi di sostentamento e trasporto, ma anche garantire fondi
nella gestione del prestigio sociale e del potere politico una volta ripresa la tirannide. A questa
lista delle forze pisistratidi non dobbiamo dimenticare di aggiungere le ricchezze e le milizie
168
Aristot. Ath. Pol. 17.4.
Hdt. I 64.
170
Hdt. I 61s.
171
Aristot. Ath. Pol. 15.2, 17.4. VIVIERS 1987.
169
88
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
mercenarie che Pisistrato aveva acquisito nel decennio di permanenza in Tracia,
nell’insediamento al Pangeo sullo Strimone.
Le forze di Pisistrato si raccolsero dunque ad Eretria, si imbarcarono e scelsero la località
di Maratona per sbarcare in Attica; qui convennero i sostenitori ateniesi del tiranno. Il governo
ateniese non reagì all’iniziativa di Pisistrato finché il tiranno rimase a Maratona. Si tratta a mio
avviso questa di una riprova che non necessariamente i Pisistratidi sarebbero dovuti rientrare in
madrepatria con l’obiettivo di conquistare la polis e il potere: l’aristocrazia al governo in quel
momento pensò, o sperò, che Pisistrato fosse intenzionato a rientrare in Attica e ricreare una
propria area geografica e sociale di potere personale, pur senza aspirare ad eliminare la
condivisione del governo inter-aristocratico. Atene raccolse la propria forza armata solo quando
Pisistrato si spostò da Maratona, mise il campo nella località di Pallene e fu chiaro che avrebbe
attaccato Atene172. La battaglia che seguì non riceve un’ampia descrizione nelle fonti; piuttosto
si direbbe che l’esercito della polis si sia ritirato o sia stato messo in fuga. Pisistrato fece
inseguire i fuggitivi dalla cavalleria, non però per portare il colpo fatale alle forze nemiche, ma
al contrario per proclamare le sue intenzioni pacifiche e per incoraggiare i concittadini a
ritornare alle proprie faccende173.
La lista degli alleati di Pisistrato a Pallene è un elemento di significativo interesse per
l’obiettivi di questa ricerca poiché costituisce una testimonianza delle relazioni internazionali su
cui Pisistrato poteva contare nel 546; è importante dunque tentare un’analisi di ciascun
componente, al fine di individuarne l’origine, i moventi, l’interesse reciproco e lo sviluppo
diacronico dell’intesa con il tiranno ateniese174.
172
FROST 1984, pp. 290-294.
Hdt. I 62s.
174
STAHL 1987, pp, 60-66.
173
89
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Fig. 2: gli alleati e le risorse di Pisistrato in occasione della battaglia di Pallene (546)
Eretria
Nella narrazione delle vicende di Pisistrato le fonti mettono in rilievo il ruolo di Eretria
nel momento in cui si andava preparando il ritorno in Attica, al termine del decennio di esilio
passato in Tracia e prima della fatidica battaglia di Pallene del 546. È necessario invece
ricostruire per Eretria un ruolo di centro di ospitalità e organizzazione coloniale per tutta la
durata dell’esilio, a partire dalle prime fasi successive alla fuga da Atene nel 556175.
Nel 556 Pisistrato subì il secondo esilio da Atene che portò la famiglia a insediarsi sulle
coste dell’Egeo settentrionale, prima a Rhaikelos nella penisola calcidica e successivamente
sulle rive del fiume Strimone presso il Pangeo in Tracia176. È significativo che lo stanziamento
a Rhaikelos in Calcidica sia avvenuto proprio in un contesto geo-politico di antica
colonizzazione euboica, come attestano le eminenti colonie di Pallene e Sitone, fondate dalle
poleis di Calcide ed Eretria177. Prima di dirigersi verso la Tracia i Pisistratidi avrebbero dovuto
175
VIVIERS 1987.
COLE 1975.
177
GEHRKE 1996, p. 983. Sull’origine e la cronologia della colonizzazione euboica in Calcidica: BRADEEN 1952.
176
90
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
non solo organizzare la spedizione, ma soprattutto avrebbero dovuto necessariamente ottenere
l’avallo della madrepatria euboica che deteneva interessi e preminenza coloniale nella penisola
calcidica ove Pisistrato intendeva dirigersi: una simile autorizzazione sarebbe stata senz’altro
necessaria per non incorrere in incidenti con le colonie o con le poleis di Calcide euboica e di
Eretria. Su questa premessa dobbiamo accettare la ricostruzione di un primo contatto e di una
prima intesa fra Pisistrato ed Eretria nel 556178.
Ritengo utile approfondire ulteriormente l’analisi in questa direzione: si può ricostruire
che Eretria fornì a Pisistrato un numero consistente di volontari per l’impresa che si accingeva
a compiere, che andarono ad aggiungersi alle forze che Pisistrato portava da Atene. I familiari e
gli stasiòtai del tiranno costituivano infatti un gruppo troppo esiguo per tentare l’insediamento
in un’area di non facile gestione, sia per le pre-esistenti colonie con cui si sarebbero potuti
scontrare, sia per la pressione dei bellicosi barbari traci locali, sia per le possibilità di ingerenza
del vicino regno macedone. Così trova una spiegazione anche la terminologia usata da
Aristotele in riferimento a Rhaikelos, considerato come un insediamento coloniale, o paracoloniale (sun%¯kise), numericamente più consistente dunque di un insediamento familiare,
condiviso fra Pisistratidi e partigiani esuli dei tiranni e membri dell’aristocrazia di Eretria.
Dunque l’intesa fra Pisistrato e il ceto dirigente di Eretria risaliva al 556, all’inizio dell’esilio
decennale precedente il rientro in Attica avvenuto con la battaglia di Pallene: consistette
nell’offerta di ospitalità, nell’autorizzazione alla colonizzazione a Rhaikelos e nella
compartecipazione all’impresa tracica.
Ulteriori elementi attestano l’alleanza fra Pisistrato e gli hippéis di Eretria. Uno scolio alle
Nuvole di Aristofane menziona infatti il matrimonio di Pisistrato con una donna di Eretria di
nome Koisyra, all’epoca in cui egli tentò di farsi tiranno179; il riferimento è dunque ad un
periodo di poco antecedente la tirannide del 546, proprio quando Eretria funse da luogo di
raccolta per le forze di Pisistrato e come luogo di partenza per il contingente diretto a Maratona.
L’aristocrazia di Eretria aveva dunque appoggiato il tiranno in esilio, rimanendo al corrente del
suo comportamento nel corso del decennio trascorso in Tracia, e nel 546 poté verificare la
consistenza delle ricchezze raccolte e le capacità diplomatiche e strategiche della famiglia che
si apprestava a ritornare al governo di Atene. Fu una scelta naturale per l’aristocrazia di Eretria,
non solo continuare ad appoggiare Pisistrato nei suoi progetti, ma cercare in quel momento di
stringere un legame ancor più solido nella prospettiva di godere, di lì a poco, dei vantaggi
178
VIVIERS 1987; WALKER 2006, pp. 149s.
Schol. Aristoph. Nub. 48; Suda s.v. Ἐγκεκοισυρωµένην, E 87 Adler. VIVIERS 1987; LAVELLE 2005, pp. 134136.
179
91
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
garantiti da un’alleanza familiare con un ricco e potente tiranno e con una polis della levatura
della vicina Atene.
Così l’appoggio di Eretria in occasione della battaglia di Pallene vede esplicitati i propri
moventi: una tradizione di collaborazione coloniale risalente al 556, la constatazione del
successo economico e diplomatico nel corso dell’esilio, l’evidenza della vittoria che andava
preparandosi per Pisistrato ad Atene, l’alleanza matrimoniale con la famiglia aristocratica di
Koisyra. Si è già constatato che il contributo di Eretria e dei suoi cavalieri sembra sia stato
limitato all’offerta di ospitalità, all’appoggio logistico e al contributo finanziario, in virtù della
collocazione della notizia nel testo tramandatoci da Aristotele. L’oligarchia degli hippèis
eretriesi va d’altronde inserita in una categoria socio-culturale prettamente aristocratica, legata
cioè alle tradizioni e al codice morale omerico dell’affermazione del valore e dell’eccellenza
(areté) personale; i campi in cui tale areté trovava la propria espressione erano la battaglia,
l’agonismo, la politica e la ricchezza: sulla base di questa contestualizzazione si potrebbe
ipotizzare che un pur limitato contingente di cavalieri di Eretria abbia preso parte ai
combattimenti a Pallene180.
Tebe
Tebe è indicata come il maggiore contribuente finanziario di Pisistrato: questa notizia è
una delle più difficili da comprendere e contestualizzare poiché non si riscontrano altre notizie
di rapporti fra Pisistrato e questa polis181. Unica altra notizia letteraria relativa alle relazioni fra i
Pisistratidi e i Tebani risale al regno non di Pisistrato ma del figlio e successore alla tirannide,
Ippia. Nel 519 la polis di Platea, al confine fra Beozia e Attica, subiva l’ingerenza di Tebe e si
rivolse in supplica ad Atene invocandone la protezione; a conseguenza di queste trattative
Ateniesi e Tebani vennero a scontrarsi e i Beoti subirono una sconfitta che ne ridimensionò i
confini al corso del fiume Asopo; così Platea rientrò nella sfera di influenza di Atene da quel
momento in avanti182. Pochi anni dopo gli eventi di Platea, nel 511, ebbero inizio le campagne
militari di Sparta per espellere Ippia dalla posizione di tiranno ad Atene. In due occasioni i
Tessali dimostrarono la loro alleanza con i Pisistratidi intervenendo militarmente in loro difesa.
L’alleanza dei Pisistratidi con i Tessali mi pare contraddittoria con la possibilità di intrattenere
rapporti concilianti con Tebe: poiché l’egemonia tebana sulla Beozia andava naturalmente a
scontrarsi con le mire espansionistiche dei Tessali verso meridione183, le due potenze erano fra
180
FROST 1984, pp. 290s.; VIVIERS 1987.
HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 61; ANDREWES 1982 b, pp. 398-403.
182
Hdt. VI 108; Thuc. III 55, 68. PICCIRILLI 1973, n. 9; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 28-31, 51s., 61-64, 180-184,
225-240 180-184.
183
FORREST 1956, pp. 42-44; SORDI 1958, pp. 54-84.
181
92
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
loro contrapposte e difficilmente avrebbero potuto condividere un medesimo alleato nei
Pisistratidi ateniesi, perlomeno Tebe non avrebbe consentito il passaggio dei cavalieri tessali
attraverso il proprio territorio184.
Dunque disponiamo dell’attestazione di un’intesa fra Tebe e Pisistrato risalente al 546 che
non possiamo però legare ad altre notizie che contribuiscano a darne spiegazione; d’altro canto
disponiamo di altre due attestazioni, risalenti al 519 e al periodo 511-510, che contraddicono la
possibilità di rapporti pacifici fra Tebe e il successore pisistratide Ippia. Le fonti che ho finora
esaminato e le stesse opinioni della critica purtroppo non permettono ulteriori discussioni e il
contributo di Tebe rimane un fatto apparentemente isolato, discontinuo ed accidentale; la
notizia è tanto più contraddittoria in quanto entrambe le fonti a nostra disposizione identificano
proprio in Tebe l’offerente fra tutti più generoso. Mi pare nondimeno di essere tenuto ad
esprimere un giudizio perlomeno speculativo alla luce dei temi trattati in questa ricerca. È
possibile che l’offerta di Tebe a Pisistrato sia stata un tentativo di quella polis di assicurarsi un
alleato nella Grecia meridionale e, più specificamente, di intavolare relazioni positive con colui
che avrebbe governato il territorio immediatamente a sud della Beozia e che avrebbe dunque
potuto costituire una minaccia all’integrità dell’egemonia che Tebe aveva sviluppato poc’anzi
durante la prima metà del VI secolo. Gli eventi relativi a Platea risalenti al governo di Ippia
costituiscono una giusta riprova di questi timori. Il fatto che l’intesa fra i Pisistratidi e Tebe sia
stata effimera è chiaramente dimostrato dalla strategia internazionale seguita da Ippia, la cui
svolta si presta a due interpretazioni speculative. È possibile che il figlio Ippia non si sia curato
di perpetuare e rispettare la posizione che il padre era andato costruendo per la famiglia nelle
reti di alleanze internazionali; Ippia d’altronde si trovò a governare in un contesto storicoculturale in cui le vecchie forme di intesa inter-aristocratica andavano perdendo velocemente
pregnanza a fronte della ragione di stato185. La seconda alternativa è che sia stato già lo stesso
Pisistrato ad accettare in modo poco onesto l’offerta di aiuto di Tebe, pur nella consapevolezza
che quel donativo non sarebbe mai andato cementandosi in un’alleanza politica che non aveva
fondamenti tradizionali né prospettive di altra utilità.
Da un contrario punto di vista, si potrebbe anche leggere nell’intervento di Tebe a favore
di Pisistrato l’obiettivo di destabilizzare Atene provocando un cambiamento di governo o un
stàsis fra le fazioni e da ultimo una lotta civile: in quelle circostanze la polis attica in ascesa
avrebbe cessato, perlomeno per un periodo, di costituire un pericolo sulla frontiera meridionale
184
SORDI 1958, pp. 54-84.
É in questa prospettiva che si spiega peraltro la rottura, nel 514-510, della tradizionale alleanza che legava
Sparta ai Pisistratidi: allora Sparta attaccò Ippia malgrado i Lacedemoni e i Pisistratidi fosse xènoi, cioè alleatiospiti di vecchia data. Hdt. V 63; Aristot. Ath. Pol. 19.4.
185
93
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
tebana; nel periodo di tumulto della lotta civile ad Atene e nell’incerto periodo iniziale della
tirannide di Pisistrato, Tebe poteva aspettarsi che gli Ateniesi, occupati in faccende interne, si
ritirassero dall’intervenire al di fuori dell’Attica e dunque lasciassero libera Tebe di affermare
la propria egemonia nella confinante Beozia186.
Ligdami di Nasso
Ligdami di Nasso contribuì portando ad Eretria risorse finanziarie e un contingente di
armati, valutati dalle fonti come di considerevole entità187. Una prima osservazione significativa
deve puntualizzare che l’iniziativa fu esplicitamente personale, cioè Ligdami venne a Pisistrato
negli interessi propri e della propria famiglia e non in rappresentanza della polis di Nasso o di
alcuna parte della sua comunità. Possiamo poi estrapolare dalle fonti un altro dato di estrema
rilevanza: Ligdami offrì spontaneamente, volontariamente (ethelontès), il proprio contributo.
Questo significa che Ligdami non faceva parte di quel gruppo di individui e comunità che
avevano degli obblighi verso Pisistrato e dai quali i Pisistratidi avevano il diritto di esigere in
quel momento aiuto per la loro impresa; il Nassio nondimeno si prodigò in maniera eccezionale
e di propria iniziativa, investendo le proprie sostanze, raccogliendo e armando un contingente
per le operazioni militari e facendo vela dalla propria isola alla volta di Eretria.
Il movente della decisione di Ligdami va cercato nelle modalità di istituzione delle
alleanze inter-aristocratiche sopra descritte: in questa notizia ci è dato cioè di osservare
esattamente come ebbe inizio il legame di reciprocità fra Ligdami e Pisistrato: un legame che
sappiamo proseguì negli anni successivi. Ligdami compì un primo passo nei confronti di
Pisistrato portandogli esattamente le risorse e l’aiuto nella forma che erano in quel momento
necessari; egli fece un investimento di natura finanziaria, politica e strategica, da cui poteva
solo sperare di trarre in futuro un rendiconto altrettanto consistente e vantaggioso. Si trattò
certamente per Ligdami di correre un rischio, poiché nessuna autorità sovra-statale
internazionale obbligava Pisistrato a ricambiare quanto ricevuto dal suo nuovo alleato
personale; l’obbligo era piuttosto determinato da un sentimento di aderenza ai valori morali
della reciprocità, dal sentimento del debito. Per altro verso Ligdami poteva evidentemente
contare sulla vittoria di Pisistrato vista la sicurezza e la grande entità della sua offerta. Con la
186
Si tratta questo di un modello interpretativo in parte affine a quello applicato, in altra circostanza, anche da
Erodoto: secondo la sua ricostruzione, quando i Plateesi cercarono l’aiuto di un alleato contro l’egemonia di Tebe,
essi si rivolsero in un primo momento agli Spartani, ma il sovrano Cleomene consigliò loro di interpellare i più
vicini Ateniesi; Erodoto vede nelle parole di Cleomene non il tentativo di aiutare i Plateesi, ma piuttosto
l’intenzione di spingere Atene a venire coinvolta nella spinosa questione beotica e conseguentemente a venirne
indebolita. Sia per il proposto movente anti-ateniese di Tebe, sia per quello del consiglio di Cleomene, è presente il
tentativo di provocare, per vie traverse, problemi interni o regionali ad Atene che ne indeboliscano il campo di
intervento. Hdt. VI 108.
187
BERVE 1967, pp. 78s.
94
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
vittoria e la tirannide di Pisistrato l’investimento di Ligdami si sarebbe rivalutato: inizialmente
egli aveva fatto un donativo ad un pur potente ed intraprendente aristocratico in esilio, ma in
futuro poteva aspettarsi di ricevere un contro-dono da parte di un uomo divenuto tiranno: in
futuro cioè Pisistrato avrebbe ripagato il suo evergete in maniera non più commisurata al dono
ricevuto, ma piuttosto superando quella misura e dimostrando, a vantaggio del proprio
prestigio, la ricchezza e la potenza della sua nuova posizione di supremazia come tiranno di
Atene. A garanzia ulteriore dell’investimento che Ligdami fece alla vigilia di Pallene, era
evidente che Pisistrato avrebbe trovato vantaggioso conservare un alleato fidato in una località
strategica al centro dell’arcipelago delle Cicladi: la strategia di lungo periodo dei Pisistratidi
dimostra infatti uno spiccato interesse per l’Egeo.
Ci sono tracce evidenti che il contributo di Ligdami fu più di un semplice donativo, ma
potrebbe interpretarsi già piuttosto nel senso di una alleanza istituita sul fondamento di un
preciso progetto strategico. Fra le prime iniziative di Pisistrato giunto alla tirannide, le fonti
menzionano infatti la conquista di Nasso e l’imposizione colà del potere tirannico di
Ligdami188. A Nasso furono poi portati come ostaggi i figli di quegli Ateniesi che si erano
opposti all’instaurazione della tirannide di Pisistrato. Successivamente alla conquista di Nasso e
alla sua incorporazione entro la sfera di influenza di Atene, abbiamo anche la notizia della
purificazione dell’isola sacra di Delo, da parte di Pisistrato189. È evidente dunque come il
prosieguo delle vicende relative a Ligdami e alla strategia marittima di Pisistrato giustifichi
pienamente l’alleanza istituita da Ligdami e Pisistrato nel 546 e la sua interpretazione nella
prospettiva degli interessi reciproci fra i due. Ligdami aiutò Pisistrato a conquistare la tirannide
ad Atene e viceversa Pisistrato aiutò Ligdami ad assicurasi il potere a Nasso190; l’isola funse
subito da postazione salda da cui Pisistrato poté affermare una forma di controllo nelle acque
delle Cicladi: la dimostrazione di questo progetto venne con il gesto rituale e simbolico della
purificazione dell’isola-santuario sacra ad Apollo, che attestava pubblicamente e a livello
internazionale il ruolo di Pisistrato come garante dell’ordine e della protezione degli uomini e
della divinità191.
188
È pervenuta una tradizione relativa alla presa della tirannide di Ligdami a Nasso incentrata sulle vicende locali,
raccolta nella perduta Costituzione di Nasso di Aristotele: Ath. VIII 40 (347f-348c). SANDYS 1912, pp. 61-65;
BOLLANSÉE 2007, pp. 186-189. Non condivido l’opinione di B.M. Lavelle che ritiene, contro il testo delle fonti,
più opportuno collocare l’aiuto di Pisistrato verso Ligdami al 548, prima della battaglia di Pallene, cosicché
l’offerta di Ligdami discussa in questo paragrafo troverebbe migliore giustificazione: LAVELLE 2005, pp. 136-139,
216-218.
189
Hdt. I 64. CAWKWELL 1995, p. 78.
190
ANDREWES 1982 b, pp. 399, 405.
191
SHAPIRO 1989, pp. 48-60.
95
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Argo
Il contingente militare di Pisistrato a Pallene fu composto senz’altro dai mercenari che
egli stesso aveva ingaggiato in Tracia, dagli uomini che Ligdami portò da Nasso e da un
consistente gruppo di soldati provenienti da Argo. Nel testo di Erodoto questi figurano
chiaramente nella lista delle forze militari e sono definiti come mercenari di Argo provenienti
dal Peloponneso (Argèioi misthotòi)192. Nell’elenco degli alleati fornito da Aristotele questa
notizia è passata sotto silenzio, ma è comunque tramandata in un altro passo dell’opera:
narrando della morte di Pisistrato, si presenta l’opportunità di discutere dei figli del tiranno; fra
questi erano Iofonte ed Egesistrato, nati da una moglie argiva, e fu proprio in virtù di questo
matrimonio, secondo Aristotele, che Pisistrato godette dell’amicizia degli Argivi e che mille di
essi combatterono al fianco di Pisistrato alla battaglia di Pallene, sotto il comando di Egesistrato
(ὅθεν καὶ ἡ πρὸς τοὺς Ἀργείους ἐνέστη φιλία, καὶ συνεµαχέσαντο χίλιοι τὴν ἐπὶ Παλληνίδι
µάχην, Ἡγησιστράτου κοµίσαντος)193.
I due testi potrebbero far sorgere dei dubbi per via della diversa terminologia con cui
Erodoto e Aristotele si riferiscono al drappello di Argivi: per il primo sarebbero dei mercenari,
per il secondo degli uomini di Argo nondimeno fedeli alla famiglia pisistratide. La
contraddizione è tuttavia solo apparente. Erodoto evidentemente non fu a conoscenza del ruolo
di Egesistrato a Pallene, malgrado conoscesse il personaggio, la sua discendenza dal tiranno
ateniese e il suo contributo in altri progetti del padre194; è invece proprio in questa prospettiva
che Aristotele inserisce l’apporto argivo. I parenti pisistratidi ad Argo, in particolare il figlio
Egesistrato, organizzarono dunque nella propria madrepatria il reclutamento di 1.000 soldati
scelti entro il corpo cittadino; Argo fu peraltro una comunità di antichissima tradizione oplitica
e di capacità militari tali da avere tenuto testa all’espansionismo spartano nel corso di tutta
l’epoca arcaica. A livello logistico però le spese per stipendiare e mantenere il contingente
furono evidentemente delegate a Pisistrato: questi era innanzitutto il diretto interessato e il
massimo depositario finanziario della famiglia; Pisistrato aveva organizzato e avrebbe condotto
la campagna militare contro l’Attica, si sarebbe occupato delle decisioni strategiche e dunque
anche delle spese quali il mantenimento quotidiano delle truppe e il loro compenso. A
quest’ultimo scopo servivano appunto quelle ricchezze che portavano gli altri alleati. Cosicché
è vero che da Argo vennero 1.000 soldati (Argéioi), sotto la guida di Egesistrato, ma è anche
vero che furono mantenuti e stipendiati (misthotòi) da Pisistrato stesso. Un altro elemento
192
Hdt. I 61.
Aristot. Ath. Pol. 17.4.
194
Egesistrato fu tiranno a Sigeo dopo la conquista di Pisistrato: Hdt. V 94s.
193
96
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
contribuisce a questa ricostruzione: nonostante il lessico usato dalle fonti dia adito a confusioni,
per Argo non dovette trattarsi di una impresa della comunità per la quale si potesse mobilitare la
cittadinanza libera in armi; piuttosto si trattò dell’iniziativa familiare di Egesistrato, che arruolò
sostenitori e concittadini a sé vicini in vista di uno scopo privato: è naturale dunque che gli
Argivi a Pallene si aspettassero di ricevere uno stipendio e una ricompensa195. La relazione dei
soldati argivi con Egesistrato e Pisistrato è da assimilarsi alla pratica delle imprese militari e di
pirateria diffuse nel mondo omerico, in cui un signore di prestigio raccoglieva attorno a sé un
gruppo di sovrani minori, clienti e soldati per impegnare le loro capacità guerresche in vista
dell’accumulo e della spartizione del bottino196.
Dalle stesse parole di Aristotele appare evidente quali moventi spinsero questi Argivi ad
intervenire a favore di Pisistrato a Pallene: fra Pisistrato e una famiglia dell’aristocrazia argiva
esisteva un’alleanza matrimoniale risalente agli anni della prima tirannide ad Atene; sulla base
di questi vincoli parentelari, era nell’interesse degli stessi Argivi che Pisistrato guadagnasse la
tirannide, migliorasse la posizione internazionale della famiglia e conseguentemente anche lo
status e le possibilità del suo ramo argivo. Un’analisi approfondita di questa alleanza
matrimoniale appartiene ad altra sezione della ricerca, tuttavia è necessario comprenderne
perlomeno alcuni aspetti per fare luce sulla partecipazione di Argivi a Pallene. Nel 561/0
Pisistrato assunse la tirannide ad Atene per la prima volta; il suo successo fu presto piegato
dall’opposizione delle altre due eminenti famiglie aristocratiche ateniesi e il tiranno subì un
primo esilio. Durante quel breve periodo di tirannide Pisistrato sposò Timonassa, una donna di
Argo, figlia di un cittadino eminente di nome Gorgilo197; Timonassa era al suo secondo
matrimonio poiché era vedova di Archino, uno degli ultimi membri della casata dei Cipselidi, la
celebre famiglia di tiranni di Corinto; Archino era stato egli stesso tiranno della colonia corinzia
di Ambracia, sul Mar Ionio.
Con il matrimonio precedente Timonassa aveva associato la propria famiglia ad una
dinastia di tiranni che in passato erano stati riconosciuti come una autorità internazionale, ma
che nel 560 avevano perduto il potere: a Corinto esisteva un governo oligarchico ormai da un
ventennio e gli ultimi discendenti cipselidi nelle colonie andavano appunto scomparendo. Per
Gorgilo e Timonassa il matrimonio con Pisistrato rappresentava un’occasione per associarsi ad
un personaggio di levatura aristocratica e tirannica, come lo era stato Archino, ma dalle
prospettive più promettenti e di successo. Per Pisistrato il matrimonio con Timonassa era il
195
BING 1977, pp. 311s.
GSCHNITZER 1988, p. 67.
197
Vd. supra, pp. 64ss.
196
97
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
primo passo verso la creazione di una rete di alleanze personali e familiari di apertura
internazionale; con l’opposizione di tutte le famiglie aristocratiche locali ad Atene, era
essenziale per Pisistrato assicurarsi l’alleanza di altri membri dell’élite ellenica di cui poteva
fidarsi e che potevano contribuire al mantenimento del suo potere e questi alleati potevano
trovarsi solo fuori da Atene. Altro movente di Pisistrato era quello di legarsi, tramite la vedova,
al gruppo familiare allargato dei tiranni cipselidi che, se pure avesse ormai perso ogni capacità
politica, ancora poteva offrire un’immagine di prestigio internazionale e di saggezza politica.
Non è difficile evidenziare la mancanza di comuni interessi strategici fra le posizioni sul piano
internazionale delle due città-stato di Argo e Atene: questo significa che l’alleanza fra Pisistrato
e Gorgilo ebbe una funzione prettamente personale e inter-familiare e non fu l’espressione di un
gruppo di governo interessato alle esigenze della polis; per questo motivo e per l’esilio di
Pisistrato da Atene nel decennio 556-546 questa alleanza rimase latente per un certo lasso
tempo, per tornare infine di nuovo attiva e significativa nel 546.
Al 546 risale la grave sconfitta militare di Argo contro Sparta, nella cosiddetta Battaglia
dei Campioni, in conseguenza della quale Argo perdette il controllo sull’importante territorio di
confine della Tireatide; la critica segna in questo evento l’inizio del declino della potenza argiva
nel Peloponneso198. Se accettata, la sincronicità fra la Battaglia di Pallene e la Battaglia dei
Campioni esige una riflessione storica; le fonti non tramandano tuttavia alcuna osservazione al
riguardo e trattano i due casi del tutto separatamente: perciò non possiamo sapere in che
relazione i due eventi furono percepiti, né possiamo sapere in che cronologia relativa dobbiamo
disporli. In primo luogo è significativo che, proprio in un momento di attrito e scontro con
Sparta, una famiglia eminente e altri 1.000 Argivi abbiano ritenuto opportuno lasciare il
Peloponneso per soccorrere Pisistrato a Pallene. È possibile che Sparta possa avere approfittato
proprio di quel momento per portare a segno un attacco decisivo nella guerra per la Tireatide; è
pure altrettanto possibile che, al contrario, la decisione di Egesistrato di rispondere all’appello
di Pisistrato sia stata una conseguenza della sconfitta contro Sparta e vada dunque interpretata
piuttosto come una fuga da una polis che aveva ormai perduto le proprie possibilità di
affermazione199.
La critica ha messo in relazione il nuovo ruolo che Egesistrato sembra assumere in questo
periodo con la sconfitta argiva nella Tireatide. Oltre a condurre il contingente a Pallene,
198
Hdt. I 82. KELLY 1976, pp. 156-161; ANDREWES 1982 b, p. 402; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 61s., 201-203.
Si applichi d’altronde una certa cautela nell’accettare la sincronicità della battaglia di Pallene e di quella dei
Campioni giacchè le loro datazioni appartengo a filoni di tradizioni cronografiche separate. Ringrazio il Prof. F.
Raviola per avere portato alla luce questa osservazione, du cui assumo d’altronde la piena responsabilità, in uno
dei colloqui che ho avuto con lui.
199
98
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Egesistrato ebbe un ruolo nelle operazioni di Pisistrato al Sigeo, ove governò come tiranno; di
questa iniziativa in Troade non sono pervenute informazioni cronologiche ed è genericamente
collocata alla metà del VI secolo. È stata avanzata dunque la ricostruzione secondo cui
Egesistrato lasciò Argo in seguito alla sconfitta nella Battaglia dei Campioni e prestò servizio a
Pallene. Pisistrato aveva già avuto una
moglie ateniese da cui erano nati due figli, il
primogenito Ippia e Ipparco, i quali erano i successori destinati alla tirannide; la presenza ad
Atene del figlio argivo avrebbe potuto però causare attriti con il ramo locale e legittimo della
famiglia: perciò fu decisa l’assegnazione ad Egesistrato delle operazioni e della tirannide al
Sigeo. Si delineerebbe così una scansione diacronica che vede la Battaglia dei Campioni come
causa dell’abbandono di Argo da parte di Egesistrato, dunque poi la battaglia di Pallene nel 546
e infine il trasferimento in Asia del figlio argivo e di parte del suo stesso contingente200. Anche
senza volersi prestare a ricostruzioni eccessivamente speculative sull’utilizzo e sulla
dislocazione del contingente argivo portato da Egesistrato, pure è condivisibile la semplice
constatazione che quei soldati stipendiati costituirono una presenza militare significativa per il
potere di Pisistrato e nondimeno una complicazione per l’equilibrio sociale della comunità
ateniese201.
Tralasciando le congetture sopra proposte ed indipendentemente dalla relazione
cronologica tra i due eventi bellici, è necessario notare che il comportamento di Egesistrato e
del suo contingente costituisce una prova significativa della forza delle alleanze parentelari
internazionali e del fatto che questo genere di obbligazioni poteva esercitare un peso maggiore
di quello degli obblighi civici dell’individuo verso la propria polis. La critica ha infatti messo in
luce come nella cultura ellenica aristocratica esistesse una forma di stratificazione sociale
orizzontale e panellenica che separava le élites dalla popolazione cittadina: esisteva cioè un
senso di compartecipazione e di appartenenza comune fra le élites delle molteplici poleis che
spingeva gli aristocratici ad assegnare più importanza ai legami internazionali degli uni verso
gli altri, piuttosto che verso la propria comunità poleica202. Cosicché, nel caso in esame,
Gorgilo, Egesistrato e i soldati che a loro si associarono ritennero più utile e più decisivo
200
ANDREWES 1982 b, p. 402.
È stata avanzata l’ipotesi che questo consistente corpo di armati abbia peraltro costituito il primo esercito
organizzato ateniese: Pisistrato e i figli avrebbero cioè utilizzato e stipendiato i soldati argivi impiegandoli nella
propria protezione ad Atene e nelle operazioni al Sigeo condotte da Egesistrato; successivamente alla cacciata della
tirannide questi Argivi rimasero ad Atene, sarebbero stati incorporati nella cittadinanza dalla riforma di Clistene e
dunque utilizzati nella difesa armata dalle incursioni di Sparta: BING 1977. Sulle capacità militari di Pisistrato e
della comunità ateniese che si trovò a fronteggiare a Pallene: FROST 1984, pp. 290-294.
202
GERNET 1983, pp. 77-81, 146-159, 277-299; HERMAN 1987, pp. 11-12, 34-40, 70-80; GSCHNITZER 1988, pp. 6670, 102-113; LIVERANI 1994, p. 182; MURRAY 1996, pp. 51-74; NIPPEL 1996, pp. 167-168; KONSTAN 1997, pp. 2437, 56-61, 84-87; MITCHELL 1997, pp. 41-51; ANDERSON 2005, pp. 173-210.
201
99
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
preservare gli interessi della famiglia pisistratide nello scenario internazionale piuttosto che
rimanere ad Argo pure in un momento delicato per le posizione della polis nell’ambito locale e
regionale.
Altri alleati
Sia Erodoto che Aristotele sembrano ritenere che gli alleati elencati nei loro testi siano
solamente i soggetti i cui contributi furono di particolare nota, mentre vi sarebbero stati
numerosi altri alleati di cui non è stata tramandata l’identità203. Nonostante il silenzio delle
fonti, pare utile in questa analisi dedicare una riflessione volta a suggerire alcune
identificazioni, sulla base della storia dei Pisistratidi e del contesto storico e strategico. La
sorpresa espressa dalla critica e da chi scrive nel riscontrare Tebe fra i maggiori contribuenti
finanziari dovrebbe d’altronde ridimensionare le possibilità dell’analisi contestuale nel riempire
il vuoto lasciato dalle fonti204.
Corinto
Viene alla luce una tendenza filo-corinzia nella politica estera di una parte della classe
politica ateniese dell’epoca arcaica. La direzione economico-strategica che questi ateniesi
miravano ad implementare per la polis volgeva all’espansione marittima, nel golfo Saronico e
verso le rotte dell’Egeo, e conseguentemente al conflitto con la confinante e concorrente polis
di Megara; la tendenza anti-megarica comportò viceversa un atteggiamento filo-corinzio poiché
la posizione e gli interessi di Corinto creavano una condizione di attrito con Megara e la
rendevano un alleato naturale per Atene nel conflitto contro quest’ultima. Entro questo gruppo
politico filo-corinzio è possibile collocare l’alcmeonide Megacle che nel 636 si oppose alla
tirannide di Cilone, alleato di Teagene di Megara; anche Pisistrato va ascritto a questa tendenza
politica filo-corinzia. In una chiara funzione anti-megarica è da collocarsi l’intervento di
Pisistrato nella conquista del porto di Nisea, nel 565; nel quadro di una tendenza filo-corinzia e
filo-cipselide di lungo periodo si potrà inserire anche il matrimonio del tiranno con Timonassa
di Argo, la quale era stata sposa di un Cipselide.
È possibile dunque che in occasione della battaglia di Pallene alcuni contributi siano
giunti alle forze pisistratidi da una parte dell’aristocrazia corinzia che vedeva nella tirannide di
Pisistrato il governo di un politico che avrebbe perseguito quella intesa strutturale di lungo
periodo fra le due poleis. Contro questa interpretazione rimane la netta opposizione del
contingente corinzio alle intenzioni di Sparta di aiutare Ippia a rientrare ad Atene, nel 500 ca.;
203
204
Hdt. I 61.3s.; Aristot. Ath. Pol. 15.2.
ANDREWES 1982 b, pp. 399, 405.
100
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
pure la critica ha fatto notare che esistono dei cambiamenti significativi nella strategia e nella
posizione internazionale dei figli rispetto a Pisistrato e dunque quest’ultima notizia non deve
necessariamente essere presa come metro dei precedenti rapporti fra Corinto e Pisistrato a metà
del VI secolo205.
Sparta
Nel 510 Sparta scacciò i Pisistratidi da Atene e in quella occasione le fonti notano che i
Lacedemoni contravvennero ad un vincolo di ospitalità e reciprocità (xenìa) che li legava alla
famiglia di Pisistrato. Non esistono altre notizie relative a questo legame, ma la xenìa dovette
essere istituita precedentemente da Pisistrato o da suo padre nel corso del VI secolo206. Se la
xenìa fosse stata dunque valida nel 546, Pisistrato ed Ippia avrebbero potuto giustamente
chiedere aiuto ai Lacedemoni.
La ricostruzione di questo legame è irrimediabilmente imprecisa perché le fonti ne danno
notizia solo nel momento della sua dissoluzione. È sicuro d’altronde che, se nel 510 Sparta poté
ignorare questo legame tradizionale, significa che l’alleanza era andata perdendo utilità
reciproca e non veniva da tempo rinnovata e ritualmente espressa. Il matrimonio di Pisistrato
con Timonassa nel 560 costituì, a mio avviso, un significativo spartiacque nel peggioramento
dell’intesa fra i tiranni ateniesi e Sparta. Quell’alleanza matrimoniale poté essere interpretata
come l’allineamento di Pisistrato agli interessi internazionali di Argo; per Sparta questo dovette
essere inaccettabile vista la crescente ostilità che andava creandosi con quella polis nel
controllo del Peloponneso orientale, culminata appunto nel 546 nello scontro per la Tireatide207.
Sulla base di questa contestualizzazione asserirei che Sparta non fu tra gli alleati di Pisistrato a
Pallene perché in quella data l’intesa doveva essere già irrimediabilmente incrinata.
I Macedoni
Nel 504 ca. svanirono le ultime possibilità di Ippia di rientrare ad Atene operando tramite
la diplomazia familiare nella Grecia continentale; in quel momento Ippia ricevette dal sovrano
di Macedonia Aminta l’offerta di stabilirsi e governare Antemunte, nella penisola calcidica208.
È possibile offrire una ricostruzione secondo cui le relazioni positive dei Pisistratidi con i
sovrani macedoni erano iniziate all’epoca del secondo esilio da Atene, nel 556, quando
Pisistrato lasciò l’Attica e si insediò prima a Rhaikelos e poi in una località più a est, sul fiume
Strimone. Rhaikelos e lo Strimone segnano infatti un’area di espansione del regno macedone e
205
ANDREWES 1982 b, p. 402.
Vd. supra, pp. 41ss.
207
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 61s., 201-203.
208
Hdt. V 94.1. CASSON 1926, pp. 117s.; ROBINSON 1945, pp. 246s.; SORDI 1958, pp. 54-84; BORZA 1990, pp.
117s.; NENCI 2006, ad Hdt. V 17.
206
101
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
di attrito con i barbari traci locali209: Pisistrato dovette allora rendere qualche offerta di doni,
beni o servizi agli Argeadi di Macedonia, in base alla quale i rapporti reciproci continuarono
fino alla fine del secolo e del dominio dei Pisistratidi ad Atene. È più che plausibile quindi che
in occasione di Pallene i Macedoni abbiano offerto il proprio aiuto a Pisistrato, in osservanza
del patto di reciprocità che si è ora ricostruito.
I Tessali
Quando nel 504 ca. Ippia ricevette l’offerta di Antemunte dal re di Macedonia, gli fu
offerta in modo analogo Iolco da parte dei Tessali210. Anche questa alleanza va retrodatata: è
noto che nel 511 e nel 510 i Tessali si opposero strenuamente, con la propria armata di
cavalieri, alle invasioni di Sparta che minacciavano il potere dei Pisistratidi, in virtù di una
effettiva alleanza militare (symmachìa)211. Rapporti positivi fra i Pisistratidi e i Tessali si
possono ricostruire con buona certezza anche all’epoca dello scontro fra Atene e Tebe nel 519,
poiché Tebe e i Tessali erano potenze confinanti e in attrito fra loro212.
Un ulteriore elemento permette a mio avviso di far risalire alla metà del VI secolo
l’esistenza di relazioni amichevoli fra Pisistrato e i Tessali. È noto che uno dei figli di Pisistrato
avuti con la sposa argiva Timonassa ebbe nome Egesistrato e soprannome Tessalo213. La pratica
di utilizzare l’onomastica per segnalare e favorire le relazioni familiari con i propri alleati e
xènoi è ampiamente attestata e infatti il soprannome del giovane argivo è universalmente
interpretato dalla critica moderna come indice dell’alleanza di Pisistrato con quell’omonimo
èthnos214. La cronologia della vita di Pisistrato, si è visto, colloca il matrimonio con Timonassa
nel 560 ca. e dobbiamo supporre che il giovane sia nato intorno a quella data: se questi ricevette
il proprio soprannome al momento della nascita, o comunque in giovane età, si potrà dunque
ricostruire l’esistenza di una forma di alleanza familiare fra Pisistratidi e Tessali intorno a quei
medesimi anni, prima del 546215. È pur vero che la datazione dell’assegnazione del soprannome
di Tessalo ad Egesistrato è una congettura poiché non è possibile ricavare il dato dalle fonti; è
209
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 51s. sul fiume come segno confinario.
Hdt. V 94.1.
211
Aristot. Ath. Pol. 19.5. G. Nenci esprime la difficoltà di risalire, oltre il 510, alla ricostruzione dell’origine di
questa alleanza: NENCI 2006, p. 250.
212
Hdt. VI 108; Thuc. III 68. WELLS 1905, pp. 199s.; HOW-WELLS 1928, ad Hdt. VI 108; ANDREWES 1982 b, pp.
402s.; FROST 1984, p. 292; SORDI 1958, pp. 54-84. Vd. infra, pp. 320ss.
213
Aristot. Ath. Pol. 17.3. STAHL 1895, p. 384; WILCKEN 1897, p. 480. SORDI 1958, pp. 54-84; RHODES 1981, pp.
225s. rifiuta invece l’identificazione Egesistrato-Tessalo, perché la considera derivante dalle controversie
storiografiche intorno all’assassinio di Ipparco.
214
SANDYS 1912 p. 69; HOW-WELLS 1928, ad Hdt. v 94; SORDI 1958, pp. 54-84; ANDREWES 1982 b, pp. 402s.;
HERMAN 1987, p. 21; HERMAN 1990, pp. 349, 353-355, 361.
215
L’alleanza fra Pisistratidi e Tessali è collocata alla metà del VI secolo anche dagli studi sulla storia della Beozia
e della Tessaglia: BUCK 1972; BUCK 1979, pp. 107-120.
210
102
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
peraltro possibile che, trattandosi appunto di un soprannome, gli sia stato assegnato negli anni
successivi alla sua nascita e giovinezza: un momento appropriato potrebbe identificarsi appunto
quando l’assistenza militare dei Tessali fu cruciale per la difesa di Atene, nel 511; oppure
durante quel periodo di intesa strutturale fra Atene e Tessali, sopra delineato, risalente al 519. In
questa prospettiva d’altronde, per capire l’origine e la collocazione cronologica del soprannome
straniero di Egesistrato, può essere utile cercare una circostanza storica adeguata nella quale i
Pisistratidi avrebbero potuto voler esprimere la propria gratitudine e vicinanza ai Tessali: la
cruciale battaglia di Pallene mi pare si presti in maniera del tutto appropriata e meglio delle date
con cui si è mossa l’obiezione poc’anzi esposta.
In conclusione si potrà pure considerare una speculazione, e legittimamente rifiutare, la
ricostruzione secondo cui Egesistrato dovette necessariamente ricevere il proprio soprannome
nei primi anni di vita: la conseguenza sarà quella di abbassare a dopo il 560 ca. l’inizio
dell’intesa fra Pisistratidi e Tessali216. Nondimeno rimane da spiegare l’esistenza di quel
soprannome e mi pare che la ricostruzione più logica sia quella di considerare che i Tessali
abbiano fornito un contingente o un contributo finanziario a Pisistrato in occasione del suo
rientro ad Atene nel 546 e conseguentemente i Pisistratidi avrebbero preservato memoria di
quell’alleanza nella propria onomastica familiare. Mi pare dunque che le considerazioni fin qui
esposte siano sufficientemente ragionevoli per collocare i Tessali fra quegli alleati dei
Pisistratidi che le fonti hanno lasciato senza nome.
I mercenari traci
Nel periodo 556-546 Pisistrato trascorse un periodo di esilio in Tracia ove fondò un
insediamento personale nella regione mineraria del Pangeo. Le fonti sono al corrente del fatto
che in Tracia Pisistrato raccolse ingenti ricchezze in metalli preziosi, le quali andarono a
stipendiare truppe mercenarie tracie217. Malgrado dunque non figurino esplicitamente nel
racconto di Pallene, dobbiamo accettare che i mercenari traci fedeli a Pisistrato siano andati a
costituire un elemento importante del suo schieramento.
La questione dello status e della cronologia di Egesistrato
La notizia del ruolo di Egesistrato in qualità di condottiero del contingente argivo nella
battaglia di Pallene, nel 546, impone di trattare due serie di problemi fra loro legate: una
questione relativa alla posizione e alla legittimità della famiglia argiva di Pisistrato nell’òikos
del tiranno e una seconda questione di carattere cronologico. La figura di Egesistrato è stata
216
217
SORDI 1958, pp. 54-84.
Hdt. I 64. HOPPER 1961, pp. 141-146.
103
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
infatti oggetto di numerose perplessità da parte della critica moderna e mi pare appropriato
valutare le interpretazioni offerte in merito a tali questioni e le loro ricadute nella prospettiva
della presente ricerca.
Per quello che concerne lo status sociale dei figli dell’argiva Timonassa, le fonti
qualificano Egesistrato come nòthos, cioè un figlio illegittimo218. In queste scelte lessicali trova
espressione l’anacronistica preoccupazione che Egesistrato, come il fratello, non avrebbe potuto
godere di pieni diritti di cittadinanza e partecipazione politica ad Atene perché nato da una
donna non-ateniese219; tuttavia la qualifica di nòthos e le limitazioni politiche che comportava
sono delle applicazioni da parte delle fonti di modelli di diritto politico e familiare di epoca
classica, posteriori specificamente alla legge periclea sulla cittadinanza, promulgata nel 451220,
e perciò del tutto inadatte a comprendere la posizione dei figli di Timonassa nel contesto storico
dell’Atene arcaica. Fino alla legge periclea del 451 era infatti sufficiente avere uno dei due
genitori di cittadinanza ateniese per poter essere considerati cittadini; ancor più nel contesto
storico e sociale dell’arcaismo, in cui vissero i tiranni di Atene, i figli di Pisistrato poterono tutti
rientrare pienamente di diritto nell’òikos paterno con pari diritti e prerogative dettate solo dalle
capacità individuali e dal diritto di primogenitura, nonché dalle scelte organizzative di Pisistrato
e dell’òikos stesso. Per l’epoca arcaica, e tanto più per la famiglia tirannica, sarà piuttosto più
utile fare riferimento a modelli tramandati dalla letteratura omerica: in questo contesto storicosociale vigeva d’altronde un regime poligamico in cui era diffusa l’esogamia, cioè la pratica di
sposare individui di città diverse o lontane, e insieme una distinzione debole fra mogli legittime,
concubine e schiave; i figli delle donne dell’òikos godevano cioè di un proprio ruolo legittimo
indipendentemente
dall’origine
geografica
e
sociale
della
madre221.
La
questione
dell’ascendenza, dell’appartenenza alla cittadinanza e della fruizione di diritti politici assunse
importanza solo con la fine della tirannide e l’ampliamento alla partecipazione politica,
nell’epoca classica, e poi con le limitazioni introdotte dall’azione legislativa periclea del 541222.
218
Hdt. V 94; Aristot. Ath. Pol.17.3. Erodoto è esplicito nelle proprie definizioni: παῖδα τὸν ἑωυτοῦ νόθον
Ἡγησίστρατον; Aristotele qualifica Egesistrato e il fratello altrettanto chiaramente pur nell’opposizione ai figli nati
dalla moglie ateniese del tiranno: ἦσαν δὲ δύο µὲν ἐκ τῆς γαµετῆς Ἱππίας καὶ Ἵππαρχος, δύο δ᾽ ἐκ τῆς Ἀργείας
Ἰοφῶν καὶ Ἡγησίστρατος, ᾧ παρωνύµιον ἦν Θέτταλος. La testimonianza di Tucidide è più problematica poiché
non conosce i nomi di Egesistrato e Iofonte, ma, seguendo testimonianze epigrafiche del suo tempo, inserisce
Tessalo, alias Egesistrato, in un elenco di cui fanno parte Ippia e Ipparco, figli legittimi del tiranno: Thuc. VI 55.
219
HOW-WELLS 1928, ad Hdt. V 94.
220
Aristot. Ath. Pol. 26.4; Plut. Per. 37.3. VAN LEEUWEN et alii 1891, p. 226; COX 1998, p. 73; PATTERSON 2005.
221
K.J. Beloch accettò la legittimità di Egesistrato non tanto sulla base di questa contestualizzazione storicosociale, ma piuttosto sul presupposto del nobile rango della madre Timonassa: acutamente la sua analisi propone il
caso affine di Clistene figlio di Megacle Alcmeonide, nato da madre sicionia eppure politicamente attivo, vd.
BELOCH 1913, pp. 298s. Sullo status delle mogli in epoca arcaica e nella cultura greca: BRINDESI 1961, pp. 1-27;
VERNANT 1973.
222
VERNANT 1973.
104
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Così dunque si può giustificare la notizia tramandata da Tucidide sui figli di Pisistrato; lo
storico sostiene di avere visto egli stesso sull’acropoli ateniese una stele ove si tramandavano i
nomi dei tiranni e le ingiustizie da loro compiute (στήλη περὶ τῆς τῶν τυράννων ἀδικίας) e nella
quale si menzionavano tre figli legittimi di Pisistrato: Ippia, Ipparco e Tessalo223; Aristotele
d’altro canto ci informa che Tessalo altro non era che il soprannome (paronýmion) di
Egesistrato224.
Un’interpretazione di queste fonti concilia i dati tramandati: è stata avanzata infatti la
proposta di accettare, per un verso, l’originaria condizione di illegittimità di Egesistrato, in virtù
della sua nascita fuori da Atene e della precedenza di cui dovettero godere i figli ateniesi Ippia e
Ipparco; per altro verso, si è assegnata l’origine del soprannome “Tessalo” di Egesistrato ad un
procedimento di legittimazione del giovane di origine straniera entro le strutture socio-politiche
di Atene, in conseguenza del quale egli avrebbe appunto assunto il secondo nome. Cosicché si
darebbe conto anche dell’iscrizione di Tessalo accanto a Ippia e Ipparco nel decreto di atimìa
visto da Tucidide225. L’origine del soprannome Tessalo è universalmente attribuita ai buoni
rapporti che legavano Pisistrato ai Tessali226: la pratica di assegnare ai figli il nome di alleati,
xènoi o phìloi, era molto diffusa e trova più di una attestazione nelle biografie dei tiranni227.
La notizia della partecipazione di Egesistrato alla battaglia di Pallene pone inoltre un
problema, a mio avviso di più difficile soluzione, di natura cronologica. Si è già avuto modo di
ricostruire la cronologia del matrimonio di Pisistrato con Timonassa di Argo, datandolo al 560
ca.228: ad una data dunque di poco successiva è necessario porre la nascita dei figli Egesistrato e
Iofonte. In base a questo computo tuttavia consegue che il giovane Egesistrato non avrebbe
potuto avere più di 14 anni all’epoca della battaglia di Pallene, nel 546: non posso che trovarmi
d’accordo con buona parte della critica nel ritenere che si tratti di un’età troppo giovane per
assegnare al figlio argivo di Pisistrato un ruolo chiave nel reclutamento e nel comando di un
contingente numeroso ed importante delle forze militari pisistratidi. Si consideri peraltro che 14
anni costituiscono il termine massimo a cui le fonti ci consentono di spingere l’età di
223
Thuc. I 20, VI 55. SANDYS 1912, p. 69; HOW-WELLS 1928, ad Hdt. V 94; CARTWRIGHT-REX 1977, p. 242.
Aristot. Ath. Pol. 17.3. STAHL 1895, p. 384; WILCKEN 1897, p. 480. P.J. Rhodes rifiuta invece l’identificazione
Egesistrato-Tessalo, perché la considera derivante dalle controversie intorno all’assassinio di Ipparco: RHODES
1981, pp. 225s.
225
Thuc. VI 55. L’interpretazione fu avanzata da J. Töpffer, poi ripresa da W.W. How e J. Wells nel loro
commento ad Erodoto: TÖPFFER 1897, pp. 251s.; HOW-WELLS 1928, ad Hdt. V 94. Opinione contraria esprime A.
Andrewes in virtù del fatto che la stele menzionata da Tucidide (Thuc. VI 55) non prova di fatto l’iscrizione di
Egesistrato in una fratria ateniese: ANDREWES 1982 b, p. 401.
226
SANDYS 1912 p. 69; HOW-WELLS 1928, ad Hdt. V 94; BUCK 1972, p. 94; BUCK 1979, pp. 107s.; ANDREWES
1982 b, pp. 402s.; SORDI 1958, pp. 54-84.
227
HERMAN 1987, p. 21; HERMAN 1990, pp. 349, 353-355, 361.
228
Vd. supra, pp. 64ss.
224
105
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Egesistrato nel 546; tuttavia è possibile che egli fosse ancor più giovane nel caso che Pisistrato
non avesse sposato Timonassa nel primissimo anno di tirannide o che la coppia avesse tardato
nel generare eredi.
Una diffusa soluzione a questa contraddizione considera la notizia semplicemente
un’invenzione della tradizione, dovuta al nome stesso del figlio argivo di Pisistrato, poiché
Hegesìstratos significa “condottiero di soldati”: dunque le fonti avrebbero registrato la notizia
del contingente proveniente da Argo e vi avrebbero associato la presenza del figlio del tiranno
proveniente da quella polis in virtù del significato del suo nome229.
Mi pare onesto d’altro canto, a questo punto, ricordare l’esistenza di numerose
ricostruzioni della cronologia delle tirannidi e degli esìli di Pisistrato, diverse da quella che è
parso corretto adottare a chi scrive, alcune delle quali abbassano il calcolo della data di Pallene
fino al 529230: è evidente che abbassando la data della battaglia di Pallene, e conservando la
data del 560 ca. per la nascita di Egesistrato, diviene senz’altro più plausibile l’intervento di
quest’ultimo al comando dei connazionali, all’età di una trentina di anni.
Colgo l’occasione di questa ricerca per proporre una soluzione al problema della
cronologia e dell’età di Egesistrato volta a preservare quanto più possibile delle parole
tramandate dalle fonti sulla famiglia dei tiranni e sugli eventi di Pallene e, al contempo,
rispettare la cronologia che sulla base delle fonti è parso corretto seguire: propongo dunque di
riflettere sulla possibilità che Egesistrato fosse figlio non di Pisistrato, ma di Timonassa e del
precedente marito, Archino d’Ambracia, e che il giovane argivo fu adottato da Pisistrato dopo il
matrimonio con Timonassa231. Questa ipotesi nasce dal tentativo di rispettare i seguenti
presupposti: è innegabile la cronologia del matrimonio di Pisistrato e Timonassa nel 560 ca.; si
vuole accogliere la notizia della partecipazione di Egesistrato alla battaglia di Pallene; ci si
vuole attenere alla cronologia adottata per l’ultima tirannide di Pisistrato e dunque la datazione
della battaglia di Pallene al 546; rimane forte la perplessità rispetto alla possibilità per un
giovane di non più di 14 anni organizzare e condurre un esercito di 1.000 opliti dal Peloponneso
all’Attica e tantomeno di comandarne poi le azioni in battaglia. In base a quest’ultimo punto, è
necessario dunque che Egesistrato fosse vicino all’età adulta nel 546; eppure il testo di
Aristotele è molto chiaro e preciso nel collocare il matrimonio di Pisistrato e Timonassa durante
229
BELOCH 1913, pp. 298s.; HOW-WELLS 1928, ad Hdt. V 94; DAVIES 1971, p. 449; RHODES 1981, pp. 199, 227;
ANDREWES 1982 b, pp. 399-403; LAVELLE 2005, pp. 203s.; NENCI 2006, pp. 300s. Sul positivo auspicio di questo
antroponimo: Hdt. IX 91.
230
SANDYS 1912, pp. 55-70.
231
Questa ipotesi ricostruttiva può considerarsi come una revisione, o una versione modificata, di quella proposta
da J. Töpffer e dai commentatori W.W. How e J. Wells: TÖPFFER 1897, pp. 251s.; HOW-WELLS 1928, ad Hd. V
94.
106
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
la prima tirannide, oppure il primo esilio. Mi pare del tutto plausibile d’altronde che Timonassa
avesse avuto dei figli con il precedente marito: le fonti sono del tutto chiare nello specificare
che ella prendeva Pisistrato in seconde nozze232. Cosicché propongo una ricostruzione che
permetterebbe di risolvere le contraddizioni cronologiche rimanendo fedeli ai testi delle nostre
fonti: Egesistrato sarebbe nato prima del 560, dal matrimonio di Timonassa con Archino di
Ambracia, della famiglia dei Cipselidi; quando Pisistrato sposò la giovane argiva egli accolse
nel proprio òikos non solo la moglie ma anche il figlio di primo letto di questa; in un secondo
momento il tiranno ateniese avrebbe preso Egesistrato in adozione secondo le istituzioni
ateniesi e lo avrebbe inserito a pieno titolo nella propria famiglia e nella propria fratria; con
quel cerimoniale Egesistrato avrebbe assunto il secondo nome di Tessalo, col quale venne in
effetti iscritto nei registri della sua polis di adozione.
Questa ricostruzione ha il vantaggio di rendere conto di molteplici aspetti finora rimasti
contraddittori o controversi. È innanzitutto risolto il problema di conciliare l’età di Egesistrato
con la datazione della battaglia di Pallene, poiché si attribuisce all’Argivo una data di nascita
antecedente al 560 e conseguentemente, nel 546, egli sarebbe stato più vicino alla maggiore età
e in possesso di capacità fisiche e intellettive concordi al ruolo che le fonti gli attribuiscono
effettivamente in quella occasione. Se accettiamo che Egesistrato sia nato fuori dalla famiglia
pisistratide e sia stato poi adottato in un secondo tempo, diventa possibile dare conto della
qualifica di illegittimità che le fonti tramandano: non si tratterebbe più, o non più soltanto, di un
anacronismo degli storici di epoca classica, ma piuttosto andrebbe interpretata nei termini della
preservazione di un nucleo di informazioni relative all’origine e alla nascita dell’Argivo sulle
quali la tradizione non riuscì mai però a fare completa luce. Infine questa ricostruzione
contestualizza l’attribuzione del doppio nome Egesistrato-Tessalo. Non sarebbe in effetti
necessario giustificare l’esistenza di un secondo nome, poiché la sovrapposizione di
soprannomi e attributi non è sconosciuta alla cultura greca233; tuttavia il caso di EgesistratoTessalo pare significativo perché trasmesso non solo nella tradizione orale e poi storiografica,
ma anche nella produzione epigrafica e ufficiale della polis post-tirannica, come osservò
Tucidide234, e in quest’ultima è il nome Tessalo a comparire come unico termine, piuttosto che
come soprannome nel binomio Egesistrato-Tessalo. Queste caratteristiche impongono a mio
avviso di rendere conto del cambiamento del nome e della sua trasmissione, del valore legale
232
Aristot. Ath. Pol. 17.4.
RIX 2010, s.v. “Personal names”, in BNP.
234
Thuc. I 20, VI 55.
233
107
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
della stele sulle adikìai dei tiranni osservata da Tucidide e del contesto in cui il nome fu
introdotto: a tutti questi requisiti l’ipotesi proposta dell’adozione risponde adeguatamente.
Merita riprendere dunque, alla luce della ricostruzione ora proposta, quelle motivazioni
politiche ed ideologiche che si sono già attribuite a Pisistrato nella scelta di stringere l’alleanza
matrimoniale con Gorgilo di Argo235. Nella conduzione della politica estera ateniese della fine
del VII sec. e della prima metà del VI si è individuata infatti una fazione che vedeva
favorevolmente Atene proiettata nell’attività marittima e nella navigazione nell’Egeo, dunque
necessariamente anti-megarese, che caldeggiava una soluzione violenta contro quella polis
vicina, e conseguentemente filo-corinzia. Pisistrato è stato inserito in questa fazione politica in
virtù del suo ruolo nella sconfitta definitiva di Megara intorno al 565 ca. In virtù del legame di
Pisistrato con la famiglia di Timonassa si è inoltre postulata l’affiliazione del tiranno ateniese
ad un gruppo aristocratico filo-corinzio in politica estera ma anche filo-cipselide nell’autorappresentazione del proprio prestigio. Molteplici indizi portano a ricostruire l’esistenza ad
Atene di un’alleanza fra Pisistrato e la famiglia dei Filaidi236; i Filaidi erano a loro volta legati
alla famiglia dei Cipselidi, gli antichi tiranni di Corinto237; ai Cipselidi è noto che era associata
la famiglia dell’Argivo Gorgilo, per il tramite del matrimonio di Timonassa con il Cipselide
Archino Ambaciota. Sulla base dell’alleanza che i Filaidi e l’òikos di Gorgilo condividevano
con i Cipselidi, si è perciò ricostruito che per il tramite dei Filaidi Pisistrato poté entrare in
contatto ed associarsi alla famiglia di Timonassa ad Argo238. La tendenza filo-cipselide, in
un’epoca in cui la dinastia corinzia aveva chiaramente perso il proprio potere, si spiega, a mio
avviso, con un’aspirazione del nuovo tiranno di Atene a fare parte di quella élite aristocratica di
potere e di prestigio panellenico a cui i Cipselidi erano appartenuti: tramite il matrimonio con
una famiglia precedentemente associata ai Cipselidi, Pisistrato poteva richiamare i fasti e la
tradizione di potere e prestigio associati a quella famiglia tirannica. In questa chiave dunque si
spiegherebbe anche la decisione di accettare e adottare il figlio di primo letto di Timonassa: il
giovane Egesistrato era di fatto l’ultimo discendete della dinastia di Cipselo e Periandro.
Acquisendo questo rampollo nel proprio òikos Pisistrato poteva aspirare a presentarsi come il
protettore di quella discendenza; qualora Egesistrato fosse stato effettivamente l’ultimo
Cipselide, per suo tramite, Pisistrato avrebbe potuto fare leva su alcune della antiche
prerogative ereditarie di quella famiglia nelle proprie relazioni internazionali.
235
Vd. supra, pp. 64ss.
Vd. infra, pp. 190ss.
237
ANDREWES 1958, pp. 105s.
238
Vd. infra, pp. 190ss.
236
108
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
Egesistrato non sembra avere avuto un ruolo nella conduzione della politica ateniese e mi
trovo perciò d’accordo con quelle analisi che ritengono che egli sia rimasto ad Argo, con la
madre, finché non fu chiamato alla battaglia di Pallene: dunque per 14 anni dal 560 al 546.
Dobbiamo immaginare che, crescendo, Egesistrato sia andato assumendo un ruolo sempre più
importante nella gestione del potere familiare e politico ad Argo; infine, quando Pisistrato
chiamò a raccolta i suoi alleati in vista del ritorno ad Atene, pare giustificato che in quel
momento, per gli interlocutori argivi, il ruolo di referente sia ricaduto su Egesistrato. Le
vicende vedono Egesistrato rispondere in aiuto di Pisistrato e recarsi in Attica nel 546. Se si
decide di seguire la ricostruzione dell’adozione di Egesistrato da parte di Pisistrato, credo che la
situazione più appropriata per lo svolgimento del rituale di adozione sia da collocarsi poco dopo
la vittoria di Pallene e la presa della tirannide: in quel momento Pisistrato poté legare a sé il
giovane Egesistrato più saldamente, a riprova della fiducia e dell’appoggio dimostrato dal
contributo argivo. La scelta del secondo nome giustifica inoltre la ricostruzione di una presenza
di alleati Tessali fra i contingenti pisistratidi del 546, o perlomeno una qualche forma di aiuto
da parte di questi239.
La condizione di Egesistrato-Tessalo e la sua presenza ad Atene dopo la battaglia,
soprattutto considerando il comando che esercitava sui 1.000 concittadini armati, avrebbero
potuto creare degli attriti nel bilanciamento dei ruoli e del potere dei pisistratidi ateniesi,
particolarmente verso i figli ateniesi di Pisistrato, Ippia e Ipparco. Non mi pare casuale dunque
che Pisistrato abbia di lì a poco affidato proprio ad Egesistrato la difesa dell’insediamento
familiare del Sigeo in Troade: questa scelta dovette costituire la soluzione più appropriata nella
gestione degli interessi familiari. Pisistrato ebbe dunque modo di affidare quel settore delle sue
operazioni ad un individuo di fiducia, verso il quale aveva dimostrato un legame profondo con
la recente adozione; Egesistrato ottenne un ruolo importante e significativo e il comando
personale di un insediamento coloniale ateniese. Malgrado le difficili condizioni in cui si trovò
in Asia e gli incidenti bellici cui dovette provvedere nella difesa del Sigeo, quella posizione
dovette sembrare ad Egesistrato comunque più desiderabile del rimanere ad Argo, dopo che la
polis era stata sconfitta da Sparta proprio nel 546240.
L’ipotesi qui avanzata, della nascita di Egesistrato da Timonassa ed Archino Ambraciota e
della sua successiva adozione da parte di Pisistrato, è chiaramente esposta a delle obiezioni. In
primo luogo, nessuna fonte menziona o discute affatto una notizia di questo genere. Eppure la
memoria storica che preservò la qualifica di nòthos per i figli di Timonassa muoveva con
239
240
SORDI 1958, pp. 54-84. Vd. supra, pp. 102ss.
KELLY 1976, pp. 157s.
109
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte II: Atene e l’ascesa di Pisistrato
l’evidente fine di insinuare il carattere illegittimo del loro ruolo nell’òikos pisistratide; secondo
questo criterio di selezione storiografica, questa medesima tradizione avrebbe potuto trarre
maggior vantaggio nel registrare la nascita di Egesistrato da due genitori non-ateniesi. Da un
altro punto di vista, queste fonti ostili ai tiranni potrebbero avere avuto validi motivi per
scegliere di ignorare la notizia dell’adozione e preferirvi quella della nascita semi-ateniese:
questa versione delegittimava irrimediabilmente la posizione giuridica di Egesistrato, agli occhi
dei nostri autori e del loro pubblico di V secolo; al contrario, l’atto di adozione che si è qui
postulato avrebbe avuto pur sempre un valore legale che poneva l’argivo sotto la paternità
legale di Pisistrato, rendendolo un legittimo componente dell’òikos pisistratide e della
cittadinanza ateniese.
La mancanza di notizie relative all’adozione di Egesistrato e la condizione della tradizione
preservata potrebbero inoltre spiegarsi non in termini di una progettualità storiografica quanto
piuttosto di una semplice confusione. I testimoni che vissero gli eventi di Atene alla metà del
VI secolo e che li tramandarono poi agli storici di V secolo dovettero evidentemente
considerare Egesistrato come un figlio naturale di Pisistrato: dovremo perciò ritenere che
l’argivo nacque prima del 560, ma non a molti anni di distanza. Se infatti si fosse presentato a
Pallene un adulto al comando del contingente argivo, non si comprende come si sarebbe potuta
conservare la tradizione della paternità di Egesistrato da Pisistrato e Timonassa: i testimoni non
avrebbero cioè mai potuto pensare che il condottiero argivo fosse figlio di Pisistrato. Se si è
conservata la tradizione della paternità di Pisistrato, e se si vuole tentare di rispettare il
complesso delle fonti, si dovrà ritenere che l’età e l’aspetto di Egesistrato corroborassero
l’attribuzione della paternità a Pisistrato: Egesistrato dunque non era più un ragazzino, ma
doveva essere ancora abbastanza giovane da venire confuso e considerato quale un figlio
naturale di Pisistrato. Si consideri infine a questo riguardo che il matrimonio di Pisistrato e
Timonassa era avvenuto 14 anni prima della battaglia di Pallene e che quel ramo della famiglia
era rimasto, come si è ricostruito, ad Argo in quel lasso di tempo; inoltre, dopo Pallene,
Egesistrato rimase per un periodo piuttosto breve ad Atene e fu presto insediato da Pisistrato al
Sigeo: mi pare che questa distanza temporale e geografica possa contribuire a giustificare la
confusione inseritasi nella fonti in merito alla paternità di Egesistrato e alla sua età.
110
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
PARTE III: GLI ALCMEONIDI, OPPOSITORI DEI PISISTRATIDI
Prima di affrontare l’analisi delle iniziative di politica estera attuate da Pisistrato durante
la sua tirannide, merita discutere della storia di un’altra famiglia aristocratica ateniese di grande
eminenza: gli Alcmeonidi. Come si è già avuto modo di notare, la storia della tirannide ad
Atene, e in genere tutta la storia politica ateniese, si lega infatti indissolubilmente alle iniziative
di questa potente famiglia aristocratica che fu uno dei principali avversari del potere dei
Pisistratidi1. Gli Alcmeonidi inoltre costituiscono un caso di studio significativo per questa
ricerca poiché per tutta la storia arcaica dimostrarono un intenso impegno nell’operare sul piano
internazionale: cosicché le iniziative degli Alcmeonidi e la loro posizione nel sistema
internazionale determinano, per difetto, le aree e i soggetti rimasti avversi o non accessibili alla
rete di relazioni dei Pisistratidi.
III.1. Gli Alcmeonidi contro Cilone e la condanna della famiglia
La famiglia aristocratica degli Alcmeonidi ebbe indubbiamente un ruolo negli eventi del
fallito tentativo tirannico di Cilone, nel 636: in quell’occasione, gli attentatori alla tirannide
furono assediati sull’acropoli e poi uccisi a tradimento dagli Ateniesi sotto il comando
dell’arconte Megacle I, della famiglia degli Alcmeonidi. Secondo la narrazione preservata dalle
fonti, Cilone e i suoi compagni di eteria occuparono con successo l’acropoli, ma si ritrovarono
presto assediati entro le mura Pelargiche poiché la cittadinanza era accorsa dalla campagna e
non accettava quell’iniziativa violenta. L’assedio si protrasse a lungo cosicché le autorità
politiche furono incaricate di mantenere le posizioni; in quel momento gli Alcmeonidi
occupavano una posizione di comando entro la polis. Su questo punto le fonti assegnano
unanimemente la responsabilità della risoluzione violenta della crisi alla famiglia degli
Alcmeonidi, ma non concordano in merito a quale magistratura ricevette l’incarico: Erodoto
attribuisce il comando dell’azione statale al collegio dei pritani dei naucrari, mentre Tucidide
menziona il collegio dei nove arconti2. Il motivo di questa incertezza storiografica è senz’altro
da attribuirsi all’antichità delle informazioni giunte ai nostri storici, alla difficoltà di
comprensione che essi ebbero nel raffrontarsi con le istituzioni e le magistrature della polis
arcaica e alla tendenza a modernizzare anacronisticamente soggetti politici precedenti entro il
1
2
URE 1922, pp. 64-67.
Hdt. V 71; Thuc. I 126. Prandi 2000, pp. 1-12.
111
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
quadro sociale e istituzionale a loro contemporaneo; entrambe le magistrature risalgono
comunque ad epoca arcaica3. Indipendentemente dalla versione che si voglia considerare più
attendibile, non si può ignorare la tradizione che attribuisce all’alcmeonide Megacle I il ruolo di
arconte e la responsabilità nella scelta di risolvere violentemente la crisi ciloniana4:
considerando inoltre la responsabilità e il sacrilegio attribuiti alla famiglia dalla tradizione
letteraria, mi pare dunque si renda inevitabile accettare come storicamente fondata la
responsabilità di Megacle stesso nel massacro dei Ciloniani5.
I Ciloniani cessarono infine di resistere e si dichiararono supplici presso i santuari
poliadi6; ciononostante gli arconti, sotto il comando degli Alcmeonidi, li fecero uccidere.
Tucidide registra che Cilone stesso e suo fratello riuscirono a fuggire. Poiché gli Alcmeonidi
non rispettarono la sacralità della condizione di supplici dei Ciloniani e le disposizioni di
comportamento dettate per le aree sacre, la famiglia si macchiò di sacrilegio (enagès) e fu
odiata (emisèo). È da questo episodio che originò dunque quell’accusa che influenzò la
successiva storia di Atene. La fazione di Cilone riprese forza e negli anni successivi alla crisi
politica del 636 la contrapposizione fra i Ciloniani sopravvissuti (τῶν Κυλωνείων οἱ
περιγενόµενοι) e gli Alcmeonidi (τοὺς ἀπὸ τοῦ Μεγακλέους) seguitò ad infiammare la lotta
politica entro la polis7. Solone intervenne poi a sedare quella situazione che avrebbe potuto
facilmente sfociare in una lotta civile; egli convinse gli Alcmeonidi a sottomettersi ad un
processo che avrebbe giudicato le loro azioni in occasione dell’intervento anti-tirannico8: gli
Alcmeonidi furono ritenuti colpevoli e perciò esiliati e anche i morti della famiglia furono
dissepolti e tumulati fuori dal perimetro della città9. Non disponiamo di informazioni per datare
con precisione il processo contro gli Alcmeonidi: ci si dovrà attenere ad una data successiva al
tentativo di Cilone (636) come terminus post quem e ad una data antecedente all’arcontato di
Solone (594) e alla purificazione di Epimenide (596)10 come terminus ante quem11. Prendendo
3
SMITH 1890, s.v. “Naucraria”; FORNARA 1983, n. 22, pp. 26s.. Preferiscono accettare la versione di Erodoto
WRIGHT 1892, pp. 28-33, 55, 71; URE 1922, pp. 326-331; LANG 1967, p. 248. Preferiscono invece accettare la
magistratura individuata da Tucidide MACAN 1895, p. 214; HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 71.
4
Heracl. Lemb. Exc. Polit. f. 2 ; Plut. Sol. 12.1. HOW-WELLS 1928, ad Hdt. VI 125; CADOUX 1948, pp. 91s.; LANG
1967, pp. 246s.; STAHL 1987, pp. 116-119.
5
RAAFLAUB 1996, pp. 1048s. sull’a memoria collettiva del sacrilegio.
6
Hdt. V 70s.; Thuc. I 126; Plut. Sol. 12.1. Le fonti divergono nell’identificare l’area o le aree cultuali presso cui si
svolsero i drammatici eventi. Vd. supra, pp. 27ss.
7
Plut. Sol. 12.2. PRANDI 2000, pp. 13-15.
8
Plut. Sol. 11.1. PRANDI 2000, pp. 15-20. Vd. supra, pp. 27ss.
9
Plut. Sol. 12.2- 13.1.
10
Plat. Leg. 642d; Aristot. Ath. Pol. 1; Plut. Sol. 12.4; Diog. Laert. I 109s.; Euseb. Chron. ap. Hier. p. 175f Helm;
Suda, s.v. Ἐπιµενίδης, E 2471 Adler. Sulla datazione dell’arcontato di Solone: LEVY 1973, pp. 90s.
11
La sequenza narrativa del testo di Plutarco implica un ordine di eventi che vede susseguirsi il tentativo ciloniano,
il processo agli Alcmeonidi, la perdita di Salamina, l’invito ad Epimenide e infine l’arcontato di Solone e
l’amnistia: Plut. Sol. 12.1-14.2, 19.3. ANDREWES 1982 a, p. 369. FORREST 1956, pp. 41s. giustamente distingue il
112
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
in considerazione la notizia sul periodo di lotta politica fra Ciloniani e Alcmeonidi che
intercorse fra il massacro a danno dei primi e il processo contro i secondi, si dovrà, a mio
avviso, spostare la data del processo, e dunque dell’esilio, più verso il secondo dei termini sopra
proposti.
L’esilio degli Alcmeonidi non fu comunque di lunga durata poiché la famiglia poté godere
dell’amnistia promulgata nel 594 da Solone durante il suo arcontato; al contrario ne furono
esplicitamente esclusi i membri fuoriusciti della fazione ciloniana per aver tentato
l’instaurazione della tirannide12. Dunque gli Alcmeonidi ripresero il proprio ruolo politico ad
Atene all’inizio del VI secolo e si ritrovarono nella vantaggiosa posizione di vedere i propri
antichi avversari ciloniani estromessi e politicamente sconfitti13.
La successiva storia della famiglia, a seguito dell’incidente di Cilone, è dunque da
interpretarsi secondo due termini antitetici: da un lato, l’affermazione del potere politico ad
Atene e nella Grecia, dopo la crisi conclusasi con l’arcontato di Solone; d’altro canto, il peso
morale della condanna di empietà che si prestò in successive occasioni a venire politicamente
strumentalizzata a scapito della famiglia14.
III.2. L’inizio dei rapporti favorevoli con il santuario di Delfi
Gli Alcmeonidi e il santuario di Delfi: la svolta della Prima Guerra Sacra (595-591)
Alcmeone era figlio di Megacle I e fu lo stratego al comando del contingente ateniese
nella Prima Guerra Sacra contro la città di Crisa che, secondo la tradizione, minacciava il
santuario di Delfi. Questo conflitto ebbe luogo nel periodo 595-591, con conseguenze fino al
586, e vide formarsi un’alleanza fra Ateniesi, Sicioni e Tessali a favore del santuario di Delfi15.
Si consideri che antecedentemente alla Prima Guerra Sacra, prima della fine del VII secolo, il
santuario delfico aveva appoggiato la posizione di Cilone, evidentemente a scapito delle altre
famiglie aristocratiche ateniesi; è possibile peraltro che l’emergere ad Atene di un sentimento di
condanna politico-morale contro gli Alcmeonidi sia da imputarsi anche all’autorità del responso
processo agli Alcmeonidi dalla purificazione di Epimenide, poiché il primo fu un procedimento legale contro la
famiglia, mentre la seconda fu un rito religioso a favore della polis. PRANDI 2000, p. 19s. propone le date del 599 o
595.
12
Plut. Sol. 19.3. NENCI 2006, p. 262.
13
WRIGHT 1892, pp. 5-8, 42s.; MANFREDINI-P ICCIRILLI 1998, pp. 218-220; PRANDI 2000, pp. 13-20; NENCI 2006,
pp. 261s.; ANDREWES 1982 a, pp. 368s.
14
RAAFLAUB 1996, pp. 1048s.; PRANDI 2000, pp. 12-15.
15
Mar. Par. FGrHist 239 A 37; Paus. II 9.6, X 37.2; Plut. Sol. 11.1s. DEMPSEY 1918, p. 164; CADOUX 1948, pp.99101; FORREST 1956, soprattutto pp. 3s.; SORDI 1958, pp. 39-60; ANDREWES 1982 a, pp. 374s.; NOUSSIA 2001, p.
16. Sulla ricostruzione della Prima guerra sacra e i difficili problemi storiografici ad essa relativi: FORREST 1956;
SORDI 1958, pp. 51-58; ROBERTSON 1978; FORREST 1982 b, pp. 305s.; DAVIES 1994.
113
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
delfico e alla scelta di parte operata dai sacerdoti nel 63616. La risoluzione del conflitto
dell’anfizionia contro Crisa portò ad un rovesciamento della posizione del santuario di Delfi nei
confronti degli Alcmeonidi poiché da quel momento, e per tutto il VI secolo, questa famiglia
sviluppò una relazione di reciproco appoggio con i sacerdoti pitici17. Come la sanzione delfica a
favore di Cilone poté influire sull’accusa di empietà e sulla decisione dei giudici in occasione
del processo agli Alcmeonidi, poco prima del 595, così la loro inclusione nell’amnistia
soloniana e la loro reintegrazione nel tessuto sociale ateniese potrebbe essersi giovata di un
consenso tacito della nuova autorità del santuario18. Fra la nobile famiglia ateniese e il santuario
di Delfi si instaurò da questo momento in avanti un rapporto di appoggio reciproco, evidente
nel corso di tutto il VI sec., che fu fra le cause della caduta della stessa tirannide ateniese e del
successo infine del noto riformatore democratico Clistene.
Gli Alcmeonidi come intermediari presso Delfi per i sovrani di Lidia
Oltre alla partecipazione alla Prima Guerra Sacra in difesa del santuario, esiste
un’ulteriore notizia che potrebbe attestare l’esistenza di una relazione significativa fra
Alcmeone e l’oracolo di Delfi: Erodoto conserva infatti la tradizione secondo cui il celebre
Alcmeonide prestava il proprio aiuto e le proprie premure quando giungevano gli incaricati del
sovrano lidio Creso ad interrogare l’oracolo19. È doveroso osservare che il testo erodoteo è
guastato da un anacronismo poiché Alcmeone e Creso non poterono essere coevi: all’epoca
dell’attività di Alcmeone, all’inizio del VI secolo, il sovrano di Lidia era Aliatte (610-561);
mentre quando regnò Creso, nel periodo 561-546, l’esponente attivo degli Alcmeonidi era
Megacle II, figlio di Alcmeone. La critica accetta dunque con un elevato grado di cautela questa
notizia20. La notizia perde ulteriormente credibilità quando analizzata nel contesto narrativo e
testuale delle Storie: Erodoto la presenta infatti per rendere conto al proprio pubblico
dell’origine e della ragione della fama e della ricchezza degli Alcmeonidi; la narrazione
prosegue infatti spiegando che Creso volle ricompensare Alcmeone delle cure prestate ai propri
emissari e lo invitò a Sardi affinché accettasse in dono tanto oro quanto egli fosse in grado di
portare sulla propria persona21; cosicché il paragrafo successivo descrive la comica immagine di
Alcmeone che sagacemente veste abiti larghissimi, giunge a riempirsi la bocca d’oro e ad uscire
dalla sala del tesoro trascinando a fatica i calzari colmi: da quell’episodio, secondo Erodoto,
16
Thuc. 126.4. FORREST 1956, pp. 39-41, 48-52.
FORREST 1956, pp. 39-41, 48-52; ANDREWES 1982 a, pp. 360-362, 374s.
18
PRANDI 2000, pp. 15-18.
19
Hdt. VI 125.
20
RAWLINSON 1858, v.III, p. 512; WRIGHT 1892, pp. 42, 50-52; HOW-WELLS 1928, ad Hdt. VI 125.
21
THOMAS 1989, pp. 146s. ritiene che la storia sia del tutto infondata, costruita da Erodoto su fonti di parte
alcmeonide appunto con lo scopo di giustificare la ricchezza della famiglia:
17
114
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
ebbe dunque origine la straordinaria ricchezza della famiglia22. È evidente che qui lo storico
utilizzò quanto egli aveva raccolto riguardo alla tradizione aneddotica sugli Alcmeonidi e ai
rapporti della famiglia con i regni orientali insieme alla comune nozione della loro ricchezza
per comporre una situazione umoristica fondata sulla comicità delle stesse immagini e sul
motivo del personaggio che contravviene e supera con scaltrezza le limitazioni imposte tramite
un espediente23.
Non volendo rifiutare interamente la storicità di questa notizia, la critica ha trovato
necessario correggere l’informazione di Erodoto secondo due diverse ipotesi ricostruttive24: i
contatti internazionali di Alcmeone devono essere attribuiti all’indirizzo del coevo sovrano lidio
Aliatte, padre e predecessore di Creso25; altrimenti, viceversa, si può conservare il ruolo di
Creso, ma diviene necessario trasferire la responsabilità della relazione a Megacle II, figlio di
Alcmeone e successore nella conduzione della famiglia26. Personalmente concordo con questi
studiosi nel tentare di rendere conto di questa notizia e di inserirla entro un quadro storico dei
rapporti degli Alcmeonidi con il santuario delfico che si va delineando per il VI secolo; in
particolare, alcune considerazioni incoraggiano, a mio avviso, ad accettare la prima delle due
ipotesi sopra delineate per la rilettura storica dell’episodio erodoteo. Si è già fatto notare che
Alcmeone era stato uno dei protagonisti dell’alleanza multilaterale che soccorse il santuario
delfico nella contesa contro Crisa in occasione della Prima Guerra Sacra, nel 595-591 ca., e che
questa iniziativa segnò una svolta costruttiva nei rapporti fra la famiglia ateniese e il
santuario27: il ruolo di Alcmeone in questo conflitto concorda con l’attribuzione a lui, piuttosto
che al figlio Megacle II, di una posizione di rappresentanza o di ospitalità presso il santuario
che gli avrebbe consentito di intercedere in favore degli emissari lidi. Nel 596 ca. si è collocato
il processo contro gli Alcmeonidi che ne sancì l’esilio da Atene; pochi anni dopo la famiglia
poté godere dell’amnistia promulgata da Solone durante il suo arcontato del 59428. Nonostante
la breve durata dell’esilio, perlomeno alcuni membri della famiglia dovettero in effetti
trascorrere un periodo fuori da Atene: in questo intervallo troverebbe dunque appropriata
collocazione la visita di Alcmeone presso la corte di Sardi, di cui parla Erodoto, nonché la
22
Hdt VI 125s.
Questa è l’abilità che il pensiero greco ammirava nella mètis del paradigmatico eroe Odisseo: VISSER 2010, s.v.
“Odysseus” in BNP. HOW-WELLS 1928, ad. Hdt. VI 125; STADTER 2006, pp. 242, 248s.
24
Alcuni critici non ritengono di poter prendere una posizione determinata riguardo alle due cronologie proposte,
ma accettano nondimeno la notizia come una prova dell’esistenza di relazioni internazionali fra gli Alcmeonidi e i
sovrani mermnadi nel VI secolo e come prova di una posizione speciale della famiglia ateniese a Delfi: MACAN
1895, vol. I, p. 359; HOW–WELLS 1928, ad Hdt. VI 125.
25
WRIGHT 1892, pp. 50-56; FORREST 1956, p. 51.
26
RAWLINSON 1859, v. III, p. 512; GOODLEY 1922, vol. III, p. 279; NENCI 2006, pp. 247s.
27
ANDREWES 1982 a, p. 374s.
28
PRANDI 2000, pp. 15-20.
23
115
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
presenza dello stesso a Delfi. La pratica di consultare i santuari ellenici chiedendo delucidazioni
oracolari e dedicando offerte è ampiamente attestata presso i sovrani lidi; nondimeno la
possibilità di costruire tesori entro le aree sacre era una prerogativa esclusa ai barbari orientali:
è plausibile perciò che i postulanti orientali avessero bisogno di una qualche forma di
intermediazione culturale e linguistica nel rivolgersi al clero ellenico, soprattutto in aree della
Grecia continentale come è quella di Delfi29. Le donazioni al santuario delfico di Aliatte30 e del
successore Creso31 sono ampiamente documentate nelle fonti antiche32. Fra i monarchi di Lidia,
Creso giunse a rappresentare nell’immaginario greco il paradigma del sovrano dalle ricchezze
smisurate e amante delle compagnia di Greci saggi e sagaci: perciò mi pare plausibile che
Erodoto, giunto in possesso di una informazione frammentaria sui remunerativi rapporti
internazionali degli Alcmeonidi con la Lidia, abbia ritenuto corretto attribuire quelle notizie
appunto a Creso piuttosto che ad altri sovrani della medesima dinastia33. Si consideri infine che
Erodoto dimostra una notevole imprecisione nella cronologia dell’alto VI secolo e dei sovrani
lidi del tempo e questo può avere dato adito all’anacronistica attribuzione a Creso, piuttosto che
ad Aliatte, dell’incontro di Alcmeone a Sardi e della sua funzione di intermediazione a Delfi34.
Parte della critica ha voluto rendere ragione del nesso che lo stesso Erodoto pone fra
l’episodio presso la corte lidia e l’origine della ricchezza della famiglia: è possibile che la
grande disponibilità finanziaria degli Alcmeonidi giungesse effettivamente da redditizi contatti
familiari con i sovrani lidi da intendersi non solo sotto l’aspetto di relazioni di amicizia e
ospitalità, ma soprattutto sotto l’aspetto di vantaggiose imprese commerciali che la famiglia
poté portare a termine in Anatolia proprio grazie all’appoggio della corte35; il rapporto
privilegiato con il santuario delfico poté inoltre mettere a disposizione degli Alcmeonidi le
risorse finanziarie dei templi e dei tesori dedicati al dio, all’inizio come per tutta la durata del
secolo e del loro antagonismo contro i Pisistratidi36. Quanto si è ora discusso in merito ai
legami di Alcmeone con Delfi e con Aliatte trova appropriata collocazione cronologica
29
MIDDLETON 1888, pp. 308s.; DYER 1905, pp. 308-310. FORREST 1982 b, p. 318; HERMAN 1987, pp. 28s., 46s.,
89, 73-106; DOPICO CAINZOS 1997, p. 530; MAZZARINO 2007, p. 186. In maniera non dissimile dal caso di
Alcmeone, anche per Periandro e i tiranni cipselidi di Corinto si può ricostruire la posizione di mediatori culturali e
religiosi a favore dei Mermnadi presso il santuario di Delfi: OLIVIERI 2010; vd. infra, pp. 203ss.
30
Hdt. I 25; Paus. X 16.1-2; Ath. V 45, XIII 72 . FORREST 1982 b, p. 318.
31
Hdt. I 50-52, 54, 92; Paus. X 8.7.
32
POULSEN 1920, pp. 71s.
33
WRIGHT 1892, pp. 51-53. La tradizione conserva notizie di una visita di Solone presso la corte di Creso: Hdt. I
29-33; Plut. Sol. 27.1-7.
34
WRIGHT 1892, p. 52; MACAN 1895, vol. I, p. 359; WILL 1955, pp. 366-371; DOPICO CAINZOS 1997, p. 530.
35
WRIGHT 1892, pp. 51-53; URE 1922, pp. 64s., NENCI 1988, ad Hdt. VI 125, p. 304; NENCI 2006, ad Hdt. V 62,
pp. 245s.
36
DEMPSEY 1918, pp. 84-86; POULSEN 1920, pp. 143s.; DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 95-97, 103, 107-114; SHAPIRO
1989, pp. 49s.; NENCI 2006, ad Hdt. V 62, pp. 245s. Vd. infra, pp. 370ss.
116
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
all’inizio del VI secolo e inserisce la famiglia degli Alcmeonidi entro una rete di contatti
internazionali di ampia portata e di grande prestigio.
Dopo aver legato la ragione della grande ricchezza degli Alcmeonidi al rapporto
privilegiato con il sovrano di Lidia Erodoto chiude il paragrafo notando che fu grazie appunto a
tale ricchezza che Alcmeone poté allevare una squadra di cavalli da corsa per quadrighe
(tethrippotrophèo) con i quali ottenne una vittoria ad Olimpia37. Le fonti scritte tramandano per
gli Alcmeonidi una lunga tradizione di successi agonistici presso i centri cultuali panellenici
enumerando un totale di 9 vittorie fino all’inizio del V secolo38; fra queste l’unica vittoria
olimpica è appunto da attribuirsi ad Alcmeone e da datarsi al 59239. Questo elemento si
aggiunge all’analisi che si va ora sviluppando degli Alcmeonidi nel delineare il profilo di una
famiglia aristocratica ricca e di ampio prestigio, conosciuta per i propri successi entro il circuito
delle élites che frequentavano i santuari panellenici e che partecipavano agli eventi di richiamo
internazionale. Alcmeone, come già suo padre Megacle I, fece parte senz’altro dell’aristocrazia
cittadina ateniese coinvolta nelle decisioni e nella gestione della polis; egli si inserì nel più
ampio circuito aristocratico panellenico, con la sua vittoria olimpica, e guidando l’intervento
ateniese nella Prima Guerra Sacra; inoltre, se risulta efficace l’analisi qui proposta, Alcmeone
ampliò la rete dei contatti familiari entrando in rapporto con la corte dei sovrani di Lidia e
sfruttando ad ulteriore vantaggio la propria posizione a Delfi.
III.3. Il matrimonio di Megacle II con Agariste di Sicione
Nel 576 ca.40 il tiranno di Sicione Clistene invitò i più eminenti aristocratici da tutto il
mondo ellenico a recarsi presso la sua corte per contendersi la mano della figlia Agariste, la
quale sarebbe dunque andata in sposa al Greco che Clistene avesse ritenuto più meritevole. Il
tiranno sicionio favorì i due pretendenti ginti da Atene: Ippoclide, della famiglia dei Fialaidi, e
Megacle, figlio di Alcmeone dell’omonima famiglia. Infine la scelta per l’alleanza
37
Hdt. VI 125. Vero è che fonti successive attribuiscono invece l’origine della ricchezza degli Alcmeonidi
piuttosto alla curatela dell’appalto per la ricostruzione del tempio di Apollo di Delfi, nella seconda metà del VI
sec.: Arisot. Ath. Pol. 19.4; Demosth. Contra Meid. 21.144; Schol. Demosth. Contra Meid. 21.144; Isocr. Antid.
15.232. Ciononostante la critica è concorde nell’accettare una data più alta per la fama e la ricchezza della nobile
famiglia ateniese e nell’accogliere positivamente la testimonianza di Erodoto: DEMPSEY 1918, pp. 85s., 164;
FORREST 1969 a; LLOYD-JONES 1976, pp. 63s.; NENCI 2006, ad Hdt. V 62, p. 247. Vd. infra, pp. 370ss.
38
Pind. Pyth. VII; Isocr. De Big. 16.25. GILDERSLEEVE 1885, pp. 321-323; WRIGHT 1892, pp. 42-57; FORREST
1956, p. 51; MORETTI 1957, n. 47, 81; KINZL 2010, s.v. “Megacles” [4] in BNP.
39
Schol. Pind. Phyth. VII 14. MORETTI 1957, n. 81.
40
WRIGHT 1892, pp. 57-59; CADOUX 1948, p. 104.
117
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
matrimoniale ricadde su Megacle e da questo evento la fama degli Alcmeonidi fu rinomata
presso tutti i Greci41.
L’istituzione di una alleanza interfamiliare fra gli Alcmeonidi e gli Ortagoridi di Sicione
segna un ampliamento della rete dei contatti della già eminente famiglia ateniese; nondimeno
non si tratta di un indirizzo del tutto nuovo poiché è possibile intravedere l’avvio di questa
intesa già all’inizio del VI secolo, all’epoca della generazione di Alcmeone. Fra gli alleati che
nel 595 mossero in soccorso del santuario di Delfi erano infatti Alcmeone da Atene e appunto il
tiranno Clistene di Sicione: è evidente dunque che già all’inizio del VI secolo le due famiglie
avevano preso contatto e avevano probabilmente riconosciuto interessi internazionali comuni
oltre a quelli delle circostanze belliche di quel momento; cosicché, nella generazione
successiva, quell’intesa, prima espressa in un’iniziativa militare congiunta, ebbe modo di
consolidarsi e di esprimersi con un matrimonio interdinastico fra Megacle II e Agariste42.
L’alleanza matrimoniale qui discussa attesta dunque la capacità degli Alcmeonidi di
mantenere, rafforzare ed ampliare costruttivamente la propria posizione di eminenza entro la
società aristocratica panellenica. Riprendendo le osservazioni finora espresse e le ricostruzioni
finora proposte, si delinea per gli Alcmeonidi una rete di relazioni internazionali di lungo
periodo incentrata sui centri del santuario di Delfi, della corte lidia di Sardi e di Sicione43.
L’opposizione di Megacle I al tentativo tirannico di Cilone è stata interpretata come il segno di
una posizione degli Alcmeonidi di ispirazione “marittima” e aperta alle iniziative commerciali
di lungo raggio; questo indirizzo di politica estera si può ritrovare nei contatti che la famiglia
mantenne con i sovrani di Lidia, da intendersi, secondo alcuni studiosi, come un segno
dell’apertura al commercio con le coste micrasiatiche44. Questa è dunque la posizione di
Megacle II e della sua famiglia al momento dell’ascesa politica di Pisistrato nel 565 ca.45: non
deve dunque sorprendere la difficoltà che il tiranno ateniese incontrò nel fronteggiare un tale
avversario politico e nel difendere la propria posizione entro il quadro politico ateniese.
41
Hdt. VI 126-131.
FORREST 1956, pp. 36-41, 48-52; ANDREWES 1982 a, p. 374s.
43
WRIGHT 1892, pp. 6, 42s., 47s., 53-61; DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 95s., 99s., 103, 112.
44
WRIGHT 1892, pp. 50-52
45
WRIGHT 1892, p. 57.
42
118
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
III.4. Le relazioni fra Alcmeonidi e Pisistratidi
Megacle II avversario di Pisistrato: l’alleanza matrimoniale disconosciuta
Si è ricostruita l’ascesa alla fama politico-militare di Pisistrato associandola alle sue
imprese vittoriose nel conflitto contro Megara, nel periodo 570-565 ca.; l’instaurazione della
prima, breve, tirannide è da datarsi al 560. Le fonti delineano per Pisistrato il profilo di un
politico emergente che si mise a capo degli abitanti delle aree montuose dell’Attica
(hyperàkrioi o diàkrioi) e contese il potere alle altre due tradizionali fazioni (stàseis): i Pediaci
(pediakòi), abitanti delle aree cittadine e delle aree pianeggianti e fertili dell’Attica, di
orientamento oligarchico e capeggiati dal nobile Licurgo; e i Paralii (paràlioi), abitanti delle
aree costiere meridionali dell’Attica, politicamente moderati comandati dall’alcmeonide
Megacle II46. Poco dopo che Pisistrato aveva conquistato l’Acropoli con l’aiuto dei suoi
stasiòtai e dei 300 portatori di clava assegnatigli pubblicamente, Megacle e Licurgo misero da
parte le divergenze per scacciare di comune accordo il tiranno. Come la prima tirannide, anche
il primo esilio di Pisistrato fu di breve durata.
Megacle si trovò presto di nuovo in lotta con Licurgo e il suo partito e decise perciò di
cambiare drasticamente la propria strategia politica47: l’Alcmeonide inviò un araldo a Pisistrato
in esilio, offrendogli un accordo secondo il quale Pisistrato avrebbe ripreso la tirannide ad
Atene a patto che sposasse sua figlia48. Il rientro di Pisistrato ad Atene e il suo re-insediamento
al potere supremo furono dunque accompagnati dall’alleanza familiare, nonché da un
espediente religioso-simbolico riguardo al quale lo stesso Erodoto esprime esplicitamente la
propria incredula sorpresa49. Secondo questa narrazione Megacle cedette a Pisistrato il controllo
personale della polis; l’accordo con Megacle comportò senz’altro l’appoggio della fazione
alcmeonide: come la prima espulsione di Pisistrato si era realizzata soltanto con lo sforzo
congiunto di Megacle e Licurgo, così l’accordo fra Pisistrato e Megacle avrebbe consentito loro
di soverchiare Licurgo e gli altri aristocratici ateniesi.
Unica condizione imposta da Megacle per il suo appoggio fu che Pisistrato ne avrebbe
sposato la figlia. Nella prospettiva dei meccanismi del potere familiare e del potere politico
questa clausola deve essere interpretata come una forma di spartizione e compartecipazione al
46
Hdt. I 59; Aristot. Ath. Pol. 13.4s. Sulle questioni relative ai tre partiti, alla loro composizione sociale e alla
localizzazione geografica: Thuc. II 55. WRIGHT 1892, pp. 42s.; ANDREWES 1958, pp. 102-107; ELLIS-STANTON
1968; HOLLADAY 1977; GOUŠCHIN 1999, pp. 14-19; NENCI 2006, ad Hdt. V 62, p. 246.
47
HOW–WELLS 1929, ad Hdt. I 60.
48
Hdt. I 60.
49
Pisistrato entrò in Atene su un carro accompagnato da una alta ragazza che impersonava la dea Atena; per
un’analisi dell’episodio: HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 60; BOARDMAN 1972 per una analisi del legame tra questa
iniziativa e la coeva decorazione ceramica attica; CONNOR 1987, pp. 42-47; DEACY 2008, pp. 98-101; ANGIOLILLO
2009 per una revisione delle tesi di BOARDMAN 1972.
119
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
potere. Non solo i figli nati dal quel matrimonio avrebbero avuto accesso, almeno parzialmente,
alla successione al potere di Pisistrato; ma, considerando la sua esperienza, il suo prestigio e il
suo peso politico, Megacle avrebbe senz’altro partecipato alla conduzione della politica
tirannica del genero50.
La situazione politica di Atene avrebbe potuto dirsi stabilizzata in maniera duratura con
questa alleanza interfamiliare: da un lato gli Alcmeonidi erano una antica famiglia eupatride
con una lunga tradizione di partecipazione politica e un appoggio sociale nella classe moderata,
con una politica internazionale avviata da almeno mezzo secolo e in via di consolidamento,
interessata all’ampliamento delle capacità marittime della loro polis; d’altro canto Pisistrato si
presentava come un uomo politico nuovo, senza una forte tradizione familiare di contatti
internazionali, ma con un seguito politico fra quella parte del dèmos ateniese che si sentiva
esclusa dai privilegi politici51; egli era un militare di successo che aveva risolto l’annoso
contenzioso con Megara e godeva dell’appoggio e della fiducia dei concittadini al punto da
ottenere una guardia del corpo pubblica52. L’alleanza fra i due sanciva il saldarsi di un’affine
politica estera ed economica, volta all’ampliamento della navigazione nell’Egeo, e di una
politica interna indirizzata ad assecondare gli interessi della maggioranza della cittadinanza a
scapito della componente conservatrice dei proprietari terrieri tradizionali, guidata da Licurgo.
L’alleanza fra Pisistrato e Megacle mi pare possa interpretarsi come un’alleanza fra un politico
della vecchia classe, conoscitore del panorama internazionale e locale, e un parvenu che
nondimeno era in grado di fare leva su strati sociali recentemente affacciatisi alla politica e che
sapeva sfruttare a maggior vantaggio la propria immagine pubblica53.
Pisistrato nondimeno ruppe l’accordo con Megacle: egli ne sposò la figlia, ma si rifiutò di
generare con lei una discendenza; quando la ragazza ne mise al corrente i genitori, Megacle
considerò subito nullo il patto con il tiranno e riannodò l’intesa con gli altri stasiòtai ateniesi;
prima che vi fossero altre ripercussioni Pisistrato preferì allontanarsi dall’Attica. Il matrimonio
nella cultura greca arcaica è da considerarsi indirizzato e pienamente legalizzato con la
50
Una situazione non dissimile si può ritenere operante nelle motivazioni per cui Teagene aveva dato in sposa sua
figlia a Cilone: il tiranno di Megara sperava cioè di partecipare e influenzare la gestione di Atene per il tramite del
genero acquisito.
51
Aristot. Ath. Pol. 13.4s.
52
Il peculiare armamento di questo corpo di guardia fu probabilmente inteso ad associare il potere di Pisistrato a
strumenti efficaci nonché ad una serie di rimandi simbolici: BOARDAMAN 1972 riconosce nei korunéphoroi
l’allusione all’arma del mitico eroe Eracle e dunque l’associazione del potere di Pisistrato all’eroe e alla sua dea
protettrice Atena; MCGLEW 1993, pp. 74-78 ritiene che i portatori di mazze fossero lo strumento che il demos volle
fornire al tiranno per correggere e limitare il potere dell’aristocrazia ad Atene e portare giustizia alla polis.
53
Questa ricostruzione è giustificata dal giudizio espresso da Aristotele nelle sue opere che considerò Pisistrato un
demagogo impostosi alla tirannide con l’appoggio del popolo e in contrapposizione ai ceti possidenti: Aristot. Ath.
Pol. 13.4-5; Aristot. Pol. 1305a (V 5), 1310b-1311b (V, 10); Aristot. Rh. 1357b, 31-33. FRENCH 1957, p. 241.
120
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
generazione di una discendenza che assicuri la continuità della famiglia, della casa e del culto;
il talamo era
pertanto comunemente inteso come la rappresentazione del matrimonio e
l’infertilità causa sufficiente per un giusto divorzio54: cosicché, per Megacle e sua figlia, in
quella situazione, non rimaneva alcuna garanzia di poter far valere i propri diritti sulla famiglia
di Pisistrato e sul potere politico ad Atene. Erodoto fa notare che Pisistrato non volle unirsi alla
nuova moglie poiché egli già aveva dei figli da una precedente moglie ateniese i quali
avrebbero ereditato il potere e le ricchezze: è comprensibile che il tiranno non volesse
depauperare il primogenito e il fratello costringendoli a condividere il potere con altri fratelli
non uterini e a dividere i possedimenti e le ricchezze in multiple parti55.
Nella rottura del matrimonio fra Pisistrato e la figlia di Megacle ritornò inoltre ad influire
quell’antica accusa di empietà che gravava sul gènos degli Alcmeonidi. Nella sua narrazione
Erodoto tramanda che Pisistrato non voleva generare figli con la moglie alcmeonide appunto
per via della maledizione divina che pesava sulla famiglia56: si dovrà intendere dunque che il
tiranno non volesse trasferire quella maledizione alla propria discendenza. È possibile
d’altronde che questa informazione sia soltanto un’interpretazione costruita dallo stesso
Erodoto, poiché Aristotele, pur conoscendo la vicenda del matrimonio e della sua rottura, non
menziona queste considerazioni fra i moventi di Pisistrato57. Si consideri a questo proposito che
gli Alcmeonidi avevano subito un esilio in conseguenza delle loro azioni contro Cilone, ma
avevano presto goduto dell’amnistia promossa da Solone nel 594, la famiglia aveva poi ripreso
appieno il proprio ruolo sociale e politico, Alcmeone aveva condotto gli Ateniesi nella
vittoriosa guerra contro Crisa, il nome della famiglia era stato redento nella considerazione del
santuario di Delfi e infine Megacle II era stato accettato come un prestigioso alleato familiare
da parte del tiranno di Sicione Clistene58. Se invece si accetta la storicità del racconto erodoteo
se ne dovrà inferire che nel 560 ca., a distanza di più di mezzo secolo e di due generazioni dai
fatti dell’eccidio dei Ciloniani, l’accusa di empietà che gli Alcmeonidi si erano visti affiggere
dopo il 636 rimaneva ancora un fatto sociale conosciuto ed efficace, o perlomeno politicamente
strumentalizzabile. Mi pare necessario accettare questa interpretazione in virtù del fatto che
l’accusa di empietà agli Alcmeonidi fu chiamata in causa anche in seguito ai fatti qui discussi:
nella richiesta di espulsione contro Clistene alcmeonide e altri membri della famiglia mossa
54
VERNANT 1973, pp. 58-60; CANTARELLA 2005, pp. 246s.; WAGNER HASEL 2010, s.v. “Marriage” in BNP.
Il diritto arcaico greco imponeva spesso di dividere l’eredità in parti uguali fra tutti gli eredi. ROY 1999, pp. 2-5,
10; MAFFI 2005, pp. 254-258.
56
Hdt. I 61.
57
Aristot. Ath. Pol. 15.1.
58
PRANDI 2000, pp. 15-20.
55
121
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
dallo spartano Cleomene nel 50859; l’accusa di empietà fu di nuovo strumentalizzata dagli
Spartani nel secolo successivo, all’inizio della Guerra del Peloponneso, quando fu richiesta
l’espulsione da Atene di Pericle, per via della sua ascendenza materna alcmeonide60. È evidente
dunque che la veridicità e la continuità storica dell’impronta infamante sugli Alcmeonidi non è
da mettersi in dubbio. Per meglio comprendere il valore e il peso di quest’accusa, si consideri
che essa non impedì agli Alcmeonidi, nel VI come nel V secolo, di intervenire nella politica e
nella società ateniese e panellenica e di godere di un ampio consenso fra i concittadini e fra i
protagonisti della diplomazia internazionale; eppure nondimeno la famiglia non poté liberarsi di
quel tratto distintivo negativo che si prestò ad essere legittimamente strumentalizzato, in
momenti di crisi, dai suoi nemici politici61.
Al fine di portare la discussione dal piano della politica interna ateniese a quello delle
relazioni internazionali che interessano questa specifica ricerca, vorrei soffermare l’analisi sulle
implicazioni che le rispettive reti di alleanze familiari di Pisistrato e Megacle poterono avere
nella svolta che portò alla rottura dell’intesa matrimoniale fra le due famiglie. Nel giro di
pochissimi anni a cavallo della prima tirannide e del primo esilio, Pisistrato sposò l’argiva
Timonassa oltre che l’Ateniese figlia di Megacle. Secondo una ricostruzione proposta dalla
critica moderna, si può ragionevolmente supporre che quando Megacle offrì sua figlia a
Pisistrato egli fosse all’oscuro del matrimonio argivo del tiranno oppure che si aspettasse che
quel matrimonio extrapoleico perdesse importanza di fronte all’alleanza fra famiglie ateniesi;
cosicché, quando si rese conto che l’alleanza che il tiranno aveva stretto con Argo rimaneva
salda e operativa e, anzi, l’Argiva aveva generato dei figli, Megacle decise di rompere l’accordo
con Pisistrato. In quella condizione infatti, i figli nati dalla moglie alcmeonide sarebbero stati
ancora più svantaggiati nella successione alle ricchezze e al potere dei Pisistratidi, nascendo
dopo i primi figli ateniesi e dopo i figli argivi62.
Come Pisistrato, anche Megacle aveva stretto un’alleanza matrimoniale al di fuori di
Atene, prendendo in moglie Agariste di Sicione, figlia del tiranno Clistene, in occasione del
celebre convito panellenico organizzato dal padre della sposa nel 575 ca.63 Da quel matrimonio
nacque l’ateniese Clistene che ebbe un ruolo storico nello sviluppo dell’organizzazione politica
59
Hdt. V 70-73; Thuc. I 126.
Thuc. I 126s.
61
THOMAS 1989, pp. 149s.; RAAFLAUB 1996, pp. 1048s.; PRANDI 2000, pp. 12-15; FORSDYKE 2005, p. 89.
62
LAVELLE 2005, pp. 206s. Rimane in discussione la possibilità della nascita di Egesistrato dal matrimonio
precedente di Timonassa e dunque la possibilità che Pisistrato lo avesse adottato nel 546 e in questo caso si
ammetterà che la considerazione qui esposta assume un minor peso, vd. supra, pp. 103ss. Nondimeno pare
indiscutibile che Timonassa generò a Pisistrato anche Iofonte: Aristot. Ath. Pol. 17.3.
63
Sul matrimonio di Agariste, le sue implicazioni politiche e sulla sua datazione precisa: MCGREGOR 1941, pp.
268-279, 287; PARKER 1994, pp. 412s., 416s., 421.
60
122
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
ateniese alla fine del VI secolo. È verosimile che da quel matrimonio sia nata anche la ragazza
che Megacle offrì in sposa a Pisistrato64; se dunque la moglie alcmeonide di Pisistrato
discendeva dagli Ortagoridi di Sicione per parte materna, questa unione matrimoniale risultava
in contraddizione con l’alleanza che Pisistrato aveva stretto con Argo sposando Timonassa, la
figlia del nobile Gorgilo: sotto il comando di Clistene, Sicione aveva infatti combattuto una
guerra appunto contro Argo, nel primo quarto del VI secolo, durante la quale il tiranno aveva
perseguito non solo iniziative belliche ma anche una politica culturale e religiosa anti-argiva e
grazie alla quale Sicione si era liberata da una condizione di dipendenza da Argo65. Come si è
ricostruito, il matrimonio di Pisistrato con Timonassa non solo creava un tramite con
l’aristocrazia di quella polis, ma stabiliva anche la tendenza del tiranno ateniese ad inserirsi
nella tradizione della casata degli antichi tiranni cipselidi di Corinto. Anche questo indirizzo di
politica familiare internazionale pisistratide entrava in contrasto con la storia di Sicione e degli
Ortagoridi: le fonti permettono infatti di ricostruire un conflitto avvenuto fra Clistene e Corinto,
all’epoca della sua presa del potere tirannico66. Le vicende politico-militari di Clistene lo
avevano visto dunque avversario di Argo e di Corinto, proprio le due poleis verso cui Pisistrato
si era avvicinato stabilendo l’alleanza matrimoniale con Timonassa, figlia di Gorgilo. Mi pare
d’altronde necessario evitare di sopravvalutare la questione dei conflitti di Sicione con Argo e
con Corinto e dunque e ridimensionare il grado in cui poterono influire sulle scelte di Megacle e
Pisistrato. In primo luogo si trattava di fatti avvenuti mezzo secolo prima, relativi al nonno
materno della figlia di Megacle, cosicché potevano considerarsi ormai trascorsi e ininfluenti
all’epoca del matrimonio di Pisistrato con la ragazza. Inoltre la giovane sposa di Pisistrato va
considerata in primo luogo una Alcmeonide e i legami con la famiglia materna non poterono
costituire moventi di rilievo maggiore di quelli relativi alla parte paterna della sua ascendenza,
in virtù peraltro del sistema patrilineare vigente nella cultura greca67. Infine è ragionevole
pensare che i fatti relativi all’ambito della politica interstatale più antica potessero essere
64
È pure doveroso ammettere che le fonti scritte non permettono di accertare una ricostruzione precisa della
genealogia alcmeonidea che qui interessa: la giovane sposa di Pisistrato potrebbe essere nata da un matrimonio di
Megacle con una donna ateniese di cui non si è preservata memoria giacché l’ascendenza della giovane non è
infatti precisata in alcuna fonte. In maniera non dissimile, siamo a conoscenza di un primo matrimonio ateniese di
Pisistrato esclusivamente per via dell’esistenza dei due primi figli del tiranno, Ippia e Ipparco, che ebbero un ruolo
nella storia di Atene; ma l’identità e la genealogia di questa prima moglie del tiranno rimangono imperscrutabili.
Nondimeno, nel caso di Megacle e di sua figlia non mi pare costruttivo lavorare su argomenti ex silentio.
65
Hdt. V 67s. ANDREWES 1958, pp. 54s., 58-63; KELLY 1976, pp. 154s.
66
Nic. Dam. FGrHist 90 F 61.5; Frontin. Str. III 9.7. FORREST 1956, pp. 39-41, 48-52.
67
MAFFI 2005, pp. 254-256.
123
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
facilmente tralasciarsi a fronte degli interessi familiari delle parti coinvolte, soprattutto nel
contesto sociale dei gène aristocratici arcaici68.
Il quadro che va prendendo forma è quello dell’accumularsi di una serie di fattori, di
ambito locale e panellenico, familiare e politico, che assommatisi portarono Megacle a invertire
in breve tempo la propria posizione nei confronti di Pisistrato e ad avversarlo. Inizialmente,
dopo un primo momento di opposizione, Megacle scelse come alleato il nuovo politico
Pisistrato piuttosto che il conservatore Licurgo. Si può inferire dal suo comportamento e dalla
sua storia personale e familiare che Megacle mirava a fare di Pisistrato il tiranno di Atene
assicurandosi però la sua alleanza e il suo appoggio e mettendo Pisistrato in una condizione di
dipendenza politica nei suoi confronti; fondamento di questa intesa poté essere un’affine
politica marittima, dimostrata dagli Alcmeonidi fin dalla fine del VII secolo e da Pisistrato nella
conduzione del conflitto megarico. Pisistrato tuttavia dimostrò di avere, oltre all’alleanza locale
con Megacle, anche un’agenda di relazioni personali internazionali, quando sposò Timonassa di
Argo: con questa alleanza Pisistrato si assicurò un sostenitore personale fuori da Atene,
indipendente perciò dagli interessi attici e dal campo di intervento di Megacle. Considero
inoltre accertata dalle precedenti analisi la formazione di un’alleanza interfamiliare di Pisistrato
entro Atene con i Filaidi, un altro gènos aristocratico, alternativa dunque all’alleanza con
Megacle69. Dunque Megacle dovette inizialmente pensare di accordare a Pisistrato la tirannide
ma di partecipare indirettamente anch’egli stesso al controllo della polis; Pisistrato si rivelò
invece un politico avveduto e preparato che andava costruendo per sé una posizione solida e
indipendente sia entro che al di fuori di Atene. Megacle capì entro poco tempo che il
matrimonio che egli aveva assicurato a sua figlia risultava infruttuoso e non-vincolante poiché
Pisistrato non generò figli; per di più venne a conoscenza dei figli che Pisistrato aveva avuto
dalla moglie argiva: si allontanò così ulteriormente la possibilità di inserire gli Alcmeonidi in
una posizione vantaggiosa entro la discendenza dei tiranni di Atene. Assume cogenza ora la
ricostruzione proposta in questo scritto che vede Egesistrato come un figlio di Timonassa e del
Cipselide Archino e adottato da Pisistrato come proprio: in queste circostanze Pisistrato avrebbe
disposto non solo di un alleato politico ad Argo, ma anche di un figlio adottivo già avviato
all’età adulta, in grado cioè di agire a favore di Pisistrato sia ad Argo che sul piano
internazionale, come si dimostrò in effetti in seguito in occasione della battaglia di Pallene e poi
68
A titolo esemplificativo si consideri che al medesimo concorso per la mano di Agariste si presentò anche
Leocede, figlio del tiranno Fidone, giunto da Argo e che proprio contro Argo Clistene, padre della giovane, aveva
condotto una aspro conflitto: Hdt. VI 127. MCGREGOR 1941, pp. 268-279, 287; PARKER 1994, pp. 410-412, 416s.,
421.
69
ANDREWES 1958, pp. 105-111; DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 113s. Vd infra, pp. 190ss., 213ss.
124
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
nel controllo del possedimento del Sigeo. Secondo questa ricostruzione Egesistrato sarebbe
inoltre nato da famiglia cipselide e il matrimonio di Pisistrato con la vedova di Archino poteva
essere interpretato da Megacle come un segno dello slittamento di Pisistrato entro una tendenza
politica internazionale filo-cipselide e filo-corinzia. Al contrario Megacle rientrava palesemente
in una rete di alleanze familiari che faceva riferimento a Sicione, tradizionale nemica di
Corinto. Con il matrimonio argivo Pisistrato entrava dunque contemporaneamente in contatto
sia con gli Argivi che con i Cipselidi e Corinto: avversari tradizionali degli Ortagoridi di
Sicione, alleati di Megacle. Si intende dunque come la serie di iniziative di Pisistrato e le
implicazioni che poté trarne Megacle crearono una frattura sempre più ampia fra i due politici
ateniesi.
È legittimo interrogarsi sui moventi che spinsero Pisistrato ad abbandonare l’intesa con
Megacle perché, secondo un altro punto di vista, il matrimonio con la ragazza alcmeonide si
sarebbe potuto considerare vantaggioso: gli Alcmeonidi erano una famiglia di lunga tradizione
politica ad Atene, godevano di ampio prestigio e di contatti internazionali con i potenti
Ortagoridi di Sicione, con il santuario di Delfi, e perfino con i ricchi sovrani di Lidia;
partecipare come parte integrante della rete familiare degli Alcmeonidi avrebbe assicurato a
Pisistrato una posizione di potere sicura ad Atene e ampi contatti internazionali; Megacle aveva
inoltre pattuito la cessione della tirannide a Pisistrato. Pisistrato avrebbe potuto anche
mantenere i propri contatti argivi pur concedendo dei nipoti a Megacle e assicurandogli un certo
livello di compartecipazione al potere.
La stessa alleanza argiva non assicurava un potere
indiscusso ad Atene e nella Grecia, soprattutto considerando la posizione declinante di quella
polis nel Peloponneso70. Nemmeno la famiglia di Gorgilo, malgrado la precedente alleanza con
i Cipselidi di Ambracia, deve considerarsi di ampie risorse: Egesistrato mosse infatti da Argo
con i suoi 1.000 opliti, nel 546, solo grazie alle ricchezze che Pisistrato si era procurato in
Tracia, ma non era potuto intervenire nelle precedenti occasioni di crisi, come appunto nel 560
ca. e nel 556, quando Pisistrato fu esiliato. Per ricavare la soluzione di questi interrogativi si
pone qui la necessità di interpretare fatti e comportamenti alla luce del loro contesto storico e
culturale: io credo che Pisistrato rifiutò di portare a termine l’alleanza matrimoniale con
Megacle per un suo spirito di autoaffermazione, per l’aspirazione al potere personale e alla
dimostrazione della propria eccellenza sociale, militare e politica. Pisistrato dovette considerare
la moglie argiva come il punto di avvio dell’affermazione della sua famiglia entro l’élite
aristocratica internazionale e preferì coltivare quell’alleanza piuttosto che favorire l’alleato
70
KELLY 1976, p. 153. È pur vero che all’epoca della prima tirannide di Pisistrato (560) non si era ancora
verificata la decisiva sconfitta di Argo contro gli Spartani (546).
125
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
Megacle e rimanere così legato alla politica locale ateniese in una condizione di dipendenza e
compartecipazione politica. Senz’altro Pisistrato avrebbe preferito evitare di compiere una
scelta drastica, ma fu costretto a mostrare le proprie aspirazioni dall’irata reazione del nuovo
suocero alcmeonide: messo alle strette abbandonò Atene per un secondo e decennale esilio nel
quale si adoperò però sollecitamente nella costruzione della propria ricchezza in Tracia. Il
ritorno a Pallene mise infine Pisistrato saldamente al governo di Atene, senza rivali e senza
intralci.
La tirannide di Pisistrato e l’esilio degli Alcmeonidi
In un breve paragrafo della sua opera Erodoto fornisce un resoconto del comportamento di
Pisistrato nei confronti dei suoi concittadini e degli avversari politici interni a seguito della
vittoria di Pallene: molti Ateniesi, che pure avevano appena combattuto a Pallene, si lasciarono
persuadere dai figli di Pisistrato ad interrompere la fuga, lasciare le armi e ritornare alle proprie
occupazioni senza subire alcun torto da parte del tiranno; di quegli Ateniesi che non fuggirono
dal campo di battaglia e continuarono invece a combattere strenuamente, Pisistrato sequestrò i
figli e li tenne sull’isola di Nasso, anch’essa allora in suo potere. Molti Ateniesi caddero in
battaglia contro le forze pisistratidi e molti fuggirono da Atene (ἔφευγον ἐκ τῆς οἰκηίης): fra
questi erano gli Alcmeonidi71.
Si ripropone dunque il tema dell’esilio degli Alcmeonidi. Alcune delle moderne analisi
accettano la storicità di questa notizia in virtù di una serie di attestazioni diffuse nelle fonti
letterarie, relative a tutta la seconda metà del VI secolo, che sembrano certificare la presenza
della famiglia fuori da Atene72. Altre analisi rifiutano la storicità dell’esilio degli Alcmeonidi
imposto da Pisistrato: centrano l’attenzione infatti su una interpretazione politica della
tradizione storiografica, sull’effettiva possibilità cioè che gli Alcmeonidi abbiano contribuito a
costruire per sé una fittizia reputazione anti-tirannica all’interno della memoria storica collettiva
ateniese sfruttando appunto il tema di un loro supposto esilio73; le fonti epigrafiche smentiscono
inoltre la tradizione erodotea dell’esilio. Il problema assume un certo grado di importanza per il
tema di questa ricerca perché rientra nell’obiettivo di delineare il quadro strategico-politico
internazionale entro cui operò la tirannide pisistratide: l’esilio degli Alcmeonidi da Atene
metteva Pisistrato in una condizione di superiorità indiscussa entro la politica locale ateniese,
71
Hdt. I 64. Isocrate tramanda notizia dell’onorevole scelta degli Alcmeonidi di preferire l’esilio alla schiavitù
della tirannide: Isocr. De Big. 16.25.
72
STAHL 1987, pp. 120-136.
73
BICKNELL 1970; KINZL 1976, pp. 313s.; THOMAS 1989, pp. 147-151; GIULIANI 2001, pp. 36-40; FORSDYKE
2005, pp. 121-125; NENCI 2006, ad Hdt. V 62.
126
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
ma, per converso, la loro fuoriuscita da Atene deve anche intendersi come la costituzione di un
soggetto politico attivo sul piano internazionale e avverso al potere e alle iniziative di Pisistrato.
Si consideri in primo luogo che la pratica dell’esilio è ampiamente diffusa e attestata in
tutta la storia greca: un individuo o un gruppo politico che abbia raggiunto una posizione di
predominanza tende a salvaguardare quella posizione eliminando del tutto gli oppositori
sconfitti74. I tiranni dovettero mantenere e difendere il proprio regime autocratico dalle
aggressioni, politiche o fisiche, degli aristocratici loro avversi: una soluzione fu quella di
acquisire sostenitori e alleati extra-poleici come appunto mette in luce questa ricerca; altro
espediente diffuso fu però quello di estromettere gli avversari non solo dalla pratica politica, ma
dallo stesso territorio della polis. Con l’affermazione di una tirannide, gli avversari si
ritrovavano in una condizione di inferiorità politica, sociale e militare: non solo il loro potere
politico era scalzato dal tiranno e reso minoritario, ma essi si sarebbero ritrovati in una
condizione svantaggiata e financo pericolosa nel caso la lotta politica fosse sfociata in violenza
e guerra civile, come effettivamente spesso accadde75. A fronte di questa situazione di pericolo
gli avversari si videro imposto l’esilio dal tiranno; oppure scelsero volontariamente di lasciare
la polis, ritirandosi al sicuro entro i propri possedimenti familiari ove godevano dell’appoggio e
della difesa dei sostenitori locali; in alternativa lasciarono il territorio per ritagliarsi un ruolo
nello scenario panellenico e internazionale.
Episodi di esilio e fuoriuscite di avversari politici della tirannide si riscontrano secondo
modelli affini in molteplici casi: così per le notizie frammentarie sul confronto politico a
Mitilene, all’inizio del VI secolo, fra l’esimnete Pittaco e la fazione del nobile Alceo76; così per
la tirannide a Corinto, di Cipselo e del figlio Periandro, i quali, secondo la tradizione, spinsero i
maggiorenti in esilio oltre a praticare altre iniziative crudeli contro quelle famiglie77; nella
seconda metà del VI secolo Policrate di Samo non solo esiliò gli aristocratici dell’isola, ma
perfino il proprio fratello78.
74
Sull’esilio, la pratica della violenza politica cittadina e sull’ostracismo nella storia greca si veda FORSDYKE 2005.
Il pericolo che l’opposizione politica giungesse a minacciare l’incolumità di un capo di fazione era ben noto
nella polis greca; un esempio calzante è dimostrato, per l’Atene arcaica, dall’assegnazione a Pisistrato, nel 560, di
una guardia del corpo che lo proteggesse dalle altre due fazioni: Hdt. I 59; Aristot. 14.1-2. Le preoccupazioni
espresse da Solone per gli eccessi dello scontro politico-sociale sono rivolte proprio allo scoppio della violenza:
Sol. FF 13, 30, 31. Sul rapporto fra politica e violenza nella polis greca arcaica: BERENT 2000, pp. 260s.;
ANDERSON 2005, pp. 178, 182-189, 198, 204; FORSDYKE 2005, pp. 15-28, 108-109.
76
Alc. FF 45, 48 69, 76, 130B, 131, 148, 306A, 306B (Loeb); Aristot. Pol. 1285a; Hor. Carm. 2.13.28; P. Oxy
2506, 77; P. Oxy. 2733, 11-14; Favorin. De exil. 9.2.
77
Hdt. III 48; V 92e-h.
78
Hdt. III 44-47; Plut. De Her. Mal. (Mor. 859c-d).
75
127
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
Lo stesso Pisistrato impose la propria tirannide ad Atene nel 546, ma solo dopo due
successivi e lunghi periodi di esilio provocati dal confronto con gli Alcmeonidi79. La dottrina
politica aristotelica considerò l’esilio come uno degli strumenti di mantenimento del potere del
tiranno, insieme alla violenza, alla demagogia e alla rovina dei maggiorenti80. Dopo
l’istituzione della democrazia clistenica ad Atene l’ostracismo fu nel V secolo uno strumento
per converso volto a scongiurare il pericolo della tirannide, ma tramite il medesimo strumento
dell’esilio.
Nel merito specifico degli Alcmeonidi, questa famiglia aveva già subito una condanna
all’esilio all’inizio del VI secolo impostale non da un tiranno, ma piuttosto da una giuria di
concittadini a seguito dei torbidi provocati dal loro violento trattamento della fazione
ciloniana81. La notizia della loro espulsione a seguito dell’instaurazione della tirannide di
Pisistrato nel 54682 è da associarsi ad una serie di altre testimonianze relative al comportamento
del tiranno nei confronti degli avversari politici aristocratici: le fonti collocano gli Alcmeonidi
in esilio da Atene per via dell’opposizione al tiranno in vari momenti della seconda metà del VI
secolo, seppure le testimonianze siano problematiche83.
Fonti storiografiche e letterarie tramandano la presenza degli Alcmeonidi a Delfi nel corso
della seconda metà del VI secolo: le testimonianze pervenute sono complesse ed eterogenee,
eppure concordano nell’identificare in questa famiglia gli appaltatori della ricostruzione del
tempio di Apollo a Delfi distrutto da un incendio nel 54884. La generosa esecuzione dell’opera
assicurò agli Alcmeonidi la gratitudine del clero delfico e il perpetuarsi di quel rapporto
privilegiato fra la famiglia e il santuario già individuato per l’inizio del VI secolo. Sfruttando
questa prestigiosa posizione a Delfi e la loro ampia disponibilità di ricchezze gli Alcmeonidi si
assicurarono l’appoggio inoltre di Sparta poiché spinsero la Pizia ad incoraggiare i Lacedemoni
ad espellere la tirannide da Atene: queste iniziative culminarono infine nel 510, durante
l’arcontato di Arpactide, con la cacciata dei tiranni da Atene, ad opera di una spedizione
comandata dal re Cleomene, e con il rientro degli Alcmeonidi dall’esilio85. Erodoto, la cui
79
Vd. supra, pp. 70ss.
Aristot. Pol. 1310b-1311b (V, 10).
81
Hdt. I 126; Plut. Sol. 12.3, 19.3. Vd. supra, pp. 27ss.
82
Hdt. I 64; Isocr. De Big. 16.25; Plut. Sol. 30.6; Schol. Demosth. Contra Meid. 21.144. KINZL 1976.
83
Hdt. I 64, 62, VI 123; Thuc. VI 59; Aristot. Ath. Pol. 19.3. BICKNELL 1970; KINZL 1976; STAHL 1987, pp. 120138; NENCI 2006, pp. 245s.
84
La data dell’incendio è fornita in Paus. X 5.13.
85
Aristot. Ath. Pol. 19.6. Le fonti divergono sui nessi causali che legherebbero gli elementi dell’appalto per la
ricostruzione, della disponibilità di ricchezze degli Alcmeonidi, della corruzione della Pizia e dell’intervento
spartano. Erodoto considera la ricchezza della famiglia la premessa condizionale che spinse gli Alcmeonidi ad
assumere l’incarico dell’appalto: Hdt. V 62s.; VI 125. Secondo Aristotele, al contrario, fu lo sfruttamento
dell’appalto delfico a procurare agli Alcmeonidi un surplus economico con cui poterono finanziare l’intervento
80
128
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
versione pare più attendibile86, inserisce infatti esplicitamente il compimento dell’appalto del
tempio delfico fra le macchinazioni (mexanw/menoi) che gli Alcmeonidi muovevano contro i
Pisistratidi durante il loro esilio87 e vi fa seguire nella narrazione le notizie relative alla
subornazione della Pizia e all’intervento spartano88.
Le notizie relative all’espulsione degli Alcmeonidi nel 546, a seguito del ritorno di
Pisistrato ad Atene, mi paiono dunque trovare conferma nella cronologia dell’incendio del
santuario delfico, datato al 548, nell’assegnazione agli Alcmeonidi dell’appalto per la
ricostruzione e nei propositi sopra esposti in base ai quali agirono gli esuli a Delfi89.
D’altronde la sequenza narrativa preservata sia da Erodoto che da Aristotele sembra
collocare insieme l’appalto, la ricostruzione del tempio e il coinvolgimento degli Spartani,
abbassando quegli avvenimenti entro la cronologia degli ultimi anni della tirannide dei
Pisistratidi, dopo il tirannicidio di Ipparco, nel 514. Assumerebbe dunque efficacia la
ricostruzione sopra accennata che considera le notizie relative all’esilio alcmeonide fin dai
primi anni della tirannide di Pisistrato come una fabbricazione storiografica di parte
alcmeonide, volta a mettere la famiglia in luce come strenua oppositrice della tirannide fin dalla
sua prima instaurazione90. Non ritengo però questa un’obiezione valida: oltre a fondarsi su una
ricezione eccessivamente rigida della narrazione dei testi, implica una inverosimile cronologia
degli eventi in discussione. Implicherebbe infatti che il clero delfico abbia atteso almeno 34
anni prima di appaltare la ricostruzione del principale tempio del santuario (548-514); sarebbe
poi necessario collocare nei due anni successivi, fra l’espulsione degli Alcmeonidi del 514 e la
prima spedizione spartana contro Atene nel 511/510 al più tardi, una fitta sequenza di eventi:
l’appalto e la ricostruzione del tempio, la corruzione della Pizia, una serie di reiterati responsi
oracolari ai Lacedemoni, l’allestimento dell’esercito dello spartano Anchimolio e l’assedio di
Ippia sull’acropoli. L’intervallo utile si riduce ad un anno, o pochi mesi, se si sceglie come
terminus post quem per questa serie di avvenimenti la disfatta di Leipsydrion, avvenuta dopo
militare di Sparta; nondimeno anche questo storico è a conoscenza del ruolo giocato dai responsi oracolari: Arisot.
Ath. Pol. 19.4. La versione aristotelica è sostanzialmente quella poi accettata entro la tradizione storiografica e
retorica ateniese: Demosth. Contra Meid. 21.144; Schol. Demosth. Contra Meid. 21.144; Isocr. Antid. 15.232.
Nondimeno quest’ultima tradizione piega la narrazione aristotelica secondo un modello economico-militare
anacronistico, condizionato dalle preoccupazioni del IV secolo, quando la pratica diffusa era quella di recepire
prestiti col fine di assoldare eserciti mercenari. DEMPSEY 1918, pp. 85s., 164; FORREST 1969 a; LLOYD-JONES
1976, pp. 64-68; NENCI 2006, p. 247.
86
FORREST 1969 a, pp. 279s., 283-286.
87
Hdt. VI 62. NENCI 2006, p. 247.
88
Hdt. VI 63.
89
STAHL 1987, p. 126.
90
Vd. supra, pp. 119ss. BICKNELL 1970; KINZL 1976, pp. 313s.; THOMAS 1989, pp. 147-151; GIULIANI 2001, pp.
36-40; FORSDYKE 2005, pp. 121-125; NENCI 2006, ad Hdt. V 62.
129
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
l’espulsione del 514, probabilmente nel 51391. Altri dati concorrono a superare l’obiezione. Fra
i finanziatori della ricostruzione di Delfi è noto il faraone egizio filelleno Amasi92, il cui regno è
datato al periodo 570-526: questa notizia attesta senz’altro l’attività dei sacerdoti delfici in vista
della ricostruzione del santuario almeno prima del 526. Infine l’analisi archeologica e stilistica
colloca i reperti associati al tempio delfico di Apollo al periodo certamente anteriore al 51493.
La conclusione necessaria è che gli Alcmeonidi subirono un primo esilio ad opera di
Pisistrato subito in seguito alla battaglia di Pallene94; contando su un rapporto già avviato con il
clero delfico, essi trovarono presso il santuario apollineo una sede e un rifugio ideali per il
periodo dal 546 fino al loro rientro ad Atene; si adoperarono in quel lasso di tempo nella
ricostruzione del tempio e poterono sfruttare a proprio vantaggio il prestigio e la gratitudine dei
sacerdoti e della Pizia.
Il successore di Pisistrato alla tirannide di Atene, suo figlio Ippia, aggravò il peso e
l’ampiezza delle misure contro gli avversari aristocratici dopo che si verificò l’assassinio di suo
fratello Ipparco nel 51495; negli anni successivi al tirannicidio gli Alcmeonidi furono senz’altro
in esilio insieme ad altri non meno specificati gruppi di dissidenti poiché essi tentarono di
rientrare con la forza in Attica fortificando la l’insediamento di Leipsydiron ove sostennero
senza successo il contrattacco di Ippia ed ebbero successo solo con l’intervento spartano del
511/1096.
Gli Alcmeonidi non furono senz’altro gli unici aristocratici a subire l’esilio forzato dai
Pisistratidi: nelle notizie relative agli Alcmeonidi esiliati si evince, dalle stesse parole delle
fonti, che essi costituivano la componente maggioritaria, più eminente o in comando di un più
ampio gruppo di fuoriusciti. Malgrado il profilo che si è finora andato tracciando punti
all’esistenza di un’alleanza fra Pisistratidi e Filaidi97, anche per quest’ultima famiglia esistono
attestazioni che si potrebbero interpretare come riferite ad una loro fuoriuscita da Atene, forzata
dai difficili rapporti con i tiranni: un’attestazione inequivocabile a questo proposito si colloca
nell’Olimpiade del 536, nella quale vinse la gara di quadrighe il filaide Cimone; egli si trovava
91
FORREST 1969 a.
Hdt. II 180.
93
Gli studiosi che hanno preso in esame la datazione del tempio di Apollo a Delfi, sulla base di considerazioni
stilistiche, propendono per una collocazione più vicina agli anni ’20 del VI secolo: FORREST 1969 a, pp. 283-286;
BOARDMAN-HAMMOND 1982, p. 467; GIULIANI 2001, pp. 36-40; cautela esprime MUSTI 2006, p. 246.
94
Hdt. I 64; Isocr. De Big. 16.25; Plut. Sol. 30.6; Schol. Demosth. Contra Meid. 21.144. KINZL 1976.
95
Aristot. Ath. Pol. 19.1.
96
Hdt. V 62; VI 123; Thuc. VI 59; Isocr. Antid. 15.232; 16.26; Demosth. Contra Meid. 21.144; Aristot. Ath. Pol.
19; Schol. Aristid. Panath. 120.6; Schol. Demosth. Contra Meid. 21.144. CHANDLER 1926, p. 15; MCCREDIE 1966,
pp. 59-61; BICKNELL 1970, pp. 130s.; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 180, 182, 234-240 sul significato territoriale dei
sistemi di fortificazione; NENCI 2006, p. 247.
97
Vd. infra, pp. 190ss., 213ss.
92
130
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
allora in esilio e poté infatti rientrare cedendo il premio al nome di Pisistrato98. Altro membro
eminente dei Filaidi fu Milziade I che fu scelto come tiranno dei Traci nel Chersoneso Tracico:
Erodoto attribuisce la sua iniziativa ad un esplicito invito dei Traci Dolonci che Milziade fu
lieto di accettare per poter lasciare Atene ove mal sopportava lo strapotere di Pisistrato;
l’episodio è però da collocarsi durante il primo periodo di tirannide di Pisistrato nel 558 ca99.
La lista degli arconti ateniesi: indice di forme di concertazione
Il quadro di questa serie di esìli tracciato tramite le fonti letterarie è tuttavia annullato
dalle prove storiche fornite dall’epigrafia: sono infatti celebri i frammenti di una lista degli
arconti eponimi ateniesi, ritrovata sull’acropoli e risalente al 425 ca., che tramanda i nominativi
di coloro che ricoprirono quella magistratura per una serie di anni nel corso del VI secolo;
grazie a questo reperto veniamo a conoscenza del fatto che membri delle famiglie degli
Alcmeonidi, dei Filaidi e di altri gène aristocratici ricoprirono la prestigiosa carica di supremo
magistrato eponimo proprio durante la tirannide di Ippia100. Le implicazioni che questo
documento comporta sono di grande importanza per la comprensione della gestione delle
istituzioni e della politica ateniese da parte dei tiranni pisistratidi e per la comprensione dei
rapporti di forza entro la classe politica e dirigente cittadina; nondimeno la presente ricerca non
può dedicare l’attenzione che l’epigrafe meriterebbe in un discorso sulla tirannide perché i dati
che da essa si possono ricavare concernono eminentemente l’ambito della politica locale
ateniese ed esulano invece da quello delle relazioni internazionali oggetto di questo lavoro.
L’epigrafe pure è interessante per il discorso qui sviluppato nella misura in cui offre la
possibilità di collocare ad Atene piuttosto che fuori dall’Attica individui altrimenti considerati
in esilio e di verificare il loro coinvolgimento nelle magistrature cittadine in un momento in cui
altrimenti li si considererebbe in pericolo o avversati dal regime tirannico.
Il pisistratide Ippia divenne tiranno nel 528/527 alla morte del padre e, secondo la lista,
ricoprì l’arcontato nel 526/525; più tardi, nel 522/521, fu arconte un uomo di nome Pisistrato
98
Hdt. VI 103.
La critica non è concorde nella collocazione cronologica di questo evento e lo associa ad una delle prime due
tirannidi, nel periodo 560-556; oppure, come ho preferito seguire, all’instaurazione definitiva del potere pisistratide
nel 546: HAMMOND 1956, pp. 123, 129; HIND 1974, pp. 14-16. Un’iniziativa coloniale come quella condotta da
Milziade non poteva nondimeno esulare dalla decisione o dalla concertazione di Pisistrato, a capo del governo
ateniese: perciò mi pare necessario in questo caso ritenere che le parole di Erodoto risentano di una tendenza antitirannica inseritasi entro la tradizione storiografica dei Filaidi e in genere delle famiglie aristocratiche ateniesi solo
dopo la caduta della tirannide. WHITE 1955, p. 17; CAWKWELL 1995, pp. 79-80; GAZZANO 2002, p. 43. Vd. infra,
pp. 198ss.
100
IG I3 1031 (= SEG X, n. 352). MERITT 1939, pp. 59-65; CADOUX 1948, pp. 77-79, 109-112; BRADEEN 1963;
BICKNELL 1970; KINZL 1976; MEIGGS-LEWIS 1989, pp. 9-12; THOMAS 1989, p. 148. È possibile peraltro
riconoscere la regolare continuità della magistratura dell’arcontato anche per il periodo di governo di Pisistrato:
Aristot. Ath. Pol. 14.3, 17.1; Mar. Par. FGrHist 239 A 41s. CADOUX 1948, pp. 106-109.
99
131
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
che dobbiamo considerare come il figlio di Ippia, al quale fu dato il nome del nonno paterno,
come era tradizione diffusa nell’onomastica ellenica. Questi sono gli unici due anni di arcontato
pisistratide che l’epigrafe registra: l’anno successivo all’arcontato di Ippia fu invece arconte
Clistene (525/524), della famiglia degli Alcmeonidi, colui che sarebbe poi diventato il
protagonista della riforma politica ateniese nel 508101; nel 524/523 l’arconte fu Milziade (II),
della famiglia dei Filaidi, colui che si recò qualche anno più tardi in Chersoneso per rilevare la
tirannide che già il suo antenato omonimo aveva istituito durante il governo di Pisistrato;
l’epigrafe registra inoltre altri nomi meno celebri che non è possibile relazionare a delle fazioni
politico-familiari a noi conosciute.
L’interpretazione che la critica offre di questo documento porta alla luce una posizione dei
Pisistratidi nei confronti degli aristocratici ateniesi molto più costruttiva e conciliatoria di
quanto la tradizione scritta abbia trasmesso. L’atteggiamento della fonti scritte tramandateci si
spiega dunque in ragione di una generale tendenza a costruire un’immagine negativa della
tirannide presso gli storici e i filosofi di V e IV secolo; inoltre le fonti a cui gli storici, Erodoto
in primis, poterono attingere provenivano dalla memoria storica delle famiglie ateniesi stesse e
dovevano perciò risentire di coloriture anti-tiranniche volte d’altronde a mettere in una luce
positiva i loro protagonisti dell’epoca arcaica e conseguentemente avvicinarne i protagonisti di
epoca classica al favore popolare dell’Atene democratica102.
È innegabile dunque che i Pisistratidi offrirono ai propri avversari sconfitti la possibilità di
partecipare alla gestione della polis e di mantenere in parte quei privilegi politici e quelle
cariche tradizionalmente concertate in seno all’élite cittadina, senz’altro a condizione che essi
sottostessero ai progetti politici della tirannide e non ne inficiassero la posizione di comando; si
evince dunque che, grazie alla propria posizione di forza, i Pisistratidi gestirono in effetti le
cariche pubbliche, ma senza nominalmente tenerne il controllo esclusivo103. L’alternativa alla
conciliazione proposta all’aristocrazia rimaneva l’esilio, che costituiva tuttavia non una
condanna penale, ma piuttosto un periodo, anche transitorio, di abbandono del campo politico.
In questa prospettiva si spiegano, a mio avviso, i giudizi positivi sulla conduzione della politica
101
Dion. Hal. Antiquit. Rom. VII 3,1.
La tradizione sull’esilio degli Alcmeonidi è attentamente analizzata da R. Thomas che ne evidenzia i temi, il
loro contesto di formazione e trasmissione e la strumentalizzazione politica in funzione filo-democratica e antitirannica: BICKNELL 1970, p. 130; THOMAS 1989, pp. 147-151. P.J. Rhodes considera la posizione di R. Thomas
eccessivamente scettica in merito alla storicità degli esili degli Alcmeonidi: RHODES 2000, pp. 121s.
103
Thuc. VI 54. CADOUX 1948, pp. 103-112; ANDREWES 1958, pp. 107-113.
102
132
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
interna ateniese, sul rispetto dei concittadini e delle leggi della polis espressi dalle fonti
scritte104.
Il modello storico di un esilio moderato e variabile
La ricostruzione verso cui vorrei muovere tenta di conciliare le due tradizioni
contraddittorie relative, per un verso, all’esilio degli oppositori politici della tirannide e degli
Alcmeonidi in particolare, e per altro verso alle prove della presenza degli Alcmeonidi e di altri
soggetti politicamente attivi fra le magistrature ateniesi durante il regime pisistratide: le tracce
epigrafiche non possono intendersi diversamente da quanto sopra illustrato, eppure ritengo che
le notizie preservate dalle fonti storiche non siano da disconoscersi esclusivamente come una
tarda costruzione propagandistica e ideologica di parte alcmeonide105. L’episodio di
Leipsydrion attesta infatti con sicurezza che, perlomeno nel 513 ca., esisteva un gruppo di
Alcmeonidi in esilio e avversati dal tiranno Ippia al punto da dover tentare il rientro in Attica
con la forza. La presenza di Alcmeonidi e di Filaidi fuori dall’Attica non è da mettersi in dubbio
nemmeno per il periodo precedente poiché i primi ebbero interessi economici e politicoideologici che li impegnarono nella ricostruzione del santuario di Delfi, dopo il 548; mentre i
secondi presero parte ad una significativa impresa strategico-coloniale nel Chersoneso per tutta
la durata della seconda metà del VI secolo e nei primi anni del V106.
Un dato da salvaguardare delle fonti letterarie è che si sviluppò ad Atene una naturale
condizione di opposizione e antagonismo, più o meno marcata a seconda dei casi, da parte delle
famiglie aristocratiche contro i Pisistratidi: gli Alcmeonidi furono fra i sostenitori di una linea
più intransigente, mentre i Filaidi sono da inserirsi nell’estremo opposto di questa scala di
valori. La reazione del tiranno di fronte all’opposizione aristocratica fu d’altronde senz’altro più
articolata e razionale di quanto non sia stato tramandato dalla classica immagine letteraria di
violenza e oppressione. È dimostrato che i Pisistratidi potevano contare su un sostegno politico,
su ricchezze e capacità militari sufficienti per sconfiggere in battaglia gli avversari, per esiliarli
o ridurli all’inattività; nondimeno la capacità di imporre il proprio dominio dovette fare anche
affidamento sulla ricerca di un’intesa con gli avversari sconfitti, di una conciliazione, tramite
l’offerta di compartecipare alle cariche magistraturali e alla politica ateniese: eliminati gli
individui più intransigenti, si dovette cioè riorganizzare quella forma di concertazione della vita
104
Hdt. I 59; Thuc. VI 54; Aristot. Ath. Pol. 14.3, 16.1-17.1; Aristot. Pol. V 10-23 (1314a-1316a). HORNBLOWER
2008, ad Thuc. VI 54.5. Sul rispetto delle istituzioni ateniesi da parte dei Pisistratidi e sulla gestione della politica
interna ed edilizia: ANDREWES 1958, pp. 107-113; AMPOLO 1973; STAHL-UWE 2009, pp. 149-151.
105
Vd. Supra, pp. 119ss. K.H. Kinzl non riscontra alcuna contraddizione tra i dati forniti dalle fonti letterarie quelli
forniti dall’epigrafia, pur senza proporre una specifica ricostruzione delle modalità e delle fasi degli esili degli
Alcmeonidi: KINZL 1976.
106
BICKNELL 1970; NENCI 2006, pp. 245s.
133
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
politica cittadina che era pratica normale nella polis arcaica, seppure con uno sbilanciamento
egemonico a favore della famiglia dei tiranni107.
È necessario peraltro focalizzare l’attenzione su alcune caratteristiche della polis e della
società greca: queste devono intendersi come un ambiente fortemente permeabile per ciò che
riguarda le attività della classe aristocratica a cui afferivano i tiranni e i loro oppositori. I
protagonisti delle vicende qui esaminate erano individui cioè in grado di viaggiare, di
frequentare i luoghi e gli eventi per eccellenza panellenici quali i santuari e gli agoni ed erano
in grado di sostenere le proprie necessità e riorganizzare le proprie attività fuori dai territori
nativi anche per lungi periodi; i gruppi familiari avevano ampie reti di contatti, numerosi
sostenitori internazionali e interessi in aree anche lontane dalle loro poleis. In questa
prospettiva, nel momento in cui si instaurò la tirannide di Pisistrato o in cui quella di Ippia si
volse verso un atteggiamento più violento e pericoloso, la soluzione aperta ad un oppositore dei
Pisistratidi era quella di lasciare volontariamente Atene e l’Attica per spostare la propria sede e
le proprie attività in altri centri comunque afferenti alla sua rete di relazioni internazionali e agli
interessi della sua famiglia. Questa soluzione si può definire come un esilio imposto dal tiranno,
e così passò nelle fonti storiche, quando la situazione da cui aveva avuto origine era un evento
violento che metteva a repentaglio la vita degli esiliati: così fu infatti per gli Alcmeonidi ed altri
in occasione della battaglia di Pallene nel 546, oppure dopo la reazione di Ippia all’assassinio di
Ipparco nel 514. Per altro verso l’esilio può considerarsi una scelta soggettiva e strategica se
l’aristocratico decideva di lasciare Atene a causa della limitatezza delle possibilità politiche che
il controllo tirannico gli aveva imposto: questi individui sceglievano di perseguire la propria
affermazione politica fuori da Atene in luoghi a loro familiari, legati alla loro tradizione
familiare, ossia sceglievano di cercare per sé e la famiglia una posizione migliore e più
vantaggiosa nello scenario internazionale, piuttosto che in quello locale. Questa interpretazione
dell’esilio si avvale anche di una contestualizzazione delle famiglie aristocratiche e
dell’organizzazione statale adeguata all’epoca arcaica quando la famiglia e il gènos costituivano
soggetti politici, oltre che sociali, di primaria importanza nella gestione della polis; per via delle
caratteristiche intrinseche ai rapporti familiari, il gènos poteva dunque mantenere la propria
identità, la propria unità, la propria linea politica e i propri interessi vitali indipendentemente
dalla collocazione geografica e anzi avvantaggiandosi della dislocazione internazionale dei
107
Hdt. I 59; Aristot. Ath. Pol. 16.9; Pol. V 11 (1315b). BICKNELL 1970; GREENHALGH 1972.
134
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
propri membri. In un certo senso il gènos va considerato come uno stato entro lo stato,
indipendente da esso e dal territorio in parte108.
Infine non credo sia da trascurarsi la dimensione individuale e soggettiva nel ricostruire
l’opposizione fra aristocrazia poleica e tirannide: le famiglie aristocratiche avevano senz’altro
una posizione politica e una rete di interessi e contatti condivisa da tutti i membri imparentati;
eppure è comprensibile che entro l’ampio numero dei componenti di un gènos e delle famiglie
ad esso affiliate esistesse una molteplicità di reazioni individuali diverse di fronte alla tirannide,
alla perdita di indipendenza politica e di prestigio che essa impose e alle situazioni di pericolo
che la violenza politica comportava109. Cosicché mi pare corretto ritenere che, con
l’affermazione del potere personale di Pisistrato, quegli aristocratici che più si erano
compromessi nella lotta politica o militare contro di lui si siano visti costretti a lasciare Atene,
temendo per la propria vita; dovettero d’altronde esservi altri che colsero la situazione
sfavorevole per rivolgere i propri sforzi ad altri luoghi ove la loro famiglia aveva degli interessi,
lasciando la città con una preparazione più agevole e meno precipitosa, allontanandosi dalla
patria per periodi transitori e rimanendo in contatto con la politica ateniese assumento una
posizione di liminarità o di transitorietà fra il contesto locale e quello internazionale; non dubito
che altri ancora accettarono di limitare la propria visibilità politica e di rimanere in Attica, nelle
proprietà familiari110. Assume cogenza ora l’affermazione di Tucidide che, concludendo il
racconto sull’esilio degli Alcmeonidi a seguito del tentativo tirannico ciloniano, afferma che,
nonostante la loro fuoriuscita:
[gli Alcmeonidi] finirono sempre col ritornare, e la loro discendenza vive ancora in
città111.
Concludo fornendo una ricostruzione a mio avviso attendibile degli esìli e delle
fuoriuscite degli Alcmeonidi durante la tirannide dei Pisistratidi112. Nella battaglia di Pallene,
nel 546, Pisistrato sconfisse l’armata cittadina e gli oppositori aristocratici fra i quali
primeggiavano gli Alcmeonidi; a seguito del conflitto un numero consistente dei membri della
108
Si consideri il lessico tipico delle relazioni interstatali con cui Megacle si rivolge a Pisistrato nell’invitarlo a
ritornare dal primo esilio. DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 93-95.
109
Prospettive attente alla comprensione delle spinte soggettive in relazione alle cause della tirannide arcaica e alla
direzione politica delle famiglie aristocratiche in: DREWES 1972, p. 129; STEIN HÖLKESKAMP 2010, s.v.
“Philaidae”.
110
La possibilità che non tutti, ma solo parte degli Alcmeonidi fossero in esilio è accettata da parte della critica:
FORNARA 1967, p. 294-; BICKNELL 1970; KINZL 1976; NENCI 2006, pp. 245s. CULASSO GASTALDI 1996, pp. 507509 traccia un quadro dell’ambigua posizione dei Filaidi nei confronti dei tiranni che può associarsi al discorso qui
sviluppato. Sull’identificazione delle sedi in Attica degli Alcmeonidi: ELIOT 1967; BICKNELL 1970.
111
Thuc. I 126.12.
112
Ricostruzione analoga è condivisa succintamente da RHODES 2000, p. 121.
135
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
famiglia dovette lasciare la polis, in considerazione del pericolo costituito dall’esercito
pisistratide e nel timore di ritorsioni dopo quel fatto di sangue. Nel forzare l’esilio degli
Alcmeonidi più scomodi Pisistrato poté peraltro, a mio avviso, fare appello all’accusa di
empietà che gravava sulla famiglia: Pisistrato stesso l’aveva sfruttata in occasione della rottura
dell’alleanza matrimoniale con Megacle, prima dell’esilio in Tracia; inoltre, si è appurato,
l’accusa fu un efficace strumento politico anti-alcmeonide fino al secolo successivo113. L’esilio
di parte degli Alcmeonidi dopo la battaglia di Pallene mi pare provato dalla loro presenza a
Delfi, impegnati nella ricostruzione del tempio, negli anni successivi all’incendio avvenuto nel
548114. Non dubito d’altronde che fra quei cittadini che, alla battaglia di Pallene, i figli di
Pisistrato convinsero a non fuggire e a ritornare alle loro occupazioni ci furono anche membri
degli Alcmeonidi che dunque non furono esiliati; altri dovettero inoltre ritornare ad Atene dopo
il primo periodo di instaurazione della tirannide di Pisistrato, quando fu appurata la posizione
non intransigente del tiranno nei confronti della famiglia e il suo indirizzo conciliatorio nella
politica interna. Così si spiega la presenza degli Alcmeonidi ad Atene, provata dai nomi della
lista degli arconti, per l’anno 525. L’assassinio, nel 514, di Ipparco fratello dell’allora tiranno
Ippia, determinò una posizione più violenta e repressiva da parte del tiranno nei confronti degli
oppositori politici: questo fatto di sangue segnò un secondo momento di fuga degli Alcmeonidi
da Atene115. Non solo gli storici tramandano esplicitamente questo cambiamento di regime nel
514116, ma la ricostruzione collima con una contestualizzazione cronologica e strategica degli
eventi che, nel giro di quattro anni da allora, portarono alla caduta della tirannide pisistratide.
Ippia dovette imporre con la violenza la fuga di molti avversari, in primis i membri degli
Alcmeonidi: poco dopo infatti gli Alcmeonidi, a capo dei fuoriusciti, tentarono senza successo
di rientrare con la forza in Attica occupando la fortezza di Leipsydrion, nel 513 ca117. Nel corso
di tutto il VI secolo gli Alcmeonidi avevano mantenuto la propria favorevole posizione presso il
santuario di Delfi e si erano guadagnati ancor più il favore dei sacerdoti gestendo l’appalto per
la ricostruzione del tempio; ora impiegarono ancora le proprie ricchezze, pure in modo
disonesto, subornando la Pizia affinché, nei suoi responsi oracolari, spingesse gli Spartani ad
assumere una posizione anti-pisistratide. Delfi dunque costituì un punto di raccolta degli
Alcmeonidi ove trovare ospitalità, trovare alleati e organizzare la strategia per il rientro. L’esito
113
THOMAS 1989, pp. 149s.; RAAFLAUB 1996, pp. 1048s.; PRANDI 2000, pp. 12-15.
STAHL 1987, pp. 120-138.
115
Hdt. V 62; Aristot. Ath. Pol. 19.1. MERITT 1939, pp. 61s.; THOMAS 1989, p. 148.
116
Hdt. V 56, 62; Aristot. Ath. Pol. 19.1.
117
Hdt. V 62; Aristot. Ath. Pol. 19.3.
114
136
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
di queste iniziative fu infine appunto l’intervento spartano contro Atene e la cacciata dei
Pisistratidi nel 510118.
III.5. La rete delle relazioni internazionali degli Alcmeonidi
Sulla base della ricostruzione ora proposta e della storia della famiglia degli Alcmeonidi
mi pare utile portare avanti ulteriormente l’interpretazione e la riflessione al fine di individuare
la posizione della famiglia nello scenario internazionale, individuare i centri di potere della sua
rete di alleanze familiari e conseguentemente, per difetto, comprendere quali aree e quali
soggetti politici erano interdetti al contatto e ai propositi dei Pisistratidi. La storia degli
Alcmeonidi vede i contatti internazionali di questa famiglia incentrati su quattro soggetti
principali: la dinastia mermnade di Lidia all’inizio del VI secolo, il santuario panellenico di
Delfi, la famiglia tirannica di Sicione e, con la fine del secolo, Sparta.
Fin dalla fine del VII secolo la famiglia ricoprì una posizione di grande rilievo nella
politica locale ateniese: ne è prova il ruolo cruciale dei magistrati alcmeonidi in occasione
dell’incidente di Cilone nel 636. L’analisi condotta su quella serie di eventi ha evidenziato nella
reazione avversa degli Alcmeonidi il segno della loro collocazione economico-politica in seno
ad un indirizzo di apertura della polis alla navigazione e ai commerci internazionali, contro
quelle fazioni conservatrici ed oligarchiche che miravano a mantenere Atene entro una politica
economica autarchica, cui sembra appartenesse appunto Cilone. La ricchezza e gli interessi
commerciali della famiglia sono anche a fondamento delle pur scarne e romanzate notizie
relative ai contatti fra Alcmeone e la dinastia dei sovrani di Lidia all’inizio del VI secolo: si può
dunque ricostruire che tramite l’appoggio della corte lidia la famiglia si assicurò la possibilità di
intraprendere significative attività commerciali in Asia Minore119. La componente degli
interessi emporici si riscontra infine anche nella generazione successiva degli Alcmeonidi
quando, nel 560, Megacle II fu a capo della fazione politica dei Paralii (Paràlioi), ossia “gli
abitanti della costa”, che la critica ritiene appunto essere quella parte degli Ateniesi afferente al
ceto artigianale e commerciale, maggiormente interessato a spingere la navigazione ateniese
verso l’Egeo e il Mediterraneo120. Fu appunto sulla base di questa linea politica aperta alla
navigazione e al commercio che Megacle e Pisistrato poterono pensare ad una alleanza nel
periodo fra il 560 e il 554, quando Pisistrato sposò la figlia dell’Alcmeonide.
118
FORREST 1969 a, sulla tradizione storiografica del rapporto fra Alcmeonidi, Delfi e Sparta che culminò
nell’espulsione di Ippia nel 510.
119
URE 1922, pp. 64s.; DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 92-100.
120
ANDREWES 1958, pp. 100-107.
137
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
Il legame con i Mermnadi di Lidia è attestato per Alcmeone e dunque a partire dal primo
decennio del VI secolo; questa alleanza non solo assicurò alla famiglia la possibilità di accedere
alle aree costiere micrasiatiche indisturbata dall’autorità che governava il territorio, ma anche la
possibilità di contare sulle grandi risorse finanziarie di quei generosi sovrani orientali121; in
cambio gli Alcmeonidi funsero da mediatori religiosi e culturali per i Lidi presso il santuario di
Delfi. Si consideri poi che l’alleanza familiare con i celebri sovrani di Lidia dovette apportare
agli Alcmeonidi anche un miglioramento del loro status e del loro prestigio a livello
panellenico, indipendentemente dai risvolti prettamente economici. Se, come mi pare
necessario, si vuole accettare la storicità del primo antico esilio imposto al gènos durante
l’attività di Solone all’inizio del VI secolo, è probabile che la corte dei sovrani di Lidia abbia
costituito anche un luogo di asilo ed ospitalità per un pur breve intervallo fino all’amnistia
soloniana. Non a caso dunque Pisistrato riuscì a imporre la propria tirannide ad Atene soltanto
al suo terzo tentativo nel 546, quando infatti nel Vicino Oriente i grandi eventi storico-politici
avevano creato una situazione drammatica per il regno di Lidia. È appunto in quella data che
Ciro, re di Persia, condusse il proprio regno ad una inarrestabile espansione e sconfisse Creso
provocando la caduta e l’assimilazione del regno di Lidia; in quelle circostanze gli Alcmeonidi
videro probabilmente mancare i ricchi donativi e prestiti che fino ad allora avevano ricavato dai
propri alleati orientali, cosicché non poterono più eguagliare economicamente, e dunque anche
sul piano delle risorse messe in campo, l’avversario Pisistrato che faceva ritorno in Attica dopo
essersi arricchito con le operazioni minerarie in Tracia122. In questa prospettiva dunque si può
meglio collocare la cronologia delle iniziative pisistratidi in Asia Minore, quali la spedizione
dei Filaidi in Chersoneso Tracico e la conquista di Sigeo, solo dopo il 546.
Nel 575 ca. gli Alcmeonidi furono scelti da Clistene, tiranno di Sicione, come famiglia
alleata presso la polis di Atene; i significati di questa alleanza matrimoniale, sancita dall’unione
di Megacle con Agariste e meriterebbero una trattazione la cui ampiezza non è qui
consentita123. Nondimeno si consideri ora che con quell’alleanza gli Alcmeonidi si assicurarono
un alleato nel Peloponneso, contrastando di fatto la politica internazionale di Pisistrato che,
oltre a contare su una antica xenìa con Sparta, aveva alleati significativi ad Argo e, per loro
tramite, una posizione favorevole presso Corinto. L’opposizione naturale che vigeva fra le due
potenti poleis dell’istmo, Corinto e Sicione, si riscontra dunque anche nella scelta dei rispettivi
121
DAVERIO ROCCHI 1973, p. 95-98.
URE 1922, p. 64; HOPPER 1961, pp. 141-146.
123
MCGREGOR 1941; PARKER 1994.
122
138
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
alleati operata dagli opposti Pisistrato e Megacle124. La tirannide degli Ortagoridi finì però
intorno al 550 ca. per iniziativa di Sparta e conseguentemente la polis entrò nella Lega del
Peloponneso; è possibile a mio avviso che gli interessi familiari che gli Alcmeonidi avevano
coltivato a Sicione non si siano interrotti ma siano continuati con il nuovo governo
repubblicano: se così fosse si aggiungerebbe un elemento ulteriore a rendere conto della
convergenza degli interessi degli Alcmeonidi e degli Spartani alla fine del VI secolo.
Il santuario panellenico di Apollo a Delfi fu il più importante dei centri di potere a cui si
legarono gli Alcmeonidi, fu determinante per la loro capacità di affermazione sia nel contesto
internazionale che sul piano della politica locale ateniese e fu senz’altro un elemento decisivo
nella loro finale vittoria sulla tirannide. Il rapporto privilegiato col santuario ebbe inizio a
seguito dell’intervento di Atene, capeggiato da Alcmeone, nella Prima Guerra Sacra, nel primo
decennio del VI secolo. L’atteggiamento favorevole che il santuario assunse da quel momento
in poi verso gli Alcmeonidi fu probabilmente uno dei motivi, pure non l’unico, che
contribuirono a spostare l’opinione pubblica ateniese nuovamente a favore del gènos, dopo
l’accusa di empietà, e a permetterne il rientro dall’esilio, grazie all’amnistia di Solone125. In
virtù della loro posizione privilegiata presso il clero delfico gli Alcmeonidi funsero da
mediatori culturali e religiosi per gli emissari lidi presso il santuario, in occasione delle loro
consultazioni e dei loro donativi; senza questa contropartita in terra greca, gli Alcmeonidi non
avrebbero avuto capacità sufficienti per poter contare sull’alleanza con i Mermnadi. Il figlio di
Alcmeone, Megacle II, assunse l’appalto per la ricostruzione del tempio di Apollo dopo
l’incendio del 548: malgrado alcune contraddizioni nelle fonti relative al margine di profitto
economico che la famiglia avrebbe ricavato, si può determinare che l’iniziativa fu senz’altro
determinante nell’elevare il loro prestigio internazionale e i loro meriti presso il santuario ed
entro la comunità panellenica126.
La ricostruzione del tempio e l’esilio imposto da Pisistrato dopo la battaglia di Pallene
quasi coincidono cronologicamente: questo significa che Delfi costituì probabilmente un luogo
di asilo per i fuoriusciti alcmeonidi da Atene; inoltre si spiega con maggiore facilità la loro
attiva presenza al santuario durante i restauri e per tutta la seconda metà del secolo. Poiché gli
Alcmeonidi si erano assicurati il favore dell’oracolo, viceversa i Pisistratidi non poterono mai
contare sull’appoggio di quell’autorità morale e dovettero anzi la propria sconfitta all’influenza
124
DAVERIO ROCCHI 1973.
PRANDI 2000, pp. 14-20.
126
Hdt. I 80, V 63; Isoc. Antid. 232; Aristot. Ath. Pol. 19; Strab. IX 421; Paus. X 5.13. URE 1922, p. 64; DAVERIO
ROCCHI 1973, pp. 92-101, 103, STAHL 1987, pp. 120-138; SHAPIRO 1989, pp. 49s.; HAGG-MARINATOS 1993, p.
181.
125
139
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte III: Gli Alcmeonidi, oppositori dei Pisistratidi
dei responsi della Pizia. Sia Pisistrato che Ippia portarono avanti una chiara politica religiosa
tramite l’istituzione di festività religiose e la costruzione di edifici di culto, ma Delfi rimase
sempre fuori dalla loro sfera di iniziative127. Si è proposta l’interpretazione del matrimonio di
Pisistrato e Timonassa in chiave di un avvicinamento, pur tardivo, del tiranno al gènos degli
antichi tiranni corinzi; l’inserimento di Pisistrato entro la rete familiare cipselide collima con
l’avversione del santuario nei suoi confronti: i Cipselidi infatti non avevano partecipato alla
Prima Guerra Sacra e la loro fama fu sempre inficiata, da allora in poi, dalla posizione
indifferente di Delfi nei loro confronti128. Fra le iniziative internazionali a carattere religioso di
maggiore portata, Pisistrato compì una purificazione dell’isola sacra di Delo: anche nel
rivolgersi alla medesima divinità dunque Pisistrato volle, o dovette, scegliere un santuario del
tutto diverso e lontano da quello dell’Apollo di Delfi. La narrazione delle fonti è esplicita infine
nel delineare il quadro che portò alla caduta della tirannide di Ippia: gli Alcmeonidi sfruttarono
il loro indiscusso prestigio a Delfi per convincere la Pizia a fornire responsi a loro favorevoli;
cosicché ogni qualvolta gli Spartani interrogavano l’oracolo, ricevevano sempre il medesimo
responso che li esortava a liberare Atene dai tiranni.
Alla fine del VI secolo, prese corpo l’intesa fra Alcmeonidi e Sparta e poco prima del 510
si palesò la posizione anti-pisistratide di quella polis; ma si trattò, a mio avviso, di una
convergenza di interessi a breve termine, non certo un’alleanza strutturale: questo è evidente dal
fatto che, caduti i Pisistratidi e rientrati gli Alcmeonidi, Sparta appoggiò da quel momento in
avanti soggetti avversi a quella famiglia, preferì cioè Isagora a Clistene nel confronto che si aprì
fra i due partiti politici post-tirannici e successivamente (504 ca.) richiamò il vecchio Ippia
malgrado l’avversione degli alleati della Lega peloponnesiaca.
127
128
FORREST 1982 b , pp. 315-317; SHAPIRO 1989, pp. 49s.
FORREST 1982 b, pp. 315-317; SALMON 1997, p. 228.
140
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
PARTE IV: PISISTRATO TIRANNO
L’importanza dello scenario internazionale non cessò con la presa della tirannide ad Atene
da parte di Pisistrato: le risorse militari, economiche e politiche al di fuori dell’Attica ebbero un
ruolo chiave nella conservazione del potere ad Atene, sia per Pisistrato che, in seguito, per il
successore Ippia. È soprattutto interessante prendere atto del fatto che Pisistrato perseguì
un’attiva politica estera, sia nella cura degli interessi familiari e delle relazioni personali, ma
anche nella conduzione delle attività e degli interessi della polis e dei propri concittadini; le
principali imprese e aree di interesse che si discuteranno sono: la sottomissione di Nasso alla
tirannide dell’alleato Ligdami, la purificazione dell’isola sacra di Delo, la conquista e il
mantenimento di una posizione al Sigeo, l’iniziativa coloniale degli alleati ateniesi filaidi nel
Chersoneso Tracico. Ognuno di questi eventi merita una discussione specifica poiché legato a
spiegazioni causali proprie e a problemi storiografici ed interpretativi peculiari.
IV.1. Strategia e diplomazia nelle Cicladi: la conquista di Nasso e la tirannide di Ligdami
La cronologia dell’attacco a Nasso
Erodoto e Aristotele tramandano che, dopo la vittoria di Pallene e la conquista della
tirannide ad Atene, Pisistrato mosse alla conquista di Nasso; l’isola fu presa con le armi e
Pisistrato vi impose la tirannide dell’alleato Ligdami, il quale in precedenza era venuto da
Nasso ad Eretria alla vigilia della battaglia di Pallene offrendo denaro e soldati1; a Nasso furono
anche subito trasferiti in ostaggio i figli di quegli Ateniesi che si erano opposti strenuamente al
tiranno nella battaglia di Pallene. Aristotele contribuisce a chiarire il sintetico quadro fornito da
Erodoto spiegando che fra la vittoria di Pallene e la spedizione contro Nasso intercorse un
periodo di tempo nel quale il nuovo tiranno ateniese disarmò la cittadinanza e si preoccupò di
rendere saldo il proprio potere2.
La conquista di Nasso e la realizzazione della tirannide di Ligdami sarebbero dunque da
intendersi come un’iniziativa dovuta in segno di riconoscenza per i meriti che il Nassio aveva
acquisito nei confronti di Pisistrato in preparazione e in occasione della battaglia di Pallene. La
sequenza di eventi dipanata in narrazione pone in successione: le offerte di Ligdami a Pisistrato
in preparazione di Pallene, da datarsi al 546 o, poco prima, al 547-548; la vittoria di Pisistrato e
1
2
Hdt. I 64.1s.; Aristot. Ath. Pol. 15.3. BERVE 1967, pp. 78s.
Hdt. 64.1; Aristot. Ath. Pol. 15.3s.
141
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
degli alleati a Pallene nel 546; dopo la presa della tirannide, la spedizione navale militare contro
Nasso, l’affidamento del potere a Ligdami e il confino colà dei giovani ostaggi ateniesi, da
datarsi al 546 o poco dopo, al 545-5443.
La sequenza cronologica e la serie di contatti e iniziative sopra esposti possono d’altronde
essere meglio precisati e analizzati al fine di comprendere il quadro delle relazioni
internazionali dei Pisistratidi e della tirannide di Ligdami di Nasso.
B.M. Lavelle ha proposto un’attenta critica alla ricostruzione diacronica degli eventi sopra
delineata secondo cui la conquista di Nasso e l’affidamento dell’isola al potere di Ligdami
furono iniziative che Pisistrato avrebbe condotto prima del rientro ad Atene, nel periodo
intercorso fra l’arrivo dei Pisistratidi ad Eretria e la battaglia di Pallene, da collocarsi perciò nel
548-547. Sorprende in effetti che i Pisistratidi abbiano deciso di intraprendere la conquista di
Nasso subito dopo la presa della tirannide ad Atene, cioè in un periodo politicamente delicato in
cui il loro potere non poteva ancora essere del tutto saldo; per contro la conquista dell’isola non
poté essere una impresa semplice e dovette richiedere dispendio di tempo e di risorse
economiche e un’ampia disponibilità di risorse navali e militari4. Si potrà però rispondere a
questa critica facendo affidamento al testo dell’Athenàion Politèia nella quale Aristotele
dimostra di essere al corrente di un certo intervallo di tempo successivo alla presa del potere ad
Atene, durante il quale Pisistrato assestò il proprio potere locale prima di volgersi all’impresa di
Nasso5. La cronologia non è dunque a mio avviso l’unico elemento su cui si vorrà meglio fare
luce.
L’accordo tra Pisistrato e Ligdami
È verosimile che la strategia seguita da Pisistrato nella preparazione del suo definitivo
rientro ad Atene abbia richiesto che i Pisistratidi rimanessero ad Eretria per un periodo non
breve, sufficiente perché tutti i loro alleati internazionali rispondessero all’appello e si recassero
in Eubea e perché i Pisistratidi organizzassero l’esercito e lo sbarco a Maratona; durante la
3
Questa è la ricostruzione accettata da gran parte della critica moderna: SANDYS 1912, pp. 56-59; HIND 1974, p.
15; ANDREWES 1982 b, pp. 399s.; FROST 1984, p. 291; HAAS 1985, p. 44; CAWKWELL 1995, p. 78; DE LIBERO
1996, pp. 236s.
4
Per ricostruire un’immagine delle capacità militari di Nasso, si consideri che, nel 500, il tiranno di Mileto,
Aristagora, e il satrapo persiano di Sardi, Artafrene, impiegarono una flotta di 200 navi al comando del cugino del
Gran Re per conquistare l’isola. La conquista di Nasso da parte dei Persiani avvenne d’altronde in un periodo
storico in cui l’isola disponeva di una flotta particolarmente numerosa e capace e godeva di una speciale posizione
di potere nel controllo del mare: la talassocrazia di Nasso è infatti collocata dalle fonti antiche nel decennio
anteriore alla sua conquista da parte dei Persiani, nel periodo 510-500. È pure possibile che le capacità militari di
Nasso non fossero ancora di tale portata nel 546 all’epoca dell’attacco di Pisistrato, ma certamente è necessario
inferire che non poteva costituire una facile preda. Hdt. V 30-32; Euseb. Chron. arm. p. 321 Aucher. FORREST
1969 b, pp. 97-104; LAVELLE 2005, pp. 136-139; ANDREWES 1982 b, p. 403.
5
SANDYS 1912, pp. 60-69.
142
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
permanenza ad Eretria Pisistrato ebbe inoltre il tempo sufficiente per intavolare trattative
familiari con gli aristocratici locali e sposare Koysira6. Ad Eretria Pisistrato avrebbe peraltro
dovuto portare con sé un contingente di mercenari traci che rimasero però inutilizzati fino
all’iniziativa militare; vista la disponibilità di tempo e risorse militari, Pisistrato avrebbe dunque
deciso di intraprendere un felice tentativo di espansione militare del proprio dominio
internazionale: in questa prospettiva B.M. Lavelle interpreta la conquista militare di Nasso e vi
assegna una datazione anteriore alla battaglia di Pallene, intorno cioè al 548. Lavelle inserisce
dunque Ligdami di Nasso fra quei soggetti ai quali i Pisistratidi, nel momento in cui decisero di
preparare il rientro dal secondo esilio, sollecitarono doni in virtù degli obblighi (proaide/ato)
verso la loro famiglia; questo meccanismo si basava su un legame di debito, su un sentimento di
reciprocità degli alleati verso i Pisistratidi, contratto per via di precedenti beneficienze ricevute.
In questa prospettiva lo studioso pone la conquista di Nasso e l’affidamento del governo a
Ligdami, da parte di Pisistrato, come causa e antecedente del contributo del Nassio all’impresa
di Pallene7.
A favore della ricostruzione proposta da B.M. Lavelle, si aggiunge una considerazione
relativa alle scelte sintattiche operate da Erodoto nella sua narrazione. Nel menzionare la
conquista di Nasso e il trasferimento colà degli ostaggi ateniesi egli si esprime infatti usando il
tempo aoristo medio (καὶ γὰρ ταύτην ὁ Πεισίστρατος κατεστρέψατο πολέµῳ καὶ ἐπέτρεψε
Λυγδάµι)8. L’uso di questo tempo verbale potrebbe significare che l’autore menzioni la
conquista di Nasso dopo la battaglia di Pallene solo in funzione della propria sequenza
narrativa: giunto cioè a descrivere il trasferimento a Nasso degli ostaggi Ateniesi, Erodoto si
rese conto di dover esplicitare la causa antecedente a quella scelta e decise di collocare in quella
precisa sezione del testo la menzione della precedente conquista dell’isola. Secondo questa
lettura, sarebbe dunque giustificata una traduzione in questo senso: “[Pisistrato prese in
ostaggio i figli degli Ateniesi suoi avversari e li portò a Nasso] giacché Pisistrato aveva in
precedenza conquistato [Nasso] con la guerra e l’aveva affidata a Ligdami”.
La ricostruzione di B.M. Lavelle non tiene tuttavia conto della descrizione peculiare che
Erodoto fornisce di Ligdami, specificando che egli si recò ad Eretria di propria spontanea
volontà (ethelontès): questo significa perciò che Ligdami non faceva affatto parte di quel
gruppo di individui e comunità già legati e debitori di Pisistrato, ma che piuttosto egli muoveva
6
Schol. Aristoph. Nub. 48; Suda s.v. Ἐγκεκοισυρωµένην, E 87 Adler. RHODES 1981, p. 84; LAVELLE 2005, pp.
134-136.
7
LAVELLE 2005, pp. 136-139.
8
Hdt. I 64.2.
143
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
di propria iniziativa, senza esservi obbligato, con lo scopo di instaurare egli stesso un primo
contatto con Pisistrato9.
Ligdami tiranno protettore del popolo
Si aggiunge un ulteriore elemento a problematizzare la questione della conquista e della
tirannide di Nasso: tramite l’opera di Ateneo è pervenuto un frammento della Costituzione dei
Nassi di Aristotele, relativo proprio all’instaurazione della tirannide di Ligdami e agli
antecedenti di quell’evento. Secondo Aristotele vigeva a Nasso un’oligarchia di carattere
aristocratico ristretto che dava adito ad uno stato di tensione fra i detentori del potere e i
cittadini di ceto basso e medio, i piccoli agricoltori, artigiani e pescatori. Il nobile nassio
Telestagora era tenuto in grande considerazione e onorato dal dèmos per la sua saggezza e
reputazione; l’oltraggio di alcuni giovani aristocratici contro Telestagora e le sue figlie fu un
incidente sufficiente perché la tensione fra il popolo e il ceto dominante scoppiasse in una
guerra civile (stàsis); in quel frangente Ligdami, pur egli aristocratico, seppe porsi come
protettore del popolo, prese il comando della sommossa civile e giunse a rendersi tiranno di
Nasso10.
Il racconto preciso e dettagliato di cui Aristotele sembra fosse disponesse per la
Costituzione dei Nassi delinea con chiarezza una dinamica del tutto locale, legata al conflitto,
tipico della polis arcaica, fra cittadini e aristocrazia politica: il testo esclude cioè il contesto
internazionale, non fa menzione alcuna dell’intervento di Pisistrato e vede Ligdami instaurare la
propria tirannide a Nasso senza alcun aiuto esterno. Ligdami si profila così come un
aristocratico che sfrutta un momento di tensione sociale e di violenza politica per svincolare la
propria posizione dal vecchio ceto politico aristocratico, ormai avverso ai concittadini, e per
porsi come un nuovo tipo di politico in grado di assicurarsi un consenso ampio fra classi sociali
in precedenza escluse. La posizione di Ligdami nello scenario politico della propria polis e le
modalità della sua ascesa al potere possono in effetti assimilarsi da vicino alle dinamiche che
portarono lo stesso Pisistrato alla sua prima tirannide ad Atene11.
Questo quadro della tirannide di Ligdami è confermato da Aristotele nella Politica, ove
Ligdami è citato quale esempio significativo di uno dei modi in cui possono cadere le
oligarchie: cioè il caso in cui, appunto in una oligarchia, un individuo della classe dirigente
assurga a protettore del popolo e giunga a rendersi tiranno; nemmeno nella Politica dunque la
9
Hdt. I 61.
Ath. VIII 40 (347f-348c). RANKIN 1978 in cui si dà un’analisi e una contestualizzazione della vicenda entro le
dinamiche sociali e familiari della polis arcaica. Sul frammento aristotelico in Ateneo: BOLLANSÉE 2007, pp. 186189.
11
BLAKESLEY 1854 vol. I, pp. 46s., vol. II, pp. 16s.; GREENIDGE 1914, p. 30.
10
144
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
tirannide di Ligdami è considerata come promossa o instaurata dall’azione armata di
Pisistrato12. La lettura proposta del frammento aristotelico in Ateneo è dunque perfettamente
coerente e compatibile con la versione della Politica di Aristotele che, come è noto, funse da
sintesi analitica e teoretica del lavoro di ricerca della scuola aristotelica che produsse le 158
Politèiai. È vero che l’opera di Ateneo in cui è inserito il frammento della Costituzione dei
Nassi risente di forti peculiarità nel proprio soggetto e nei temi trattati ed è vero che Ateneo
dimostra uno spiccato disinteresse per i fatti della storia politica nonché un utilizzo sommario e
indiretto delle opere storiografiche citate; nondimeno non mi paiono queste caratteristiche
sufficienti per far disconoscere l’importanza e la storicità di questa versione della storia della
tirannide nassia giacché le informazioni dal frammento della Costituzione dei Nassi e quelle di
origine aristotelica dalla Politica concordano13.
Ricostruzione della vicenda, dei moventi politici e della tradizione storiografica
Vi sono dunque sufficienti elementi per eccepire alla tradizionale ricostruzione e
cronologia degli eventi relativi a Pallene, a Nasso e alla tirannide di Ligdami e per
problematizzare la relazione fra il tiranno ateniese e il suo alleato di Nasso. La ricostruzione
della relazione fra Pisistrato e Ligdami deve dunque, a mio avviso, conciliare sia le
contraddizioni rilevate dalla critica di B.M. Lavelle, cioè la difficoltà per Pisistrato di avviare
una impresa militare contro Nasso in un momento delicato come quello successivo alla presa
della tirannide, sia le incontestabili informazioni che Aristotele conserva, in due opere distinte,
relative alle vicende interne di Nasso e alla tirannide di Ligdami. Su questi presupposti mi pare
più attendibile seguire una ricostruzione secondo cui Ligdami impose la tirannide a Nasso in un
primo momento con le proprie forze, senza interventi esterni; il suo governo dovette poi
incontrare delle difficoltà che lo spinsero a ricercare l’alleanza di Pisistrato; cosicché
quest’ultimo, dopo avere ottenuto la tirannide ad Atene, investì le proprie risorse militari per
riconquistare Nasso e reinstaurare Ligdami al potere.
Le fonti aristoteliche sopra citate mi paiono elemento sufficiente per considerare con
sicurezza la tirannide di Nasso come originata, almeno inizialmente, entro le dinamiche della
12
Aristot. Pol. V 6 (1305a). Sul presupposto delle notizie di fonte aristotelica G. Rawlinson propone, piuttosto
radicalmente, di considerare come una costruzione fittizia di matrice filo-pisistratide la versione di Erodoto relativa
al supporto che Pisistrato avrebbe fornito per l’imposizione della tirannide di Ligdami: RAWLINSON 1858 vol. I, p.
201.
13
Un’analisi dei frammenti degli storici greci pervenuti nei Deipnosophistai di Ateneo nel volume di LENFANT
2007; in particolare l’analisi dei frammenti delle Politeiai aristoteliche nel contributo di BOLLANSÉE 2007,
soprattutto pp. 186-188, sul frammento della Costituzione dei Nassi qui discussa. J. Bollansée, seguendo il
commento di W.L. Newman al corrispondente passo nella Politica di Aristotele, accetta una ricostruzione storica
simile a quella qui proposta, ma ritiene che Ligdami abbia inizialmente istituito una democrazia, convertita in
seguito in una tirannide con l’ausilio di Pisistrato, vd. NEWMAN 1902, p. 346. Si fa notare però che questa
ricostruzione contraddice il quadro offerto dallo stesso Aristotele nella Politica.
145
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
stàsis nassia: secondo un modello diffuso nel mondo arcaico, Ligdami si assicurò il massimo
potere a Nasso grazie all’appoggio del dèmos, contro gli interessi dell’aristocrazia14. Per altro
verso, l’iniziativa di Ligdami nei confronti di Pisistrato e l’intervento armato dell’Ateniese
contro l’isola spingono a ritenere che Ligdami non sia stato in grado di consolidare il proprio
potere dopo il colpo di stato e che non riuscì a contrastare l’opposizione degli avversari
aristocratici locali, i quali ebbero certamente motivo per coalizzare le proprie forze contro il
nuovo tiranno: perciò egli lasciò Nasso alla ricerca di un alleato capace di coadiuvare
militarmente dall’esterno quell’appoggio politico di cui già godeva presso il dèmos a Nasso.
Proprio la presente ricerca dimostra che i governi tirannici godettero certo sempre di un grado
di appoggio interno, fra le famiglie aristocratiche che condivisero il potere oppure fra strati
sociali in precedenza esclusi dalla politica e ignorati dagli esponenti politici aristocratici;
nondimeno la componente locale raramente fu sufficiente perché le tirannidi consolidassero la
propria posizione contro gli avversari aristocratici cittadini e perciò questi governi dovettero
combinare in ogni caso l’attenzione al contesto cittadino con l’apporto di ampie risorse
economiche e militari internazionali e con la disponibilità di alleati aristocratici o tirannici
esterni all’ambito locale, disposti a intervenire diplomaticamente o militarmente in loro favore.
Ligdami, messo in difficoltà dalla reazione aristocratica al suo nuovo potere, decise di
avvicinare Pisistrato, che andava in quel momento (547-546) preparando lo sbarco a Maratona,
nella prospettiva dunque di guadagnare un alleato politico influente, interessato a rinforzare e a
garantire il suo potere a Nasso con l’appoggio di risorse militari e diplomatiche. A Pisistrato
Ligdami scelse di offrire il proprio aiuto e contemporaneamente di richiedere ospitalità e
amicizia perché proprio in quel momento Pisistrato avrebbe trovato utile il suo apporto di
denaro e uomini in vista della battaglia di Pallene: l’alleanza fra i due nasceva dunque su un
piano paritario e reciprocativo, piuttosto che costituire una forma di supplica che avrebbe
invece legato Ligdami alla soggezione del futuro tiranno ateniese. L’espulsione da Nasso fu
cioè per Ligdami l’occasione per richiedere ospitalità a Pisistrato, ad Eretria, e per intavolare un
accordo personale con lui. Ligdami aiutò dunque Pisistrato a rientrare ad Atene; viceversa,
secondo le convenzioni della reciprocità aristocratica arcaica, Pisistrato avrebbe poi aiutato
Ligdami a rientrare a Nasso.
W.W. How e J. Wells ipotizzano che Ligdami abbia subito a tutti gli effetti un esilio da
Nasso e che perciò si sia rivolto a Pisistrato15; in tal caso, secondo la pratica delle espulsioni
14
Aristot. Pol. V 11 (1315b). NEWMAN 1902, p. 346; ANDREWES 1958, pp. 101-118; DREWES 1972, pp. 129s.;
RANKIN 1978; DE LIBERO 1996, p. 235; WILSON 2000, p. 641.
15
HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 64.
146
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
degli aristocratici, nel lasciare l’isola, il Nassio dovette prendere con sé tutte le proprie
ricchezze mobili, i propri mercenari o i propri stasiòtai. L’ipotesi di una espulsione di questo
tipo ben si accorda con la necessità per Ligdami di trovare un ospite internazionale e di recarsi
egli stesso ad Eretria; inoltre proprio nelle risorse personali mobili prese con sé nella fuga
dall’isola si potranno identificare quei contributi che Ligdami mise generosamente a
disposizione di Pisistrato. È pur vero che non esistono tracce documentarie di un esilio di
Ligdami da Nasso. Non è necessario, a mio avviso, che il nuovo tiranno dell’isola fosse stato
espulso perché si recasse a proporre l’alleanza con Pisistrato; piuttosto è sufficiente ricostruire
l’intercorrere di un momento di difficoltà o di violenza politica verificatosi nelle prime fasi
della rivolta popolare dei cittadini di Nasso: forse una reazione organizzata dell’aristocrazia
nassia che abbandonò le reciproche diffidenze per coalizzarsi contro un nemico comune16. Le
vicende delle prime due tirannidi di Pisistrato costituiscono in questo senso un modello per
conoscere da vicino le dinamiche socio-politiche della crisi delle aristocrazie e dell’avvento
delle tirannidi.
Una volta che fu risolta la battaglia di Pallene e assicurata la conquista del potere tirannico
ad Atene, fu il turno di Pisistrato di onorare la beneficienza ricevuta da Ligdami: Pisistrato
restituì il denaro e i soldati ricevuti da Ligdami alla vigilia della battaglia e inoltre si impegnò a
incrementarne l’entità con un proprio contributo. La conquista militare di Nasso e la salda e
definitiva tirannide di Ligdami furono dunque una impresa congiunta di Pisistrato e Ligdami: il
Nassio mise in campo le proprie forze armate personali e si adoperò certamente nel risuscitare
le reti di appoggio politico di cui godeva nella propria polis; Pisistrato fornì invece il grosso del
contingente navale e militare. Non solo l’apporto militare di Pisistrato poté servire a
sconfiggere gli avversari più violenti di Ligdami, ma ebbe anche la funzione propagandistica di
dimostrare ai Nassi l’entità degli alleati internazionali del loro nuovo tiranno, con una funzione
deterrente in vista di eventuali nuovi sommovimenti aristocratici anti-tirannici.
La ricostruzione ora proposta rende conto peraltro di alcune delle critiche inizialmente
sollevate contro la cronologia della sequenza narrativa tradizionale. Si giustifica infatti la
vicinanza temporale fra la battaglia di Pallene e l’impegnativa missione navale nelle Cicladi:
nelle circostanze ora postulate per l’alleanza fra Ligdami e Pisistrato, quest’ultimo fu tenuto a
restituire le risorse al proprio alleato e a ricambiare l’aiuto ricevuto secondo un piano che i due
avevano stabilito. L’obiezione sollevata contro l’apparente facilità con cui fu conquistata Nasso
cade in virtù del fatto che non si trattava dunque di una conquista armata contro una polis
16
SANDYS 1912, ad Aristot. Ath. Pol. 15.3, pp. 62-67; ANDREWES 1982 b, pp. 402-404; LAVELLE 2005, pp. 136139.
147
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
organizzata, bensì del rientro armato di un tiranno che godeva già di un forte seguito personale
locale, che si sarebbe attivato politicamente o eventualmente anche con la violenza, e che
inoltre disponeva non solo delle risorse militari proprie, ma anche di quelle di un nuovo alleato.
Merita riflettere sulle circostanze storiografiche che hanno contribuito a originare due
diverse e apparentemente contraddittorie tradizioni per l’instaurazione della tirannide a Nasso:
cioè la tradizione preservata da Erodoto e da Aristotele nell’Athenaion Politeia e quella
preservata da Aristotele nella Costituzione dei Nassi tramite Ateneo e nella Politica. È
condivisibile il giudizio della critica moderna che considera il logos di Erodoto sui Pisistratidi
come essenzialmente non sfavorevole ai tiranni, soprattutto in merito alla loro gestione della
polis e delle istituzioni; un affine giudizio positivo preserva l’Athenaion Politeia17: in ragione di
questa valutazione positiva si è perciò preservata in queste due fonti una narrazione storica che
assegnava all’intervento di Pisistrato un ruolo importante nella storia di Nasso. Movente non
secondario perché le fonti di epoca classica avrebbero potuto voler marcare il legame fra Atene
e la sovranità a Nasso viene alla luce peraltro nelle circostanze propagandistiche del V secolo,
all’epoca della Lega delio-attica, quando risultò conveniente fornire un’immagine consolidata e
di antica data del primato di Atene sulle Cicladi. Sia i paragrafi di Erodoto che, ovviamente,
l’Athenaion Politeia sono chiaramente centrati sulla storia politica di Atene e dei suoi
protagonisti18: perciò pare ragionevole che i due autori abbiano adottato un criterio di selezione
che lasciava spazio esclusivo alle vicende di questa polis e al ruolo di Pisistrato. Viceversa la
Costituzione di Nasso e La politica tramandano la vicenda della stàsis interna a Nasso giacché
sono chiaramente il frutto di una raccolta di notizie che Aristotele attinse dalla storia locale ed
istituzionale di Nasso: si comprende dunque perché dedichino attenzione specifica a quella
parte della vicenda. In conclusione, si tratta a mio avviso di due tradizioni storiografiche
entrambe locali, una ateniese e l’altra nassia, preservate ciascuna indipendentemente in gruppi
di fonti distinte; fra queste, la ricostruzione storica non deve operare una scelta ma piuttosto una
riconciliazione.
Nasso nella strategia internazionale di Pisistrato
È possibile riconoscere che per Pisistrato l’alleanza con Ligdami e la posizione di potere
del suo alleato a Nasso ricadevano anche in un progetto politico di termine più lungo e di più
ampio respiro strategico. A Nasso Pisistrato trasferì in ostaggio i figli degli Ateniesi
aristocratici che si dimostrarono più intransigenti nel rifiutare la sua posizione di potere
assoluto ad Atene, dopo la battaglia di Pallene. La posizione insulare di Nasso e l’alleanza
17
18
WATERS 1971, pp. 20-26.
BLAKESLEY 1854, vol. I, pp. 46s.
148
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
personale di Pisistrato col tiranno Ligdami resero quel luogo particolarmente sicuro per il
confino dei giovani ateniesi. La pratica della presa di ostaggi è peraltro conosciuta anche per
altre tirannidi: da un lato, consentiva di mantenere in una condizione di dipendenza le famiglie
degli ostaggi in patria; per altro verso allontanava dalla politica locale individui che avrebbero
in futuro potuto costituire un pericolo per la tirannide19.
L’iniziativa militare a Nasso e l’alleanza con Ligdami rientrano in un progetto di politica
estera di espansione marittima nell’Egeo20. Nasso era infatti una posizione strategica per il
controllo della navigazione nell’Egeo: era un’isola di considerevoli dimensioni e di
significativa forza navale e la sua collocazione geografica consentiva di controllare
militarmente l’arcipelago delle Cicladi, attraverso le quali correva una delle rotte marittime che
legavano l’Eubea, e per suo tramite la Grecia, alle coste della Ionia e dell’Asia Minore21. Nella
conduzione della propria politica estera, familiare quanto statale, i Pisistratidi perseguirono
chiaramente un progetto volto a controllare posizioni strategiche nell’Egeo; questa ricostruzione
è evidente, oltre che dall’operazione militare e politica portata a termine a Nasso, anche dalle
iniziative a Delo, al Sigeo, in Chersoneso Tracico e dai precedenti interventi personali in Tracia
e in Eubea. Da un lato, il patto stretto fra i due tiranni di Atene e Nasso si configura come una
iniziativa personale volta a rinforzare reciprocamente il loro potere nelle rispettive poleis;
d’altro canto, l’impegno diplomatico e militare investito da Pisistrato al fine di far rientrare
Nasso nella propria rete di alleanze è da considerarsi, nel quadro del progetto marittimo
sopramenzionato, come una iniziativa di diplomazia estera a favore non solo della famiglia
tirannica, ma anche della cittadinanza ateniese e della posizione internazionale della polis;
l’esito fu di consolidare posizioni utili agli Ateniesi nella navigazione e nel commercio
marittimo nelle Cicladi e verso l’Asia Minore22. Questa interpretazione si appoggia sulle
considerazioni espresse in merito alla posizione strategica cruciale dell’isola di Nasso per il
controllo delle Cicladi non solo per l’epoca pisistratide ma anche per i successivi avvenimenti
della storia greca23.
Una testimonianza epigrafica conferma il quadro storico qui tracciato di un’apertura e
frequentazione reciproca, non solo fra i tiranni Pisistrato e Ligdami, ma fra le comunità di
19
Sulla pratica della presa degli ostaggi: Cfr. Hdt. III 45, 122. HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 64; PARKE 1946, pp.
107s.; CAWKWELL 1995, p. 78; RAAFLAUB 2007 b, pp. 10, 17s.; YATES 2007, pp. 36-39.
20
HAAS 1985, p. 44; DAVIES 1997, pp. 134s.
21
In questi termini, nel 500, si esprime Aristagora di Mileto nel suggerire al Persiano Artafrene la conquista di
Nasso: Hdt. V 30s. Sulla vantaggiosa posizione di Nasso e sul suo carattere strategico per la navigazione cicladica:
JEBB 1880, pp. 7s.; HAAS 1985, p. 44; CRAIK 1996, pp. 885-889; LAVELLE 2005, pp. 136-139.
22
ANDREWES 1958, pp. 110-113; LAVELLE 2005, pp. 136-139.
23
Vd. supra, pp. 94, infra, pp. 152ss.
149
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
Atene e Nasso, appunto durante la seconda metà del VI secolo. Alla fine del VI secolo fu infatti
eretto nel quartire Ceramico di Atene un monumento funerario in memoria ed in onore del
defunto Anaxila di Nasso; si tratta della più antica testimonianza della presenza di un meteco ad
Atene, da intendersi non necessariamente già come una istituzione giuridica consolidata, ma
senz’altro nel senso di uno straniero e immigrato, residente stabilmente e morto onorato ad
Atene; l’iscrizione preserva dunque la testimonianza dell’alta considerazione degli Ateniesi
verso il Nassio immigrato, nonché il nome e la riconoscenza del dedicatario ateniese24.
Fig. 3: Atene, Samo e lo scenario delle Cicladi
IV.2. La politica culturale nelle Cicladi: La purificazione di Delo (545 ca.)
La datazione e le fonti relative alla purificazione di Delo da parte di Pisistrato
Oltre che fornendo il proprio appoggio militare a Ligdami a Nasso, Pisistrato intervenne
nell’arcipelago cicladico anche con un’iniziativa di natura religiosa sull’isola sacra di Delo: il
tiranno ateniese, in obbedienza ad un oracolo, purificò l’isola rimuovendo e spostando tutte le
sepolture visibili dal santuario di Apollo. In considerazione della sequenza narrativa erodotea e
delle implicazioni strategiche e logistiche, questa operazione dovette avere luogo entro la
medesima cronologia della missione militare condotta a Nasso, dunque nel 545 ca.: è plausibile
24
IG I3 1357 = CEG 58 = SEG XXII 79. BABA 1984; PAPADOPOULOS – SMITHSON LORD 2002, soprattutto pp.
187-190; KEESLING 2005, p. 404; DUPLOUY 2006, pp. 138-142. La critica elencata offre anche discussioni
specifiche sulla restituzione, traduzione e datazione dell’epigrafe, nonché un apparato iconografico e fotografico: il
monumento funerario e l’epigrafe apposta sono infatti cruciali nello studio e ricostruzione delle origini dell’istituto
della metoikìa e per l’interpretazione storica delle riforme clisteniche. È evidente d’altronde che la discussione
specifica non è di rilievo per la ricostruzione e contestualizzazione qui proposta.
150
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
che Pisistrato abbia prima provveduto ad appoggiare l’alleato Ligdami a Nasso e che poi, da là,
abbia fatto vela verso Delo per compiere la purificazione dell’isola25.
Erodoto e Tucidide sono le fonti da cui è possibile ricostruire questi avvenimenti. In
particolare, Tucidide inserisce la sua narrazione nella cronaca dell’inverno del 426 della guerra
del Peloponneso. In quell’anno, riferisce Tucidide, Atene, obbedendo ad un oracolo, purificò
l’intera isola sacra di Apollo, rimuovendo tutte le tombe e decretando che non avessero mai più
luogo nascite o morti a Delo; gli Ateniesi designarono la vicina isola di Rheneia a questi aspetti
impuri della vita umana. In quello stesso anno gli Ateniesi re-istituirono le antiche festività
penteteriche delie a cui furono chiamati a partecipare tutti i Greci di stirpe ionica, come era
pratica nel passato più remoto e come era testimoniato dagli inni omerici. Lo storiografo sfrutta
questa notizia per inserire un breve excursus sulla storia più antica di Delo in cui riferisce di un
intervento militare e religioso del tiranno samio Policrate e in cui discute della storia e della
natura delle feste Delie26. Il passo di Tucidide è significativo non solo per le notizie storiche che
fornisce, ma perché testimonia dell’importanza ricoperta da Delo e dal locale culto di Apollo
per la storia e la cultura della Grecia e soprattutto dei Greci Ioni che abitavano le isole e il
litorale micrasiatico27. Si notano delle evidenti coincidenze fra gli avvenimenti relativi a
Pisistrato, a metà del VI secolo, e quelli relativi alle vicende della guerra del Peloponneso, nel
426: al punto che si potrebbe sospettare siano il frutto di una proiezione anacronistica delle
fonti, mirante a retro-datare ad epoche più antiche la politica religiosa di Atene nell’ambito
della Lega delio-attica. Nondimeno la critica non ritiene necessario dubitare della storicità
dell’intervento di Pisistrato: le similitudini messe qui in evidenza sono piuttosto da intendersi
come il segno di un’affinità fra la politica di Pisistrato e quella della successiva polis
democratica nelle modalità di espressione politico-propagandistica. Questi due simili interventi
cultuali a Nasso, a distanza di più di un secolo uno dall’altro, segnano cioè una tendenza
strutturale di lungo periodo nella politica estera di Atene, condotta a metà del VI secolo dal
tiranno come nella seconda metà del V secolo dalla polis democratica, mirante ad espandere e
consolidare il ruolo di Atene nelle Cicladi. Vero è che nel V gli Ateniesi poterono sfruttare a
propria giustificazione e vantaggio l’antichità dell’intervento di Pisistrato per imporsi allora
nuovamente28.
25
PARKE 1946, pp. 107s.; ANDREWES 1982 b, pp. 402-404; HAAS 1985, p. 44; HEDRICK 1988, pp. 206s.; SHAPIRO
1989, pp. 48-60; DE LIBERO 1996, p. 61, 93, 239; LAVELLE 2005, pp. 136-139.
26
Hdt. I 64; Thuc. I 8, III 104.
27
CRAIK 1996, pp. 885-900; ASHERI 1997, p. 18; DAVIES 1997, pp. 134-137; HORNBLOWER 1997, ad Thuc. I 13,
ad Thuc. III 104; BURKERT 2003, pp. 289-297, 467; MAZZARINO 2007, pp. 227.
28
Thuc. I 4, III 104. PARKE 1946; HORNBLOWER 1997, ad Thuc. I 4, pp. 18-20.
151
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
Il ruolo di Nasso nel controllo di Delo
L’alleanza fra Pisistrato e Ligdami, l’intervento navale e militare di Pisistrato a Nasso e la
purificazione rituale dell’area circostante il tempio di Apollo a Delo sono iniziative strettamente
legate fra loro29.
La storia dell’isola sacra ad Apollo fu caratterizzata, nel corso dell’epoca arcaica, da un
duplice carattere di neutralità e dipendenza politica: Delo fu infatti un santuario aperto al culto
dei Greci Ioni nonché di popolazioni non-elleniche fin dall’VIII-VII secolo30; le ridotte
dimensioni dell’isola e delle terre coltivabili e la scarsa disponibilità di altre risorse economiche
contribuirono ad impedire che l’isola acquisisse alcuna preminenza politica e limitarono il suo
ruolo a quello di centro sacrale panellenico. D’altronde proprio questi fattori imposero all’isola
una forma di dipendenza economica da quelle poleis interessate a dimostrare la propria
devozione verso il locale culto panellenico di Apollo. Già nel VII secolo, nell’Inno ad Apollo
omerico, Delo è dunque descritta come un’isola povera di bestiame, di ovini e dei frutti della
terra, con un terreno inadatto alla coltivazione; il poeta nondimeno afferma che, grazie al culto
di Apollo, molti si raccolgono colà ad offrire sacrifici e i Delii possono così giovarsi di quei
banchetti31.
La critica ha individuato una sequenza cronologica secondo cui nel VII e VI secolo fu
Nasso ad esercitare un ruolo preponderante a Delo; nella seconda metà del VI secolo quella
forma di protettorato fu assunta da Pisistrato e passò poi al potere di Policrate di Samo fino alla
sua morte nel 522. La storia della Lega delio-attica ribadisce con chiarezza come Delo fu
nuovamente posta sotto la protezione e il controllo serrato di Atene per tutta l’epoca classica32.
Le tracce archeologiche attribuiscono le prime attività di edilizia templare a Delo all’iniziativa e
alla devozione della nobiltà di Nasso, polis dotata, si è ricordato, di una buona flotta e di
capacità navali, nonché di una posizione strategicamente rilevante nel controllo della
29
LAVELLE 2005, pp. 136-139.
Le fonti antiche menzionano un culto di Apollo a Delo fin dall’VIII secolo: Hom. Od. VI 162; Paus. IV 4.1.
L’attività cultuale a Delo risale ad epoca micenea; le testimonianze archeologiche specifiche del culto di Apollo
iniziano dal VII-VI secolo. DYER 1905; BERVE-GOTTFRIED 1963, pp. 59-64, 363-366; CRAIK 1996, p. 900;
CALCYC 2004, s.v. “Delos” in BNP; RICHARDSON 2010, pp. 10-17, 81-.
31
Hom. H. Hom. h. Ap. 53-60. La datazione, l’attribuzione e le vicende della composizione dell’inno omerico ad
Apollo sono questioni filologicamente complesse su cui la critica non raggiunge un consenso unanime e la
datazione della parte delia viene variamente assegnata ad epoca compresa fra l’VIII e il VI secolo; in base a criteri
linguistici e all’analisi comparata delle due sezioni in cui si divide l’inno, mi pare più appropriato datare una prima
composizione al VII secolo, periodo che collima peraltro con i dati archeologici. Pure, con questa datazione, non si
escludere il fatto che la composizione sia stata rielaborata, scritta e recitata in circostanze storiche significative
durante il VI secolo, come ha giustamente puntualizzato la critica. FORREST 1956: metà del VI sec.; SHAPIRO 1989,
pp. 48-60; HORNBLOWER-SPAWFORD 19963, s.v. “Ionian Festivals”; HORNBLOWER 1997, ad Thuc. III 104;
BURKERT 2003, p. 467, 522; RICHARDSON 2010, pp. 13-15, 81-119.
32
JEBB 1880; PARKE 1946, pp. 107s.; MEIGGS 1972, p. 42s.; CRAIK 1996, p. 900; PARKER 1996, pp. 85-85, 148156; BURKERT 2003, p. 467; KALCYC 2004, s.v. “Delos” in BNP.
30
152
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
navigazione attraverso le Cicldi33. Alla prima metà del VI secolo e all’ininiziativa dei Nassi
risalgono una statua colossale di Apollo, la celebre serie di sculture di leoni reclinati e l’òikos
dei Nassi che, oltre a fungere da deposito delle offerte votive dei cittadini di quella polis,
potrebbe avere assolto anche a funzioni cultuali per il santuario prima che venisse costruito il
pòrinos naòs di Apollo34. È possibile, a mio avviso, che Nasso abbia riaffermato la propria
autorità su Delo dopo la morte di Policrate, negli ultimi decenni del VI secolo: a questa
ricostruzione concorrono le notizie sulla breve talassocrazia attribuita a Nasso nel catalogo di
Eusebio, datata variamente dalle interpretazioni critiche al periodo 515-510 ca., nonché le
testimonianze epigrafiche rinvenute a Delo e attribuibili a dediche nassie del periodo 520-490
ca.35.
Posto dunque per Nasso un ruolo di preminenza nel sostegno del santuario delio e nel
controllo dell’isola sacra, si chiarisce il ruolo dell’alleanza che Pisistrato strinse con Ligdami e
l’utilità della sua posizione di governo a Nasso36: con l’appoggio e l’avallo dell’autorità politica
di Nasso, Pisistrato ebbe dunque la libertà di intervenire nell’amministrazione del santuario e
delle attività cultuali, specificamente appunto eseguendo la cerimonia di purificazione dei
terreni circostanti il santuario apollineo.
Oltre alla purificazione qui discussa, parte della critica attribuisce a Pisistrato la
costruzione del primo tempio di Apollo in pietra a Delo, il cosiddetto pòrinos naòs, datato
dall’analisi archeologica appunto alla metà del VI secolo: l’attribuzione si avvale della
coincidenza cronologie, della constatazione dell’intervento armato di Pisistrato nelle Cicladi, a
Nasso, e della rilevanza storica e simbolica della purificazione condotta a Delo37. Sebbene
sarebbe logico che la famiglia tirannica ateniese avesse voluto contribuire economicamente al
sostegno del santuario, non mi pare ci siano ragioni sufficienti per andare oltre la speculazione
nell’attribuire la costruzione del tempio ad una iniziativa pisistratide, perlomeno in via diretta.
Il significato ideologico dell’intervento a Delo
L’intervento di Pisistrato a Delo ebbe un significato culturale, politico e propagandistico
profondo. Il santuario di Apollo di Delo era da antichissima data il centro cultuale comune dei
33
Vd. supra, pp. 150ss.; LAVELLE 2005, p. 139.
DYER 1905; BERVE-GOTTFRIED 1963, pp. 59-64, 363-366; KALCYC 2004, s.v. “Delos” in BNP; OSBORNE 2009,
pp. 197s.; RICHARDSON 2010, pp. 81-110.
35
Euseb. Chron. arm. p. 321 Aucher. JEBB 1880, pp. 8-10, 18-20; PARKE 1946. Sulla lista delle talassocrazie di
Eusebio vd. anche MYRES 1906, pp. 97ss.; FORREST 1969 b, pp. 95-106; MILLER 1971, pp. 5-10, 28s., 40s., 59-70.
36
HOW-WELLS 1928, app. XVI.8; HEDRICK 1988, pp. 206s.
37
JEBB 1880, pp. 8-20; FORREST 1982 b, pp. 305-318; SHAPIRO 1989, PP. 48-60; KALCYC 2004, s.v. “Delos” in
BNP; BURNEAU-DUCAT 2005, p. 182; OSBORNE 2009, p. 205, tav. 7; RICHARDSON 2010, p. 81-99.
34
153
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
Greci di stirpe ionica, un luogo che funse da fulcro dell’identità degli Ioni delle isole ma anche
delle poleis micrasiatiche e delle aree ioniche della Grecia continentale; di questa identità
culturale partecipava peraltro anche l’Attica stessa, considerata dalle fonti come la madrepatria
e il luogo di origine degli Ioni38. A Delo si tennero, in epoca alto-arcaica, le celebrazioni della
panégyris degli Ioni: una festa in onore di Apollo in occasione della quale gli Ioni navigavano
alla volta di Delo, oppure le poleis ioniche inviavano una theorìa in propria rappresentanza; al
santuario si teneva una processione sontuosa al termine della quale venivano offerte ecatombi
in onore di Apollo e si consumavano le carni in un grande banchetto comune; nel corso della
panégyris avevano luogo anche gare atletiche39. È vero che questa celebrazione era caduta in
disuso molti anni prima del tempo di Tucidide, il quale ne preservò una descrizione per la
maggior parte dipendente dall’inno omerico ad Apollo, ma in parte anche frutto delle proprie
indagini storiche. Già all’epoca di Pisistrato inoltre la Panègyris non era più un elemento del
culto a Delo. Ciònonostante, Delo e il santuario di Apollo rimasero sempre un fulcro religioso
significativo per la Grecità delle isole come è testimoniato dalla successiva storia delle Cicladi
alla fine del VI secolo e poi in epoca classica. Con la fine del potere di Pisistrato, nel 528,
Policrate, il tiranno di Samo, prese infatti il posto della tirannide ateniese nel controllo delle
acque intorno a Delo e nel patronato cultuale del santuario di Apollo: si ritiene che egli abbia
allora tentato di re-istituire la panègyris, seppure senza successo. Senz’altro poi la celebrazione
pan-ionica fu ripresa sotto l’autorità di Atene nell’ambito della Lega delio-attica, a partire dal
426.
Si può concludere dunque che la protezione e la devozione verso il santuario delio furono
dimostrazioni, in ambito culturale e religioso, necessarie per tutti quei poteri che ambirono a
controllare l’area egea delle Cicladi. In questo senso si spiega l’intervento di Pisistrato a Delo;
per le medesime ragioni intervenne poi a Delo anche Policrate nella costruzione della sua
talassocrazia e nel 490 i Persiani rispettarono e onorarono Delo e i suoi cittadini nella prima
spedizione navale contro la Grecia40. Con la purificazione del santuario di Apollo Delio,
Pisistrato volle scientemente fare una dichiarazione simbolica alla comunità panellenica, e
38
Hom. Il. XIII 685; Sol. Fr. 4 G.-P.2 (4a W.2); Thuc. I 2.6; Aristot. Ath. Pol. V 2; Plut. Sol. 10.2. SANDYS 1912,
ad Aristot. Ath. Pol. V 2; BUCK 1996, p. 869; CRAIK 1996, p. 900; HORNBLOWER-SPAWFORD 1996, s.v. “Ionians”;
ASHERI 1997, pp. 14-19; DAVIES 1997, pp. 134s.; HORNBLOWER 1997, ad Thuc. III 104; MAZZARINO 2007, p.
490; NOUSSIA 2001, p. 259; DE POLIGNAC 2009, p. 430; OWENS 2010, pp. 159s.
39
H. Hom. h. Ap. 143–164. JEBB 1880, pp. 18-22; GERNET 1983, pp. 21-61; PARKER 1996, pp. 77s., 150;
OSBORNE 2009, p. 233s.; LOHMANN 2011, s.v. “Panionion”, in BNP.
40
Policrate e Delo: Thuc. I 13, III 104; Euseb. Chron. arm. p. 321 Aucher; Suda, s.v. Pu/qia kai\ Dh/lia, P 3128
Adler, s.v. Ταῦτά σοι καὶ Πύθια καὶ ∆ήλια, T 175 Adler; vd. infra, pp. 306ss. I Persiani e Delo: Hdt. VI 97. JEBB
1880, pp. 17-20; HOW-WELLS 1928, App. XVI.8; HAAS 1985, p. 44; HORNBLOWER1997, ad Thuc. III 104;
LAVELLE 2005, pp. 136-139; OSBORNE 2009, p. 312.
154
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
soprattutto ionica, della sua aspirazione ad assumere il primato e la protezione sul santuario e
conseguentemente sulla Grecità delle isole41. L’appello all’identità di stirpe e al ruolo di
madrepatria ionica dell’Attica furono gli elementi simbolici e culturali che soggiacevano
all’iniziativa di Pisistrato; queste due rivendicazioni costituiscono peraltro un carattere di lungo
termine della politica culturale e dell’auto-identificazione di Atene: sono attestati sia prima
della tirannide, nell’opera poetica di Solone, sia successivamente a Pisistrato, come
testimoniato dalla storia di Atene in epoca classica, nella partecipazione alla rivolta ionica, nel
corso delle guerre persiane e nel ruolo assunto, come si è detto, con la Lega delio-attica42. Si
consideri l’episodio di Delo anche per la visibilità sociale e il valore propagandistico e politico
associato all’evergetismo aristocratico nei luoghi di culto condivisi: in questo senso,
l’intervento a Delo costituisce un ulteriore momento della partecipazione dei Pisistratidi a quel
circuito culturale aristocratico panellenico che ne assicurava il prestigio43.
Dunque assume un senso ulteriore quel nesso e quella contingenza, di cui si è già fatta
menzione, fra l’alleanza con Ligdami, l’attacco a Nasso e la purificazione di Delo. Fra gli
indirizzi di affermazione internazionale della propria famiglia e insieme della propria polis, si
può concludere che Pisistrato mirò alle Cicladi. Di questo progetto politico Nasso e la tirannide
di Ligdami costituirono la componente politica, militare e strategica, che assicurava al tiranno
Pisistrato un alleato personale e agli Ateniesi una località di appoggio nella navigazione
attraverso le Cicladi. Non si trascuri il ruolo di Nasso e delle Cicladi nella rotta marittima che
conduceva dal golfo saronico, oppure dall’Eubea, verso Andros, poi attraverso le Cicladi fino a
Nasso e da qui attraverso l’Egeo fino a Samo, a Mileto e in genere alla costa della Ionia. Per
altro verso, la purificazione di Delo costituì invece l’aspetto religioso, culturale e
propagandistico di questo progetto politico ed ebbe l’obiettivo di guadagnare la benevolenza del
santuario di Delo e il prestigio che da questo derivava44.
La scelta dei Pisistratidi di onorare l’Apollo di Delo
Ritengo si possa individuare e discutere un’ulteriore caratteristica dell’assetto culturale e
politico della Grecia che spinse Pisistrato a scegliere Delo e il culto locale di Apollo quale
punto di riferimento religioso e propagandistico, piuttosto che il celebre culto panellenico di
41
HOW-WELLS 1928, App. XVI.8; ANDREWES 1958, pp. 112s.
Sull’appello di Pisistrato all’identità ionica e più in genere sulla tradizione di affinità di stirpe fra l’Attica e gli
Ioni: Hom. Il. XIII 685; Sol. fr. 4 W. (Aristot. Ath. Pol. 5.2); Hdt. I 146. HOW-WELLS 1928, ad Hdt. I 142; SEALEY
1976 a, p. 143; ANDREWES 1982 a, pp. 361s.; FORREST 1982 b, pp. 305-318; ASHERI 1988, ad Hdt. I 142; BROWN –
BLAKESLEY TYRRELL 1991, p. 143; PARKER 1996, pp. 87s., 150; FIGUEIRA 2008, pp. 455s.; ZACHARIA 2008, pp.
32-35.
43
Sulla partecipazione dell’aristocrazia alle riunioni anfizioniche: PARKER 1996, pp. 86-88.
44
LAVELLE 2005, p. 136-139.
42
155
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
Apollo presso il santuario di Delfi: quest’ultimo costituiva un santuario e un circuito politicodevozionale sempre precluso all’interesse dei Pisistratidi perché, viceversa, furono gli
Alcmeonidi a godere di un legame preferenziale con l’Apollo delfico per tutto il VI secolo.
Come si è già avuto modo di analizzare estesamente, fin dall’epoca della Prima Guerra Sacra,
nel periodo 595-586, gli Alcmeonidi volsero a proprio favore l’influenza politica di Delfi e
dell’oracolo45; durante gli esìli da Atene a seguito della tirannide di Pisistrato, a partire da 546,
gli Alcmeonidi trovarono sempre un luogo di ospitalità e appoggio a Delfi; dopo l’incendio che
colpì il santuario nel 548 furono gli Alcmeonidi a contribuire largamente alla ricostruzione del
tempio di Apollo; è noto infine che fu proprio per la collusione fra il clero apollineo, la Pizia,
gli Alcmeonidi e Sparta che si verificò la caduta della tirannide dei Pisistratidi nel 51046.
Non sorprende dunque che la storiografia non abbia preservato alcuna notizia di contatti o
consultazioni dei Pisistratidi presso il santuario o l’oracolo di Delfi47. Le fonti degli oracoli e
delle predizioni pure utilizzate dai Pisistratidi, in primo luogo appunto nelle circostanze qui
discusse della purificazione di Delo, furono tuttavia altre. Si preserva notizia del fatto che, alla
vigilia della battaglia di Pallene, l’indovino (xrhsmolo/goj) Anfilito di Acarnania si trovava
presso il campo di Pisistrato e pronunciò una profezia che il futuro tiranno seppe interpretare
egli stesso48. È noto poi che i Pisistratidi tennero presso di sé l’interprete di oracoli
(xrhsmolo/goj) Onomacrito, che fu riordinatore delle profezie di Museo49. Ippia stesso fu un
riconosciuto esperto di oracoli, al punto da poterne riferire egli stesso agli alleati di Sparta che
gli rifiutarono l’appoggio al rientro ad Atene, nel 504 ca. (τοὺς χρησµοὺς ἀτρεκέστατα ἀνδρῶν
ἐξεπιστάµενος)50. L’isola sacra di Delo era stata anch’essa sede di un oracolo che era situato
nella grotta nel fianco del monte Cynthus; nella grotta sacra, non diversamente dall’oracolo
delfico, erano un crepaccio e un bàtylos, una pietra di origine celeste51. Lo storico Semos di
Delo tramanda nella propria opera sull’isola natale che, in occasione di un sacrificio offerto
dagli Ateniesi a Delo, si può supporre in occasione della panégyris ionica, avvenne un prodigio
che fu spiegato dagli interpreti oracolari (µάντεις) delii con la profezia che gli Ateniesi
avrebbero imposto il loro dominio sul mare. Buona parte della critica associa la profezia alla
45
ANDREWES 1982 a, p. 374s.
VERRALL 1894, p. 21; LANG 1899, p. 12; FORREST 1982 b, pp. 305-318; SHAPIRO 1989, pp. 49s.
47
PARKER 1996, pp. 86-89. Contra HEDRICK 1988, pp. 206s., il quale però non distingue fra il culto verso Apollo,
che i Pisistratidi chiaramente non osteggiarono, e l’intesa col santuario di Delfi; SHAPIRO 1989, pp. 49s.
48
Hdt. I 62.4-63.1. FLOWER 2008, p. 79.
49
Hdt. VII 6. Museo è un personaggio mitico, guaritore e profeta oracolare, associato alla religione orfica e al culto
ad Eleusi, vd. HEINZE 2011, s.v. “Musaeus” in BNP. Su Onomacrito, vd. MURRAY 1901, pp. 10-13, 64-69;
FLOWER 2008, pp. 63s. Sulla familiarità dei Pisistratidi con le istituzioni religiose e anche specificamente con
aspetti oracolari, vd. HOW-WELLS 1928, app. XVI, 7; FLOWER 2008, p. 218.
50
Hdt. V 93.2.
51
H. Hom. h. Ap . 79-82, 131S. JEBB 1880, pp. 18-22.
46
156
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
costituzione della Lega delio-attica nel V secolo; nondimeno le pur scarse testimonianze
puntano a collocare l’attività oracolare a Delo in epoca arcaica, non più tardi del VI secolo:
questo dato, insieme all’attività politica e religiosa di Pisistrato nelle Cicladi, contribuisce, a
mio avviso, ad avvalorare l’interpretazione offerta da F. Jacoby secondo cui questo frammento
di Semos andrebbe piuttosto contestualizzato come una testimonianza a favore di un’intesa fra
il clero di Delo e Pisistrato52. In base dunque a questi dati è possibile, a mio avviso, avanzare
l’ipotesi che fra le fonti oracolari pisistratidi vi fosse anche l’oracolo apollineo di Delo. Proprio
nel VI secolo l’oracolo di Delo andava progressivamente perdendo importanza a fronte della
crescente consultazione panellenica della Pizia di Delfi e questo spiegherebbe come il clero di
Delo potrebbe avere riposto le proprie speranze di una protezione politica nel potere del tiranno
ateniese53.
Ad ulteriore riprova dell’esclusione dei Pisistratidi dalla frequentazione di Delfi, si
consideri l’erezione dell’altare di Apollo Pizio ad Atene da parte di Pisistrato II, figlio di Ippia e
nipote del tiranno Pisistrato; l’iniziativa è da collocarsi nel 522/521, durante il suo arcontato54.
Alcuni studiosi ritengono questa una scelta dettata dalla necessità di provvedere in maniera
alternativa appunto al culto di Apollo negli aspetti che contraddistinguevano la divinità a Delfi:
per la famiglia dei Pisistratidi era necessario dimostrare ai concittadini la propria devozione
verso quella divinità, ma non sarebbe stato possibile rivolgere le proprie offerte presso il clero
di Delfi. La scelta potrebbe anche rispondere ad un progetto politico anti-delfico nel senso che
l’iniziativa evergetica di erigere l’altare mise a disposizione degli Ateniesi uno spazio sacro ove
poter pregare l’Apollo di Delfi senza la necessità di lasciare Atene: di conseguenza intaccando
parzialmente il potere propagandistico e anti-pisistratide degli Alcmeonidi a Delfi55.
La devozione dimostrata da Pisistrato verso l’Apollo di Delo e il suo santuario segnala
dunque il tentativo del tiranno di controbilanciare il potere e l’appoggio religioso che gli
Alcmeonidi, suoi avversari politici, godevano presso la medesima divinità a Delfi. Per gli
52
Semus Delius FGrHist 396 F 12 (ap. Ath. VIII 3). HORNBLOWER 1997, ad Thuc. III 104. Per un commento del
frammento di Semos e un’ampia discussione sulla mantica delia vd. BETELLI 2011, ad Semos BNJ 396 F 12, in
BNJ.
53
RICHARDSON 2010, pp. 13-18 per la datazione delle prime attestazioni dell’attività oracolare della Pizia all’inizio
del VI sec.
54
HEDRICK 1988, pp. 206s.; SHAPIRO 1989, pp. 48-60.
55
IG I2 761. Thuc. II 15, VI 54s. VERRALL 1894, p. 20s.; HICKS-HILL 1901, n. 10; TOD 1933, n. 8; SHAPIRO 1989,
pp. 48-60; PARKER 1996, pp. 72-89; HORNBLOWER 2008, ad Thuc. VI 54s. Contro la tradizione degli studi, M.F.
Arnush ha proposto un’attenta revisione dell’iscrizione e argomenta, in base a criteri epigrafici e linguistici, che
essa risalga piuttosto al 496: dunque la fondazione dell’altare sarebbe stata piuttosto l’occasione per Pisistrato II di
commemorare l’arcontato che egli aveva ricoperto effettivamente nel 522, vd. ARNUSH 1995, soprattutto pp. 144150. Questa proposta di datazione non modifica sostanzialmente l’interpretazione qui offerta della relazione
sfavorevole fra i Pisistratidi e il clero di Delfi. Sulla data dell’arcontato di Pisistrato II: IG I3 1031 (= SEG X, n.
352). MERITT 1939, pp. 59-65; CADOUX 1948, pp. 77-79, 109-112; BRADEEN 1963; BICKNELL 1970; KINZL 1976;
MEIGGS-LEWIS 1989, n. 6; THOMAS 1989, p. 148.
157
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
aspiranti alla tirannide, e in genere al potere politico, fu di cruciale importanza poter godere di
una sanzione religiosa favorevole e tanto più dell’appoggio psicologico e propagandistico del
peso di quello fornito da un oracolo apollineo: questo è evidente dalla storia non solo dei
Pisistratidi e degli Alcmeonidi, ma di numerose altre tirannidi56.
IV.3. La colonizzazione di Sigeo in Troade
Fra i moventi degli interventi di Pisistrato nelle isole Cicladi, sopra discussi, si è messo in
luce un interesse per località cruciali nella navigazione nell’Egeo, specificamente per la rotta
dall’Attica verso la Ionia. Una strategia affine, ma indirizzata su altre direttrici marittime
sembra soggiacere anche alle operazioni dei Pisistratidi in Troade e nell’Ellesponto. Si è infatti
preservata chiara notizia del fatto che Pisistrato conquistò l’insediamento di Capo Sigeo, in
Troade, alla foce del fiume Scamandro, e successivamente i figli del tiranno ne conservarono il
controllo.
L’intera area della Troade era parte dell’estesa peràia lesbia, interessata fin dal VII secolo
dalla colonizzazione e dal controllo delle poleis di Lesbo e particolarmente di Mitilene57. Poco
tempo dopo la presa del potere ad Atene, Pisistrato conquistò la località del Sigeo combattendo
(ai¹xma/zw) contro Mitilene. Il Sigeo fu poi affidato al controllo tirannico del figlio argivo
Egesistrato, il quale mantenne il controllo della cruciale località, ma a costo di continui conflitti
armati contro le rivendicazioni di Mitilene. Il Sigeo rimase nondimeno nel saldo controllo dei
Pisistratidi e anche in seguito fu una sede preferenziale della famiglia tirannica di Atene:
quando Ippia e i Pisisitratidi furono espulsi da Atene nel 510, essi fuggirono e trovarono rifugio
a Sigeo.
Qualche tempo dopo l’istituzione del regime isonomico di Clistene ad Atene, Sparta mutò
la propria posizione nei confronti di quel governo e volle tentare di riportare Ippia al potere:
anche in questa occasione le fonti conservano la nozione che i discendenti di Pisistrato
vivevano al Sigeo; anzi, quando l’impresa spartana fu interrotta dalla disapprovazione degli
56
La tirannide di Cipselo a Corinto fu presagita da un oracolo delfico favorevole: Hdt. V 92 b2-3, e2. Cilone ebbe
l’appoggio di Delfi: Thuc. I 126.4. Solone stesso fu incoraggiato ad assumere la tirannide ad Atene dal santuario di
Delfi: Sol. Fr. 29a G.-P.2 (33 W.2). Si è più volte menzionato viceversa il ruolo della Pizia nella caduta della
tirannide dei Pisistratidi: Hdt. V 63, 66. FORREST 1982 b, pp. 305-318. Entro questo quadro di conflittualità
religiosa e propagandistica, fra Pisistratidi e Alcmeonidi, si inserisce l’interpretazione, a mio avviso non
convincente, di A.W. Verrall sulla datazione e la composizione dell’omerico Inno ad Apollo: questi riconosce un
tono anti-delfico nella fine della seconda parte dell’inno e ne rende conto attribuendo la composizione finale
dell’inno ad ambiente pisistratide, anti-anfizionico e dunque anti-alcmeonide, nel quadro dell’arrangiamento e
stesura delle opere omeriche attribuita appunto alla politica artistico-culturale dei Pisistratidi. Vd. VERRALL 1894,
pp. 19-22. Contra LANG 1899, pp. 12s..
57
Strab. XIII 1.8, 1.38. HANSEN-SPENCER-WILLIAMS 2004, n. 798, pp. 1026-1030.
158
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
alleati della Lega del Peloponneso e Ippia ricevette offerte di ospitalità da parte dei sovrani di
Macedonia e da parte dei Tessali, nondimeno egli preferì fare ritorno al rifugio del Sigeo58.
L’importanza che Sigeo dimostra di avere nelle scelte dei Pisistratidi è dovuta a una serie
di fattori che mi accingo ad analizzare: in primo luogo fu una posizione cruciale nella
navigazione attraverso l’Ellesponto e dunque fra l’Egeo e il Ponto Eusino; il comportamento di
Ippia dimostra poi che i Pisistratidi furono in grado di mantenere il controllo di quella posizione
quale luogo sicuro per la propria attività anche dopo la fine della tirannide ad Atene; si nota
inoltre che il Sigeo fu un obiettivo non solo della strategia pisistratide, ma anche delle necessità
strategiche a lungo termine della polis di Atene.
Il conflitto di lungo periodo fra Atene e Mitilene per il controllo di Sigeo
Fonte quasi esclusiva per le iniziative dei Pisistratidi a Sigeo è Erodoto: la sua narrazione
al riguardo prende l’avvio proprio dalle ultime vicende della tirannide ateniese, quando Ippia si
rifugia a Sigeo a seguito dell’espulsione dalla propria polis; a questo punto del testo, Erodoto è
portato a dare conto della scelta e della destinazione di Ippia e fornisce perciò un breve
excursus sulla storia precedente di Sigeo in cui riferisce della conquista da parte di Pisistrato e
della tirannide del figlio Egesistrato. Erodoto però spinge la ricognizione della storia arcaica di
Sigeo più indietro ancora della tirannide pisistratide: lo stato di guerra che Egesistrato dovette
sostenere contro Mitilene trovava infatti la propria origine alla fine del VII secolo, quando a
Sigeo Atene aveva fondato una colonia. L’olimpionico Frinone condusse allora i coloni ateniesi
a Sigeo e Mitilene rispose rivendicando il proprio controllo sull’Eolide; gli Ateniesi
combatterono dalla posizione conquistata a Sigeo, mentre Mitilene muoveva guerra dal vicino
insediamento di Achilleo; nel corso di quel conflitto il tiranno lesbio Pittaco sconfisse e uccise
in duello l’ecista ateniese e il poeta Alceo fuggì dal campo di battaglia abbandonando il proprio
scudo. Erodoto mette il lettore a conoscenza anche delle rivendicazioni mitistoriche degli
Ateniesi, che risalivano all’epoca della guerra di Troia. Infine quel contenzioso di epoca prepisistratide fu risolto dall’arbitrato di Periandro, tiranno di Corinto, all’inizio del VI secolo:
Atene conservò Sigeo e Mitilene la propria posizione ad Achilleo59. Il quadro che si ricava
esplicitamente dai paragrafi erodotei è quello di un contenzioso di lunga durata in cui ciascuna
parte, pur fra successi e sconfitte, non riuscì mai a sopraffare completamente l’altra: così si
58
Hdt. V 65, 91, 94s.; Thuc. VI 59.
Alc. fr. 428 a Loeb; Hdt. V 94s.; Strab. XIII 1.38; Plut. De Her. Mal. 15; Diog. Laert. I 74; Suda, s.v.
Pikkako/j. WRIGHT 1892, pp. 9, 50-52, 55; BURN 1935, pp. 141s.; TREVER 1925, 124; PAGE 1955, pp. 152-158;
WILL 1955, pp. 369s., 382-386, 555-562; PICCIRILLI 1973, n. 7, pp. 28-35; ANDREWES 1982 a, pp. 366, 373s.;
ANDREWES 1982 b, pp. 400s., 403s.; GRAHAM 1982, pp. 121s., 162; FROST 1984, pp. 287s.; DAVERIO ROCCHI
1988, pp. 231s.
59
159
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
spiegano la lunga durata e la scelta infine di ricorrere ad un arbitrato. È interessante notare che
il carattere della lunga durata e della difficile soluzione di questo conflitto in Troade
contraddistinsero anche il conflitto che oppose Atene e Megara per il controllo di Salamina, in
epoca più o meno coeva60.
Nonostante l’arbitrato, Mitilene dovette riprendere le ostilità e guadagnare una posizione
favorevole; è possibile spiegare e datare questo periodo di arretramento della posizione di
Atene in riferimento alle difficoltà insorte con la stasis che interessò la politica di Atene negli
anni fra la fine dell’operato di Solone e l’affermazione della tirannide61. Pisistrato intervenne
dunque sulla scia di questa lunga storia pregressa, riorganizzando le forze ateniesi, con buona
probabilità contribuendo con le proprie risorse economiche e militari, e portando la propria
polis a riconquistare l’antica colonia; il figlio Egesistrato proseguì nelle operazioni difensive e
militari, ma successivamente Sigeo fu definitivamente accorpata all’area di influenza ateniese e
pisistratide, a scapito dei tentativi di Mitilene, poiché non si conservano cenni di disturbi o
tensioni nelle notizie relative ad Ippia e al suo insediamento a Sigeo. La conquista di Sigeo
dunque non fu solo un’iniziativa tirannica a favore del potere e del prestigio dei Pisistratidi;
piuttosto Pisistrato decise di mettere le proprie capacità militari al servizio della sua polis, per
portare ad una soluzione definitiva e favorevole un conflitto che si era prolungato per vari
decenni e che mostrava, al suo tempo, una situazione di incertezza e instabilità. Anche sotto
questo aspetto l’intervento a Sigeo si configura nella forma di quello a Salamina, contro
Megara: cioè nel proposito di Pisistrato di intervenire risolutivamente in un contenzioso di
lunga data di Atene62.
L’interesse di Erodoto per la composizione di questi paragrafi in cui, sotto molteplici
aspetti giuridico-militari e su un ampio arco temporale, viene affermato il diritto di Atene ad
esercitare la propria autorità sull’insediamento in Troade rientra peraltro nelle aspettative del
pubblico ateniese a cui lo storico si rivolgeva: nella seconda metà del V secolo la Lega delioattica andava assumendo i caratteri dell’imperialismo ateniese e prendevano forma quelle
rivendicazioni autonomistiche degli alleati che avrebbero alimentato il conflitto con Sparta; in
questo contesto culturale, le notizie relative all’espansione dell’autorità ateniese nell’Egeo in
epoca arcaica risultavano allora di una pregnante attualità63.
60
Vd. supra, pp. 31ss. BERVE 1967, p. 62.
TREVER 1925, p. 124s.
62
WADE-GERY 1951, pp. 218s.; LAVELLE 1994; DUPLOUY 2006, pp. 87s.
63
Ringrazio la Prof.ssa R. Thomas per avere discusso con me di persona dell’utilità di analizzare le notizie
erodotee entro il contesto storico dell’epoca di produzione dell’opera. STADTER 2006, pp. 242-256; THOMAS 2006.
61
160
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
La data e il contesto storico dell’iniziativa di Pisistrato
Mi pare necessario tentare di stabilire dei parametri cronologici per l’operato di Pisistrato
e dei Pisistratidi al Sigeo: una serie di considerazione contestuali mi pare contribuisca a fissare
la conquista del Sigeo da parte di Pisistrato agli anni successivi alla presa definitiva della
tirannide e all’impegno a Nasso e a Delo, dunque negli anni intorno al 540 ca64.
La riconquista di Sigeo da parte di Pisistrato fu un’iniziativa del tiranno di natura statale e
pubblica, piuttosto che un’operazione familiare: la natura politicamente organizzata
dell’insediamento, la storia coloniale pregressa e la forte conflittualità con Mitilene rendono
innegabile il contributo della cittadinanza ateniese alla conquista e al popolamento della
località. In base a questa considerazione, un primo terminus post quem mi pare si possa fissare
al 546, quando Pisistrato prese definitivamente la tirannide e potè perciò da allora dirigere gli
sforzi collettivi della polis in suo controllo.
Si potrebbe eventualmente assegnare l’iniziativa anche ad uno dei precedenti brevi periodi
di tirannide, ma l’instabilità del potere tirannico di Pisistrato ed insieme altri fattori
contribuiscono a respingere una datazione più alta. Dopo la conquista armata, Pisistrato assegnò
la tirannide di Sigeo al figlio Egesistrato e questo trapasso del potere dovette a mio avviso
avvenire molto presto dopo la conquista del sito: le fonti non registrano infatti alcuna assenza
prolungata di Pisistrato da Atene, come invece fu per l’insediamento al Pangeo, né d’altronde
sarebbe stato possibile per il tiranno lasciare a lungo la polis incustodita dopo la sua recente
presa di potere. La biografia che si è ricostruita per Egesistrato rinforza la datazione proposta: il
giovane argivo era senz’altro troppo giovane per assumere la tirannide in Asia Minore durante
le prime due tirannidi del padre; inoltre si è concluso che Egesistrato era rimasto ad Argo dopo
la sua nascita e dopo il matrimonio di Pisistrato e Timonassa e che lasciò la patria natale solo in
occasione della battaglia di Pallene nel 54665.
Egesistrato faceva parte a tutti gli effetti dell’òikos pisistratide e aveva infatti dimostrato
la propria lealtà e il proprio valore nel condurre il contingente argivo a Pallene; nondimeno, si è
già puntualizzato, la sua presenza ad Atene avrebbe potuto generare una certa tensione con i
figli ateniesi legittimi, Ippia e Ipparco; inoltre la presenza dell’ingente contingente di mercenari
argivi poteva essere causa di difficoltà organizzative per Pisistrato e di tensioni con i cittadini di
64
GRAHAM 1964, p. 32, segue la proposta di BERVE 1937 nel datatare l’insediamento di Egegsistrato al 530;
FROST 1984, p. 287, concorda con la data qui proposta del 540.
65
Contra: GRAHAM 1964, p. 32s. ritiene che la colonizzazione ateniese di Sigeo e parallelamente del Chersoneso
Tracico debbano datarsi ante 546, poiché in quella data Ciro sconfisse e conquistò definitivamente l’impero di
Lidia estendendo il potere della Persia su tutta l’Asia Minore; mi pare nondimeno che A.J. Graham sopravvaluti
molto le ricadute politico-territoriali di questi eventi, soprattutto per le poleis elleniche micrasiatiche e ancor più
per l’Eolide e l’Ellesponto che erano relativamente lontani dagli interessi persiani a quell’epoca.
161
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
Atene. Egesistrato non dovette rimanere a lungo ad Atene e la possibilità di re-impiegare questo
giovane nella riconquista di Sigeo dovette sembrare a Pisistrato la scelta migliore66; è stato
persino proposto che il contingente argivo, o parte di esso, abbia seguito il proprio comandante
in Asia Minore andando dunque a costituire il corpo militare con cui Egesistrato difese Sigeo
nel conflitto con Mitilene67.
Se la riconquista di Sigeo e l’affermazione del potere ateniese nelle Cicladi fanno parte di
una medesima strategia di affermazione marittima, è possibile che le due missioni abbiano
avuto luogo a poca distanza una dall’altra; tuttavia non si trattò di una medesima spedizione
navale poiché la rotta seguita da Atene verso Nasso e Delo volgeva da Atene verso sud-est,
mentre la rotta che conduceva in Troade seguiva il litorale settentrionale, costeggiando la
penisola e la costa della Tracia68.
La conquista di Sigeo dunque è da datarsi non molto tempo dopo il 546, pure se si assegna
un lasso di tempo sufficiente per la stabilizzazione della tirannide ad Atene, per la
riorganizzazione della carriera di Egesistrato e per le operazioni nelle Cicladi: in base alle
considerazioni finora espresse, mi pare che una data vicina al 540 sia la più ragionevole69.
Sigeo è sicuramente in potere di Atene e dei Pisistratidi nel 510, quando Ippia vi trova
rifugio dopo l’espulsione da Atene, e ancora poi nel giro di anni fra il governo di Clistene ad
Atene e lo scoppio della rivolta ionica (508-500), per i quali è attestata la presenza di Ippia a
Sigeo70.
La questione dell’interruzione del potere pisistratide a Sigeo o eventualmente della
continuità dell’autorità di Atene sulla colonia è complicata dai fattori dell’espulsione dei
Pisistratidi e della loro fuga in Asia Minore, dall’espansione dell’impero persiano oltre
l’Ellesponto e dalle considerazioni in merito alla posizione di Sigeo nelle testimonianze relative
al V secolo. Fin dal tirannicidio di Ipparco nel 514, e senz’altro dopo la fuga a Sigeo nel 510,
Ippia mosse la propria diplomazia nella direzione di ottenere l’appoggio e l’ospitalità del Gran
Re di Persia; la storia della Prima Guerra Persiana vede appunto l’antico tiranno di Atene,
66
DUPLOUY 2006, pp. 87s. interpreta invece l’assegnazione di Sigeo ad Egesistrato nel quadro di uno scambio di
risorse fra Pisistrato e Gorgilo di Argo: Gorgilo fornì a Pisistrato il contingente di opliti argivi col cui contributo
divenne tiranno ad Atene; di conseguenza Pisistrato ricambiò in egual misura il dono del suocero assegnando una
tirannide ad Egesistrato ed assicurando dunque anche alla famiglia di Gorgilo una tirannide. La dinamica sarebbe
dunque affine alla relazione fra Pisistrato e Ligdami nella creazione delle rispettive tirannidi ad Atene e Nasso. A.
Duplouy non tiene conto però, a mio avviso, della relazione familiare fra Pisistrato ed Egesistrato e della storia di
Sigeo alla fine del VI che dimostra lo stretto legame fra quell’insediamento e la famiglia dei Pisistratidi.
67
BING 1977, pp. 311s.
68
HOW-WELLS 1928, app. XVI.8; FRENCH 1957, p. 239; HAAS 1985, pp. 43-45; DAVIES 1997, pp. 134s.; LAVELLE
2005, p. 139.
69
BERVE 1937, p. 28, seguito da GRAHAM 1964, p. 32, n. 2, propongono la data del 530 ca.
70
Hdt. V 91, 93s. LEWIS 1988, pp. 301s.
162
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
ormai anziano, condurre i Persiani allo sbarco a Maratona nel 49071. In questa prospettiva
dunque è accettabile la ricostruzione secondo cui il Sigeo rimase sotto l’autorità dei Pisistratidi
fino all’estinzione o alla caduta della famiglia tirannica locale, nel quadro di una forma di
accordo fra il Gran Re e i Pisistratidi72. Alla metà del V secolo Sigeo ricompare nelle fonti
come una delle poleis della Lega delio-attica, attestata nei registri della tesoreria e in
un’iscrizione onorifica73. Su questi presupposti ritengo si debba sostenere che Sigeo rimase una
località sotto il saldo comando dei Pisistratidi certamente fino alla rivolta ionica e con buona
probablità anche negli anni successivi e fino alle ultime attestazioni della loro presenza in Asia
Minore nel 48074.
La storia della condizione politica dell’insediamento di Sigeo
La storia dell’occupazione coloniale di Sigeo all’epoca di Frinone, poi la riconquista da
parte di Pisistrato e successivamente la tirannide di Egesistrato e Ippia delineano un quadro
istituzionale e politico mutevole e complesso per questo insediamento, in merito al quale mi
pare utile proporre alcuni chiarimenti.
L’episodio della conquista e colonizzazione da parte di Frinone, alla fine del VII secolo,
assegna a Sigeo lo status di un insediamento coloniale, promosso dallo stato ateniese, con un
ecista aristocratico e un contingente armato di coloni; l’opposizione di Mitilene e il lungo
conflitto fra Sigeo e Achilleo non possono che implicare il trasferimento di un numero di
uomini consistente e un investimento sociale ed economico significativo75. Fonti epigrafiche
attestano inequivocabilmente nel VI secolo la presenza di un pritaneo a Sigeo e l’attività
politica e deliberativa di un corpo civico di Greci: sono elementi che caratterizzano
l’insediamento come una polis coloniale, socialmente e politicamente organizzata. Le fonti
letterarie, pure di epoca tarda, confermano la definizione di polis nei riferimenti a Sigeo76.
L’intervento di Pisistrato va interpretato dunque su questi presupposti in maniera non
dissimile da quello dello stesso Frinone: il nuovo tiranno ateniese operò con l’obiettivo di
riconquistare, rifondare e difendere una colonia che era appartenuta ad Atene più di mezzo
secolo prima. Lo stesso testo erodoteo infatti, pur tramandando il ruolo di Pisistrato e della
tirannide di Egesistrato, continua nondimeno a fare riferimento agli Ateniesi e ai Mitilenei
71
Thuc. VI 59.
MURRAY 1988, pp. 464-466.
73
RHODES 1992, p. 59; LOW 2008, p. 70s.
74
Hdt. VI 9.2, 43, VII 6-7.1, VIII 52.
75
BIRASCHI 1989, p. 50-52; WADE-GERY 1951, pp. 218s.; GRAHAM 1964, pp. 32s.; DAVERIO ROCCHI 1988, pp.
231s.; NOUSSIA 2001, p. 15; HANSEN-SPENCER-WILLIAMS 2004, n. 798, pp. 1026-1030; DECKER 2011, s.v.
“Phrynon” in BNP.
76
Hdt. V 94; Strab XIII 1.31. SIG 1.2; SEG IV, n. 667. HICKS-HILL 1901, n. 8; FORNARA 1983, n. 20; MITCHELL
2004, n. 791, p. 1000, s.v. “Sigeion”, p. 1014.
72
163
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
come parti interessate e dunque conserva la nozione di un’operazione comunitaria a cui prese
parte un corpo di cittadini sotto la guida del tiranno. Visti i presupposti storici e l’importanza
strategica della colonia del Sigeo, la sua riconquista fu senz’altro auspicata dagli Ateniesi e
Pisistrato volle condurre quella missione per godere del prestigio e della popolarità che gli
avrebbe procurato77. Sigeo non fu dunque un’operazione privata della famiglia tirannica: a
sostegno di questa ricostruzione rimane il fatto che Sigeo fu effettivamente una polis con una
propria cittadinanza attiva, piuttosto che una roccaforte familiare; la colonia era stata oggetto di
un contenzioso che coinvolgeva il corpo sociale ateniese il quale vantava sulla località il
proprio impegno militare e rivendicazioni politiche e mitistoriche; infine, il lungo conflitto
contro Mitilene sarebbe stato troppo impegnativo anche per le ingenti risorse di Pisistrato78.
Si è stabilito che nel 540 ca. il Sigeo fu presto affidato da Pisistrato alla tirannide del
figlio Egesistrato. È possibile fornire una contestualizzazione storica della breve notizia
erodotea per approfondire il profilo istituzionale di Sigeo in quel momento. La relazione fra
Egesistrato e la polis coloniale non va intesa diversamente, a mio avviso, da quella che vigeva
fra Pisistrato e Atene: una forma di controllo indiretto, fondato sulla repressione e conciliazione
dell’opposizione politica, sull’appoggio della cittadinanza e sul prestigio personale del tiranno.
Dalla narrazione erodotea si dovrà inferire che il potere autocratico di Egesistrato trovò una
giustificazione nella sua capacità di difendere Sigeo e i concittadini dalle ripetute aggressioni di
Mitilene, ricorrendo alle sue già comprovate capacità militari, alle disponibilità economiche e
militari della sua famiglia oltre che all’impegno dei Sigeei stessi79.
La pratica, qui dimostrata da Pisistrato, di installare membri più giovani della famiglia
tirannica al comando delle colonie riprende la strategia seguita dalla tirannide dei Cipselidi
nelle colonie di Corinto80. Un’analoga forma di colonizzazione dinastica si riscontra anche nella
tirannide della famiglia ateniese dei Filaidi nell’occupazione del Chersoneso Tracico: i Filaidi
mantennero il potere personale nella penisola per due generazioni: eppure le fonti delineano il
quadro di una fondazione coloniale a cui partecipò parte della popolazione di Atene. Per un
77
LAVELLE 1994.
WADE-GERY 1951, pp. 218s.; GRAHAM 1964, p. 32, cita a sua volta BERVE 1937, BENGTSON 1939 e
EHRENBERG 1946 come concordi con questa medesima ricostruzione.
79
Contra: LEWIS 1988, p. 297, considera il Sigeo come un possedimento familiare già dall’epoca di Pisistrato.
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 234-240 sul prestigio che sarebbe potuto derivare a Milziade dalla costruzione delle
fortificazioni sull’istmo del Chersoneso Tracico.
80
Leucas, Anattorio, Eraclea di Acarnania, Ambracia, Corcira, Potidea sono attestate quali colonie fondate o
governate da membri della famiglia dei Cipselidi: Hdt. III 52; Nic. Dam 90 F 57. GRAHAM 1964, pp. 7-33, 118153, propone anche egli la similitudine fra le colonie cipselidi e l’iniziativa pisistratide a Sigeo; GOMME 1937;
GWYNN 1918, pp. 117s.; WILL 1955, p. 517-539; DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 98s., 101-106; RHODES 1981, ad
Aristot. Ath. Pol. 17.4; LINTOTT 1982, p. 42-51; HORNBLOWER 1997, ad Thuc. I 4; SALMON 1997, pp. 132-139.
Vd. infra, pp. 65ss.
78
164
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
verso dunque, questo tipo di organizzazione coloniale può considerarsi peculiare poiché
comporta l’intervento e la riproduzione della tirannide stessa nella colonia, ma le caratteristiche
dell’insediamento implicano la partecipazione di un gruppo sociale ampio. Per altro verso
l’intervento dells tirannide non deve distrarre da fatto che i due aspetti, quello dell’iniziativa
individuale e quello della partecipazione pubblica, sono caratteristiche che si riscontrano, di
fatto, nelle modalità organizzative di tutte le fondazioni coloniali di epoca arcaica: motore
iniziale è infatti l’iniziativa privata e l’organizzazione di un ecista di status aristocratico, con il
supporto di un circolo di suoi sostenitori, e d’altro canto l’impresa si configura come
un’iniziativa a partecipazione pubblica, aperta all’intera cittadianza e il cui controllo ultimo
risiede nella polis e nell’auto-organizzazione dei coloni. È proprio in quest’ultimo campo che
rimane assicurato per l’ecista un ruolo di governo e di prestigio sociale, a volte eroico, nella
nuova fondazione. Nel caso delle colonizzazioni tiranniche si ripresenta dunque quel dualismo
fra il pubblico e il privato che informa il governo del tiranno: si riscontrano il peso del potere
personale e la cura per la conservazione del potere della famiglia; d’altro canto si riscontrano
anche un’evidente attenzione al governo costruttivo della polis e la comprensione degli interessi
strategici e internazionali della polis, a vantaggio dei concittadini81.
Parte della critica ritiene di dover considerare l’insediamento a Sigeo come un
possedimento familiare pisistratide, ma personalmente non condivido questa lettura82. È pur
vero che Pisistrato ebbe un ruolo militare decisivo nella riconquista di Sigeo e che Egesistrato
assunse, apparentemente senza contrasti interni, la tirannide sulla colonia; inoltre, quegli
Ateniesi che seguirono Pisistrato e poi Egesistrato nella ricolonizzazione di Sigeo sono da
considerarsi fra i sostenitori dei Pisistratidi o perlomeno acquiescenti alla supremazia politica
della famiglia negli affari della polis. Questi fattori dunque configurano senz’altro un controllo
specialmente stretto dei tiranni ateniesi sul Sigeo; tuttavia la contestualizzazione finora addotta
e le notizie fornite dalle fonti impongono di qualificare il Sigeo come una colonia ateniese
piuttosto che come un esclusivo possesso familiare dei Pisistratidi. Tutt’al più, il carattere
familiare della gestione politica e militare di Sigeo da parte dei Pisistratidi trova la propria
giustificazione nella necessità di condurre con decisione e mano ferma l’attività di Sigeo: per
81
GWYNN 1918, pp. 117s.; GOMME 1937 qualifica Sigeo, come anche l’occupazione filaide del Chersoneo, come
delle apoikìai e rifiuta di considerarle come primi casi di cleruchie e pure ribadisce nella sua ricostruzione il ruolo
dell’iniziativa familiare; CULASSO GASTALDI 2011, p. 123. Sul ruolo e il potere dell’ecista e sul potere dei tiranni
nelle colonie: GRAHAM 1964, pp. 29-39; LAVELLE 1994. Sulla condizione giuridica delle colonie ateniesi, vd.
critica in WADE-GERY 1951, p. 218 n. 36 contro le posizioni di H. Berve; CULASSO GASTALDI 2011, pp. 135-138;
DEN BOER 1969, pp. 325-327 sulla relazione fra iniziativa privata e responsabilità verso la polis.
82
BERVE 1937, pp. 26s.; GOMME 1937; GRAHAM 1964, p. 32-34, 192-194 non sostiene questa interpretazione ma
ne offre un quadro conoscitivo e una critica; LEWIS 1988, p. 297.
165
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
via dell’importanza strategica della posizione di Sigeo per gli interessi marittimi di Atene
nell’area dell’Ellesponto, per via della necessità di soccorrere quegli Ateniesi insediati al Sigeo
dal VII secolo che vivevano affrontando le rivendicazioni di Mitilene e conseguentemente per
via dell’appoggio sociale che i Pisistratidi dovettero godere fra i coloni sigeei83.
A mio avviso, quell’interpretazione di Sigeo come possedimento familiare origina, e si
avvicina invece ad essere più appropriata, entro la situazione politica attestata piuttosto per
l’attività di Ippia negli anni a cavallo fra il VI e il V secolo: in quel contesto vi sono motivi
sufficienti per ritenere che la disposizione politica di Sigeo fosse cambiata. Nel 510 Ippia e i
Pisistratidi si arresero al fortunato assedio dell’acropoli condotto dall’esercito spartano con
l’appoggio degli Alcmeonidi, i tiranni accettarono di lasciare l’Attica entro cinque giorni e
dunque ripararono al Sigeo, durante l’arcontato di Arpactide84. Pochi anni dopo l’instaurazione
del governo isonomico di Clistene ad Atene, la politica di Sparta nei confronti degli Ateniesi
mutò radicalmente e Cleomene decise di appoggiare il ritorno dei Pisistratidi nella loro
madrepatria: allora, narra Erodoto, gli Spartani mandarono a chiamare Ippia al Sigeo, ove i
Pisistratidi vivevano dal momento della fuga da Atene (µετεπέµποντο Ἱππίην τὸν Πεισιστράτου
ἀπὸ Σιγείου τοῦ ἐν Ἑλλησπόντῳ ἐς ὃ καταφεύγουσι οἱ Πεισιστρατίδαι)85; la strategia di Sparta
non ebbe alcun supporto dai membri della Lega del Peloponneso e dunque Ippia fece
nuovamente ritorno al Sigeo86. Questa serie di contatti spartano-pisistratidi non riceve una
datazione nelle fonti, nondimeno può collocarsi negli anni 507-50087. In quel momento Sigeo
doveva costituire un sito di particolare valore per i Pisistratidi poiché in quella fase Ippia
ricevette offerte di ospitalità dai sovrani macedoni, che gli offrirono Antemunte su cui
governare, e dai Tessali che offrirono Iolco (di/dwmi)88: eppure Ippia preferì invece ritirarsi a
Sigeo ove, si dovrà dedurre, egli godeva di una sicurezza e di un potere superiori a quelli che
avrebbe avuto in quei nuovi possedimenti personali e monarchici89.
Queste notizie storiche sembrano mostrare, per gli ultimi anni del VI secolo, un
consolidamento della posizione dei Pisistratidi a Sigeo e viceversa una rinuncia, se non
83
GWYNN 1918, pp. 117s.; WADE-GERY 1951, pp. 218s.; GRAHAM 1964, pp. 191-194; LAVELLE 1994.
Hdt. V 65; Aristot. Ath. Pol. 19.6.
85
Hdt. V 91.
86
Hdt. V 93s.
87
Il terminus post quem è l’instaurazione del governo di Clistene nel 508, il terminus ante quem è da fissarsi
all’ambascieria di Aristagora da Mileto presso Sparta nel 500. PETER 1882, p. 32 propone una datazione al 507;
MERITT 1939, pp. 61-65 propone una data poco successiva al 504; ROBINSON 1945, p. 250, propone il 504;
OLMSTEAD 1982, p. 94 permette di ricavare una data fra il 507 e il 504; BALTRUSCH 2002, p. 44 propone il 506;
MUSTI 2006, p. 249, propone anche egli il 506.
88
Hdt. V 94.1. CASSON 1926, pp. 117s.; ROBINSON 1945, pp. 246s.; SORDI 1958, pp. 54-84; BORZA 1990, pp.
117s.; NENCI 2006, ad Hdt. V 17.
89
LEWIS 1988, p. 302.
84
166
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
l’impossibilità, del nuovo governo democratico di Atene ad esercitare la propria direzione e il
proprio controllo sull’antico insediamento coloniale: il Sigeo sembra configurarsi dunque come
un rifugio e un dominio familiare per Ippia e i membri dei Pisistratidi che con lui vi
risiedevano. Ritengo che si possa trovare una spiegazione per questa svolta nella natura politica
di Sigeo, entro le mutate condizioni della Grecità d’Asia Minore in relazione all’espansionismo
dell’impero persiano.
Dalla fine del VI secolo l’impero persiano affermò con violenza il proprio domino
nell’area della Troade e dell’Ellesponto90: nel 513 la spedizione scitica di Dario, in Tracia e in
Scizia, comportò l’asservimento, o perlomeno la pacificazione, di tutto il retroterra asiaticoellenico dell’area affacciata sulle sponde della Propontide; la repressione della rivolta ionica,
conclusa nel 493, segnò definitivamente la sottomissione della Grecità d’Asia Minore alla
Persia; già dalla seconda metà del VI secolo gran parte delle poleis greche micrasiatiche era
governata da regimi tirannici locali, invisi ai concittadini, ma appoggiati dall’autorità politica e
dalla forza militare dei Persiani91. Ippia aveva avviato la costruzione di una rete di contatti
familiari in Ellesponto fin dal tirannicidio del fratello Ipparco nel 514, dopo il quale strinse
un’alleanza matrimoniale con i tiranni di Lampsaco, secondo Tucidide, col fine di entrare, per
tramite dei tiranni lampsaceni, nel circuito di alleanze della corte achemenide92. Dopo il
fallimento del tentativo spartano di reinsediare i Pisistratidi ad Atene, nel 504 ca., dalla sua
posizione sicura a Sigeo Ippia entrò nei favori del Gran Re Dario e del satrapo persiano
Artafrene93; infine Ippia condusse personalmente lo sbarco persiano a Maratona nel 49094. Per
comprendere la posizione di Ippia e di Sigeo entro il quadro politico persiano, è significativo
considerare che, nel 493, all’approssimarsi della flotta persiana, Milziade II e i Filaidi che
reggevano la tirannide in Chersoneso Tracico fuggirono precipitosamente dagli insediamenti
ellespontini per fare ritorno ad Atene95: al contrario, poste le notizie dei contatti favorevoli di
Ippia con la corte achemenide, si può concludere che Ippia rimase allora in possesso del Sigeo e
anzi vide rafforzato e garantito il suo potere dalla presenza militare persiana e dalla
soppressione del movimento anti-tirannico della rivolta96.
90
Sulle pratiche violente di conquista dei Persiani contro i Greci: Hdt. VI 31s.
Hdt. IV 137, VI 31, 33, VII 106. OLMSTEAD 1982, pp. 91-144; WALLINGA 1984; AUSTIN 1990, 289-306;
MITCHELL 1997, pp. 111-133; LURAGHI 1998; ANDRESON 2005, pp. 191 n. 50, 210-215.
92
Thuc. VI, 59.3. WADE-GERY 1951, pp. 215s., 219; DUPLOUY 2006, pp. 88-90.
93
Hdt. V 96.
94
Hdt. VI 102, 107s.
95
Hdt. VI 40s.
96
WADE-GERY 1951, pp. 216-219.
91
167
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
Assume dunque cogenza una ricostruzione secondo la quale il Sigeo entrò nella sfera
politica dell’impero persiano a partire dal 513, con la spedizione scitica: è appunto per quel
motivo che Ippia si legò presto ai tiranni filo-persiani lampsaceni e che potè considerare Sigeo
come un rifugio sicuro nel 510 e poi nel 504 ca.97. Successivamente Atene vide
irrimediabilmente recisi i legami con quella comunità in occasione della rivolta ionica nel 500493, quando l’esercito e la flotta persiana sottomisero le sponde e le acque dell’Ellesponto al
proprio dominio98. Viceversa Ippia, in quegli anni vide rafforzato il proprio potere sulla polis di
Sigeo e il proprio ruolo politico in qualità di personalità autorevole di collegamento fra
l’amministrazione locale dei cittadini di Sigeo e il sistema imperiale achemenide99.
In questo senso, Sigeo rimase pure sempre una polis nelle sue qualità urbanisitiche e
sociali, ma relativamente alla sua situazione politica passò gradualmente dall’essere una
fondazione coloniale di Atene ad un dominio persiano-pisistratide.
La strategia di accesso alle rotte marittime verso la Propontide
Stabilito un quadro cronologico e politico della storia di Sigeo, mi pare fondamentale
tentare di comprendere quali moventi strategici, militari, politici o economici fossero sottesi
all’iniziativa di Pisistrato di riconquistare Sigeo e all’interesse che il sito ebbe per i Pisistratidi e
in genere per Atene, durante e dopo la tirannide.
In prima istanza, Pisistrato scelse di intervenire specificamente a Sigeo in virtù della più
antica storia coloniale di Atene nella Troade, che risaliva alla fondazione di Frinone alla fine
del VII secolo: si trattò per il tiranno di farsi carico delle rivendicazioni della propria polis su un
insediamento che da Mitilene era stato ingiustamente sottratto alla sovranità di Atene, giacchè
l’arbitrato di Periandro, all’inizio del VI secolo, aveva giudicato favorevolmente le
rivendicazioni ateniesi. In questo senso Sigeo va interpretata come una rifondazione coloniale e
dunque mi pare corretto attribuire a quell’iniziativa le consuete implicazioni socio-economiche
che la critica ha riconosciuto per il fenomeno della colonizzazione greca: l’opportunità cioè di
ricollocare una porzione della popolazione ateniese e, sul sito, di assegnare agli emigrati nuovi
lotti di terreni; dunque un’iniziativa volta essenzialmente ad alleggerire il rapporto fra
popolazione e risorse alimentari in Attica100.
97
BERVE 1937, pp. 49, 88 ritiene che già nel 546, con la conquista dell’impero lidio da parte del persiano Ciro,
Egesistrato dovette sottomettersi alla Persia e associare la propria sovranità sul Sigeo al beneplacito del Gran Re;
GRAHAM 1964, pp. 32-34, 192-196; AUSTIN 1990, p. 297, n. 29 concorda con BERVE 1937.
98
TOZZI 1978, pp. 125s.; WALLINGA 1984.
99
MURRAY 1988, p. 464-466.
100
GWYNN 1918; WADE-GERY 1951, pp. 218s.; WHITE 1961; GRAHAM 1964, pp. 5, 29s., 193s.; SEALEY 1976 a,
pp. 30-33; ANDREWES 1982, p. 372s.; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 211-217; MURRAY 1996, pp. 102-123; DE STE.
CROIX 2004, pp. 349-351; MORENO 2007, p. 140-143, 206-210; MORRIS 2009, pp. 66-68, 103.
168
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
È innegabile tuttavia che alla base della strategia internazionale di Pisistrato vi fosse il
chiaro e non secondario obiettivo di assicurare ad Atene una posizione favorevole entro le rotte
marittime che conducevano dall’Egeo attraverso l’Ellesponto e verso l’area commerciale del
Ponto Eusino. Non si spiegherebbero altrimenti né la scelta del sito, né lo sforzo economico,
marittimo, militare e sociale che i tiranni di Atene investirono per tre generazioni nel controllo
di Sigeo e nella difesa contro le aggressioni di Mitilene.
La parallela iniziativa coloniale dei Filaidi in Chersoneso d’altronde contribuisce a far
riconoscere, nelle scelte dei Pisistratidi e dei Filaidi, fra loro alleati, una chiara strategia
marittima indirizzata verso l’Ellesponto. La tirannide di Milziade I, e successivamente degli
altri Filaidi, nel Chersoneso Tracico, durata per tutta la seconda metà del VI secolo, e insieme la
tirannide di Egesistrato al Sigeo sono due situazioni che vanno necessariamente essere
interpretate
congiuntamente.
Il
Chersoneso
e
il
Sigeo
furono
infatti
conquistati
approssimativamente nel medesimo giro di anni; l’iniziativa dei Filaidi fu chiaramente
concertata insieme ai Pisistratidi poiché è riconoscibile una duratura intesa politica fra le due
famiglie101. La conformazione geografica dell’imbocco dell’Ellesponto dimostra il chiaro
proposito di installare insediamenti in due posizioni strategiche, sulle due opposte rive
dell’accesso allo stretto, così da permettere ai Pisistratidi e ai Filaidi, e conseguentemente agli
Ateniesi, di accedere alla navigazione verso la Propontide e di controllarne le rotte marittime102.
Parte della critica ha cautamente proposto di riconoscere questa medesima strategia di
posizionamento sulle opposte rive dell’Ellesponto già nelle iniziative di Atene fra il VII e il VI
secolo: come si è visto, Frinone conquistò il Sigeo e vi fondò la colonia ateniese, ma per il
medesimo contesto cronologico è riconosciuta una fondazione ateniese anche sull’estremità
meridionale del Chersoneso, nella località di Elaious, che dunque precorrerebbe la strategia
pisistratidie-filaide103. Se questa interpretazione è da ritenersi valida, si conferma ulteriormente
il proposito di Pisistrato ed Egesistrato di assumersi la responsabilità delle iniziative di lungo
periodo della polis e di operare nell’interesse della posizione internazionale di Atene, piuttosto
che solamente in difesa del potere familiare tirannico104.
101
Infra, pp. 190ss, 213ss. WADE-GERY 1951, pp. 214, 218s.. Sul ruolo dei Filaidi e di Pisistrato nella fondazione
delle Grandi Panatenee e dei relativi agoni: DAVISON 1958, pp. 28-29; PARKE 1986, pp. 34-35; FROST 1994, pp.
51-59; RAAFLAUB 1996; PARKER 1996, pp. 67-71.
102
TREVER 1925, p. 125; HOW-WELLS 1928, app. XVI.8; WADE-GERY 1951, P. 218; ANDREWES 1958, pp. 112s.;
GRAHAM 1964, p. 193-197; NENCI 1988, ad Hdt. VI 34; KOROMILA 1991, Pp. 191s.; KEEN 2000, pp. 66s.; LAVELLE
2005, p. 127; HORNBLOWER 2008, ad Thuc. VI 54.
103
Ps. Scymn. 707s. WADE-GERY 1951, pp. 218s.; GRAHAM 1964, pp. 33 n. 5; BIRASCHI 1989, pp. 30-33, 50-52;
DEVELIN 1989, pp. 32s.; KEEN 2000, pp. 66s.; LOUKOPOULOU 2004, n. 663, p. 906; MORENO 2007, pp. 144s., 165167; TIVERIOS 2008, pp. 122s.; HOUBY NIELSEN 2009, p. 197.
104
URE 1922, p. 63; ANDREWES 1958, p. 112-114.
169
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
Numerosi studiosi ritengono che la preoccupazione di mantenere aperta la rotta marittima
verso la Propontide nascesse dalla necessità per Atene di accedere alle risorse agricole
provenienti dalle coste del Ponto Eusino. Il Sigeo ebbe cioè per Atene la funzione di una
località sicura, in quanto polis coloniale e alleata, verso cui navigare e ove attraccare, al fine di
disporre del circuito commerciale delle esportazioni di grano che giungevano dalle colonie sulle
coste settentrionali e occidentali del Ponto Eusino che disponevano di un ampio surplus
produttivo. Nel quadro del sistema internazionale ellenico, Sigeo e il Chersoneso Tracico
fornirono ad Atene delle posizioni vantaggiose tramite cui garantire la capacità della
madrepatria di difendere e mantenere l’afflusso degli approvvigionamenti cerealicoli contro
eventuali azioni di disturbo di altre poleis avversarie. Per altro verso, a sua volta Atene poteva
da là influenzare e ostacolare la navigazione e l’approvvigionamento delle altre poleis della
Grecia continentale, qualora si trovassero nella necessità di dover fare affidamento sulle
importazioni di grano105.
La navigazione attraverso l’Ellesponto era peraltro di particolare difficoltà poiché
attraverso il Bosforo, la Propontide e l’Ellesponto per una parte dell’anno spirano venti dalla
direzione di nord-nordest, provenienti dalle steppe della Scizia e dal Ponto Eusino, che agitano
le acque e impediscono ai navigli di fare vela e risalire dall’Egeo verso la Propontide, o da
questo mare al Ponto Eusino: perciò i piloti greci erano costretti ad ormeggiare presso i porti
posizionati all’imbocco dello stretto e attendere venti favorevoli da sud. La Propontide era
inoltre interessata da una continua corrente marina che rendeva difficoltosa la navigazione in
mare aperto e richiedeva manovre particolari ai piloti che risalivano dall’Egeo. Poste queste
condizioni geo-metereologiche, si palesa l’importanza della posizione di Sigeo106.
La valutazione del ruolo di Sigeo entro la politica marittima pisistratide in relazione
all’importazione di cereali dal Ponto Eusino deve essere comprovata alla luce della complessa,
e tutt’ora discussa, questione storica relativa alle capacità alimentari del territorio dell’Attica in
epoca arcaica, cioè al rapporto fra la produzione agricola e la crescita della popolazione, e alla
105
WRIGHT 1892, pp. 9, 55, 65, 73s.; HOW-WELLS 1928, app. XVI.8; WADE-GERY 1951, p. 218; WHITE 1955, p.
17; FRENCH 1957, pp. 9, 50, 52, 55s.; ANDREWES 1958, pp. 111-113; GRAHAM 1964, pp. 32-34, 192s.; PICCIRILLI
1973, n. 7; HAAS 1985, pp. 41-43; NENCI 1988, ad Hdt. VI 34; DAVIES 1992, pp. 300s.; AUSTIN 1994, pp. 558564; DAVIES 1997, pp. 134s.; SCOTT 2000, p. 98; DE STE. CROIX 2004, pp. 353-367; HOUBY-NIELSEN 2009, pp.
196s.
106
ANDREWES 1982 a, p. 374; ANDREWES 1982 b, pp. 404s.; KOROMILA 1991, pp. 16-40; GREAVES 2000, p. 4849; HÜNEMÖRDER 2011, s.v. “Etesiai” in BNP. Sull’impossibilità di navigare da Atene verso Lemno con vento
contrario vd. Hdt. VI 139.4. Viceversa sul favorevole influsso dei venti Etesii di nord-est nella navigazione
dall’Ellesponto in direzione dell’Egeo, vd. Hdt. VI 140. Non diversamente dalla situazione qui discussa, nel IV
secolo i venti Etesii influenzano le scelte militari e politiche di Filippo II di Macedonia e di Atene nelle operazioni
in Chersoneso e nell’Ellesponto: vd. Demosth. De Chers. 8.14-18. Sulla corrente marina nella Propontide, oltre
alla bibliografia citata, si veda l’attestazione in Strab. XIII 1.22.
170
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
possibilità di stimare la produttività del suolo e l’andamento dei raccolti delle antiche poleis
greche. Per altro verso la ricostruzione proposta per Sigeo richiede la verifica dello sviluppo e
dell’evoluzione diacronica della produzione agricola delle colonie elleniche nel Ponto Eusino e,
particolarmente, dell’esportazione di surplus cerealicolo verso la Grecia, o perlomeno verso la
Propontide.
Gli studi specializzati in questa materia hanno determinato infatti che Atene e l’Attica
furono perlopiù autosufficienti dal punto di vista alimentare fino al IV secolo: questa stima
smentirebbe dunque che la strategia pisistratide fosse volta, nel VI secolo, a procurare alla polis
le risorse cerealicole del Ponto107. Eppure, le analisi più approfondite valutano non solo il
rapporto dell’area coltivabile dell’Attica in relazione alla stima della crescita della popolazione,
ma prendono in considerazione un complesso sistema di fattori quali, ad esempio, la bassa
produttività del suolo in Attica, la mancata pratica di un’adeguata rotazione dei raccolti e
concimazione dei terreni in Grecia, il basso rapporto fra seminato e produzione, soprattutto la
peculiare caratteristica della Grecia di subire drammatiche fluttuazioni annuali delle
precipitazioni; si consideri infine che eventi accidentali o militari potevano facilmente
sconvolgere l’equilibrio fra risorse e popolazione108. Questi ed altri fattori agronomici delineano
dunque per la Grecia arcaica un sistema di poleis che, pur rientrando entro i parametri medi
dell’autosufficienza alimentare, corsero sempre, fin dall’epoca più antica, il rischio di non
raggiungere, di anno in anno, una produzione sufficiente alle necessità della propria
popolazione. Si potrà pur riconoscere dunque che le importazioni alimentari non furono lo
strumento principe della politica alimentare di Atene fino al IV secolo, tuttavia fin
dall’arcaismo Atene dovette almeno poter fare affidamento su fonti alternative, esterene
all’Attica, per implementare il proprio mercato cerealicolo in ricorrenti situazioni di necessità,
emergenza o pericolo109.
Per implementare le proprie risorse alimentari le poleis greche fecero certo ricorso ad un
sistema economico regionale di centri e territori produttivi. In questo senso si potrebbe
aggiungere un interesse economico ai moventi di Pisistrato nel mantenimento delle alleanze con
Eretria e i Tessali, entrambe regioni ad alta produttività agricola110. Alla luce di una
107
DAVIES 1997, pp. 134s.
GARNSEY 1988, pp. 107-133; KEEN 2000, soprattutto p. 63-65, 70-73; SCOTT 2000, pp. 99s.; REED 2003, pp.
15-19, 47s.; MORENO 2007.
109
Ps. Xen. Ath. Pol. II 6 esplicita le disconitinuità regionali della produzione cerealicola e stringe un chiaro nesso
fra risorse alimentari e importazioni via mare; Plut. Sol. 24.1 tramanda della preoccupazione di Solone, nel 594, di
limitare le esportazioni di cereali dall’Attica. DAVIES 1992, pp. 300s.; KEEN 2000, pp. 64-66; MORENO 2007, pp.
165-210.
110
MORENO 2007, pp. 37-76 sul sistema economico alimentare dei mercati interni all’Attica, pure nel V e IV
secolo, pp. 77-140 sul sistema regionale di mercati cerealicoli legati all’Attica; TSETSKHLADZE, 2009, p. 335.
108
171
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
preoccupazione per l’autosufficienza alimentare dell’Attica nonché per il consolidamento di un
sistema economico affidabile è da interpretarsi anche il fenomeno della colonizzazione, nel
caso specifico la fondazione di Sigeo: la colonia consentì di dislocare parte della cittadinanza e
alleggerire così il carico che gravava sulla produzione agricola attica; inoltre la nuova colonia
poteva a sua volta creare un mercato ulteriore per rifornire Atene di risorse agricole e per
l’esportazione delle produzioni specializzate dell’Attica, quali l’olio di oliva111.
Spostando l’analisi all’area del Ponto Eusino, l’archeologia conferma effettivamente che
dalla metà del VI secolo si intensificarono i contatti commerciali fra le colonie e la Grecia sia
asiatica sia continentale. La ceramica attica, in particolare, compare in percentuali significative,
insieme a ceramica di provenienza micrasiatica, fra i reperti di scavo in tutte le colonie greche
del Ponto Eusino, dalla Scizia alla Colchide, proprio a partire dall’epoca della tirannide
pisistratide112. Non mi pare il caso di discutere in questa sede il problema dell’identificazione
dei vettori di questo commercio, che non necessariamente dovettero essere commercianti
ateniesi113, ma intendo sostenere che la fondazione pisistratide a Sigeo trova la propria ragione
d’essere nel quadro di questo sistema economico e commerciale che andava allora prendendo
forma. Non era cioè una priorità che i commercianti ateniesi giungessero a navigare la
Propontide e tantomeno il Ponto Eusino, delle cui pericolose acque non avevano peraltro alcuna
esperienza: la considerazione di Pisistrato dovette piuttosto essere quella di garantire ai navigli
provenienti da, o diretti ad, Atene un attracco sicuro in una regione di tangenza ed accesso a
questo nuovo e dinamico areale commerciale114.
Gli specialisti nello studio della grecità coloniale del Ponto notano la ingente e costante
produttività delle coltivazioni di quelle poleis; proprio a partire dalla metà del VI secolo, è
riconoscibile con chiarezza una tendenza nelle poleis dell’area danubiana e scitica ad espandere
il territorio messo a coltivazione, tramite la fondazione di insediamenti rurali nella propria
chora: è innegabile dunque che da quel periodo in avanti i Greci del Ponto Eusino producessero
cereali in surplus, specificamente in vista della loro esportazione115.
In considerazione dunque della storia che si è tracciata degli approvvigionamenti
alimentari della Grecia e di Atene e in considerazione della cronologia dello sviluppo del
111
Plut. Sol. 24.1. HAAS 1985, pp. 43s.; MORENO 2007, pp. 33-74.
KATCHARAVA 1990; LORDKIPANIDZÉ-MIKÉLADZÉ 1990, pp. 173-185; PAROMOV 1990; VINOGRADOVZOLOTAREV 1990; KATCHARAVA 1997; KREBS 1997; LICHELI 1997.
113
KEEN 2000, p. 63.
114
URE 1922, p. 63; DE STE. CROIX 2004, pp. 353s.
115
NOONAN 1973; PAROMOV 1990; ŠČEGLOV 1990; KREBS 1997; KEEN 2000; TSETSKHLADZE 2009, pp. 337-345.
La prima attestazione letteraria dell’importazione di cereali dal Ponto Eusino verso la Grecia continentale riguarda
l’inizio del V secolo: Hdt. VI 5, 26; VII 147.
112
172
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
commercio greco-pontico, mi pare innegabile che il Sigeo fosse inteso anche come un approdo
ateniese che consentisse di accedere alle esportazioni di grano dal Ponto Eusino.
Quand’anche si volesse applicare una giusta cautela nel valutare la portata delle
importazioni ateniesi di grano dal Ponto Eusino in epoca arcaica, mi pare non superficiale
considerare che attraverso l’Ellesponto transitava una varietà di merci di grande interesse
provenienti dall’area pontica: dall’area danubiana e dalla Scizia provenivano essenziali materie
prime e lavorate quali pelli, pelliccie, miele, cera, fibre di canapa, bestiame e cacciagione,
nonché cavalli; dalle poleis costiere si esportavano grandi quantità di pesce essicato; Sciti e
Traci erano fra i principali bacini umani da cui provenivano gli schiavi alla Grecia; i grandi
fiumi che sfociavano nel Ponto Eusino dovevano essere una delle vie di transito per il
commercio dei frammenti di ambra provenienti dall’Europa settentrionale; la Colchide era
un’area di produzione di metalli preziosi; l’intero arco montano dei Carpazi, nella Tracia
interna, era un’importante area metallifera i cui prodotti giungevano al Ponto lungo le vie di
transito fluviale dell’Istro e dei suoi affluenti116.
In conclusione mi pare vi siano sufficienti dati per considerare il fattore alimentare e
commerciale fra i moventi principali della strategia di Pisistrato ed Egesistrato a Sigeo. In
prima istanza Pisistrato dovette ritenere utile difendere la causa dell’antica fondazione coloniale
ateniese in Troade, derivandone un immediato prestigio sociale e militare e trovandovi un
espediente per mitigare le tensioni sociali in Atene e per migliorare il rapporto fra risorse e
popolazione. In virtù anche della sua pregressa esperienza nell’Egeo settentrionale, Pisistrato
era però anche al corrente del traffico commerciale che era andato sviluppandosi fra la Grecia
propria e la grecità coloniale del Ponto e volle assicurarsi che Atene, la sua classe aristocratica e
la sua stessa famiglia, non fossero tagliati fuori da questi sviluppi: Sigeo ricoprì dunque
parallelamente questa funzione di accesso e controllo delle rotte commerciali verso la
Propontide e allo stesso modo funse anche il possedimento tirannico dei Filaidi in Chersoneso.
116
Hdt. V 6; Strab. VII 4.6; XI 1.3; Pol. IV 38.4s. LORDKIPANIDZÉ-MIKÉLADZÉ 1990, pp. 170-185; ŠČEGLOV
1990, pp. 151-153; KOROMILA 1991, pp. 87s., 192-196; KATCHARAVA 1997; REED 2003, pp. 21-23; MORENO
2007, pp. 165-167; VON BREDOW-BOROFFKA 2011, s.v. “Thraci, Thracia” in BNP.
173
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
IV.4. La tradizione sulla conduzione della politica interna da parte dei Pisistratidi (540527)
Con la terza e definitiva tirannide Pisistrato controllò Atene per diciannove anni, dal 546
al 528/7, fino alla sua morte117. La tradizione letteraria fornisce, come si è visto finora, un buon
novero di notizie e informazioni sull’instaurazione della tirannide nel 546, circa le relazioni
internazionali della famiglia tirannica e la conduzione della politica di Atene sul piano locale e
inter-statale nei primi anni della tirannide, nel periodo 546-540 ca. La biografia di Pisistrato e le
iniziative di natura internazionale dei Pisistratidi rimangono però senza trattazione puntuale per
buona parte dei 19 anni di tirannide, fino alla successione di Ippia nel 528/7. La tradizione
scritta fornisce piuttosto memoria del modo in cui Pisistrato condusse la politica locale ad
Atene: il governo di Pisistrato fu ricordato come non gravoso, né odioso, misurato e saggio,
rispettoso delle consuetudini e delle istituzioni politiche dello stato; i Pisistratidi imposero una
tassazione oculata e dedicarono particolare attenzione alle condizioni economiche degli strati
più bassi della società, pure ottenendo comunque l’appoggio di “molti dei nobili come dei
democratici (τῶν γνωρίµων καὶ τῶν δηµοτικῶν οἱ πολλοί)118; il giudizio nelle fonti fu tanto
positivo che alcuni inserirono il tiranno Pisistrato nel novero dei sapienti della Grecia119. I dati
archeologici e la critica moderna concordano con la tradizione antica nell’attribuire a Pisistrato
una politica locale di un certo rilievo soprattutto nell’ambito urbanistico, cultuale e giuridico120.
Se non per un cenno in Tucidide in merito alla conduzione positiva delle guerre di Atene,
questa tradizione non apporta dati utili alla ricostruzione dell’operato di Pisistrato sul piano
internazionale.
Per un verso sembra si debba dunque inferire che, dopo la conquista del potere ad Atene,
Pisistrato abbia posto subito i capisaldi della propria politica internazionale e che poi, per il
resto del suo governo e della sua vita, egli abbia rinunciato ad ulteriori interventi, piuttosto
mantenendo e consolidando la rete creata a partire dai primi anni della sua vita pubblica, poi
durante l’esilio dal 556 e infine nei primi anni di tirannide successivi al 546. Per altro verso, il
silenzio delle fonti sulle relazioni internazionali di Pisistrato nel periodo 540-528 può, a mio
avviso, colmarsi con un’analisi e una contestualizzazione storica delle informazioni disponibili
per la tirannide del successore Ippia, ricostruendo cioè la catena di eventi e cambiamenti
intercorsi fra l’uno e l’altro e dunque infine delineando un quadro più dinamico anche dei
rimanenti dodici anni dell’operato di Pisistrato.
117
Aristot. Ath. Pol. 17.1. SANDYS 1912, pp. 58-60, 68s.; ADCOCK 1924; RHODES 1981, ad Aristot. Ath. Pol. 17.1.
Aristot. Ath. Pol. 16.9.
119
Hdt. I 59.6; Thuc. VI 53.3, 54.5-7; Aristot. Ath. Pol. 14.3, 16.1-17.1; Diod. IX 57; Diog. Laert. I 9.
120
KYLE 1987, p. 159.
118
174
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
IV.5. Le risorse economiche e militari del Pangeo nel mantenimento del potere di
Pisistrato
La terza e definitiva tirannide di Pisistrato fu “radicata” (rhizòo), secondo le fonti, grazie
alle numerose guardie armate mercenarie (epìkouroi) e alle ingenti ricchezze (chrèmata)
provenienti dall’Attica e dal fiume Strimone121. Queste ricchezze derivavano certamente dalle
miniere del monte Pangeo in Tracia, ove Pisistrato aveva istituito un possedimento personale
durante l’esilio da Atene nel periodo 556-546; è evidente peraltro che quelle stesse risorse
finanziarie furono il mezzo per assoldare e mantenere le proprie guardie mercenarie testé
menzionate122. Nelle “ricchezze provenienti da Atene” (χρηµάτων συνόδοισι, τῶν µὲν αὐτόθεν)
la critica ha identificato i proventi dell’attività estrattiva presso le miniere del Laurion in
Attica123; a questi introiti mi pare necessario aggiungere anche una serie di ricchezze che il
tiranno dovette avere modo di raccogliere in patria da fonti alternative all’attività mineraria,
dalla gestione delle proprietà familiari o dai vantaggi derivati dall’ampio potere politico che
poteva esercitare entro lo stato ateniese124.
Volendo dunque accettare le parole di Erodoto dovremo avanzare la ricostruzione secondo
cui, anche durante la tirannide, i proventi economici del Pangeo in Tracia e i mercenari che
questi assicuravano furono strumenti importanti nel mantenimento del potere personale contro
le possibilità di reazione degli avversari aristocratici ateniesi125. Nondimeno Pisistrato integrò
queste due risorse in un insieme molto più ampio di interventi politici, sociali, urbanistici ed
121
Hdt. I 64.1; Aristot. Ath. Pol. 15.2.
G. Grote ritenne di dover interpretare il passo erodoteo nel senso che le ricchezze provenissero dall’Attica,
mentre i mercenari provenissero dallo Strimone: GROTE 1862, vol. IV, p. 145. Personalmente concordo con
l’obiezione mossa a Grote da G. Rawlinson che non riconobbe elementi sufficienti per attribuire alle parole di
Erodoto tale distinzione: RAWLINSON 1858, vol. I, p. 201. Mi pare ormai ampiamente provato il carattere minerario
e il ruolo economico che lo stanziamento al Pangeo ebbe per Pisistrato; si può d’altronde infine accettare che le
squadre di mercenari impiegate dal tiranno provenissero effettivamente dalla Tracia, piuttosto che dall’Attica.
HOPPER 1961, pp. 141-146; COLE 1975.
123
DESBOROUGH COOLEY – LARCHER 1844 vol. I, p. 69; URE 1922, pp. 41-51, 291s.; HOPPER 1961, pp. 141-144;
DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 95-97, 106; ANDREWES 1982b, pp. 394s; WATERS-ANNIBALETTO 2000, n. 1 ad Hdt. I
64; HOUBY NIELSEN 2009, pp. 193-196.
124
Erodoto stesso non menziona infatti le miniere dell’Attica, ma usa invece un avverbio non specifico per riferirsi
a “ricchezze raccolte sul luogo (Atene)”: il riferimento potrebbe essere dunque a sovvenzioni dei clienti locali,
requisizioni agli avversari espulsi, introiti familiari agricoli o commerciali, forme di tassazione o di appropriazione
di risorse pubbliche. Non è peraltro questione di secondo ordine quella in merito al grado di controllo che il tiranno
fu in grado esercitare sui beni pubblici quali appunto le miniere del Laurion. Hdt. VII 144. RAWLINSON 1858, vol.
1, pp. 200s.; HOPPER 1961, pp. 140s.; ANDREWES 1982b, p. 409. Sulla tassazione imposta agli Ateniesi dai
Pisistratidi: Thuc. VI 54. Sulla questione del ruolo dei mercenari stranieri alla battaglia di Pallene e nel
mantenimento del potere di Pisistrato: ANDREWES 1958, pp. 107-115; DREWES 1972, p. 144; FROST 1984, pp. 291293; BETTALLI 1995, pp. 88-90; DE LIBERO 1996, pp. 65s.; HÖLKESKAMP 1997, p. 484; LAVELLE 1997; DE LIBERO
1998; LAVELLE 2005, pp. 136-139.
125
STEIN HÖLKESKAMP 1996, pp. 654-656; DELIBERO 1996, pp. 81-84; LAVELLE 1997 recensione a DE LIBERO
1996; DELIBERO 1997 fornisce risposta a LAVELLE 1997.
122
175
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
economici rivolti alla gestione della polis e tendenzialmente di carattere demagogico tesi ad
assicurare un consenso ampio e trasversale, sia fra il dèmos che fra le famiglie più eminenti126.
È interessante rilevare da questa ricostruzione il meccanismo per cui le iniziative di politica
estera, quale fu appunto l’intervento in Tracia, ebbero per i tiranni non solo un ruolo
nell’affermazione del ruolo della famiglia e della polis entro il sistema internazionale, ma anche
nella successiva gestione del potere e del consenso al livello locale ateniese, insieme agli
interventi propriamente di gestione amministrativa: si afferma dunque quella relazione di
dipendenza reciproca fra ambito locale e ambito internazione che è uno dei temi che emergono
ricorrenti in questa ricerca.
Ora si ripropone il problema relativo alla durata del controllo pisistratide
dell’insediamento al Pangeo, poiché ci si pone l’obiettivo di capire quali elementi della politica
internazionale furono determinanti nell’assicurare il mantenimento, a lungo termine, del potere
tirannico di Pisistrato e dei suoi successori, dunque nel periodo 540-528/7 e poi in seguito.
Parte della critica moderna ritiene che l’insediamento presso le miniere del Pangeo sia coinciso
con il decennio di esilio (556-546), cioè che sia stata un’operazione limitata e temporanea volta
all’accumulo di risorse economiche e militari in vista del rientro forzato ad Atene e in funzione
delle spese militari da sostenere nella preparazione dello sbarco a Maratona. Alla luce di questa
ricostruzione si potrebbe giustificare infatti il fatto che la tradizione storica ne abbia perso
presto le tracce127. Relativamente invece al precedente insediamento para-coloniale di
Rhaikelos si è ipotizzato che esso si sia unito ad altri centri preesistenti dell’area, venendo così
assorbito da entità statali più organizzate128; d’altronde lo sviluppo della situazione al Mt
Pangeo presso il fiume Strimone rimane invece poco chiaro e poco analizzato.
Senz’altro i Pisistratidi controllavano e sfruttarono l’insediamento del Pangeo nel 546,
quando, in preparazione del rientro in Attica dall’esilio, dalla Tracia pervennero ricchezze e
corpi armati mercenari che assicurarono la vittoria alle forze del tiranno. Eppure non mi pare si
debba sottovalutare l’osservazione di Erodoto secondo cui durante la terza tirannide, dunque
anche dopo il rientro in Attica e dopo la stabilizzazione della tirannide, Pisistrato rese saldo il
proprio potere grazie ai mercenari (epìkouroi) e alle ricchezze (chrèmata) provenienti dallo
Strimone129. Questa testimonianza impone dunque di escludere che i Pisistratidi abbiano
abbandonato il loro insediamento presso lo Strimone pur essendo rientrati in Attica:
l’insediamento familiare in Tracia rimase cioè strategico anche nel corso della tirannide di
126
Aristot. Ath. Pol. 16.9.
COLE 1975, pp. 42-44; VENEDIKOV 1977; ISAAC 1986, pp. 14-17, 33, 145s.; BRAUND 2001, pp. 7, 13-25.
128
COLE 1975.
129
Hdt. I 64; Aristot. Ath. Pol. 15.2. COLE 1975; BING 1977, p. 311.
127
176
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
Pisistrato il quale continuò a usufruire dei proventi economici derivanti dallo sfruttamento
dell’area mineraria, trasferendo ricchezze a vantaggio del potere personale che deteneva ad
Atene130.
Se non è dunque necessario legare il rientro in Attica all’abbandono delle attività in
Tracia, ritengo più sicuro scendere nella cronologia della storia dei Pisistratidi e dell’area
tracica per verificarvi situazioni ed eventi politico-strategici che abbiano potuto sconvolger gli
equilibri della zona: in questo senso ritengo si debba abbassare la data della fine
dell’insediamento pisistratide presso il Pangeo al periodo della spedizione scitica di Dario I, nel
513, dunque durante la tirannide di Ippia, periodo per il quale le fonti mostrano un significativo
silenzio in merito alla presenza dei Pisistratidi in Tracia, peraltro nonostante le notizie sulle
operazioni militari del generale persiano Megabazo.
IV.6. L’esilio e il rientro di Cimone filaide e la proclamazione olimpionica di Pisistrato
(532)
La storia della famiglia dei Filaidi fornisce una traccia per aggiungere alcune informazioni
sulla posizione di Pisistrato sul piano internazionale nel periodo 540-528. Quando il Filaide
Cimone riportò la sua prima vittoria olimpica con la celebra quadriga di cavalle, secondo
Erodoto, egli era allora in esilio, allontanato da Atene da Pisistrato; questo avvenimento è stato
collocato nell’Olimpiade 61, nel 536. Nella successiva olimpiade (Ol. 62, nel 532) Cimone
vinse per la seconda volta la gara delle quadrighe, ma egli concesse a Pisistrato di essere
proclamato vincitore (παραδιδοῖ Πεισιστράτῳ ἀνακηρυχθῆναι): così, secondo l’accordo stretto
col tiranno (ὑπόσπονδος), egli poté fare ritorno ad Atene e riottenere le sue proprietà. La terza
vittoria, all’Olimpiade 63, che rese Cimone oltremodo celebre, ricade in un’epoca in cui
Pisistrato era già morto, se pur da poco, nel 528/27131.
L’imposizione dell’esilio a Cimone da parte di Pisistrato è apparentemente in
controtendenza rispetto all’intesa inter-familiare che questa ricerca è andata individuando fra
Pisistratidi e Filaidi132. È pure comprensibile che moventi, atteggiamenti e scelte individuali
abbiano caratterizzato il rapporto fra i Pisistratidi e singoli individui dei Filaidi: la storia
tracciata per questa famiglia ha infatti individuato per Cimone una posizione e uno status atipici
rispetto a quelli del resto dei Filaidi. Gli elementi che si pongono in evidenza nel motivare
130
HOPPER 1961, pp. 141-146.
Hdt. VI 103.
132
CULASSO GASTALDI 1996, pp. 507s.
131
177
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
l’alleanza che i Pisistratidi furono interessati a mantenere con i Filaidi sono infatti quelli della
discendenza dai Cipselidi, tiranni di Corinto133, e l’impegno congiunto nell’organizzare la
colonizzazione del Chersoneso Tracico e nel posizionamento di insediamenti ateniesi sulle rotte
dell’Ellesponto. Cimone non rispondeva invece a nessuna di queste due caratteristiche: egli era
figlio di Stesagora e non di Cipselo ateniese; inoltre la stessa notizia dell’esilio, del rientro e
della successiva riappropriazione delle ricchezze in Attica testimoniano la volontà di Cimone di
rimanere ad Atene. Questi aspetti del carattere e dell’operato di Cimone giustificano l’attrito fra
lui e Pisistrato che provocò il suo esilio alcuni anni prima del 536. Inoltre queste medesime
caratteristiche furono il motivo per cui, più tardi, anche Ippia, nel 528/7, venne in disaccordo
aperto con Cimone, al punto che si giustifica agli occhi della tradizione storiografica successiva
l’attribuzione del commissionamento dell’assassinio di Cimone, di recente vincitore olimpico,
alla volontà del tiranno appena insediato al potere. Se pure dunque nel 540 ca. Pisistrato godeva
di una buona e costruttiva intesa con Milziade I, attivo nella penisola del Chersoneso Tracico,
viceversa la presenza di Cimone ad Atene e la sua attività agonale sul piano panellenico
rappresentarono invece una minaccia per il tiranno.
La storia dell’esilio di Cimone e poi dell’accordo che permise il suo rientro ad Atene ha
fornito alla critica l’occasione per riflettere sull’interesse dei Pisistratidi per l’ippotrofia134;
relativamente all’analisi delle relazioni internazionali, mi pare che la notizia sia significativa
perché permette di collocare i Pisistratidi entro il circuito sociale e culturale panellenico del
santuario di Olimpia e in genere entro quel gruppo aristocratico panellenico che frequentava i
grandi santuari e le celebrazioni agonistiche dell’Ellade135. Già il padre di Pisistrato, Ippocrate,
visitò il santuario di Olimpia in occasione delle celebrazioni panelleniche in onore di Zeus, alla
fine del VII sec: in quel contesto si colloca l’incontro tra lui e lo spartano Chilone136. L’accordo
che Pisistrato strinse con Cimone in occasione dell’Olimpiade del 532 ebbe come scopo proprio
quello di guadagnare l’onore e la celebrità della vittoria olimpica alla medesima celebrazione
cultuale panellenica. È attestata epigraficamente una dedica di Ipparco, figlio di Pisistrato, al
tempio di Athena Pronaia presso il santuario di Apollo Ptoios in Beozia. L’analisi e la
contestualizzazione che la critica ha condotto su questa epigrafe e su un’altra ad essa affine, ma
133
ANDREWES 1958, pp. 105s.
Sull’importanza dell’ippotrofia per i Pisistratidi la critica ha messo in evidenza l’onomastica familiare, in cui
abbondano nomi con la radice Hipp-, il rientro di Pisistrato dal primo esilio a bordo di un carro (Hdt. I 60; Aristot.
Ath. Pol. 14.4), nonché l’attenzione al programma agonale delle Grandi Panatenee, ad Atene; a queste osservazioni
aggiungo la notizia erodotea secondo cui i figli a cavallo, al comando di un contingente di cavalieri, inseguirono
gli Ateniesi in fuga dal campo di battaglia di Pallene, nel 546 (Hdt. I 63). KYLE 1987, pp. 158s.; DUPLOUY 2006,
pp. 133-135; contra DAVIES 1971, p. 454.
135
NENCI 1988, ad Hdt. VI 103.
136
Hdt. I 59.
134
178
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
dedicata invece da un membro degli Alcmeonidi, porta a ritenere che l’iscrizione fosse apposta
sulla base di una statua di Atena e che l’occasione per la dedica fosse quella di una vittoria agli
agoni delle Grandi Panatenee di Atene, nel 520 ca137. Se questa ricostruzione fosse valida
contribuirebbe a confermare ulteriormente l’attenzione dei Pisistratidi non solo verso il
santuario di Olimpia, ma in genere verso l’agonismo aristocratico, le forme di proclamazione
pubblica e il circuito dei santuari panellenici.
Come per i Filaidi Milziade I e Cimone, entrambi vincitori olimpionici, anche per i
Pisistratidi la frequentazione dei santuari panellenici e particolarmente, nel caso in discussione,
del santuario di Olimpia aveva un valore non solo cultuale e onorifico, ma anche politico: la
partecipazione e la vittoria negli agoni offrivano l’opportunità di dimostrare e affermare il
proprio merito personale e il prestigio della famiglia, costituivano momenti di visibilità
internazionale privilegiati e dunque anche di propaganda, di dimostrazione e ricollocamento del
proprio status: conseguentemente ne derivava anche un miglioramento del proprio ascendente
politico, sia entro la polis nei confronti dei concittadini, sia nel contesto internazionale e nel
circuito aristocratico panellenico; per Pisistrato e per i tiranni si trattava anche di giustificare
tramite azioni fisiche e simboliche il ruolo di comando che essi detenevano nella gestione della
politica statale.
La proclamazione della vittoria olimpica e tanto più la cessione da parte di Cimone di
quell’onore furono una dimostrazione per il popolo e gli aristocratici di Atene del potere di
Pisistrato e della necessità per tutti di cedere alla sua tirannide. Viceversa l’accordo fra
Pisistrato e Cimone privava il Filaide degli onori olimpionici, imponeva una riduzione del suo
status e una sottomissione della sua libertà di auto-affermazione nei confronti del tiranno138.
Nel contesto internazionale Pisistrato proclamava indiscutibilmente la propria supremazia su
Atene e dunque la sua posizione quale referente politico per i concittadini e lo stato.
IV.7. I figli durante la tirannide di Pisistrato
Pisistrato ebbe quattro figli nel corso della propria vita: Ippia e Ipparco nacquero da una
donna ateniese che egli sposò prima della tirannide del 560; nel periodo intorno alla prima
tirannide egli sposò Timonassa di Argo da cui ebbe i figli Egesistrato, soprannominato Tessalo,
e Iofonte. Ippia era il primogenito e perciò fu il naturale ed indiscusso erede e successore di
Pisistrato nel controllo tirannico: alla morte di Pisistrato, nel 528, Ippia subentrò perciò al padre
137
138
SHAPIRO 1989, pp. 49s.; KYLE 1987, pp. 158s.
NENCI 1988, ad Hdt. VI 103; KYLE 1987, pp. 158s.
179
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
nella gestione dell’òikos pisistratide, ereditò le relazioni familiari e personali che Pisistrato
aveva costruito, assunse la tirannide e perciò il controllo politico di Atene e portò avanti dunque
anche le relazioni internazionali dei Pisistratidi e la direzione della politica estera di Atene139.
Nonostante la posizione preminente di Ippia, si è già puntualizzato come la gestione della
tirannide dipendesse da un’organizzazione familiare organica ed allargata che faceva in modo
di assicurare il controllo di posizioni politiche nella polis oppure di contesti strategici o
geografici extra-poleici tramite l’intervento e il posizionamento di membri della famiglia o
alleati a loro vicini. Si riscontra dunque il fatto che i due figli ateniesi, Ippia ma anche Ipparco,
ricoprirono ruoli significativi nella storia e nella politica di Atene degli ultimi decenni del VI
secolo; dei due figli argivi si conosce la carriera di Egesistrato/Tessalo nel conservare il potere
dei Pisistratidi a Sigeo in Troade140. Appunto entro la prospettiva della gestione familiare,
piuttosto che personale, del potere tirannico già durante la tirannide di Pisistrato si può notare
l’intervento dei figli nella gestione del controllo su Atene e delle iniziative internazionali.
Il consiglio ad Eretria in vista del rientro ad Atene (546)
La prima notizia relativa alla partecipazione al potere di Ippia risale all’epoca del secondo
decennale esilio dei Pisistratidi da Atene: allora Pisistrato, rifugiatosi ad Eretria nel periodo
precedente al 546, tenne un consiglio insieme ai propri figli per decidere come procedere.
L’opinione che prevalse fu quella di Ippia, al quale Erodoto attribuisce la proposta di
raccogliere alleati, denaro e soldati fra quelle poleis che avevano degli obblighi nei confronti
della loro famiglia e dunque di rientrare con la forza ad Atene per conquistare il potere141.
In prima istanza il passo di Erodoto fornisce testimonianza della partecipazione della
famiglia nei processi decisionali della tirannide e dimostra come, già nel 546, il successore
destinato Ippia ricoprisse un ruolo significativo e attivo e fosse in grado di coadiuvare il padre e
impostare la strategia per la famiglia. Relativamente alla comprensione delle relazioni
internazionali dei Pisistratidi, il resoconto erodoteo implica che Ippia fosse a conoscenza della
struttura della rete di alleanze costruita e sostenuta da Pisistrato: almeno già nel 546 egli era
cioè al corrente di quali fossero gli alleati e gli associati della propria famiglia e delle loro
posizioni strategiche e politiche, era in grado di valutare la natura e il grado di reciprocità e il
legame che li univa ai Pisistratidi, possedeva informazioni sufficienti in merito alle loro
139
Hdt. V 94; Thuc. VI 54s.; Aristot. Ath. Pol. 17s. HOW-WELLS 1928, ad Hdt. V 94; SUTHERLAND 1943, p. 142;
DAVIES 1971, n. 11793; RHODES 1981, ad Aristot. Ath. Pol. 14-19; LAVELLE 2005, pp. 103s., 207; DUPLOUY
2006, pp. 86s.; HORNBLOWER 2008, ad Thuc. VI 54; KINZL 2011, s.v. “Peisistratids”, in BNP.
140
Aristot. Ath. Pol. 18.1s.
141
Hdt. I 60. VIVIERS 1987.
180
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
capacità politiche, economiche o militari e al contributo che avrebbero potuto fornire per il
rientro ad Atene.
La compartecipazione dei figli in questa circostanza nasce anche dalla natura stessa delle
relazioni internazionali che segnavano la posizione dei Pisistratidi nella comunità di élite della
Grecia arcaica, specificamente in quel momento della loro carriera politica: si è infatti più volte
avuto modo di notare come la natura personale e familiare di quelle relazioni comportasse la
loro applicabilità all’òikos dei contraenti e soprattutto si è chiarito il loro carattere ereditario. In
questo senso dunque fu naturale, se non indispensabile, per Pisistrato chiamare i figli, e
soprattutto il primogenito Ippia, a partecipare della gestione della tirannide e delle relazioni
internazionali sue ma, per necessaria estensione, anche della famiglia. Sulla base di queste
considerazioni dunque si giustifica anche quella naturale continuità che si rileva nella
narrazione della vicenda storica dei Pisistratidi al momento della morte di Pisistrato e
dell’assunzione del potere da parte di Ippia142.
Quando fu poi messa in atto la proposta di Ippia e i Pisistratidi con i propri alleati
giunsero alla decisiva battaglia di Pallene, nel 546, di nuovo Erodoto fornisce testimonianza
dell’intervento attivo dei figli. Nella battaglia la maggior parte dell’esercito ateniese fu presto
volta in fuga; allora Pisistrato ordinò ai figli di inseguire gli Ateniesi per assicurarli delle sue
intenzioni non violente e per persuaderli a rientrare con tranquillità nelle proprie abitazioni e a
riprendere le loro abituali occupazioni143. Il passo testimonia di una posizione di Ippia e Ipparco
nell’organizzazione militare delle forze pisistratidi, quali comandanti della cavalleria; inoltre è
segno del carattere di rappresentatività politica e di autorità dei figli quali portavoce di
Pisistrato nei confronti della comunità.
142
143
SUTHERLAND 1943, p. 142.
Hdt. I 63.
181
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte IV: Pisistrato al potere tirannico
182
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
PARTE V: I FILAIDI
V.1. I Filaidi: la posizione della famiglia nella diplomazia internazionale
Insieme ai Pisistratidi che tennero la tirannide e agli Alcmeonidi che a questi si opposero,
i Filaidi furono una delle famiglie influenti e attive nell’Atene di epoca arcaica e del V secolo; i
Filaidi si inserirono appieno nell’élite aristocratica panellenica e internazionale, ebbero un ruolo
nella gestione della politica estera di Atene e mantennero una dinastia tirannica nel Chersoneso
Tracico durante il periodo della tirannide pisistratide ad Atene.
La prestigiosa parentela dei Filaidi con i Cipselidi di Corinto
Le prime tracce degli interventi dei Filaidi sul piano extra-poleico risalgono alla seconda
metà del VII secolo, quando la famiglia strinse legami di parentela con la celebre e potente
dinastia dei Cipselidi, tiranni di Corinto. La ricostruzione della genealogia dei Filaidi è
compromessa dalla frammentarietà e imprecisione delle fonti e si è prestata a interpretazioni
diverse; ciononostante la critica ha ricostruito un quadro piuttosto preciso entro il quale,
specificamente, la parentela con i Cipselidi è un dato indiscusso1. Nel 576 ca., il celebre tiranno
di Sicione, Clistene, diede in sposa la figlia Agariste e per scegliere il migliore fra i pretendenti
tenne un convito panellenico cui parteciparono tredici aristocratici provenienti da tutto il mondo
greco2. In un primo momento il favorito fra quel gruppo di élite fu l’ateniese Ippoclide, figlio di
Tisandro, della famiglia ateniese dei Filaidi; sebbene la vicenda si sviluppò in modo tale che
Agariste andò infine in sposa al secondo pretendente proveniente da Atene, l’Alcmeonide
Megacle, figlio di Alcmeone.
La notizia è significativa, non solo per la preferenza inizialmente accordata a Ippoclide,
ma perché questi costituì un valido pretendente esplicitamente in virtù della parentela che i
Filaidi avevano con i Cipselidi di Corinto (καὶ ὅτι τὸ ἀνέκαθεν τοῖσι ἐν Κορίνθῳ Κυψελίδῃσι
ἦν προσήκων), oltre che per la prestanza del giovane stesso (καὶ κατ᾽ ἀνδραγαθίην ἐκρίνετο)3.
Questa discendenza di membri dei Filaidi dai potenti tiranni di Corinto trova ulteriore conferma
nei dati ricavabili dall’onomastica: il filaide Milziade I, vissuto nella seconda metà del VI
1
Hdt. VI 34, 103.1; Pherecyd. Ath. BNJ 3 F 2 (ap. Marcell. Vit. Thuc. 2-5) giunge nondimeno in forma
frammentaria e certamente corrotta; Paus. IV 23.10, VI 19.6, VIII 39.3 confonde Milziade I per Milziade II figlio
di Cimone. BLAKESLEY 1854, ad Hdt. VI 34, n. 84; ANDREWES 1958, pp. 105s.; RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 35;
HAMMOND 1956; MEIGGS-LEWIS 1969, p. 11; DAVIES 1971 n. 8429, pp. 293-312; FORNARA 1983, n. 26, pp. 25s.;
DUPLOUY 2006, pp. 56-64; KINZL 2011, s.v. “Miltiades” in BNP.
2
MCGREGOR 1941, pp. 268-279, 287; MORETTI 1957, n. 96 data la vittoria olimpica di Clistene al 572, in
occasione della quale fu annunciato l’invito del tiranno a concorrere per la mano di Agariste; PARKER 1994, pp.
412s., 416s., 421.
3
Hdt. VI 126-130, in particolare 128. Contra ALEXANDER 1959, p. 133.
183
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
secolo, è riconosciuto dalle fonti affidabili come il figlio di Cipselo4; questi è da identificarsi
non con l’omonimo tiranno corinzio, ma senza dubbio con un omonimo ateniese che ricoprì
l’arcontato nel 597/6, secondo attestazioni epigrafiche5.
Confrontando fra loro i dati dunque assume cogenza la ricostruzione secondo cui, nella
seconda metà avanzata del VII secolo, il tiranno di Corinto, Cipselo, diede una figlia in sposa
ad un membro dei Filaidi di Atene, Agamestore. Da quel matrimonio nacquero due figli: il
primo ebbe nome Tisandro e fu il padre di Ippoclide, il secondo prese il nome dal nonno
materno e fu appunto quel Cipselo ateniese che fu arconte eponimo nel 597/6 e il padre di
Milziade I. Sulla base della data dell’arcontato di Cipselo e dell’età minima di trenta anni per
ricoprire quella carica, si desume che questo Cipselo filaide nacque poco prima del 627 e che il
matrimonio di Agamestore con la donna cipselide dovette avere luogo pochi anni prima, nel
635-6306. Fra le pratiche elleniche più comuni nella scelta dei nomi dei neonati vi era quella di
tramandare il nome del nonno, cioè del padre di uno dei genitori; normalmente i nomi erano
tramandati all’interno della linea paterna; quando la scelta ricadeva invece sulla linea materna si
possono desumere circostanze in cui il nonno era un personaggio di particolare spicco nella
società aristocratica panellenica, oppure casi in cui il padre del neonato assegnava una
particolare importanza personale o politica all’alleanza inter-familiare che il matrimonio aveva
sancito e che la nascita contribuiva a convalidare7.
La genealogia dei Filaidi era dunque indubitabilmente legata ai Cipselidi di Corinto per
via dell’alleanza matrimoniale fra il filaide Agamestore e il tiranno Cipselo; che quella alleanza
fu poi onorata e tenuta in alta considerazione dalla famiglia ateniese è comprovato
dall’onomastica scelta per uno dei figli nati dall’unione interdinastica. Questa parentela si
dimostrò ancora valida un quarto di secolo più tardi, nel 576 ca., quando fu un elemento
favorevole nella valutazione dei meriti del filaide Ippoclide alla corte di Clistene di Sicione. È
significativo che Clistene valuti con tale interesse la discendenza cipselide, in un’epoca in cui
già la tirannide era decaduta a Corinto: si tratta a mio avviso di un’ulteriore traccia del valore
onorifico e del prestigio sociale che il legame con i celebri tiranni di Corinto poteva assicurare
entro l’élite aristocratica panellenica8.
4
Hdt. VI 34.1, 35.1, 36.1.
MEIGGS-LEWIS 1969, n. 6 pp. 9-12.
6
HOW-WELLS 1928 ad Hdt. VI 38; DAVIES 1971, pp. 297-299; HOLLADAY 1977, pp. 43s., 55 n. 11; PICCIRILLI
1978; HERMAN 1990, p. 352.
7
Su questo punto nonchè sulla pratica delle alleanze interdinastiche entro l’aristocrazia ellenica e dunque anche fra
tiranni in genere: WILL 1955, PP. 440, 546; ANDREWES 1958, pp. 105s.; DAVERIO ROCCHI 1973; VERNANT 1973;
HOLLADAY 1977, pp. 43-44; GERNET 1983, pp. 157-159, 287-299; HERMAN 1990, pp. 19-26, 352s.; CAWKWELL
1995, p. 84, p. 84; ANDERSON 2005, 183-192.
8
WILL 1955, pp. 363-371. Vd. supra, pp. 64ss.
5
184
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
L’alleanza matrimoniale fra Filaidi e Cipselidi nel contesto internazionale
Mi pare opportuno tentare di contestualizzare quest’alleanza interfamiliare entro il quadro
degli eventi coevi e della situazione politica internazionale, al fine di comprenderne gli
eventuali moventi. L’alleanza matrimoniale fra i Filaidi e i Cipselidi, stretta tramite il
matrimonio di Agamestore con una figlia di Cipselo, fu sostanzialmente coeva all’alleanza che
portò l’ateniese Cilone a sposare la figlia di Teagene, tiranno di Megara. Il matrimonio di
Agamestore può essere avvenuto nel periodo 535-530 mentre quello di Cilone dovrebbe risalire
a poco prima del suo tentativo di prendere la tirannide ad Atene, dunque poco prima del 536 o
del 5329.
Ad un primo livello interpretativo, le due coeve alleanze familiari sono espressione della
rivalità politica fra le famiglie aristocratiche e politicamente attive di Atene e dimostrano quali
furono gli strumenti della lotta politica nella polis arcaica. Il prestigio e la ricchezza
costituirono mezzi con cui assicurarsi alleanze personali utili al di fuori della polis; da quegli
alleati potenti derivava ulteriore capacità operativa: nel caso di Cilone l’aiuto militare e nel caso
dei Filaidi un duraturo marchio di prestigio nell’élite panellenica10.
La relazione fra Cilone e Teagene, è noto, ebbe un chiaro scopo politico-militare poiché,
grazie al contributo del suocero, Cilone conquistò l’acropoli di Atene; l’alleanza trova una
contestualizzazione entro il conflitto di lungo periodo fra Atene e Megara per il controllo di
Salamina. La storia del fallimento del tentativo ciloniano e le notizie sui continuati scontri fra
Ciloniani e Alcmeonidi negli anni successivi testimoniano della presenza nella classe politica
ateniese di opposte correnti di pensiero, in merito alla politica da seguire nelle relazioni con
Megara e nella questione di Salamina: una favorevole alla riconciliazione con Megara e
un’altra, al contrario, votata a una politica militare e navale. Per quest’ultimo gruppo politico
Corinto rappresentò un naturale alleato, in funzione anti-megarese. In questa prospettiva di
politica internazionale va, a mio avviso, interpretata l’alleanza matrimoniale fra Agamestore e
Cipselo11. La scelta di politica matrimoniale dei Filaidi è dunque uno specchio della loro
inclinazione nella conduzione della politica internazionale della polis e il matrimonio
interfamiliare costituì esso stesso uno strumento della diplomazia internazionale condotta dai
Filaidi; le ricadute di quell’alleanza influirono non solo nella gestione del prestigio panellenico
della famiglia, ma anche nella disposizione di Atene entro la geopolitica del Golfo Saronico.
9
WRIGHT 1892; ALEXANDER 1959; DAVIES 1971, n. 8429 [II], p. 293-296; DAVERIO ROCCHI 1973; DUPLOUY
2006, p. 84.
10
WILL 1955, pp. 517, 545s., 567-570.
11
ANDREWES 1982 a, pp. 372-375.
185
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Secondo un altro punto di vista le due alleanze matrimoniali in discussione potrebbero
essere interpretate non solo come scelte operative delle due famiglie ateniesi, ma anche come il
tentativo di due tiranni già politicamente affermati, Cipselo e Teagene, di guadagnare alleati
all’interno della classe dirigente di Atene e dunque condizionare a proprio favore le scelte che
gli Ateniesi avrebbero compiuto in politica estera12.
Fig. 4: genealogia dei Filaidi secondo la ricostruzione degli eventi proposta in questo scritto
Le vittorie olimpiche di Milziade e Cimone
La storia della famiglia dei Filaidi è contraddistinta da una sequenza notevole di vittorie
negli agoni di Olimpia: la portata panellenica delle feste olimpiche, il significato ideologico
delle vittorie agonistiche e le conseguenze in relazione alla storia della tirannide ad Atene
impongono di fornire qui un’analisi degli eventi e delle loro implicazioni nella prospettiva delle
relazioni internazionali.
Nel medesimo periodo in cui ad Atene Pisistrato teneva saldamente la tirannide, il filaide
Cimone, figlio di Stesagora e fratello uterino del più celebre Milziade, vinse per tre volte la
corsa con le quadrighe (téthrippon) a Olimpia13, in tre celebrazioni penteteriche successive,
gareggiando ogni volta con la medesima squadra di cavalle. La datazione di queste vittorie non
è tramandata e la critica non offre ricostruzioni concordi, ma l’attribuzione che mi pare più
sicura è alle Olimpiadi n. 61, 62 e 63, tenutesi negli anni 536, 532 e 52814.
12
DAVERIO ROCCHI 1973.
DREES 1968, pp. 96-100 per una specifica esposizione degli agoni ippici di Olimpia.
14
Hdt. VI 103.2-3; Plut. Cat. Mai. 5.4. DESBOROUGH COOLEY – LARCHER 1844, ad Hdt. VI 103; WOODBURN
HYDE 1921, p. 363; WADE-GERY 1951 pp. 212-214, 219; ANDREWES 1958, p. 106; DAVIES 1971, n. 8429 VII;
13
186
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Anche il fratello uterino di Cimone, Milziade I, figlio di Cipselo, vinse la medesima gara
ippica a Olimpia, secondo le fonti, non molto prima di lasciare Atene per la fondazione
coloniale in Chersoneso Tracico. Anche per la data della vittoria olimpica di Milziade è
necessario confrontarsi con interpretazioni discordi: Erodoto informa il lettore solamente del
fatto che, all’epoca in cui Pisistrato era tiranno ad Atene, Milziade, già vincitore olimpionico,
lasciò Atene alla volta dell’Ellesponto15. Non ci sono dati sicuri per identificare quale dei tre
periodi di tirannide di Pisistrato sia lo sfondo politico della spedizione tracica di Milziade e
nemmeno siamo informati su quanto tempo fosse trascorso tra la vittoria olimpica e la sua
partenza da Atene, eppure i due eventi sono senz’altro fra loro relazionati in considerazione
delle implicazioni politiche e del prestigio ricavato dalla vittoria olimpica. Il vincitore della gara
di quadrighe nelle Olimpiadi n. 61, 62 e 63, come si è menzionato, fu il filaide Cimone;
Erodoto nota nel suo testo l’eccezionalità della sua sequenza di vittorie e tramanda il dettaglio
che l’unico altro atleta che era stato in precedenza in grado di emulare l’impresa era stato lo
spartano Evagora16; dunque le vittorie di Evagora devono perlomeno risalire necessariamente
alle tre Olimpiadi precedenti quelle in cui vinse Cimone, cioè alle Olimpiadi n. 58, 59 e 60,
rispettivamente negli anni 548, 544 e 54017. Pure, ritengo che le tre vittorie consecutive di
Evagora non necessariamente precedettero immediatamente quelle di Cimone, ed è più
probabile anzi che vi furono altri vincitori alle quadrighe nel periodo fra Evagora e Cimone; la
narrazione erodotea non esclude affatto questa sequenza. In base a queste considerazioni, la
vittoria olimpica di Milziade è da individuarsi nelle Olimpiadi n. 55, 56 o 57, tenutesi negli anni
560, 556 e 55218; fra queste ritengo che la più storicamente plausibile sia la prima, cioè
l’Olimpiade 55 del 560. Seguendo infatti il testo erodoteo e la contestualizzazione storica,
emerge che la vittoria di Milziade a Olimpia costituì una premessa funzionale alla successiva
spedizione che egli condusse in Chersoneso Tracico; a sua volta, si vedrà, questa spedizione è
da collocarsi durante il periodo della seconda tirannide di Pisistrato, antecedente al 556:
IMMERWAHR 1972, p. 183; MORETTI 1975, n. 120, 124, 127; STEIN HÖLKESKAMP 2011, s.v. “Cimon” in BNP. Una
datazione diversa da quella qui proposta abbassa la sequenza nella misura di un evento olimpico attribuendo
dunque le tre vittorie alle Olimpiadi n. 62, 63 e 64, negli anni 532, 528, 524: HOW-WELLS 1928, ad Hdt. VI 103;
HAMMOND 1956, pp. 117, 119; ANNIBALETTO 2000, ad Hdt. VI 103, n. 1. Concorda con questa datazione ribassata
il Prof. R. Lane Fox col quale ho avuto il privilegio di discutere della questione personalmente.
15
Hdt. VI 36.1.
16
Hdt. VI 103.4. Paus. VI 10.8 sulla dedica offerta da Evagora in commemorazione delle sue vittorie.
17
La critica concorda unanimemente su queste date: WOODBURN HYDE 1921, p. 265; MORETTI 1957, n. 110;
HODKINSON 1997, p. 49 e n. 54 p. 53; BLAKE TYRRELL 2004, p. 85; SCOTT 2010, p. 161. Contra: DESBOROUGH
COOLEY – LARCHER 1844, ad Hdt. VI 103 asserisce non sia possibile ricostruire la datazione di queste vittorie.
18
WADE-GERY 1951, p. 219: pone la vittoria al 548; MORETTI 1957, n. 106: data la vittoria al 560; DAVIES 1971,
n. 8429 VI, segue H.T. Wade-Gery nella data del 548; KINZL 2011, s.v. “Miltiades” in BNP, data al 548.
187
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
incrociando questi dati, l’unica data per la vittoria di Milziade a Olimpia che soddisfa le
premesse discusse rimane appunto quella dell’Olimpiade 55, dunque da collocarsi nel 560.
L’attività agonistica panellenica contribuisce a caratterizzare la famiglia dei Filaidi come
aristocratica e ricca, riconosciuta a livello locale e panellenico, per fama, prestigio e importanza
politica. La possibilità di partecipare agli agoni panellenici implica di necessità che l’atleta
disponesse di quelle ampie risorse economiche necessarie a garantirgli la possibilità di investire
il proprio tempo negli allenamenti e di viaggiare e soggiornare presso i santuari panellenici
anche per vari mesi19. Queste considerazioni sono ancor più valide nel caso dei Filaidi che le
fonti specificano essere stata “una casata che manteneva cavalli per la corsa alle quadrighe”
(oi)ko/j teqrippotro/foj)20: l’ippotrofia era un’attività, ovviamente, molto dispendiosa che
richiedeva infrastrutture e attrezzature specifiche, la disponibilità di cavalli e la capacità di
allevarli e inserisce di necessità la famiglia perlomeno nella classe timocratica soloniana degli
hippèis; d’altro canto un òikos tethrippotròphos era compensato con un elevato status di onore e
prestigio sociale agli occhi del pubblico, dei partecipanti agli agoni e dei concittadini21.
La vittoria a Olimpia, come agli altri agoni panellenici, aveva una serie di ricadute ampie
e profonde, che non si limitavano all’aristocratica dimostrazione di eccellenza e di superiorità
tipica della cultura agonale ellenica22. Il premio per i vincitori delle Olimpiadi consisteva in una
semplice corona di olivo selvatico: non solo questa era il simbolo agli occhi della Grecia della
prestanza fisica dell’atleta, ma la vittoria era essa stessa un segno del favore e approvazione di
cui gli dèi investivano l’individuo23. Era pratica consueta, da parte dei vincitori, dedicare le
proprie corone e altre offerte nel santuario di Zeus; coloro che, come Cimone, avevano ottenuto
una triplice vittoria avevano il raro privilegio di dedicare una statua che rappresentasse le loro
stesse fattezze24; si considerino dunque la visibilità internazionale e il valore propagandistico
conferito da questa concessione. Se il premio conferito dal santuario di Zeus era simbolico, in
patria i vincitori ricevevano però consistenti premi di valore economico dallo stato25; le
testimonianze riguardanti Solone tramandano che il nomoteta impose un limite di 500 dracme
per il premio pubblico ateniese conferito ai vincitori olimpici, sufficienti comunque per
innalzare il ricevente, qualora già non lo fosse stato, al rango più alto delle classi timocratiche
19
DREES 1969, pp. 43s. per la durata dell’allenamento e del soggiorno ad Olimpia.
Hdt. VI 35.1. HOW-WELLS 1928, ad Hdt. VI 35; IMMERWAHR 1972.
21
RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 35; YOUNG 2004, pp. 92-97; FISHER 2009, pp. 530-536.
22
Hom. Il. VI 108, XI 784; Xen. Mem. 2.6.35. MURRAY 1996, pp. 245-266; HÖLKESKAMP 1997, pp. 485-489;
DUPLOUY 2006, pp. 271-277.
23
DREES 1968, pp. 101-104.
24
Paus. VI 15.8, 18.7; VIII 40.1-2; Plin. Nat. Hist. XXXIV 9.4. DREES 1964, pp. 104s.
25
Xenoph. fr. 2.1-11 West.
20
188
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
soloniane26. Anche nella propria polis il valore della vittoria agonale trascendeva d’altronde gli
aspetti materiali: la cittadinanza attribuiva un ingresso trionfale agli atleti vittoriosi e in quelle
circostanze erano recitati epinici commissionati per elogiare l’atleta e la sua famiglia27; il
vincitore era onorato come un rappresentante internazionale della propria polis, la quale con lui
condivideva l’onore della fama. Anche nel santuario poliade era consuetudine commemorare la
propria vittoria con la dedica di una statua alla divinità o della decima del premio pubblico.
Inoltre un vincitore panellenico godeva della proedrìa agli spettacoli della polis e di pasti a
spese pubbliche nel pritaneo (sìtesis); quest’ultima misura, si consideri, metteva il vincitore in
diretto contatto quotidiano e conviviale con i magistrati operativi dello stato ateniese, in un
momento forse non decisionale, ma certamente significativo per il suo valore sociale oltre che
ideologico28. La celebrazione nella polis era dunque non lontana da una forma di eroizzazione
del vincitore e insieme consentiva un subitaneo innalzamento alla massima visibilità nei luoghi
sacri e politici più eminenti della polis e del circuito panellenico.
La vittoria olimpica era occasione di auto-rappresentazione e di affermazione sociale e
politica sia entro l’élite degli esponenti dell’aristocrazia panellenica, a Olimpia, che in patria fra
i propri concittadini; la vittoria forniva l’occasione per dimostrare ed elevare il proprio status
sociale, rafforzare la propria posizione politica, mostrare e ampliare la propria ricchezza. La
vittoria olimpica dunque era un chiaro strumento della politica di prestigio nella lotta fra le
famiglie influenti per il controllo della polis. Nella prospettiva della società di élite aristocratica
internazionale riunita agli agoni, il vincitore dimostrava di essere un elemento importante della
vita politica della propria polis, cioè un interlocutore affidabile con cui era utile o necessario
legare nella conduzione della diplomazia inter-poleica, o perlomeno un interessante alleato per
un accordo matrimoniale.
Queste considerazioni vanno dunque mantenute nel comprendere la posizione favorevole
che per quattro volte i Filaidi, prima con Milziade e poi con Cimone, riuscirono ad ottenere
nell’ambito dei rapporti politici all’interno di Atene e nella Grecia29. Questi importanti vantaggi
e questo riconosciuto prestigio sottendono al ruolo che i Filaidi ebbero nella storia di Atene nel
VI secolo e giustificano la scelta dei Pisistratidi di mantenere con loro una relazione conciliante
e costruttiva nella spartizione del potere ad Atene e nella conduzione delle iniziative
internazionali in Ellesponto. Il prestigio derivato a Milziade I dalla vittoria olimpica è da
26
Plut. Sol. 23. YOUNG 2004, pp. 97-101.
DREES 1964, pp. 101-104; HARRELL 2002, sul valore politico degli epinici recitati per I vincitori panellenici;
EMMET 2011, s.v. “Pindarus” [2] in BNP.
28
Xenoph. fr. 2.1-11 West. CONNOR 1987; FISHER 2009, pp. 530s.
29
ANDREWES 1958, pp. 105-113; FISHER 2009, pp. 536-538.
27
189
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
considerarsi come premessa ideologica e propagandistica della sua spedizione in Chersoneso
Tracico30. La relazione discontinua e infine drammaticamente conflittuale fra Cimone e i
Pisistratidi è, in effetti, imperniata sulle attività agonistiche del Filaide, sia nei momenti di
riconciliazione, sia nell’occasione che, secondo le fonti, portò all’assassinio di Cimone.
L’intesa fra Filaidi e Pisistratidi
Le notizie fornite dalle fonti e una loro analisi contestuale permettono di ricostruire
l’esistenza di un rapporto continuativo fra i Filaidi e i Pisistratidi tendenzialmente costruttivo.
Questa collaborazione fra le due famiglie può essere, a mio avviso, fatta risalire in prima
istanza al 566, in base ad alcune considerazioni sulla datazione e sull’attribuzione della
rifondazione delle celebrazioni cultuali e agonistiche della festa delle Panatenee penteteriche ad
Atene. Sull’autorità di uno scolio all’orazione panatenaica di Elio Aristide, la critica ha stabilito
una diretta relazione fra il tiranno Pisistrato e la fondazione delle grandi Panatenee,
contestualizzando l’attribuzione entro la politica centralistica religiosa, sociale e culturale della
tirannide31; per altro verso, la tradizione cronografica ha conservato la data dell’istituzione delle
Grandi Panatenee e degli agoni a esse associate, collocandola nel 566, durante l’arcontato di
Ippoclide, un membro della famiglia dei Filaidi32. Si delineano apparentemente due tradizioni
alternative in merito all’autorità a cui si dovrebbe ascrivere la rifondazione e riorganizzazione
della massima festa religiosa ateniese, attribuendone cioè la responsabilità all’arconte oppure al
tiranno33; se invece accettiamo la coincidenza fra le due tradizioni, si potrà ricostruire che
Pisistrato si adoperò nella riorganizzazione delle Panatenee già nel 566, durante l’arcontato e
con l’approvazione del filaide Ippoclide. Il 566 potrebbe sembrare una data troppo alta perché
Pisistrato fosse in grado di agire sull’ordinamento civico ateniese, ma questa obiezione perde
peso a fronte del ruolo già eminente che Pisistrato si era in precedenza guadagnato nelle
operazioni militari contro Megara: già allora egli doveva essere una personalità politica di
spicco, pur non avendo ancora tentato di acquisire la tirannide. È plausibile altrimenti
l’obiezione che le due tradizioni storiche potrebbero riferirsi una all’istituzione della festività da
30
MORETTI 1957, n. 106.
Schol. Aristid. Panath. p. 189.4 (=3.323 Dindorf; Aristot. Peplos F 637 Rose): ta\ de\ mega/la
Peisi/stratoj e)poi/hse. Sulla fondazione delle Panatenee: Marcell. Vit. Thuc. 2-5; Harp. s.v. “Panathenaia”.
DAVISON 1958, pp. 26-29; BRELICH 1969, p. 319-320; PARKE 1986, pp. 34s.; KYLE 1987, pp. 15-31; SHAPIRO
1989, pp. 19-21; BRUIT ZAIDMAN – SCHMITT PANTEL 1992, pp. 84-86 ; DAVERIO ROCCHI 1993, pp. 151-153;
FROST 1994, pp. 51-59; CALAME 1996, p. 474-476 ; RAAFLAUB 1996, pp. 1070-1071; PARKER 1996, pp. 67-71;
HURWIT 1999, pp. 23-24, 30-31, 45, 104-116.
32
Pherec. FGrHist 3 F 2 (Marcell. Vit. Thuc. 2-4); Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 181c Helm. CADOUX 1948, p. 104.
Ippoclide è da identificarsi in quel pretendente alla mano di Agariste, figlia di Clistene di Sicione, che fu poi
rifiutato in favore del pretendente degli Alcmeonidi: vd. Hdt. VI 126-129.
33
DAVISON 1958, ppp. 28-36; PARKE 1986, pp.34s., 45s., 171s.; KYLE 1987, pp. 15-31, 57s.; SHAPIRO 1989, pp.
17-21, 40-47; HURWIT 1999, pp. 23-24, 30-31, 45, 107-111.
31
190
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
parte di Ippoclide nel 566 e l’altra a innovazioni introdotte nel programma festivo
successivamente da Pisistrato durante la tirannide, dopo il 546. Nonostante le obiezioni la
questione fornisce una traccia dei modi di conduzione della politica religiosa cittadina e
conferma che era in opera perlomeno una convergenza d’interessi e di indirizzo fra Filaidi e
Pisistratidi che li portò ad agire in modo affine, se non effettivamente a collaborare, nella
conduzione della politica ateniese. Nel quadro della ricostruzione che qui propongo, è possibile
che, anticipando la presa del potere da parte di Pisistrato, i Filaidi abbiano deciso di associarsi a
lui promuovendone l’affermazione e conservando d’altronde per sé una posizione di favore
durante la successiva tirannide. L’ipotesi di un’intesa inter-familiare nel 566 coincide peraltro
cronologicamente con le vittoriose imprese di Pisistrato nella guerra contro Megara e
confermerebbe, dunque, che egli si era schierato fin dal principio con quel partito ateniese che
avversava Megara, che perseguiva l’apertura di Atene alle attività oltremare e che
conseguentemente trovava un naturale alleato in Corinto, a cui anche i Filaidi appartenevano.
Successivamente, traccia di questa intesa collaborativa fra Pisistrato e i Filaidi si può a
mio avviso rilevare riflettendo sulle circostanze della politica matrimoniale di Pisistrato. Nel
560 ca. Pisistrato prese in sposa l’aristocratica Timonassa di Argo, vedova del tiranno di
Ambracia, Archino, un discendente della famiglia dei Cipselidi. Il matrimonio segnò in primo
luogo un’alleanza fra Pisistrato e il padre di Timonassa, Gorgilo di Argo; tuttavia non mi pare
un dettaglio trascurabile quello del precedente matrimonio della giovane con un Cipselide.
Ritengo che i Filaidi possano avere costituito gli intermediari fra i Pisistratidi ateniesi e la
famiglia filo-cipselide di Gorgilo ad Argo; questa intermediazione poté esercitarsi, da un lato,
in virtù della discendenza dei Filaidi dal capostipite eponimo dei Cipselidi, tiranni di Corinto, e
in virtù, d’altro canto, dei legami di matrimonio che avevano in precedenza unito Timonassa e
la sua famiglia argiva con quel ramo dei Cipselidi che aveva governato Ambracia fino alla
morte di Archino. Il valore e l’efficacia di questo tipo di legami personali nella gestione della
diplomazia familiare internazionale dei tiranni e degli aristocratici è comprovato dalle
considerazioni che Erodoto attribuisce a Clistene di Sicione, soltanto un decennio prima del
560, nella preferenza perlomeno inizialmente accordata a Ippoclide fra tutti i pretendenti alla
mano di sua figlia: il Filaide fu infatti esplicitamente apprezzato allora per la sua discendenza
dalla famiglia dei Cipselidi34. Propongo dunque una ricostruzione secondo la quale Pisistrato,
una volta avviata la propria carriera politica ad Atene e poi ottenuta la tirannide, si avviò a
costruire una personale rete di alleanze internazionali; nel medesimo momento Gorgilo di Argo
34
Hdt. VI 128. DAVERIO ROCCHI 1973.
191
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
si trovò nella situazione di dover rimaritare la figlia Timonassa dopo la morte del precedente
marito Archino. Furono in quel momento i Filaidi a mettere dunque in contatto Pisistrato e
Gorgilo: essi costituirono per Pisistrato il tramite per accedere all’élite internazionale
panellenica e per entrare in contatto con quella cerchia sociale che godeva del prestigio della
memoria dei tiranni di Corinto; per Gorgilo rappresentarono una famiglia di consanguinei,
legata come lui ai Cipselidi, e l’occasione per trovare un nuovo pretendente alla mano della
figlia in un secondo matrimonio35.
Nel corso della seconda metà del VI secolo i Filaidi mantennero essi stessi una propria
tirannide nel Chersoneso Tracico. Milziade I colonizzò per primo la penisola affacciata
sull’Ellesopnto e vi impose una prima organizzazione, il comando fu ereditato poi dal fratello
Stesagora e in seguito da Milziade II il quale mantenne il controllo fino al 493 quando l’area fu
conquistata dall’impero Persiano. La critica ha spesso messo in evidenza una stretta relazione
fra l’iniziativa dei Pisistratidi a Sigeo e quella dei Filaidi in Chersoneso. La penisola tracica e
l’insediamento in Troade costituiscono due località strategiche nel controllo delle rotte
attraverso l’Ellesponto. Peraltro non solo Sigeo ma anche il Chersoneso Tracico, nella località
di Elaious, potrebbe rientrare fra gli interessi dell’Atene pre-tirannica già alla fine del VII
secolo, all’epoca delle imprese di Frinone. Nonostante le difficoltà cronologiche che si
presentano nella datazione precisa dell’avvio della missione dei Filaidi in Chersoneso, la
concomitanza delle attività delle due famiglie alleate, Filaidi e Pisistratidi, sulle sponde
dell’Ellesponto è palese. Se non per le iniziative dell’ecista Milziade I e di Stesagora, la pratica
di una strategia comune fra Pisistratidi e Filaidi è attestata con sicurezza nella narrazione
erodotea relativa alla tirannide di Ippia e alla spedizioni in Chersoneso di Milziade II, giacché
l’invio del Filaide è descritto come una decisione dei Pisistratidi. Si può concludere che la
strategia di occupazione di Sigeo e del Chersoneso Tracico furono due elementi di una strategia
congiunta, stabilita e concordata fra Pisistratidi e Filaidi36. L’interesse delle due famiglie per
l’area strategica dell’Ellesponto e per questa direzione di politica estera conferma
l’appartenenza delle due famiglie a un gruppo della classe politica ateniese che mirava a
condurre Atene in direzione di una politica navale e marittima, dunque in opposizione al potere
di Megara e in un’intesa strutturale con Corinto37.
Le testimonianze letterarie ed epigrafiche relative alla gestione dell’arcontato durante la
tirannide di Ippia confermano la partecipazione dei Filaidi al governo di Atene: è noto che
35
WILL 1955, pp. 517-522, 544, 546; DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 98-102, 104-107
TREVER 1925, pp. 117, 124; WILL 1955, pp. 381-391; GRAHAM 1964, pp. 7, 30-35, 76; ANDREWES 1982 b, pp.
403-405, 415s.; CULASSO GASTALDI 1996, pp. 507s.; KEEN 2000, pp. 66-73; HORNBLOWER 2008, ad Thuc. VI 54.
37
WELLS 1923, pp. 112-124.
36
192
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Milziade II, prima di recarsi in Chersoneso, fu arconte eponimo ad Atene nel 524/338. A questa
positiva intesa politica devono probabilmente riferirsi le parole di Erodoto secondo il quale i
Pisistratidi trattarono Milziade con riguardo ad Atene, nel periodo precedente la sua missione in
Chersoneso Tracico (ἐν Ἀθήνῃσι ἐποίευν εὖ), nonostante avessero assassinato Cimone39.
Critica della storicità delle notizie sull’assassinio di Cimone
In contraddizione con l’esistenza di questa intesa politica fra le famiglie dei Pisistratidi e
dei Filaidi si pongono le testimonianze concernenti l’esilio e l’assassinio di Cimone I, fratello
uterino di Milziade I e padre di Milziade II. La prima vittoria olimpica di Cimone (536) fu
infatti guadagnata, secondo le fonti scritte, in un periodo in cui egli si era allontanato da Atene a
causa del pericolo rappresentato per lui dal potere di Pisistrato. La seconda vittoria olimpica
(532) fu però poi lo strumento della riconciliazione fra Cimone e Pisistrato, secondo un preciso
accordo stipulato fra i due aristocratici: Cimone cedette a Pisistrato il titolo della vittoria e
dunque il privilegio della proclamazione olimpionica; in cambio di quell’onore egli poté
rientrare ad Atene e riprendere possesso dei propri beni che erano stati confiscati da Pisistrato40.
Queste informazioni dimostrano in primo luogo come a un aristocratico quale Cimone, pure in
esilio, rimanessero aperte possibilità di autoaffermazione nel circuito internazionale ed extrapoleico e come proprio queste attività gli consentissero di rinegoziare la relazione con il tiranno
che controllava Atene. L’accordo del 532, in occasione della seconda vittoria, è indicativo di
come la vittoria olimpionica potesse cioè essere commutata e spesa entro le dinamiche della
gestione del potere politico e del prestigio sociale, di fatto costituendo un ulteriore strumento
della diplomazia inter-aristocratica arcaica. In un’epoca in cui Pisistrato era già deceduto,
Cimone vinse la sua terza e più celebre vittoria olimpica; Erodoto sembra implicare nella
sequenza della propria narrazione che questo successo fu la causa che portò Ippia a
organizzarne, poco dopo, l’assassinio.
L’assassinio di Cimone per ordine di Ippia è stato contestualizzato dalla critica entro la
situazione di tensione accesasi al momento della morte di Pisistrato: da un lato il tiranno era
morto e Ippia si ritrovò nella posizione di farsi carico della famiglia e del potere politico
acquisito dal padre ad Atene e sul piano internazionale; d’altro canto Cimone, nel 532, era
rientrato ad Atene e aveva riacquisito il possesso e la conduzione delle proprie sostanze e
senz’altro di un proprio seguito personale; poi, con la terza vittoria olimpica nel 528, si assicurò
38
Dion. Hal. Ant. Rom. VII 3.1. IG I3 1031. MERITT 1939, pp. 60-62; CADOUX 1948, pp. 90, 109s., 122; MEIGGSLEWIS 1983, n. 6.
39
Hdt. VI 39.1. CULASSO GASTALDI 1996, pp. 507s.
40
Hdt. VI 103. MORETTI 1975, n. 124; RHODES 1981, ad Aristot. Ath. Pol. 26.1.
193
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
fama imperitura a Olimpia e una posizione sociale e politica di ancor maggiore preminenza ad
Atene. Cimone avrebbe allora costituito un avversario eccessivamente pericoloso ed esperto
perché Ippia potesse affrontarlo entro i limiti della regolare lotta politica interaristocratica: per
questo motivo larga parte della critica ritiene che Ippia avrebbe commissionato l’assassinio di
Cimone41.
Insieme ad Erodoto ci si meraviglia d’altronde delle palesi discrepanze nel
comportamento degli interessati, fra la relazione di Ippia con Cimone da un lato e dall’altro
con Milziade II, figlio dello stesso Cimone: meno di quattro anni dopo la morte violenta di suo
padre per opera del tiranno, Milziade II mostra di essere in intesa con i suoi assassini: ricoprì
l’arcontato e poco dopo ricevette il pieno supporto di Ippia nel mantenimento della tirannide
filaide in Chersoneso Tracico, giacché egli giunse in Ellesponto d’intesa con Ippia e a bordo di
una trireme concessa dal tiranno stesso. Dal canto suo Ippia, dopo avere assassinato il padre di
Milziade II, sembra comunque ritenere questi un uomo di fiducia al punto da affidargli prima
l’arcontato e poi il controllo della strategica posizione sull’Ellesponto42. Questa incoerenza di
comportamento fra tutti i soggetti coinvolti attira tanto più l’attenzione a confronto con
quell’intesa politica che si è andata ricostruendo finora fra le due famiglie e merita perciò
alcune considerazioni.
Personalmente ritengo che l’attribuzione dell’assassinio di Cimone all’ordine di Ippia sia
una costruzione storiografica anti-tirannica di parte filaide, risalente all’epoca post-tirannica.
Nel 493 Milziade II lasciò il Chersoneso Tracico fuggendo la rappresaglia persiana che
schiacciava la rivolta ionica, rientrò ad Atene quando era ormai retta dal governo isonomico e
fu allora processato sotto l’accusa di avere praticato la tirannide. L’accusa si fondava in prima
istanza sui sistemi di governo praticati dai Filaidi nella colonia tracica dell’Ellesponto, ma
quello non avrebbe costituito un elemento sufficiente per un processo poiché l’accusa
riguardava solo il territorio oltremare, di fatto al di fuori di Atene43. L’accusa era invece
41
WADE-GERY 1951, pp. 212-214; MORETTI 1975, n. 127; FISHER 2009, pp. 536-538.
CULASSO GASTALDI 1996, pp. 507s.
43
La validità dell’obiezione dipende dal rapporto che si attribuisce ad Atene con le proprie colonie: cioè il livello
di controllo che si ritiene la madrepatria potesse esercitare sulle colonie e viceversa il valore della dipendenza delle
colonie dalle istituzioni di Atene. A questo proposito H. Berve e A.W. Gomme qualificano il Chersoneso e Lemno
come delle apoikìai in piena regola, ove dunque gli abitanti avevano perso lo statuto di cittadini di Atene per
assumere quello nuovo di Chersonesiti e Lemni, vd. GOMME 1937. Al contrario, A. Moreno, citando V.L.
Ehrenberg, sostiene la posizione secondo cui le colonie fondate da Atene non acquisirono mai uno status
indipendente rimanendo piuttosto come delle sezioni aggiunte di chòra attica oltremare: EHRENBERG 1946;
MORENO 2007, pp. 140-143. Sulla posizione giuridica della colonia del Chersoneso: Hdt. VI 140. GRAHAM 1964,
pp. 164-170; DAVIES 1971, n. 8429 XVI; KEEN 2000, pp. 66s. La riflessione è complicata dal peculiare fenomeno
ateniese della creazione delle cleruchie, in particolare vd. decreto relativo alla cleruchia su Salamina, IG I2 1 (= IG
I3 1): HICKS-HILL 1901, pp. 6s.; TOD 1933, n. 11; MERITT 1941, pp. 301-307; ANDREWES 1982 a, pp. 372-375, pp.
372s.; MEIGGS-LEWIS 1989, n. 14, pp. 25-27; LAVELLE 2005, pp. 30-32, 386s.; MORENO 2007, pp. 77-143, 320s.
42
194
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
giustificata anche nell’ambito politico ateniese in virtù proprio di quella lunga intesa familiare
che i Filaidi avevano mantenuto fin dall’inizio con i Pisistratidi al potere e dunque in questo
senso Milziade II era accusato di connivenza con i tiranni pisistratidi e veniva processato da un
tribunale ateniese. I due aspetti erano peraltro fra loro strettamente legati entro la strategia di
politica estera pisistratide-filaide di controllo dell’Ellesponto. La difesa adottata da Milziade di
fronte all’heliàia dovette consistere in un’esposizione della storia e dei meriti pubblici, cioè
democratici, della propria famiglia44. In questa fase storica, all’omonimo predecessore di questo
Milziade, cioè Milziade I ecista del Chersoneso, si attribuì quale movente, per l’iniziativa
coloniale, quello dell’insofferenza del cittadino libero per il governo tirannico di Pisistrato; in
questa revisione della storia familiare filaide che operò Milziade II, l’assassinio notturno di suo
padre Cimone ad opera di sicari si sarebbe potuto facilmente attribuire a un ordine del giovane
Ippia; la supposizione lanciata da Milziade II poté essere peraltro tanto più credibile in quanto il
tiranno aveva davvero assunto un atteggiamento più intransigente e repressivo contro gli
aristocratici di Atene dopo il 514 e l’assassinio del fratello Ipparco45.
Non propongo d’altronde di smentire del tutto la testimonianza erodotea sulla biografia di
Cimone: al contrario, la sua chiara posizione antagonistica rispetto ai Pisistratidi è in linea con
quella di un aristocratico che mantenne con successo la fama e il prestigio dei Filaidi ad Atene e
nel contesto panellenico e che accumulò alti onori personali. Mentre il fratello uterino Milziade
e i suoi stessi figli, Stesagora e Milziade II, scelsero tutti di intraprendere la propria carriera in
Tracia, Cimone dimostrò chiaramente di voler rimanere in Atene e questo costituì senz’altro un
motivo di attrito con i Pisistratidi in prima istanza e con gli altri aristocratici attivi nella polis.
Appunto alla luce dell’eminenza dell’individualità di Cimone si spiega il suo assassinio, si
spiega il fatto che l’accusa postuma rivolta ai Pisistratidi sembrò plausibile all’uditorio del
tribunale che giudicava Milziade II e, successivamente, anche alla selezione storica di Erodoto.
Si consideri infine che l’attribuzione dell’assassinio all’ordine di Ippia giovava non solo al buon
nome di Milziade II, ma anche a quello dei reali committenti da identificarsi in un’altra delle
famiglie aristocratiche di Atene avverse ai Pisistratidi e ai Filaidi, forse gli Alcmeonidi46.
Riflessione affine e perciò utile la critica conduce sulla posizione giuridica delle colonie di Corinto rispetto alla
madrepatria: WILL 1955, p. 517-519.
44
WADE-GERY 1951, pp. 215-218; CAWKWELL 1995, pp. 79s.; CULASSO GASTALDI 1996, pp. 507-510.
45
DUPLOUY 2006, pp. 54-64 riflette sull’influenza che il contesto storico del processo per tirannide contro
Milziade II poté avere sulla formazione della tradizione sui Filaidi.
46
Questa ricostruzione, di cui mi assumo piena responsabilità, nasce da considerazioni suggeritemi in un colloquio
personale con il Prof. R. Lane Fox al quale va la mia gratitudine.
195
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
V.2. La tirannide dei Filaidi in Chersoneso Tracico
Milziade I, la spedizione in Chersoneso e la realizzazione della tirannide secondo Erodoto
La famiglia dei Filaidi merita una discussione entro questo scritto specificamente per le
notizie riguardanti la tirannide istituita ed esercitata nella penisola del Chersoneso Tracico, per
due generazioni, durante la seconda metà del VI secolo47.
Secondo la narrazione di Erodoto, nel Chersoneso Tracico la popolazione locale dei Traci
Dolonci subiva gli attacchi dei Traci Apsinti, stanziati a nord della penisola; i re delle tribù dei
Dolonci si rivolsero perciò all’oracolo di Delfi e ricevettero il responso di condurre nel proprio
paese, come ecista, il primo uomo che avesse loro offerto ospitalità (ἐπὶ ξείνια καλέσῃ). La
delegazione tracica percorse tutta la Via Sacra48 in attesa che si verificasse il segno premonitore
ma, non essendosi compiuto alcun prodigio, giunsero fino ad Atene e fu dunque infine Milziade
I a notarli passare e ad offrire loro ospitalità (cei/nia): perciò i Traci pregarono Milziade di
seguirli, in obbedienza all’oracolo apollineo. In quel momento, ad Atene, Pisistrato aveva
massimo potere, ma anche Milziade godeva di grande influenza (εἶχε µὲν τὸ πᾶν κράτος
Πεισίστρατος ἀτὰρ ἐδυνάστευέ γε καὶ Μιλτιάδης) e aveva in precedenza riportato la vittoria
agonistica a Olimpia; secondo il racconto, il Filaide accolse l’offerta dei Traci perché non
sopportava la supremazia di Pisistrato e desiderava lasciare Atene. Milziade consultò dunque
l’oracolo di Delfi e ricevette un responso positivo, poi prese con sé quegli Ateniesi che si
offrirono di partecipare alla colonizzazione e navigò alla volta del Chersoneso Tracico, dove
prese possesso del territorio (ἔσχε τὴν χώρην) e fu fatto tiranno49.
Vi sono alcuni elementi del testo erodoteo la cui storicità ritengo sia il caso di vagliare e
discutere. Mi pare infatti evidente che siano di natura favolistica quelle nozioni che si
riferiscono all’interrogazione oracolare dei basilèis traci e del compimento della profezia
apollinea da parte di Milziade50; non credo d’altronde che i Traci e l’oracolo delfico siano
soggetti del tutto immaginari e fabbricati dalla tradizione. La causa scaturente da cui Erodoto
avvia la propria narrazione è quella del conflitto che i Traci Dolonci sostenevano contro i vicini
Apsinti: al suo arrivo in Chersoneso, Milziade si preoccupò in effetti di edificare infrastrutture
di difesa sulla strettoia dell’istmo e fu impegnato militarmente nella regione. Questi dati
concordano nell’individuare un pericolo militare posto dai Traci a nord del Chersoneso, sia nei
47
BERVE 1967, pp. 79-88.
Sulla via sacra da Atene a Delfi: HOW-WELLS 1928, ad Hdt. VI 34; DAVERIO ROCCHI 2011, pp. 71-84.
49
Hdt. VI 34-36; Scymn. 689-702; Paus. VI 19.6 confonde questo Milziade I figlio di Cipselo con l’omonimo
figlio di Cimone che ereditò effettivamente la tirannide del Chersoneso Tracico nella generazione successiva
all’ecista, suo zio.
50
MALKIN 1987, pp. 77s.
48
196
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
confronti della colonia ateniese che della popolazione tracica locale dei Dolonci51. Se pure la
dinamica della profetica scelta di Milziade come ecista dei Traci sia chiaramente
un’invenzione, il santuario di Delfi ebbe necessariamente un ruolo nelle premesse che
portarono all’impresa dei Filaidi in Tracia. Il racconto e il lessico erodoteo nonché le notizie
storiche sul Chersoneso Tracico confermano infatti che l’impresa di Milziade fu di fatto una
fondazione coloniale ateniese: perciò Milziade, con l’incarico di ecista ateniese designato,
interrogò l’oracolo di Delfi per ricevere preventivamente l’approvazione del santuario alla
nuova fondazione, nel rispetto della consuetudine ellenica relativa alle pratiche coloniali52.
Intorno a questa interrogazione oracolare e intorno al ruolo di ecista assunto da Milziade si può
ritenere che si sia andata formando quella leggenda eziologica registrata da Erodoto relativa
all’oracolo ricevuto dall’ambasceria tracica e alla portentosa scelta di Milziade come ecista.
La conclusione più sicura mi pare quella di considerare la spedizione in Chersoneso
Tracico come un’iniziativa nata ad Atene, specificamente per iniziativa congiunta di Filaidi e
Pisistratidi. L’intesa fra Milziade e i Traci Dolonci, di carattere quasi soprannaturale, che
Erodoto colloca all’origine del proprio racconto assume un certo grado di attendibilità storica se
collocata dopo l’arrivo di Milziade in Chersoneso Tracico: mi pare plausibile infatti che, una
volta insediatosi, il contingente ateniese abbia trovato un motivo di accordo con i locali Traci
Dolonci nella comune e condivisa necessità di difendere il territorio dai Traci Apsinti53. Su
questi presupposti dunque nacque poi, fra la popolazione del Chersoneso Tracico, oppure
presso il santuario di Delfi, quella leggenda eziologica incentrata sull’oracolo pitico.
Erodoto afferma inoltre che Milziade fu lieto di intraprendere l’iniziativa coloniale in
Chersoneso Tracico perché era desideroso di lasciare Atene per via dell’oppressione e del
potere tirannico di Pisistrato: anche questo elemento del racconto non è, a mio avviso,
storicamente reale54. Erodoto è esplicito nel tramandare che Pisistrato e Milziade erano, in quel
momento, entrambi individui di riconosciuto potere politico e che Milziade era stato vincitore
olimpionico. In questa situazione Milziade non avrebbe avuto alcun motivo per abbandonare la
competizione politica e fuggire da Atene: egli non era affatto in una posizione sfavorevole; al
contrario la sua vittoria olimpica aveva certo favorito il suo prestigio: egli avrebbe potuto perciò
facilmente tenere testa al potere di Pisistrato e inoltre la sua partenza sembra essere stata
spontanea e non imposta come un esilio da parte del tiranno. La spedizione in Chersoneso è
51
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 234-240.
Hdt. V 42. GRAHAM 1964, pp. 25-27.
53
Sulla familiarità con la cultura greca, sul filellenismo delle corti tracie e sulla collaborazione di condottieri
ellenici con popolazioni tracie, vd. MITCHELL 1997, pp. 134-147; BRAUND 2001, pp. 20s.
54
CULASSO GASTALDI 1996, pp. 507-509.
52
197
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
chiaramente descritta come una fondazione coloniale: Milziade ne fu l’ecista, prima di
organizzare la partenza egli interpellò la Pizia e ne ottenne l’approvazione, in Atene fu raccolta
una massa di volontari disposti a trasferirsi in Chersoneso Tracico. Queste caratteristiche
delineano l’impresa come un’iniziativa non solo filaide ma più in genere ateniese, condivisa e
approvata dunque dalla polis. Difficilmente avrebbe potuto avere luogo dunque senza
l’approvazione e il sostegno di Pisistrato il quale controllava la politica ad Atene. Si
riconsiderino a questo punto gli elementi che puntano all’esistenza di un’intesa di lungo periodo
fra Pisistratidi e Filaidi, precedentemente analizzati, e particolarmente la possibilità che le due
famiglie condividessero idee affini sulla conduzione della politica estera di Atene e sulla
direzione delle attività oltremare, prima contro la posizione di Megara nel Golfo Saronico e in
seguito in direzione dell’Ellesponto.
La realtà storica è dunque che la colonizzazione del Chersoneso e la tirannide dei Filaidi
colà furono avviate di comune accordo e sotto l’autorità di Milziade e Pisistrato. La notizia
registrata da Erodoto sull’insofferenza di Milziade I per lo strapotere di Pisistrato nacque
dunque, a mio avviso, all’interno di quella revisione della storia dei Filaidi operata da Milziade
II nel 493 durante il processo per tirannide a suo carico55.
La data della spedizione in Chersoneso Tracico: 558 ca.
La datazione di questa spedizione di Milziade rimane soggetto aperto a discussione e
critica poiché gli elementi forniti dalla nostra fonte storica non consentono di identificare una
data né un contesto cronologico sicuri56; ritengo tuttavia che la contestualizzazione dei rapporti
fra Filaidi e Pisistratidi e una considerazione del valore politico e sociale dell’agonismo
panellenico possano contribuire a sciogliere quelle difficoltà. Alcune notizie fornite da Erodoto
sulle circostanze della partenza di Milziade per il Chersoneso Tracico e sugli eventi successivi
al suo insediamento mi spingono a collocare la fondazione della colonia ellespontica al periodo
intorno al 558.
55
CAWKWELL 1995, pp. 79s.
Gli studiosi moderni assumono posizioni disomogenee e forniscono per la spedizione di Milziade diverse date,
precise oppure indicative: DESBOROUGH COOLEY – LARCHER 1844, ad Hdt. VI 35.32, pone la data al 560; WADEGERY 1951, p. 219, pone la data al 546, nel breve lasso di tempo fra la battaglia di Pallene e la caduta di Sardi;
HAMMOND 1956, p. 113, 121, 123, 129, al 556; GRAHAM 1964, p. 32, fra il 561 e il 556; DAVIES 1971, n. 8429
[VI], afferma che la communis opinio data l’evento al 560 oppure al 556 egli tuttavia non accetta la datazione della
caduta di Creso al 546 e pone la missione di Milziade al 540 ca.; JEFFERY 1978, p. 96, limita la data alla prima
oppure alla seconda tirannide di Pisistrato, nel 560 oppure nel 556; RHODES 1981, pp. 191s., pone la data al
561/60; GRAHAM 1982, p. 121, ripropone il periodo 561-556; HAAS 1985, p. 43, data al 560 ca.; ISAAC 1986: p.
170-172 pone il terminus ante quem del 546; NENCI 1988, ad Hdt. VI 35.1, implica la coincidenza con la prima
tirannide di Pisistrato che egli data al periodo 561-557; THOMAS 1989, p. 290, data la fondazione coloniale entro il
periodo 559-556; SCHWERTHEIM 2011, s.v. “Lampsacus” in BNP, utilizza la data del 560 per i fatti di poco
successivi all’arrivo di Milziade in Chersoneso Tracico.
56
198
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Erodoto è esplicito nel contestualizzare gli eventi entro uno dei periodi di tirannide di
Pisistrato, dunque durante la prima o la seconda tirannide, nel periodo 561-556, oppure dopo la
definitiva presa di potere successiva al 546.
La vittoria olimpica di Milziade mi pare un elemento da non trascurarsi nella
comprensione degli eventi: come si è visto, il prestigio e la notorietà, locali e internazionali, che
quell’affermazione di prodezza individuale apportò costituiscono un antecedente significativo e
funzionale alla spedizione coloniale di Milziade, sia nel determinare il favore con cui l’oracolo
delfico rispose alla sua interpellanza, sia nel determinare l’appoggio sociale e la partecipazione
dei concittadini ateniesi alla fondazione coloniale e al ruolo di ecista di Milziade. Ritengo
perciò che il Filaide sfruttò la propria recente fama di olimpionico per organizzare e condurre la
spedizione in Ellesponto e che dovette dunque muovere alla volta del Chersoneso Tracico non
molti anni dopo la sua vittoria. Incrociando le possibili date stabilite per vittoria olimpica di
Milziade, cioè il 560, 556, oppure il 552 al più tardi, si giunge a escludere dalle considerazioni
cronologiche il contesto dell’ultima e definitiva tirannide di Pisistrato, un periodo cioè troppo
lontano anche dalla data più bassa fra le tre proposte per la vittoria olimpica. Questa
conclusione concorda peraltro con la notizia relativa ai contatti che vi furono fra Milziade I e il
sovrano di Lidia Creso, nei primi anni dello stanziamento in Chersoneso. La sconfitta di Creso
e la caduta dell’impero lidio sono da datarsi probabilmente al 546: perciò la datazione della
spedizione in Chersoneso entro l’ultima tirannide di Pisistrato, dopo il 546, non è plausibile
poiché non consentirebbe tempo sufficiente affinché il contingente ateniese si insediasse in
Chersoneso, Milziade avviasse le proprie attività e intavolasse infine i contatti con Creso57.
La ricostruzione che si è offerta della prima tirannide di Pisistrato stabilisce che fu di
breve durata e di minore incidenza politica; il primo esilio dovette anch’esso essere breve; la
seconda tirannide ebbe invece una durata più lunga della prima58. La collocazione cronologica
più logica e appropriata per la spedizione di Milziade I in Chersoneso rientra dunque in un giro
di anni durante la seconda tirannide di Pisistrato: in un momento successivo al 560, quando
Pisistrato fu espulso dalla sua prima tirannide, eppure antecedente al 556, quando sappiamo che
Pisistrato era al potere ad Atene ma subì il secondo esilio. Si può proporre, in conclusione e a
titolo di convenzione, una data intorno al 558 ca.
Se si accetta la necessità di legare fra loro in rapporto temporale e causale la vittoria
olimpica di Milziade I con la spedizione in Ellesponto, in conseguenza di queste considerazioni,
57
58
ISAAC 1986: p. 170-172.
Vd. supra, pp. 61ss., 71ss.
199
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
la vittoria nella corsa delle quadrighe trova la propria necessaria collocazione cronologica
soltanto all’Olimpiade 58, appunto nel 560.
L’intesa con i Traci Dolonci e la difesa contro i Traci Apsinti
Il racconto di Erodoto, dopo le notizie sull’insediamento di Milziade e dei suoi volontari
in Chersoneso Tracico, prosegue con la storia degli interventi dell’ecista in quel territorio.
Milziade fu posto come tiranno da coloro che lo accompagnavano (ἐπαγαγόµενοι τύραννον
κατεστήσαντο); la sua prima iniziativa fu di costruire un muro per sbarrare la penisola del
Chersoneso Tracico dalla terraferma: la fortificazione fu costruita nella sezione più stretta
dell’istmo, collegando la polis di Cardia, sul versante settentrionale, con quella di Pactie,
affacciata sulla Propontide59. In questo modo il tiranno impedì le scorrerie dei Traci Apsinti
che, secondo Erodoto, avevano costituito la ragione stessa del suo invito da parte dei locali
Traci Dolonci. Lo stretto istmo e l’aggiunta della fortificazione rendevano il Chersoneso
Tracico un territorio particolarmente difendibile contro gli attacchi provenienti dal continente:
da quel momento in poi i Traci Apsinti non sembrano avere costituito più un pericolo60. La
notizia è significativo indice di una volontà di Milziade non solo di proteggere i volontari che
erano con lui, ma soprattutto di impegnare il proprio governo e le proprie risorse in opere
infrastrutturali, non diversamente da quello che fu l’atteggiamento diffuso fra i tiranni arcaici
nei confronti del tessuto urbano della polis61.
La narrazione erodotea ritrae Milziade impegnato nella difesa dei Traci Dolonci presso
cui egli è tiranno, in ottemperanza al volere di Apollo e secondo quell’accordo raggiunto fra il
Filaide e la delegazione reale tracica che aveva interpellato l’oracolo di Delfi. Come si è
anticipato nell’analisi letteraria del passo, ritengo che questa relazione sia piuttosto frutto di una
costruzione storiografica apologetica filo-filaide, oppure di origine delfica, prodotta allo scopo
giustificare e fornire un’eziologia positiva e portentosa alla spedizione coloniale dei Filaidi in
Chersoneso Tracico62. Eppure gli elementi del racconto relativi all’accordo stretto fra Traci
Dolonci e Milziade e alla difesa del Chersoneso contro i Traci Apsinti possono, a mio avviso,
essere accolti nel senso che, successivamente al loro insediamento nella penisola, Milziade e gli
59
Hdt. VI 36. RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 37, pp. 436s.
RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 37, pp. 436s.; LOUKOPOULOU 2004, p. 900.
61
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 234-240.
62
CAWKWELL 1995, p. 79. Parte della critica suggerisce la possibilità che i Traci Dolonci stessi avessero potuto
ricercare o favorire l’insediamento di una colonia ellenica allo scopo di ottenere alleati nella loro resistenza agli
Apsinti; ma anche quei commentatori che propongono questa ipotesi ritengono comunque più probabile una
ricostruzione affine a quella che viene proposta in questo scritto, secondo cui cioè la responsabilità dell’iniziativa è
da ascriversi a Milziade e agli Ateniesi: MACAN 1895, ad Hdt. VI 34; HOW-WELLS 1928, ad Htd. VI 35; NENCI
1988, ad hdt. VI 34.3. Testimonianze a favore della pratica dei Traci di ricorrere all’aiuto militare di condottieri e
contingenti ellenici, pure in periodi successivi all’arcaismo, in MITCHELL 1997, pp. 134-147; BRAUND 2001, pp.
13-25.
60
200
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Ateniesi ebbero modo di stringere rapporti pacifici e collaborativi con i locali Traci Dolonci,
convivendo nel medesimo territorio63. È sulla base di questa collaborazione che poté poi
svilupparsi in maniera credibile la leggendaria eziologia della spedizione filaide con la vicenda
della consultazione oracolare dei basilèis traci e il portentoso compimento della predizione
pitica da parte di Milziade.
A convalidare la storicità dell’esistenza di un’intesa fra Milziade e i Traci nel Chersoneso
contribuisce anche il lessico utilizzato da Erodoto nel racconto dell’interpellanza oracolare dei
Traci e in quello del loro incontro con Milziade ad Atene: in entrambi i casi le formule usate
dallo storiografo incorporano un riferimento alle pratiche e alle regole di comportamento della
xenìa64; questa considerazione potrebbe far luce sulla forma della relazione che legò Milziade e
i Traci Dolonci. Le formule usate sono accettate e tradotte dalla critica moderna come
riferimenti all’offerta di ospitalità e di commensalità; eppure è noto che la xenìa fu
un’istituzione fondamentale nella costruzione delle relazioni internazionali delle élites della
Grecia arcaica e uno degli strumenti specifici nel contatto fra individui di poleis e culture
diverse. L’ospitalità e la condivisione della mensa erano parte delle effettive azioni rituali della
xenìa ma, per loro tramite, fra le parti contraenti veniva istituita una relazione personale di
ospitalità, amicizia, alleanza e supporto reciproco, estesa alle famiglie e allargata ai campi di
intervento dei contraenti65: nel caso di individui di ampio potere personale, come appunto il
tiranno Milziade e i sovrani traci, queste relazioni private potevano assumere un valore
diplomatico significativo. In questa prospettiva dunque, le formule erodotee relative alla xenìa
potrebbero preservare traccia della forma che assunsero le relazioni istituite fra il condottiero
aristocratico filaide Milziade e i basilèis dei Traci Dolonci: non cioè semplici momenti di
ospitalità, ma piuttosto forme para-diplomatiche di alleanza e accordo inter-aristocratico che
suggellavano rapporti pacifici fra le comunità dei coloni ateniesi e dei Traci autoctoni66.
La guerra contro Lampsaco
La narrazione erodotea passa rapidamente a trattare l’iniziativa militare che Milziade
subito rivolse contro Lampsaco, polis coloniale ellenica sul litorale micrasiatico della Troade,
fondata nel VII secolo da Focea, o meno probabilmente da Mileto, localizzata all’estremità
63
Aristot. Pol. VII 2.9-15 (1324b) testimonia dell’apprezzamento dei Traci per le capacità militari. BRAUND 2001,
pp. 20s.
64
Hdt. VI 34.2: ξείνια καλέσῃ, cioè “(il primo che li avesse) invitati a un pranzo ospitale”. Hdt. VI 35.2:
ἐπηγγείλατο καταγωγὴν καὶ ξείνια, cioè “(Milziade) offrì loro un luogo di ristoro e trattamenti ospitali”. NENCI
1988, ad Hdt. VI 34.2, citando SPITZER 1993, riconosce nelle parole usate da Erodoto una costruzione formulare;
RUNDIN 1996, p. 193; BUDIN 2004, pp. 136-142.
65
DAVERIO ROCCHI 1993, pp. 79-81; BRAUND 2001, pp. 13-25.
66
Sul valore pubblico e statale che il termine xenìa poteva assume nel volgere dell’epoca arcaica vd. RAVIOLA
2005.
201
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
settentrionale dello stretto dell’Ellesponto, 15 Km a sud di Pactie67. Dalle essenziali notazioni
di Erodoto si ricava che il conflitto perdurò per lungo tempo, senz’altro fin dopo la morte di
Milziade I e quella del successore Stesagora68: il successore alla tirannide di Milziade I fu
infatti Stesagora, suo nipote, figlio di suo fratello uterino Cimone69; questi continuò il conflitto
contro Lampsaco e fu assassinato da un Lampsaceno che riuscì ad avvicinarlo fingendosi un
disertore70. L’animosità fra i Chersonesiti e gli abitanti di Lampsaco rimane registrata nelle
usanze religiose del Chersoneso giacché i Lampsaceni, ancora nel V secolo, erano esclusi dalla
partecipazione agli agoni che si tenevano in osservanza del culto eroico di Milziade I come
ecista71. Lo svolgimento degli eventi nell’ultimo quindicennio del VI secolo e le iniziative di
Ippia dimostrano quanto Lampsaco sia rimasta, anche in seguito, un soggetto politico e
diplomatico con cui era necessario confrontarsi e con cui i Pisistratidi, si vedrà, preferirono
infine venire a patti, di fatto tradendo quell’intesa familiare che li aveva legati ai Filaidi per il
precedente mezzo secolo.
La tradizione letteraria non fornisce ulteriori dati relativi al conflitto fra Milziade in
Chersoneso e Lampsaco, ma vale la pena procedere contestualizzando storicamente. È certo che
l’insediamento della colonia ateniese in Chersoneso non fosse stato accolto di buon grado dalle
locali poleis affacciate sullo stretto quali Lampsaco o Abido, che detenevano propri interessi
marittimi. Ritengo si possa inferire che l’attrito sia nato dalla posizione stessa di Lampsaco
rispetto alla importante località del Chersoneso, Crithote: Lampsaco si trovava sul litorale
asiatico, in prossimità della strettoia che segnava l’estremità settentrionale del passaggio
dell’Ellesponto; sul versante direttamente opposto dello sbocco che conduce dall’Ellesponto
nella Propontide, sulla costa del Chersoneso Tracico, si trovava la località di Crithote, secondo
una fonte, fondata dallo stesso Milziade I72. Posta l’importanza, che andava proprio allora
sviluppandosi, del controllo della navigazione attraverso l’Ellesponto, l’imboccatura
settentrionale di quello stretto braccio di mare può avere costituito un’area di significativi
interessi e di accesi conflitti fra i due poteri che vi si affacciavano.
Forse il conflitto sorse perché Milziade fu interessato a stabilire una posizione di forza sul
versante asiatico dell’Ellesponto, interferendo perciò nell’area direttamente sotto il controllo di
67
Hdt. VI 37; Strab. XIII 1.19; Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 167d Helm. NENCI 1988, ad Hdt. VI 36; BAKHUIZEN
1990, p. 57; SCHWERTHEIM 2011, s.v. “Lampsacus”, in BNP.
68
WADE-GERY 1951, pp. 212, 216, 218; ISAAC 1986: p. 170-172; SCOTT 2000, ad Hdt. VI 34-41, pp. 163-179.
69
Hdt. VI 37.
70
Hdt. VI 38.2.
71
Hdt. VI 38.1.
72
Ps. Scymn. 706-712.
202
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Lampsaco73: quest’ipotesi collima con la storia dell’occupazione di Sigeo in Troade, iniziata già
alla fine del VII secolo, ripresa proprio da Pisistrato stesso, nel 540 ca., una volta instaurata la
tirannide ad Atene e aspramente contesa contro gli interessi di Mitilene che controllava l’area.
La scelta operata da Pisistrato di puntare alla conquista di Sigeo e poi la scelta di Ippia di
passare a un’alleanza inter-familiare con i tiranni di Lampsaco possono cogliersi come indizi
delle difficoltà e del poco successo che i Filaidi dovettero riscuotere nell’opporsi a Lampsaco.
In senso più riduttivo e con maggiore sicurezza, il conflitto può essere visto non come una
campagna militare organizzata, ma piuttosto come una serie di azioni violente reciproche, nel
quadro di una forma di naturale conflittualità di frontiera fra poleis elleniche, oppure come
conseguenza di vicendevoli atti di pirateria nelle acque dell’Ellesponto74.
L’intercessione di Creso di Lidia nella guerra fra Milziade e Lampsaco
Erodoto tramanda la notizia che, nel corso del conflitto contro Lampsaco, Milziade fu
fatto prigioniero in un’imboscata; il Filaide però godeva del favore personale di Creso, sovrano
di Lidia (ὁ Μιλτιάδης Κροίσῳ τῷ Λυδῷ ἐν γνώµῃ γεγονώς): cosicché quando Creso seppe della
situazione in cui versava Milziade, mandò ordine ai Lampsaceni di rilasciare l’ostaggio,
minacciando gravemente la distruzione della città; gli abitanti di Lampsaco, temendo il potere
dell’impero lidio, non poterono fare altro che liberare incolume il loro nemico. Milziade dunque
si salvò grazie all’intervento di Creso: così conclude Erodoto75.
La notizia potrebbe suscitare perplessità poiché non siamo a conoscenza di altre relazioni,
precedenti o successive, fra i Filaidi e la corte lidia; Erodoto dimostra peraltro di disporre di una
cronologia alquanto confusa dei regni dei sovrani di Lidia e la sua narrazione cede spesso al
leggendario e al novellistico nel tramandare la storia della dinastia dei Mermnadi, appunto
proprio in merito al personaggio di Creso76; a quest’ultimo proposito proprio il passo ora
discusso dedica un’ampia sezione alle emblematiche parole con cui Creso si rivolse ai
Lampsaceni e al modo in cui furono accolte e interpretate dai destinatari.
73
ANDREWES 1982 b, p. 405; GRAHAM 1982, pp. 121s.
BLAKESLEY 1854, ad Hdt. VI 37, n. 87; SCOTT 2000, ad Hdt. VI 34-41. Sulla stretta relazione fra pirateria,
brigantaggio individuale e intervento militare pubblico: LINTOTT 1982, pp. 1-31; JACKSON 2000, pp. 133-140;
ALONSO TRONCOSO 2007. Un inquadramento dei conflitti di frontiera nel mondo greco in DAVERIO ROCCHI 1988,
pp. 28-31, 61-64, 225-240.
75
Hdt. VI 37. Si nota che critica ha dedicato scarsa attenzione a questo passaggio, concentrando piuttosto gli studi
sulla tirannide filaide in Chersoneso Tracico in relazione ai contemporanei eventi in Atene oppure, in direzione dei
regni orientali, solo in relazione all’impero persiano: WADE-GERY 1951; HAMMOND 1956; BERVE 1967, pp. 79-81,
PEMBERTON 1988, pp. 231-234; AUSTIN 1990, pp. 295, 300-304.
76
MAZZARINO 1966, pp. 130-141; KINDT 2006. Hdt. I 29-34 narra ampiamente di una visita di Solone presso la
corte di Creso e costituisce un excursus prettamente filosofico e leggendario. Hdt. VI, 125 tramanda notizia di una
visita di Alcmeone presso la corte di Creso: come si è discusso il passo presenta caratteri novellistici nonché una
impossibilità cronologica, vd. supra, pp. 114ss.
74
203
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
È d’altronde un elemento storicamente ineludibile l’atteggiamento filellenico che
contraddistinse i sovrani Mermnadi e particolarmente il regno di Creso: questo sovrano fu
estremamente attivo nella costruzione di una rete di contatti e alleanze internazionali, in oriente
quanto in Grecia77, e fu devoto a numerosi santuari e oracoli ellenici78. Creso strinse rapporti di
xenìa con i Greci delle isole79; è noto e discusso il trattato di alleanza che egli stipulò con
Sparta, alla vigilia del suo scontro con l’impero persiano in espansione80; Creso interrogò gli
oracoli ellenici in vista di quel conflitto, ma dimostrò particolare devozione verso quello di
Delfi con ricchissime offerte votive e l’oracolo ricambiò conferendogli ambiti onori81. Questa
dimestichezza con la cultura greca e l’attivo interesse per le poleis, la classe dirigente e i
santuari ellenici sono caratteristiche già riscontrabili nel predecessore di Creso, suo padre
Aliatte: questi fu ospite dell’Ateniese Alcmeone nelle consultazioni dell’oracolo di Delfi e
ricompensò quell’attività di intermediazione con ampi donativi alla famiglia82; Aliatte fu xénos
del tiranno di Mileto, Trasibulo83, ed ebbe contatti con il tiranno corinzio Periandro84.
Secondo queste premesse, mi pare più che credibile che Creso avrebbe trovato facile e
interessante entrare in contatto con Milziade e gli Ateniesi stanziati in Chersoneso Tracico:
dunque la testimonianza di Erodoto merita un certo grado di attendibilità storica e un’analisi più
attenta85. Creso scelse dunque di intervenire nel conflitto fra i Filaidi e Lampsaco e scelse di
prendere le parti dei Chersonesiti: è necessario concludere perciò che quella dovette sembrare
allora la direzione più utile e vantaggiosa da impartire alla politica della Lidia nell’area
dell’Eolide e dell’Ellesponto. Lampsaco era effettivamente una polis potente e ricca giacché nel
proprio entroterra disponeva di miniere d’oro86. È incerta l’attribuzione della fondazione di
77
In oriente Creso e il padre Aliatte strinsero contatti diplomatici con i sovrani di Cilicia, Babilonia, Media ed
Egitto: Hdt. I, 69-70, 74, 77. NENCI 1981, pp. 57-61, 68s.
78
NENCI 1981, pp. 61-65. La celebre storia delle interrogazioni oracolari di Creso presso i santuari del mondo
orientale e greco: Hdt. I 46-55.
79
Hdt. I 27.5.
80
Hdt. I 69s. SALMON 1996, pp. 857-859; PANESSA 1999, pp. 76-81; RAVIOLA 2005, pp. 104s..
81
Creso sacrificò 3000 capi di bestiame, offrì letti placcati d'oro e d'argento, coppe d'oro, vestiti di porpora, 117
mattoni d'oro, una statua leonina di oro puro, un cratere d'oro e uno di argento, quattro giare d'argento, due urne
lustrali rispettivamente d'oro e d'argento, altri vasi d'argento, una statua femminile, le collane delle sue mogli, le
proprie cinture ornate, due stateri d'argento ad ogni cittadino di Delfi, uno scudo d'oro, un incensiere d'argento; in
cambio Delfi concesse a Creso e ai Lidi la precedenza nelle consultazioni, l’esenzione dalle tasse, la proedrìa ai
Giochi Pitici e la possibilità di ottenere il diritto di cittadinanza: Hdt. I 50s., 54, 92; IV 162; Paus. X 8.7
82
Hdt. VI 125. Vd. supra, pp. 114ss. Sulla relazione fra xenìa e conduzione dell’attività presso i santuari: DOPICO
CAINZOS 1997, p. 530.
83
Hdt. I 16-22.
84
Hdt. I 25, III 48s., 53; Paus. X 16, 1-2; Ath. V 45. OLIVIERI 2010.
85
ANDERSON 2005, pp. 184, 191, 201.
86
KOROMILA 1991, pp. 32, 52-55.
204
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Lampsaco nel 654, assegnata a Focea oppure, meno probabilmente, a Mileto87; pure sia Mileto
che Focea furono potenze strategiche ed economiche della Ionia, mantennero contatti con le
proprie colonie nella Propontide, come approdi utili nella navigazione che conduceva verso il
Mar Nero88: indebolire Lampsaco avrebbe potuto contribuire a rendere la madrepatria
fondatrice meno indipendente e dunque più permeabile al controllo lidio. Per altro verso,
l’insediamento ateniese in Chersoneso Tracico si trovava al di là dell’Ellesponto, in Europa,
fuori dall’area di interesse della Lidia, e non costituiva perciò un pericolo per l’autorità e il
dominio di Creso. Sono questi, forse, motivi sufficienti perché Creso prendesse allora le difese
di Milziade sottoponendo Lampsaco alla minaccia di un casus belli, riaffermando l’autorità dei
sovrani di Lidia sul continente e fornendo ai Lampsaceni e a Milziade una prova della potenza
diplomatica del trono di Lidia.
Ritengo d’altronde che Creso stesse allora agendo non solo in considerazione delle
circostanze strategiche finora esposte, ma che egli stesse rispettando l’eredità di un legame di
reciprocità inter-familiare di lunga data che lo associava, almeno indirettamente, a Milziade.
È possibile ricostruire l’esistenza di un’intesa personale che associò i Mermnadi di Lidia e
i tiranni Cipselidi di Corinto, a partire dalla fine del VII secolo. La dinastia dei Mermnadi di
Lidia si legò all’autorità sacrale di Delfi fin dalla propria ascesa e i sovrani Gige, Aliatte e il suo
successore Creso depositarono generosissime offerte presso il santuario oracolare di Apollo89. I
popoli orientali non ebbero però mai il privilegio di edificare un proprio òikos, un tesoro votivo,
presso i santuari ellenici90: nel caso di Delfi, le fonti attestano appunto che, nella gran parte dei
casi, le offerte dei Mermnadi si trovarono depositate presso il tesoro dei Corinzi, edificato e
dedicato da Cipselo, il fondatore della dinastia tirannica di Corinto. Questo significa che i
Cipselidi accolsero nel proprio tesoro familiare le dediche dei Mermnadi e ne garantirono la
protezione; in senso lato questa pratica si allargava però alla necessità per i Lidi di disporre di
un ospite greco presso il santuario, cioè un intermediario che appoggiasse, proteggesse e
garantisse per le ambascerie della corte lidia in occasione delle visite devozionali e delle
consultazioni oracolari presso il santuario91. In base a queste premesse dunque si individua
l’esistenza di un rapporto di ospitalità fra i Cipselidi e i Mermnadi, secondo le modalità messe
in pratica nelle relazioni di xenìa. La storia delle relazioni internazionali del secondo tiranno di
87
Strab. XIII 1.19. afferma che Lampsaco è una colonia di Mileto. Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 167d Helm.
RADET 1893, pp. 187-195; GRAHAM 1982, p. 161; BAKHUIZEN 1990, p. 57; JACKSON 2000, pp. 140-142.
88
FOSSEY 1997.
89
MIDDLETON 1888, pp. 287, 291s., 308-310; LLOYD-JONES 1976, pp. 63s.; KINDT 2006.
90
Unica eccezione sembra essere costituita dall’òikos Lydòn a Delo: MIDDLETON 1888, in particolare pp. 308s.;
DYER 1905, in particolare pp. 308-310.
91
DOPICO CAINZOS 1997, p. 530; MOSSÉ 2009, pp. 8-10.
205
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Corinto, Periandro, dimostra la continuità di questa ospitalità e inoltre la capacità di Periandro
di agire come mediatore diplomatico per il sovrano di Lidia, Aliatte92.
Per altro verso, si è sopra esplicitato il legame familiare per cui era riconosciuta ai Filaidi,
Milziade e Ippoclide, la discendenza dai Cipselidi di Corinto; l’onomastica di Milziade
(Miltia/dhj o( Kuye/lou) e la fama di Ippoclide in occasione del matrimonio di Agariste
confermano che quel retaggio familiare costituiva ancora un elemento significativo nelle
relazioni internazionali personali dei Filaidi a metà del VI secolo93.
È noto infine che le forme di alleanza personale e inter-familiare, quali appunto la xenìa e
altre più generiche relazioni di ospitalità, erano considerate applicabili e fruibili entro l’ambito
allargato delle famiglie e dei parenti dei due contraenti ed erano normalmente intese come
ereditarie, perlomeno certamente rinnovabili, da una generazione alla successiva. Per il tramite
dunque del loro legame di parentela con i Cipselidi, i Filaidi poterono sfruttare anche il retaggio
delle relazioni personali e familiari che avevano costruito i tiranni di Corinto, Cipselo e poi
Periandro, appunto con i Mermnadi94.
In base alle considerazioni finora esposte mi pare vada dunque interpretata quella
attestazione di contatto e collaborazione fra Milziade I e Creso all’epoca della guerra fra i
coloni del Chersoneso e Lampsaco95. Negli anni di quel conflitto, poco dopo il 548 ca.,
Milziade era da poco giunto in Ellesponto e non aveva mai conosciuto la sponda micrasiatica;
come si è detto, non esistono notizie di precedenti contatti fra i Filaidi e i sovrani orientali:
ciononostante Milziade fu considerato da Creso come un individuo a lui caro e Milziade poté
fare appello all’appoggio e all’autorità di Creso nell’assicurarsi la propria liberazione da
Lampsaco96. Il presupposto che agì allora a fondamento di questa, altrimenti inaspettata, intesa
non poté essere altro che quello di una discendenza da individui fra loro associati: cioè il
presupposto di una relazione personale, che Creso ereditava dal padre Aliatte e dai Mermnadi,
per via della quale egli stesso si trovava associato in una xenìa all’òikos allargato dei Cipselidi,
di cui Milziade poteva dirsi un discendente diretto.
È vero che in Grecia, a quell’epoca, la tirannide dei Cipselidi era finita da un quarto di
secolo; eppure si è già avuto modo di notare l’allure della fama di quella famiglia tirannica,
entro la politica matrimoniale dei tiranni Clistene di Sicione e Pisistrato ad Atene, e inoltre
92
Vd. il caso dell’intermediazione di Periandro nel conflitto fra la Lidia e Mileto all’inizio del VI secolo. OLIVIERI
2010, in particolare pp. 127-132.
93
PARKER 1994, pp. 408, 417s.
94
L’associazione con i sovrani orientali costituì un elemento di legittimazione del potere dei tiranni: ANDERSON
2005.
95
WILL 1955, pp. 546-551, riporta e appoggia una ricostruzione già enunciata in MAZZARINO 1939.
96
ISAAC 1986: p. 170-172.
206
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
l’importanza della storia politica delle poleis continentali deve essere parsa ridimensionata
ancor più agli occhi del re di Lidia. Creso agiva entro il quadro culturale della monarchia
personale orientale e Milziade, dal canto suo, agiva entro i parametri culturali e
comportamentali dell’aristocrazia ellenica: nella prospettiva dei due interessati rimanevano
perciò attivi e vincolanti quegli obblighi familiari istituiti fra il padre di Creso, Aliatte, e gli
antenati di Milziade, i Cipselidi; Creso stesso poteva ancora provare riconoscenza nei confronti
della famiglia cipselide per l’ospitalità e l’intermediazione presso Delfi97.
La riflessione ora scaturita sulle posizioni di Milziade e Creso può essere approfondita
ulteriormente: è possibile infatti che la discendenza cipselide di Milziade sia stata un fattore che
Milziade stesso e Pisistrato presero effettivamente in considerazione nella progettazione della
spedizione in Chersoneso Tracico e della loro generale strategia nell’Ellesponto. Milziade cioè
sarebbe potuto essere perfettamente consapevole del valore della sua parentela con Periandro,
di fatto suo prozio materno, e dei vantaggi che potevano derivarne; inoltre si deve ritenere che
l’élite tirannica arcaica fosse perfettamente a conoscenza della posizione della dinastia
mermnade entro le genealogie e le relazioni delle importanti famiglie aristocratiche elleniche e
delle dinastie orientali. A questo punto l’intesa familiare fra Pisistratidi e Filaidi acquisisce
un’ulteriore elemento di pregnanza nella valutazione del ruolo dei Filaidi nella gestione della
politica internazionale di Pisistrato. La scelta di Pisistrato di appoggiare la spedizione di
Milziade e di affidargli la propria fiducia fu dovuta anche all’ascendenza del Filaide ai
Cipselidi: Pisistrato e Milziade dovettero ritenere che quella caratteristica genealogica avrebbe
potuto rivelarsi utile nell’operare nell’Ellesponto, un’area geo-politica tangente al sistema di
governo della Lidia, ove regnava appunto un sovrano che doveva ai Cipselidi la propria
riconoscenza per la possibilità di consultare e fare offerte presso Delfi. Per altro verso, il
fratello uterino di Milziade, Cimone, era nato non da quel Cipselo ateniese legato ai tiranni di
Corinto, ma piuttosto da Stesagora, di ascendenza locale, e non poteva dunque vantare alcun
legame di discendenza con i tiranni di Corinto: perciò Cimone risultò non costituire un alleato
utile per Pisistrato e fu di fatto estromesso dalla gestione congiunta della politica di Atene. Si
presenta dunque alla ricostruzione storica un elemento ulteriore per comprendere l’indirizzo che
presero le relazioni positive fra Milziade e i Pisistratidi e viceversa quell’atteggiamento
antagonistico che distinse il rapporto di questi con Cimone.
97
DOPICO CAINZOS 1997, p. 530. Sul ruolo delle genealogie nell’auto-identificazione dell’aristocrazia ellenica:
MAZZARINO 1966, pp. 130-141; JEFFERY 1976, pp. 34-38; GERNET 1981, pp. 294s.; ANDERSON 2005, pp. 178,
184-189; DUPLOUY 2006, pp. 56-69.
207
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
In conclusione, l’intervento di Creso nelle dinamiche fra Milziade e Lampsaco deve
essere compreso alla luce di entrambi gli aspetti finora discussi: sia entro il quadro degli
interessi strategici dell’impero lidio nell’area, sia entro il quadro ideologico della genealogia
filaide e delle relazioni familiari ereditarie dei Mermnadi; soprattutto quest’ultimo aspetto rende
conto dell’esistenza di una storia personale pregressa di Milziade e Creso capace di spiegare
l’interesse del sovrano di Lidia nei confronti del nuovo arrivato in Chersoneso Tracico.
V.3. Il significato della tirannide di Milziade I in Chersoneso Tracico
Mi pare opportuno cercare di approfondire la natura del ruolo di comando di Milziade I e
dei Filaidi nel governo dello stanziamento del Chersoneso Tracico e di tracciare un quadro
politico e istituzionale della penisola, al fine di valutare il senso storico e politico della tirannide
filaide, cioè di valutare la portata dell’intervento di Milziade entro il sistema internazionale,
nella conduzione della politica estera di Atene e nei rapporti con la politica estera della
tirannide di Pisistrato.
La spedizione in Chersoneso Tracico: una fondazione coloniale
Si dispone di sufficienti dati letterari, storici e contestuali per riconoscere con chiarezza
nella missione di Milziade I in Chersoneso una spedizione coloniale ateniese: in primo luogo, la
narrazione e il vocabolario della fonte principale, Erodoto, riprendono la prassi e le espressioni
formulari normalmente usate nel caso appunto delle fondazioni coloniali arcaiche in aree extraelleniche. Una volta accettata l’offerta dei Traci, nonostante fosse stato proprio l’oracolo pitico
a indurre la loro visita ad Atene, Milziade I si recò nuovamente egli stesso a Delfi allo scopo di
ricevere dal santuario l’approvazione per la sua impresa98: è noto infatti che la consultazione
dell’oracolo apollineo sanciva l’avvio delle fondazioni coloniali e dunque né Milziade né la
narrazione erodotea potevano evitare quell’atto devozionale99. In Atene, Milziade prese con sé
tutti i concittadini che volessero partecipare alla spedizione: in questa circostanza il testo
erodoteo ricalca con precisione la formula conosciuta per l’arruolamento dei volontari in vista
di una spedizione coloniale100. La figura di Milziade ha i chiari connotati dell’ecista, il
conduttore e fondatore della colonia. Nel testo erodoteo, il responso pitico ricevuto dai Traci
Dolonci ingiunge di affidare al loro ospite l’incarico di fondare una colonia, definendolo
98
Hdt. VI 35.3-36.1.
GWYN 1918, pp. 98s.; FORREST 1957; GRAHAM 1964, pp. 25-28; NENCI 1988, ad Hdt. VI 36.1; MURRAY 1996,
p. 142.
100
Hdt. VI 36.1: τότε παραλαβὼν Ἀθηναίων πάντα τὸν βουλόµενον. NENCI 1988, ad Hdt. VI 36.1.
99
208
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
appunto oi)kisth/j; le successive fonti storiografiche associano spesso a Milziade questo
epiteto, oppure il corrispondente verbo kti/zw. Infine, dopo la morte di Milziade, i Chersonesiti
istituirono sacrifici e agoni ippici e ginnici in suo onore: questa notizia testimonia l’istituzione
di un culto pubblico, come era costume per le figure degli ecisti101.
Le fonti antiche, e particolarmente quelle geografiche, tramandano per varie località del
Chersoneso la definizione di colonie ateniesi o attiche e ne attribuiscono la fondazione, o la
rifondazione, a Milziade I: Elaious, Crithote, Pactie, Agorà102. All’epoca della spedizione di
Milziade II per la conquista di Lemno, nel 500 ca., Erodoto descrive testualmente il Chersoneso
come sotto il dominio degli Ateniesi, piuttosto che dei soli Filaidi103. La storia della tirannide
dei Filaidi in Chersoneso conosce, per il periodo del 525 ca., l’esistenza di un pritaneo nella
fondazione istituita da Milziade I: il pritaneo è un elemento urbanistico che implica chiaramente
l’esistenza di istituzioni e di un sistema di governo tipici di una polis, dell’auto-governo e della
partecipazione alla politica del corpo dei cittadini-coloni104. Anche la numismatica potrebbe
contribuire a identificare fin da subito l’insediamento di Milziade come una polis coloniale
indipendente dalla madrepatria giacché sono attestate coniazioni, per il periodo 515-498,
interpretate di norma dalla critica come il segno di un’iniziativa statale, locale e pubblica105.
Le fonti antiche descrivono il Chersoneso come un territorio fertile, ricco di terreni
coltivabili e di buoni pascoli e la stessa toponomastica dei luoghi determina associazioni di
significato con la coltivazione di cereali e olivi e con la disponibilità di legname; dal
Chersoneso, nel V secolo, Atene importava infatti risorse cerealicole106. Queste caratteristiche,
prescindendo dalla strategia marittima pisistratide che si sta ricostruendo in questo scritto, sono
elementi fondamentali per il richiamo dei coloni ellenici e per la scelta dei luoghi ove insediare
le apoikìai, in risposta alle speranze dei volontari di ottenere nuovi e più produttivi terreni107.
101
Hdt. VI 34.2, 38; Thuc. V 11.1; Ps. Scymn. 711s.; Ael. Var Hist. 12.35; Marcell. Vit. Thuc. 8.3, 10.3.
HAMMOND 1956, pp. 114-117; GRAHAM 1964, pp. 29-39; BERVE 1967, p. 80; DAVIES 1971, n. 8429 [VI];
FONTENROSE 1978, pp. 304s.; NENCI 1988, ad Hdt. VI 34.1, ad Hdt. VI 38 pp. 201s.; LAVELLE 1994 discute il
modello del tiranno fondatore. Non escludo che sia i Greci che i Traci del Chersoneso Tracico partecipassero agli
agoni cittadini in onore dell’Ecista ed è indubbio che i barbari perlomeno apprezzarono e compresero pienamente il
senso del rito e dell’agone: sulle strette affinità fra i sacrifici, gli agoni cittadini greci e i riti funebri per uomini di
riguardo presso i Traci, vd. Hdt. V 8. Se questa supposizione fosse corretta si disporrebbe di un ulteriore elemento
culturale di unione e concordia fra i coloni e le istituzioni di origine ateniese e la popolazione autoctona.
102
Hdt. VII 58; Ephor. FGrHist 70 F 40; Ps. Scymn. 711s. LOUKOPOULOU 2004; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 140.1, p.
453.
103
Hdt. VI 140.
104
Hdt. VI 38.2. LOUKOPOULOU 2004, p. 901, n. 661 p. 905; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.2, p. 177.
105
ISAAC 1986, pp. 167s.; LOUKOPOULOU 2004, n. 661, p. 904s. Contra DAVIES 1971, n. 842 [XVI].
106
Xen. Anab. V 6.25; Id. Hell. III 2.10; Aristoph. Eq. 262. Il senso del toponimo Krithote fa riferimento all’orzo;
Elaious agli olivi; Pteleon richiama la disponibilità di legname. ISAAC 1986, pp. 159-197.
107
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 46, 237-240 fornisce un’inquadramento storico per comprendere lo sfruttamento
del territorio chersonesita; MORENO 2007 ritiene primari questi elementi nella scelta della fondazione coloniale di
Milziade I, piuttosto che il movente strategico relazionato alla navigazione dell’Ellesponto.
209
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Mi pare corretto dunque concludere che la spedizione condotta da Milziade I nel 558 ca.
fu a tutti gli effetti una spedizione coloniale: il Filaide assunse il ruolo di ecista, in virtù del suo
status sociale aristocratico, delle sue capacità di governo e dell’appoggio di cui godeva ad
Atene; i volontari che accompagnarono Milziade, e ne assicurarono poi la tirannide, furono il
contingente che andò a costituire la cittadinanza della nuova polis108. In questo senso, la
colonizzazione del Chersoneso Tracico condotta da Milziade fu un’impresa pubblica: cioè
un’iniziativa, un onere e un vantaggio per la cittadinanza di Atene, o più specificamente per
quegli Ateniesi che decisero di lasciare la madrepatria e ristabilirsi nel nuovo territorio di
colonizzazione, e a questo gruppo è necessario attribuire un fattore decisionale nella genesi
della spedizione109. Milziade, prescindendo dalla tirannide che le fonti gli attribuiscono in
Chersoneso, fu innanzitutto piuttosto un condottiero ateniese, l’oi)kisth/j appunto, investito
dai propri concittadini del potere di decidere e comandare l’organizzazione della spedizione
coloniale e detentore della responsabilità sacrale e politica nella nuova comunità110.
Lo scenario geo-politico del Chersoneso Tracico
La comprensione della posizione geografica e politica occupata dalla colonia fondata da
Milziade in Chersoneso Tracico è resa problematica non solo dalla presenza delle locali
popolazioni traciche nella penisola, ma anche dai pre-esistenti insediamenti coloniali ellenici.
Prima dello stanziamento coloniale di Milziade, il Chersoneso Tracico era stato infatti oggetto
di colonizzazione eolica e ionica nel corso del VII e VI secolo. Coloni provenienti da Lesbo
fondarono Sesto e Madytos, sulla costa meridionale affacciata sull'Ellesponto, e Alopeconneso
sulla costa settentrionale al limite meridionale del Golfo di Melas. Mileto fondò Limnai, sul
litorale occidentale; Mileto e Clazomene insieme fondarono Cardia nell'insenatura del Golfo di
Melas111. A Milziade I è attribuita specificamente la fondazione di alcuni insediamenti nei
pressi dell’istmo che separava la penisola dal continente: Crithote, Pactie e una polis il cui
toponimo le fonti confondono fra Agorà, Chersonesos oppure Cherronesos; l’opera dell’ecista è
associata anche alla rifondazione di Elaious, sull’estremità meridionale della penisola112.
108
GOMME 1937; BERVE 1967, p. 80; MALKIN 1987, pp. 189s.; HORNBLOWER 1997, ad Thuc. I 4.
MORENO 2007.
110
GOMME 1937 ritiene pure che la missione di Milziade fosse un’apoikìa per quello che concerne lo status di
quegli Ateniesi che si recarono in Chersoneso, ma considera nondimeno l’impresa come un’iniziativa privata di
Milziade I; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 234-240 menziona il prestigio personale che potè derivare a Milziade dalle
operazioni di difesa e dalla costruzione delle fortificazioni.
111
Ps. Scymn. 700-3; Strab. VI fr. 5.
112
Ephor. Fr. 40; Ps. Scymn. 711.s. RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 37, pp. 436s.; ISAAC 1986, pp. 18-20, 146-197;
LOUKOUPOULOU 2004, pp. 901, 903, n. 659 p. 904, n. 661 p. 905, n. 664 p. 907, n. 667 p. 908, n. 669 p. 909, n.
671 p. 909, n. 672 p. 910; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 140.1, p. 453.
109
210
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
L’estensione e l’influenza politica dello stato fondato da Milziade in Chersoneso Tracico
dipesero dunque dal condizionamento dei pre-esistenti insediamenti ellenici e dalle reciproche
posizioni e relazioni fra la sopraggiunta comunità ateniese-filaide e quelle ioniche ed eoliche.
Le fonti al riguardo sono scarse e imprecise e conseguentemente la critica non ha al momento
offerto un’analisi conclusiva. Alcune considerazioni si possono trarre dalla presenza delle
poleis del Chersoneso entro la Lega Delio-Attica e nelle liste dei tributi versati dagli alleati al
tesoro della Lega, nel V secolo, pure con la precauzione di tenere in conto la collocazione
cronologica più tarda di quelle informazioni. Si ricava nondimeno un dato utile che mette in
luce un’evidente disomogeneità in merito all’entità politica e al peso economico delle varie
poleis del Chersoneso: alcune località furono sempre poleis indipendenti e forti, come è il caso
della milesia Limnai, altre invece non ebbero voci proprie nelle liste tributarie della Lega ma
furono accorpate sotto la voce “Chersonesiti”, altre ancora sembrano essere state soltanto degli
empori commerciali come nel caso di Deris113. Si potrebbe perciò desumere che le comunità
pre-esistenti più consolidate resistettero all’influenza politica di Milziade; altri insediamenti, di
entità e capacità più ridotte, trovarono invece utile associarsi, o incorporarsi, all’organizzazione
della nuova colonia ateniese di Chersonesos (o “Cherronesos”). Il principale insediamento
filaide sembra abbia avuto nome Chersonesos, o Cherronesos, anche se in fonti il nucleo urbano
principale fu conosciuto con il nome di Agorà; nondimeno la legenda XER sulle coniazioni
della colonia ateniese non lascia grossi dubbi sulla denominazione della polis. La critica ha
notato d’altronde come non sempre i riferimenti delle fonti siano chiaramente indirizzati a
designare la polis fondata da Milziade I, l’etnonimo dei coloni e il toponimo geografica per la
penisola114.
Non sono documentate esplicite interazioni di Milziade e dei coloni ateniesi con le poleis
che sorgevano in Chersoneso al loro arrivo; eppure alcune informazioni testimoniano
dell’esistenza di una forma di coesistenza pacifica, di intesa o anche di collaborazione. La
monetazione della polis di Chersonesos, risalente al periodo 515-498, cioè alla tirannide di
Milziade II, reca su un lato la legenda XER e lo stemma della testa di Atena, sull’altro lato lo
stemma di un leone. La testa di Atene indica l’auto-identificazione ideologica con la
provenienza ateniese dei coloni; il leone è invece il simbolo della città di Mileto, madrepatria
della vicina Cardia. La critica ritiene dunque che l’estensione territoriale e politica della polis
fondata da Milziade I, Chersonesos, avesse assorbito e comprendesse la più antica colonia di
Cardia; altrimenti è possibile dedurre, perlomeno, che la popolazione di Chersonesos fosse, fin
113
114
LOUKOPOULOU 2004, nn. 659, 662, 668, pp. 904-908.
LOUKOPOULOU 2004, n. 661, pp. 904s.
211
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
dai primi anni, composta di coloni ateniesi e immigrati dalla vicina Cardia. Questa osservazione
si combina con la notizia secondo cui Milziade II, in fuga dal Chersoneso nel 493, avrebbe
preso il largo appunto dal porto di Cardia115: la critica ha ritenuto che Cardia fungesse da
località portuale di Agorà/Chersonesos situata invece nell’entroterra dell’istmo del Chersoneso
Tracico116. L’assenza di notizie in merito a conflitti con le pre-esistenti entità politiche potrebbe
dunque non risultare da una mera lacuna delle fonti, quanto piuttosto da un’effettiva coesistenza
pacifica fra i nuovi arrivati Ateniesi e i coloni eolici e ionici. In questo senso è una differenza
significativa il fatto che fino al 540 ca. i Pisistratidi insediati a Sigeo abbiano sostenuto un
lungo conflitto contro Mitilene di Lesbo per il possesso della località, mentre Milziade I e i suoi
volontari non ebbero apparentemente alcun problema con le colonie fondate dalla stessa Lesbo
nel Chersoneso Tracico.
Il novero di dati finora esposti non mi pare sufficiente per tracciare con sicurezza un
quadro geo-politico della situazione che si creò con l’arrivo dei coloni ateniesi in Chersoneso e
con l’affermazione del potere tirannico di Milziade; nondimeno voglio proporre alcune
considerazioni che, a mio avviso, presentano un grado di cogenza superiore alla semplice
speculazione.
Assume cogenza una ricostruzione secondo cui l’insediamento di Milziade e dei coloni
ateniesi non interessò l’intera penisola del Chersoneso Tracico, ma si concentrò nell’area
dell’istmo, dove sono localizzate le poleis a lui appunto attribuite o associate: Cardia, Agorà (o
Chersoneso), Pactie, sull’istmo, e poco più a sud lungo il litorale ellespontico la località di
Krithote. Non è da trascurarsi la prossimità di quest’area insediativa al muro difensivo che
Milziade I edificò all’istmo: le aree di insediamento ateniese e le strutture difensive erano cioè
funzionalmente associate fra loro e alla conduzione politica e militare di Milziade I117.
Nonostante le pesanti incertezze toponomastiche, la critica concorda nell’identificare una
polis con funzione di capitale politica e di centro economico, denominata Chersonesos oppure
Agorà, da localizzarsi appunto al centro dell’istmo e dello sbarramento difensivo di Milziade
I118. Contribuiscono a questa ricostruzione lo stesso toponimo “Agorà”, la coniazione attestata
115
Hdt. VI 41.
LOUKOPOULOU 2004, n. 665, p. 907.
117
RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 37, pp. 436s.; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 11-13, 34-37, 234-240 mette in
evidenza che le opere difensive in genere, e specificamente il muro costruito da Milziade in Chersoneso Tracico,
non sono da assumersi come il segno di un territorio economicamente arretrato, ma al contrario contradistinto da
funzioni economiche ed agricole significative.
118
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 46, 234-240 sul significato territoriale, politico ed economico dello sbarramento
difensivo.
116
212
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
fin dall’epoca di Milziade II e la stessa posizione geografica centrale e vicina allo sbarramento
difensivo119.
Nell’area scelta da Milziade I gli insediamenti non necessariamente presero la forma di
poleis indipendenti e auto-sufficienti, ma piuttosto dovette trattarsi di villaggi che si
svilupparono come centri di sfruttamento agricolo e di occupazione territoriale senza
comportare la creazione in ciascuno delle istituzioni e degli organi politici tipici delle cittàstato120. Nelle funzioni politiche e organizzative gli insediamenti minori poterono dipendere
dalla località centrale di Agorà/Chersonesos, ove si trovavano appunto l’agorà e il pritaneo e
dove si svolgevano dunque la vita assembleare e l’attività politica. È in quest’ultima località
che avevano probabilmente dimora i Filaidi e appunto dal controllo stretto e centralizzato delle
funzioni politiche che derivava loro quell’ampio potere che assicurò la tirannide di Milziade e
dei successori121.
Le fonti non testimoniano di alcun caso di ostilità fra Milziade I, nonché il successore
Stesagora, e i precedenti coloni ellenici del Chersoneso Tracico; le notizie raccolte sulle
relazioni con Cardia e altri insediamenti minori puntano verso l’esistenza di rapporti non solo
pacifici, ma collaborativi e costruttivi. Voglio formulare l’ipotesi che tale buona disposizione
dei Greci di origine eolica e ionica nascesse in riconoscimento dei meriti per l’iniziativa
difensiva intrapresa e organizzata da Milziade all’istmo del Chersoneso: il Filaide dimostrò cioè
ai Chersonesiti la sua buona volontà e la sua capacità militare e organizzativa occupando
quell’area strategica nelle comunicazioni terrestri fra Chersoneso e Tracia e costruendovi un
sistema difensivo di cui si avvantaggiarono non solo i coloni ateniesi che lo accompagnavano,
ma certo anche le altre poleis elleniche della penisola. In virtù di questa responsabilità Milziade
dovette ottenere il consenso dei Greci locali e dei coloni ateniesi e guadagnare presso entrambi i
gruppi una posizione organizzativa e di comando militare, sia pure non istituzionale, ma
fondata sul prestigio; da questa situazione deriva, a mio avviso, il potere personale di Milziade
nel Chersoneso Tracico nonché la stessa tradizione storiografica sulla tirannide filaide.
Milziade I ecista, tiranno e alleato dei Pisistratidi e la politica estera ateniese per il controllo
dell’Ellesponto
119
RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 37, pp. 436s.
Il modello qui proposto, di un insediamento coloniale nella forma di villaggi volti allo sfruttamento agricolo del
territorio, trova un paragone, in un periodo coevo, nello sviluppo della colonizzazione greca nell’area del Ponto
Eusino: PAROMOV 1990; KREBS 1997. Il quadro dell’antropizzazione del territorio di Anfipoli in Tracia che si può
ricavare dalla cronaca di Tucidide per l’anno 424 potrebbe accostarsi a questo modello: Thuc. IV 103.5-104.1.
121
SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.2, p. 177.
120
213
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Alla luce dei dati e delle considerazioni finora esposte è utile rileggere la tradizione
relativa alla tirannide di Milziade I e al suo operato in Chersoneso Tracico. Il profilo
istituzionale dell’insediamento che Milziade I condusse in Chersoneso Tracico è
innegabilmente quello di una apoikìa di Ateniesi, sotto il comando di Milziade in qualità di
ecista e autorità suprema122; fermo restando il carattere più frammentario e scarsamente
urbanizzato a livello insediativo che si è intravisto per l’area di occupazione scelta da Milziade
e dai suoi volontari.
È innegabile d’altronde che una volta in Tracia, al comando di Milziade I, e ancor più nel
passaggio di potere ai successori Stesagora e Milziade II, il ruolo di comando di cui i Filaidi
godevano venne assimilato a una tirannide. La tirannide filaide in Chersoneso va dunque però
interpretata non come la fondazione di un insediamento familiare o di una roccaforte personale,
ma piuttosto come una fondazione coloniale nella quale Milziade e i suoi successori, con vari
mezzi, mantennero un potere personale molto superiore a quello degli altri soggetti attivi nelle
decisioni politiche. Propongo in sostanza di applicare alla tirannide filaide del Chersoneso
Tracico uno dei modelli storici interpretativi che la ricerca ha ormai definito per la tirannide in
genere: cioè quello di un controllo informale, implicito, non-istituzionalizzato, nato da ruoli o
azioni pubbliche cruciali, spesso militari, e poi perpetuato e sostenuto piuttosto dalle capacità
personali del tiranno e dalle relazioni internazionali della famiglia123. In questo senso la
tirannide del Chersoneso Tracico va distinta dal modello di occupazione individuato, ad
esempio, per i Pisistratidi in Tracia e può essere invece paragonata alla posizione tirannica che i
Pisistratidi acquisirono nella colonia di Sigeo. Il potere tirannico di Milziade I gli derivò in
prima istanza dal ruolo di ecista che egli ricoprì nella fondazione coloniale: Milziade fu, per
decisione consensuale dei coloni, il referente per i primi momenti di organizzazione e decisione
politica. La posizione di massima eminenza politica e autorità decisionale rimase poi
appannaggio di Milziade per una serie di fattori che credo siano ormai evidenti: la capacità
politica e la ricchezza economica della famiglia ad Atene; l’appoggio politico assicurato
dall’alleanza con il tiranno di Atene Pisistrato; il suo ampio prestigio internazionale, derivato
dalla discendenza familiare e dalla tradizione agonistica; la capacità di assicurarsi l’appoggio
dei monarchi di Lidia; la sua capacità organizzativa e militare dimostrata nella conduzione della
guerra contro i Traci Apsinti, contro Lampsaco e nella costruzione del muro all’istmo124.
122
BERVE 1967, p. 80.
ANDREWES 1968; ANDERSON 2005; DUPLOUY 2006, pp. 11-130; LAVELLE 2010, s.v. “Tyranny”.
124
RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 36, pp. 436s. sulla fortificazione dell’istmo; LAVELLE 1994. Sul prestigio e il
potere detenuto e poi conservato dall’Ecista si consideri il caso di Batto, fondatore di Cirene: FORNARA 1983, nn.
17s.
123
214
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
La
forma
di
occupazione
territoriale
lassa
che
pare
contraddistinguere
sia
l’antropizzazione che le istituzioni della colonizzazione ateniese del Chersoneso Tracico, cioè
provvista di un unico centro politico presso la polis di Agorà/Chersoneso, può avere contribuito
alla centralizzazione delle istituzioni e dei processi decisionali
e conseguentemente al
mantenimento del potere individuale di Milziade I. Nella medesima direzione può avere
contribuito anche il contesto sociale e geo-politico della Tracia, nel quale era necessario
intrattenere relazioni con tribù traciche governate monarchicamente e nel quale era necessario
mantenere un certo grado di militarizzazione.
La storia della tirannide dei Filaidi nel Chersoneso Tracico nei periodi successivi, e
soprattutto il comando di Milziade II, dimostra una tendenza all’inasprimento dei metodi di
preservazione del potere e un’evidente cristallizzazione dinastica della tirannide: da questi
fattori consegue uno slittamento dell’identità della comunità di coloni verso la forma di un
dominio dinastico familiare, verso cioè un’iniziativa piuttosto privata dei Filaidi. Testimonianze
relative agli interessi della famiglia nei confronti del Chersoneso Tracico e delle rotte che vi
conducevano si riscontrano nella tirannide di Milziade II, ma anche nel V secolo, quando l’area
rimase cruciale per Atene e per Cimone II, figlio di Milziade II; Cimone II vide interrompersi la
propria carriera politica quando fu colpito da ostracismo nel 461 e si ritirò allora in Chersoneso
Tracico: segno che la famiglia ancora vi deteneva una forma di controllo o di primato125.
In conclusione, l’impresa di Milziade si configura secondo tre fattori: la direzione della
politica estera poleica da parte di Pisistrato, il potere e le facoltà personali di Milziade I, infine
il contributo degli Ateniesi che partirono per il Chersoneso. La fondazione coloniale è in prima
istanza una decisione e una necessità della comunità di Atene e specificamente di coloro che
sarebbero poi stati i coloni: nata dalla prospettiva di ricollocazione in territori nuovi e della
ripartizione di nuovi terreni. L’aspetto organizzativo della spedizione coloniale ebbe origine
entro i disegni strategici di Milziade I e di Pisistrato, eppure non in maniera artificiale, ma in
risposta alle volontà e necessità pubbliche.
Seguendo le fonti storiografiche, Milziade I deve senz’altro essere considerato il
promotore e il responsabile organizzativo e politico della spedizione, dal momento della fase
preparatoria ad Atene, a quello dell’organizzazione e dell’amministrazione degli insediamenti
in Chersoneso; egli mantenne in seguito, con la tirannide, una posizione di ampia decisionalità
politica e responsabilità personale126.
125
Andoc. De Pace, 3.3. Sul continuato interesse dei Filaidi per l’Egeo settentrionale vd. CULASSO GASTALDI
2011, pp. 122-124.
126
DEN BOER 1969; LAVELLE 1994.
215
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
L’alleanza politica fra Filaidi e Pisistratidi, la coesistenza dei due poteri personali di
Milziade I e Pisistrato ad Atene all’epoca della partenza della spedizione, nonché la posizione
di potere tirannico di cui godeva Pisistrato sono dati storici che consentono di individuare un
ulteriore livello decisionale. Concordo dunque con quella parte della critica che ritiene che la
spedizione sarebbe stata impossibile senza perlomeno un avallo o un tacito consenso del tiranno
ateniese; da Pisistrato dovette venire perciò l’appoggio all’iniziativa e un contributo nella
promozione politica ed economica della spedizione. La direzione della tirannide di Pisistrato
dovette intervenire sugli aspetti organizzativi e politici della spedizione: cioè nelle scelte in
merito al momento in cui agire, all’ecista a cui affidare il potere e all’area verso cui dirigere gli
sforzi dei coloni ateniesi. In base a queste ultime considerazioni, dunque, l’occupazione filaide
del Chersoneso Tracico fu parte organica della politica estera di Pisistrato, insieme con un
novero significativo di altre iniziative che influenzarono il sistema internazionale dell’Egeo
nella seconda metà del VI secolo. Nel loro insieme queste notizie mettono in evidenza
chiaramente un progetto di politica estera avviato da Pisistrato e Milziade I e implementato
attraverso il potere tirannico del primo ad Atene e del secondo in Chersoneso; la strategia dei
due tiranni aveva lo scopo di assicurare ad Atene la navigazione verso l’Ellesponto, l’accesso
alla Propontide e una posizione di forza nel controllo delle rotte marittime ellespontiche. Sulla
base di queste considerazioni mi pare si possa concludere con sicurezza che l’operazione in
Chersoneso Tracico fu decisa e organizzata sotto l’impulso politico congiunto di Pisistrato e
Milziade I127.
L’avvio di questa strategia congiunta potrebbe riconoscersi già nel 565 ca. quando
Pisistrato concluse vittoriosamente il conflitto fra Atene e Megara per il possesso di Salamina:
si consentì così ad Atene il libero accesso all’isola e una più ampia mobilità navale nel Golfo
Saronico e verso l’Egeo. Già per questo periodo, durante l’arcontato di Ippoclide nel 566, si
sono messe in luce le tracce di un’intesa fra Pisistratidi e Filaidi perlomeno nella gestione della
politica culturale e religiosa della polis. Meno di un decennio dopo, nel 558, durante la seconda
tirannide di Pisistrato, la fondazione coloniale nel Chersoneso Tracico sembra essere stata, si è
detto, una decisione politica concordata fra il tiranno e Milziade I. Si stabilì allora un indirizzo
di politica estera per Atene volto a un’espansione oltremare e all’insediamento in una zona
strategica nella navigazione fra l’Egeo e la Propontide che allora andava prendendo piede128. La
tirannide di Milziade I nella colonia è indice di un accresciuto potere del filaide e di una
127
HOW-WELLS 1928, app. XVI.8; GRAHAM 1964; AUSTIN 1994, pp. 558-564; DAVIES 1997, N. 8429 [VI]; DE
STE. CROIX 2004, pp. 46-49; MORENO 2007: pp. 165-167. Contra GOMME 1937.
128
FOSSEY 1997.
216
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
ripartizione delle aree di influenza fra i due alleati; i Filaidi stessi separarono la famiglia in due
nuclei di potere: Milziade e il suo seguito si stabilirono in Chersoneso; il mezzo-fratello
Cimone rimase invece ad Atene. La guerra subito ingaggiata fra Milziade I e Lampsaco è
sintomatica dell’importanza che l’Ellesponto ricopriva allora. Nel 556 Pisistrato fu espulso da
Atene e si insediò egli stesso in Tracia, nell’area mineraria del Pangeo: questo significa che, a
partire da quella data e fino alla fine dell’occupazione di quest’ultimo insediamento, intorno al
513129, per quattro decenni le due famiglie alleate controllarono due posizioni strategiche sulle
coste dell’Egeo settentrionale, forse dunque influendo sulle rotte che costeggiavano quel litorale
nella navigazione fra le coste della Grecia orientale e l’Ellesponto. Con la definitiva terza
tirannide di Pisistrato si riconosce una serie di interventi che implementarono una strategia di
posizionamento di Atene nelle Cicladi: l’alleanza con Ligdami di Nasso, la conquista dell’isola
e la purificazione del santuario di Delo. A queste iniziative seguì presto la rioccupazione della
colonia a Sigeo e l’assestamento colà della tirannide di Egesistrato, figlio di Pisistrato; il valore
assegnato a questa località è testimoniato dalla continuata opposizione militare di Mitilene.
L’occupazione pisistratide di Sigeo e la contemporanea tirannide degli alleati filaidi in
Chersoneso testimoniano di una politica estera del tiranno di Atene volta verso l’Ellesponto;
tale indirizzo strategico era stato già avviato all’epoca della seconda tirannide, con la spedizione
di Milziade I, e veniva ripreso dopo la fine dell’esilio di Pisistrato con la presa di Sigeo. È
possibile, a mio avviso, che alla conquista di Sigeo abbia contribuito anche un appoggio
logistico da parte dei Filaidi sulla sponda opposta dell’Ellesponto, specificamente dalla
posizione di Elaious; i Filaidi poterono perlomeno mettere a disposizione di Pisistrato, e poi di
Egesistrato, le loro conoscenze pregresse della geografia e della geopolitica dell’area
ellespontica. Si vedrà che anche in seguito alle tirannidi di Pisistrato e Milziade I questa
strategia marittima congiunta, imperniata sull’Ellesponto e sulle rotte marittime che vi
conducono, rimase una costante dei progetti dei Pisistratidi e dei Filaidi. La continuità
dell’alleanza e della strategia concordata è testimoniata dall’invio in Chersoneso di Milziade II
durante la tirannide di Ippia. I Filaidi manterranno poi per decenni i propri interessi nell’area
dell’Ellesponto e della Tracia, conducendovi le imprese dell’Atene democratica nel V secolo130:
in questo senso, nel V secolo, la famiglia aristocratica dovette comprendere e condurre le
necessità strategiche della polis, non diversamente da quanto Milziade e Pisistrato avevano fatto
nel VI secolo.
129
130
Vd. Infra, pp. 301ss.
Hdt. IX 108, 114s.; Thuc. I 89.
217
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
V.4. Stesagora, la seconda generazione della tirannide del Chersoneso Tracico (525-520
ca.)
La tirannide dei Filaidi in Chersoneso Tracico durò fino al primo decennio inoltrato del V
secolo: all’ecista Milziade I successe il nipote Stesagora che a sua volta trasmise il comando al
fratello Milziade II. Non appena conchiusa la narrazione dell’intervento di Creso che salvò
Milziade dalla prigionia presso i Lampsaceni131, Erodoto fornisce subito la notizia che il tiranno
ed ecista morì senza figli, lasciando il potere e le ricchezze a suo nipote Stesagora, il figlio di
suo fratello uterino Cimone. Le uniche notizie che Erodoto fornisce su Stesagora sono che
anch’egli, come lo zio, condusse una guerra contro Lampsaco nel corso della quale, in un
momento in cui egli si trovava nel pritaneo, ricevette a tradimento un fatale colpo di scure da un
uomo che si era dichiarato un disertore lampsaceno e che era invece un nemico ed un esaltato;
cosicché anche Stesagora, come Milziade I, morì senza figli132. In un altro passo Erodoto
dimostra di sapere che nel momento in cui Cimone, dopo la terza consecutiva vittoria olimpica,
veniva assassinato ad Atene, suo figlio maggiore Stesagora stava vivendo presso lo zio
Milziade I in Chersoneso Tracico133. La genealogia dei Filaidi chiarisce che Cimone, il fratello
uterino dell’ecista Milziade I, aveva avuto due figli: Stesagora, il maggiore, prendeva il nome
dal nonno paterno, mentre il minore ebbe nome Milziade da quello di suo zio, ecista del
Chersoneso Tracico134.
La critica calcola che Stesagora II sia nato nel 560-550 ca.135; Stesagora e il fratello
Milziade II dovettero lasciare Atene insieme a loro padre Cimone quando questi fu esiliato da
Pisistrato resosi tiranno della polis, a partire da una data precedente alla vittoria olimpica del
536136. Il padre e il figlio minore fecero ritorno ad Atene nel 532, ma Erodoto tramanda che nel
528, quando Cimone fu assassinato, Stesagora si trovava già in Chersoneso Tracico con lo zio
Milziade I: dunque una ricostruzione verosimile si può ritenere quella secondo cui, durante
l’esilio da Atene, la famiglia di Cimone abbia trovato ospitalità presso il mezzo-fratello
Milziade I in Chersoneso Tracico; Cimone poi rientrò nella Grecia continentale, ma preferì
lasciare il figlio Stesagora presso la tirannide che la famiglia teneva nei territorio
131
Hdt. VI 37-38.1.
Hdt. VI 38-39.1. SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.2, p. 177.
133
Hdt. VI 103.4. MORETTI 1957, n. 120.
134
Hdt. VI 34.1, 39, 103. DAVIES 1971, n. 8429 [V].
135
DAVIES 1971, n. 8429 [VIII] ; IMMERWAHR 1972, p. 183.
136
MORETTI 1957, n. 120.
132
218
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
dell’Ellesponto137. La scelta di lasciare Stesagora con Milziade I potrebbe essere dovuta alla
mancanza di figli di quest’ultimo e dunque alla volontà dei due rami dei Filaidi di garantire la
continuità dinastica del potere tirannico in Chersoneso Tracico; oppure, secondo un’altra
ipotesi, Milziade I potrebbe avere trovato utile disporre di un giovane nel fiore degli anni nella
gestione del potere nella penisola e soprattutto nell’affrontare la situazione sempre accesa di
conflitto con Lampsaco. Altrimenti potrebbe essersi trattato di una forma di riorganizzazione
del potere interna alla famiglia: si è messo in evidenza che fino all’ultimo quarto del VI secolo
vi sono indizi che indicherebbero un’intesa interfamiliare dei Pisistratidi con il ramo cipselide
della famiglia dei Filaidi, a cui apparteneva appunto Milziade I, piuttosto che con il ramo
discendente da Stesagora I, padre di Cimone; il trasferimento del giovane Stesagora presso il
semi-zio Milziade I potrebbe dunque interpretarsi come un segno di condivisione del potere e
degli interessi familiari fra i due rami dei Filaidi, deciso fra i due fratelli e al di fuori
dell’ambito di intervento dei Pisistratidi.
Non si dispone di dati sufficienti per datare con precisione o sicurezza né il trapasso della
tirannide da Milziade I a Stesagora, né la morte di Stesagora e la successione di Milziade II e
dunque in genere per datare gli estremi e la durata della tirannide di Stesagora in Chersoneso
Tracico. In base alle notizie sotto analisi, la data della morte di Cimone, il 527, costituisce un
valido terminus post quem per la morte di Milziade I138. D’altro canto un terminus ante quem
per la morte di Stesagora può rintracciarsi al 520 ca. quando si data l’arrivo di Milziade II in
Chersoneso Tracico139. Mi pare inoltre appropriato attribuire una breve durata per la tirannide di
Stesagora: l’intera tradizione storiografica offre scarsissime attestazioni di questo individuo, al
contrario di quanto d’altronde si è conservato per altri membri dei Filaidi; la scarsezza di
notizie è resa ancor più significativa in considerazione del fatto che la sua tirannide in
Chersoneso Tracico non fu pacifica e senza eventi drammatici, ma egli condusse invece la
guerra contro Lampsaco; infine si consideri che egli morì senza generare figli. Concluderei
datando la morte di Milziade e dunque l’avvio della tirannide di Stesagora al 525 ca. e
attribuendo a quest’ultima una durata di circa cinque anni, fino al 520 ca.140.
137
DAVIES 1971, n. 8429 [VIII]; KINZL 2011, s.v. “Miltiades” [1], in BNP. Reperti ceramici ritrovati in Attica
concordano con la datazione qui fornita della presenza di Stesagora in Attica e del momento in cui si sarebbe
trasferito in Chersoneso Tracico: IMMERWAHR 1972; NENCI 1988, ad Hdt. VI 38, p. 202.
138
Hdt. VI 103.4. DAVIES 1971, n. 8429 [VI].
139
KINZL 2011, s.v. “Miltiades” [2], in BNP.
140
KINZL 2011, s.v. “Miltiades” [1], [2], in BNP. CLINTON 1834, p. 26; MACAN, 1895, vol. I, ad Hdt. VI 38, p.
298: fissano il terminus ante quem per la morte di Stesagora al 515 ca. WADE-GERY 1951, pp. 212, 217, 220s. data
la morte di Stesagora e la tirannide di Milziade II al 516.
219
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Continuità dinastica della tirannide e natura del conflitto fra il Chersoneso Tracico e
Lampsaco
Secondo il testo erodoteo, quando Milziade I morì senza figli, egli lasciò il dominio
(arché) e le ricchezze (chrérmata) al nipote Stesagora. L’arché non è da intendersi in altro
modo che come quella forma di controllo politico, sociale e militare che distingue la tirannide
arcaica, non regolato e non identificabile entro una specifica istituzione della polis, ma piuttosto
come una posizione de facto di capacità decisionale e operativa nella direzione della polis. I
chrèmata sono ricchezze mobili da identificarsi con metallo in lingotti o in monete coniate, utili
appunto alla gestione degli emolumenti ai sostenitori politici e ai soldati mercenari agli ordini
del tiranno141. Stesagora eredita dunque la posizione socio-politica di Milziade e i mezzi
economici per mantenerla. Inoltre la notizia relativa alla presenza di Stesagora nel pritaneo in
Chersoneso deve essere accolta come una attestazione della posizione raggiunta da Stesagora
anche all’interno delle istituzioni statali del Chersoneso, almeno nell’anno della sua morte. Il
quadro che prende forma è quello di un passaggio di potere, familiare, tirannico e politico, da
Milziade a Stesagora, senza soluzione di continuità142.
Senza soluzione di continuità rispetto al proprio predecessore si direbbe sia stata anche la
conduzione della politica extra-poleica durante la tirannide di Stesagora: egli portò avanti il
conflitto contro Lampsaco che già aveva impegnato e messo in pericolo Milziade I. Dalla
narrazione erodotea sembrerebbe che il conflitto fosse scoppiato entro poco tempo dalla
fondazione di Milziade I, dunque pochi anni dopo il 558; certamente era in atto prima del 546
poiché il sovrano lidio Creso ebbe modo di intervenire in favore del Filaide143. Stesagora visse
il conflitto certamente nell’epoca della sua morte. Questi dati sono di ordine non secondario al
fine di approfondire la comprensione delle relazioni fra la tirannide filaide del Chersoneso
Tracico e la polis di Lampsaco: si impone infatti di riconoscere il conflitto fra le due parti non
come una guerra campale e continua, ma piuttosto come una prolungata situazione di attrito fra
poleis confinanti e vicendevolmente ostili, che poteva rimanere latente ed erompere in diversi
scontri militari minori e circostanziali144. L’inferenza si impone in virtù dell’ampio arco
temporale fra la prima attestazione delle ostilità, all’epoca del primo periodo di tirannide di
141
Il riferimento a beni mobili è una ulteriore traccia per identificare in questo strumento il mezzo per assicurare ai
tiranni del Chersoneso la loro capacità operativa: di conseguenza si esclude la possibilità che fossero gli esclusivi
proprietari del terreno in Chersoneso e dunque che il Chersoneso Tracico fosse un possedimento familiare dei
Filaidi, ma piuttosto una colonia di diritto comunitario: DAVIES 1971, n. 8429 [XVI].
142
WELLS 1923, pp. 112-124; ISAAC 1976, pp. 170-172; LOUKOPOULOU 2004, p. 901; SCOTT 2005, ad Hdt. VI
38.2, p. 177.
143
ISAAC 1986: p. 170-172.
144
SCOTT 2000, pp. 95-115; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.2, p. 177.
220
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Milziade I, nel 555 ca., e la tirannide di Stesagora, morto nel 520 ca.; ma una guerra
interpoleica di una trentina d’anni avrebbe certo lasciato tracce più evidenti nella storiografia
pervenuta. D’altro canto, si può anche notare che i motivi di contrasto fra la colonia ateniese e
Lampsaco, per il controllo dell’area ellespontica, erano ancora attivi nel 525-520 come a metà
del secolo e non erano giunti ad alcuna soluzione145.
L’internazionalismo dei Filaidi
La breve biografia di Stesagora che si è qui raccolta permette di trarre alcune
considerazioni sulla politica e sulle relazioni internazionali della famiglia dei Filaidi. L’esilio e
il trasferimento di Cimone e dei figli presso la colonia del Chersoneso Tracico e il fatto che
Stesagora vi fosse rimasto sono l’indice che questa famiglia, come le grandi famiglie
aristocratiche operative sul piano internazionale, aveva la capacità di gestire e sfruttare
molteplici posizioni sparse per il mondo greco e di adattarsi a contesti geopolitici distanti e
diversi. Come si è notato nel considerare le iniziative dei Pisistratidi, anche i Filaidi sembrano
avere fatto affidamento in modo organico e organizzato su ciascun membro della famiglia per
gestire e mantenere la propria rete internazionale di posizioni e di interessi, spostando tanto le
risorse quanto gli individui da un luogo ad un altro e affidando ad ognuno il perseguimento o la
difesa di specifici obiettivi.
Per un verso il riferimento alla presenza del pritaneo in Chersoneso Tracico segna
chiaramente l’esistenza di un’istituzione politica statale, cioè di una città-stato e dunque una
vita politica comunitaria; d’altronde proprio la presenza di Stesagora stesso nel pritaneo
potrebbe testimoniare di una forma di controllo delle istituzioni politiche da parte della
tirannide, perlomeno della partecipazione del Filaide all’attività politica146. Malgrado dunque
l’attestazione di un’istituzione politica statale e malgrado il quadro politico che si è in
precedenza delineato per la colonia del Chersoneso Tracico, la maniera incondizionata e fluida
in cui il potere passò in via ereditaria da Milziade I a Stesagora dimostra che il controllo che i
Filaidi esercitarono su coloni e Traci del Chersoneso fu a tutti gli effetti di tipo tirannico e
personale, continuativo, ereditario e dinastico, nonché senza opposizione interna perlomeno
fino al 520 ca.147. Le differenze fra l’opera di Milziade I in qualità di ecista e le modalità in cui
Stesagora prese il potere possono interpretarsi come il segno che la tirannide filaide andò
145
Questo potrebbe costituire uno dei motivi che spinsero Ippia a tentare la soluzione diplomatica conciliatoria
dopo il 514, quando concesse la figlia Archedice in sposa proprio ad Eantide il tiranno di Lampsaco. Vd. infra, pp.
356ss.
146
NENCI 1988, ad Hdt. VI 39, p. 202; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.2, p. 177.
147
ISAAC 1986, p. 170; KINZL 2011, s.v. “Miltiades” [1], in BNP.
221
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
gradualmente spostandosi verso forme più autocratiche148. Il lungo periodo di tirannide di
Milziade I, dal 558 al 520 ca., deve senz’altro avere contribuito a rafforzare le prerogative e
l’influenza del tiranno.
Si è determinato che Stesagora fu trasferito in Chersoneso Tracico in giovane età e perciò
si trovava presso la corte filaide da un quindicennio quando suo zio l’ecista venne a morire: il
giovane avrà certamente avuto l’occasione di venire gradualmente associato al potere personale
di Milziade, di partecipare alla vita politica e istituzionale dello stato e di dimostrare le proprie
capacità organizzative o militari; è stato anche ipotizzato che Milziade I avesse a tutti gli effetti
adottato il nipote e questo sarebbe potuto avvenire dopo la morte di Cimone nel 528/7149. In
questo senso si inquadra la facilità con cui Stesagora ereditò e portò avanti la tirannide filaide in
Chersoneso Tracico.
Fig. 5: il Chersoneso Tracico, le poleis e le fondazioni interessate dall’attività dei Filaidi
148
149
ISAAC 1986, pp. 170-172.
DAVIES 1971, n. 8429 [VII].
222
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
V.5. Milziade II figlio di Cimone
V.5.1. La carriera di Milziade II e l’assunzione della tirannide in Chersoneso Tracico
L’ultimo Filaide che tenne la tirannide in Chersoneso Tracico fu Milziade II, figlio di
Cimone e fratello di Stesagora; dei due fratelli Milziade era il figlio minore. Gli studiosi
valutano che questo Milziade sia nato nel 555 ca.150. Insieme a loro padre Cimone, Milziade e
Stesagora lasciarono Atene nel periodo fra l’instaurazione della tirannide di Pisistrato e la prima
vittoria del padre ad Olimpia (546-536); la famiglia dovette trovare ospitalità presso lo zio
Milziade I in Chersoneso; poi Stesagora, forse perché il primogenito, rimase presso la tirannide
familiare sull’Ellesponto, mentre, dopo un decennio o poco meno di esilio, Milziade II fece
ritorno ad Atene con il padre Cimone quando questi cedette la seconda vittoria olimpica a
Pisistrato nel 532151.
Nel 528-27 Cimone fu assassinato, stando alla narrazione di Erodoto, per mandato dei
Pisistratidi; eppure ad Atene i tiranni riservarono invece un buon trattamento nei confronti di
suo figlio Milziade, come se essi non fossero stati coinvolti nell’assassinio del padre152. Dati
storiografici ed epigrafici consentono di attribuire a questo Milziade II l’arcontato ad Atene
nell’anno 524/3153.
Intorno al 520 Stesagora trovò la morte per mano di un sicario lampsaceno esaltato: i
Pisistratidi subito reagirono inviando in Chersoneso Tracico Milziade II, fratello del tiranno
defunto, a bordo di una trireme, affinché egli assumesse il governo colà154. Giunto in
Chersoneso Tracico, Milziade si ritirò nella casa di famiglia per onorare il fratello morto;
quando ne furono a conoscenza, i Chersonesiti si radunarono da ogni luogo e i capi da tutte le
città (del Chersoneso) si recarono insieme da Milziade come per esibire le loro condoglianze;
ma egli li mise tutti in catene e così tenne in proprio controllo il Chersoneso Tracico,
stipendiando un contingente di 500 mercenari. Milziade poi prese in moglie Egesipile, la figlia
di Oloro il re dei Traci155.
150
WADE-GERY 1951, pp. 212, 220 data la nascita al 550 ca.; DAVIES 1971, n. 8429 [VIII]; KINZL 2011, s.v.
“Miltiades” [2], in BNP.
151
Hdt. VI 103.
152
Hdt. VI 39.1. Ringrazio il Prof. F. Raviola per avere discusso con me la traduzione e l’interpretazione qui
proposta del passo erodoteo, di cui mi assumo comunque la responsabilità.
153
Dion. Hal Ant. Rom. VII, 3.1. IG I3 103 Ia. MERITT 1939, n. 21, pp. 59-65; CADOUX 1948, pp. 90, 109-112, 122;
FORNARA 1983, n. 23, pp. 27s. È appunto sulla base della data dell’arcontato e dell’età minima perché un cittadino
potesse ricoprire quella carica che gli studiosi calcolano la data di nascita di Milziade II intorno al 555 ca.
154
Hdt. VI 39.1.
155
Hdt. VI 39.2. BERVE 1967, pp. 81-85.
223
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
L’intesa interfamiliare fra Pisistratidi e Filaidi nella generazione di Ippia e Milziade II
Nell’esposizione del lògos di cui dispone sui Filaidi, Erodoto utilizza un tono di sorpresa
nel notare l’incoerenza fra il comportamento tenuto dai Pisistratidi nei confronti di Cimone e
poi verso suo figlio Milziade II: l’assassinio del primo, nel 528/7, venne infatti attribuito ai
tiranni ateniesi, eppure Milziade II fu da loro trattato bene (ἐν Ἀθήνῃσι ἐποίευν εὖ) e fu peraltro
di lì a poco scelto per la missione in Chersoneso; Erodoto aggiunge che i Pisistratidi si
comportavano con Milziade “come se non fossero stati implicati nell’assassinio di suo
padre”156. Si è già discussa l’interpretazione secondo cui l’attribuzione dell’assassinio di
Cimone al volere dei Pisistratidi sarebbe una costruzione storiografica anti-tirannica risalente
all’epoca del processo per tirannide contro Milziade II, nel 493: in epoca post-tirannica ad
Atene vi sarebbe stato cioè il tentativo di dissociare la famiglia dall’alleanza con i Pisistratidi e
di assimilare anch’essa, come gli Alcmeonidi, alla fazione anti-tirannica157. Non è d’altronde da
rifiutarsi la storicità di quegli aspetti di accesa competizione nel rapporto fra Pisistrato e
Cimone, evidenti nella notizia dell’esilio e nella vicenda incentrata sulle vittorie olimpiche del
Filaide. Accettare però che nel 528/7 la relazione fra Ippia e Cimone sia degenerata al punto di
giungere fino alla violenza e all’assassinio è del tutto incoerente con il comportamento e la
fiducia che il tiranno dimostrò subito negli anni successivi nei confronti del figlio naturale di
Cimone ed altrettanto incoerente sarebbe stato viceversa il comportamento di Milziade II nei
confronti di colui che avrebbe dovuto essere l’assassino di suo padre.
Il trattamento favorevole che Erodoto menziona essere stato riservato dai Pisistratidi a
Milziade II trova un riscontro sia storiografico che epigrafico che dimostra che questi ricoprì
l’arcontato nel 524/3158. Il controllo che la tirannide esercitò sullo stato fu perlopiù di natura
informale e indiretta e la tradizione attribuisce proprio ai Pisistratidi il merito di non avere
alterato le istituzioni cittadine; la medesima tradizione asserisce però che i tiranni si
assicurarono che le cariche civiche fossero assegnate ad individui a loro associati159. In questo
senso dunque il quadro che l’epigrafia tramanda di un’alternanza fra le famiglie aristocratiche
più importanti alla carica dell’arcontato deve considerarsi, in genere, come il segno di una
tendenza conciliatoria nella gestione della politica interna di Ippia. Nel 525/24 fu arconte
eponimo Clistene: il dato è da considerarsi come l’indice di una apertura conciliatoria di Ippia
156
Hdt. VI 39.1.
WADE-GERY 1951, pp. 216-218; CULASSO GASTALDI 1996, pp. 507-509; DUPLOUY 1996, pp. 63s., 84s.
158
Hdt. VI 39; Dion. Hal Ant. Rom. VII, 3.1. IG I3 103 Ia. TOD 1933, n. 8; MERITT 1939, n. 21, pp. 59-65;
CADOUX 1948, pp. 90, 109-112, 122; ANDREWES 1958, pp. 111-114; KINZL 1976; FORNARA 1983, n. 23, pp. 27s.;
MEIGGS-LEWIS 1989, n. 6 associano esplicitamente le parole di Erodoto alla carica dell’arcontato di Milziade II;
KEEN 2006, p. 66.
159
Thuc. VI 54.6. JEFFERY 1976, pp. 39-45; ANDERSON 2005; DUPLOUY 2006, pp. 11-35.
157
224
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
verso gli Alcmeonidi160. Nel caso dell’arcontato, l’anno successivo, di Milziade II, il dato è da
accogliersi come il segno della continuazione, entro la gestione del potere politico locale, della
relazione d’intesa fra Pisistratidi e Filaidi avviata nella generazione precedente161.
A distanza di pochi anni dall’arcontato di Milziade II ad Atene, Stesagora che comandava
la tirannide in Chersoneso Tracico venne a morire nel 520 ca. Questo vuoto di potere costituì
sia un’emergenza dinastica filaide, sia un’emergenza politico-strategica per i tiranni di Atene:
nel quadro delle relazioni costruttive fra Ippia e Milziade, la narrazione della fonte evidenzia
appunto sia il coinvolgimento decisionale di Ippia, sia il ruolo attivo di Milziade162. Nelle
circostanze della morte di Stesagora in Chersoneso Tracico, sede in effetti di una tirannide
familiare da due generazioni, ci si sarebbe verosimilmente potuto aspettare la riunione di un
consesso di parenti autorevoli di Stesagora e dei Filaidi per deliberare sul da farsi163: perciò
risulta significativa la posizione decisionale che viene riservata a Ippia.
Erodoto afferma che furono i Pisistratidi, cioè Ippia, a mandare Milziade in Chersoneso; il
verbo a)poste/llw, che viene utilizzato nel passo, ha il senso fondamentale di “mandare” o
“inviare”, ma è significativo che compaia anche in circostanze relative all’invio di messaggi,
messaggeri, contingenti di uomini e armati: dunque non è da escludersi l’ambito semantico di
una operazione strategica e politico-militare164.
Il testo erodoteo è esplicito nel delineare il proposito con cui Ippia affida la missione a
Milziade: egli viene inviato per “prendere possesso degli affari in Chersoneso Tracico”
(καταλαµψόµενον τὰ πρήγµατα ἐπὶ Χερσονήσου)165. La precedente missione dell’omonimo zio
di questo Filaide è stata classificata in questa ricerca, in base anche ad un’analisi lessicale,
piuttosto nell’ambito di una fondazione coloniale nella quale l’ecista acquisì e mantenne
prestigio, prerogative e potere personale superiori al consueto; la breve tirannide di Stesagora fu
poi una naturale successione dinastica. La presa del potere da parte di Milziade II sembra vada
piuttosto interpretata come un’iniziativa di forza, propriamente tirannica nel senso classico del
termine, imposta agli abitanti del Chersoneso Tracico dall’esterno e contro il loro volere166.
160
IG I3 103 Ia. TOD 1933, n. 8; MERITT 1939, n. 21, pp. 59-65; CADOUX 1948, pp. 90, 109-112, 122; ANDREWES
1958, pp. 112-117.
161
WADE-GERY 1951, pp. 214, 217-219; DAVIES 1971, n. 8429 [VIII.B], p. 301; ]KEEN 2000, pp. 66s.
162
KEEN 2000, pp. 66s.
163
Pure in risposta a necessità diverse da quelle che interessarono il Chersoneso e Stesagora, un consesso familiare
ebbe luogo fra i Pisistratidi quando fu decisa la strategia da seguire alla fine dell’esilio in Tracia alla vigilia del
546.
164
KEEN 2000, pp. 66s.
165
Hdt. VI 39.1.
166
HAMMOND 1956, p. 123.
225
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Ippia affida a Milziade una trireme (trih/rhj) per compiere il viaggio e, verosimilmente,
da aggiungere poi alle forze navali che fossero già del Chersoneso Tracico167. Si fa menzione
qui di un’imbarcazione militare di tipo specifico, giacché la fonte avrebbe altrimenti usato il
termine di ναῦς nel caso di una imbarcazione da trasporto generica. Potrebbe trattarsi di un
anacronismo di Erodoto, il cui pubblico di V secolo conosceva quel modello di imbarcazione
come principale strumento dell’egemonia attraverso i mari; nondimeno la diffusione delle
attestazioni letterarie e iconografiche di triremi già in epoca arcaica, e ancor più chiaramente
nel periodo ora in questione della fine del VI secolo, porta a rifiutare con sicurezza questa
obiezione168. La trireme era un tipo di nave precipuamente destinata ad operazioni militari,
progettata per disporre di grande manovrabilità e velocità negli scontri sul mare contro altre
navi, ed aveva dunque una funzione militare univoca e specializzata; la costruzione e il
mantenimento di triremi richiedevano materie prime e risorse finanziarie ingenti, infrastrutture
ed equipaggi specializzati: in base a queste caratteristiche si tende ad escludere che privati
aristocratici costruissero e disponessero di triremi, e che il coinvolgimento, perlomeno parziale,
dell’iniziativa statale fosse indispensabile169. Ippia dunque ebbe accesso a questa risorsa
militare della polis, e la affidò poi all’alleato Milziade, in virtù sia del controllo tirannico che
esercitava sullo stato, sia dell’interesse pubblico che l’iniziativa in Chersoneso Tracico
ricopriva170.
167
HAMMOND 1956, p. 123; SCOTT 2000, pp. 93-115.
Hdt. II 159; III 4, 44, 136, V 32, 38, 47, 85, 99, 112, VI 5, 8; Thuc. I 13s.; Nic. Dam. FGrHist 90 F 59 Muller
(= F 60 Jacoby); Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 147a Helm; Suda, s.v. Περίανδρος, P 1068. URE 1922, pp. 321-331;
HAAS 1985; MEIJER 1988; HORNBLOWER 1997, ad Thuc. I 13, pp. 41-47; SALMON 1997, p. 135; COATESMORRISON-RANKOV 2000, pp. 25-49; GREAVES 2000, pp. 49-53; JACKSON 2000, pp. 143s.; SCOTT 2000;
SCHNEIDER 2010, s.v. “Trireme”, in BNP; TILLEY 2010, s.v. “Trireme”, in BNP.
169
Vero è che la critica non concorda unanimemente su questa interpretazione proprio nei casi, come quello ora
discusso, in cui le fonti menzionano singole triremi o numeri esigui di queste imbarcazioni; in questo senso sono
attestati casi espliciti di triremi di proprietà individuale: Filippo di Crotone (Hdt. V 47) e l’Ateniese Clinia (Hdt.
VIII 17). Nel caso della singola trireme affidata da Ippia a Milziade II potrebbe dunque trattarsi di una trireme di
proprietà privata, del tiranno o di Milziade, entrambi in effetti individui di ampie risorse economiche ed interessi
marittimi. La questione rientra però piuttosto nella storia della sviluppo delle istituzioni poleiche piuttosto che in
quella delle relazioni internazionali: mi limito dunque ora ad inserirla in quel novero di attestazioni e di attività
peculiari alla tirannide per le quali l’ambito privato e quello pubblico risulta di difficile distinzione. URE 1922, p.
239; HAAS 1985; COATES-MORRISON-RANKOV 2000, pp. 25-49; SCOTT 2000; SCHNEIDER 2010, s.v. “Trireme”, in
BNP; TILLER 2010, s.v. “Trireme”, in BNP. È stato notato che questo passo costituisce la prima attestazione
storiografica della presenza di triremi ad Atene o presso gli Ateniesi.
170
SCOTT 2000.
168
226
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Fig. 6: trireme Olympias varata dalla marina militare greca nel 1987
<http://www.hellenicnavy.gr>
Si può concludere con sicurezza che, perlomeno fino a queste circostanze del 520 ca.,
perdurò tra Ippia e Milziade II quell’intesa interfamiliare di lungo periodo fra Pisistratidi e
Filaidi nella conduzione delle relazioni e della politica internazionale che la presente ricerca ha
messo in luce in numerose occasioni fin da prima dell’avvio del potere tirannico di Pisistrato ad
Atene. Come si è visto, questa intesa fra le famiglie era volta alla preservazione delle
reciproche posizioni di potere in Atene, ma soprattutto fu funzionale al perseguimento di una
concorde linea di politica estera, indirizzata essenzialmente al controllo navale delle rotte per
l’Ellesponto171. La spedizione coloniale di Milziade I in Chersoneso Tracico è stata riconosciuta
come un’impresa pubblica, decisa dalla direzione politica di Pisistrato, organizzata
congiuntamente fra il tiranno e Milziade e affidata alla gestione diretta, sul luogo, dei Filaidi. Il
quadro che emerge dall’analisi della vicenda di Milziade II ad Atene e dalle tracce delle
relazioni con il tiranno Ippia giustifica una interpretazione in tutto affine alla relazione che a
suo tempo aveva legato Pisistrato all’omonimo Filaide e che si perpetuò dunque linearmente
nella generazione successiva. L’analisi finora condotta sul testo fornisce molteplici elementi a
questa ricostruzione: il ruolo decisionale di Ippia negli affari dei Filaidi, la favorevole carriera
politica di Milziade II durante la tirannide, la fiducia dimostrata da Ippia nei confronti di
Milziade II nell’affidargli la missione in Chersoneso e nel dotarlo di risorse navali. Vero è che
la scelta di Milziade II nell’affidamento del potere in Chersoneso Tracico fu una scelta quasi
obbligata in virtù della tradizione tirannica incontrastata che i Filaidi godevano
nell’insediamento, fra i coloni e fra i locali. Eppure è innegabile che la narrazione mostra che
Ippia godeva di una misura di libertà operativa, o perlomeno organizzativa, anche in quelle
circostanze: perciò se questa fu applicata in favore di Milziade II è da intendersi come il segno
171
WELLS 1923, pp. 112-124.
227
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
che il tiranno riponeva la propria fiducia in quel Filaide. Viceversa Ippia non avrebbe avuto
l’autorità e i mezzi per gestire a distanza la successione dinastica della tirannide del Chersoneso
Tracico qualora non avesse goduto dell’approvazione e dell’alleanza dei Filaidi172.
Come nella generazione precedente, di Pisistrato e Milziade I, anche nel 520 ca. la
missione in Chersoneso Tracico fu un’operazione decisa e gestita in accordo fra gli esponenti
delle due famiglie. Anche nel 520 ca. Filaidi e Pisistratidi condividevano interessi personali
negli insediamenti all’imbocco dell’Ellesponto, nonché una affine politica espansionistica
navale verso le rotte di quelle aree marittime. Anche nel 520 ca. il tiranno e il Filaide agirono
non solo seguendo un progetto politico familiare, ma anche in osservanza degli interessi
internazionali della polis di Atene173. L’insediamento del Chersoneso, fondato da Milziade I nel
558 ca., fu effettivamente una colonia ateniese: perciò in virtù dei contatti fra madrepatria e
colonia e dei vantaggi economici e navali che gli Ateniesi potevano ricavare da quella posizione
sull’Ellesponto fu certo importante anche per la comunità mantenere un controllo efficiente sul
governo del Chersoneso Tracico174. La stessa polis di Atene dimostra di perseguire una politica
estera di lunghissimo periodo mirante a controllare l’Ellesponto e a preservare per sé la rotta
che dall’Attica vi conduceva175. In questo senso si intende il ruolo direttivo del tiranno, quale
motore principale delle scelte politiche dello stato, nell’organizzazione della spedizione di
Milziade I: dunque in virtù del coinvolgimento degli interessi della polis si giustificano quegli
aspetti strategico-militari rilevabili dal lessico erodoteo e soprattutto dalla menzione della
trireme fra le risorse impiegate.
V.5.2. Milziade II e il conflitto con i dinasti del Chersoneso
La narrazione erodotea dei fatti che si susseguirono all’arrivo di Milziade II in Chersoneso
Tracico merita una rilettura attenta in virtù degli episodi drammatici che si verificarono e con
l’obiettivo di estrarne una ricostruzione storica della situazione politica dell’insediamento e
della posizione della tirannide di Milziade II. L’ordine narrativo seguito da Erodoto implica che
Milziade II abbia preso dimora nella casa di famiglia (òikos) e che dopo poco la notizia del suo
arrivo si sia diffusa nelle poleis della penisola; in reazione i Chersonesiti, specificamente i
dinasti al potere, da tutte le città si radunarono (συνελέχθησαν ἀπὸ πασέων τῶν πολίων οἱ
172
MAZZARINO 1939; KEEN 2000, pp. 66s.
WELLS 1923, pp. 112-124; KINZL 2011, s.v. “Miltiades” [2], in BNP.
174
Non è questa la sede per discutere la pure peculiare posizione giuridica delle colonie di Atene nei confronti
della madrepatria; si consideri però che nel 493 il Chersoneso Tracico sembra fosse considerato dagli Ateniesi
stessi come territorio attico: Hdt. VI 140. KEEN 2000, pp. 66s.
175
Hdt. VI 140; Diod. Sic. X 19.6. WELLS 1923, pp. 112-124; GRAHAM 1964; DAVIES 1997, pp. 134s.
173
228
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
δυναστεύοντες πάντοθεν) con lo scopo di dirigersi insieme alla dimora di Milziade per porgere
le loro dimostrazioni di cordoglio176.
Situazione politico-sociale del Chersoneso Tracico nel 520 ca.: poleis e dinasti locali
La lettera del testo è significativa in quanto, pur in poche parole, fornisce importanti
informazioni sulle condizioni sociali e politiche del Chersoneso Tracico in quel momento. Nel
520 ca. il territorio sembra essere stato caratterizzato da un numero di insediamenti definiti
dalla fonte come delle poleis: cioè delle città-stato, con un nucleo urbano e un territorio
afferente, autonome e dotate di proprie istituzioni politiche. La tradizione coloniale eolica
risalente al VII secolo, nonché il trentennio trascorso dall’insediamento dei primi coloni
ateniesi al seguito di Milziade I corroborano questo quadro dell’antropizzazione del territorio
per l’epoca dell’arrivo di Milziade II177. I dinasti menzionati nel testo sono da intendersi come
uno strato sociale di natura aristocratica, numericamente ristretto, detentore del potere politico e
decisionale all’interno delle proprie comunità. Il sostantivo è fondato sul verbo dynastéuo, che
ha il significato di “avere il potere”, “essere influente”, “prevalere”: il termine cioè non
identifica un’istituzione o una carica politica, ma piuttosto una condizione di capacità di
intervento entro la comunità, di operatività politica in senso lato; l’analisi semantica in questo
senso concorda con le attestazioni d’uso nelle fonti. Dunque i dinasti del Chersoneso non
sembrano avere costituito un gruppo di magistrati propriamente istituzionalizzati, ma piuttosto
un insieme generico di individui altolocati con attivi interessi politici e capaci di dirigere i
concittadini e la gestione del territorio178.
Se da un lato il Chersoneso Tracico sembra configurarsi come un territorio coloniale di
piccole poleis governate da regimi aristocratici debolmente istituzionalizzati, per altro verso la
storia della tirannide dei Filaidi aggiunge a questo quadro la presenza di una forma di
organizzazione sovra-poleica regionale affidata all’ecista Milziade I e poi ereditata dai suoi
successori in virtù del potere personale, del prestigio, delle capacità di comando e delle risorse
della famiglia. È stato possibile identificare un centro urbano di maggiore importanza rispetto
agli altri, denominato Chersonesos/Cherronesos, ove certamente esistevano istituzioni politiche
(nelle fonti è citato il pritaneo) su cui e tramite le quali i Filaidi imponevano il proprio controllo
ed esercitavano la tirannide179: verosimilmente questa era anche la sede dell’òikos dei Filaidi e
176
Hdt. VI 39.
Hdt. VII 58; Ps. Scymn. 698-710; Strab. VII fr. 50; Ephor. Fr. 40. HAAS 1985, pp. 40-44; ISAAC 1986, pp. 159175; NENCI 1988, ad Hdt. VI 39; LOUKOPOULOU 2004, pp. 900-911.
178
Hdt. IX 2.3; Thuc. VI 89; Isocr. Panath. 12.82. LOUKOPOULOU 2004, pp. 900-911; MORLEY 2008, pp. 133-138.
179
Hecat. FGrHist 1 F 163; Hdt. VII 58.2, VI 38.2.; Ps. Scyl. 67; Demosth. De Halonn. 7.39. IG I3 259.II.28,
268.II.7. LOUKOPOULOU 2004, n. 661, pp. 900-911; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.2, p. 177.
177
229
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
dunque il luogo ove Milziade II restava in lutto e verso cui si diressero gli aristocratici
chersonesiti.
L’opposizione aristocratica ellenica locale e l’involuzione autocratica della tirannide di
Milziade II
Stando alla narrazione di Erodoto, la spedizione dei dinasti chersonesiti aveva il pietoso
scopo di portare le condoglianze a Milziade II; eppure il nuovo tiranno reagì imprigionandoli
tutti (δέω: lett. “mettere in catene”) e proprio anzi in conseguenza di questa iniziativa fulminea,
e del fatto di disporre di un esercito mercenario di 500 uomini, Milziade II tenne in proprio
potere (ìscho) il Chersoneso Tracico. Questi comportamenti drammatici, violenti e fra loro
discordanti meritano una riflessione e una contestualizzazione storica180.
Si è determinato che nel 520 ca. il Chersoneso Tracico poteva avere raggiunto un naturale
grado di antropizzazione e sviluppo politico, con poleis autonome e una propria classe dirigente
aristocratica; a questo si aggiunga che nel trentennio dalla fondazione coloniale ateniese era
andata montando l’importanza del territorio nella regione dell’Ellesponto181: in questo contesto
è verosimile che le classi dirigenti locali avessero per allora preso coscienza del proprio ruolo e
auspicassero cambiamenti in direzione di una maggiore autonomia nelle forme di governo e
nelle relazioni nei confronti dei fondatori della colonia. Da un'altra prospettiva, in quel
momento la tirannide dei Filaidi giungeva alla seconda generazione e al terzo tiranno e poteva
apparire come una forma di controllo e organizzazione ormai non necessaria. Milziade I aveva
infatti avuto il prestigioso ruolo di ecista, cruciale per l’organizzazione civica e militare;
Stesagora aveva preso parte al governo dello zio da anni prima di salire egli stesso al potere e la
sua tirannide può essere sembrata fisiologia e accettabile; non è secondario il fatto che egli poté
disporre del tempo e delle opportunità per creare intorno a sé un circolo di sostenitori politici
locali182. Di fronte alla società e alla classe politica del Chersoneso, Milziade II risultava invece
in effetti come una presenza estranea, nuova, che giungeva dall’esterno e per mandato di poteri
che avevano ormai pochi contatti con la realtà locale; unico diritto che egli poteva vantare era la
parentela con il precedente tiranno; i mezzi di cui poteva servirsi per far valere quel diritto
erano quelli procuratisi da sé e affidatigli da Ippia, ma mancava di una solida rete di legami
personali e politici nel Chersoneso Tracico183. È noto inoltre che il modello storico delle
tirannidi arcaiche mostra nella stragrande maggioranza dei casi una durata massima di due
180
HAMMOND 1956, p. 123.
WELLS 1923, pp. 112-124.
182
SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.1-2, pp. 174-177.
183
HAMMOND 1956, p. 118; ISAAC 1986, pp. 170-172.
181
230
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
generazioni184. Il quadro che si sviluppa da queste premesse mostra che il ruolo di potere paraistituzionale e personale che Milziade II veniva a ricoprire in Chersoneso Tracico aveva ormai
perduto la propria ragione d’essere e la propria giustificazione di fronte all’aristocrazia locale.
Nelle condizioni politiche e sociale in cui versava il Chersoneso Tracico e in base alle
premesse finora analizzate, quando Stesagora morì senza lasciare discendenti è del tutto logico
che gli aristocratici locali si attendessero la fine dello strapotere dei Filaidi e l’opportunità di
rimaneggiare secondo forme a loro più consone gli equilibri del poter politico e gestionale del
territorio. Invece Ippia e Milziade II fra loro d’intesa ad Atene reagirono velocemente alla crisi
dinastica, decisero l’invio di Milziade II in Chersoneso Tracico e disposero l’utilizzo di una
fulminea trireme da guerra per compiere il viaggio. Stando alla narrazione di Erodoto, gli eventi
si accavallarono drammatici nel breve tempo di un mese: Stesagora fu assassinato e Milziade II
lasciò presto Atene; nel proprio òikos a Chersonesos provvide alle onoranze funebri per il
fratello; quando i Chersonesiti vennero a conoscenza dei fatti, organizzarono la collettiva
dimostrazione di condoglianze e giunsero alle porte della casa di Milziade II, egli ancora
osservava il lutto per Stesagora185.
Dalla narrazione erodotea si può giungere in conclusione a ricavare la ricostruzione della
vicenda storica e delle sue cause e implicazioni politiche. Quando si verificò la crisi dinastica
nella famiglia dei Filaidi, i notabili delle poleis del Chersoneso Tracico si riunirono per dirigersi
insieme verso il centro politico e gestionale del potere, a Chersonesos, alle porte della casa della
famiglia tirannica, ove da poco era giunto Milziade II da Atene: il proposito era però
verosimilmente quello di spodestare Milziade II dalla posizione di potere, o altresì
genericamente imporre il proprio peso politico e la propria autonomia contro il nuovo tiranno, e
dividere e concordare fra loro su nuove basi l’accesso al potere politico186. Solo reinterpretando
il proposito dei dinasti e solo postulando un’immediata, o perfino pregressa, situazione di
pericolo e conflitto fra Milziade II e i capi chersonesiti lo svolgimento degli eventi e la reazione
violenta di Milziade hanno una spiegazione razionale. Ippia e Milziade II dovevano avere
chiara fin dalla sua partenza da Atene la situazione che il Filaide avrebbe potuto trovare al suo
184
Aristot. Pol. V 13 (1312b 21-25; 1315b11–18, 21–39). URE 1922, p. 306; WILL 1955, pp. 504s.; ANDREWES
1958, p. 20; MORRIS 1987, p. 25; MCGLEW 1993, pp. 83-85; 133s.; MURRAY 1996, p. 169; LAVELLE 1997;
DILLON-GARLAND 2000, pp. 34s., 66; BUDIN 2004, pp. 192s.; BRODY-MURRAY-SACKS 2005, s.v. “Tyrants”, p.
357.
185
Il perìdeipnon, banchetto nel quale i parenti onoravano il morto, si teneva nel terzo giorno dalla sepoltura e
poteva essere ripetuto nel nono e nel trentesimo giorno. A questo rituale si dovrà riferire l’azione di Milziade II in
onore del fratello morto menzionata in Hdt. VI 39.2. BRUIT ZAIDMAN – SCHMITT PANTEL 1992, pp. 93-99;
KIERDORF 2011, s.v. “Perideipnon”, in BNP.
186
In questo senso il participio sulluphqhso/menoi preceduto da w(j usato da Erodoto (Hdt. VI 39.2) nel
descrivere il proposito pietistico dei Chersonesiti può dare adito alla traduzione con “come per dimostrare il loro
cordoglio”, finanche “fare finta di dimostrare il loro cordoglio”.
231
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
arrivo: perciò questi sfruttò abilmente le circostanze di quella minacciosa riunione dei notabili
per operare un colpo di mano violento, atterrire la resistenza delle aristocrazie locali e
consolidare la propria posizione personale187.
L’iniziativa di catturare e imprigionare i capi politici locali può a mio avviso assimilarsi
ad altre circostanze in cui i tiranni reagirono violentemente di fronte agli avversari politici
aristocratici, non necessariamente giungendo a delle uccisioni, ma piuttosto imponendo esili,
oppure prendendo in ostaggio membri delle famiglie degli oppositori. I dinasti che Milziade
imprigionò erano soggetti politici attivi e cruciali entro le rispettive poleis ed erano inoltre
membri importanti delle rispettive famiglie. La possibilità di tenere questi individui in proprio
potere offriva a Milziade il vantaggio di scardinare l’opposizione e la gestione politica nelle
città del Chersoneso, rendendo viceversa funzionale il suo ruolo tirannico di governo.
Altrettanto vantaggiosa era la possibilità di controllare e reprimere gli altri componenti delle
famiglie aristocratiche con la minaccia di ritorsioni sui prigionieri.
Dopo l’imprigionamento dei notabili locali la seguente iniziativa di Milziade II fu di
dotarsi di un contingente di 500 mercenari (epìkouroi), probabilmente di origine trace188. Il
modello storico del fenomeno della tirannide dimostra anche in altri casi il ricorso a questa
risorsa militare, quasi sempre in generazioni tiranniche successive alla prima e volta sempre alla
preservazione del potere personale contro l’opposizione degli avversari aristocratici locali, mai
invece in funzione di operazioni militari contro nemici esterni189. Né per Milziade I, né per
Stesagora vi fu la necessità di disporre di un corpo di guardia di questo tipo, o almeno così pare;
di fronte invece all’opposizione politica anti-tirannica che Milziade II si ritrovò a dover gestire,
il corpo di guardia divenne uno strumento necessario per imporre con la forza il suo controllo
sul territorio. A questa risorsa militare si aggiunga quella trireme con cui Ippia aveva
previdentemente mandato Milziade II in Chersoneso e quelle costruite e mantenute negli anni
successivi colà190. Esito infine di questi eventi e di queste iniziative fu dunque che Milziade II
tenne in proprio controllo il Chersoneso Tracico. Il verbo usato da Erodoto, ìscho, si traduce
con “tenere”, “tenere in proprio possesso”, oppure anche “frenare, bloccare, reprimere” e
fornisce dunque anch’esso un rimando a mezzi violenti piuttosto che a strumenti politici o
consensuali.
187
HAMMOND 1956, p. 123.
BRAUND 2001, pp. 14s. Contra ISAAC 1986, pp. 170-172.
189
Aristot. Pol. V 6 (1036a), V 10 (1310b-1311b); Diod. Sic. VI fr. 10; Polyaen. V 1.1. ANDREWES 1958, pp. 4953 per il caso analogo della prima e seconda generazione dei tiranni Cipselidi di Corinto.
190
Hdt. VI 39.1. Quando Milziade II lasciò il Chersoneso Tracico nel 493 egli poté disporre almeno di cinque
triremi: Hdt. VI 41.1. HAMMOND 1956, p. 123; BETTALLI 1995, p. 91; SCOTT 2000.
188
232
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
In conclusione la tirannide istituita da Milziade II in Chersoneso Tracico trovò subito
un’opposizione locale, organizzata e comune; reagendo al pericolo di una trasformazione
politica e della perdita dei privilegi tirannici, la scelta quasi naturale di Milziade II fu di fare
ricorso a iniziative violente e a risorse militari, cosicché l’ultima tirannide filaide assunse
carattere oppressivo191. La violenza che il Filaide dovette esercitare e le risorse economiche e
militari che dovette impiegare per conservare il potere contribuiscono a mettere in luce
l’importanza che il Chersoneso Tracico doveva avere entro gli interessi dei Filaidi, nonché dei
Pisistratidi e di Atene192. Per Milziade II era in gioco un territorio che, pur essendo antropizzato
da città-stato e pur essendo una colonia di Atene, egli doveva comunque considerare un luogo
di pertinenza familiare, una necessaria posizione sicura di potere e rifugio contro avversari
politici ad Atene o nell’Egeo. Sul piano strettamente materiale non doveva essere un movente
di secondo ordine per Milziade la volontà di preservare i terreni e i beni di proprietà familiare
accumulati dai predecessori nel ricco territorio cerealicolo del Chersoneso Tracico193. Per
Milziade II era imprescindibile ristabilire il controllo che per due generazioni la sua famiglia
aveva detenuto di diritto sulla penisola.
Ippia non aveva interessi personali in Chersoneso; nondimeno, in quanto detentore del
potere sovrano ad Atene, su di lui ricadeva la responsabilità di assicurarsi che la polis non
perdesse il contatto e il controllo sulla colonia che era stata fondata appena una generazione
avanti. La posizione del Chersoneso era vitale per mantenere la strategia marittima verso cui
Pisistrato prima e Ippia poi avevano diretto la politica estera ateniese, indirizzata alla
navigazione verso l’Ellesponto e da là verso l’areale commerciale del Ponto Eusino. La
posizione tirannica dei Filaidi in Chersoneso Tracico risultava funzionale al controllo della
politica estera delle poleis locali: tramite il patto fra Pisistratidi e Filaidi si manteneva cioè il
controllo della madrepatria ateniese sui coloni chersonesiti194. La crisi dinastica in Chersoneso
rischiava di provocare la rottura di questa catena di relazioni di alleanza e dipendenza e le
poleis del Chersoneso avrebbero potuto non avere più interesse a mantenere rapporti aperti o
costruttivi con la madrepatria Atene; nell’area rimaneva vivo il pericolo dell’annoso scontro fra
l’insediamento ateniese e l’avversaria Lampsaco; sul versante asiatico dell’imbocco
dell’Ellesponto la colonia pisistratide di Sigeo aveva un contenzioso aperto con Mitilene di
Lesbo; a loro volta gli Eoli di Lesbo e della Troade avevano certo percepito come una
intrusione l’arrivo degli Ateniesi a Sigeo e in Chersoneso; il fertile Chersoneso Tracico vantava
191
HAMMOND 1956, p. 118, 123; ISAAC 1986, pp. 170-172; BETTALLI 1995, p. 91.
WELLS 1923, pp. 112-124.
193
SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.1, p. 175.
194
WELLS 1923, pp. 113-118; HOW-WELLS 1928, app. XVI.8.
192
233
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
un sicuro surplus di risorse cerealicole su cui Atene intendeva fare affidamento in circostanze di
necessità. Tutti questi fattori insieme giustificano appieno la volontà di Ippia e della classe di
governo ateniese di mantenere uno stretto controllo sul Chersoneso Tracico, contro gli interessi
autonomistici dell’aristocrazia locale. Così la reazione violenta di Milziade II di fronte ai dinasti
chersonesiti trovò un movente razionale anche entro il quadro delle relazioni internazionali
tiranniche195.
Gli eventi qui analizzati si realizzano dunque su due livelli: sul piano delle individualità e
della biografia dei tiranni sono attivi gli interessi e i progetti personali di Ippia e soprattutto di
Milziade II; sul piano politico e della storia delle poleis sono d’altronde in azione le necessità e
le posizioni internazionali delle comunità civiche di Atene da un lato e dei Chersonesiti
dall’altro196. Sotto quest’ultimo punto di vista la vicenda rientra nella questione storica della
comprensione delle relazioni fra madrepatria e colonia; è noto peraltro che i territori oltremare
di Atene ebbero sempre uno status non del tutto indipendente, come fu invece il caso usuale
nelle colonie: così si nota per il territorio di Salamina, oppure per le fondazioni delle cleruchie
come quella in Eubea; le fonti dimostrano proprio per il Chersoneso tracico un’ambiguità
ricorrente nel considerare il territorio come suolo ateniese piuttosto che come una colonia
indipendente197. Il rapporto stretto e il controllo dinastico che Atene sembra interessata a
preservare con i propri insediamenti oltremare sembra peraltro ricalcare da vicino il modello
storico della colonizzazione corinzia all’epoca della tirannide di Cipselo e di Periandro198.
Stesagora tiranno indesiderato
La riflessione sull’opposizione da parte dei Chersonesiti alla tirannide di Milziade II porta
a sollevare dei dubbi su alcuni aspetti emblematici della morte violenta di Stesagora. L’ecista
Milziade I aveva avuto il pieno appoggio dei propri concittadini, tanto quelli di origine ateniese
quanto i Traci autoctoni, e fu onorato dai Chersonesiti dopo la propria morte. Di Stesagora non
sono pervenute informazioni in merito al rapporto costruito con i propri concittadini. Nei
confronti di Milziade II i Chersonesiti dimostrarono invece un’accesa animosità fin dai
primissimi momenti tanto che lo stesso Milziade aveva lasciato Atene preparato forse ad
affrontare l’opposizione anti-tirannica locale e ad agire con violenta risoluzione in brevissimo
tempo dal suo primo insediamento in Chersoneso Tracico. Se si accetta di attribuire quei
195
GRAHAM 1964, pp. 34-36.
WELLS 1923, pp. 112-118.
197
Hdt, VI 140. GOMME 1937; GRAHAM 1964, pp. 32, 34-37, 166s.; ANDREWES 1982 a, pp. 405, 415s.; LAVELLE
2005, pp. 32s.; MORENO 2007, pp. 77ss.
198
GWYNN 1918, pp. 117s.; WILL 1955, pp. 373, 517-539; ANDREWES 1958, pp. 49-53; GRAHAM 1964, pp. 118153; SALMON 1997, pp. 209-218; LAVELLE 2010, s.v. “Tyranny”, in BNP.
196
234
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
moventi socio-politici, economici e strutturali sopra indagati all’avversione dimostrata dai
Chersonesiti alla tirannide filaide nel 520 ca. e non si limita dunque la ricerca delle cause alla
circostanziale animosità contro la persona stessa di Milziade II, è ragionevole allora ritenere che
la rottura dell’intesa fra i tiranni e i Chersonesiti sia avvenuta secondo un processo storico
graduale e dunque che fosse già avviata nel corso della breve tirannide di Stesagora.
Erodoto preserva la nozione che l’eclatante assassinio di Stesagora sarebbe stata opera di
un sedicente ed esaltato disertore lampsaceno. Il tiranno fu ucciso da un colpo di ascia: un’arma
nondimeno che si accompagna a profondi significati simbolici e rituali legati alla sfera religiosa
e morale. Anche il luogo in cui avvenne l’aggressione mortale, il pritaneo, è altamente
significativo: questo costituiva uno dei luoghi cardinali delle attività politiche e civiche della
polis, era sede del focolare comune e luogo di rappresentanza della comunità, dunque anch’esso
carico di significato simbolico199. La preparazione nascosta dell’assassinio di Stesagora, il
chiaro proposito di caricare quel gesto di significati simbolici eppure noti ai cittadini, nonché la
scelta di un luogo pubblico e centrale della polis per agire sono tutte caratteristiche che
benissimo si adatterebbero alle forme d’azione di un tirannicidio, di una iniziativa cioè antitirannica organizzata dagli avversari politici, volta a vendicare l’oppressione tirannica e a
provocare un cambio nelle famiglie di governo200.
Si dispone a mio avviso di dati non sufficienti a rivedere la communis opinio e la
narrazione preservata dalle fonti storiografiche; eppure sono argomenti bastevoli ad alimentare
il dubbio sulla veridicità delle informazioni giunte all’attenzione di Erodoto. L’opposizione dei
Chersonesiti ai Filaidi potrebbe facilmente essere sorta e giunta ad un momento di crisi già
durante il governo di Stesagora; secondo l’interpretazione che si sta proponendo, questi sarebbe
stato assassinato non da un Lampsaceno esaltato, ma da un sicario arruolato a bella posta in una
congiura ordita da oppositori politici Chersonesiti: si spiegherebbe così quel carattere di
emergenza riconosciuto nell’invio di Milziade II da Atene e soprattutto il manifestarsi subitaneo
della violenza del Filaide contro gli avversari politici locali201.
Le fonti di cui Erodoto dispose nel V secolo in merito a quelle vicende sarebbero state
inquinate, come già si è avuto modo di discutere, nel corso del processo per tirannide intentato
contro Milziade II al suo rientro in Atene nel 493, con lo scopo di dare forma a un’immagine
dei Filaidi distante dall’alleanza con i Pisistratidi, aliena dalle forme tiranniche autoritarie e
invece vicina al popolo della nuova polis democratica. Già per le notizie sull’assassinio di
199
SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.2, p. 177; EDER 2011, s.v. “Prytaneion”, in BNP.
Il tirannicidio di Ipparco ebbe luogo durante la preparazione della processione panatenaica nel Ceramico: Thuc.
VI 56s.
201
SCOTT 2005, ad Hdt. VI 38.2, p. 177s.
200
235
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Cimone si è ricostruito che l’attribuzione ad Ippia è probabilmente falsa e nata dal proposito di
ritrarre i Filaidi come anti-tirannici e nemici dei Pisistratidi. In merito alle vicende di Milziade
II, solo l’analisi storica ha messo in luce l’opposizione locale al suo potere, altrimenti del tutto
opacizzata nelle notizie erodotee; viceversa i metodi tirannici, autoritari e violenti usati da
Milziade II, se pure ne rimane traccia nelle fonti, non vengono affatto messi in evidenza e non
ricevono la minima nota di biasimo. La medesima operazione sulle testimonianze potrebbe
essere stata compiuta per la storia della tirannide di Stesagora, il cui tirannicidio fu facilmente
attribuito ai nemici lampsaceni, con lo scopo mostrare di Stesasoga l’immagine di un
governante legittimo e ben accetto dai concittadini, anzi sacrificatosi in difesa del Chersoneso
contro i nemici esterni.
Preferisco però concludere con una nota di riserva in merito a questa ricostruzione che va
piuttosto considerata come un esercizio di induzione storica: le fonti in merito a Stesagora sono
drammaticamente scarse e inoltre potrebbe essere in atto una applicazione ai fatti di un modello
storico derivato dalle vicende del tirannicidio ateniese di Ipparco.
V.5.3. Il matrimonio con Egesipyle e l’alleanza con Oloro re dei Traci (516-510)
Si attribuiscono con sicurezza a Milziade II due matrimoni: prima di Egesipile egli ebbe
infatti una prima moglie ateniese che sposò prima della partenza per il Chersoneso Tracico; da
questo matrimonio nacque il figlio Metioco che nel 493 viveva con lui in Chersoneso Tracico e
comandò una delle triremi con cui i Filaidi fuggirono dalle acque del Chersoneso verso
Atene202. La ricostruzione dell’identità e ancor più della biografia della prima moglie ateniese
di Milziade II è altamente ipotetica203. È possibile che la madre di Metioco fosse morta
prematuramente all’epoca delle attività di Milziade II in Chersoneso Tracico, ma non è una
condizione necessaria perché Milziade sposasse poi Egesipile: la critica ha sviluppato un
attendibile modello storico secondo cui, presso l’èlite tirannica, vigeva la pratica della
poligamia come attestata in epoca omerica. In particolare, pur senza costituire una regola fissa,
si possono verosimilmente riconoscere casi di poligamia extrapoleica matrilocale: la sposa cioè
entrava naturalmente a fare parte dell’òikos del marito, ma conservava la residenza presso la
propria città e presso la casa del padre. Questi meccanismi assumono un significato e un senso
pratico alla luce dell’alleanza fra lo sposo e il suocero che il matrimonio stesso suggellava.
202
Hdt. VI 41.2; Marcellin. Vit. Milt. 11. HAMMOND 1956, p. 118; DAVIES 1971, n. 8429 [IX], p. 302.
Esistono convincenti argomenti a favore di una origine pisistratide di questa donna: WADE-GERY 1951, p. 219;
BURN 1962, p. 217; DAVIES 1971, n. 8429 [IX], p. 302, n. 11793 [IX], p. 452; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 39.2, pp.
180s.
203
236
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Perciò è verosimile che la moglie ateniese fosse rimasta in patria presso la famiglia o presso
l’òikos filaide locale, mentre la nuova moglie trace sia stata inserita nella rete familiare filaide
del Chersoneso Tracico204.
Egesipile fu dunque la seconda moglie di Milziade II: ciononostante, e pur trattandosi di
una donna di origine non-greca, è evidente dall’analisi lessicale come da quella storica che si
trattò di una unione regolare, ufficiale e onorata. Il verbo preservato dal testo erodoteo (gaméo)
viene infatti utilizzato in riferimento a regolari unioni riconosciute dalla comunità e dalle leggi
della polis; a favore del pieno status come sposa legittima di Egesipile all’interno dell’òikos
filaide si pone la testimoniata dall’indiscusso riconoscimento dei diritti civici e politici del
figlio Cimone negli anni successivi al rientro della famiglia ad Atene205. È verosimile dunque
che Egesipile abbia seguito il marito ad Atene nel 493; si ritiene che da questa donna di origine
trace sia nato ad Atene un figlio che prese il nome di Oloro secondo la linea matrilineare e che
da questo Oloro ateniese abbia avuto i propri natali lo storico Tucidide206. Altra figlia nata dal
matrimonio di Milziade ed Egesipile fu Elpinice che sposò l’ateniese Callia dopo che i Filaidi
erano rientrati dal Chersoneso. Le fonti attestano come il marito fosse di bassi natali, ma la
moglie potesse vantare una nobile discendenza, sia in virtù della positiva memoria civica degli
antenati paterni, sia in virtù dell’origine regale della famiglia materna207.
Fenomeni di matrimoni fra Greci e non-Greci sono rintracciabili con una certa facilità
nella storia delle relazioni internazionali delle èlites di epoca arcaica; nel caso dei rapporti
culturali fra Greci e Traci la critica riscontra una facilità all’intesa e alla condivisione di
istituzioni sociali, quali appunto il matrimonio, ma anche la xenìa, la philìa, il legame morale
reciproco istituito dalla scambio di doni e dall’euergesìa208.
Questa serie pur frammentaria di dati contribuisce in conclusione a delineare il
matrimonio di Milziade II ed Egesipile con sicurezza come un legame istituzionalizzato e
ufficiale: questo è il segno pertanto che quel matrimonio segnava un’alleanza interfamiliare in
funzione politica sviluppatasi, concordata e infine suggellata fra lo sposo e il padre della sposa,
il sovrano trace Oloro209.
204
VERNANT 1973; GERNET 1983, pp. 177-199; HERMAN 1990, pp. 352s.
DAVIES 1971, n. 8429 X, p. 302; HERMAN 1990, pp. 352s.
206
Thuc. IV 104; Marcell. Vit. Thuc. 1; RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 39, n. 3, pp. 439; PACKARD 1873, pp. 50-59;
HOPPER 1961, pp. 141-146; HABICHT 2000, pp. 119-121; BRAUND 2001, pp. 7, 13-25. Contra HERMAN 1990, pp.
349-353.
207
TANNER 1923, p. 146.
208
Hdt. V 21. RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 39, n. 3, pp. 439; GWYNN 1918, pp. 107-109; HERMAN 1987, pp. 34,
40, 77, 98s., 103s., 127; MITCHELL 1997, pp. 134-147; BRAUND 2001, pp. 13-25; Gazzano 2002, pp. 9-17;
ANDERSON 2005, pp. 184-191; MAZZARINO 2007, pp. 26s., 105-164, 178-202, 278-288 .
209
BRAUND 2001, pp. 14-22.
205
237
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
La datazione della sequenza di eventi: 520-515 ca.
Il passo erodoteo in cui si tramandano gli eventi che segnarono le fasi iniziali della
tirannide di Milziade II in Chersoneso Tracico offre scarsi capisaldi cronologici ad esclusione
della sequenza narrativa in base alla quale il matrimonio di Milziade con la principessa
Egesipile ebbe luogo dopo i provvedimenti violenti contro i dinasti chersonesiti.
Secondo la ricostruzione che si è proposta, l’arrivo di Milziade II in Chersoneso Tracico
sarebbe da datarsi al 520 ca.; nondimeno il matrimonio con Egesipile sembra debba
ragionevolmente appartenere ad un periodo di alcuni anni successivo. Dal matrimonio di
Milziade II ed Egesipile nacque infatti Cimone II che in età adulta assunse la conduzione della
politica estera dell’Atene democratica nella prima metà del V secolo; la biografia plutarchea di
questo Cimone offre alcune informazioni utili per valutarne la data di nascita: quando Milziade
II morì in carcere ad Atene, nel 489, i figli avuti con Egesipile, Cimone II e la sorella Elpinice,
erano entrambi di giovane età; vero è d’altronde che al medesimo tempo Cimone non era più un
adolescente perché era già in un’età sufficientemente avanzata da permettergli di avere una
reputazione pubblica, se pur cattiva210; in base alla notizia per cui Cimone condusse le
operazioni a Sesto e Bisanzio nel 478, si può stabilire che in quella data egli avesse già
compiuto il trentesimo anno di età211. La critica dunque colloca la nascita di Cimone II nel
periodo 515-507 e personalmente concordo con quegli studiosi che propendono per una data
alta entro quell’arco cronologico212. Mi pare opportuno infine seguire N.G.L. Hammond
nell’intento di rispettare la sequenza degli eventi, perlomeno quelli principali, tracciata dalla
narrazione di Erodoto: ritengo perciò che il matrimonio di Milziade ed Egesipile debba
rispettare il terminus ante quem della spedizione scitica di Dario, nel 513213. In conclusione
Cimone nacque intorno al 515 da un matrimonio che poté dunque avere luogo non più di pochi
anni prima, nel periodo 518-516.
La sequenza narrativa che Erodoto esaurisce in pochi passaggi deve dunque essere
assegnata ad una serie di eventi che ebbero luogo nell’arco di circa cinque anni. L’arrivo di
Milziade in Chersoneso e l’attacco contro i dinasti locali si verificarono certamente entro il
primo mese dalla morte di Stesagora214. A questo primo intervento repentino seguì un periodo,
della durata di qualche anno, di assestamento e consolidamento del potere al quale si possono
attribuire il reclutamento, l’organizzazione e l’acquartieramento del contingente di 500
210
Plut. Cim. 4.4s.
Plut. Cim. 9.1. FUSCAGNI 1989, p. 96.
212
WADE-GERY 1951, p. 212, 218;DAVIES 1971, n. 8429 data al 510 ca.; STEIN HÖLKESKAMP 2011, s.v. “Cimon”,
in BNP.
213
HAMMOND 1956, p. 118.
214
Vd. supra, pp. 218ss.
211
238
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
epìkouroi, nonché l’instaurarsi di contatti con il locale sovrano trace Oloro che condussero nel
517 ca. al matrimonio con la figlia Egesipile e infine, qualche anno più tardi, alla nascita del
figlio Cimone II nel 515 ca.
L’intesa politica fra Milziade II e Oloro re dei Traci
In merito al suocero trace di Milziade storici antichi e moderni non dispongono di altri
dati al di fuori della menzione qui fornita da Erodoto215. Il testo definisce Oloro come un
basiléus: è noto che il vocabolo fu comunemente applicato a contesti istituzionali delle
monarchie non greche, orientali o appunto traci, oltre che in ambiti ellenici, con applicazione
però diversificata e più problematica216. Mi pare che l’inferenza che si trae necessariamente è
che Erodoto voglia marcare una distinzione fra il ruolo istituzionale e l’appartenenza culturale
del re dei Traci (tou= Qrhi/kwn basile/oj) Oloro da una parte e quelle dei dinasti delle poleis
elleniche menzionati nei passaggi precedenti dall’altra.
L’appartenenza tribale e l’estensione del regno di Oloro non ricevono trattazione alcuna
nella tradizione antica; ciononostante pare logico seguire la communis opinio nel ritenere che
Oloro fosse il sovrano di quelle popolazioni di Traci che risiedevano entro la penisola del
Chersoneso Tracico, coabitando con gli insediamenti coloniali greci antichi e recenti217: mi pare
in effetti verosimile che Oloro non governasse popolazioni traci al di fuori dell’istmo del
Chersoneso giacché, in primo luogo, Milziade I si adoperò proprio per la difesa dei Traci
chersonesiti contro popolazioni tracie del continente, fissando all’istmo il baluardo territoriale,
e difensivo218, e soprattutto il comportamento di Milziade II non dimostra interesse alcuno,
nemmeno dopo il matrimonio con Egesipile, per i territori al di fuori della penisola in Europa.
Come si è anticipato, il matrimonio di Milziade II con Egesipile deve essere considerato
come il segno e la consacrazione definitiva di un’intesa interfamiliare costituita e costruita negli
anni precedenti fra lo sposo e il padre della sposa: quest’alleanza fra i due leader aristocratici
doveva avere la funzione politica, oltre che personale, di rafforzare le reciproche posizioni nella
gestione del potere e della supremazia entro il Chersoneso Tracico219.
È verosimile che Milziade II abbia preso contatto con Oloro fin dal suo primo arrivo in
Chersoneso Tracico, se non altro in via conoscitiva, in quanto il sovrano ricopriva un ruolo
rappresentativo per una componente numerosa e non di secondo ordine della popolazione della
215
ARCHIBALD 1988, p. 80, 113s.
Anacr. Fr. 491 Page. TOD 1933, nn. 1, 4, 6, 10; ANDREWES 1968; DREWES 1972, n. 31, p. 137; JEFFERY 1976,
pp. 39s.; HAMMOND 1982 b, p. 353; GSCHNITZER 1988, p. 71; ASHERI 1992, pp. 149, 161; LAVELLE 1994;
MURRAY 1996, p. 54; SALMON 1997, p. 207; DUPLOUY 2006, pp. 11-35.
217
ARCHIBALD 1988, pp. 80, 113s ; PETER 2011, s.v. “Olorus”, in BNP.
218
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 46, 234-240.
219
GWYNN 1918, p. 107; BRAUND 2001, pp. 14-22.
216
239
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
penisola. La costituzione di un’alleanza personale fra i due sovrani, il tiranno e il basilèus,
divenne per Milziade II una scelta necessaria man mano che egli perse la propria legittimazione
presso l’aristocrazia greca. È probabile che fra i due si sia dunque formata prima una relazione
di reciprocità, affine a quella che fondava le relazioni della xenìa o della philìa, in base alla
quale i due capi coadiuvarono e appoggiarono le iniziative e le posizioni uno dell’altro; questa
relazione di reciprocità aristocratica fu poi presto cementata e istituzionalizzata tramite
l’alleanza matrimoniale che rinforzò la relazione e ne assicurò la continuità nel tempo220.
Alla luce dei dati finora raccolti mi pare attendibile proporre la ricostruzione secondo la
quale Milziade II, appena insediatosi in Chersoneso, incontrò l’opposizione politica al suo poter
personale da parte della classe dirigente ellenica delle poleis locali e comprese dunque di avere
perduto il prestigio e la legittimazione di cui aveva goduto la sua famiglia fino ad allora: di
fronte al pericolo di perdere la tirannide Milziade reagì applicando una duplice strategia. Come
si è visto, nei confronti dell’aristocrazia greca il tiranno reagì opprimendo con violenza gli
oppositori più pericolosi e proteggendo la propria incolumità e la propria preminenza con lo
strumento militare dei 500 epìkouroi. Nondimeno, una seconda direttrice della strategia di
Milziade utilizzò vie diplomatiche e fu rivolta alla componente sociale e politica della
popolazione tracia locale e alla sua élite dirigente. Per Milziade, Oloro costituì un alleato locale
dotato di un ampio seguito politico e di risorse militari che lo mettevano in grado di rafforzare
la sua posizione di potere contro gli avversari aristocratici greci, adoperandosi sia con l’uso - o
con la minaccia dell’uso - della violenza, sia con un’azione diplomatica e politica di
legittimazione221. Per Oloro, l’alleanza con il tiranno greco locale dovette viceversa assicurare
appoggio politico e militare e prestigio sociale utili a confermare la sua posizione di preminenza
regale all’interno degli equilibri di potere fra i capi delle varie tribù in cui i Traci erano divisi.
I Filaidi come interpreti delle necessità strategiche internazionali della comunità ateniese in
Tracia
Applicando una prospettiva di lungo periodo a questa analisi emerge una tendenza
strutturale da parte dei Filaidi a gestire relazioni costruttive e vantaggiose con l’elemento etnico
dei Traci222: questa scelta è chiaramente dovuta in primo luogo al quadro stesso del
popolamento della regione del Chersoneso Tracico che per tutta la seconda parte del VI secolo
venne a costituire la principale area di pertinenza dei Filaidi, fra quelle interessate dalle
direttrici della politica estera di Atene. Già nella storia della conduzione delle relazioni
220
ARCHIBALD 1988, p. 80, 113s.; JONES 1999, pp. 6-35; BRAUND 2001, pp. 14-22; ANDERSON 2005.
GWYNN 1918, p. 107; ARCHIBALD 1988, p. 80, 113s.
222
RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 39, n. 3, pp. 439; GWYNN 1918, p. 107; BRAUND 2001, pp. 14-22.
221
240
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
internazionali da parte di Milziade I i Traci ebbero un ruolo significativo: il lògos eziologico
della fondazione coloniale in Chersoneso Tracico identifica proprio nella richiesta di ausilio dei
locali Traci Dolonci un movente per la decisione di Milziade; la contestualizzazione storica ha
stabilito l’esistenza di un’intesa in funzione difensiva fra l’ecista e i barbari autoctoni del
Chersoneso. D. Braund ritiene probabile che sia Milziade I che il successore Stesagora abbiano
avuto moglie tracia, come è poi attestato per Milziade II223. Quando Milziade II cercò l’alleanza
di Oloro e poi ne prese in sposa la figlia certamente agiva in risposta ad una necessità
contingente di recuperare un alleato influente contro l’opposizione politica greca; il fatto però
che egli abbia operato proprio la scelta nella direzione dell’elemento trace, il fatto che abbia
stretto un contatto con il più alto vertice politico dei Traci e il fatto che l’intesa sia stata
approfondita al punto da unire le due famiglie segnalano però che Milziade II stava allora
seguendo e praticando una strategia delle relazioni familiari internazionali di lungo periodo,
avviata nella generazione precedente dal suo omonimo zio, che in quel momento drammatico
veniva soltanto convertita in un’intesa più stretta224.
La storia della famiglia dei Filaidi nelle generazioni successive a Milziade II esula dalla
storia delle relazioni internazionali tiranniche poiché essi persero quella posizione di comando
autocratico fuggendo dal Chersoneso Tracico nel 493; ciononostante vi sono chiare
testimonianze del fatto che il legame che univa la famiglia all’area della Tracia perdurò anche
nel V secolo. Già Milziade II, una volta rientrato ad Atene ed assunto un ruolo direttivo nella
politica della nuova polis democratica, dimostrò di volere continuare la precedente politica
marittima espansiva quando tentò la conquista di Paro225. Suo figlio Cimone II operò negli anni
’70 e ’60 del V secolo in qualità di stratego ateniese conducendo una serie di operazioni militari
e navali che facevano chiaramente parte di un progetto volto a difendere la posizione di Atene
in Tracia: così fu certamente per la conquista di Eione sullo Strimone, la colonizzazione di
Anfipoli, la riconquista del Chersoneso stesso ai Persiani, l’attacco a Taso prospiciente le coste
della Tracia e il disastroso tentativo a Drabesco presso il Pangeo. Quando Cimone II subì
l’ostracismo da Atene egli trascorse l’esilio in Tracia: chiaro segno che la famiglia ancora
manteneva là possessi personali, o perlomeno relazioni di ospitalità226. La genealogia dello
storico Tucidide si lega alla famiglia dei Filaidi: il padre di Tucidide nacque dai discendenti nati
ad Atene da Milziade II ed Egesipile e prese appunto il nome dell’onorato padre della Trace,
223
BRAUND 2001, pp. 20s.
ARCHIBALD 1988, p. 80, 113s.
225
Hdt. VI 132-136.
226
Thuc. I 98.1, 100, IV 102.2; And. De Pace 3.3; Diod. XI 70.5; Plut. Cim. 7, 8.3, 14.1-3. PACKARD 1873, p. 55;
WELLS 1923, pp. 133s.; BRAUND 2001, pp. 14-22; CULASSO GASTALDI 2011, pp. 122-124; STEIN HÖLKESKAMP
2011, s.v. “Cimon” [2], in BNP.
224
241
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Oloro227. In considerazione della tradizione familiare e dell’ascendenza di Tucidide non
sorprende dunque riscontrare che egli ricoprì un incarico militare in Tracia durante la stessa
guerra di cui fu il cronista, nel 424, a Taso e ad Anfipoli. Lo stesso Tucidide tramanda, fra i
pochi cenni biografici nella sua opera, nozione dei possedimenti minerari familiari in Tracia,
presso la località di Skapté Hyle, da cui egli derivava la propria ricchezza; qui la tradizione
colloca anche le circostanze della morte dello storiografo228. Queste informazioni insieme
indirizzano a ricostruire, anche nel caso di questo individuo, una continuità generazionale dei
contatti della famiglia dei Filaidi, pur nelle sue componenti allargate, verso l’area strategica
della Tracia, sia tramite interessi economici personali sia in osservanza di incarichi direttivi
pubblici, pur a distanza di anni dalla tirannide che essi avevano mantenuto nel Chersoneso
Tracico.
In conclusione, l’analisi di lungo periodo dimostra la continuità del coinvolgimento dei
Filaidi nelle faccende della Tracia, sia durante la tirannide dei Pisistratidi che successivamente
durante il governo democratico. Questa conclusione fa parte di un modello interpretativo della
storia delle relazioni internazionali tiranniche che lega a doppio filo gli interessi privati dei
tiranni a quelli pubblici della comunità di Atene e viceversa. I Filaidi cioè agirono in primo
luogo evidentemente perseguendo vantaggi e interessi familiari: per preservare la posizione di
potere e prestigio acquisita e conquistata nel tempo in Chersoneso e per preservare beni mobili
e immobili e assetti finanziari che essi avevano sviluppato in Tracia e sui quali si fondava parte
della ricchezza della famiglia229.
È innegabile d’altronde che esista una continuità diacronica degli interventi di Atene, e
dell’impiego delle risorse pubbliche economiche ed umane, in direzione della Tracia, del
Chersoneso e del’Ellesponto: un interesse e una volontà civica che esulavano cioè dalle
aspirazioni di potere di una singola famiglia e che anzi ebbero il potere di imporre al proprio
ceto dirigente il disegno generale degli interventi internazionali da perseguire, pubblici, ma
anche privati e familiari. È noto che l’interesse di Atene come di altre poleis e soggetti politici
ellenici per l’area della Tracia era dovuto essenzialmente all’abbondanza di risorse e materie
prime cruciali eppure scarse sul continente greco: legname, fondamentale per la costruzione
delle imbarcazioni, e depositi minerari di particolare ricchezza d’oro e soprattutto d’argento230.
227
Thuc. IV 104.4; Plut. Cim. 4.1-4. RAWLINSON 1858, ad Hdt. VI 39, n. 3, pp. 439; PACKARD 1873, pp. 54, 59;
HOPPER 1961, pp. 141-146; HERMAN 1990, presenta la communis opinio e offre anche una interpretazione diversa
per il trasferimento del nome trace nella famiglia ateniese di Tucidide; HABICHT 2000, pp. 119-121; BRAUND
2001, pp. 14-22.
228
Thuc. IV 104s. Plut. Cim. 4.1-4. PACKARD 1873, pp. 50s.; HOPPER 1961, pp. 141-146; LAVELLE 1997.
229
PACKARD 1873, pp. 50s.; HOPPER 1961, pp. 141-146; STAHL 1987, pp. 201-228.
230
Thuc. IV 102. HOPPER 1961, pp. 141-146; ERRINGTON 2001, s.v. “Amphipolis”, in BNP.
242
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Come si è già messo in evidenza per le relazioni internazionali dei Pisistratidi, così anche per
quelle dei Filaidi si può riconoscere un interesse strategico ed economico della comunità degli
Ateniesi che si espresse a metà del VI secolo tramite la conduzione politica di Pisistrato e
Milziade, poi nella seconda metà del secolo tramite quella di Ippia e Milziade II, nel V secolo,
infine, pur entro il quadro istituzionale democratico e non più tirannico, tramite la conduzione
politica e militare dello stratego Cimone II, nonché da ultimo di Tucidide di Oloro. Ai Filaidi si
dovrà dunque ascrivere sia un interesse familiare quanto anche la presa in carico di un volere
pubblico. Viceversa la continuità della delega pubblica delle attività in Tracia all’iniziativa dei
Filaidi, per tre generazioni ed oltre, trova giustificazione in virtù delle tradizioni di famiglia,
delle sue conoscenze pregresse di quell’area, della sua rete di contatti e alleanze personali la cui
operatività poteva essere trasferita dai singoli al vantaggio dell’intera comunità.
V.5.4.
Imperi
orientali
e
Greci
d’Asia
Minore:
poleis
e
tiranni
ellenici
nell’amministrazione persiana
Episodi di contatti collaborativi fra tiranni greci e imperi orientali risalgono all’epoca
dell’impero di Lidia, quando esistettero relazioni di reciprocità fra la dinastia regnante dei
Mermnadi e, fra altri, membri delle famiglie tiranniche dei Cipselidi, degli Alcmeonidi e dei
Filaidi231.
Nel 546 l’impero persiano, sotto la conduzione di Ciro il Grande, sconfisse le armate del
sovrano lidio Creso e incorporò l’impero di Lidia entro i confini del multietnico impero di
Persia; insieme ai territori della Lidia passarono all’amministrazione achemenide anche le
poleis greche d’Asia Minore collocate sul litorale asiatico dell’Egeo, dalla Troade fino alla
Ionia. Erodoto ricorda come una svolta epocale la sottomissione dei Greci di Ionia e delle isole
al potere di Ciro232. Rispetto agli accordi che avevano in precedenza legato le poleis all’impero
di Lidia, l’amministrazione persiana di Ciro e poi dei suoi successori impose uncontrollo più
stretto sulla popolazione e sulle entità statuali preesistenti233.
231
Contatti dei Mermnadi con l’élite ellenica: NENCI 1981, pp. 61-65. Periandro: Hdt. I 19-22, III 48. AUSTIN
1990, pp. 295; OLIVIERI 2010. Alcmeone: Hdt. VI, 125. ANNIBALETTO 2000, n. 1 p. 1107; HERMAN 1987, p. 89;
AUSTIN 1990, p. 295. Milziade: Hdt. VI 35-38. DESBOROUGH COOLEY – LARCHER 1844, v.II, p. 200; HOW-WELLS
1928, ad Hdt. VI, 37.
232
Hdt. I 169. MAZZARINO 2007, pp. 136-137.
233
A riprova del cambio di regime e dell’insoddisfazione dei Greci si consideri la rivolta delle poleis della Ionia al
seguito del funzionario Pacties poco dopo che Ciro si fu allontanato dalla Lidia nel 546: Hdt. I 153ss. BURN 1962,
pp. 108-119, 137-139; OLMSTEAD 1982, pp. 93-144; AUSTIN 1990, pp. 293-297; MAZZARINO 2007, pp. 159, 136s.,
352s. nn. 470-472.
243
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Il Gran Re Dario I ascese al trono di Persia nel 521 e procedette a una riorganizzazione
dell’impero che interessò gli strumenti amministrativi, le ripartizioni territoriali, la richiesta dei
tributi e le forniture militari a cui i sudditi erano tenuti a conformarsi: i Greci d’Asia Minore
furono allora più strettamente inseriti nella compagine imperiale achemenide e soprattutto le
classi dirigenti delle poleis si legarono in maniera più organica all’apparato amministrativo
persiano nonché al sovrano stesso. Dario procedette inoltre al consolidamento e
all’allargamento dei confini del regno: perciò, a differenza di quanto era avvenuto con i suoi
predecessori, durante il suo regno le poleis greche dell’area dell’Egeo nordorientale,
dell’Ellesponto e della Propontide dovettero accettare definitivi compromessi con lo stato
achemenide, come avevano già fatto i Greci della Ionia all’epoca di Ciro234. Dario intraprese nel
513 un’imponente spedizione volta ad ampliare i confini dell’impero achemenide oltre
l’Ellesponto, in Europa, con il progetto di sottomettere gli Sciti oltre l’Istro e la Tracia: in
conseguenza di questi interventi in Europa gli interessi dei Greci in Tracia furono pesantemente
intaccati e Pisistratidi e Filaidi dovettero entrambi definire una propria strategia politica nella
gestione delle relazioni con il nuovo potere sopraggiunto dall’Asia235.
Nel contatto fra impero persiano e poleis greche d’Asia Minore, particolarmente durante il
regno di Dario, vennero a convergere, da un lato, le modalità e le necessità specifiche del
sistema di governo persiano e, d’altro lato, i metodi di affermazione del potere politico e di
alleanza personale usati dalle classi aristocratiche elleniche: essenzialmente la combinazione di
questi due fattori diede impulso ad una nuova diffusione della tirannide presso le poleis greche
micrasiatiche236. I Persiani lasciarono ampia discrezione e autonomia nelle gestione della
politica interna a tutte le realtà statali preesistenti perché l’interesse precipuo del Gran Re fu
piuttosto quello di assicurare che le amministrazioni locali provvedessero al versamento del
tributo e alla leva militare237. Nelle poleis greche il controllo della politica locale fu sempre
oggetto di un acceso conflitto interaristocratico: la tirannide sorse appunto da questo conflitto in
quei casi in cui un singolo individuo riuscì ad imporsi sopra i propri avversari e ad eliminare le
loro possibilità di opposizione politica. Le relazioni internazionali furono uno degli strumenti
tramite cui gli aristocratici e i tiranni si assicurarono un maggiore potere personale ricorrendo
234
Hdt. III 89-99. OLMSTEAD 1939, pp. 310-311; AUSTIN 1990, pp. 289-292, 295-306; LURAGHI 1998, 26-27, 4043; WIESEHÖFER 2003, pp. 24-32, 40-71; ANDERSON 2005, pp. 173-210; MUSTI 2006, pp. 277-279.
235
Hdt. IV 83-93, 97s., V 2, 10. STAHL 1987, pp. 201-228; FOL-HAMMOND 1988.
236
AUSTIN 1990; CORSARO 1997, pp. 27-47.
237
Hdt. I 7, 27. WARDMAN 1961; LURAGHI 1998, pp. 27-31; 28-30, 35-38; PANESSA 1999, pp. xviii, 82-84;
PANAINO 2001, pp. 84-93; WIESEHÖFER, 2003, pp. 28-32, 40-60; MAZZARINO 2007, pp. 196-202.
244
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
ad alleati personali che potessero di volta in volta offrire l’aiuto necessario per prevalere238.
Nella prospettiva di questo meccanismo che legava l’affermazione del potere personale nella
polis alla disponibilità di alleati internazionali influenti, fu naturale per le famiglie tiranniche
elleniche d’Asia Minore ricercare l’alleanza dei sovrani orientali che potevano contribuire con
risorse economiche e militari sconfinate e sostegno diplomatico autorevole a che la loro
tirannide rimanesse salda e sicura contro i nemici interni ed esterni239.
Il fondamento delle relazioni e delle alleanze fra tiranni greci e sovrani orientali rimaneva
peraltro il medesimo che regolava le relazioni personali e familiari presso l’élite panellenica
della Grecità: le élites aristocratiche internazionali dei Greci e dei Barbari condividevano
ampiamente cioè modelli di comportamento sociale, paradigmi ideologici e persino le forme
delle istituzioni che regolavano il contatto. Istituzioni quali la xenìa, la philìa, l’euergesìa,
l’hiketèia, nonché le forme di intesa di più lassa istituzionalizzazione, si fondavano tutte sul
vincolo interpersonale della reciprocità, del dono e del contro-dono, compreso a livello
interculturale: a fronte di un’azione positiva di uno dei due associati, la controparte godeva in
primo luogo di un vantaggio per sé, ma veniva legata a rispondere e ricambiare con un dono o
un favore di eguale valore, o di valore superiore, creando così una continuità virtuosa che
poteva potenzialmente giungere ad approfondire e intensificare l’intesa fra i due soggetti,
ampliandosi così dall’ambito personale a quello politico240.
I sovrani achemenidi, avvicinati da individui greci aristocratici e capaci, abili nella
gestione politica e nella pratica diplomatica, furono a loro volta disposti a istituire con questi
delle alleanze personali: la gestione del potere nei regni orientali prevedeva infatti da parte del
sovrano la concessione a individui fidati di privilegi politici e posizioni preminenti e la
concessione delle risorse necessarie al mantenimento del potere; tramite costoro il Gran Re
poteva disporre di un’autorità rappresentativa univoca nei rapporti fra la corte e le singole
comunità. Il rapporto di reciprocità che veniva così a crearsi legava indissolubilmente il
beneficiario locale a mantenere una stretta fedeltà al sovrano, sotto l’impulso di rispettare un
codice morale aristocratico e soprattutto sotto l’impulso di mantenere la benevolenza
dell’autorità che in primo luogo assicurava il suo potere personale241.
238
VERNANT 1973; GERNET 1983, pp. 77-81, 146-153; MITCHELL 1997, pp. 111-120; ANDERSON 2005, p. 184, n.
27-29.
239
ANDREWES 1958, pp. 116-127; TOZZI 1978, pp. 118-124; OLMSTEAD 1982, pp. 79-94; BURN 1985, pp. 295296; GRAF 1984; AUSTIN 1990, pp. 289-292, 295, 306; LURAGHI 1998; ANDERSON 2005, pp. 209-218.
240
GERNET 1983, pp. 77-81, 146-153; HERMAN 1987; AUSTIN 1990, pp. 289-292, 295-306; DAVERIO ROCCHI
1993, pp. 177-189; KONSTAN 1997; MITCHELL 1997; LURAGHI 1998, soprattutto pp. 27-29, 35-45; PANESSA 1999,
pp. pp. XV-XXVI, 82-84; PICCIRILLI 2002, pp. 65-70.
241
ANDREWES 1958, pp. 116-127; TOZZI 1978, pp. 118-124; BURN 1985, pp. 295-296; GRAF 1984; HERMAN 1987,
pp. 39-45, 73-106, 118-128; GERNET 1983, pp. 77-81, 146-153, 160-170, 177-179; AUSTIN 1990, pp. 289-306.
245
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Tramite questa serie di meccanismi politici e di relazioni interpersonali, si rende conto
dunque della particolare situazione della Grecità d’Asia Minore nell’ultimo quarto del VI
secolo e della diffusione sia delle tirannidi che delle posizioni filo-persiane presso la classe
dirigente locale242. Questo è dunque il contesto entro cui Filaidi e Pisistratidi si trovarono a
gestire in Asia le relazioni internazionali, da un lato con le poleis greche, e d’altro lato con
l’impero persiano. Nel caso dei Filaidi il quadro finora delineato funge da premessa alle
relazioni e ai moventi che regolarono le iniziative di Milziade II negli anni successivi alla
spedizione di Dario in Europa e fino alla fuga dei tiranni dal Chersoneso Tracico nel 493
durante la repressione della rivolta ionica contro la Persia243. Per Ippia il potere e la protezione
che Dario dimostrava di accordare ai tiranni divennero sempre più importanti a partire dalla
crisi del tirannicidio di Ipparco ad Atene, poi soprattutto nel momento dell’espulsione dei
Pisistratidi da Atene nel 510 e infine determinarono l’avvicinamento di Ippia presso la corte di
Susa244.
Casi di relazione fra sovrani persiani e tiranni greci
Una relazione di reciprocità fra un tiranno greco e un sovrano persiano si riconosce già
durante il regno di Ciro il Grande, a metà del VI secolo, quando il sovrano donò al greco
Pitarco di Cizico sette città della Troade245. Il successore di Ciro, Cambise, strinse una forma di
alleanza militare con il tiranno di Samo Policrate all’epoca della conquista dell’Egitto nel
525246. Le relazioni fra impero persiano e la tirannide di Samo proseguirono nella generazione
successiva a quella di Cambise: durante la campagna per la conquista dell’Egitto, il fratello del
tiranno samio, Silosonte, aveva avuto modo di entrare in contatto con Dario quando questi era
soltanto un lanciere al comando di Cambise e di guadagnarne il favore con una euergesìa, cioè
una azione favorevole. Quando Dario fu poi sul trono di Persia, Silosonte poté chiedere al
nuovo sovrano il contraccambio del suo precedente favore, nel rispetto delle pratiche della
reciprocità: Dario concesse perciò un corpo di spedizione navale e militare persiano affinché
Silosonte potesse impossessarsi di Samo e ottenere la tirannide; in questo modo nondimeno
CORSARO 1997, pp. 27-47; KONSTAN 1997, pp. 23-37, 84-87; MITCHELL 1997, pp. 111-120, 131-133; LURAGHI
1998, pp. 28-43; ANDERSON 2005, pp. 184, n. 27-29, 173-122, 209-218.
242
AUSTIN 1990; ANDERSON 2005.
243
Hdt. VI 40s.
244
Hdt. V 94, 96-98. DUPLOUY 1996, p. 90.
245
Heracl. Lemb. Exc. Pol. 38; Agat. Cyz. FGrHist 472 F 6; Ath. I 52. HUXLEY 1966, p. 121; GERNET 1983, pp.
77-81, 146-153; AUSTIN 1990, pp. 296-297; MITCHELL 1997, pp. 4-10, 18-21, 111-120; LURAGHI 1998, pp. 31-35.
246
Hdt. III 44. LATTIMORE 1939, pp.26, 32; DE STE. CROIX 1977, p. 146; LA BUA 1978, pp. 1-30; HERMAN 1987,
pp. 1-47, 71-72; MITCHELL 1997, pp. 7s., 20-22; PANESSA 1999, pp. 85-87; WIESEHÖFER 2003, pp. 24-32, 40-71.
246
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
l’isola e il potere del tiranno passarono entro un rapporto vincolante di fedeltà a Dario e di
dipendenza dalla Persia247.
La spedizione scitica di Dario (513-512)
La spedizione scitica condotta da Dario I in Europa costituisce il caso certamente più
significativo in cui riconoscere i fenomeni storici dell’ultimo quarto del VI secolo finora
discussi: cioè la diffusione del potere tirannico nelle poleis elleniche micrasiatiche; le forme in
cui le poleis furono incorporate entro l’amministrazione politica e militare dell’impero
persiano; l’istituzione di relazioni di reciprocità e soggezione che legarono i tiranni greci al
sovrano achemenide248.
Nel 513 Dario intraprese la spedizione in Europa249: l’obiettivo di Dario fu quello di
oltrepassare il Bosforo, procedere a nord oltre il corso del fiume Istro e percorrere le steppe a
occidente e settentrione delle coste del Ponto Eusino per sottomettere le tribù dei cavalieri sciti;
obiettivo non secondario della spedizione fu di conquistare la Tracia e incorporare all’impero
quei territori europei, costieri quanto interni, affacciati sulla sponda settentrionale dell’Egeo,
fino al regno di Macedonia250. La spedizione scitica fornì anche l’opportunità per consolidare
definitivamente il potere persiano sui territori nordoccidentali della penisola anatolica: in Misia,
Eolide, Troade, Propontide ed Ellesponto.
247
Hdt. III 45-49. OLMSTEAD 1982, pp. 67s., 79; LURAGHI 1998, p. 31.
BERVE 1967, pp. 85-88. Sulla spedizione scitica vd. Hdt. IV, 83-89, 97-98, 128, 133, 136-139. Il racconto della
spedizione scitica di Dario funge in Erodoto da precedente e modello per la spedizione di Serse contro la Grecia, si
distingue un comune modulo letterario che comprende: la vendetta come movente, l’inascoltato consiglio prudente,
la leva militare dalle nazioni, il ponte sul mare, la lealtà filo-persiana degli Ioni, la sconfitta e la fuga del Gran Re:
FOL-HAMMOND 1988, pp. 234-235.
249
Dareus Behistun, I 12-17, V 74-76; Hdt. IV 83-98, 118-144; Ctes. FgrHist 688 FF 13, 16-22, 82-87; Aristot.
Rhet. III 16.6; Pol. IV 42; Diod. X 19.5s.; Strab. VII 3.9 (= Ephor. FGrHist 70 F 42), XIV 1.17; Polyaen. VII 11;
Ath. XII 522. IG XIV 1297, II.8-27. La questione della datazione della spedizione scitica di Dario I è in effetti
complessa e non priva di controversie: uno spoglio della critica esistente, sia degli storici orientalisti che dei
classicisti, raccoglie proposte di datazione per tutti gli anni che vanno dal 520 al 511; le date che godono di
maggiore credito sono quella del 519, del 514 e del 513. L’iscrizione reale persiana di Behistun, nonché la
sequenza narrativa offerta dalla maggior parte delle fonti greche imporrebbero di datare la spedizione scitica al
519; nondimeno l’analisi linguistica ed epigrafica delle iscrizioni persiane e una contestualizzazione della sequenza
di eventi relativi ai primi anni del regno di Dario I porta a ricostruire l’esistenza di una prima e più antica
spedizione persiana contro popolazioni scitiche stanziate però al confine dei territori orientali dell’impero persiano.
La spedizione ricordata dalle fonti greche sarebbe dunque una seconda spedizione contro gli Sciti dell’area europea
appunto e contro i Traci, da datarsi nel 514-513; entro quel periodo la datazione più diffusa fra classicisti e
orientalisti è quella del 513. In questa ricerca accetto quest’ultima data: non solo per la maggiore diffusione e
autorevolezza presso la critica moderna, ma soprattutto perché mi pare quella più coerente con gli eventi e le
conseguenze collegati appunto alla spedizione persiana, nonché con la ricostruzione delle successive operazioni
prima in Scizia e poi in Tracia. KING-THOMPSON 1907; OLMSTEAD 1938; CAMERON 1943; WADE-GERY 1951, p.
215, nn. 14s. e bibliografia citata; BURN 1962, pp. 127-139; BALCER 1972; OLMSTEAD 1982, pp. 84s., 89-94; FOLHAMMOND 1988, pp. 235-244; SEKUNDA 1992, pp. 13-14; ANNIBALETTO 2000, ad Hdt. IV 1, p. 645; WIESEHÖFER
2003, pp. 14-23, 29-31, 40-71.
250
OLMSTEAD 1982, pp. 89-92; FOL-HAMMOND 1988, pp. 234-157.
248
247
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
L’esercito di Dario fu raccolto con la leva ordinaria ei Persiani; ai sudditi ellenici di
Ionia, Eolide e dell’Ellesponto giunse invece l’ordine del Gran Re di allestire e condurre la
flotta che avrebbe appoggiato l’avanzata dell’esercito sulla terraferma251. Il greco Mandrocle di
Samo fu incaricato di costruire un ponte di barche per unire le due rive del Bosforo ove
l’esercito persiano passò in Europa252. Ai Greci che conducevano la flotta fu affidato il compito
di avanzare lungo le coste del Ponto Eusino, di imboccare e risalire il fiume Istro fino al punto
in cui si dipartivano i numerosi rami della foce e là costruire un ponte di barche che avrebbe
permesso ai Persiani l’accesso alla Scizia; i contingenti dei Greci si fermarono poi a guardia del
ponte che costituiva l’unico passaggio e l’unica via di ritirata per la spedizione di Dario253.
Erodoto tramanda un elenco delle poleis e dei tiranni che egli ritenne più degni di nota
fra quelli che presero parte alla spedizione scitica, da cui emerge un campione significativo
dell’ampia diffusione della tirannide fra le poleis greche soggette alla Persia. Le tirannidi
dell’Ellesponto che seguirono Dario nella spedizione scitica furono Dafni di Abido, Ippoclo di
Lampsaco, Eforanto di Pario, Metrodoro di Proconneso, Aristagora di Cizico, Aristone di
Bisanzio; a questi si deve aggiungere Milziade II del Chersoneso Tracico. Per l’area della Ionia
i nomi notevoli furono: Stratti di Chio, Eace II di Samo, Laodamante di Focea, Istieo di Mileto.
L’unico che Erodoto ritenne degno di memoria fra i tiranni dell’Eolide fu Aristagora di Cuma.
Erodoto stesso afferma esplicitamente di fornire una lista parziale secondo il criterio di
tramandare solo i nomi di quei tiranni e strategòi (comandanti militari) che presero parte alle
assemblee per le decisioni comuni dei Greci durante la spedizione e fra questi solo i nomi, e
dunque le poleis, di coloro che il sovrano di Persia riteneva degni di considerazione254.
Secondo la ricostruzione storica che il brano erodoteo permette di trarre, le poleis
elleniche d’Asia Minore entro l’impero persiano, nel 513, erano dunque in buona parte
governate da tiranni locali. Questi aristocratici godevano cioè di una supremazia politica, pur
non istituzionalizzata, fra i propri concittadini, secondo il consueto modello della tirannide;
eppure tale controllo locale era esercitato da individui che godevano dell’approvazione e
dell’appoggio del sovrano di Persia il quale non solo ne accettava la posizione nella politica
locale, ma anzi assicurava loro i mezzi economici, militari e diplomatici per mantenerla. In
questo senso, il discorso tenuto da Istieo, tiranno di Mileto, è inequivocabile. I tiranni ellenici
vengono d’altronde ripetutamente definiti come strategòi dei contingenti navali delle rispettive
251
Hdt. IV 83, 87. ROEBUCK 1953, soprattutto p. 11; BRAUND 2001, pp. 37-38.
Hdt. IV 87-89.
253
Hdt. IV 83, 87-89, 137.
254
Hdt. IV 137s. WELLS 1923, pp. 95-111 sulle fonti di Erodoto per questo passo; BLAMIRE 1959, pp. 142s., 145,
149, 152s.
252
248
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
poleis: il dato è da intendersi dalla prospettiva dell’amministrazione persiana per la quale i
tiranni ricoprivano un incarico militare ufficiale e istituzionalizzato e una funzione di
rappresentanza della propria polis nei confronti del governo del Gran Re255.
Fig. 7: le poleis elleniche che fornirono la flotta per la spedizione scitica di Dario I
L’assemblea dei Greci all’Istro: i tiranni filo-persiani e le poleis anti-tiranniche
La narrazione erodotea riporta una descrizione ampia dei fatti della campagna di Dario in
Scizia all’interno della quale la notizia dell’incidente avvenuto nel campo greco al ponte
sull’Istro costituisce uno strumento imprescindibile per comprendere la posizione dei tiranni
greci verso il Gran Re, verso i propri concittadini e, non da ultimo, per comprendere lo sviluppo
della posizione e delle relazioni internazionali delle tirannidi di Ippia e di Milziade II256.
Ad un certo momento dell’avanzata persiana attraverso le steppe della Scizia, fu chiaro a
Dario che l’iniziativa si stava rivelando fallimentare e fu perciò decisa la ritirata; un contingente
255
Hdt. IV 137. BURY 1897; BERVE 1967, pp. 85-88; GERNET 1983, pp. 77-81, 146-153; HERMAN 1987, pp. 14s.,
39-49, 70, 89-91, 102-108; AUSTIN 1990, pp. 289-306; MITCHELL 1997, pp. 111-120, 131-133; soprattutto
LURAGHI 1998; GAZZANO 2002, pp. 15, 30-31 fa luce sulla scarsa precisione terminologica di Erodoto nella
designazioni di sovrani, despoti, tiranni e comandanti; ANDERSON 2005, pp. 178, 184, 192, 211-213.
256
Hdt. IV 137. BURY 1897; HERMAN 1987, p. 102; AUSTIN 1990; DUPLOUY 1996, p. 90; LURAGHI 1998.
249
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
di cavalieri sciti sopravanzò però i Persiani e giunse al campo dei Greci all’Istro: gli Sciti
suggerirono allora ai comandanti di disertare gli ordini del Gran Re, distruggere il ponte di
barche, ritornare alle proprie sedi e godere infine della libertà dal giogo persiano; grazie alla
loro sfiancante tattica militare gli Sciti avrebbero infatti assicurato che né l’esercito né il
sovrano di Persia sopravvivessero257. I Greci tennero allora un’assemblea nella quale Milziade
II, tiranno del Chersoneso Tracico, prese la parola e convinse gli astanti a seguire la proposta
degli Sciti. Parlò poi Istieo, il tiranno di Mileto, le cui parole inquadrano con chiarezza le forme
di potere e dipendenza vigenti allora nella grecità micrasiatica: il tiranno milesio ricordò ai
propri pari che era il Gran Re Dario ad assicurare loro il potere e la sovranità nella loro poleis e
qualora fosse venuta a mancare la sua autorità i Greci avrebbero certamente espulso i tiranni e
avrebbero preferito reggersi con regimi democratici. Il consesso dei generali greci scelse infatti
di seguire l’opinione filo-persiana di Istieo e i Greci rimasero dunque fedeli agli ordini di
Dario258.
La critica tratta naturalmente il brano erodoteo con le giuste cautele in merito alla libertà
compositiva dello storiografo, alla possibilità di Erodoto di disporre di testimoni e fonti relativi
all’evento, all’uso dei discorsi nelle scelte stilistiche dell’autore259. Pur accettando queste
valutazioni, è possibile preservare una ricostruzione storica secondo la quale, durante l’assenza
dell’esercito persiano e del Gran Re, in un momento critico della campagna militare persiana,
fra gli strateghi greci vi fu l’opportunità di mettere in discussione la loro aderenza ai progetti
del Gran Re e personaggi di particolare levatura rappresentarono posizioni discordi al
riguardo260.
Alla luce delle parole di Istieo e delle premesse finora esposte, si mette in evidenza come
le tirannidi elleniche in Asia Minore dipesero in maniera vitale dall’appoggio persiano; inoltre
proprio le sproporzionate capacità del Gran Re assicurarono ai tiranni la loro posizione nelle
rispettive poleis, annullando cioè sia la fisiologica contrapposizione politica locale
interaristocratica, sia la necessità per il tiranno di godere di una misura di legittimazione presso
i concittadini. Gli sviluppi della rivolta ionica (500-493) confermano questa ricostruzione
poiché è evidente, tanto dalle fonti quanto nei giudizi della critica moderna, che quello fu
257
Hdt. IV 136s.
Hdt. IV 137. BERVE 1967, pp. 85-88.
259
AUSTIN 1990; BURY 1897; GAZZANO 2002, pp. 10-24.
260
BURY 1897, p. 278; BLAMIRE 1949, p. 142; SEALEY 1973, p. 19; AUSTIN 1990, p. 291.
258
250
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
essenzialmente, e pur nelle variegate dinamiche regionali, un moto non solo anti-persiano, ma
anche in egual misura anti-tirannico261.
Il legame fra Dario e i tiranni si fondava sul rapporto di reciprocità secondo il quale il
Gran Re garantiva la posizione di supremazia locale ai tiranni e questi, viceversa, garantivano
l’adesione delle poleis alla politica dell’impero persiano. Associato a quest’obbligo morale
della reciprocità, il quadro ideologico delle monarchie orientali prevedeva peraltro il
comportamento secondo cui il sovrano ricambiava i sudditi fedeli con doni e ricompense e
altrettanto gli atti di sedizione e tradimento con la repressione; entrambi erano proporzionati
non solo e non tanto alle azioni dei sudditi, ma piuttosto alle capacità e alle possibilità
sproporzionatamente superiori del monarca262. Anche su questo presupposto il legame di
reciprocità dei tiranni con il Gran Re era de facto una forma di sudditanza di difficile solubilità.
I tiranni favoriti da Dario I
La relazione di reciprocità e soggezione, riconoscenza e dipendenza, che legava Dario e i
tiranni ellenici è il criterio dunque con cui si deve identificare e caratterizzare la scelta compiuta
da Erodoto nell’elencare le tirannidi degne di nota che parteciparono alla spedizione scitica: in
questo senso dunque la selezione erodotea costituisce non solo una lista delle più notevoli
tirannidi micrasiatiche, ma più specificamente un elenco di quei tiranni che nell’assemblea
all’Istro votarono a favore della proposta di Istieo, fautori cioè di una politica filo-persiana, che
rimasero allora fedeli a Dario; la considerazione di cui Erodoto tramanda essi godevano presso
il Gran Re nasceva appunto in virtù e in conseguenza della fedeltà personale e politica
dimostrata in quelle circostanze critiche263. Non sorprende dunque che Milziade II, pur
menzionato nella narrazione di Erodoto dei fatti dell’Istro, ma in virtù della posizione antipersiana assunta nell’assemblea, non figuri in effetti nella sezione del testo relativa ai tiranni
favoriti da Dario.
Per alcuni di quei tiranni è possibile tracciare le conseguenze del contributo di fedeltà alla
Persia e del favore presso Dario negli anni immediatamente successivi alla campagna scitica.
Erodoto tramanda che, rientrato in Persia, Dario volle infatti ricompensare per le loro
importanti euergesìai (le azioni favorevoli) Istieo di Mileto e Coes di Mitilene: invitò i due a
corte e si impegnò a concedere loro l’approvazione per qualunque richiesta avessero fatto.
261
TOZZI 1978, pp. 44-52, 118-128, 134-143, 210-217; WALLINGA 1984, pp. 411-436; AUSTIN 1990, pp. 289-292;
LURAGHI 1998, pp. 37-38; PANAINO 2001, pp. 84-93; ANDERSON 2005, pp. 210-215; MAZZARINO 2007, pp. 45,
237s.
262
LIVERANI 1994, p. 168-182; MITCHELL 1997, pp. 111-120; LURAGHI 1998, pp. 31-25; WIESEHÖFER 2003,pp.
43-45.
263
BLAMIRE 1959.
251
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Durante la spedizione in Scizia, Coes era stato soltanto lo strategòs del proprio contingente
navale, ma già era stato apostrofato quale xènos dal Gran Re: cioè un ospite-onorario legato
tramite un vincolo di amicizia personale. Dietro sua richiesta, Coes ottenne la tirannide di
Mitilene. Istieo chiese e ottenne la possibilità di fondare e gestire una colonia in Tracia, a
Mircino, presso il fiume Strimone; anche negli anni a seguire Istieo mantenne una relazione di
amicizia, perfino intima, con Dario264. Riguardo al tiranno di Lampsaco, Ippoclo, si conserva
conoscenza dell’esistenza di un legame preferenziale della sua famiglia con Dario; vero è che la
notizia non lega il favore del Gran Re a cause o moventi specifici, eppure la presenza di Ippoclo
fra gli strategòi fedeli all’Istro fornisce una circostanza appropriata da cui può avere avuto
origine la gratitudine di Dario265. A Samo già Silosonte aveva ottenuto la tirannide con
l’appoggio militare di Dario e aveva insieme posto l’isola sotto la soggezione dalla Persia266; il
figlio e successore fu Eace II che figura preminentemente nelle vicende fra Greci e Persiani
negli anni a cavallo fra il VI e il V secolo. Nel 513 Eace II è infatti il tiranno strategòs di Samo
nella spedizione scitica e uno dei tiranni che all’Istro confermarono la fedeltà a Dario
ottenendone il favore particolare267. Allo scoppio della rivolta ionica nel 499 Eace II fu dunque
fra quei tiranni invisi ai concittadini che furono espulsi dalle proprie poleis; quando la rivolta
giunse alla decisiva battaglia di Lade, nel 494, egli si adoperò con successo perché i Samii
disertassero lo schieramento greco268. Quando il sommovimento dei Greci d’Asia Minore fu
sedato, in riconoscenza degli alti meriti e dei servigi resi alla causa persiana, Eace II fu
ricondotto dalla flotta persiana a Samo e restituito alla sua posizione di comando; in quel
momento i Sami riconobbero esplicitamente nel ritorno di Eace II la rinnovata soggezione alla
Persia269.
In conclusione il meccanismo che accomuna tutti questi casi è quello di una relazione sia
personale che politica fra il tiranno e il sovrano di Persia in osservanza della quale, in
circostanze critiche, il tiranno rimase fedele all’autorità di Dario e apportò servigi vantaggiosi;
in riconoscenza il Gran Re attribuì al tiranno considerazione particolarmente favorevole,
contribuì al mantenimento della sua posizione nella polis e ne favorì gli obiettivi anche sul
piano internazionale.
264
Hdt. V 11. BURY 1897, pp. 177-190; LATTIMORE 1939, p. 27; LURAGHI 1998, p. 26, n. 14, 31-38.
Thuc. VI 59. CAMERON 1943, p. 313 n.22; AUSTIN 1990.
266
Hdt. III 120, 140.
267
Hdt. IV 138.
268
Hdt. VI 13s.
269
Hdt. VI 22, 25. WHITE 1954; BARRON 1964, in particolare pp. 210-211, 217-219; LA BUA 1978, pp. 39-50; TOZZI
1978, pp. 113-127; WALLINGA 1984; AUSTIN 1990, pp. 289-291, 295-306; ANDERSON 2005, pp. 210-215.
265
252
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
In virtù appunto dei vantaggi sul piano internazionale che Dario assicurò ai tiranni propri
alleati, non solo l’impero persiano, ma anche i tiranni più strettamente associati alla corte
achemenide sono da considerarsi soggetti attivi del sistema internazionale, soprattutto nella
regione nordorientale dell’Egeo. Nella comprensione delle dinamiche che influenzarono e
modificarono gli interessi internazionali di Ippia e di Milziade II è essenziale considerare da un
lato l’azione della Persia, del Gran Re, dei satrapi o dei generali persiani, soprattutto per via
delle vaste risorse e della imponente capacità militare; d’altro lato, la rete delle alleanze del
Gran Re includeva anche i tiranni filo-persiani, ognuno dei quali perseguiva d’altronde in propri
interessi internazionali.
La conquista persiana della Tracia (513-512)
La fallimentare conquista della Scizia si risolse in una disastrosa ritirata dalle terre oltre
l’Istro e il Gran Re Dario fece ritorno in Persia; non terminò così però la campagna persiana in
Europa poiché il Gran Re lasciò preciso ordine al persiano Megabazo, in qualità di stratego in
Europa (στρατηγὸν ἐν τῇ Εὐρώπῃ), di sottomettere la Tracia e a tale scopo furono stanziati ai
suoi ordini 80.000 soldati270. Megabazo conquistò Perinto sulla Propontide, polis che doveva
essersi ribellata durante la campagna scitica; poi l’esercito persiano si spinse attraverso tutti i
territori della Tracia muovendo sempre verso occidente e sottomettendo tutte le tribù dei Traci;
particolarmente le zone costiere furono interessate dall’occupazione persiana271. L’avanzata
persiana si spinse fino al fiume Axio che segnava il confine fra i territori della penisola
Calcidica e il regno di Macedonia: qui le pratiche di deportazione conosciute presso le
monarchie orientali furono messe a frutto per riassestare gli equilibri in maniera favorevole al
consolidamento delle posizioni persiane272. Aminta il sovrano di Macedonia ricevette gli
emissari persiani consegnando terra e acqua, da intendersi in senso lato come segno della sua
alleanza, o soggezione, nei confronti del potere del Gran Re di Persia273. Gli specialisti di
orientalistica riconoscono nella conquista dei territori della Tracia e della Macedonia
l’istituzione in quel momento della nuova satrapia di Skudra274. È in vista di una strategia di
conquista della Tracia e dello sfruttamento delle risorse minerarie della regione che si devono
270
Hdt. IV 143.1. BERVE 1967, pp. 85-88.
Hdt. V 10.
272
Hdt. V 1s., 12.1, 14, 17.1, DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 51s. sugli elementi fluviali del territorio in qualità di
segno confinario; FOL-HAMMOND 1988, soprattutto pp. 241-246.
273
Hdt. V 17s. OLMSTEAD 1939, p. 308-312; GERNET 1983, pp. 168-170; MITCHELL 1997, pp. 111-120.
274
OLMSTEAD 1939, p. 308; OLMSTEAD 1982, pp. 79-94; FOL-HAMMOND 1988, pp. 236-250; PANAINO 2001, pp.
91s.
271
253
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
intendere i moventi della conquista ordinata a Megabazo; le medesime considerazioni
fondarono chiaramente la concessione della colonia sul fiume Strimone ad Istieo di Mileto275.
Fig. 8: Persepoli, rilievo dell’Apadana, probabile processione dei Traci <www.livius.org>
Otane e la riconquista delle poleis elleniche anti-persiane (512-511)
L’anno successivo, nel 512, il comando del contingente in Europa fu affidato al persiano
Otane276. Il nuovo stratego d’Europa reclutò un contingente navale a Lesbo, certamente facendo
leva sull’autorità locale del tiranno di Mitilene Coes che, si è visto, aveva da poco imposto il
proprio potere proprio per concessione di Dario; con le navi lesbie Otane procedette a
sottomettere Bisanzio e Calcedone all’imbocco del Bosforo; poi in Troade fu conquistata
Antandro; l’anno successivo, nel 511, le operazioni navali incorporarono alla Persia le
strategiche isole di Lemno e Imbro. Al governo di Lemno Otane pose il greco Licareto, già
associato alla gestione del potere tirannico di Samo negli anni precedenti277. Erodoto definisce
Licareto un hýparchos, utilizzando cioè un termine attestato per figure di governatori facenti
parte dell’apparato amministrativo persiano: questa scelta lessicale, piuttosto che quella del
termine týrannos, è indice significativo e storicamente rilevante della nuova condizione di
dipendenza con cui i poteri autocratici della grecità micrasiatica si erano sottoposti all’autorità e
alla protezione del Gran Re278.
Erodoto tramanda la notizia della fedeltà pressoché unanime dei tiranni ellenici al potere
di Dario durante la campagna in Scizia; nondimeno, le missioni di Otane contro le poleis
275
BLAMIRE 1959; BURY 1897; FOL-HAMMOND 1988, pp. 235-248.
Hdt. V 25s.
277
Hdt. III 143, V 27. FERNANDEZ NIETO 1975, n. 86 pp. 200s.; CULASSO GASTALDI 2011, pp. 116-118.
278
Si vedano le attestazioni del termine hýparchos usate sia in riferimento a Greci che a dignitari persiani: Hdt. V
20, 25. VII 26, 33, 194, IX 116. BERVE 1967, pp. 85-88; WALLINGA 1984, pp. 411-436; AUSTIN 1990; LURAGHI
1998, p. 22; ANDERSON 2005, pp. 211-213.
276
254
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
elleniche rivelano che fra i Greci sudditi della Persia era diffusa anche una tendenza di segno
contrario, anti-persiana. Erodoto trasmette le ragioni dell’intervento di Otane: il generale
persiano accusava alcuni di avere disertato la spedizione contro la Scizia, altri erano accusati di
avere molestato l’esercito di Dario durante la ritirata dalla Scizia279. Le circostanze delineate
nella fonte, la repressione di Otane e la cronologia di questi fatti collimano con la posizione
dissidente assunta da Milziade II all’Istro. La spedizione di Dario in Scizia si era conclusa con
un pericoloso e drammatico fallimento che poteva cogliersi come il segno che anche l’esercito
persiano non era invincibile; dal punto di vista politico l’episodio presso l’Istro aveva messo a
nudo l’esistenza di un disaccordo fra i tiranni alleati del Gran Re in merito all’opportunità di
rimanere sotto la protezione persiana, anche se non giunse ad una crisi decisiva e al distacco del
contingente ellenico. Dario rientrò in Asia con parte dell’esercito, mentre il contingente europeo
al comando di Megabazo si spinse progressivamente verso le regioni occidentali della Tracia. In
questo contesto e in quel momento dunque le poleis che si sentivano più lontane dal pericolo
persiano, appunto nelle regioni della Propontide e dell’Ellesponto, si dissociarono da Dario e
dal giogo dei tributi dovuti alla Persia280. Le operazioni militari di Otane e le esplicite notizie
recepite da Erodoto al riguardo rivelano appunto la necessità per il nuovo generale persiano
delle regioni europee di riassestare il dominio achemenide sui confini nordoccidentali
dell’impero281.
La narrazione erodotea ricorda infine esplicitamente che a conclusione di questi eventi
perdurò un breve periodo in cui non sorsero difficoltà per i Greci d’Asia282; per poco più di un
decennio cioè, dal 511 al 500, le relazioni fra poleis greche micrasiatiche e impero persiano
rimasero pacifiche, certo sotto il minaccioso controllo del potere e della potenza persiana e dei
tiranni dipendenti, fino allo scoppio della rivolta ionica.
Il nuovo sistema internazionale dell’egemonia persiana: il contesto per le scelte di Ippia e
Milziade II nell’ultimo quarto del VI secolo
La storia fino a qui tracciata segna essenzialmente un processo che vide l’imposizione
del potere persiano sulle aree di insediamento e, più in genere, di interesse dei Greci in Asia e in
Tracia nel corso della seconda metà del VI secolo: si tratta dunque di un fenomeno ineludibile
per la comprensione della politica internazionale delle tirannidi elleniche283.
279
Hdt. V 27.2.
BURY 1897, p. TOZZI 1978, p. 127; OLMSTEAD 1982, pp. 89-102.
281
Hdt. V 27.
282
Hdt. V 28.
283
BERVE 1967, pp. 85-88.
280
255
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Il sopraggiungere del potere persiano nelle aree elleniche comportò conseguenze sia sul
piano locale che su quello internazionale per i cittadini e i governanti delle poleis. I Greci, pur
rimanendo polìtai delle proprie città-stato, divennero anche sudditi del Gran Re e ai loro
governanti fu richiesto di diventare membri dell’apparato amministrativo achemenide: la
reazione a questo cambiamento tanto istituzionale quanto culturale informa il modo in cui le
poleis, insieme e singolarmente, parteciparono del sistema internazionale su cui era egemone la
Persia. Gli eventi discussi mostrano come l’adeguamento della prospettiva internazionale
presso i Greci e i tiranni fu problematico, dinamico e non univoco: la storia della spedizione
scitica, delle conquiste di Megabazo e di Otane e successivamente della rivolta ionica mostrano
una varietà di esiti per i tiranni di quelle regioni e una varietà di posizioni nelle relazioni con il
Gran Re. Conseguenza cruciale fu lo spostamento delle tirannidi entro una forma di
clientelismo verso il sovrano di Persia, invisa però ai concittadini delle loro stesse poleis.
Per comprendere il sistema internazionale a cui afferivano le famiglie tiranniche ateniesi
nell’ultimo quarto del VI secolo diventa imprescindibile prendere atto dell’espansione
dell’impero persiano in Europa, cioè in Ellesponto e in Tracia284. Si è riconosciuta infatti una
serie di interessi strategici ateniesi proprio nell’area dell’Egeo nordorientale: la colonia di Sigeo
in Troade, la colonia in Chersoneso Tracico, l’accesso alla rotta marittima attraverso
l’Ellesponto e verso il Ponto Eusino. Direttamente interessate furono perciò le comunità dei
coloni ateniesi là stanziati che dovettero necessariamente accettare l’annessione persiana;
indirettamente però anche la stessa Atene risentì delle modificazioni che avvenivano in
Ellesponto. Le parole di Milziade II all’Istro, nella misura in cui si voglia accettarne il grado di
storicità, segnalano la delusione del tiranno per la dipendenza in cui egli e la sua comunità
dovevano versare nei confronti della Persia. Come Milziade II, anche i Pisistratidi stanziati a
Sigeo dovettero adeguarsi a fare riferimento al Gran Re per le questioni relative alla politica
estera; con la conquista della Tracia da parte di Megabazo si è ricostruito inoltre che i
Pisistratidi persero il controllo dell’insediamento minerario sul fiume Strimone, regione peraltro
ambita anche dai tiranni di Mileto e dallo stesso strategòs persiano. Le scelte operate da
Milziade II e da Ippia segnano due percorsi diversi che giunsero infine ad essere opposti uno
all’altro. Il primo, fin dal discorso all’Istro, progettò il distacco e l’indipendenza del Chersoneso
Tracico dall’impero persiano e perseguì attività di matrice anti-persiana compromettendosi al
punto da dover abbandonare infine gli insediamenti familiari e rientrare ad Atene nel 493.
Viceversa Ippia colse nell’espansione del potere di Dario la necessità di adeguarsi e ritagliare
284
TOZZI 1978, pp. 125s., 160-163.
256
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
per la sua famiglia una posizione entro la rete di alleanze personali del sovrano di Persia e man
mano che, nel corso degli anni, i suoi referenti internazionali in Grecia vennero a mancare egli
andò avvicinandosi alla corte persiana. È dunque un caso emblematico della storia il fatto che la
battaglia di Maratona vide Milziade e Ippia fronteggiarsi infine da due schieramenti opposti,
rispettivamente quello ateniese e quello persiano: tanto il conflitto quanto la posizione dei due
tiranni nel 490 sono l’esito finale dei processi storici che si stanno ora analizzando.
V.5.5. Milziade II alleato di Dario durante la Spedizione Scitica (513)
I Filaidi, si è ricostruito, potevano vantare un rapporto personale favorevole con la
dinastia dei Mermandi che regnò in Lidia fino al 546: in virtù dell’alta considerazione in cui
Creso teneva Milziade I il re di Lidia intervenne per la liberazione del tiranno del Chersoneso
Tracico quando questi fu catturato dai Lampsaceni nel corso del conflitto scoppiato fra questi
ultimi e i coloni ateniesi. L’analisi di quelle circostanze ha portato a concludere che fra
Milziade I e Creso veniva in effetti riattivata una relazione di ospitalità interfamiliare che i due
avevano essi stessi ereditato dalle precedenti generazioni285.
In merito ai contatti fra la tirannide dei Filaidi in Chersoneso Tracico e l’impero degli
Achemenidi, la prima attestazione di cui si dispone presenta Milziade II come uno dei tiranni
strategòi che condussero il contingente navale ellenico nella spedizione scitica di Dario, nel
513. Quando i comandanti greci discussero la proposta degli Sciti di distruggere il ponte di
barche e tagliare così l’unica via per la ritirata di Dario dalla Scizia, fu Milziade II l’esponente
che parlò a favore della proposta degli Sciti, con il proposito di assicurare alla Ionia e ai Greci
d’Asia la libertà dalla Persia286.
Esiti svantaggiosi per i Filaidi nella fine del regno di Lidia dei Mermnadi
Le fonti sono d’altronde mute in merito ai contatti fra Filaidi e impero persiano per tutto il
periodo precedente, sulla reazione cioè di Milziade I di fronte al sopraggiungere della Persia e
degli Achemenidi quale nuovo potere egemonico in Anatolia. Se è però attendibile l’ipotesi di
un’alleanza dei Filaidi con i precedenti sovrani di Lidia della dinastia dei Mermnadi, la caduta
di Sardi nel 546 e la conseguente fine del regno lidio di fronte alla conquista di Ciro il Grande
dovettero segnare un momento drammatico nel quadro del sistema internazionale conosciuto da
Milziade I. La conquista persiana della Lidia potrebbe avere determinato persino una fase di
crisi per la rete di alleanze internazionali dei Filaidi, ovvero un momento di debolezza
285
286
Hdt. VI 37s. Vd. supra, pp. 203ss.
Hdt. IV 137.
257
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
diplomatica per la tirannide dei Filaidi in Chersoneso, poiché venne allora a mancare un alleato
che era stato a loro favorevole e che si era infatti già dimostrato capace di influenzare a loro
favore il comportamento delle poleis della regione dell’Anatolia nordoccidentale.
Un’ipotesi per l’istituzione dei contatti fra Milziade II e Dario
Come tutti i tiranni e i poteri politici dell’Asia Minore, anche i Filaidi trovarono una
nuova collocazione entro il quadro dei soggetti politicamente attivi e dei funzionari dell’impero
achemenide. Nonostante i legami con i precedenti sovrani di Lidia, o forse in virtù di essi,
Milziade I e i suoi successori riuscirono ad entrare in contatto con il Gran Re di Persia. La
storiografia non fornisce assolutamente dati in merito alle modalità con cui la tirannide filaide
del Chersoneso venne in contatto con i sovrani achemenidi: si possono nondimeno proporre
alcune riflessioni e alcune congetture in base alla contestualizzazione storica più appropriata per
l’istituzione di quelle relazioni, in base ai modelli storici finora elaborati.
Nel 520 ca. morì Stesagora che aveva tenuto la tirannide in Chersoneso Tracico e
Milziade II giunse velocemente da Atene con una trireme per raccogliere la gestione degli affari
familiari e pubblici della tirannide. Al suo arrivo in Chersoneso Milziade II dovette affrontare
l’avversione della classe aristocratica locale al potere tirannico della sua famiglia: si è
ricostruita infatti la vicenda che lo portò a distaccarsi dall’aristocrazia ellenica delle poleis del
Chersoneso, ad assumere un controllo tirannico più violento e repressivo, a trasferire perciò la
sua base di consenso sociale sulla componente tracia e a trovare un nuovo alleato locale nel re
dei Traci Oloro287. Essenzialmente dunque si è identificata nel potere di Milziade II la fase di
involuzione tirannica del governo filaide sul Chersoneso Tracico e la perdita della
legittimazione al suo potere da parte dei concittadini288.
Secondo il suddetto modello storico, questo quadro della politica locale risponde
perfettamente alle esigenze che spinsero, in genere, le tirannidi a ricercare non più entro la
propria polis, ma piuttosto nello scenario internazionale nuovi alleati potenti che con mezzi
diplomatici, militari ed economici superiori assicurassero il loro potere indipendentemente
dall’avversione aristocratica all’interno della loro comunità. Come si è esposto, questo è il
modello di comportamento che segnò l’inserimento delle tirannidi micrasiatiche sotto la
protezione dei sovrani di Persia289. Contemporaneamente all’arrivo di Milziade II in
Chersoneso Tracico, in Persia Dario I era salito al trono, nel 521, e andava riassestando il potere
287
Hdt. VI 38s.
Vd. supra, pp. 228ss.
289
ANDREWES 1958, pp. 116-127; TOZZI 1978, pp. 118-124; OLMSTEAD 1982, pp. 79-102; BURN 1985, pp. 295296; GRAF 1984, pp. 15s.; AUSTIN 1990, pp. 289-292, 295, 306; LURAGHI 1998; WIESEHÖFER 2003, pp. 28-71;
ANDERSON 2005, pp. 209-218.
288
258
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
del Gran Re sui territori dell’impero: queste circostanze mi paiono particolarmente appropriate
per contestualizzare l’avvio di una relazione di alleanza reciproca personale fra Milziade II e
Dario e, per estensione, una condizione di dipendenza dell’insediamento coloniale ateniese in
Chersoneso Tracico dall’impero persiano. Milziade II si trovò cioè nella necessità di rinsaldare
il proprio potere tirannico contro le aspirazioni della classe politica locale, e dovette allora
pensare di rivolgere i propri contatti diplomatici alla corte di Susa, come altri tiranni e Greci
avevano già fatto con successo (si consideri il caso di Silosonte di Samo, nel 520 ca.290). Dario
I, da poco salito al trono, dovette dal canto suo scorgere nell’alleanza con Milziade II la
possibilità di acquisire la fedeltà di una famiglia da tempo instaurata in Ellesponto e già
riconosciuta come un valido alleato dai precedenti sovrani di Lidia. È possibile dunque che
Dario abbia fornito risorse o ricchezze necessarie a Milziade II per reprimere l’opposizione
dell’aristocrazia locale chersonesita e che dunque Milziade II si sia da quel momento ritrovato
in debito verso il Gran Re; anzi, la sua stessa posizione di comando autocratico in Chersoneso
Tracico può essere dipesa dall’intervento persiano.
Se questa ricostruzione è valida, la relazione fra Milziade II e Dario si limitava ad una
alleanza personale, un vincolo di reciprocità fra due individui; d’altro canto le ricadute sul
piano politico e interstatale dipendevano dalle loro posizioni di comando nelle rispettive realtà
politiche. La relazione tra l’insediamento coloniale ateniese del Chersoneso Tracico e l’impero
persiano potrebbe essere rimasta esclusa, o potrebbe essere rimasta piuttosto informale,
perlomeno fino all’epoca del passaggio persiano in Europa, cioè oltre l’Ellesponto, nel 513. Si
tratta dunque di una relazione in parte diversa da quanto si è analizzato nel ricostruire il
modello storico delle tirannidi elleniche micrasiatiche entro la compagine imperiale
achemenide: nel caso dei territori dell’Asia Minore, il tiranno era legato al sovrano achemenide
con un vincolo di reciprocità e d’altro canto la polis era a tutti gli effetti un territorio
dell’impero persiano, dunque obbligata a fornire tributi e leva militare e a rispettarne le direttive
politiche. Diversamente, per il Chersoneso Tracico è necessario considerare che l’impero
persiano non poteva certamente esercitare la propria autorità politica diretta su di un territorio
che si trovava oltre l’Ellesponto, in Europa.
L’alleanza fra Milziade II e Dario prevedeva naturalmente lo scambio di doni e favori
reciproci: Dario potrebbe dunque avere contribuito a fornire le risorse necessarie a Milziade II
per conservare il potere tirannico; Milziade II dal canto suo disponeva di risorse economiche e
militari infinitamente minori di quelle del Gran Re e aveva dunque limitati mezzi per rispettare
290
Hdt. III, 139-141, 144-149. GERNET-HAMILTON-NAGY 1981, pp. 100s.; ANDERSON 2005, pp. 209-220.
259
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
l’obbligo morale a ricambiare il dono del proprio ospite. Perché l’alleanza fra i due fosse
vantaggiosa anche per Dario, Milziade II non poté fornire altro che la sua lealtà: avrebbe
dunque associato da quel momento il suo operato in campo internazionale al rispetto delle
necessità e delle richieste di Dario e della Persia. Passando per il ruolo direttivo di Milziade II
in Chersoneso Tracico, Dario poté naturalmente aspettarsi che il tiranno estendesse la
dipendenza personale che li legava individualmente anche entro le rispettive pertinenze
statali291. In sostanza, seppure il Chersoneso rimanesse estraneo all’Asia e ai territori persiani,
Dario poté associare quel territorio e le sue entità politiche entro l’area di influenza della Persia
tramite l’alleanza personale che il Gran Re strinse con il tiranno Milziade II. In questo senso
infine si può rendere conto del contributo di navi e uomini fornito dal Chersoneso Tracico, sotto
il comando di Milziade II, per la spedizione scitica di Dario nel 513.
Obiezioni alla storicità dei discorsi all’Istro
La critica ha avanzato significative cautele sia sulla cronaca di Erodoto della spedizione
scitica di Dario I, sia specificamente sulla sua versione dell’assemblea dei tiranni greci all’Istro.
Da un lato infatti lo storico dimostra di avere avuto a disposizione ottime fonti che permisero di
conoscere approfonditamente la regione e l’etnografia degli Sciti, ma per altro verso la cronaca
della campagna militare risente di numerose approssimazioni e di punti poco limpidi
relativamente alle sezioni sui combattimenti fra Persiani e Sciti oltre l’Istro292. La storiografia
moderna ha criticato la notizia della mozione anti-persiana attribuita a Milziade II come un
elemento della narrazione artefatto, o perlomeno non storicamente attendibile, prodotto da
informatori di parte filaide. È un problema infatti ricorrente e già constatato nella ricostruzione
delle vicende relative alla tirannide dei Filaidi quello di riconoscere nelle notizie preservate
elementi inventati o travisati di proposto dagli informatori ateniesi filo-filaidi nell’ambito della
revisione operata dalla famiglia sulla propria storia tirannica in occasione del processo, appunto
per tirannide, a cui Milziade II fu sottoposto nel 493 al suo rientro in patria293.
Esistono significative circostanze contestuali e storiche che potrebbero avere incoraggiato
i Filaidi a fabbricare questo discorso di matrice filellenica, anti-persiana e anti-tirannica, a
favore della libertà della Ionia. L’anno precedente il rientro ad Atene dei Filaidi, i contingenti
ellenici avevano subito la sconfitta nella battaglia di Lade e Mileto aveva subito una tragica ed
esemplare punizione ad opera dei Persiani294. Nel quadro di un’opinione pubblica ateniese
291
HERMAN 1987, pp. 31-34, 43-45, 73-106, 118-122; AUSTIN 1990, pp. 289-292, 295-306; MITCHELL 1997, pp.
23-30, 54-55, 71, 111-120, 131-133; LURAGHI 1998, pp.24-45.
292
FOL-HAMMOND, 1988, pp. 235-243; WEST 2002.
293
AUSTIN 1990, pp. 289-291, 295-306.; BURY 1897.
294
Hdt. VI 18-22.
260
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
scossa e addolorata, il discorso attribuito a Milziade II da Erodoto avrebbe potuto contribuire a
dissociare i Filaidi da una scomoda alleanza con la Persia e con Dario, ovvero a caratterizzare il
loro comando in Chersoneso in modo diametralmente opposto alle tirannidi micrasiatiche
espulse dagli Ioni nella rivolta del 499; soprattutto le parole attribuite a Milziade II nei fatti del
513 suonano come un’anticipazione del pensiero anti-tirannico e anti-persiano che portò i Greci
d’Asia a unirsi per scuotere il giogo persiano nel 499295.
Ci si può interrogare in merito a quanto apertamente o esplicitamente Milziade II dimostrò
la propria opinione nell’assemblea dell’Istro, sulla circolazione che poterono avere le sue
parole, sia nel 513 che negli anni successivi e fino alla loro acquisizione da parte di Erodoto a
metà del V secolo. Le obiezioni avanzate sulla storicità dei fatti fanno notare che Dario non
sembrerebbe avere tenuto in grande considerazione il tentativo di sedizione di Milziade II
poiché, se da un lato ricompensò la fedeltà di Istieo e di Coes, d’altro canto non si conservano
narrazioni esplicite in merito a decisioni punitive contro Milziade II296. Se la notizia
dell’assemblea dei tiranni e della posizione assunta da Milziade II giunse fino ad Erodoto nel V
secolo, difficilmente non sarebbe però giunta all’attenzione del Gran Re durante le operazioni
in Europa.
Ricostruzione della storicità dei fatti dell’Istro
Nonostante le obiezioni sopra esposte non mi pare vi siano motivi sufficienti per dubitare
della storia tramandata da Erodoto al punto da considerare la narrazione dei fatti dell’Istro come
un’invenzione e dunque eliminare del tutto queste circostanze dalla ricostruzione storica. Una
serie di fattori si assomma per contribuire alla ricostruzione, a mio avviso sicura, del fatto che
una qualche sorta di incidente di natura sediziosa dovette avere luogo fra i Greci che
presiedevano il ponte sull’Istro nel 513297.
In primo luogo è chiaramente attestata, oltreché naturale, l’esistenza di un sentimento e di
una strategia anti-persiana fra i Greci coinvolti dall’espansione persiana in Europa: quando
Otane prese il comando delle operazioni in Europa, nel 512, egli dovette procedere a
conquistare le poleis di Calcedone, Bisanzio, Antandro e Lamponio poiché queste, durante o
poco dopo la spedizione scitica di Dario, si erano opposte alle operazioni del Gran Re298.
Questo dato è da considerarsi come il segno sicuro del fatto che esistevano delle poleis che, nel
513-512, intervennero attivamente contro la Persia: la linea politica anti-persiana e libertaria e
295
Sulla reazione degli Ateniesi alla tragedia di Frinico sulla presa di Mileto: Hdt. VI 21.
BURY 1897, p. 278.
297
BURY 1897; ISAAC 1986, pp. pp. xi-xiv, 40-51
298
Hdt. V 25-27.
296
261
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
la scelta strategica di operare nel momento delicato della campagna scitica dimostrate, nei fatti,
da questo gruppo di poleis sono le medesime che si riscontrano, d’altro canto, nella retorica del
discorso di Milziade II all’Istro. È inoltre significativo che si tratti di un gruppo di poleis tutte
afferenti all’area strategica dell’Ellesponto e della Propontide entro cui si può collocare appunto
anche il Chersoneso Tracico: dunque le classi di governo di quelle poleis e Milziade II
condividevano i medesimi interessi internazionali e regionali, le medesime strategie e le
medesime considerazioni rispetto al potere persiano. È verosimile che l’iniziativa, o perlomeno
la posizione politica, di queste poleis fosse nota ai tiranni riuniti all’Istro e che i progetti di
intervento e la capacità politica e militare di queste poleis abbiano costituito un elemento di
considerazione e valutazione durante i dibattiti nell’assemblea dei tiranni: la proposta antitirannica di Milziade II fece cioè probabilmente riferimento a questo elemento strategico nel
tentare di convincere gli astanti.
È noto che a conclusione della campagna scitica Dario premiò Coes di Mitilene e Istieo di
Mileto per i servizi da loro resi alla causa persiana299. La gratitudine di Dario non si
spiegherebbe se non si fosse verificato un qualche incidente fra i Greci in virtù del quale
l’intervento appunto di questi due tiranni contribuì in qualche modo alla salvaguardia degli
interessi di Dario e della Persia. Se il contingente ellenico fosse rimasto fedele non si
intenderebbe altrimenti quale posizione speciale Coes e Istieo avrebbero guadagnato rispetto ai
loro pari. Altresì, se i discorsi di Milziade II e Istieo fossero un’invenzione letteraria erodotea,
Dario non avrebbe avuto motivo per premiare Istieo con la fondazione di Mircino in Tracia300.
Sul piano delle operazioni strategiche, dunque, Otane punì le poleis che si ribellarono e
parimenti sul piano della diplomazia aristocratica Dario premiò i tiranni che rimasero a lui
fedeli.
Si è obiettato contro la veridicità storica di Erodoto notando che Milziade II non avrebbe
subito ritorsioni in seguito alla sua dissidenza all’Istro, a differenza appunto delle poleis prese
d’assalto da Otane nel 512; ritengo invece che si possano identificare le circostanze successive
al 513 in cui il potere persiano rivolse il proprio intervento contro il Chersoneso Tracico. La
narrazione erodotea offre infatti un passaggio di difficile lettura e interpretazione che testimonia
nondimeno, proprio per gli anni fra la spedizione scitica e la rivolta ionica; la necessità per
Milziade II di abbandonare, forse a più riprese, il Chersoneso301. L’attacco persiano giunse poi
effettivamente nel 493 e Milziade II decise allora di fuggire ad Atene: il movente per
299
BLAMIRE 1959.
EVANS 1970.
301
Hdt. VI 40. SEALEY 1973, p. 19; ISAAC 1986, pp. pp. xi-xiv, 40-51; AUSTIN 1990, p. 291. Vd. infra, pp. 266ss.
300
262
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
l’intervento è da contestualizzarsi in primo luogo nei disordini della rivolta ionica, nondimeno
lo stesso Erodoto lo interpreta come una ritorsione per la dissidenza all’Istro302. La posizione
anti-persiana che Milziade II esprime nella narrazione di Erodoto in occasione dell’assemblea
all’Istro è peraltro coerente con la condotta seguita negli anni successivi durante la rivolta
ionica, ovvero con la conquista di Lemno e Imbro, che può interpretarsi essenzialmente in
funzione antipersiana303. Dal punto di vista strategico, il Chersoneso Tracico sembra essere
stata una posizione favorevole e difendibile tanto da giustificare il ritardo della ritorsione
persiana: già Milziade I aveva fortificato la strettoia all’imbocco della penisola e nemmeno
durante la repressione della rivolta ionica la flotta fenicia riuscì a conquistare tutti i porti
chersonesiti304.
In conclusione ritengo che il quadro fornito da Erodoto delle opinioni politiche e
strategiche dei tiranni greci durante la spedizione scitica sia da accettarsi come una valida
testimonianza storica. Valide sono le obiezioni contro un’accettazione letterale della versione
erodotea e contro una caratterizzazione estremizzata dei propositi antipersiani attribuiti a
Milziade II; d’altronde i momenti, i protagonisti e le posizioni politiche della vicenda sono
storicamente attendibili e risultano coerenti con il contesto storico e con gli interessi in gioco in
quel momento. Si può disconoscere che il punto in discussione nell’assemblea fosse
effettivamente la rottura del ponte di barche all’Istro e forse finanche la proposta di disertare
l’esercito persiano. Il tema del taglio del ponte di barche è peraltro ripetuto a distanza piuttosto
ravvicinata nella narrazione erodotea in contesti diversi e con moventi inverosimili305. Di taglio
letterario sono anche una serie di altri dettagli del racconto: ad esempio le istruzioni del Gran
Re di attendere il suo ritorno per 60 giorni e altrimenti lasciare l’Istro senza di lui306. In questo
senso, è indubbiamente in azione nelle parole attribuite a Milziade II una componente di
invenzione letteraria: è dunque necessario ammettere di non poter giungere ad una ricostruzione
storica esatta di quanto avvenne fra i Greci all’Istro.
È fuori di dubbio d’altronde che fra i Greci incorporati nell’impero persiano esistessero
opinioni numerose e diverse in merito alla posizione da adottare nei confronti del potere
persiano, che potevano variare sia da polis a polis, in ragione delle posizioni geografiche e degli
interessi strategici, sia in base ai diversi gruppi sociali all’interno delle singole poleis: le parole
302
Hdt. VI 41. SEALEY 1973, p. 19; A ISAAC 1986, pp. pp. xi-xiv, 40-51; AUSTIN 1990, p. 291; MAZZARINO 2007,
pp. 238-243.
303
Hdt. VI 136, 140. COX 1876, p. 69.
304
Hdt. VI 33, 37. WALLINGA 1984, pp. 411-436; ISAAC 1986, pp. pp. xi-xiv, 40-51; DAVERIO ROCCHI 1988, pp.
46, 234-240 sul significato territoriale del sistema difensivo di Milziade I.
305
Hdt IV 97.
306
Hdt. IV 98.
263
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
attribuite a Milziade II e ad Istieo rappresentano le posizione estreme ed opposte. La
conclusione che mi pare corretto seguire ammette dunque che durante la spedizione scitica di
Dario si sia verificato un moto di dissidenza e distacco fra i sudditi greci dell’impero, sia fra le
poleis dell’area della Propontide ed Ellesponto, sia fra i generali ellenici del contingente navale
all’Istro307. Il contributo greco alla spedizione scitica fu certo significativo: perciò, quando
sopraggiunsero difficoltà serie nella ritirata persiana dalla Scizia, è verosimile che i tiranni greci
si siano interrogati sulla possibilità di sfruttare in modo per loro vantaggioso tale situazione.
Certamente entrò in discussione l’opportunità per quel gruppo di élite di rimanere o meno fedeli
agli impegni personali e politici che li legavano al Gran Re e viceversa l’opportunità di
appoggiare il moto di ribellione che le poleis di Calcedone, Bisanzio, Antandro e Lamponio
avevano avviato o erano in procinto di avviare. Se pure la narrazione erodotea non può
prendersi alla lettera per ricostruire la parole e le azioni di Milziade II e Istieo, non è però da
mettere in dubbio che i due tiranni furono coinvolti in decisioni drammatiche e cruciali per
l’esito delle conquiste della Persia in Europa; è un dato da conservare inoltre il fatto che uno e
l’altro assunsero posizioni fra loro opposte: quella di Istieo era di carattere filo-persiano e quella
di Milziade filellenica, se non anti-persiana308.
Le ragioni della posizione antipersiana di Milziade II
Fra i soggetti legati a Dario I, proprio Milziade II è particolarmente suscettibile di avere
assunto una posizione se non anti-persiana certamente indipendentista. Si è visto come la
tirannide filaide in Chersoneso rispondesse non solo agli interessi di potere personale della
famiglia, ma anche alle necessità strategiche internazionali di Atene stessa, in quanto il
Chersoneso Tracico assicurava una rotta commerciale fino all’area del Ponto Eusino. Con
l’espansione in Europa della Persia e dunque l’incorporamento della Propontide e
dell’Ellesponto e della Tracia nell’impero persiano, Atene rischiava di vedere compromessi gli
interessi che manteneva in quell’area, a favore dei sudditi ellenici delle poleis ioniche. Milziade
II dovette dunque certamente considerare svantaggioso per gli interessi della madrepatria la
creazione nella Propontide di un mare persiano309.
Come si è anticipato, il Chersoneso Tracico godeva di una posizione strategica che
Milziade II può avere considerato particolarmente vantaggiosa nell’eventualità di un attacco
persiano: in virtù della relativa sicurezza e difendibilità dei suoi insediamenti Milziade II poté
307
TOZZI 1978, p. 127; ISAAC 1986, pp. pp. xi-xiv, 40-51.
BURY 1897; BLAMIRE 1959; EVANS 1970. Sulla vexata quaestio dell’attendibilità di Erodoto e sul carattere dei
discorsi diplomatici in Erodoto, v: GAZZANO 2002, pp. 10-24.
309
WADE-GERY 1951, p. 116-119; BERVE 1967, pp. 85-88; TOZZI 1978, pp. 125s.
308
264
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
parlare coraggiosamente all’Istro310. Il Chersoneso si trova infatti in Europa, oltre il braccio di
mare dell’Ellesponto che lo separa dall’Asia; nel 513 era chiaro inoltre ai tiranni che Dario
doveva affidarsi appunto ai Greci per valicare l’Ellesponto, o il Bosforo, nonché per la
navigazione. Alla luce di queste considerazioni strategiche e geografiche Milziade II poteva
ritenersi al di fuori dell’ambito di intervento dell’immenso esercito terrestre che l’impero
achemenide poteva coscrivere in Asia. Ancor più al sicuro sarebbero stati gli insediamenti
europei di Milziade II se egli fosse riuscito a portare dalla sua parte anche gli altri tiranni
ellenici e dunque a togliere al Gran Re la sua flotta. A discapito delle considerazioni che qui si
attribuiscono a Milziade II, è vero che la Persia disponeva già nel 513 delle capaci flotte di
Cipro e della Fenicia: nondimeno si ribadisce che Milziade II e i Greci, se pure ne erano a
conoscenza, certamente non potevano comprendere la portata e la capacità della flotta asiatica;
piuttosto, nel 513, i tiranni constatavano di ricoprire un ruolo cruciale nelle strategie marittime e
fluviali persiane. È vero anche che nel corso della rivolta ionica fu proprio la capacità marittima
dei Greci l’elemento a loro favore e che il Gran Re mise in campo un capace flotta persiana solo
nella battaglia di Lade e poi nelle ultime fasi della repressione311. Di importanza strategica
rimanevano inoltre le fortificazioni sull’istmo erette da Milziade I che avrebbero protetto il
Chersoneso Tracico dagli attacchi provenienti dal continente europeo312.
Come si è già ricordato, la storia familiare dei Filaidi li associava alla dinastia dei
monarchi lidi Mermnadi: il fatto che gli Achemenidi avessero conquistato la Lidia ed eliminato
uno degli alleati personali dei Filaidi può, a mio avviso, essere stato un ulteriore motivo perché
Milziade II non stimasse la relazione a cui Dario lo legava.
In conclusione la ricostruzione che mi pare più corretto seguire per comprendere la
posizione di Milziade II nei confronti dell’impero persiano è quella di un tiranno che era
diventato un alleato personale del Gran Re nelle prime fasi del suo potere, i cui territori erano
sottoposti ad una pressione coercitiva territoriale inferiore a quella che manteneva leali gli altri
strategòi ellenici della spedizione scitica313. La conquista dei territori europei da parte della
Persia venne dunque a ledere la libertà politica di cui Milziade II aveva fino a quel momento
goduto, mise in pericolo le pertinenze territoriali dei Chersonesiti e la sicurezza della penisola,
310
ISAAC 1986, pp. 16-20, 33s., 146-148, 163-174; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 46, 234-240 sul sistema difensivo
che Milziade I aveva edificato sull’istmo.
311
Hdt. V 108s., VI 6, 14, 25, 28, 33, 41. SEALEY 1973, p. 19; WALLINGA 1984, pp. 411-436; ISAAC 1986, pp. pp.
16-20, 33s., 146-148, 163-174; AUSTIN 1990, p. 291.
312
Hdt. VI 37. ISAAC 1986, pp. pp. 16-20, 33s., 146-148, 163-174.
313
ISAAC 1986, pp. pp. 16-20, 33s., 146-148, 163-174.
265
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
infine venne ad intaccare la libera disponibilità commerciale dei naviganti che giungevano in
Ellesponto dalla madrepatria314.
A compensazione di questi pesanti svantaggi Milziade II non aveva alcun ulteriore
privilegio o prospettiva, a differenza invece delle prospettive che muovevano gli altri tiranni
delle poleis micrasiatiche della Ionia: per questi l’espansione persiana in Europa avrebbe
significato un ampliamento dell’areale politico e dunque commerciale della loro influenza e la
conquista della nuova satrapia di Tracia avrebbe aperto possibilità di ricollocamento politico e
geografico e opportunità di sfruttamento economico (come fu per Istieo). Per Milziade II
l’espansione persiana in Europa avrebbe invece comportato la presenza dell’esercito del Gran
Re alle porte del Chersoneso e l’ingerenza di nuovi funzionari imperiali e di tiranni in aree che
erano fino ad allora di sua pertinenza.
È possibile che Milziade II non abbia assunto ed espresso una posizione
intransigentemente ed esplicitamente antipersiana durante la spedizione all’Istro; certamente
però maturò proprio in quel momento la volontà di liberarsi dal vincolo di fedeltà verso la
Persia e già allora dovette ritenere opportuno che la spedizione in Europa non giungesse a buon
esito315. Senz’altro già nelle fasi degli incidenti e del moto di dissidenza durante la campagna di
Dario oltre l’Istro Milziade II dovette compromettere la propria posizione. Con il rientro di
Dario e dell’esercito persiano in Asia è verosimile che la posizione antipersiana di Milziade II
sia andata invece esplicitandosi sempre più: si riconosce una valenza antipersiana degli
interventi di Milziade II a Lemno e Imbro ed è possibile che egli si sia schierato con i Greci
nella rivolta ionica316: la conclusione della repressione della rivolta pone i Filaidi del
Chersoneso Tracico fra le fila dei rivoltosi antipersiani che dovettero evitare il confronto con le
forze del Gran Re.
V.5.6. La strategia antipersiana di Milziade II (512-493)
Nella ricostruzione della storia della tirannide di Milziade II in Chersoneso Tracico e
specificamente nella ricostruzione della sua posizione politica e delle sue iniziative nei
confronti della Persia, l’analisi risente di una certa limitatezza delle fonti storiografiche: si
dispone infatti, tramite Erodoto, di dati relativi alla sua partecipazione alla spedizione scitica di
314
BERVE 1967, pp. 85-88; TOZZI 1978, pp. 125s.
SEALEY 1973, p. 19; AUSTIN 1990, p. 291.
316
ISAAC 1986, pp. pp. 16-20, 33s., 146-148, 163-174.
315
266
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Dario, nel 513, particolarmente in merito all’episodio sedizioso all’Istro317; dopodiché ulteriori
informazioni specifiche sui rapporti fra Milziade II e l’impero persiano riguardano la fuga dei
Filaidi dal Chersoneso Tracico, durante la repressione della rivolta ionica nel 493318. Rimane
fra i due estremi cronologici un divario di un ventennio in relazione al quale le fonti non
forniscono una narrazione storica univoca, ma piuttosto notizie frammentarie319. In quel
ventennio ebbero luogo significativi interventi persiani in Asia Minore, in Ellesponto e in
Europa: insieme a Dario e successivamente al suo rientro in Asia il generale persiano Megabazo
sottomise la Tracia europea e il regno di Macedonia nel 512320; l’anno seguente Otane fu
impegnato in Ellesponto e nell’Egeo nordorientale contro le poleis elleniche321. Di fronte a
queste campagne militari significative per gli interessi ellenici in Asia non sembra si possa
conoscere la reazione di Milziade II.
È però proprio durante la spedizione scitica che Milziade II passò dall’essere uno dei
tiranni-hýparchoi che accompagnarono Dario ad essere il portavoce nell’assemblea dei tiranni
greci della fazioni anti-persiana e favorevole alla ribellione; da quelle circostanze in poi
Milziade II compromise le relazioni con la Persia al punto da considerarsi un nemico della
Persia quando, alla fine del periodo in oggetto, la repressione della rivolta ionica toccò il
Chersoneso Tracico. La ricostruzione di quel periodo storico contribuirebbe a collocare in un
quadro diacronico l’evoluzione delle opinioni politiche di Milziade II e delle sue scelte
strategiche in ambito internazionale e regionale: essenzialmente cioè il passaggio, o le fasi di
passaggio, dalla condizione di tiranno associato e dipendente a Dario a quella di condottiero
anti-persiano.
Interpretazione di Erodoto VI, 40 sulla fuga dal Chersoneso Tracico
A fornire alcune informazioni sulle vicende di Milziade II nel periodo fra la spedizione
scitica e il rientro in Atene, interviene uno dei passi di più complessa lettura dell’opera
erodotea.
Milziade figlio di Cimone era da poco giunto in Chersoneso Tracico quando fu
colpito da disagi peggiori (πρηγµάτων χαλεπώτερα) di quelli che lo avevano colpito in
precedenza. Nel terzo anno da questi avvenimenti, già egli era dovuto fuggire di fronte
agli Sciti, i quali si erano spinti fino in Chersoneso Tracico perché erano stati
provocati da Dario. Milziade non attese l’attacco e fuggì dal Chersoneso, i nemici
317
Hdt. IV 136-139.
Hdt. VI 41.
319
BURN 1962, p. 220.
320
IV, 143; V, 2, 10, 15-21.
321
Hdt. V 25-27.
318
267
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
lasciarono poi il territorio e i Traci Dolonci riportarono Milziade in Chersoneso.
Questi fatti ebbero luogo nel terzo anno prima delle cose che impegnavano Milziade in
quel momento322.
A questa narrazione segue immediatamente il resoconto della fuga di Milziade II dal
Chersoneso all’arrivo della flotta fenicia durante la repressione della rivolta ionica nel 493323.
Nel corso della storia degli studi il passo è stato oggetto di interpretazioni numerose,
differenti e fra loro discordanti324. Il capitolo fornisce due volte una nota cronologica
relativamente a periodi di (o al medesimo periodo) tre anni, oltreché un primo riferimento
temporale non oggettivo ad un periodo di breve durata prima dell’emergere di una situazione di
difficoltà non meglio specificata. Le incertezze nell’interpretazione del testo sorgono già nel
tentativo di comprendere se le due menzioni cronologiche, dei tre anni, siano da riferirsi a due
diversi lassi di tempo oppure ad un medesimo periodo325. Le difficoltà maggiori nondimeno
emergono nell’intendere a quali eventi della biografia di Milziade II Erodoto intendesse
ancorare i riferimenti cronologici. L’arrivo in Chersoneso menzionato all’inizio del passo viene
spesso interpretato come il momento in cui Milziade II giunse da Atene per prendere possesso
della tirannide, ma nulla nel testo impone quell’identificazione326. Successivamente il testo
menziona due situazioni o periodi di difficoltà e fra loro pone un paragone ritenendo una
situazione più grave dell’altra: anche in questo caso la critica è discorde nell’identificazione
poiché Milziade II fu in difficoltà al momento del suo primo arrivo, come poté anche esserlo
nelle fasi in cui rientrò in Chersoneso Tracico dopo la spedizione oltre l’Istro: il testo menziona
d’altronde anche la scorreria degli Sciti e infine l’opera erodotea descrive altre difficoltà
ulteriori per Milziade durante la repressione della rivolta ionica; in alternativa potrebbe trattarsi
di un riferimento alla operazioni di Megabazo in Tracia nel 513-512327. L’ultimo riferimento
del capitolo alle vicende in cui Milziade II sarebbe stato impegnato allora è generalmente inteso
come un rimando agli eventi della funga dal Chersoneso Tracico, narrati infatti nel successivo
capitolo. La scelta peraltro di un’identificazione o di un caposaldo cronologico o evenemenziale
spesso porta a contraddizioni con altre sezioni del passo o dell’opera erodotea.
322
Hdt. VI 40. Ringrazio il Prof. Raviola per avere contribuito a fornire di questo passo un’accurata traduzione, di
cui mi assumo nondimeno la responsabilità.
323
Hdt. VI 41. Tr. it. in NENCI 2006.
324
GROTE 1854, vol. IV, pp. 368-371; MACAN 1845, ad Hdt. VI 40, pp. 299s.; RAWLINSON 1858, ad. Hdt. VI 40,
p. 439 n. 4; WELLS 1923, pp. 118-122; HOW-WELLS 1928, ad. Hdt. VI 40 contra RAWLINSON 1858 ad loc. cit.;
HAMMOND 1956, p. 119; WADE-GERY 1951, pp. 216s.; BURN 1962, pp. 133s., 218-220; PRONTERA 1972 tratta
specificamente il passo erodoteo in questione; SCOTT 2005, app. X, pp. 522-532.
325
HOW-WELLS 1928, ad. Hdt. VI 40 a favore dell’identità fra le due menzioni di tre anni.
326
Hdt. VI 39.
327
GROTE 1854, vol. IV, p. 368; HAMMOND 1956, p. 119; NENCI 1988, ad Hdt. VI 34, cita l’opinione di J.B.
Salmon; KINZL 2011, s.v. “Milziades” [2], in BNP.
268
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
L’occupazione discontinua del Chersoneso Tracico da parte di Milziade II
Alcuni dati, pur non precisi, possono a mio avviso essere estratti per fare luce sulla storia
delle relazioni internazionali di Milziade II e per comprendere la sua posizione nello scenario
regionale e nei confronti dell’impero persiano.
Nonostante le grandi incertezze, la notizia erodotea fornisce con sicurezza il quadro di
un’occupazione discontinua del Chersoneso Tracico da parte di Milziade II nel ventennio
precedente il suo rientro ad Atene nel 493328. La narrazione menziona e coinvolge negli eventi
una pluralità di soggetti politici ed etnici. Oltre che Milziade II, si fa menzione di un’iniziativa
militare degli Sciti in Chersoneso Tracico; alla menzione degli Sciti è strettamente legato il
sovrano di Persia Dario I; i Traci Dolonci del Chersoneso compaiono nella narrazione come
fautori e associati di Milziade II.
Il testo lega senza dubbio la fuga di Milziade II ad una scorreria degli Sciti; a sua volta
questa sarebbe causata da operazioni militari di Dario contro di loro: con poche incertezze si
può identificare il contesto della campagna europea di Dario nel 513 e il conseguente
scompiglio che questa arrecò all’area dell’Ellesponto329.
Questi elementi assumono un significato storico e un senso logico se si collocano gli
eventi descritti qui da Erodoto nella cornice temporale compresa fra la fine della spedizione
scitica nel 512 e le ultime fasi della repressione della rivolta ionica nel 493: la stessa sequenza
narrativa dell’opera erodotea avvalora questa prospettiva giacché i guai di Milziade II, descritti
nel passo, vengono chiaramente associati alla spedizione scitica; inoltre il capitolo a questo
successivo tratta appunto della reazione di Milziade II all’arrivo delle forze navali persiane in
Chersoneso Tracico330.
La ritorsione persiana a seguito della sedizione di Milziade II all’Istro
Il passo qui analizzato può dunque assumersi come una testimonianza delle conseguenze
della presa di posizione anti-persiana di Milziade II durante la campagna scitica. Quando
l’esercito persiano incontrò serie difficoltà in Scizia, presso i Greci si diffuse una tendenza
antipersiana e autonomistica testimoniata sia entro l’assemblea dei tiranni all’Istro e dalla
posizione di cui Milziade II si eresse a rappresentante, sia fra le poleis elleniche dell’Ellesponto
che si ribellarono durante la campagna in Europa nonché al rientro dell’esercito in Asia331.
328
WELLS 1923, pp. 118-122; BURN 1962, pp. 133s., 218-220.
WELLS 1923, pp. 118-122; DAVIES 1971, n. 8429 VIII.
330
GROTE 1854, vol. IV, p. 368; WELLS 1923, pp. 118-122; NENCI 1988, ad Hdt. VI 34, cita l’opinione di J.B.
Salmon.
331
Hdt. V 27.2. GROTE 1854, vol. IV, p. 159; TOZZI 1978, p. 127.
329
269
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Applicando il passo erodoteo a quelle circostanze storiche, si può giungere alla
ricostruzione secondo la quale Milziade II sarebbe rientrato brevemente in Chersoneso Tracico
nella fase turbolenta della fine della spedizione scitica per poi essere presto sorpreso dal ritorno
dalla Scizia di Dario al comando di quel che restava dell’esercito persiano, nel 512. Dario
attraversò la Tracia e giunse al Chersoneso Tracico: nel passare in Europa, il Gran Re e
l’esercito attraversarono il Bosforo, a Calcedone; ma nel rientrare in Asia, è noto che il Gran Re
navigò l’Ellesponto da Sesto332. Verosimilmente il Gran Re era allora già venuto a conoscenza
della rottura degli accordi presi con i tiranni ellenici e della spaccatura fra una fazione leale e
una riottosa fra costoro. Similmente era certo noto al Gran Re il moto di ribellioni iniziato
presso le poleis elleniche dell’Ellesponto. Come Dario non tardò a porgere la propria
ricompensa a Coes e Istieo per la loro fedeltà in Europa, così anche il suo passaggio in
Chersoneso Tracico fu dunque volto a punire Milziade II per avere contribuito all’insuccesso
della spedizione scitica333.
In queste circostanze si deve collocare la scelta di Milziade II di abbandonare il
Chersoneso Tracico al fine di evitare l’immediata rappresaglia persiana e in queste circostanze
si deve identificare il riferimento all’incursione scitica provocata da Dario, di cui Erodoto fa
menzione. Concordo infatti con quegli studiosi che non ritengono verosimile il dettaglio del
testo che attribuisce agli Sciti l’organizzazione di una spedizione a sud dell’Istro dopo il 512, in
ragione peraltro degli 80.000 soldati persiani sotto il comando di Megabazo che ancora erano
stanziati nelle aree orientali della Tracia a quel tempo: allora la memoria storica di un corpo di
invasori provenienti da settentrione nel Chersoneso passò ad essere identificata con una
scorreria degli Sciti, piuttosto che con l’esercito achemenide di ritorno dalla Scizia334.
L’alleanza di Milziade II con i Traci
Secondo questa narrazione erodotea Milziade II fu riportato nella propria sede dai Traci
Dolonci: la fuga di Milziade II nel 512 fu dunque temporanea e niente affatto un abbandono
definitivo. È verosimile che Milziade II fosse al corrente delle perdite subite dall’esercito di
Dario in Scizia e si aspettasse perciò che il Gran Re sarebbe rientrato in Asia piuttosto che
fermarsi in Europa e in Chersoneso Tracico; il moto di ribellione delle poleis dell’Ellesponto
forniva poi ulteriori diversivi al controllo persiano sul Chersoneso Tracico335.
332
Hdt. IV 143.1.
WELLS 1923, pp. 118-122; BLAMIRE 1959.
334
Hdt. V 1s. GROTE 1854, vol. IV, p. 368; WELLS 1923, pp. 133s.; SCOTT 2005, app. X, pp. 528s.
335
TOZZI 1978, p. 127.
333
270
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Si è ricostruita una relazione piuttosto stretta fra Milziade II e i Traci locali, governati da
suo suocero il re Oloro336: sulla fedeltà di questo gruppo etnico Milziade II poteva dunque fare
affidamento al punto da sapere di poter lasciare la sede del Chersoneso Tracico
temporaneamente, per evitare l’immediata rappresaglia di Dario, e fare ritorno quando l’area
fosse stata sgombrata dal presidio persiano. Erodoto appunto asserisce che i Traci richiamarono
Milziade quando i nemici avevano lasciato il Chersoneso. Viceversa l’opposizione della classe
politica chersonesita ellenica potrebbe essersi riattivata in un momento di torbidi internazionali
e militari e avere costituito una ragione di politica interna perché Milziade II scegliesse la via
dell’esilio volontario337.
La fuga dal Chersoneso Tracico come scelta di mobilità strategica
La ricostruzione qui proposta identifica dunque quali furono le conseguenze della scelta di
Milziade II all’Istro: allora egli compì piuttosto un atto politico in circostanze assembleari;
subito però ne seguirono conseguenze militari effettive. Milziade II dovette dunque presto
assumere responsabilità e coscienza della scelta di campo compiuta all’Istro e da quel momento
non ebbe l’opportunità di ritornare sui propri passi. Il capitolo erodoteo qui discusso testimonia
proprio dei momenti successivi alla spedizione scitica e documenta che da allora Milziade II fu
inviso al Gran Re e dovette ricorrere alla fuga per evitare lo scontro con l’esercito persiano338.
Il quadro di discontinuità nell’occupazione del Chersoneso Tracico è stato inoltre
associato, in altre ricostruzioni della critica, non solo agli eventi strettamente successivi alla
spedizione scitica ma più in genere alle vicende che interessarono Milziade II in tutto il periodo
fra il 512 e la fine della tirannide del Chersoneso nel 493. In seguito alla defezione all’Istro e
soprattutto nel corso della rivolta ionica è verosimile che, pur mantenendo il potere
nell’insediamento chersonesita, Milziade II stesso dovette più volte fare perdere le proprie
tracce per evitare di scendere in campo contro le soverchianti forze militari della Persia; in
particolare si consideri che negli anni immediatamente successivi alla spedizione scitica furono
dislocati in Europa, in Tracia e in Ellesponto i generali persiani Megabazo e poi Otane con
ordini di condurre operazioni contro i Traci e i Greci339.
D’altro canto, l’assenza di Milziade II dal Chersoneso Tracico non deve necessariamente
cogliersi come il segno di una fuga, ma invece la testimonianza di fasi in cui Milziade II lasciò
la penisola per condurre operazioni militari o diplomatiche a sostegno della sua strategia anti-
336
Hdt VI 39.
SCOTT 2005, app. X, pp. 529 suggerisce queste questioni.
338
Hdt. VI 40. GROTE 1854, vol. IV, p. 368.
339
IV, 143; V 2, 10, 25-27.
337
271
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
persiana e filo-ateniese: egli certamente lasciò il Chersoneso per portare a termine la conquista
di Lemno e Imbro nel 500 ca. ed è verosimile che si sia poi impegnato a favore di Atene e dei
Greci nel corso della rivolta ionica. Dopo la conquista di Lemno e Imbro il tiranno deve avere
peraltro seguito una rotazione nell’occupazione e amministrazione delle diverse sedi sotto il suo
controllo340.
In conclusione questi dati collimano nel tramandare il quadro del turbolento periodo della
strategia di intervento internazionale di Milziade II fra il 512 e il 493, nel periodo successivo
alla spedizione scitica e poi una volta scoppiata la rivolta ionica. Fin da subito Milziade II passò
dalle parole ai fatti nel confrontarsi con la potenza persiana e andò conseguentemente
ridisegnando la propria strategia internazionale secondo un progetto antipersiano; egli seppe
d’altronde di non poter mai opporre una resistenza adeguata alle risorse militari della Persia.
Perciò negli anni 512-493 sfruttò il Chersoneso Tracico in quanto era la sede del suo potere
tirannico e una località di importanza strategica, ma d’altronde adoperò una strategia di
stanziamento flessibile, al fine sia di condurre spedizioni marittime, come a Lesbo o Imbro, sia
di evitare il confronto in campo aperto con l’esercito persiano.
V.5.7. Il corno di Amaltea dedicato ad Olimpia da un Milziade e i suoi soldati
Visitando il santuario di Olimpia nel II sec. d.C. il geografo Pausania ebbe modo di
vedere, fra le offerte depositate nel tesoro dei Sicionii, una dedicata allo Zeus Olimpio da parte
di uomini del Chersoneso al seguito del loro comandante Milziade: a riprova il geografo
trascrisse le parole dell’arcaica iscrizione dedicatoria341. La notizia di Pausania e il senso
dell’iscrizione pongono forse maggiori problemi di quanti non possano contribuire a risolvere,
in primis, l’identificazione del Milziade dedicatario, fra i due Filaidi che portarono quel
nome342. Eppure ritengo che la notizia costituisca un’istanza assolutamente non trascurabile: in
primo luogo offre una prospettiva nuova per intendere la forma del potere e della legittimazione
dei Filaidi nel Chersoneso; soprattutto testimonia di un contatto internazionale, pur di natura
cultuale, del tiranno e insieme della sua comunità verso il santuario panellenico di Olimpia e,
per tramite di questo, verso il pubblico aristocratico che vi si riuniva.
340
Hdt. VI 140; Diod. Sic. X 19.6. GROTE 1854, vol. IV, p. 159; WELLS 1923, pp. 118-122; SCOTT 2005, app. X,
pp. 528s.
341
Paus. VI 10.8, 19.6.
342
DENHAM 1902, pp. 144s.; HAMMOND 1956, pp. 123s.; MORETTI 1957, n. 106; JEFFERY 1963, p. 300; JEFFERY
1976, pp. 37s.; ISAAC 1986, pp. 170-173; GRAHAM 1993.
272
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
L’attribuzione di Pausania a Milziade I
L’offerta degna di nota consisteva in un corno che gli esegeti del santuario identificavano
nel leggendario corno di Amaltea343; sul corno Pausania lesse una dedica che trascrisse per
intero nella sua opera:
a Zeus Olimpio un’offerta gradita dal Chersoneso dedicarono coloro che
conquistarono il forte di Arato: li comandava Milziade344.
Oltre alla descrizione del corno e alla trascrizione della dedica, il testo di Pausania
fornisce una contraddittoria identificazione del Milziade dedicatario: da un lato l’autore
fornisce il patronimico di Milziade come figlio di Cimone, sulla base del quale si dovrebbe
identificare Milziade II, fratello di Stesagora e ultimo tiranno filaide del Chersoneso; d’altro
canto di questo stesso dedicatario Pausania dice che fu il primo dei Filaidi a tenere il dominio
(arché) del Chersoneso, dunque identificandovi Milziade I, ecista ateniese della comunità del
Chersoneso Tracico.
L’identificazione del Milziade a cui il testo fa riferimento e a cui sarebbe da attribuire la
dedica è dunque problematica e mi pare onesto mettere in guardia dalla possibilità di giungere
ad una soluzione sicura. Concordo con la maggior parte degli studiosi moderni nell’accettare
che Pausania stia effettivamente facendo riferimento a Milziade I: già in altra parte precedente
dell’opera Pausania annuncia che tratterà delle dediche fatte ad Olimpia da parte di quel
Milziade che aveva riportato la vittoria nella corsa delle quadrighe, cioè Milziade I, e questo
paragrafo realizza senz’altro tale proposito345. Seguo dunque la communis opinio nel ritenere
che, nel passo sul corno di Amaltea, Pausania più probabilmente confuse la genealogia di
Milziade I, a cui intendeva fare riferimento; si consideri peraltro che all’epoca in cui Pausania
scriveva egli disponeva anche di altre opere storiografiche e biografiche in cui veniva iterata
questa stessa confusione sul patronimico del Milziade ecista dei Chersoneso Tracico346.
Che Pausania stesse scientemente attribuendo, pur con qualche confusione, la dedica del
corno di Amaltea ad Olimpia a Milziade I ecista del Chersoneso Tracico non significa
d’altronde che si debba accettare quell’attribuzione come un dato storico: ci sono buoni
343
Secondo la leggenda, Amaltea fu la ninfa che protesse Zeus infante dallo sguardo del padre infanticida Crono. Il
piccolo dio spezzò giocando una delle corna alla mostruosa capra che lo allattava e dunque ne fece dono alla
propria nutrice promettendo che sarebbe stato sempre miracolosamente pieno di tutti i frutti. Sul corno di Amaltea
come attributo della dea Tyche: Paus. IV 30.6. BRENNER 2011, s.v. “Amalthea” [1], in BNP.
344
Paus. VI 10.8, 19.6. GRAHAM 1993 contribuisce alla questione con un saggio specifico e una precisa traduzione
e analisi linguistica della dedica.
345
Paus. VI 10.8.
346
Si veda la biografia di Cornelio Nepote su Milziade. BERVE 1937, p. 39; HAMMOND 1956, pp. 119-123;
GRAHAM 1993, pp. 331-338; RIZZO 2001, p. 595; LOUKOPOULOU 2004, pp. 900s., 903.
273
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
presupposti per dubitare della precisione dei dati di cui disponeva Pausania e della ricostruzione
che egli propone nella sua opera. È evidente infatti dalla composizione del testo che il geografo
procedette combinando nel suo paragrafo tre distinte tradizioni: Pausania riporta innanzitutto il
patronimico di Milziade traendolo dall’onomastica di Milziade II, celebre non solo per avere
retto la tirannide del Chersoneso Tracico, ma soprattutto per avere condotto gli Ateniesi alla
vittoria di Maratona contro lo sbarco persiano nel 490; d’altronde è evidente che Pausania sta
associando al nome di Milziade la tradizione fondata dall’opera storiografica di Erodoto in
merito all’insediamento ateniese in Chersoneso tracico sotto la conduzione dell’ecista Milziade
I347; la terza serie di informazioni Pausania trae direttamente dalla propria esperienza autoptica
nella visita dei tesori di Olimpia nel II sec. d.C. e riguarda la descrizione del corno di Amaltea,
la trascrizione della dedica nonché l’attribuzione del reperto fornitagli dagli esegeti del
santuario. È possibile che, trattandosi di una dedica proveniente esplicitamente dal Chersoneso
e di riconosciuta antichità, sia stato naturale per gli esegeti associarla a quel Milziade I che della
comunità chersonesita era stato l’ecista e l’artefice di prima mano: sulla base di queste notizie
Pausania associò il corno di Amaltea a Milziade I.
Attribuzione a Milziade II e a i suoi mercenari
Pur riconoscendo dunque l’attribuzione che Pausania intende dare alla dedica del corno di
Amaltea, emerge d’altronde il carattere artificiale e composito della sua ricostruzione storica:
ritengo invece che esistano le condizioni per considerare più plausibile l’attribuzione di quella
dedica a Milziade II348. A mettere in dubbio l’attribuzione a Milziade I mi pare contribuisca in
primo luogo l’imprecisione del testo stesso di Pausania che, confondendo il patronimico di
Milziade, dimostra di non disporre di una tradizione solida nella compilazione del suo scritto.
Motivo fondante però per l’attribuzione a Milziade II che propongo risiede in un’analisi
ragionata e contestualizzata del testo della dedica. La dedica afferma che l’offerta proviene dal
Chersoneso, da parte di coloro che conquistarono la fortezza di Arato, sotto il comando di
Milziade: in questo testo la critica ha giustamente notato l’assenza completa di qualunque
definizione etnica, toponomastica o politica del gruppo dei dedicatari349. Si tratta di un fatto
significativo poiché, se si fosse trattato dei coloni ateniesi al seguito di Milziade I, la comunità
sarebbe senz’altro stata identificata in tal senso nel testo della dedica con un riferimento agli
Ateniesi o ai volontari provenienti da Atene350. Se si fosse trattato d’altronde di una delle
347
Hdt. VI 35-38.
HAMMOND 1956, p. 123; ISAAC 1986, pp. 170-172.
349
JEFFERY 1963, p. 300; ISAAC 1986, pp. 170-172; GRAHAM 1993.
350
JEFFERY 1963, p. 300.
348
274
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
comunità poleiche formatesi in Chersoneso Tracico negli anni successivi al primo insediamento
vi sarebbe motivo ancor più impellente perché la comunità volesse auto-identificarsi con un
etnonimo, perlomeno con il riferimento anche generico di “Chersonesiti”351. Invece la
menzione del Chersoneso compare solo per identificare la località di Arato che fu conquistata,
non la sede della comunità dedicataria352. Nel caso di una dedica da parte della comunità
coloniale ateniese, il riferimento a Milziade I sarebbe stato certamente alla figura dell’ecista
(oikistès) e non del governante (éparchos) come era invece inciso sul corno.
La comunità che dedicò l’offerta è in effetti da riconoscersi nel ristretto gruppo che
attivamente operò la conquista della fortezza di Arato: emerge cioè il quadro di un gruppo
ristretto di uomini, di soldati, che conquistarono una fortezza nel territorio del Chersoneso
Tracico: fu un gruppo altrimenti disomogeneo che riconobbe un senso di corpo e di
cameratismo proprio soltanto in quella specifica azione militare, nonché nel comando di
Milziade. Queste caratteristiche mi incoraggiano a identificare nel gruppo dei dedicatari un
contingente di soldati mercenari, probabilmente insieme ad altre componenti clientelari,
associati alla tirannide di Milziade II353. Si consideri a questo proposito che la tradizione
attribuisce solo a Milziade II, e non all’omonimo ecista, il mantenimento di un corpo di
mercenari354. A corroborare la ricostruzione di un contingente mercenario si consideri che, se la
dedica fosse provenuta da un corpo di armati raccolto da Milziade II fra i coloni chersonesiti, si
sarebbe trattato della componente oplitica, per la quale difficilmente l’autoidentificazione entro
il corpo sociale sarebbe passata in secondo piano rispetto al comando del tiranno.
Nella dedica Milziade è definito come colui che comandava quelli che conquistarono la
fortezza di Arato. Il verbo utilizzato è epàrcho: cioè “comandare, governare, essere
governatore, comandare un luogo”. Il verbo e i suoi derivati sono attestati non solo con il
significato contingente qui evocato, ma più spesso nel senso di una carica autocratica di
governo, senza riferimento alla legittimazione popolare, spesso anche in associazione ad ambiti
della monarchia orientale. Queste caratteristiche in assoluto si adattano alle forme di comando
che praticò Milziade II, a partire dai primi anni della tirannide in Chersoneso quando debellò
l’opposizione ellenica locale e ancor più quando divenne uno dei tiranni sotto la protezione, pur
malaccetta, del sovrano di Persia, dal 513 ca. Dal punto di vista stilistico infine i critici
351
I dedicanti di un elmo a Olimpia dopo la conquista di Lemno si identificano ad esempio come Ateniesi.
JEFFERY 1963, pp. 299s. MEIGGS 1972, p. 242; PEMBERTON 1988, pp. 231s.; KEEN 2000, pp. 66s., riportano le
conclusioni del lavoro di E. Kunze; CULASSO GASTALDI 2011, p. 128. Vd. infra, pp. 277ss.
352
GRAHAM 1993.
353
GRAHAM 1993.
354
Hdt. VI 39. ISAAC 1986, pp. 170-172.
275
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
associano la dedica ad una data intorno alla fine del VI secolo piuttosto che alla metà del
secolo355.
La fortezza di Arato: insediamento di Traci ostili
Della località menzionata nella dedica la critica e le fonti non tramandano altre notizie: la
dedica non lascia dubbi su fatto che sia da localizzarsi in Chersoneso356; si suppone si trattasse
di un insediamento, oppure anche soltanto della piazzaforte associata ad un insediamento,
appartenente ad una popolazione di Traci ostili al popolamento greco stanziati nel Chersoneso
Tracico oppure poco oltre l’istmo della penisola e dunque forse associati a quei Traci Apsinti
che avevano costituito uno dei moventi per l’intervento di Milziade I da Atene357. Nessun dato
storiografico d’altronde impone di attribuire il possesso di Arato ai Traci piuttosto che a quei
dinasti chersonesiti che si opposero al potere tirannico di Milziade II al suo arrivo, oppure a
Greci delle colonie eoliche preesistenti all’arrivo degli Ateniesi. La volontà di rendere pubblica
dimostrazione della conquista della fortezza in ambito panellenico, tramite la dedica ad Olimpia
appunto, mi incoraggia però a seguire la prima delle due ipotesi: difficilmente il gesto avrebbe
altrimenti potuto vantare lode fra tutti i Greci in consesso. Dell’oggetto dedicato non sono
pervenute tracce materiali. La critica ha considerato la possibilità che si trattasse di un corno
d’avorio preparato per fungere da calice, come un rhytòn, giacché questo tipo di oggetti era
particolarmente diffuso proprio nei territori della Tracia358.
La data, le circostanze e il significato della dedica di Olimpia
In conclusione la conquista del forte di Arato può a mio avviso attribuirsi a Milziade II e
la contestualizzazione storica del lessico della dedica meglio si adatta a questo tiranno e alle
forme del suo governo piuttosto che all’omonimo Filaide. Il corno di Amaltea faceva dunque
parte del bottino di guerra raccolto a seguito di un vittorioso attacco da parte di Milziade II al
comando di un contingente di suoi soldati mercenari contro un insediamento militare fortificato
di Traci ostili.
Il contesto cronologico che meglio si adatta a questa descrizione dei fatti è quello degli
anni turbolenti di interferenza da parte delle truppe persiane successivi alla disastrosa
spedizione scitica di Dario, o più in genere il periodo 512-493. In tale periodo il comando di
Milziade II sui Greci del Chersoneso era ormai inviso alla Persia; Milziade II fu costretto a
355
HAMMOND 1956, p. 123 cita al riguardo un commento di P. Fiedländer.
GRAHAM 1993.
357
BERVE 1937, p. 39; RIZZO 2001, p. 595; LOUKOPOULOU 2004, pp. 900s., 903.
358
Xen. Anab. VI 3.21-25; Pherecyd. Ath. FGrHist 333 F 42; Strab. X 2.19; Ath. XI 476. GRAHAM 1993.
356
276
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
lasciare per alcuni intervalli il Chersoneso e il ritorno, in alleanza con i Traci Dolonci, dovette a
volte non essere pacifico.
La scelta del santuario ove dedicare quella pregevole parte del bottino offre all’analisi
alcune considerazioni sui propositi politici del gesto. Inferenza minima sicura è che la dedica
del corno di Amaltea ad Olimpia era volta a fornire una rappresentazione, davanti ai Greci di
rango aristocratico radunati alle celebrazioni di Olimpia, delle capacità e del potere militare di
Milziade II e del suo seguito personale in Chersoneso Tracico. La dedica aveva il senso
religioso di rendere la divinità partecipe dei vantaggi della loro conquista e ottenerne in cambio
la protezione per sé e per i possedimenti conquistati.
Lo svolgimento dei fatti impone necessariamente che una delegazione degli uomini agli
ordini di Milziade II, forse insieme a Milziade stesso, si sia recata ad Olimpia, partendo dal
Chersoneso e attraversando l’Egeo e la Grecia fino a giungere in Peloponneso ed in Elide, allo
scopo di dedicare il corno di Amaltea presso il tesoro del tempio di Zeus Olimpio nell’Altis. In
considerazione del viaggio necessario e della difficile situazione internazionale che nell’ultimo
ventennio del VI secolo andava prendendo forma intorno ad Atene, ai Pisistratidi e ai Filaidi,
ritengo che Milziade dovette potersi certo muovere liberamente nel momento di una
celebrazione olimpica e della pace generale che l’evento imponeva. L’evento religioso avrebbe
in ogni caso contribuito ad una maggiore visibilità pubblica della dedica e dell’atto dedicatorio
stesso. La dedica presso un santuario panellenico come quello di Olimpia testimonia
dell’intenzione di Milziade e dei suoi associati di ottenere un riconoscimento dei propri
successi, del proprio gruppo e della sua autorità, non solo da parte di Atene, ma da parte
dell’élite di tutte le poleis della Grecità. Il richiamo panellenico e l’identificazione dei nemici
sconfitti ad Arato potrebbero infine preconizzare l’aspirazione ad un ruolo di rappresentatività
ellenica di fronte alla lotta contro nemici barbari.
V.5.8. La conquista di Lemno e Imbro da parte di Milziade II (500 ca.)
Nel periodo della tirannide in Chersoneso Tracico Milziade II realizzò la conquista delle
isole di Lemno e Imbro. Queste iniziative si inseriscono nel discorso storico sulle relazioni
internazionali della tirannide filaide non solo in quanto furono condotte contro località al di
fuori della sede del tiranno; le località furono oggetto anche dell’occupazione persiana e la
questione dunque concerne anche la reazione dei Greci d’Asia all’espansione dell’impero
persiano in Europa; inoltre le vicende coinvolsero l’autorità della polis ateniese e dunque la
277
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
posizione del tiranno filaide nei confronti della madrepatria e il valore civico delle sue iniziative
personali359.
Le mire internazionali su Lemno nella rievocazione storiografica
Nel tramandare le vicende della spedizione scitica di Dario, Erodoto fornisce in effetti un
quadro più articolato delle operazioni persiane in Europa e in Ellesponto. Nel 513-512, mentre
Dario penetrava oltre il fiume Istro, il generale Megabazo seguì l’ordine di conquistare la
Tracia; la successiva stagione militare, nel 512-511, il Persiano Otane fu nominato stratego
delle forze armate costiere, cioè in Ellesponto ed Europa, e succedette a Megabazo nel
comando360. Otane conquistò una serie di località nell’Ellesponto che si erano ribellate al
comando persiano durante gli insuccessi di Darion Scizia: Bisanzio, Caldedone, Antandro in
Troade e Lamponio. Il generale ottenne poi una flotta da Lesbo e con quella sottomise le isole
di Lemno e Imbro. Le due isole erano al tempo abitate dai Pelasgi, una definizione etnica
applicata a popolazioni che i Greci consideravano antichi abitanti in numerosi siti
dell’Ellade361. Lemno oppose una tenace resistenza, ma fu infine sopraffatta. Ai superstiti Otane
impose come governatore (hýparchos) Licareto, fratello di Meandrio che aveva tenuto il potere
a Samo dopo la tirannide di Policrate362. Licareto tenne il governo di Lemno fino alla sua
morte363.
La narrazione erodotea torna poi a trattare della storia di Lemno e del popolamento
dell’isola in relazione alle attività di Milziade II, al tempo in cui egli teneva la tirannide in
Chersoneso Tracico. Nel 489, l’anno successivo alla vittoria a Maratona, Milziade II condusse
una flotta ateniese alla conquista di Paro, ma l’impresa non ebbe successo: al suo ritorno ad
Atene egli fu perciò processato per avere ingannato gli Ateniesi364. Nel corso del dibattito i
sostenitori di Milziade portarono a sua difesa i particolari della sua condotta e del suo successo
a Maratona nonché il fatto che egli avesse conquistato l’isola di Lemno, vendicando così le
offese dei Pelasgi contro gli Ateniesi, e avesse infine consegnato l’isola agli Ateniesi
359
Sul significato storico di questa cruciale fase dell’espansione internazionale di Atene: CLUASSO GASTALDI
2011.
360
Hdt. V 25. TOZZI 1978, p. 127.
361
Hdt. V 26.
362
Sulle vicende di Licareto a Samo: Hdt. III 142s. Sul termine hýparchos Si vedano le attestazioni sia in
riferimento a Greci che a dignitari persiani: Hdt. V 20, 25. VII 26, 33, 194, IX 116. BERVE 1967, pp. 85-88;
WALLINGA 1984, pp. 411-436; AUSTIN 1990; LURAGHI 1998, p. 22; ANDERSON 2005, pp. 211-213.
363
Hdt. V 27. Sulla consegna di Lemno a Licareto: HAMMOND 1956, pp. 124-126; BLAMIRE 1959, pp. 43-44;
EVANS 1963, p. 168; SEALEY 1976 a, p. 16; TOZZI 1978, 115-127, 169-178; OLMSTEAD 1982, pp. 89-92; LURAGHI
1998, pp. 89-92; PANAINO 2001, pp. 84-93; MAZZARINO 2007, pp. 242s.
364
Hdt. VI 132-136. GOMME 1937; HAAS 1985, pp. -; DAVIES 1997, pp. 134s.; DUPLOUY 2006, pp. 93s.
278
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
(παρέδωκε Ἀθηναίοισι)365. In questo punto del testo prende avvio l’excursus di Erodoto sulle
precise circostanze in cui Milziade aveva conquistato Lemno.
Erodoto avvia la propria narrazione con un’eziologia leggendaria della presenza dei
Pelasgi a Lemno e dell’ostilità di Milziade e di Atene nei confronti di quelli che abitavano
l’isola. In tempi mitici gli Ateniesi avrebbero espulso i Pelasgi dall’Attica e questi si sarebbero
insediati a Lemno. In un secondo momento, ma pur sempre in epoca mitica, i Pelasgi di Lemno
avrebbero offeso gli Ateniesi ghermendo alcune donne di Atene e portandole sull’isola; dalla
prole delle Ateniesi e dei Lemni pelasgi sorsero altri incidenti la cui soluzione fu imposta da un
responso oracolare di Delfi che mise Atene in condizione di richiedere ai Pelasgi la cessione di
Lemno. A questi incidenti Erodoto associa l’origine dell’espressione proverbiale “azioni
lemnie”366. Alla richiesta i Pelasgi avrebbero risposto con una sibillina condizione impossibile:
“Quando con vento di nord, in un solo giorno, una nave riuscirà a passare dal vostro paese al
nostro, allora ve lo consegneremo”367: la navigazione dall’Attica sulla rotta in direzione nordest era infatti estremamente difficile quando spiravano i venti contrari dal Ponto Eusino368.
A questo punto la narrazione giunge a riallacciarsi ad epoche storiche nel riferire infine di
come Lemno venne a trovarsi sotto l’autorità di Atene. Milziade II, durante la tirannide filaide
in Chersoneso Tracico, salpò da Elaious, con i venti Etesii in poppa giunse in poco tempo a
Lemno e impose ai Pelasgi di lasciare l’isola rammentando loro la leggendaria condizione con
cui avevano risposto all’antica richiesta degli Ateniesi: il tiranno interpretò a proprio favore
cioè lo statuto giuridico dell’insediamento ateniese sotto il suo comando in Chersoneso Tracico.
Delle due poleis dell’isola, Efestia si arrese; Mirina invece non riconobbe la definizione di
Chersoneso come territorio attico e si oppose, ma fu assediata e infine conquistata da Milziade
II369.
Erodoto sembra ignorare alcune nozioni ulteriori relative alla resa dei Lemni di Efestia
alle condizioni di Milziade II, preservate però tramite autori e lessicografi più tardi. Diodoro
Siculo tramanda che i Lemni affermarono di lasciare l’isola a Milziade in ottemperanza
all’oracolo, ma che erano in realtà mossi dal timore dei Persiani che al comando di Dario
intendevano sottomettere l’Europa. Da queste circostanze nacque la proverbiale espressione
“Doni di Hermone” ( (/Ermwnei/ouj xa/ritaj) dal nome del condottiero dei Lemni (tirreni per
365
Hdt. VI 136.2. WADE-GERY 1951, pp. 212, 217.
Hdt. VI 138.4. SCOTT 2006, ad Hdt. VI 138.4, p. 451.
367
Hdt. VI 139.
368
ANDREWES 1982 a, pp. 373-375; KOROMILA 1991, pp. 16-50; GREAVES 2000, pp. 48s.
369
Hdt. VI 140.
366
279
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Diodoro) che fece la concessione affettando la propria buona fede, ma in realtà sotto l’impulso
delle circostanze di forza maggiore370.
Testimonianze epigrafiche ed archeologiche del popolamento ateniese di Lemno
Le tracce epigrafiche forniscono una prospettiva ulteriore per comprendere il significato
dell’occupazione di Lemno da parte di Milziade II e la concessione dell’isola ad Atene. Un
elmo di stile corinzio fu dedicato ad Olimpia dagli Ateniesi di Lemno, recante l’iscrizione
)Aqenai=oi [t]o=n e)g Le/mn[o]: può considerarsi testimonianza della presenza di Ateniesi a
Lemno nel periodo di poco successivo al 500; il reperto potrebbe essere associato alla dedica
del bottino proprio dalla conquista di Lemno, o più specificamente di Mirina, al comando di
Milziade II371.
Da Efestia perviene un’epigrafe in cui i cittadini compaiono suddivisi entro le ripartizioni
tribali ateniesi; l’analisi della forma delle lettere sembrerebbe indicare una datazione intorno ai
primi anni del V secolo. Da questa categoria di fonti emerge il quadro storico di un fenomeno di
insediamento di popolazione ateniese sull’isola a partire dal primo quarto del V secolo372.
L’indagine archeologica sembrerebbe fornire dati coerenti con il quadro di popolamento
delineato dall’epigrafia: la diffusione della ceramica attica a Lemno si colloca entro l’ultimo
quarto del VI secolo e un’indagine sulla necropoli di Efestia individua la diffusione di
inumazioni di foggia ellenica a partire dal 500 ca373.
La questione della datazione della conquista di Milziade II
La questione della datazione della conquista di Lemno da parte di Milziade II non è
puramente cronologica o di erudizione, ma piuttosto strettamente legata alla contestualizzazione
politica della vicenda; la critica moderna tuttavia offre molteplici ricostruzioni e collocazioni a
questo riguardo che complessivamente vanno dal 515 fino agli anni intorno alla prima guerra
persiana: un gruppo nutrito di studiosi concorda nel collocare la vicenda entro gli anni della
rivolta ionica, 499-493, ma non mancano proposte autorevoli che individuano il contesto
370
Diod. Sic. X 19.6; Hesych. s.v. Ἑρµώνιος χάρις; Suda, s.v. Ἑρµώνιος χάρις, E 3053 Adler. SCOTT 2005, ad
Hdt. 140.2, pp. 453s.
371
IG I3 1466. JEFFERY 1963, pp. 299s. MEIGGS 1972, p. 424; PEMBERTON 1988, pp. 231s.; KEEN 2000, pp. 66s.
riportano le conclusioni raggiunte da E. Kunze. CULASSO GASTALDI 2011, p. 128.
372
PICARD-REINACH 1912, pp. 326-338; WADE-GERY 1951, pp. 217s.; JEFFERY 1961, pp. 299s.; JEFFERY 1963,
pp. 299ss., n. 59; MEIGGS 1972, p. 424; PEMBERTON 1988, pp. 231s.; KEEN 2000, p. 67; SCOTT 2005, ad Hdt. VI
140.2, p. 454; CULASSO GASTALDI 2011, pp. 117-134 ritiene in genere più opportuno associare le testimonianze
epigrafiche ed archeologiche ad una cronologia entro il secondo quarto del V secolo e all’azione di Cimone II.
373
MUSTILLI 1940 offre uno studio della necropoli di Efestia; WADE.GERY 1951, pp. 217s., segnala lo studio di D.
Mustilli sulle tombe elleniche scavate a Lemno; HAMMOND 1956 sulla ceramica attica a Lemno; CULASSO
GASTALDI 2011, pp. 117s.
280
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
cronologico nell’ultimo decennio del VI secolo, o più specificamente agli anni intorno al
500374.
Ampio consenso esiste comunque in merito alla cronologia relativa secondo cui
l’intervento di Otane sarebbe da anteporsi a quello di Milziade II e di Atene375. La narrazione
storiografica tramanda che Milziade II consegnò Lemno ad Atene e l’autorità della polis trova
infatti espressione nelle testimonianze epigrafiche ed archeologiche che attestano la presenza di
popolazione ateniese a Lemno: l’intervento di Milziade fu dunque causa e immediato
presupposto per l’insediamento ateniese sull’isola376. Quando però Otane prese Lemno e vi
pose Licareto al governo egli si trovò a confrontarsi con gli autoctoni Pelasgi e non con degli
Ateniesi. D’altronde la conquista di Otane comportò solo l’imposizione di un hýparchos filopersiano: perciò Milziade II giunse a Lemno per trovarvi ancora l’originaria popolazione
pelasga. Pare difficile infine che Milziade II avesse avuto il tempo, le risorse e l’opportunità di
occuparsi della spedizione a Lemno nei primi anni della presa di potere in Chersoneso Tracico,
prima della partecipazione alla spedizione scitica e dunque conseguentemente prima delle
operazioni successive a questa di Otane. Perciò si può concordare con la pressoché totalità della
critica sul fatto che la conquista di Milziade ebbe luogo dopo quella di Otane377.
Mi pare che il testo erodoteo sulla conquista di Otane sia da accettare come testimonianza
del fatto che Licareto tenne una forma di governo tirannico a Lemno per un certo periodo, fino
alla sua morte naturale378; le fonti permettono dunque di ricostruire che l’autorità a Lemno,
specificamente ad Efestia, fu poi assunta dal locale capo Hermon, con cui Milziade II entrò in
trattative al suo arrivo. In questo senso dunque è necessario interporre almeno un periodo di
alcuni anni fra la conquista di Otane nel 512 e la spedizione di Milziade II379.
374
HAMMOND 1956, pp. 122-127, 129, pne la data a prima della spedizione scitica, nel 515-514. KALCYK 2011,
s.v. “Lemnos”, in BNP, pone il 510 come terminus post quem. Concordano nel datare i fatti all’ultima parte del
decennio 510-500, a poco prima del 500, o al 500: HAAS 1985, p. 43; NENCI 1988, ad Hdt. VI 34-40, cita
l’opinione di J.B. Salmon; PEMBERTON 1988, pp. 131s.¸DAVIES 1997, pp. 134s.; KEEN 2000, p. 67. Ai primi anni
della rivolta ionica la vicenda è associata da WADE-GERY 1951, pp. 198; JEFFERY 1963, pp. 299s. cita E. Kunze;
MORENO 2007, app. V, segue WADE-GERY 1951. BURN 1962, pp. 218-220, propone il 495 in base a
un’interpretazione di Hdt. VI 40. Più in genere entro il periodo di anni della rivolta ionica (499-493) la vicenda è
collocata da COX 1876, p. 69; WELLS 1923, pp. 115, 121s.; MEIGGS 1972, pp. 424s.; SCOTT 2005, p. 454, cita la
ricostruzione di N. Rausch; CULASSO GASTALDI 2011, p. 116.
375
HOW-WELLS 1928, ad Hdt. IV 137, V 26; BURN 1962, pp. 129, 208s.; WADE-GERY 1971, p. 217; GEORGES
2000, p. 38; CAWKWELL 2005, p. 61; SCOTT 2006, ad. Hdt. VI 41.2, 41.3, p. 84, VI 42-45.4, p. 187; CULASSO
GASTALDI 2011, p. 116. Contra HAMMOND 1956, pp. 122-127, 129.
376
PICARD-REINACH 1912, pp. 326s.; JEFFERY 1963, pp. 299s.
377
PEMBERTON 1988, pp. 131s.
378
Hdt. VI 27.
379
WADE-GERY 1951, pp. 212, 217s.
281
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
La conquista di Lemno da parte di Milziade II entro la storia del sistema internazionale
Nella prospettiva analitica della presente ricerca, ritengo che la storia di Lemno fra VI e V
secolo e specificamente della conquista dell’isola da parte di Milziade II debba inserirsi in una
revisione del quadro del sistema internazionale di quel periodo: intorno a Lemno convergono ed
entrano in contatto molteplici soggetti storico-politici: la tirannide di Milziade II in Chersoneso,
gli interessi internazionali di Atene in Ellesponto, l’impero Persiano nella sua espansione verso
l’Europa e l’Egeo nordorientale, la tirannide di Ippia in quanto associato alla Persia e avverso
ad Atene e a Milziade II. Da queste considerazioni può emergere una ricostruzione del
significato politico e storico degli eventi di Lemno e insieme una collocazione cronologica
ragionata.
Gli anni fra il 513 e il 510 videro un progressivo peggioramento della posizione di Atene
nell’Egeo nordorientale e nella navigazione attraverso l’Ellesponto. A compromettere il
controllo di Atene nella regione tracica ed ellespontica questa ricerca ha già portato in evidenza
il ruolo della Persia e le difficoltà create rispettivamente da Milziade II e da Ippia. Il significato
dell’alleanza fra Atene e Artafrene nel 507 è dunque quello di un tentativo ateniese di
recuperare la libertà operativa in Ellesponto che la polis era andata perdendo negli anni
precedenti380.
L’intervento di Otane aveva posto Lemno sotto il governo indiretto del sovrano
Achemenide entro il 511: perciò la successiva conquista da parte di Milziade II ebbe certamente
un valore anti-persiano381. È noto poi che Milziade consegnò l’isola ad Atene. L’alleanza fra
Atene e Artafrene è però incompatibile con la cessione ad Atene di Lemno da parte di Milziade
II: se Milziade avesse conquistato l’isola e l’avesse trasferita all’autorità ateniese prima del 507,
Artafrene avrebbe certo allora richiesto la restituzione dell’isola all’autorità di un hýparchos
persiano quando fu avvicinato dagli ambasciatori ateniesi; d’altro canto, dopo il 507, Atene non
avrebbe potuto mantenere i contatti con l’anti-persiano Milziade II senza rischiare di
compromettere i termini dell’alleanza con Artafrene. Nel periodo intorno al 507 Milziade II e la
polis ateniese devono considerarsi su opposte e incompatibili posizioni nei confronti
dell’impero persiano.
Nel 504 Ippia ebbe successo nel guadagnare l’appoggio diplomatico di Artafrene e, al
contrario, Atene vide infrangersi la possibilità di un’intesa con il satrapo di Sardi a meno di non
rinunciare alla propria fisionomia politica anti-tirannica e anti-pisistratide. Dunque è a partire
dal 504 che Atene fu sospinta dalle circostanze a mutare in anti-persiana la propria politica
380
381
Hdt. V 73. BERVE 1967, pp. 85-88; TOZZI 1978, pp. 125s., 160s.
WADE-GERY 1951, pp. 215-219.
282
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
internazionale. La conferma di questo cambiamento di indirizzo si ha infatti nel 500 quando gli
Ateniesi accolsero la richiesta di aiuto di Aristagora che stava preparando la rivolta ionica. La
critica moderna attribuisce infatti l’intervento militare di Atene e di Eretria in Ionia nel 498, fra
le altre cause, ad una condizione di attrito che si era venuta a creare entro quella data fra Atene
e la Persia, specificamente in merito alla condizione di Lemno e Imbro e più in generale in
merito alla libertà di navigazione attraverso l’Ellesponto382.
Nel 498 Atene aveva già ritirato il proprio contingente dalle forze degli Ioni; poi nel 494
la battaglia di Lade segnò la sconfitta dei Greci e la fine del moto di ribellione delle poleis
micrasiatiche; gli anni seguenti videro il riaffermarsi del potere persiano fino all’Ellesponto e
alla Tracia. Le condizioni successive al 494 mi sembrano meno probabili per la cronologia di
un intervento di Milziade II a Lemno e soprattutto per un impegno di Atene in aree così vicine
alla Persia: avanzerei cioè dei dubbi circa l’entusiasmo con cui gli Ateniesi potrebbero avere
scelto di prendere sede a Lemno dopo queste drammatiche dimostrazioni delle capacità della
macchina bellica e navale persiana. Milziade stesso infine ritornò ad Atene nel 493.
Questa contestualizzazione contribuisce ragionevolmente a fissare una terminus post
quem per la conquista di Lemno da parte di Milziade II al 504 e un terminus ante quem al 494.
A partire infatti dal 504, e non prima, la nuova classe politica dell’Atene isonomica e il tiranno
chersonesita Milziade II si trovarono a convergere entro una comune direttrice anti-persiana e
anti-pisistratide nella gestione delle rispettive relazioni internazionali: negli anni subito dopo il
500 Atene scelse poi di perseguire attivamente quell’indirizzo politico contribuendo alla rivolta
ionica383. È verosimile anzi che le operazioni a Lemno fossero intese da Atene come una
strategia parallela a quelle che si conducevano in Ionia ad opera di Aristagora, costituendo cioè
due scenari strategici alternativi; in questo modo l’intervento di Milziade II e l’insediamento
degli Ateniesi poterono sfruttare il diversivo che la rivolta in Ionia offrì all’attenzione e alle
risorse persiane. Verosimilmente d’altro canto Atene non poté contemporaneamente condurre
l’intervento a Lemno e quello in Ionia, ma le iniziative furono attuate a breve distanza una
dall’altra, possibilmente in stagioni militari successive. In conclusione propendo per collocare
la conquista di Lemno da parte di Milziade II agli anni intorno al 498: forse Milziade II
potrebbe essere intervenuto a titolo personale nel 500 ca., prima della spedizione ateniese in
Ionia; poi in un secondo momento Atene avrebbe utilizzato le navi rientrate dall’Asia Minore
dopo il 498 per condurre l’occupazione coloniale del nuovo territorio insulare.
Il significato politico della conquista di Lemno e i moventi dei soggetti coinvolti
382
383
GRAHAM 1964; BERVE 1967, pp. 85-88; TOZZI 1978, pp. 125s., 160s.; WALLINGA 1984, pp. 411-436.
WADE-GERY 1951, pp. 215-219.
283
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
La vicenda della presa di Lemno ebbe un carattere spiccatamente anti-persiano, sia per
Milziade II che per Atene384. I moventi di Milziade si possono riconoscere nella volontà di
conservare il proprio potere personale nella regione, soprattutto in risposta agli interventi
persiani e alla formazione dell’intesa fra Ippia, Lampsaco e la Persia, potenziali avversari del
suo insediamento in Chersoneso Tracico. Mi sembra probabile inoltre che la conquista di
Lemno sia legata a quella confusa fase di presenza discontinua di Milziade II in Chersoneso
Tracico successiva alla spedizione scitica di Dario: dovendo cioè abbandonare la gestione degli
interessi personali nella penisola per via dell’ingerenza del potere militare persiano, Milziade II
avrebbe scelto di creare nuove sedi di potere personale nelle isole prospicienti l’Ellesponto
mettendo così i suoi interessi al riparo dalle incursioni dell’esercito terrestre persiano e
conservando al contempo una posizione strategica cruciale nella navigazione all’imbocco
dell’Ellesponto.
I moventi di Atene si riconoscono nella necessità di difendere i propri interessi
internazionali e marittimi con un nuovo corso che non poteva più essere diplomatico dopo la
rottura dell’intesa con Artafrene nel 504: allora la polis assunse la responsabilità di un’attiva
politica anti-persiana e in quel momento trovò vantaggioso riconoscere i contatti che la
legavano al tiranno del Chersoneso Milziade II che già da tempo aveva dimostrato la propria
avversione alla Persia.
Milziade si adoperò nella conquista di Lemno non esclusivamente per vantaggi
personali o in favore degli interessi dei Chersonesiti, ma scelse di cedere la propria conquista ad
Atene385: il dato deve essere interpretato come il segno della volontà di Milziade II di
riconfermare i propri contatti con la madrepatria, di dimostrare agli Ateniesi il proprio ruolo di
benefattori della comunità e la propria posizione di capace uomo politico e d’azione. La
direttrice anti-persiana della nuova classe politica ateniese fu per Milziade II un momento
opportuno per riavvicinarsi alla madrepatria, dopo il periodo di distacco degli ultimi anni della
tirannide di Ippia e dell’alleanza di Atene con Artafrene: allora egli poté trovare una rinnovata
affinità fra il proprio pensiero politico e la posizione dell’élite politica ateniese. Nel 499 i
politici ateniesi scelsero di intervenire nella rivolta ionica, contro la Persia e a favore delle
poleis elleniche che anelavano all’autonomia: questa fu, di fatto, la direttrice politica che già
Milziade II aveva auspicato nel 513, quando, più di tredici anni prima della rivolta ionica, egli
quasi aveva convinto i tiranni ellenici dell’Asia Minore ad accogliere il consiglio degli Sciti
giunti al ponte di barche all’Istro, ovvero a determinare la fine del giogo persiano sui Greci
384
385
SCOTT 2005, ad Hdt. VI 41.3, p. 184.
PEMBERTON 1988, pp. 230-232.
284
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
d’Asia. Nonostante la distanza temporale sono entrambe scelte anti-persiane e, nonostante la
posizione di Milziade II in Chersoneso, anti-tiranniche.
La tirannide in Chersoneso cadde nel 493, ma si possono notare segni di vacillamento già
negli anni precedenti: l’opposizione aristocratica al suo arrivo già nel 520-515; poi la fuga per
via della presenza delle armate persiane negli anni successivi al 513. Come anche aveva fatto
Ippia in conseguenza del tirannicidio di Ipparco, così in quel momento Milziade II stava
verosimilmente riorganizzando la propria rete di contatti internazionali in modo da assicurare
che i Filaidi avrebbero eventualmente trovato alternative e sicure sedi di ospitalità e
reinsediamento. Lemno stessa costituì allora un nuovo territorio da lui direttamente dipendente;
insieme a Lemno si ritiene che Milziade II prese anche Imbro ove trovò effettivamente rifugio
dalla flotta persiana nel 493386. La conquista di Lemno assicurò ad Atene una nuova posizione
strategica e un insediamento coloniale; viceversa Milziade si assicurò meriti civici e un sicuro
ritorno politico: così anche la madrepatria Atene, dopo gli anni di tirannide in Chersoneso,
tornava ad essere luogo accogliente. La validità di questa ricostruzione è comprovata
dall’effettivo utilizzo dell’impresa di Lemno come strumento dibattimentale in occasione del
processo a Milziade nel 489; d’altronde la necessità imprescindibile per Milziade II di
ricostruire ad Atene la propria immagine pubblica e politica è confermata anch’essa dal fatto
che egli fu accusato e processato al suo rientro in patria387.
Entro un’analisi di lungo periodo, la convergenza anti-persiana che determinò il
coinvolgimento sia di Milziade II che della polis ateniese nella conquista di Lemno si può
interpretare piuttosto come un episodio di una tendenza generale negli interessi strategici
internazionali di Atene a mantenere aperta una rotta verso l’Ellesponto e ad assicurarsi la libertà
operativa nel controllo dell’accesso allo stretto: questi furono gli obiettivi della tirannide e della
polis all’epoca dell’insediamento di Milziade I in Chersoneso nel 558 e ritornarono a
determinare le scelte degli individui e della polis di nuovo alla fine del secolo388.
La natura della collaborazione fra Milziade II e la polis di Atene
La narrazione storiografica e le testimonianze epigrafiche segnalano entrambe un pronto
coinvolgimento di Atene nelle operazioni militari di Milziade II. Lo status giuridico delle poleis
di Lemno non è del tutto chiaro alla critica moderna; tuttavia l’insediamento di gruppi di
Ateniesi a seguito della conquista di Milziade II non comportò la creazione di una colonia
386
WADE-GERY 1951, pp. 212, 217; JEFFERY 1963, pp. 300; KEEN 2000, pp. 66s.; KINZL 2011, s.v. “Miltiades”
[2], in BNP.
387
Hdt. VI 136.
388
GRAHAM 1964; DAVIES 1997, pp. 134s.; KEEN 2000, pp. 66s.
285
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
effettiva, una apoikìa, e la creazione di cleruchie avvenne però forse solo nel corso del V
secolo389. È possibile che la conquista di Lemno sia stata fin dall’inizio un’impresa organizzata
in collaborazione fra la polis di Atene e il tiranno Milziade II, secondo un accordo per cui la
prima avrebbe procurato le risorse navali e militari necessarie nonché un corpo di spedizione
consistente, il secondo avrebbe invece riorganizzato le forze dalle vicine sedi del Chersoneso e
avrebbe aggiunto le proprie risorse, avrebbe messo a disposizione il porto di Elaious per la
partenza e si sarebbe occupato personalmente della conduzione delle operazioni sul campo in
virtù della sua esperienza di comando e della conoscenza della regione390.
In questo senso si potrebbe spingere l’interpretazione dell’iscrizione sull’elmo dedicato ad
Olimpia da parte degli Ateniesi di Lemno391. Se l’operazione fosse stata all’inizio esclusivo
appannaggio di Milziade II, e se l’elmo fu un’offerta dal bottino della conquista dell’isola,
probabilmente della polis di Mirina, è verosimile che il gruppo dei dedicatari sarebbe stato
composto di Chersonesiti e che la dedica avrebbe fatto riferimento anche a Milziade stesso,
come è infatti noto per la dedica del corno di Amaltea392. Invece sull’elmo proveniente da
Lemno e dedicato ad Olimpia si menzionano degli Ateniesi (ἀθηναῖοι): l’elmo potrebbe
costituire una dedica a seguito di sconosciute operazioni militari successive all’insediamento
dei primi anni del V secolo, quando ormai gli Ateniesi vivevano a Lemno; oppure i dedicatari
potrebbero essere stati coloni ateniesi del Chersoneso che seguirono Milziade II nelle
operazioni a Lemno, ma che tuttavia si consideravano ancora Ateniesi di stirpe e di fronte alla
divinità a cui offrirono il bottino della presa dell’isola393; altresì gli autori della dedica furono
effettivamente dei cittadini di Atene che da subito furono coinvolti nella conquista di Lemno in
collaborazione con Milziade II e sotto il suo comando operativo394. Per quest’ultima
ricostruzione propendo personalmente. Se questa ricostruzione è corretta, l’uso della notizia
della presa di Lemno in tribunale nel 489 a fianco della vittoria di Maratona rievocava di fatto
imprese di Milziade II fra loro molto affini per via del coinvolgimento dei cittadini e dello
spirito di corpo che il generale-tiranno aveva con loro creato.
389
GOMME 1937; REGER 2004, pp. 742, 756-758; SCOTT 2005, ad Hdt. 140.2, pp. 153s.; MORENO 2007, pp. 140143.; CULASSO GASTALDI 2011, soprattutto pp. 125s., 135-138.
390
JEFFERY 1963, pp. 299s. accenna a questa ricostruzione su presupposti cronologici; SCOTT 2000, ad Hdt. 140.2,
pp. 153s. porta questa ricostruzione sulla base del fatto che solo la polis, e non il privato Milziade II, disponeva di
finanze sufficienti per mettere in campo un contingente navale efficace.
391
IG I3 1466. JEFFERY 1963, pp. 299s. MEIGGS 1972, p. 424. Vd. supra, pp. 280ss.
392
Paus. VI 10.8, 19.6. Vd. supra, pp. 272ss.
393
Ringrazio il Prof. F. Raviola per avere proposto questa osservazione in uno dei colloqui che ho avuto con lui.
394
JEFFERY 1963, pp. 299s.; KEEN 2000, pp. 66s.; MORENO 2007, pp. 108-111, 335-344.
286
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
Strumentalizzazione della mito-storia dei Pelasgi da parte di Milziade II
Nella conquista di Lemno Milziade II strinse un contatto fra la propria iniziativa e gli
interessi di Atene anche sul piano della memoria mito-storica e della legittimazione delle
proprie rivendicazioni. Le vicende leggendarie tramandate da Erodoto nel suo excursus con
funzione eziologica condussero a delle rivendicazioni avanzate dagli Ateniesi su Lemno e alla
formulazione, in associazione anche all’intervento dell’oracolo delfico, di una condizione
impossibile, altresì di un enigma, per l’appropriazione di Lemno (la risposta dei Pelasgi agli
antichi Ateniesi fu: “Quando spinta dal vento del nord la nave compirà il tragitto dal vostro
paese al nostro in un giorno, allora vi consegneremo Lemno”)395. Si noti riguardo a questo
aspetto delle vicende di Lemno che gli abitanti sconfitti da Milziade II furono Pelasgi nella
versione erodotea e nelle conoscenze di Tucidide, Carii in quella di Cornelio Nepote e ancora
Tirreni in quella di Diodoro Siculo396.
Ritengo vi siano ragioni culturali e contestuali sufficienti per accettare come storico il
fatto che proprio nelle circostanze della conquista di Lemno Milziade II abbia rievocato questi
elementi della mito-storia greca: non si tratterebbe cioè di un’inserzione erudita o novellistica di
Erodoto al proprio testo, ma di un elemento di cronaca397. Quando Milziade mosse alla
conquista di Lemno era naturale che egli volesse avallare il proprio atto coercitivo con una
qualche autorità morale o politica: la leggenda degli antichi rapporti di Atene con Lemno si
prestò allora a fornire uno strumento per il discorso diplomatico coi Lemni e uno strumento di
legittimazione della sua imposizione. In questa lettura degli eventi troverebbe conferma quella
ricostruzione poc’anzi proposta secondo cui la polis di Atene avrebbe collaborato con Milziade
fin dalle fasi organizzative della conquista di Lemno: cosìcchè, quando Milziade e gli Ateniesi
sbarcarono sull’isola, egli poté a ragione farsi campione della tradizione e dei diritti mitici dei
concittadini che lo accompagnavano. Nel corso di questa stessa ricerca si è già verificato l’uso
strumentale di eventi antichissimi o di nozioni di mito-storia al fine di garantire fondamento a
determinati diritti in epoca storica e al fine di guadagnare alla propria parte la legittimità morale
per rivendicazioni politiche o territoriali.
La conquista di Imbro insieme a Lemno
La critica è unanime nell’associare strettamente non solo la conquista di Lemno, ma anche
quella di Imbro all’iniziativa di Milziade II. A sostegno di questa ricostruzione la fonte addotta
395
Hdt. VI 137-139.
Thuc. IV 109.4; Diod. Sic. X 19.6; Nep. Vit. Milt. 2.
397
CULASSO GASTALDI 2011, p. 123. Vero è d’altronde che nella versione trasmessa da Cornelio Nepote la
condizione posta dai Lemni che gli Ateniesi giungessero con i venti Etesii è collocata non nel passato mitico, ma
invece in una prima fase delle operazioni di Milziade stesso: Nep. Vit. Milt. 1.
396
287
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
è nuovamente la narrazione fornita da Erodoto sulla biografia di Milziade II. Nel 493,
all’approssimarsi della flotta fenicia al Chersoneso, Milziade II raccolse una piccola flotta di
cinque triremi e lasciò il Chersoneso Tracico alla volta di Atene; i Fenici furono addosso al
convoglio, ma all’ultimo Milziade riuscì a raggiungere con quattro navi l’isola di Imbro e a
mettersi in salvo (kataphéugo); da là raggiunsero in sicurezza Atene398. L’isola di Imbro torna
ad essere caratterizzata come luogo sicuro per Milziade II in altro luogo dell’opera erodotea:
due volte, Erodoto sintetizza, Milziade II sfuggì alla morte, la prima fu nella fuga dai Fenici che
lo inseguirono fino ad Imbro; la seconda in patria, in tribunale399. Nella fonte erodotea Imbro
costituisce dunque una località sicura per Milziade II, presso la quale egli trova rifugio ed oltre
la quale la flotta persiana non prosegue la propria navigazione in direzione della Grecia.
Strategicamente Imbro è chiaramente legata, da un lato al Chersoneso e all’imbocco
dell’Ellesponto e d’altro lato all’isola di Lemno. Questa connessione è confermata dalle
operazioni di Otane nel 512-511 nelle quali appunto il persiano conquistò insieme entrambe le
isole400. Milziade II tratta chiaramente Imbro come un base da cui poter operare liberamente, o
perlomeno navigare in sicurezza, ma le fonti non trasmettono mai notizia delle circostanze in
cui egli venne ad accorparla alla propria rete di pertinenze. In questo senso la critica rende
ragione della ricostruzione secondo la quale Milziade II conquistò Lemno e Imbro nella
medesima operazione401. La ricerca epigrafica sembra trovare una conferma di questa
ricostruzione in un epitaffio in stile attico ritrovato a Lemno e risalente alla prima metà del V
secolo402.
Sarei propenso ad accogliere anche la ricostruzione più specifica secondo la quale
Milziade II cedette Lemno ad Atene, ma non altrettanto avrebbe fatto con Imbro: quest’isola
sarebbe stata cioè considerata come un nuovo territorio aggiuntosi all’insediamento del
Chersoneso Tracico e su di essa Milziade II avrebbe dunque esteso la propria autorità tirannica
personale. Questa ricostruzione renderebbe ragione della sicurezza con cui i Filaidi che
fuggivano da Chersoneso nel 493 si considerarono in salvo una volta giunti a Imbro403.
398
Hdt. VI 41.
Hdt. VI 104. CULASSO GASTALDI 2011, p. 123.
400
Hdt. V 25-27.
401
WADE-GERY 1951, pp. 212, 217; MEIGGS 1972, pp. 424s.; KEEN 2000, pp. 66-68; REGER 2004, p. 742;
MORENO 2007, pp. 107-113; KINZL 2011, s.v. “Milziades” [2], in BNP.
402
JEFFERY 1963, p. 300, n. 60.
403
WADE-GERY 1951, pp. 212, 216s.; MEIGGS 1972, pp. 424s.
399
288
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
V.5.9. La repressione della rivolta ionica e la fine della tirannide filaide in Chersoneso
Tracico (493)
Nel 493 gli ultimi focolai della rivolta ionica venivano definitivamente stroncati: dopo
avere svernato presso la conquistata Mileto (494) la flotta persiana procedette verso settentrione
e sottomise le isole di Chio, Lesbo e Tenedo404; da là la flotta procedette verso l’Ellesponto:
allora tutte le località del Chersoneso furono catturate o distrutte, ad eccezione di Cardia sulla
costa nordorientale405. Quando Milziade II seppe che la flotta fenicia era giunta all’altezza di
Tenedo, egli raccolse una piccola flotta di cinque triremi che caricò delle ricchezze che poté
(chrèmata) e fece vela verso Atene. Milziade salpò da Cardia e attraversò il golfo Melas;
quando le navi filaidi oltrepassarono la penisola del Chersoneso la flotta fenicia prese ad
inseguire il loro convoglio; ma Milziade riuscì a condurre quattro navi fino ad Imbro ove
furono in salvo e poi di là giunse ad Atene406.
Il movente dei Persiani: il coinvolgimento di Milziade II nella rivolta ionica
Le relazioni internazionali di Milziade II assunsero un carattere di avversione al potere
persiano nelle circostanze della spedizione scitica, nel 513, e del progetto di diserzione di cui
egli si rese portavoce nell’assemblea dei tiranni ellenici all’Istro407. Mancano notizie esplicite in
merito alla posizione di Milziade II verso la Persia nel ventennio successivo; nondimeno il
quadro dell’occupazione discontinua del Chersoneso Tracico dopo il 513 e la conquista di
Lemno e Imbro nel 500 ca. sono notizie che si interpretano coerentemente come il segno del
fatto che Milziade II perseguì in quel periodo una strategia anti-persiana408. La notizia ora in
discussione, relativa alla fuga dal Chersoneso Tracico di fronte al sopraggiungere della flotta
persiana, costituisce una conferma della posizione anti-persiana di Milziade II fino alla fine
della rivolta ionica: nel 493 Milziade II continuava ad essere considerato e a considerarsi un
nemico della Persia.
Il movente dei fenici nell’attaccare il Chersoneso Tracico si sarebbe fondato, secondo il
testo, sul tradimento di Milziade II ai danni di Dario all’epoca della spedizione scitica409;
eppure fra la repressione della rivolta ionica nel 493 e la spedizione scitica nel 513 erano ormai
trascorsi vent’anni: mi pare inverosimile dunque che i Fenici avessero ricevuto ordine di punire
il Filaide dopo tanto tempo. Le testimonianze della continuità dell’avversione di Milziade II ai
404
Hdt. VI 31.1.
Hdt. VI 33.
406
Hdt. VI 41.4.
407
Hdt. IV 137.
408
BURN 1962, pp. 218-220; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 41.3, p. 184.
409
Hdt. VI 41.3.
405
289
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
progetti persiani e il fatto stesso che egli fuggì nel 493 di fronte alle operazioni navali persiane
nell’ambito della rivolta mi paiono elementi validi per attribuire a Milziade II un ruolo nelle
operazioni dei Greci durante la rivolta ionica410.
L’Ellesponto fu subito infatti uno dei teatri cruciali della rivolta, sia per i Greci che per i
Persiani; la critica ritiene anzi che Aristagora dovette da subito assicurarsi l’adesione delle
poleis dell’Ellesponto e della Propontide: altrimenti la rivolta non avrebbe assolutamente potuto
sperare di avere successo, in virtù dell’importanza cruciale dei rifornimenti di risorse alimentari
dal Ponto Eusino411. La cronaca erodotea della rivolta ionica preserva notizie specifiche sulle
operazioni dei generali persiani Daurise e poi Imea nella repressione delle sollevazioni delle
poleis della regione dell’Ellesponto e delle coste asiatiche della Propontide412. La strategia di
Aristagora testimonia la volontà di spostare la rivolta non solo in Ellesponto, ma anche verso la
Tracia, ove la Persia aveva imposto la nuova satrapia dal 513-512413. Vero è che le fonti non
tramandano notizie riguardo ad operazioni dei Greci o dei Persiani specificamente in
Chersoneso Tracico, né si preserva memoria di alcuna iniziativa di Milziade II nel corso della
rivolta; eccezione però altamente significativa è appunto la vicenda ora discussa della
spedizione navale persiana contro il Chersoneso nel 493 e della fuga di Milziade II di fronte a
quel pericolo. L’attacco persiano contro il Chersoneso e la reazione allora di Milziade II non mi
pare trovino altra spiegazione ragionevole se non accettando la ricostruzione secondo cui il
tiranno chersonesita appoggiò gli Ioni durante la rivolta414.
Che i Persiani abbiano rivolto la propria attenzione contro Milziade II solo nella fase
finale della rivolta è peraltro comprensibile: in primo luogo le priorità della strategia persiana
furono logicamente rivolte ai teatri della terraferma asiatica ove l’incendio di Sardi aveva
dimostrato la pericolosità dei Greci per le infrastrutture persiane415; inoltre il vantaggio tattico
dei Greci fu sempre fondato sul controllo della navigazione e i Persiani impiegarono più tempo
a recuperare il libero accesso ai mari e dunque alla sponda europea dell’Ellesponto416.
Mancando notizie in merito alla natura dell’attività di Milziade II durante la rivolta spingo
l’interpretazione storica ad attribuirgli un impegno bellico indiretti, o piuttosto logistico e di
supporto: se infatti Milziade II avesse condotto iniziative di successo nel corso della rivolta
410
WADE-GERY 1951, p. 217; BURN 1962, pp. 208, 217-220; GEORGES 2000, pp. 37-39; SCOTT 2005, ad Hdt. VI
41.3, p. 184.
411
TOZZI 1978, pp. 125s., 163s.; WALLINGA 1984, pp. 411-436.
412
Hdt. V 103, 117, 122.
413
TOZZI 1978, pp. 110s., 166, 172s., 163, 186s., 191.
414
TOZZI 1978, pp. 44, 161, 164, 150, 158.
415
Hdt. V 102, 105.1, 108.1.
416
TOZZI 1978, pp. 46-49, 110-128; WALLINGA 1984, pp. 411-436; HIRSCH 1986 discute le implicazioni
strategiche e culturali della marineria ionica nel rapporto dei Greci con gli imperi terrestri d’Asia.
290
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
ionica è verosimile che la memoria storica dei Filaidi ne avrebbe preservato testimonianza,
come fu per la conquista di Lemno e Imbro e per la vittoria a Maratona. Il contributo di
Milziade II alla rivolta potè consistere nell’offerta di approdi sicuri in Chersoneso, o nella
gestione di rifornimenti alimentari. Entro il quadro delle attività di Milziade II durante la rivolta
ionica si inserisce a mio avviso la confusa notizia di Erodoto sulla discontinua occupazione del
Chersoneso Tracico da parte di Milziade II417.
La posizione strategica di Cardia
Il passo erodoteo permette di cogliere alcuni dati in merito alla strategia militare seguita
da Milziade II: è significativo a mio avviso il dettaglio secondo il quale Milziade II avrebbe
preparato la piccola flotta di cinque triremi e sarebbe salpato dal porto di Cardia. Cardia fu
infatti una polis significativa nel sistema della penisola chersonesita: il muro difensivo costruito
da Milziade I all’epoca della prima occupazione del territorio correva da Pactie sulla sponda
meridionale della penisola, attraverso il nucleo di Chersonesos/Agorà, per giungere infine a
Cardia sulla sponda settentrionale418. Quando poi i Persiani occuparono il Chersoneso dopo la
fuga di Milziade II, Cardia fu l’unico insediamento che, per un certo tempo, resistette alla
conquista419. Nel 493 Milziade II salpò da Cardia quando avrebbe potuto invece prendere il
largo da Elaious sull’estremità opposta del Chersoneso a poco più di venti chilometri da Imbro,
come infatti aveva fatto quando era partito alla conquista di Lemno420. Questa scelta conferma a
mio avviso che, negli anni precedenti il 493, Milziade II si era impegnato personalmente contro
le forze persiane: egli scelse di fare di Cardia la propria sede perché era una posizione sicura e
difendibile dagli attacchi persiani; inoltre la posizione sulla costa settentrionale consentì di
operare al segreto delle ricognizioni dei Persiani che operavano più attivamente
nell’Ellesponto421.
V.6. La cattura di Metioco e la sua naturalizzazione in Persia (493)
Del convoglio dei Filaidi che fuggivano la flotta persiana nel 493, la quinta nave fu
catturata dai Fenici; al comando di quella nave era Metioco, il figlio ateniese e primogenito di
Milziade II. I Fenici condussero Metioco al cospetto di Dario perché erano consapevoli del fatto
417
Hdt. VI 40.
Hdt. VI 36. HAMMOND 1956, pp. 117-124; ISAAC 1986, pp. 59s.; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 46, 234-240 sulla
storia e sul significato territoriale e politico del sistema difensivo che Milziade I per primo edificò a protezione
delle colonie del Chersoneso Tracico; LOUKOPOULOU 2004, pp. 900s.
419
Hdt. VI 34. BURN 1962, pp. 216s.
420
Hdt. VI 140.1. SCOTT 2005, ad 140.1, p. 452.
421
BURN 1962, p. 217.
418
291
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
che Milziade si era compromesso con Dario dall’epoca della sedizione ellenica all’Istro. Il Gran
Re non fece alcun male a Metioco, ma al contrario gli concesse grandi favori: donò a Metioco
una casa e dei possedimenti e una moglie persiana dalla quale ebbe figli che furono accettati
come Persiani422.
Erodoto stesso non rende ragione e non sembra poter spiegare la reazione di Dario di
fronte al Filaide Metioco: egli avrebbe dovuto rivolgere contro il figlio la punizione per cui i
Fenici erano stati inviati contro il padre. Il passo potrebbe anche infatti utilizzarsi a detrimento
della ricostruzione che ho accettato e proposto, secondo la quale Milziade II seguì una strategia
anti-persiana, e dunque potrebbe utilizzarsi a detrimento della credibilità del racconto erodoteo
dei fatti dell’Istro. Il trattamento favorevole di Metioco alla corte persiana sarebbe cioè
testimonianza del fatto che in realtà Milziade II e i Filaidi ancora godevano, nel 493, della
fiducia amichevole che il Gran Re aveva in loro riposto ai tempi della spedizione scitica423.
Questa interpretazione non rende ragione della stessa spedizione fenicia in Chersoneso nel 493,
indirizzata a sedare là gli ultimi esiti della rivolta ionica.
Ipotetica parentela di Metioco con Ippia
Il testo erodoteo è esplicito nell’affermare che Metioco era il figlio maggiore di Milziade
II, nato non da Egesipyle, ma da un’altra donna424; nondimeno le fonti non permettono di
approfondire con sicurezza la genealogia di Metioco. A questo proposito si è già avuto modo di
fare un accenno alla convincente tesi di H.T. Wade-Gery che rende ragione del trattamento
favorevole ricevuto presso Dario facendo appello ad una possibile ricostruzione dei legami
familiari di Metioco425. Un’analisi della cronologia e della biografia di Milziade II porta a
collocare il suo primo matrimonio entro il periodo trascorso ad Atene426; fino al 513, d’altro
canto, si è ricostruito che esistette una stretta collaborazione fra Pisistratidi e Filaidi: è possibile
dunque che quell’alleanza fra aristocratici fosse stata suggellata con uno scambio matrimoniale
per cui Ippia abbia dato in sposa una propria figlia a Milziade II. Se questa genealogia di
Metioco fosse valida, egli sarebbe stato dunque un nipote di Ippia. Quest’ultimo era certamente
in contatto personale con Dario entro la data del 491 ed è verosimile dunque che fosse
personalmente presente alla corte achemenide negli anni precedenti, probabilmente chiamato
come consigliere sugli affari ellenici fin dallo scoppio della rivolta nel 499. In conclusione,
422
Hdt. VI 41.4.
TURNER 1876, p. 301; AUSTIN 1990, p. 303; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 41.3, p. 184.
424
Hdt. VI 41.2.
425
WADE-GERY 1951, p. 219; BURN 1962, p. 217; DAVIES 1971, n. 8429 [IX], p. 302, n. 11793 [IX], p. 452;
GERNET 1983, pp. 177-199; HERMAN 1990, pp. 352s.;SCOTT 2005, ad Hdt. VI 39.2, pp. 180s. Vd. supra, pp.
236ss.
426
DAVIES 1971, n. 8429 [IX], [X].
423
292
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
quando Metioco fu portato alla corte di Dario, Ippia avrebbe riconosciuto nel giovane uomo il
figlio di sua figlia e avrebbe certamente chiesto al sovrano la grazia per quel suo parente
prossimo. In quel momento Ippia già godeva di una posizione di riguardo presso l’entourage di
Dario e perciò il sovrano rispose con tanta magnanimità per onorare sia il nuovo ospite che il
più vecchio consigliere427.
Metioco come ostaggio di riguardo
È possibile peraltro a mio avviso che la posizione di Metioco presso la corte di Dario
fosse quella di un ostaggio: il Gran Re avrebbe cioè accolto vicino a sé il figlio primogenito di
Milziade II per poter disporre di un elemento di persuasione e ricatto nelle future trattative
diplomatiche con Milziade II e con Atene428.
Quando i Fenici portarono Metioco al cospetto di Dario, Milziade II aveva da anni assunto
una strategia anti-persiana e aveva ripreso a difendere gli interessi di Atene, e in genere dei
Greci, in Ellesponto; con l’intervento di Milziade II, Atene aveva aperto un contenzioso con la
Persia per l’autorità su Lemno e Imbro; nel 498 Atene aveva contribuito alla ribellione che
aveva incendiato Sardi e provocato la sollevazione di tutte le poleis dell’Asia Minore; infine,
con la repressione della rivolta ionica in quel momento, era naturale aspettarsi che Atene e
Milziade II avrebbero tentato di riprendere il territorio del Chersoneso Tracico negli anni a
seguire429. Quando Metioco fu alla corte di Sardi, oppure di Susa, già Milziade II doveva
trovarsi al sicuro ad Atene: Dario stesso poteva supporre dunque quale influenza politica
l’antico tiranno chersonesita avrebbe esercitato ad Atene e Ippia, presso la sua corte, avrebbe
contribuito a chiarire ulteriormente lo status di Milziade II, di Metioco e in genere dei Filaidi.
Verosimilmente l’intento di far seguire alla repressione della rivolta la punizione di Atene ed
Eretria era già nei progetti di Dario nel 493.
Questo quadro di considerazioni strategiche e politiche doveva essere ben chiaro nella
mente del Gran Re di Persia: sarebbe certo stato più utile tenere Metioco prigioniero a corte
piuttosto che giustiziarlo. Nella prospettiva di dovere probabilmente tornare a confrontarsi con
Atene e Milziade II negli anni seguenti, Dario tenne Metioco presso di sé per poter esercitare
una pressione al fine di portare Milziade II e Atene su posizioni concilianti. A conferma di
questa ricostruzione si consideri che l’espediente di tenere i familiari in ostaggio è stato già
osservato nelle strategie di repressione messe in atto dalla tirannide di Pisistrato e si riscontra
427
WADE-GERY 1951, p. 219; BURN 1962, p. 217; DAVIES 1971, n. 8429 [IX], p. 302, n. 11793 [IX], p. 452; SCOTT
2005, ad Hdt. VI 39.2, pp. 180s.
428
La ricostruzione è suggerita in LOADER 1947, p. 21, ove è però circostanziata all’utilizzo di Metioco come
ostaggio in occasione dello scontro di Maratona.
429
GRAHAM 1964; DAVIES 1997, pp. 134s.
293
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte V: i Filaidi
inoltre esplicitamente come strumento dei re di Persia per mantenere la fedeltà dei sudditi greci,
sia presso Dario che presso il successore Serse430.
Metioco entro l’élite achemenide
Non solo Metioco non subì la punizione di Dario per la sedizione del padre, ma fu trattato
onorevolmente e di fatto completamente naturalizzato nell’élite possidente persiana: ricevette in
dono dal Gran Re una casa (òikos) e insieme delle proprietà (ktésin), ricevette una donna
persiana e i figli che nacquero dalla sua unione furono riconosciuti come Persiani legittimi431. È
evidente che qui la narrazione erodotea sta operando una compressione cronologica degli anni
che seguirono l’arrivo a corte di Metioco.
Il comportamento di Dario può spiegarsi considerando la tendenza delle grandi corti
monarchiche orientali ad accogliere entro il proprio sistema burocratico individui delle diverse
nazionalità su cui si estendeva l’impero, secondo il criterio di usufruire delle loro competenze
specializzate e conoscenze di prima mano per le relazioni con le diverse entità sociali o
politiche con cui il regno entrava in contatto432. I sovrani achemenidi si dimostrarono inoltre
sempre generosi e magnanimi verso i propri ospiti, anche quando non vi era la necessità di
creare legami di reciprocità o di alleanza, ma con il solo proposito di ostentare supremazia e
ricchezza433.
La reazione di fronte a Metioco poté forse costituire anche un messaggio rivolto ai grandi
aristocratici di Ionia e del mondo greco inteso a dimostrare la volontà di Dario di soprassedere
ai più vecchi rancori della rivolta ionica e di accogliere individui di rango elevato nell’impero
achemenide in posizioni a loro connaturate: cioè un gesto propagandistico volto ad accendere
entro la classe politica aristocratica ellenica una posizione filo-persiana.
In conclusione mi pare verosimile che queste tre interpretazioni dello status di Metioco e
dei moventi di Dario non siano affatto necessariamente esclusive e che anzi più probabilmente
abbiano agito insieme nel determinare l’esito delle vicenda e della vita di Metioco.
430
Hdt. I 64, Pisistrato prese in ostaggio i figli degli oppositori politici, dopo lo scontro di Pallene; VI 99.1, nella
prima guerra persiana furono presi in ostaggio i figli degli isolani nel tragitto verso l’Eubea; VII 52 gli Ioni
nell’esercito di Serse rimasero fedeli perché avevano lasciato mogli, figli e beni in Asia. PARKE 1946, pp. 107s.
Un’analisi di taglio antropologico sulla pratica della cattura e scambio di ostaggi in RAAFLAUB 2007, pp. 10, 17s.;
YATES 2007, pp. 36-39.
431
Hdt. VI 41.4.
432
Emblematico è il caso della relazione fra Istieo di Mileto e Dario I: Hdt. V 24. BLAMIRE 1959, p. 153; EVANS
1963, pp. 116-117; FOL-HAMMOND 1988, pp. 243-149; MITCHELL 1997, pp. 111-120; LURAGHI 1998, pp. 31-25,
43-45.
433
FOL-HAMMOND 1988, pp. 135-253; AUSTIN 1990, 289-291, 295-306; MITCHELL 1997, pp. 111-120; LURAGHI
1998, pp. 33-39; SCOTT 2005, ad Hdt. VI 24.2, pp. 137s.
294
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
PARTE VI: LA TIRANNIDE DI IPPIA (527-510; 510-490)
VI.1. Il rapporto storico fra le tirannidi di Pisistrato e Ippia
È necessario riconoscere che esistono poche notizie o attestazioni concernenti le relazioni
interstatali o la politica estera di Pisistrato dopo quel novero di interventi significativi narrati
per i primi anni della tirannide, collocati da questa analisi entro il periodo 546-540 ca.: le
uniche informazioni giunte tramite la tradizione storiografica riguardano le circostanze della
proclamazione olimpionica concordata con Cimone agli agoni panellenici del 532 e la notizia
della morte di Pisistrato e della successione alla tirannide del figlio Ippia, da collocarsi nel
528/71.
Ippia aveva in effetti già assunto un ruolo e una responsabilità operativa in occasione
dell’instaurazione della definitiva tirannide del padre ad Atene nel 546. In qualità di figlio
ateniese primogenito, Ippia era il naturale e legittimo successore di Pisistrato nella conduzione
dell’òikos e della polis. Ippia subentrò dunque al padre in qualità di capofamiglia dei
Pisistratidi, in qualità di detentore delle ricchezze e dei beni e fu da quel momento il riferimento
sociale dell’òikos. Elemento caratteristico infatti di tutte le tirannidi, da cui i non si discostarono
Pisistratidi, era che il figlio ereditasse il potere e l’autorità socio-politica del tiranno e
raccogliesse senza soluzione di continuità la posizione tirannica nella polis2.
Allo stesso modo, insieme al potere tirannico, Ippia ereditò anche il sistema di relazioni
internazionali che Pisistrato aveva costruito al di fuori di Atene: una delle caratteristiche
precipue delle relazioni quali la xenìa, la philìa e dei legami di reciprocità era appunto
l’ereditarietà e la loro estensione agli ambiti familiari dei contraenti. Con la tirannide, Ippia
ereditò la gestione della politica estera di Atene nella conformazione in cui l’aveva lasciata
Pisistrato: egli trovò aperte e attive quelle direttrici internazionali sviluppate da suo padre e ne
fu il nuovo responsabile. È logico dunque che Ippia, dal 527, abbia proseguito l’attività
internazionale, sia familiare che statale, sfruttando le posizioni raggiunte fino ad allora dal
padre.
Nella prospettiva dell’analisi storica è corretto dunque riconoscere un fattore di continuità
fra il quadro della politica internazionale ricostruito per Pisistrato e quello mostrato da Ippia.
L’operato internazionale di Ippia fu in molti casi anche il punto di arrivo di processi avviati
all’epoca di Pisistrato. Nella prospettiva della continuità, le notizie che si ricavano per la storia
1
2
Vd. supra, pp. 177ss.
Hdt. I 61; Thuc. I 20.2, VI 55. SUTHERLAND 1943, p. 142.
295
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
dei Pisistratidi negli anni successivi al 528/7, possono fornire perciò un caposaldo comparativo
per dare forma a una ricostruzione della storia della politica internazionale di Pisistrato anche
nel periodo che va dal 540 ca. fino alla sua morte per il quale le fonti non trasmettono che pochi
dati.
Viceversa però la tirannide di Ippia è chiaramente distinta da elementi di discontinuità
storica rispetto a quella del padre. Ippia si trovò naturalmente a fronteggiare dinamiche
specifiche e modificazioni anche drammatiche del sistema internazionale nel corso della sua
tirannide: a partire dall’ultimo quarto del VI secolo la Grecia centrale fu interessata da nuovi
equilibri di potere fra Tessaglia e Beozia; nelle Cicladi si affermò la talassocrazia di Samo;
l’espansione dell’impero persiano modificò per sempre il sistema internazionale. Di fronte a
questi e ad altri eventi Ippia operò delle scelte personali e modificò la strategia internazionale
familiare e pubblica.
In conclusione è costruttivo stabilire sempre un confronto storico fra le notizie relative
alla politica internazionale di Ippia e il quadro ricavato per Pisistrato per ricostruire una storia
di lungo periodo della politica internazionale della famiglia dei Pisistratidi: cioè giungere a dare
uno spessore cronologico e ad ampliare i nessi causali dall’ambito delle contingenze a quello
delle cause profonde. Di volta in volta è dunque necessario verificare la presenza di fenomeni di
continuità oppure circostanze di discontinuità.
VI.2. La tirannide di Ippia alla morte di Pisistrato (528/7)
Le fonti letterarie e gli studiosi moderni concordano tutti nel collocare la morte di
Pisistrato al 528/7: il tiranno morì anziano per cause naturali, trentatré anni dopo la prima
tirannide e dopo avere comandato Atene per 19 anni senza provocare disordini o significative
contestazioni avendo gestito in maniera oculata il rapporto con il popolo, l’aristocrazia e con le
istituzioni dello stato3. Da quel momento la tirannide fu assunta dal primogenito Ippia. Il
fratello Ipparco sembra abbia contribuito alla gestione del potere ad Atene occupandosi di
aspetti culturali utili alla politica di prestigio della famiglia. Il loro mezzo fratello Egesistrato si
trovava a Sigeo, ormai dai primi anni successivi al 546, ove deteneva la tirannide e assicurava il
controllo della posizione cruciale in Troade a vantaggio dei Pisistratidi e di Atene.
3
Aristot. Ath. Pol. 17.1; Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 185k Helm. BERVE 1967, pp. 63-77; RHODES 1981, ad.
Aristot. Ath. Pol. 17, pp. 191-199; LAVELLE 2005, pp. 210-222.
296
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
VI.3. La politica culturale internazionale di Ipparco
Nella ricostruzione della gestione del potere dei Pisistratidi si può asserire che Ippia e
Ipparco collaborarono in una certa misura e in taluni aspetti del controllo su Atene: in questo
senso si devono leggere i riferimenti ai “Pisistratidi” quali tiranni di Atene nel periodo
successivo a Pisistrato, cioè come un riferimento ai due fratelli Ippia e Ipparco, anziché al solo
tiranno primogenito4; questa osservazione è d’altronde in linea con quelle pratiche di
compartecipazione al potere e gestione organica degli interessi familiari già messe in evidenza
per la tirannide di Pisistrato. Non è possibile ignorare quelle fonti e quella critica che
puntualizzano la primogenitura di Ippia e dunque la sua successione diretta al padre Pisistrato
nel comando della famiglia: è innegabile perciò che il referente politico dei Pisistratidi e della
tirannide ateniese fosse appunto Ippia. Per il fratello minore Ipparco si delinea dunque un ruolo
di secondo piano, centrato sulle gestione delle attività culturali e degli aspetti religiosi entro il
governo tirannico di Atene e del mecenatismo della corte pisistratide5. Le fonti coinvolgono
Ipparco nell’introduzione della poesia omerica ad Atene e possibilmente della redazione di un
canone dei canti omerici, ad Ipparco sarebbe da attribuirsi l’introduzione della regola
panatenaica che stabiliva le modalità di competizione negli agoni rapsodici delle Grandi
Panatenee, egli sarebbe il responsabile dell’erezione di un gran numero di Erme in tutto il
territorio ateniese che ebbero funzione e carattere tanto cultuale quanto sapienziale in
considerazione delle massime che vi erano iscritte6. Sotto l’aspetto della politica culturale e in
relazione alla posizione internazionale dei Pisistratidi, sono interessanti le notizie sulla presenza
ad Atene e presso la corte dei tiranni di poeti lirici protagonisti della temperie culturale
dell’epoca.
Simonide e Anacreonte alla corte dei Pisistratidi
Secondo le fonti, Ipparco, durante la tirannide del fratello Ippia, fece venire ad Atene un
certo numero di poeti lirici, fra i quali i più celebri furono Simonide di Ceo e Anacreonte di
Teo7. I frammenti pervenuti di Anacreonte permettono effettivamente di ricavare espliciti
4
A titolo d’esempio cito i seguenti passi in cui le fonti non identificano con precisione un individuo, Ippia o
Ipparco, ma scelgono il riferimento ai “Pisistratidi”: Hdt. VI 39.1, 62.2, 63.2-3, 65, 70.1, 90, VI 103.3, VII 6.4-5;
Thuc. VI 54.5-6; Schol. Aristoph. Lys. 665; Aristot. Ath. Pol. 19.3-6; Pol. V 10 (1311a.36-39), V 11 (1313b.24), V
12 (1315b.29s.). ANNIBALETTO 2000, ad Hdt. VII 6, n. 1.
5
Plat. Hipparch. 228b-229d (= Anacr. Test. 6 Page); Aristot. Ath. Pol. 18.1. CAMPBELL 1988, pp. 3s. Pure si
tengano presenti le cautele espresse da J.K. Davies sulle caratteristiche storiografiche delle fonti relative a
quest’aspetto del carattere di Ipparco: DAVIES 1971, n. 11793.
6
Plat. Hipparch. 228d-229b. MAHAFFY 1892, pp. 85s.; MURRAY 1901, pp. 10-23; DAVISON 1958, pp. 29, 38;
LONG 1987, pp. 68, 159s., 170; SHAPIRO 1989, pp. 40-47, 125-132; CALAME 1996, pp. 471-489; PARKER 1996, pp.
89-92; FORD 1999, pp. 231-241; HURWIT 1999, pp. 352.
7
Plat. Hipparch. 228b-229d (= Anacr. Test. 6 Page); Aristot. Ath. Pol. 18.1. BERVE 1967, pp. 66s.; CAMPBELL
1988, pp. 3s.; KEESLING 2000, pp. 60-66; MURRAY 2009, p. 517.
297
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
rimandi all’ambiente ateniese e alla tirannide pisistratide8. Di entrambe queste personalità
poetiche la critica letteraria ha messo in evidenza il carattere simposiale della produzione: le
liriche sono eminentemente centrate sui temi dei piaceri e dei divertimenti del simposio, del
godimento del vino e sull’amore; viceversa si può notare una chiara assenza di argomentazioni
politiche o polemiche di alcun tipo; diversamente, buona parte delle liriche simposiali arcaiche
menzionano invece direttamente, o allegoricamente, fatti e circostanze politico-sociali, come è
il caso, ad esempio, nella produzione di Archiloco, Alceo o Teognide. Da queste caratteristiche
la critica ha argomentato che Anacreonte e Simonide vissero alla corte dei tiranni, quali poeti
stipendiati dai Pisistratidi per allietare gli ospiti dei simposi e dei ricevimenti presso la loro
residenza, un pubblico per il quale i riferimenti poetici ad argomenti controversi, politicamente
sensibili o a problemi sociali avrebbero potuto creare tensioni o rotture9. L’analisi dei testi
poetici concorda dunque con i riferimenti nelle fonti in merito all’intervento personale di
Ipparco il quale avrebbe inviato una pentecontere a prelevare Anacreonte dalla Ionia e avrebbe
stipendiato Simonide con compensi e costosi doni10. Della biografia di Anacreonte si è
ricostruito che visse ed operò presso la corte del tiranno Policrate di Samo; alla morte di
Policrate nel 522 Ipparco avrebbe dunque provveduto all’invio della trireme per prelevare ed
ingaggiare il rinomato poeta lirico11. È possibile dunque a mio avviso che fra i poeti non
individualmente specificati nel passo aristotelico sopra citato vi fossero anche altre personalità
artistiche provenienti dalla ricca e celebre corte tirannica di Samo. Anacreonte sembra sia poi
rimasto ad Atene, sopravvivendo alla caduta della tirannide fino ad una età avanzata12. La
poesia di Simonide testimonia invece la sua presenza presso la corte dei sovrani Alevadi di
Tessaglia e si suppone dunque che egli abbia lasciato Atene dopo il 514, quando fu assassinato
il suo patrono Ipparco, oppure dopo la fuga di Ippia nel 51013. È nota poi la presenza di
Simonide anche alla corte dei Dinomenidi, tiranni di Siracusa14.
Questi dati letterari e biografici sui due poeti lirici e la notizia del loro ingaggio presso la
corte di Ippia e Ipparco permettono di trarre alcune conclusioni sulle relazioni internazionali dei
Pisistratidi o perlomeno sulla loro posizione nello scenario internazionale. Non sorprende
8
Anacr. frr. 412, 495, 500, Page. CAMPBELL 1988, p. 3s.
CAMPBELL 1988, pp. 3s.; LABARBE 1962; KANTZIOS 2005; LAVELLE 2010, s.v. "Tyranny", in BNP. Contro
questa interpretazione si potrebbero tuttavia mettere in luce la testimonianza di Anacr. FF 348, 353 Page, in cui è
possibile rilevare dei riferimenti all’ambiente politico di Samo, ove il poeta visse prima di giungere ad Atene, vd.
CAMPBELL 1988, pp. 3s.
10
Plat. Hipparch. 228b-c; Aristot. Ath. Pol. 18.1. BERVE 1967, pp. 66s.
11
Anacr. Test. 1, 2 ed. Page. CAMPBELL 1988, pp. 3s.
12
Plat. Hipparch. 228c; Paus. I 25.1.
13
Simon. frr. 107, 108DD, ed. Page. SORDI 1958, pp. 61, 84; CAMPBELL 1988, pp. 3s.; MURRAY 2009, p. 517.
14
Timae. FGrHist 566 F 93; Diod. XI.48 3-8. ASHERI 1992, p. 147, 149, 152-154, 170, .
9
298
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
l’interesse dei due Pisistratidi per la poesia lirica simposiale poiché è del tutto in linea con la
collocazione sociale dei tiranni entro l’élite aristocratica, politicamente ma anche culturalmente
attiva, dell’epoca arcaica. Il dato contribuisce a chiarire l’ampiezza dell’intervento dei tiranni
dal punto di vista della molteplicità e varietà degli ambiti sociali e culturali in cui operarono; la
presenza di poeti ed artisti di fama alla corte pisistratide fa luce sugli strumenti e i meccanismi
di auto-affermazione, di giustificazione del potere tirannico e di visibilità di quel potere ad
Atene e nell’Ellade. Una riflessione su questo punto permette di aggiungere ulteriori aspetti ed
ambiti delle relazioni internazionali dei Pisistratidi alternativi ed integranti rispetto alle
iniziative di natura inter-personale, familiare, politica o diplomatica. Ipparco e Ippia furono cioè
non solo attivi nella costruzione delle relazioni inter-aristocratiche e diplomatiche extrapoleiche con altri soggetti politicamente significativi, non solo furono sensibili agli strumenti di
visibilità sociale e affermazione di prestigio che offrivano i centri cultuali panellenici: i tiranni
ateniesi furono anche attenti osservatori e fruitori delle tendenze artistiche internazionali del
proprio tempo, culturalmente partecipi del mondo della poesia e dell’arte su cui l’aristocrazia
ellenica e micrasiatica stendeva il proprio patronato. La politica culturale di Ipparco ebbe
dunque un chiaro respiro internazionale e una funzione propagandistica: non semplicemente era
volta al godimento di produzioni artistiche di lusso: piuttosto la presenza di Anacreonte,
Simonide e altri lirici presso la corte dei Pisistratidi aveva la funzione di affermare il loro status
e il loro potere, era un segnale rivolto agli ospiti della corte di Ippia, agli aristocratici di Atene e
della Grecia, inteso a dimostrare l’appartenenza culturale dei Pisistratidi all’élite internazionale
del loro tempo. In questo senso dunque si può concludere che il progetto artistico-culturale di
Ipparco si integrasse entro quello strategico-politico portato avanti dal fratello Ippia ed avesse
anch’esso un chiaro valore entro il quadro delle relazioni internazionali15.
Suscita interesse la constatazione della presenza di Anacreonte prima alla corte di
Policrate e poi presso quella di Ippia, in quanto trova una propria contestualizzazione entro la
sovrapposizione e la successione degli interventi di Pisistrato e di Policrate nelle Cicladi, a
Nasso e a Delo16. Cronologicamente, l’attività di Pisistrato a Nasso e a Delo è da collocarsi ai
primi anni della sua tirannide, nel periodo intorno al 545; l’intervento di Policrate fu successivo
e può farsi coincidere con la sua tirannide a Samo, nel periodo 537-522, probabilmente verso la
fine di quel periodo. Da prospettive differenti e sulla base di queste osservazioni, alcuni studiosi
hanno proposto la possibilità che vi sia stato un contatto o un’alleanza fra i tiranni di Atene e di
15
MAHAFFY 1892, pp. 85s.
Alleanza di Pisistrato con Ligdami di Nasso: Hdt. I 61; Aristot. Ath. Pol. 15.2s. Alleanza di Policrate con
Ligdami di Nasso: Polyaen. I 23.2.
16
299
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
Samo17. A mio avviso si tratta però di notizie configurate in modo troppo disorganico e relative
a momenti differenti; soprattutto nessuna fonte pone mai in contatto fra loro i Pisistratidi e
Policrate e ancor meno accenna ad un’alleanza fra le due tirannidi: postulare l’esistenza di
un’alleanza o di un’intesa non mi pare perciò possibile18. Sicuramente però Pisistrato e
Policrate ebbero modo di conoscere le rispettive personalità e i rispettivi interventi in ambito
internazionale, se non anche ricevettero notizie in merito agli avvenimenti di Atene e Samo,
seppero misurare il significato della fama uno dell’altro e sicuramente avranno avuto uno
sguardo vigile sui progetti e sulle iniziative uno dell’altro19; dall’analisi sopra condotta è
necessario dedurre infine che i due condivisero affine gusto artistico e cultura letteraria.
In questa contestualizzazione di più lungo periodo e di interazione, se pure indiretta, fra
Pisistrato e Policrate assume il proprio pieno significato la politica culturale internazionale di
Ipparco. Quando cioè Ippia successe al padre nella gestione del potere della tirannide, la
presenza di Policrate nelle Cicladi era un tema significativo e allarmante; Ippia e il fratello
erano pienamente al corrente della posizione internazionale di Policrate, del potere navale di
Samo, del lusso di quella corte, perfino delle personalità artistiche che vivevano presso il
tiranno. Nell’iniziativa che vide il trasferimento di Anacreonte dalla corte di Policrate a quella
di Ippia ritengo si possa leggere una volontà di emulazione dei giovani tiranni di Atene nei
confronti della ricca e famigerata tirannide e talassocrazia di Samo. Durante la sua tirannide, fra
gli interventi urbanistici ad Atene, Ippia avviò anche la costruzione di un colossale tempio a
doppio peristilio dedicato a Zeus Olimpio: come per il mecenatismo artistico verso Anacreonte,
è possibile che fra i moventi per questa iniziativa e questa scelta architettonica vi fosse la
volontà di eguagliare le colossali opere pubbliche realizzate a Samo da Policrate, in particolare
l’Heraion, ricordate dalla storiografia antica20. In base alla storia delle relazioni di Ipparco con
Anacreonte vorrei anzi avanzare l’ipotesi che Ipparco e Ippia avessero avuto modo di
frequentare la corte di Policrate, non necessariamente per missioni politiche o diplomatiche, e
avrebbero allora potuto apprezzare le liriche del poeta.
17
LEAHY 1957, p. 274, nn. 26, 27, 29 cita a questo proposito le posizioni di H. Bengtson, F. Cornelius, F.
Schachermeyr, F.E. Adcock e W.W. How e J. Wells, pur esprimendo il proprio dissenso; ANDREWES 1982 b, p.
403; KEESLING 2005, pp. 409s.
18
PARKE 1946, pp. 105-108; LEAHY 1957, p. 274.
19
Sulle celebri opere urbanistiche di Policrate a Samo e il ragguardevole palazzo del tiranno: Hdt. III 60; Aristot.
Pol. 1313b 24 (V 11); Svet. Calig. 21.
20
PARKER 1996, pp. 87-89, 97-99.
300
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
VI.4. L’insediamento pisistratide sul fiume Strimone in Tracia durante la tirannide di
Ippia (558-513 ca.)
Non vi sono motivi per cui Pisistrato avrebbe dovuto abbandonare l’insediamento
familiare al Monte Pangeo sullo Strimone, in Tracia, dopo il 546 e il ritorno ad Atene dall’esilio
e le fonti dimostrano di riconoscere che le ricchezze minerarie e le truppe mercenarie
provenienti dallo Strimone fossero fra gli strumenti con cui Pisistrato mantenne saldo il proprio
potere ad Atene, nel 546 come nel corso di tutta la sua tirannide21. Su queste premesse si può
ritenere che nel 527 Ippia ereditò dal padre l’insediamento presso lo Strimone in Tracia e che
anche egli poté usufruire dei vantaggi economici e militari che ne derivavano. È corretto
riconoscere che non disponiamo per Ippia di attestazioni che lo legano esplicitamente
all’insediamento tracico, come sono invece note per Pisistrato; eppure diverse fonti identificano
con chiarezza la presenza di un corpo di guardia di mercenari stranieri (epikòuroi o doryphòroi)
agli ordini di Ippia, perlomeno fino all’epoca dell’episodio del tirannicidio del fratello Ipparco
nel 514: in queste risorse militari a disposizione di Ippia si debbono a mio avviso riconoscere
quei medesimi corpi armati di mercenari traci, provenienti dall’area del fiume Strimone, di cui
Pisistrato si servì nella battaglia di Pallene e che gli assicurarono il potere fino alla sua morte22.
Tuttavia un’analisi della storia della tirannide di Ippia, dopo la presa del potere, delle
attestazioni riferite alla Tracia e all’area del Pangeo nonché degli sviluppi geopolitici nell’area
tracica nell’ultima parte del VI secolo, porta, a mio avviso, a riconoscere che l’insediamento
pisistratide al Pangeo fu effettivamente abbandonato nel corso della tirannide di Ippia all’epoca
della spedizione condotta dall’impero persiano in Europa e contro gli Sciti, nel 513.
Senz’altro i Pisistratidi avevano lasciato l’area entro il 504 ca: a quell’epoca infatti, dopo
il fallimento del tentativo di rientro ad Atene sotto l’egida spartana, Ippia decise di abbandonare
definitivamente l’attività diplomatica nella Grecia continentale, ma fra le possibilità che gli si
prospettarono nella scelta di una nuova sede, né Rhaikelos, né il Pangeo o la foce dello
Strimone, né la Tracia in genere, vengono affatto menzionati; piuttosto egli scelse di ritirarsi
presso la colonia di Sigeo in Troade23. Sigeo era in controllo di Egesistrato, fratello per parte di
padre di Ippia stesso, da poco dopo il 546, e sorgeva in una posizione strategicamente cruciale.
Diversamente da Sigeo, che era di fatto una colonia ateniese pur in controllo della tirannide
21
Hdt. I 64.1; Aristot. Ath. Pol. 15.2. HOPPER 1961, pp. 141-146; COLE 1975; STAHL 1987, pp. 201, 227s.
Thuc. VI 56.2, 57.1, 4, 58.2; Aristoph. Eq. 447-449; Aristot. Ath. Pol. 18.4; riflessione generale sui corpi di
guardia usati dai tiranni in Aristot. Pol. 1285a-1286b (III 14s.). Nel senso di una eredità non solo del potere, ma
anche della guardia armata del tiranno, potrebbe leggersi Polyaen. I 21.3. DREWES 1972, pp. 141s.; BING 1977, p.
111; RHODES 1981, ad Aristot. Ath. Pol. 15.2, p. 207s.; LINTOTT 1982, p. 15-31; FINE 1983, pp. 225s.; FROST
1984, pp. 291-293; DE LIBERO 1996, pp. 65s.; DE LIBERO 1998. Contra BETTALLI 1995, pp. 88-90.
23
Hdt. V 91.1. MERITT 1939, pp. 115-119; MCGREGOR 1987, p. 13.
22
301
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
pisistratide, lo stanziamento sul fiume Strimone in Tracia aveva il chiaro carattere di un
insediamento familiare, cioè un possedimento di cui Ippia e i Pisistratidi avrebbero potuto
disporre in completa autonomia e libertà; le risorse che l’area rendeva disponibili potevano
rivelarsi di grande utilità in vista di un possibile rientro ad Atene, come infatti si era dimostrato
per suo padre Pisistrato nel 556-546. Ciononostante, nel 504 ca., Ippia preferì recarsi a Sigeo
piuttosto che in Tracia: si dovrà inferire, a mio avviso, che in quel momento i Pisistratidi non
disponessero più della loro posizione in Tracia24.
Il 504 ca. costituisce dunque un sicuro terminus ante quem per l’abbandono da parte dei
Pisistratidi dei loro interessi in Tracia; nondimeno ritengo si debba risalire di un altro decennio
nella ricerca delle circostanze che segnano la fine dell’insediamento al Pangeo. Nel 513 il Gran
Re di Persia Dario I compì una prima spedizione in Europa con l’intento di conquistare la
Tracia e di effettuare una incursione contro gli Sciti a nord dell’Istro; la datazione di questa
cosiddetta spedizione scitica è di non semplice soluzione, ma un’analisi delle fonti, sia greche
che persiane, e della critica più attenta alla cronologia dei regni dei sovrani achemenidi porta a
collocare l’episodio con buona sicurezza entro il biennio 513-51225. La conquista della Tracia
fu affidata da Dario al generale persiano Megabazo le cui operazioni portarono all’occupazione
della Tracia affacciata sull’Egeo settentrionale, dall’Ellesponto fino all’area dello Strimone, e di
significative porzioni dell’entroterra; i territorio conquistati furono inseriti nell’organizzazione
achemenide con la creazione della nuova satrapia di Tracia (Skùdra nella fonti persiane)26. Le
risorse principali della satrapia erano oro e argento come dimostrano i beni tramite cui era
versato il tributo al Gran Re: da questo dato è possibile comprendere meglio, e da una
prospettiva non-ellenica, quale fosse l’interesse internazionale per la posizione strategica e per
le risorse della Tracia. Nella narrazione piuttosto dettagliata preservata dalle fonti non vi è
menzione della presenza di insediamenti ateniesi o pisistratidi nella zona del Pangeo: piuttosto
il soggetto politico con cui i Persiani entrarono in contatto furono i Traci; è sicuro peraltro che
le operazioni persiane interessarono tanto le aree costiere quanto l’entroterra27.
Specificamente l’area del monte Pangeo e del fiume Strimone ebbero una rilevante
importanza strategica per le operazioni militari di Megabazo nel 513-512, nonché per le scelte
organizzative e politiche operate da Dario negli anni successivi alla spedizione scitica. La
narrazione erodotea dimostra infatti di conoscere interessanti dettagli della campagna di
24
DAVERIO ROCCHI 1973, pp. 95-99.
Vd. supra, n. 857 pp. 247ss.
26
OLMSTEAD 1939, p. 308s.; CAMERON 1943, p. 312; BALCER 1972, soprattutto pp. 124-126; TALBERT 1985, p.
18; FOL-HAMMOND 1988, pp. 246-249.
27
BURY, 1897; FOL-HAMMOND 1988.
25
302
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
Megabazo sul confine dello Strimone e in prossimità del monte Pangeo e riporta i successi e le
difficoltà incontrate dal generale persiano nell’assoggettamento delle numerose popolazioni
traciche28. Dalla medesima fonte si evincono il valore strategico-geografico del fiume Strimone
e del parallelo fiume Axio, più a occidente e la condizione delle vie di comunicazione che
conducono dalla Tracia verso la confinante Macedonia29. Poco tempo dopo il rientro in Asia,
nel 512 ca., in riconoscenza dei meriti acquisiti durante la spedizione scitica, Dario ricompensò
il greco Istieo, tiranno di Mileto, con la concessione di un insediamento a Mircino, un sito
localizzato 25 Km a nord del costone montuoso del Pangeo30. Anche negli anni successivi al
512 e all’installazione di Istieo presso Mircino, l’area deve considerarsi di particolare sensibilità
poiché il generale Megabazo non rinunciò a influenzare le decisioni di Dario in merito alla
gestione dello sfruttamento e dell’insediamento di Mircino e dell’area tracica31. Sia
l’occupazione persiana della Tracia che l’importanza strategica degli insediamenti lungo il
fiume Strimone sono riconfermate ancora nel 486-480, all’epoca in cui il Gran Re Serse andava
approntando la spedizione contro la Grecia: uno dei quattro siti in cui si raccolsero i
rifornimenti per l’esercito di Persia fu Eione, una località sulla foce dello Strimone a pochissimi
chilometri dal promontorio del Monte Pangeo32.
In tutte le circostanze sopra discusse non compare né si allude mai alla presenza di
insediamenti pisistratidi, né ateniesi o principalmente greci; eppure, il contesto strategico di
grandi cambiamenti e di interessante mobilità avrebbe imposto necessariamente ai Pisistratidi di
intervenire o interagire con i Traci o con i Persiani. Il silenzio delle fonti va dunque interpretato
come il segno dell’assenza dei Pisistratidi dall’area. In conclusione, mi pare che il periodo della
spedizione di Dario in Tracia costituisca un contesto storico e cronologico appropriato per la
fine dell’occupazione pisistratide al Pangeo: lo stanziamento dell’esercito persiano, la
riorganizzazione amministrativa del territorio e lo sfruttamento delle risorse minerarie da parte
dell’impero achemenide mi paiono infatti moventi sufficienti perché i Pisistratidi si vedessero
costretti a lasciare la Tracia33. Successivamente al 514 la situazione ad Atene divenne
28
Hdt. V 15s.: Megabazo conquistò tutti i Traci: Peoni, Siriopeoni, Peopli, fino al Lago Prasia (Prasiados limne);
non riuscì a completare l’assoggettamento dei Traci che abitavano il Monte Pangeo, né quelli che abitavano il
lago Prasia: Doberi, Agriani e Odomanti (tr. it. NENCI 2006)
29
Hdt. V 17. DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 51s. sul valore dei fiumi come segno territoriale di confine.
30
Hdt. V 11.
31
Hdt. V 23: Megabazo convinse Dario a ritirare Istieo da Mircino poiché le ricchezze minerarie, le risorse naturali
di legname e la disponibilità di mercenari rendevano l’affidamento dell’insediamento al Greco troppo pericoloso.
32
Hdt. VII 25.
33
SELTMAN 1924, p. 84 ritiene che l’abbandono del Pangeo e delle miniere da parte dei Pisistratidi sia da datare al
512; HOPPER 1961, pp. 141-146 ritiene che un collegamento fra Atene e l’area mineraria del Pangeo sia rimasto
attivo fin anche dopo la spedizione scitica di Dario e dunque fino ai primi anni del V secolo; FINE 1983, pp. 225s.
offre una ricostruzione, datazione e contestualizzazione in tutto affini a quella qui proposta.
303
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
particolarmente difficile per Ippia e si mettono in evidenza i segni del tracollo del suo potere
tirannico locale: ad Atene una congiura aristocratica assassinò il fratello Ipparco, sia fuori
dell’Attica che entro la penisola si intensificò l’attività degli esuli alcmeonidi, Ippia sembra
avesse perso l’appoggio fra i concittadini e avviò la ricerca di nuovi alleati personali all’esterno;
la situazione infine precipitò nel 510 con l’espulsione dei Pisistratidi da Atene durante
l’arcontato di Arpactide34. Considerando la datazione sopra proposta per la fine
dell’occupazione in Tracia, mi pare plausibile porre una relazione causale fra l’interruzione
dell’afflusso di ricchezze e mercenari dal Pangeo con la serie di difficoltà che la tirannide
incominciò proprio allora ad affrontare nel mantenimento del potere ad Atene e infine con
l’espulsione nel 51035.
VI.5. L’esclusione dei Pisistratidi dalle Cicladi
Nel 546 Pisistrato e Ligdami di Nasso si legarono in un’alleanza personale reciproca in
osservanza della quale il Nassio fornì risorse economiche e militari (chrèmata kai àndras) a
Pisistrato per assicurargli la presa della tirannide ad Atene e viceversa Pisistrato intraprese
presto (545ca.) una spedizione navale che rese Ligdami tiranno di Nasso36. L’alleanza, si è
argomentato, ebbe sia un carattere personale e reciproco fra i due uomini di potere, sia una
funzione politica e civica volta ad assicurare ad Atene un accesso facilitato nell’area delle
Cicladi. Nasso inoltre servì a Pisistrato come luogo sicuro ove esiliare in ostaggio membri delle
famiglie che più si erano opposte al suo rientro ad Atene. La cattura di Nasso si associa,
strategicamente e propagandisticamente, alla purificazione da parte di Pisistrato del santuario di
Apollo a Delo. Dopo questi fatti vengono a mancare notizie relative alla posizione della
tirannide pisistratide nelle Cicladi, a Nasso o a Delo; gli interessi di Atene e dei Pisistratidi
nelle Cicladi mi paiono nondimeno di importanza tale da richiedere un tentativo di
ricostruzione della storia di quell’area geografica, cioè della relativa posizione di Pisistrato per
il restante periodo di tirannide e successivamente della politica seguita da Ippia.
La talassocrazia di Policrate di Samo
È noto che poco più di un decennio dopo l’incursione marittima di Pisistrato a Nasso e a
Delo l’Egeo orientale e le Cicladi furono interessate dall’azione diplomatica e militare di
34
Hdt. V 65; Aristot. Ath. Pol. 19.6.
URE 1922, pp. 291s. suggerisce questa considerazione, ma associa causalmente la fine delle disponibilità di
risorse dal Pangeo alla data del 510 e dunque alla caduta della tirannide.
36
Hdt. I 61; Aristot. Ath. Pol. 15.2-3.
35
304
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
Policrate, tiranno di Samo. Le fonti preservano una narrazione piuttosto completa della storia
della tirannide di Policrate dalla sua ascesa fino alla morte37. Policrate e i suoi fratelli
conquistarono la tirannide di Samo anche in virtù dell’aiuto giunto loro da Ligdami, il tiranno
che Pisistrato aveva imposto a Nasso; presto poi Policrate estromise i fratelli dal potere e fu
l’unico e incontestato tiranno di Samo. Policrate resse la tirannide a Samo dal 533 al 522/21; in
tale periodo egli condusse una politica di intenso attivismo militare e navale che portò la
tradizione storiografica ad ascrivere al tiranno e alla sua polis una delle talassocrazie storiche38:
la fama e i successi di Policrate furono conosciuti e ammirati nella Ionia e in tutta la Grecia;
egli giunse ad allestire e comandare una flotta di 100 pentecontere e di 40 triremi e un esercito
di 1000 arcieri e di soldati mercenari con cui praticò una spietata pirateria nell’Egeo39;
conquistò numerose isole e città della costa micrasiatica, sconfisse in battaglia, catturò e
schiavizzò le forze alleate di Lesbo e Mileto e difese con successo Samo e il proprio potere
tirannico dall’assedio portato da Sparta in aiuto degli esuli politici40; intrattenne relazioni
diplomatiche con le potenze vicino-orientali, l'Egitto e la Persia, ed è possibile ricostruire come
egli sia stato un importante elemento strategico nelle vicende dell'espansione dell'impero
achemenide nell'Egeo orientale e della conquista dell'Egitto41. Nel quadro dell’imposizione
della talassocrazia samia nell’Egeo orientale a partire dal 530 ca. Policrate conquistò e dedicò al
santuario di Apollo Delio l’intera vicina isola di Rheneia, legandola con una catena all’isoletta
37
Anacr. Fr. 349, 353, 483, 491 Page; Hdt. III, 39-48, 54-56, 120-128, 139-149; Thuc. I 13, III 104; Diod. Sic. I
95, X 16; Plut. De Her. Mal. 21 (Mor. 859b-d); Polyaen.I 23.1-2; Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 185g Helm; Suda
s.v. Ταῦτά σοι καὶ Πύθια καὶ ∆ήλια T 175 Adler. Nel caso di Erodoto la critica identifica un lògos policrateo, il
nono dell’opera; inoltre la critica nota che, in considerazione della sua origine micrasiatica, è naturale che questo
storico possedesse una buona dimestichezza con la storia di Samo. IMMERWAHR 1957; IMMERWAHR 1966, pp.
104s.; BERVE 1967, pp. 107-116; DREWES 1969; BAKKER 2002, pp. 16-19; DE JONG 2002, pp. 250-258; DEWALD
2002, pp. 274-289 RAAFLAUB 2002, pp. 183s.; ASHERI 2007, ad Hdt. III 39-60, 120-128.
38
Quella di Policrate fu la prima talassocrazia storica secondo il criterio seguito da Erodoto (Hdt. III 122.2) e una
delle poche esplicitamente ricordate da Tucidide (Thuc. I 13.6) il quale include però anche personaggi della
mitologia; la talassocrazia attribuita a Policrate da Erodoto e Tucidide può identificarsi nella tredicesima della lista
di talassocrazie preservata dalla cronologia di Eusebio e attribuita ai Sami: malgrado la data non possa ricavarsi dal
testo, il suo inizio è certamente collocato nel periodo di poco successivo al 540 (Euseb. Chron. arm. p. 321
Aucher). WHITE 1954; BARRON 1964; FORREST 1969 b, pp. 95-98; HAAS 1985, pp. 37-39; HORNBLOWER 1997, ad
Thuc. I 13.
39
Hdt. III 39, 45. BERVE 1967, pp. 107-113; Sulle navi utilizzate da Policrate vd. COATES-MORRIS-RANKOV 2000,
pp. 40s.; SCOTT 2000, p. 108. Sulla Pirateria samia e di Policrate: TOD 1933, n. 7; HAAS 1985, pp. 37-41; SHIPLEY
1987, pp. 69-72, 94-96; GREAVES 2000, pp. 48s.; JACKSON 2000, pp. 141-149.
40
GREAVES 2000, pp. 48-52; JACKSON 2000, p. 142 sulla conflittualità fra Samo e Mileto.
41
Anacr. F 491 ed. Page; Hdt. II 178, 182, III 39-48, 54-56, 120-125, 139-149; Thuc. I 13.6, III 104.2; Diod. X,
16, 4. ANDREWES 1958, pp. 117-122; FORREST 1969 b, pp. 96-98; MOSSÉ 1969, pp. 15-19; HERMAN 1987, pp. 17,
46 n. 14, 60, 168; SHIPLEY 1987, pp. 94ss.; AUSTIN 1990, p. 292s., 298-304; DE LIBERO 1996, pp. 176-181;
HORNBLOWER 1997, p. 46; JACKSON 2000, p. 142; ASSMANN 2001, pp. 401-408; WIESEHÖFER 2003, pp. 24-32,
40-71; ANDERSON 2005, p. 184; RAVIOLA 2005, pp. 114s.; MAZZARINO 2007, pp. 150s., 233s.
305
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
sacra e in quell’occasione tentò, seppure senza successo, di reintrodurre la celebrazione
dell’antica panégyris degli Ioni42.
Il confronto fra la storia della politica egea di Pisistrato e la storia della tirannide e della
talassocrazia di Policrate di Samo mette in luce con chiarezza analogie nei metodi e una
sovrapposizione degli ambiti di interesse fra i due tiranni, specificamente nell’instaurazione di
un controllo militare, politico e culturale entro l’arcipelago cicladico. È mia intenzione
argomentare che queste analogie debbano interpretarsi come il segno di un processo storico e
strategico che vide la retrocessione dei Pisistratidi e di Atene dalla posizione guadagnata nelle
Cicladi e la sostituzione del loro controllo sull’arcipelago con quello di Policrate di Samo.
L’alleanza fra Ligdami e Policrate
La cronologia della presa del potere da parte di Policrate non è sicura ed oscilla nelle
ricostruzioni della critica entro il decennio degli anni ’30 del VI secolo; la data più probabile
sembra comunque essere quella del 533 trasmessa da Eusebio, ma non è da escludersi la
possibilità di risalire all’inizio del decennio, al 53743. Sull’inizio della tirannide perviene,
tramite Polieno, la notizia che la conquista dell’acropoli non consentì effettivamente a Policrate
e ai suoi fratelli la presa salda del potere, ma essi furono in grado di prendere la tirannide di
Samo quando giunsero i soldati (stratiòtai) inviati in loro aiuto da Ligdami di Nasso44. Al più
tardi dunque nel 533 Ligdami fornì il proprio aiuto a Policrate, nella forma dell’invio di un
contingente militare, con lo scopo di contribuire a renderlo tiranno di Samo. Il modello di
comportamento adottato da Ligdami in quell’occasione è in tutto simile a quello che egli aveva
seguito nel 546 nei confronti di Pisistrato: come con Pisistrato, Ligdami intervenne a favore di
Policrate in un momento per quest’ultimo cruciale, contribuendo al successo della pericolosa
iniziativa e dunque vincolando Policrate ad un debito di riconoscenza verso di sé; per iniziativa
di Ligdami si istituì così un’alleanza personale e reciproca fra i due tiranni. Nel caso di
Pisistrato è possibile riconoscere nella conquista di Nasso la dimostrazione e il compimento
della chàris, cioè la riconoscenza, con cui egli ricambiò la precedente azione favorevole,
euergesìa, ricevuta da Ligdami. Nel caso dell’alleanza fra Policrate e Ligdami non si dispone di
42
Thuc. I 13.6, III 104.2; Suda s.v. Pu/qia kai\ Dh/lia, P 3128 Adler; s.v. Ταῦτά σοι καὶ Πύθια καὶ ∆ήλια, T
175 Adler. SHAPIRO 1989, pp. 48s.
43
Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 185g Helm, data al 533 la presa della tirannide di Policrate e dei fratelli a Samo;
tuttavia alcuni critici fanno notare che l’opera cronografica potrebbe confondendere la data dell’acmé del tiranno
con quella della presa del potere; mi pare significativo inoltre che in un paragrafo a questo poco precedente del
Chronicon (Euseb. Chron. ap. Hieron. p. 182m Helm) anche la presa della tirannide di Pisistrato venga datata con
4 anni di ritardo, al 542 piuttosto che al 546. PETER 1882, p. 32; SANDYS 1912, ad Aristot. Ath. Pol. 15.3, p. 62;
WHITE 1954; BARRON 1964, soprattutto pp. 210-223; HIND 1974, pp. 15s.; DE LIBERO 1996, pp. 259s.; COBET
2011, s.v. “Polycrates”, in BNP.
44
Polyaen. I 23.2. SANDYS 1912, ad Aristot. Ath. Pol. 15.3, p. 62.
306
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
notizie relative a come Policrate abbia ricambiato la benemerenza di Ligdami; non dubito però
che gli anni successivi provarono la lungimiranza di Ligdami nel scegliere un alleato che
sarebbe divenuto, per un decennio, un motore cruciale della storia dell’Egeo orientale: Ligdami
si assicurò in primo luogo un alleato potente che dall’esterno sarebbe potuto intervenire in caso
di dissidi che mettessero a repentaglio il suo potere personale a Nasso, mentre a livello
diplomatico protesse l’autonomia e la posizione di Nasso nelle Cicladi e poté forse ampliare il
campo di intervento nassio verso le coste micrasiatiche45.
In mancanza di notizie in contrario, si deve certo ritenere che nel 533 fosse d’altronde
ancora valida e attiva l’alleanza che legava Pisistrato e Ligdami: il contatto stabilito da Ligdami
con Policrate non è cioè affatto da considerarsi come una testimonianza dell’interruzione della
sua più vecchia alleanza con il tiranno ateniese; al contrario era normale che tiranni e
aristocratici volessero ampliare in molteplici direzioni la propria rete di alleanze, legando a sé
individui e gruppi familiari provenienti da molteplici poleis e ambiti regionali, moltiplicando e
diversificando dunque i contesti di intervento di ciascuno. Seguendo all’estremo questa
constatazione, parte della critica ritiene che l’alleanza fra Ligdami e Policrate avrebbe potuto
costituire una sorta di ponte diplomatico perché entrassero in contatto reciproco i Pisistratidi e
Policrate, oppure che esistesse una sorta di alleanza tripartita che associava fra loro Ligdami,
Pisistrato e Policrate nella prospettiva di una forma di condominio sull’Ellade, una spartizione
fra loro della Grecia continentale, della Grecità d’Asia Minore e delle poleis insulari dell’Egeo.
Questa ricostruzione è però a mio avviso da rifiutarsi in primo luogo per l’assenza di
attestazioni o anche minime inferenze al riguardo e inoltre perché la sovrapposizione di
interessi e l’emulazione di comportamenti fra Pisistrato e Policrate nelle Cicladi, che si sta qui
analizzando, mi pare indirizzi piuttosto alla ricostruzione dell’esistenza di motivi di attrito ed
ostilità fra i due46.
La notizia dell’alleanza fra Ligdami e Policrate contribuisce dunque ad insinuare i primi
dubbi sulla tenuta del potere pisistratide nelle Cicladi nel periodo intorno al 533 e sulla capacità
effettiva del tiranno ateniese di agire come protettore della comunità culturale degli Ioni:
accogliendo questi dubbi assume infatti un senso e un movente il fatto che Ligdami abbia
reputato utile o necessario trovare allora e di propria iniziativa un alleato nuovo, forse più
affidabile, nell’emergente tirannide di Samo. D’altronde quando Ligdami si associò a Policrate,
45
BLAKESLEY 1854 vol. I, pp. 46s.; HIND 1974, pp. 15s.; FORREST 1982 a, pp. 258s.; HERMAN 1987, pp. 90s.;
CRAIK 1996, pp. 891s.; POSTLETHWAITE 1998, p. 183.
46
HOLM 1894, p. 108; LEAHY 1957, pp. 274s.; MILLER 1971, pp. 28s.
307
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
questi ancora non deteneva quel potere talassocratico per cui passò alla cronaca della
storiografia e che ne determinò il decisivo ruolo nei rapporti di potere internazionale.
Le narrazioni sia di Erodoto che di Tucidide stringono esplicitamente un nesso
cronologico fra il regno di Cambise in Persia e la talassocrazia di Policrate: indipendentemente
dalla data in cui si accetta abbia avuto inizio la tirannide a Samo, nel 533 oppure all’inizio di
quel decennio, è dunque solo a partire dal 530 in poi che si dovrà porre l’estensione del
controllo politico-militare di Policrate dalle coste dell’Asia Minore alle acque delle Cicladi e
viceversa dunque la retrocessione della libertà d’azione dei Pisistratidi in Egeo47.
La ricostruzione di una capacità militare più incisiva e di un dominio marittimo più stretto
a partire dal 530 è del tutto coerente con il ruolo che Policrate venne a ricoprire, appunto nel
medesimo periodo, nello scenario diplomatico-militare del Vicino Oriente, nei rapporti con
l’impero achemenide e con l’Egitto faraonico: la posizione significativa che Policrate fu in
grado di ricavare per sé e nei confronti di queste potenti realtà statali orientali si appoggiò
interamente sulla capacità militare e navale sua privata e di Samo. L’episodio che potrebbe
essere individuato come segno dell’acmé delle capacità di intervento internazionali della
tirannide samia risale al periodo di poco precedente alla conquista persiana dell’Egitto,
avvenuta nel 525, quando Policrate allacciò contatti diplomatici sia con il Gran Re Cambise che
con il faraone egizio Amasi e fu un elemento del bilanciamento di potere fra le due potenze
orientali precedentemente alla crisi del 525 che vide il crollo dell’Egitto48. La capacità militare
samia è ribadita poco dopo, nel 524, dalla vittoriosa difesa della tirannide contro l’assedio
congiunto del contingente spartano e della flotta corinzia.
In conclusione, già al momento dell’ascesa di Policrate, nel 533, la scelta di Ligdami
potrebbe forse interpretarsi come un primo, vago, segno di disinteresse per le prerogative
precedentemente accordate a Pisistrato e ad Atene. A partire dal 530 Policrate andò poi
assumendo un ruolo diplomatico e militare di rilievo internazionale e certamente divenne allora
un fattore di vantaggio diplomatico per Ligdami e viceversa di preoccupazione per Pisistrato e i
suoi figli, in considerazione dell’area di contingenza che Samo e Atene avevano nelle Cicladi.
Dagli anni intorno al 525 Policrate può considerarsi una delle potenze indiscusse dell’Egeo
orientale e delle Cicladi, perlomeno fra i Greci, un potere di fronte al quale i Pisistratidi non
potevano sperare di opporsi. Fino a quel periodo, e dunque fino agli ultimi anni di vita di
Pisistrato, è possibile d’altronde conservare per i tiranni e per la polis di Atene il quadro di una
presenza navale e diplomatica nelle Cicladi, se pure di segno gradualmente declinante.
47
48
OLMSTEAD 1982, pp. 60-66; AUSTIN 1990; ASSMANN 2001, pp. 401-408; WIESEHÖFER 2003, pp. 24-32, 40-71.
COOK 1937, pp. 232, 235s.; PARKE 1946; MILLER 1971, pp. 25-32; DOPICO CAINZOS 1997, pp. 532-536.
308
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
Policrate nuovo prostàtes di Delo
La strategia seguita da Policrate nell’espansione entro le Cicladi fu tripartita, fondata
senz’altro sull’appoggio dell’alleato Ligdami a Nasso, su una propaganda religiosa e culturale
presso Delo, ma principalmente sulla conquista armata: secondo il lessico usato dalle fonti
bisognerà ritenere infatti che l’intervento di Policrate presso le isole egee di Delo e Rheneia
abbia avuto carattere militare e l’esito di imporre una forma di sottomissione a quelle ed altre
città-stato (τῶν νήσων ὑπηκόους ἐποιήσατο καὶ Ῥήνειαν ἑλὼν ἀνέθηκε)49.
Conquista l’isola di Rheneia, vicinissima a Delo, Policrate fece di quell’intero territorio
una offerta dedicatoria al santuario di Apollo, legando le due isole con una catene sospesa sul
braccio di mare che le separava. Sempre in quelle circostanze Policrate istituì una celebrazione
religiosa agonale a Delo per onorare il culto di Apollo; sul nome da dare a quella festa, “Pýthia”
oppure “Délia”, il tiranno interrogò l’oracolo di Delfi, ma la Pizia espresse il disinteresse di
Apollo e la premonizione che presto Policrate sarebbe venuto a morire50. È chiaro che il
movente dell’intervento dedicatorio di Policrate a Delo fu del tutto affine all’operato di
Pisistrato nel 54551. Anche Pisistrato aveva condotto una spedizione navale militare nelle
Cicladi, alla conquista di Nasso; una volta sottomessa l’isola e affidata alle cure della tirannide
dell’alleato Ligdami, egli purificò l’isola di Delo rimuovendo le tombe visibili dal santuario di
Apollo. Per Pisistrato l’iniziativa religiosa a Delo aveva avuto uno scopo propagandisticoculturale a supporto della strategia di posizionamento dei Pisistratidi e di Atene nelle Cicladi52:
identici moventi ritengo si possano ascrivere alle scelte di Policrate, in considerazione degli
interessi strategici della sua tirannide e delle analogie della sua talassocrazia con la politica
cicladica precedentemente seguita da Pisistrato. Come Pisistrato in precedenza, anche Policrate
intendeva in questo modo dare al mondo greco prova della propria devozione verso Apollo e
guadagnare altresì il favore degli abitanti e del clero dell’isola sacra ponendosi come prostàtes
del santuario, del culto e degli Ioni; il destinatario privilegiato di queste dimostrazioni
propagandistiche, oltre ai Delii, erano dunque i Greci insulari e dell’Asia Minore fra i quali
Policrate affermava appunto il proprio primato e a cui proponeva simbolicamente la propria
guida, non solo militarmente con il potere navale, ma in questo modo anche ideologicamente al
cospetto della divinità apollinea ionica53.
49
Thuc. I 13.6.
Thuc. I 13.6, III 104.2; Suda, s.v. Πύθια καὶ ∆ήλια, P 3128 Adler, s.v. Ταῦτά σοι καὶ Πύθια καὶ ∆ήλια, T 175
Adler.
51
MILLER 1971, pp. 28s.; SHAPIRO 1989, pp. 48-60.
52
Hdt. I 64; Thuc. III 104.
53
Thuc. I 13.6, III 104.2; Suda, s.v. Ταῦτά σοι καὶ Πύθια καὶ ∆ήλια, T 175 Adler. JEBB 1880, p. 19; PARKE 1946;
CRAIK 1996, p. 900.
50
309
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
Stando alla risposta oracolare in merito al nome della festa agonale creata da Policrate, gli
eventi che videro la dedica di Rheneia e il tentativo re-istituire la festività pan-ionica
andrebbero collocati verso la fine della vita e dell’operato di Policrate. Dalla sincronia con la
transizione fra il regno di Cambise e quello di Dario I in Persia è noto che il tiranno morì nel
522: dunque una data plausibile per la conquista di Rheneia ricade nel periodo 525-52254. Entro
il decennio della talassocrazia samia, a partire dal 530, il primo periodo deve dunque essere
considerato come una fase di ascesa, affermazione diplomatica ed espansione, senza contare la
necessità per Policrate di gestire la propria posizione di fronte ai cambiamenti drammatici che
accompagnarono la conquista persiana dell’Egitto nel 525; l’intervento a Rheneia e a Delo nel
525-522 è da interpretarsi come il segno di un’imposizione definitiva forte e personale
dell’autorità e degli interessi di Policrate nel cuore dell’arcipelago cicladico55. Si può collocare
perciò entro questo periodo l’abbandono pressoché completo della politica cicladica da parte
dei Pisistratidi sotto il comando di Ippia e la loro sostituzione con l’autorità di Policrate.
La tirannide di Ippia: l’abbandono delle Cicladi
Raccogliendo le notizie trasmesse dalle fonti storiografiche, riconsiderando l’analisi
finora condotta sui moventi e sui metodi dell’operato di Policrate e infine tenendo presenti le
ricostruzioni cronologiche ricavate, mi pare si possa giungere alla conclusione che ci si trovi
davanti ad un processo storico graduale per cui, cominciando dagli ultimi anni della tirannide di
Pisistrato e successivamente nel passaggio alla tirannide di Ippia ad Atene, i Pisistratidi si
videro estromessi dall’area strategico-politica delle Cicladi.
Il fatto che sia stato lo stesso Ligdami ad interessarsi a fondare un’alleanza con il nascente
potere tirannico di Samo, fin dal 533, se non dal 537, può dare adito alla ricostruzione secondo
cui l’uscita dei Pisistratidi dall’areale strategico delle Cicladi non soltanto fu una conseguenza
dello sforzo espansivo della tirannide di Samo, che giunse infatti ad imporsi colà solo intorno al
54
É logico e necessario associare la dedica di Rheneia al santuario di Apollo con il tentativo di re-istituzione della
celebrazione delia: i due interventi fecero parte non solo della medesima strategia ma anche di una medesima
spedizione militare e diplomatica. D’altro canto le fonti sono esplicite nel collocare il tentativo di introdurre la
festività a Delo in un periodo prossimo alla morte di Policrate avvenuta nel 522. Nel periodo 525-524 Policrate fu
impegnato prima nelle trattative diplomatiche con il sovrano persiano Cambise e Amasi il faraone egizio e
successivamente nella difesa dalla spedizione spartana: su questi presupposti la maggior parte della critica desume
di poter collocare la spedizione di Policrate a Delo nel periodo 523-522. D’altronde Tucidide sembra stringere un
forte nesso cronologico fra il regno di Cambise, la talassocrazia samia e la dedica di Rheneia: ritengo che la
campagna per la conquista dell’Egitto, nel 525, potrebbe essere stata quell’evento del regno di Cambise che fu
preso come riferimento cronologico dai testimoni, delii o delfici, che preservarono la notizia raccolta
successivamente da Tucidide. In questa prospettiva ci sarebbero i presupposti sufficienti per collocare gli eventi
della tirannide di Policrate relativi a Delo nel 525 ca., in alternativa alla data del 523-522. Thuc. I 13, III 104;
Suda, s.v. Πύθια καὶ ∆ήλια, P 3128 Adler, s.v. Ταῦτάσοι καὶ Πύθια καὶ ∆ήλια, T 175 Adler. PARKE 1946;
LEAHY 1957, pp. 273; FORREST 1969 b, pp. 96-98; HORNBLOWER 1997, ad Thuc. I 13.
55
MILLER 1971, pp. 25-28.
310
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
525, ma piuttosto anche in parte il risultato di una disattenzione, o dell’abbandono volontario
delle iniziative, di Atene e della famiglia tirannica stessa: è possibile cioè che a distanza di
qualche anno dopo il primo intervento a Nasso e a Delo, nel periodo 545-537/533, Pisistrato
abbia voluto reindirizzare le proprie risorse finanziarie e strategiche verso altri obiettivi, in
particolare cioè verso l’area ellespontica e verso il consolidamento della rotta commerciale e
cerealicola del Ponto Eusino che appunto nell’ultimo quarto del VI secolo andava acquistando
vivacità e importanza56.
La descrizione delle fonti e l’analisi storica e geopolitica concordano nel presentare Samo
come dotata di eccezionali capacità e risorse militari, soprattutto navali, sotto il comando di
Policrate, a partire dal 530 in poi, al punto da costituire motivo di calcolo politico non solo per
le poleis elleniche dell’Asia Minore, ma finanche per gli imperi orientali di Persia ed Egitto: a
partire dal 530 Atene e i Pisistratidi non furono perciò in condizione di avversare, né
politicamente né tantomeno militarmente, l’espansione dell’influenza di Policrate sulle isole
greche57. Non pervengono notizie di scontri fra le tirannidi o le poleis di Atene e Samo: perciò
la conclusione necessaria è che i Pisistratidi abbiano rinunciato pacificamente, se non
volontariamente, ai propri interessi dalle Cicladi.
La cronologia che si è giunti a stilare per l’espansione della talassocrazia di Policrate nelle
Cicladi non è lontana dal coincidere con l’epoca del passaggio dalla tirannide di Pisistrato a
quella di Ippia: nella seconda generazione della tirannide ateniese si deve dunque individuare il
momento di svolta nella politica marittima dei Pisistratidi e di Atene e il momento di rottura
degli equilibri a favore di Policrate.
Nel 528/7, alla morte di Pisistrato, Ippia ereditò la tirannide e la posizione di
capofamiglia: insieme a queste, al nuovo tiranno sarebbero dovuti passare anche l’alleanza
personale che aveva legato la sua famiglia a Ligdami di Nasso nonché il rapporto privilegiato
che Pisistrato aveva costruito nel 545 con il santuario di Delo58. Di queste due direttrici
diplomatiche e strategiche non si può però inferire traccia alcuna nella ricostruzione della storia
della tirannide di Ippia. Per entrambi i contatti, con Nasso e con Delo cioè, non poté trattarsi
che di una eredità poco più che formale e nominale, senza alcuna validità e praticità e senza
alcuna conseguenza: ritengo perciò che entrambe le relazioni si fossero da tempo raffreddate,
ancora quando Pisistrato era in vita, e con il passaggio di potere alla generazione tirannica
successiva nessuna delle due fu rinnovata. Deve essere stata intenzione di entrambe le parti, sia
56
URE 1922, p. 63; NOONAN 1973; ANDREWES 1982 b, pp. 404s.
Hdt. II 182, III 39s., 44. HERMAN 1987, p. 60; AUSTIN 1990, pp. 292s.
58
SUTHERLAND 1943, p. 142.
57
311
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
di Ippia che di Ligdami, lasciare decadere la validità della relazione di reciprocità che aveva
legato il Nassio ai Pisistratidi poiché per nessuna delle due parti quella relazione presentava
ormai alcuna utilità nel 527: Ligdami governava ormai sotto l’egida della temibile talassocrazia
di Policrate il quale appunto pochi anni dopo avrebbe dato prova della propria capacità militare
fra l’altro conquistando varie isole cicladiche e Rheneia; Ippia, dal canto suo, doveva essere a
conoscenza della fedeltà con cui l’antico alleato si era legato a Policrate e doveva mancare
dunque di alcun motivo per confidare nell’appoggio dell’autorità di Nasso per favorire la sua
famiglia o suoi concittadini nell’arcipelago e presso Delo, di fronte e a scapito degli interessi
samii.
La relazione che Pisistrato aveva potuto vantare con l’Apollo di Delo risaliva al 545 e
dopo più di 15 anni, nel 527, al momento della presa del potere da parte di Ippia, sarebbe stato
necessario che il nuovo tiranno riaffermasse la devozione dei Pisistratidi verso il santuario degli
Ioni; eppure mancano notizie in tal senso. Dopo pochi anni fu invece Policrate ad affermare,
con l’autorità del conquistatore di Rheneia, la protezione del suo potere sul santuario degli Ioni.
Anche se Ippia avesse voluto riconfermare la protezione pisistratide sul santuario di Delo,
ritengo che già nel 527 Policrate sarebbe intervenuto ad impedire tale interferenza, o perlomeno
senz’altro a superare in grandiosità qualunque offerta avessero fatto i Pisistratidi.
La spedizione spartana nelle Cicladi e a Samo e l’astensione di Ippia (525-524)
Il quadro che si sta qui costruendo, che vede cioè l’abbandono, in parte volontario e in
parte forzato, dell’interventismo pisistratide nelle Cicladi a partire dalla tirannide di Ippia,
concorda con quanto è possibile constatare in merito agli eventi della spedizione mossa da
Sparta e Corinto contro Samo e Nasso nel 525-524. Secondo la narrazione di Erodoto, quando
Cambise attaccò l’Egitto, nel 525, Policrate contribuì alle forze persiane con una flotta di 40
triremi; gli equipaggi di quelle navi furono tuttavia composti di oppositori politici del tiranno:
perciò le navi disertarono, fecero rotta verso Sparta e ne ottennero l’aiuto per rientrare a Samo,
con l’obiettivo di abbattere la tirannide di Policrate e prendere il potere59. La critica concorda
nella ricostruzione secondo cui Sparta poté contare sull’alleanza di Corinto, in qualità di uno
dei primi membri della Lega del Peloponneso, per disporre di una flotta capace60.
Nella rotta attraverso le Cicladi la spedizione spartano-corinzia fece tappa a Nasso; in
prima istanza gli Spartani tentarono di intavolare delle trattative con Ligdami e ottenerne
l’appoggio; non ricevendo risposte convincenti da parte di Ligdami, gli Spartani abbatterono il
59
Hdt. III 39.1, 44-48.1, 122.2. WILL 1955, pp. 374s.; BARRON 1964, pp. 212-217; SALMON 1996, pp. 856-863;
JACKSON 2000, pp. 143s.
60
DICKINS 1912, pp. 28s.; CAWKWELL 1993; SALMON 1996, pp. 856-862; SALMON 1997, pp. 240-251.
312
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
potere del tiranno e consegnarono il governo dell’isola ad un gruppo di oligarchi61. Il tentativo
di portare dalla propria parte Ligdami e la decisione poi di eliminarlo furono iniziative
necessarie nella spedizione contro Samo poiché appunto Ligdami era alleato di Policrate e
avrebbe potuto intervenire in suo aiuto, tanto più che proseguendo verso il litorale micrasiatico
la flotta corinzia si sarebbe altrimenti ritrovata ad avere un potenziale nemico alle spalle, pronto
a tagliare loro la via del ritorno62. Giunti a destinazione gli Spartani assediarono Samo, ma
senza ottenere successi; non intenzionati, come nella consuetudine laconica, a impegnarsi per
tempi lunghi in una spedizione oltremare, essi abbandonarono l’impresa e insieme agli esuli
anti-tirannici di Samo fecero ritorno in Peloponneso63.
Le fonti non conoscono alcun intervento o reazione di Ippia di fronte a questi eventi
drammatici, né la critica ha ricostruito per Ippia alcun segno di interessamento per gli esiti dei
cambiamenti che stavano avendo luogo nell’Egeo orientale. Ippia non sembra sia intervenuto al
momento delle trattative diplomatiche intercorse fra Ligdami e gli Spartani; anche quando poi il
corpo di spedizione lacedemone attaccò e conquistò Nasso ed espulse Ligdami, favorendo un
cambio di governo, non si dispone di alcuna notizia in merito ad un intervento di Ippia o di
Atene, né in favore di Nasso o Ligdami, né contro Sparta64. Questi dati costituiscono a mio
avviso una riprova del fatto che nel 525-524 non vigeva ormai più alcun vincolo di reciprocità
fra i tiranni di Atene e di Nasso: perciò Ippia non fu tenuto a soccorrere Ligdami a Nasso né a
contrastare Sparta nella Grecia continentale e nemmeno ricevette richieste in tal senso.
Altresì è significativa l’assenza di notizie e di dati storici in genere in merito ad una
reazione di Ippia e di Atene di fronte alle modificazioni politiche che l’attacco spartanocorinzio implicava. I rapporti della seconda generazione dei Pisistratidi con Sparta e con
Corinto non furono in genere di segno positivo, sono di ricostruzione complessa per il primo
periodo di tirannide ed è notorio che si incrinarono a partire dal 511. Ciononostante, nel 525524, Ippia avrebbe certo potuto tentare di sfruttare la spedizione cicladica di Sparta a proprio
favore: per avvantaggiarsi della perdita di posizioni della talassocrazia di Policrate, per
riassestare gli interessi ateniesi nei confronti del nuovo governo oligarchico di Nasso, per
riguadagnare spazio all’azione dei Pisistratidi e degli Ateniesi nelle Cicladi. Eppure mancano
attestazioni di sorta in quel senso: si riconferma a mio avviso la ricostruzione proposta secondo
61
Schol. Aesch. II.77; Aristot. Pol. 1312a; Plut. Apophtegm. Lac. (Mor. 236c.7-12); Id. De Mal. Her. 21 (Mor.
859d). WILL 1955, pp. 374s.
62
LEAHY 1957.
63
Hdt. III 54-57.1. PARKE 1946.
64
PARKE 1946 propone la ricostruzione secondo cui nel 524 Ippia stesse vivendo un momento di debolezza
politica interna ad Atene e adduce a conferma l’arcontato dell’Alcmeonide Clistene nell’anno 525/524.
313
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
cui l’abbandono dell’areale cicladico sarebbe stato in parte anche una scelta consapevole nella
gestione della politica estera pisistratide e ateniese.
Policrate resistette con successo all’assedio del contingente spartano, la sua flotta, si potrà
desumere, fu in grado di tenere testa a quella corinzia ed eliminò un pericoloso e attivo gruppo
di oppositori politici dall’isola65. Le vicende del 525-524 segnarono un pieno successo e
dovettero dunque accompagnarsi ad un ulteriore impulso al potere di Policrate, sia sul piano del
consenso interno, sia su quello del controllo marittimo delle acque dell’Egeo orientale e delle
Cicladi, nonostante la perdita dell’alleato Ligdami nella relazione verso Nasso.
Il rientro degli esuli da Nasso
Una delle conseguenze per Ippia della perdita dell’alleanza con Ligdami fu certamente la
liberazione degli ostaggi ateniesi confinati a Nasso, figli di oppositori anti-pisistratidi
particolarmente accaniti che Pisistrato aveva mandato a Nasso dopo la vittoria alla battaglia di
Pallene nel 54666. La condizione e la capacità di azione di questo gruppo di oppositori politici
dovettero a mio avviso seguire la parabola delle relazioni interpersonali fra Ligdami e i
Pisistratidi che si è andata finora ricostruendo. Gli ostaggi, le loro famiglie e il loro seguito,
riguadagnarono certamente piena libertà con l’espulsione di Ligdami dal potere tirannico e
l’imposizione del nuovo governo oligarchico, ad opera di Sparta, nel 525-52467. Si è d’altronde
ricostruito il processo storico di un allentamento della relazione già fra Pisistrato e Ligdami, a
partire dal 533, e poi di un tacito annullamento degli obblighi di reciprocità fra Ippia e il tiranno
nassio nel 528/7: se questa ricostruzione è valida, già durante gli ultimi anni di vita di Pisistrato
e nel periodo dell’ascesa al potere di Ippia gli ostaggi ateniesi dovettero godere di una più
ampia libertà d’azione, se non della possibilità di lasciare Nasso e ritornare in Attica o ad
Atene, dipendendo dalle condizioni politiche delle famiglie rimaste in patria. Nel momento in
cui ereditò il potere della tirannide Ippia dovette dunque gestire una situazione politica e sociale
più difficile e di nuovo sviluppo, fra gli altri motivi, appunto a causa del probabile rientro di
questi gruppi di aristocratici ateniesi cresciuti a Nasso e desiderosi di riguadagnare le posizioni
perdute in patria. Questa nuova presenza di Ateniesi aristocratici costituisce, a mio avviso, uno
dei moventi per quell’atteggiamento conciliatorio, nei confronti delle famiglie ateniesi
politicamente decisive, che la critica ha ricostruito per il primo periodo di tirannide di Ippia ad
Atene: la tradizione epigrafica sulla sequenza degli arconti ateniesi nel primo periodo di
tirannide di Ippia, dal 526 al 521, attesta infatti l’assegnazione della massima carica politica
65
Hdt. III 44s, 47s., 54-56. LEAHY 1957.
Hdt. I 64.
67
PARKE 1946; LAVELLE 2005, pp. 136-139.
66
314
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
ateniese sia ai principali membri della famiglia tirannica, ma anche a membri dei Filaidi e degli
Alcmeonidi, nonché di famiglie di minore peso storico68.
Mi pare significativo soffermare l’attenzione sulla ricostruzione dei movimenti degli
ostaggi ateniesi a Nasso, sulla loro relazione con le vicende dei poteri ellenici nell’Egeo e con
la storia politica di Atene sotto Ippia: questo specifico caso riafferma emblematicamente infatti
il legame fra il contesto internazionale, financo Mediterraneo, e quello locale e poleico, fra la
politica estera dei tiranni e la gestione della vita civica entro la polis.
Diffusione della ceramica attica a figure rosse e della ceramica samia
I dati archeologici, pur non in maniera vincolante, potrebbero interpretarsi come una
conferma del quadro finora delineato. La produzione e diffusione della ceramica attica a figure
rosse ebbe inizio nel 530-525; per quel che concerne la diffusione di questo materiale, gli scavi
ne attestano la presenza a Samo, Delo e Rodi in virtù della cruciale posizione commerciale di
queste località, ma significativamente risultano assenti da gran parte delle poleis d’Asia Minore,
dalle Cicladi e dal Dodecaneso, oltre che da Creta. Al contrario molti reperti provengono
dall’area del Ponto Eusino e da Taso. Viceversa la ceramica samia non ebbe diffusione nel
Ponto Eusino69. I due areali commerciali esclusivi individuati dai reperti ceramici sembrano
combaciare dunque con le aree di influenza rispettivamente di Policrate e di Ippia.
Si premette che le cause di fenomeni artistici, culturali ed economici come quelli attestati
dai reperti ceramici sono da ricercarsi in ambiti disciplinari propri, nelle sfere dell’economia e
delle tendenze artistiche locali e generali, e dunque su questi fenomeni il potere tirannico non
poté influire che in misura minima e non decisiva. Per altro verso vorrei accettare queste
informazioni entro la discussione che si sta sviluppando sul fondamento metodologico che vede
le iniziative della tirannide, sia private che politiche, legarsi in buona misura all’appoggio del
dèmos e in genere dei propri concittadini: cioè gli interventi del tiranno rientravano, e per altro
verso dirigevano, le direttrici dell’opinione pubblica e della volontà politica dei cittadini da cui
egli riceveva l’approvazione e viceversa su cui manteneva il comando personale. In questa
prospettiva è costruttivo confrontare le informazioni archeologiche sulla diffusione della
ceramica coeva, e dunque sulle direttrici economiche delle poleis, con la ricostruzione della
politica internazionale di Ippia e di Policrate.
68
MERITT 1939, pp. 59-65; CADOUX 1948, pp. 109-112, 122; ANDREWES 1958, pp. 108-110; MOSSÉ 1969, pp. 6870; BICKNELL 1970; MEIGGS-LEWIS 1989, n. 6.
69
COOK-DUPONT 1998, p. 169; CHARBONNEAUX-MARTIN-VILLARD 2005, pp. 303-339; PALEOTHODOROS 2008,
pp. 168, 175 nn. 51, 61, 181s.
315
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
I dati archeologici qui presentati collimano dunque con la ricostruzione di Samo e Atene,
e rispettivamente di Policrate e Ippia, come poteri reciprocamente avversi, con interessi ed aree
di influenza reciprocamente esclusive. Nella prospettiva economica che i ritrovamenti ceramici
permettono di intravedere, Ippia avrebbe abbandonato l’areale delle isole micrasiatiche e
cicladiche a favore dell’espansione verso la rotta del Ponto Eusino, mentre, sotto la protezione
delle capacità militari di Policrate, i commercianti samii avrebbero goduto di una posizione
privilegiata nella diffusione delle proprie produzioni ad eccezione appunto che in quell’area.
In conclusione tutta questa serie di notizie e inferenze analitiche restituisce il quadro
storico di un passaggio graduale dell’influenza politica, culturale ed economica sulle Cicladi
dalla tirannide dei Pisistratidi a quella di Policrate e dunque da Atene a Samo. Si tratta di un
processo a mio avviso contemporaneo all’emergere entro lo scenario strategico-economico
ellenico dell’areale dell’Ellesponto e delle rotte verso il Ponto Eusino e parallelamente, e
conseguentemente, delle scelte dinamiche di politica estera intraprese da Pisistrato nel corso
della sua tirannide. Il disinteresse dei Pisistratidi per le Cicladi può riconoscersi già nello
spostamento delle alleanze di Ligdami, nel 533, verso Policrate, Samo e dunque la Ionia. Nel
528, con il passaggio di potere da Pisistrato a Ippia si rende evidente e riconoscibile
l’abbandono, da parte dei tiranni ateniesi, della politica marittima cicladica e la scelta di politica
estera di Ippia è riconfermata nel corso della sua tirannide e nella reazione agli eventi nell’Egeo
nel 525-524. Contemporaneamente si affacciò sull’Egeo orientale il potere marittimo di Samo
sotto il comando tirannico di Policrate che nel periodo 533-524 andò ampliando la propria area
di influenza militare, diplomatica e culturale fino al cuore delle Cicladi, scalzando il ruolo
diplomatico e religioso anzitempo ricoperto dalla figura di Pisistrato. La sanzione definitiva di
questo trasferimento di poteri giunse nel 525-522 con la dedica di Rheneia al santuario
apollineo da parte di Policrate e, ancor più, con l’ambizione del tiranno di riattivare l’antica
panégyris ionica.
VI.6. L’invio di Milziade II in Chersoneso Tracico (520 ca.)
Questa ricerca permette di ricostruire il significativo ruolo di Ippia nella gestione delle
attività internazionali della famiglia dei Filaidi in Chersoneso Tracico e insieme degli interessi
strategici ed economici di Atene nell’area dell’Ellesponto.
I Filaidi tennero la tirannide in Chersoneso Tracico dal 558 ca. fino al 493, attraverso due
generazioni e tre membri della famiglia. La fondazione della colonia ateniese e della tirannide
familiare fu opera di Milziade I e si è d’altronde messa in luce una stretta cooperazione politica
316
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
fra l’ecista filaide e il tiranno ateniese Pisistrato negli aspetti politici e organizzativi
dell’iniziativa. Milziade I morì senza figli e il potere tirannico passò per via ereditaria al nipote
Stesagora il quale ebbe però un governo molto breve prima di essere assassinato, secondo le
fonti, da un attentatore proveniente dalla polis di Lampsaco con cui l’insediamento ateniese fu a
lungo in guerra. Stesagora dunque morì nel 520 ca. senza successori e questo provocò un crisi
dinastica e un vuoto di potere nel Chersoneso Tracico: le fonti sono esplicite nel tramandare che
fu allora il tiranno ateniese Ippia a reagire alla notizia e a prendere la decisione di inviare
Milziade II, fratello di Stesagora, in Chersoneso Tracico, affidandogli una trireme, perché
assumesse là il controllo degli affari70.
Il testo erodoteo implica che fu cioè il tiranno Ippia ad accogliere la notizia della morte di
Stesagora71; Ippia scelse di intervenire e si appellò a Milziade II, che viveva allora ad Atene,
perché si facesse carico degli affari nei possedimenti del Cherosneso Tracico; Ippia fornì a
Milziade II una trireme per compiere velocemente il viaggio e perché disponesse poi di uno
strumento bellico all’avanguardia nelle acque dell’Ellesponto. Emerge dunque il peso del potere
decisionale e la volontà di Ippia nella gestione degli interessi filaidi in Chersoneso Tracico in
funzione delle implicazioni che esse avevano per la posizione di Atene sul piano
internazionale72. In considerazione d’altronde delle prerogative familiari ed ereditarie che
Milziade II stesso poteva vantare, l’iniziativa è da intendersi come uno sforzo organizzativo,
politico, militare ed economico concordato e condiviso fra Ippia e Milziade II.
Gli eventi relativi alla tirannide di Milziade II, nonché l’intera storia della tirannide filaide
in Chersoneso Tracico, ricevono trattazione ed analisi esaustive entro la storia della politica
internazionale della famiglia dei Filaidi, anche nelle implicazioni che riguardarono la tirannide
e la posizione internazionale dei Pisistratidi e di Ippia: piuttosto che presentare argomentazioni
ridondanti in questa parte del lavoro, si preferisce ora ricordare in maniera sintetica alcuni degli
aspetti per cui questa notizia costituisce un elemento funzionale per la ricostruzione diacronica
della storia della politica internazionale della tirannide di Ippia; alla sezione relativa alla
tirannide dei Filaidi si rimanda per una critica delle fonti e una contestualizzazione esaustiva.
L’intesa interfamiliare fra Pisistratidi e Filaidi nella generazione di Ippia e Milziade II
La notizia della successione tirannica di Milziade II a Stesagora nel 520 ca. costituisce
innanzitutto una traccia del persistere nella generazione di Ippia e di Milziade II di quella intesa
interfamiliare che si è ricostruito esistere fra i Pisistratidi e i Filaidi nel corso di buona parte
70
Hdt. VI 33-40. BERVE 1967, pp. 66s., 81-85.
Hdt. VI 39.
72
URE 1922, p. 63; HOW-WELLS 1928, App. XVI.8; WADE-GERY 1951, pp. 117-221.
71
317
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
della seconda metà del VI secolo. In questo passo Erodoto afferma esplicitamente che esisteva
una relazione amichevole e costruttiva fra Ippia e Milziade II già nel periodo precedente alla
partenza per il Chersoneso Tracico73; storiografia ed epigrafia confermano che Milziade II
ricoprì la carica di arconte eponimo nel 524/374.
Alcuni studiosi ritengono anzi che la prima moglie ateniese di Milziade II fosse in effetti
una figlia di Ippia, sebbene i presupposti per questa identificazione non siano inequivocabili. È
noto certamente che Milziade sposò una donna ateniese prima di lasciare la madrepatria nel 520
ca.: da quel matrimoni nacque il figlio Metioco che seguì il padre in Tracia. Nel 493, nella
repressione della rivolta ionica, i Filaidi fuggirono dal Chersoneso Tracico; allora la flotta
fenicia catturò una delle triremi del convoglio comandata da Metioco: consegnato al sovrano
Dario il giovane Filaide fu nondimeno trattato con grandi onori, fu naturalizzato persiano,
ricevette una moglie persiana e un possedimento in Asia Minore. Il comportamento favorevole
di Dario verso Metioco potrebbe spiegarsi in ragione dell’intercessione di un proprio cliente
ellenico e a quell’epoca Ippia aveva lasciato da tempo Atene ed era in effetti entrato nei favori
del sovrano achemenide. Eppure Ippia e Milziade II nel 493 avevano ormai compromesso in
maniera critica l’alleanza familiare che li aveva precedentemente legati. In conseguenza di
queste considerazioni gli studiosi ritengono che Ippia si sia prodigato presso Dario a favore di
Metioco in ragione di un legame di parentela per cui il Filaide sarebbe stato appunto suo nipote,
figlio della giovane che egli avrebbe concesso in sposa a Milziade II intorno al 525 ca. ad
Atene75.
La tradizione familiare di reciprocità fra Pisistratidi e Filaidi e la specifica intesa
individuata fra Ippia e Milziade II insieme rendono conto coerentemente della gestione
congiunta fra il tiranno e il Filaide della spedizione in Tracia del 520 ca. Il modo in cui Ippia e
Milziade cooperarono nella gestione degli affari in Chersoneso Tracico nel 520 ca. ricalca da
vicino quanto avvenne nella precedente generazione fra Pisistrato e Milziade I nel 558 ca.: in
entrambi i casi l’iniziativa fu approvata, concordata e organizzata ad Atene congiuntamente fra
i due e sotto il governo tirannico pisistratide, poi l’esecuzione effettiva dell’impresa in Tracia
vene assegnata ai Filaidi76.
Queste considerazioni permettono di affermare con sicurezza che nel 527, alla morte di
Pisistrato, Ippia ereditò, fra le altre relazioni personali del padre, anche quella con la famiglia
73
Hdt. VI 39.
Dion. Hal. Ant. Rom. VII, 3.1. IG I3 103 Ia. MERITT 1939, n. 21, pp. 59-65; CADOUX 1948, pp. 109-112, 122;
WADE-GERY 1951, p. 212-214, 217-220; FORNARA 1983, n. 23, pp. 27s.
75
WADE-GERY 1951, p. 219; DAVIES 1971, n. 8429 [VIII], [IX]; NENCI 1988, ad Hdt. VI 39.
76
CULASSO GASTALDI 1996, pp. 507s.
74
318
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
dei Filaidi e che anzi fu personalmente interessato a costruire e rinsaldare quell’alleanza
familiare perpetuandola nella propria generazione nei confronti di Milziade II77. Un primo e più
immediato scopo di questa intesa interfamiliare, per Ippia quanto per Milziade II, apparteneva
all’ambito della politica interna ateniese: i due poterono cioè disporre di un alleato nell’ambito
della lotta politica interaristocratica e si assicurarono appoggio e protezione vicendevole per le
reciproche posizioni politiche e la possibilità di concertare pacificamente e a proprio vantaggio
la divisione del potere entro la polis.
Il controllo del Chersoneso Tracico: interessi familiari e interessi pubblici
L’intesa fra Pisistratidi e Filaidi aveva però anche una duplice funzione nell’ambito
internazionale. Dal punto di vista delle relazioni internazionali a livello personale, entrambe le
famiglie avevano ampie reti di contatti internazionali: perciò l’intesa fra loro assicurava un
grado di compartecipazione e condivisione di quegli ambiti reciprocamente vantaggiosi, nonché
dunque la possibilità di collaborare con l’alleato anche sull’areale strategico ellenico ed egeo.
Dal punto di vista della gestione della politica estera civica i due aristocratici condividevano
affini impostazioni e potevano entrambi mettere a disposizione, in maniera organizzata e
organica, le capacità familiari al fine comune del vantaggio pubblico.
I Filaidi controllavano il Chersoneso Tracico fin dal 558 ca: si trattò di una fondazione
coloniale di Milziade I che da subito assicurò però ai Filaidi una posizione di predominio
politico indiscusso, cioè una tirannide; il comportamento di Milziade II rinsaldò ulteriormente il
potere tirannico. D’altro canto, dal 540 ca. i Pisistratidi avevano rifondato la colonia ateniese di
Sigeo in Troade e la gestivano come un possedimento familiare sicuro: prova ne è il fatto che
alla fuga da Atene nel 510 Ippia scelse di ritirarsi appunto a Sigeo. Sia lo stanziamento filaide
in Chersoneso che quello pisistratide in Troade incontrarono la resistenza di poleis locali che
rivendicarono il possesso di quei territori o con cui si verificarono lunghi conflitti militari
frontalieri: Lampsaco si oppose alla fondazione chersonesita, Mitilene di Lesbo fu in guerra
contro Sigeo78. Posta l’alleanza interfamiliare che già vigeva ad Atene fra Filaidi e Pisistratidi
da prima del 560, è dunque una logica considerazione ritenere che le due famiglie furono
interessate a contribuire vicendevolmente a rinsaldare le reciproche posizioni anche nell’Egeo
nordorientale fornendosi forme di aiuto di volta in volta necessarie.
Le due regioni del Chersoneso Tracico e della Troade erano entrambe di grande
importanza geo-strategica e offrivano essenziali approdi, per la navigazione attraverso
77
SUTHERLAND 1943, p. 142.
WADE-GERY 1951, pp. 212, 215s., 218s.; HAAS 1985, p. 43; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 28-31, 61-64, 225-240
per un inquadramento dei conflitti di frontiera nel mondo greco.
78
319
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
l’Ellesponto, verso il Ponto Eusino, soprattutto in considerazione delle difficili condizioni del
mare e dei venti. La posizione tirannica di Ippia ad Atene e la conduzione della comunità
coloniale di Sigeo sotto Egesistrato mettono chiaramente i Pisistratidi, specificamente Ippia, in
una posizione di comando della compagine civica. Lo stesso vale d’altronde per i Filaidi in
Chersoneso Tracico a cui faceva capo la comunità ateniese là insediata: Milziade I ebbe
l’ufficio poleico di ecista e i successori Stesagora e Milziade II comandarono come tiranni. Ad
Ippia e Milziade II era dunque affidata non solo la conduzione delle rispettive famiglie, ma
anche la responsabilità del benessere della comunità, delle colonie e per estensione di Atene
stessa.
L’analisi che si propone qui dei moventi e della strategia di Ippia è coerente con le
modificazioni di più ampia portata nell’Egeo. Si è infatti fornita un’analisi diacronica di un
processo di arretramento della posizione dei Pisistratidi nelle Cicladi e viceversa di un
avanzamento in quell’area della talassocrazia samia sotto la tirannide di Policrate; nel passaggio
alla tirannide di Ippia, specificamente negli anni intorno al 525, si è individuato in effetti il
momento di rottura degli equilibri di potere fra i due poli tirannici e la fase critica in cui
l’influenza di Policrate non poté ulteriormente essere contrastata dalle risorse di Atene e di
Ippia. La scelta obbligata di ritirare i propri sforzi e le proprie risorse dalle operazioni nelle
Cicladi dovette dunque imporre ed offrire la possibilità a Ippia di reindirizzare e concentrare la
propria politica marittima esclusivamente in direzione dell’Ellesponto, combinando così
efficacemente la reazione alla politica talassocratica di Policrate di Samo nelle Cicladi
all’emergere del ruolo dell’areale pontico negli interessi economici di Atene e della Grecia.
VI.7. Ippia nelle relazioni internazionali con la Beozia e i Tessali
Nel corso dell’ultimo quarto del VI secolo Tebe perseguì una politica regionale volta a
riunire le poleis della Beozia in una lega militare sotto la propria egemonia79. Nel 520 ca. la
polis di Platea, sul confine meridionale della Beozia, affacciata sull’Attica, subiva perciò le
pressioni di Tebe e si vide imposta contro la propria volontà e autonomia la partecipazione alla
Lega Beotica. Platea si rivolse allora a Sparta poiché proprio allora si trovava nella zona un
contingente spartano condotto dal re Cleomene; questi rifiutò però di proteggere Platea
dall’ingerenza tebana giustificando la scelta in virtù della lontananza di Sparta dalla Beozia. I
Plateesi si rivolsero allora in seconda istanza ad Atene: la delegazione plateese giunse ad Atene
79
Hdt. VI 108; Thuc. III 55, 61.2, 68.5. GARDNER 1918, pp. 55-57; SORDI 1958, pp. 54-84; MORETTI 1962, pp. 97110; GRAHAM 1964, pp. 126s.; BUCK 1979, pp. 107-17; FORREST 1982 b, pp. 292ss.; BUCK 1996, pp. 878-883
320
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
durante i sacrifici che si compivano presso l’altare dei dodici Dei nell’agorà; i Plateesi si
sedettero presso quell’altare in qualità di supplici e consegnarono la propria città nelle mani
degli Ateniesi. Fra Atene e Platea fu perciò istituita una stretta, vincolante e duratura alleanza.
Quando i Tebani vennero a conoscenza dell’iniziativa di Platea e degli Ateniesi, subito mossero
in armi contro Platea; viceversa l’esercito ateniese si recò a Platea in difesa del suo recente
alleato. La battaglia fu inizialmente evitata per intercessione dei Corinzi: Tebani e Ateniesi
accettarono di affidare la soluzione pacifica del contenzioso all’arbitrato di una corte di giudici
di Corinto. Gli arbitri corinzi pacificarono le parti, decisero in merito alla ridefinizione del
confine dei territori di Tebe e Platea e imposero ai Tebani di lasciare libertà decisionale alle
poleis minori in merito alla partecipazione alla nascente Lega Beotica. In prima istanza dunque
Platea ottenne la definizione giuridica del proprio territorio e l’avallo della propria autonomia80.
Tebe fu scontenta della soluzione arbitrale: perciò attese che i Corinzi e l’esercito ateniese
avessero lasciato il campo e stessero ritirandosi, poi mosse all’attacco. Gli Ateniesi furono però
in grado di riguadagnare una posizione di combattimento e sconfissero i Tebani; approfittarono
poi del vantaggio acquisito e incalzarono i Tebani fin oltre i confini che erano stati in
precedenza definiti dall’arbitrato dei giudici corinzi, limitando il confine del territorio tebano
dalla parte di Platea e Isie alla linea del fiume Asopo81.
La vicenda è riferita da Erodoto e da Tucidide; i due storiografi concordano in effetti da
vicino e la critica ritiene che Tucidide dipenda in certa misura dallo stesso Erodoto82. Per altro
verso le due fonti forniscono informazioni diverse, hanno impostazioni narrative e
storiografiche indipendenti, e offrono scelte lessicali e criteri di selezione storiografica diversi.
Insieme permettono di ricostruire con precisione la narrazione, la contestualizzazione storica,
l’eziologia e la datazione della vicenda. Erodoto inserisce questa notizia come un excursus nella
narrazione della battaglia di Maratona, al fine di fornire l’eziologia del soccorso che i Plateesi
prontamente prestarono agli Ateniesi contro l’attacco persiano. Il riferimento che Erodoto
forniva al suo pubblico era però quello della posizione filo-ateniese che contraddistinse sempre
la storia delle relazioni interstatali di Platea e che i contemporanei di Erodoto conoscevano in
relazione agli eventi della Guerra del Peloponneso83.
Sia Erodoto che Tucidide ricordano che il motivo addotto dagli Spartani per rifiutare il
proprio aiuto a Platea fu la lontananza fra le due poleis e, viceversa, il suggerimento offerto di
80
PICCIRILLI 1973, n. 9.
Hdt. VI 108; Thuc. III 55, 61.2, 63.2, 65.2, 66.1, 68.5. DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 28-33, 51s., 61-64, 79, 180184, 225-240.
82
NENCI 1988, ad Hdt. VI 108, p. 273.
83
Thuc. II 2. NENCI 1988, ad Hdt. VI 108, pp. 272s.
81
321
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
rivolgersi ad Atene fu dato in virtù della vicinanza. Erodoto però trasmette la notizia che il reale
movente di Cleomene nel rispondere in questi termini sarebbe stata la volontà di mettere Atene
in difficoltà, spingendola a farsi coinvolgere nelle difficili diatribe interpoleiche della Beozia84.
Tucidide preserva una narrazione meno estesa ed organica, piuttosto inserendo rimandi a questi
avvenimenti nei discorsi attribuiti ai delegati plateesi e tebani in occasione della capitolazione
di Platea nel corso della Guerra del Peloponneso, nel 42785. Entrambi gli storici rimandano a
questi fatti come origine e momento iniziale della relazione di intesa che distinse sempre i
rapporti fra Atene e Platea e viceversa della contrapposizione in cui si trovarono Atene e Tebe
per tutto il V secolo; per entrambi gli autori esiste dunque un profondo legame fra le vicende
dell’ultimo quarto del VI secolo e la situazione, i problemi e le questioni morali sotto gli occhi
dell’opinione pubblica a cui si rivolgevano86.
La datazione dell’alleanza fra Atene e Platea: 519 contra 509
Tucidide offre una precisa datazione di queste vicende ricordando che quando Platea fu
distrutta nel corso della Guerra del Peloponneso erano trascorsi 93 anni dalla stipula
dell’alleanza fra Platea e Atene: con questi riferimenti cronologici l’alleanza deve essere datata
al 51987.
È stata avanzata più volte una critica a questa cronologia, proponendo la necessità di
emendare le cifre del testo tucidideo abbassando la data degli eventi al 509, sulla base della
considerazione che questo contesto storico-politico meglio si adatterebbe alle descrizioni degli
eventi. In particolare la critica si è interrogata sulla presenza di Cleomene e del contingente
spartano nella Beozia meridionale in concomitanza con l’alleanza fra Atene e Platea: uno dei
presupposti che hanno spinto alcuni a spostare gli eventi al 509 è il fatto che non siano attestate
spedizioni spartane oltre l’istmo nell’ultimo quarto del VI secolo, ad eccezione di quelle
condotte contro Ippia e i Pisistratidi nel 511 sotto la guida di Anchimolio e appunto poi nel
511/510 sotto il comando di Cleomene, nell’anno di arcontato di Arpactide ad Atene88. Altre
critiche riguardano le intenzioni anti-ateniesi che Erodoto attribuisce al consiglio con cui
Cleomene rispose alla richiesta di aiuto dei Plateesi: il 519 sarebbe una data troppo alta perché
84
Hdt. VI 108.2s.
Thuc. III 55.1,
86
NENCI 1988, ad Hdt. VI 108, pp. 272s.; DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 33s., 51, 61s., 79, 180-186, 205-207, 211217; HORNBLOWER 1997, ad Thuc. III 61.2; TIRTLE 2007, pp. 174-182.
87
Thuc. III 68.5.
88
Hdt. V 65; Aristot. Ath. Pol. 19.6.
85
322
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
Sparta avesse adottato già una posizione avversa ai Pisistratidi; piuttosto questo movente
sarebbe più adatto appunto all’epoca dell’attacco condotto nel 511/51089.
Se pure questi siano interrogativi su cui è necessario riflettere, non mi paiono d’altronde
elementi sufficienti per smentire l’affermazione esplicita della nostra fonte in merito alla
cronologia dei fatti: concordo perciò con quella preponderante parte degli studiosi che difende e
conserva per questi fatti la cronologia del 51990. In primo luogo non si vedono ragioni valide
per dubitare delle cifre riscontrabili nei manoscritti91; dal punto di vista storico non ci sono
ragioni per dubitare della data offerta da Tucidide: al contrario essa mi pare costituire un
contesto storico e politico più adatto del 509.
È vero che la presenza di un contingente spartano in Beozia nel 519 non è altrimenti
attestata nelle fonti; non per questo d’altronde si può ritenere sicura la deduzione che quella
attestazione debba necessariamente essere fatta coincidere con altre serie di interventi spartani
in Attica di epoca successiva; è altrettanto valida cioè la ricostruzione che accetti la notizia
come una attestazione indipendente. Sicuramente la cronologia del regno di Cleomene, pur se
di non chiara soluzione, non esclude che il sovrano fosse già attivo in quella data92.
L’attestazione della spedizione spartana anti-ateniese del 510, con cui una parte degli storici
moderni vorrebbe far collimare la menzione di Cleomene, riguarda peraltro il territorio
dell’Attica e l’assedio all’acropoli ateniese, località a 45 chilometri a sud di Platea e dunque
niente affatto vicina alla Beozia.
Il comportamento ateniese descritto dalla narrazione non si addice in effetti al contesto
politico interno post-pisistratide. Nel 509 Atene aveva infatti appena subito l’assedio di Sparta e
un drammatico cambio di governo, la classe politica si preparava ad un serio scontro interno per
guadagnare l’alleanza di Sparta o altri alleati internazionali, l’appoggio del popolo e il controllo
politico della città: mi pare assolutamente un contesto inappropriato in cui voler collocare
l’iniziativa della stipula dell’alleanza con Platea e l’impegno militare contro Tebe.
89
Esposizioni dei termini della questione e delle posizioni a favore di ciascuna data in MORETTI 1962, pp. 105107; FROST 1984, pp. 291s.; BUCK 1979, p. 107; PICCIRILLI 1973, n. 9, pp. 43s.; BUCK 1996, p. 882. Queste analisi
fanno risalire il tentativo di emendare la data al 509 in prima istanza agli studi di G. Grote, G. Busolt, P.E.
Legrand, J.B. Salmon.
90
La datazione degli eventi al 519 sembra essere la ricostruzione più diffusamente accolta: WELLS 1905; HOWWELLS 1928, ad. Hdt. VI 108; HAMMOND 1955, p. 393; WYCHERLEY 1957, pp. 119s.; MORETTI 1962, pp. 105107; GRAHAM 1964, pp. 126s.; BUCK 1972, pp. 94-96; PICCIRILLI 1973, vol. I, n. 9, pp. 42-46; FORREST 1982 b,
pp. 293s.; FROST 1984, pp. 291s.; HAAS 1985, p. 42; NENCI 1988, ad Hdt. VI 108, pp. 272s.; ARNUSH 1995, p.
137. HORNBLOWER 1997, ad Thuc. II 2, pp. 464, ad Thuc. III 55.1, 68.5, pp. 448-452; DAVERIO ROCCHI – FERRARI
– FINLEY 1998, vol. I, ad Thuc. II 2.1, pp. 462. Contra vengono citate le analisi di G. Grote, G. Busolt, P.E.
Legrand, J.B. Salmon, quali principali studiosi a favore di emendare la data al 509.
91
FROST 1984, pp. 291s.
92
WELWEI 2011, s.v. “Cleomenes” [3], in BNP.
323
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
Alcuni dei critici della datazione al 519 ritengono che il 509 sia, delle due, l’unica data
adatta alla contestualizzazione del segreto movente anti-ateniese che Erodoto attribuisce al
suggerimento fornito da Cleomene ai Plateesi93. Anche questa obiezione non mi pare
giustificata poiché è evidente che la comprensione di questa discrepanza è da affrontarsi sul
piano dell’analisi storiografica del testo e del suo autore, piuttosto che dell’analisi storica. La
natura stessa di questa informazione la distingue come un’inferenza analitica inserita da
Erodoto stesso: si tratta cioè di una notizia strettamente relativa alla psiche e all’intimità di
Cleomene, di cui mi pare impossibile lo storiografo potesse essere realmente venuto a
conoscenza. Sia Erodoto che Tucidide trasmettono in termini non dissimili la risposta e la
giustificazione di Cleomene: che cioè Sparta era troppo lontana da Platea per costituire un
alleato utile, mentre Atene era la potenza più vicina. Soltanto Erodoto però aggiunge quel
proposito nascosto che Cleomene avrebbe avuto di voler spingere Atene a compromettersi nel
mutevole e difficile areale strategico della Beozia. In questo passo Erodoto interpreta le azioni e
le scelte di Sparta e del suo sovrano in virtù degli eventi che egli sapeva sarebbero seguiti, nel
511 e soprattutto nel 510; ad un ulteriore livello testuale, è evidente che l’osservazione fosse
indirizzata al pubblico di V secolo a cui lo storiografo si rivolgeva e che recepiva la storia del
VI secolo alla luce della bipolare contrapposizione politica e ideologica che divideva l’Ellade in
cui viveva94. D’altronde l’inferenza di Erodoto non si allontana, a mio avviso, da una corretta
interpretazione della realtà storica: la particolare instabilità della Beozia appunto nel periodo
intorno al 520 giustifica appieno un interesse di Atene e di Ippia per l’espansione in quella
direzione e la posizione anti-pisistratide che Sparta dimostrò con chiarezza nel 511 aveva
certamente avuto inizio negli anni precedenti95.
In conclusione non vi sono motivi per cercare di emendare il testo tucidideo ed alterare la
datazione, anzi la data del 519 perfettamente si adatta ad inserire l’alleanza fra Atene e Platea e
lo scontro fra Atene e Tebe entro il contesto storico-politico di Atene e della Grecia Centrale96.
La questione della determinazione della cronologia di questi avvenimenti è significativa in
quanto la conclusione a cui l’analisi è fin qui giunta determina l’inserimento di questi fatti della
storia delle relazioni internazionali di Atene nel novero degli interventi di politica estera operati
durante la tirannide di Ippia.
93
FROST 1984, pp. 291s.
MORETTI 1962, p. 106s.; STADTER 2006; THOMAS 2006.
95
DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 180-184 sulla condizione di instabilità del confine attico-beotico.
96
Vd. supra, n. 90 p. 323.
94
324
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
La relazione istituita fra Atene e Platea: un’alleanza con egemonia ateniese
Nel 519 Platea si rivolse ad Atene chiedendone l’aiuto per difendere la propria autonomia
contro le pressioni di Tebe; il risultato fu l’istituzione di un’alleanza interstatale fra le due
poleis e, in ottemperanza a quest’ultima, l’intervento armato di Atene contro Tebe. La ricchezza
dei dettagli lessicali delle fonti finora discusse e dei dati storici incoraggiano a tentare di
comprendere con maggiore precisione la natura istituzionale dell’alleanza che si venne allora a
creare fra le due poleis.
Il lessico di Erodoto non fa in effetti riferimento ad una symmachìa, cioè una “alleanza
militare”, o ad una philìa, nel senso di una relazione di “amicizia” fra le due entità politiche, ma
piuttosto tramanda il chiaro quadro di una sottomissione volontaria dei Plateesi all’egemonia di
Atene. Secondo il racconto dello storico, quando la delegazione plateese si recò ad Atene, si
stavano là compiendo i sacrifici civici presso l’altare dei dodici Dei, nell’agorà; i Plateesi si
sedettero ai piedi di quell’altare, si dichiararono supplici ( i(ke/tai) e si consegnarono (ἐδίδοσαν
σφέας αὐτούς) nelle mani degli Ateniesi colà riuniti. Nel richiedere l’alleanza, sia prima nei
confronti degli Spartani di Cleomene che successivamente verso gli Ateniesi riuniti nell’agorà,
il testo usa sempre e ripetutamente il verbo dìdomi in costruzione riflessiva, che ha il significato
di “concedersi”, “darsi”, “offrirsi”, “consegnarsi”, “donarsi”. La supplica (hiketèia) e
l’affidamento (dìdomi) sono azioni sia para-diplomatiche che rituali, nonché religiose, fra loro
profondamente connesse, e costituiscono due degli strumenti delle relazioni interstatali, fra
individui oppure fra comunità, messe in atto dalla cultura ellenica e attestate a partire dalle fonti
omeriche, per tutta la storia dell’epoca arcaica, e usate e riattualizzate fino a tutta l’epoca
ellenistica97.
L’hiketèia si compiva e veniva espressa tramite un’articolata serie di gesti rituali, i cui
elementi fondamentali sono presenti nella descrizione della richiesta dei Plateesi: il supplice si
recava presso un altare o un luogo sacro e così in prima istanza invocava su di sé la protezione
della divinità del santuario e l’inviolabilità sacrale. La supplica rientrava dunque in prima
istanza nell’ambito del rapporto con il divino, ma comportava delle immediate ricadute nelle
fattive relazioni umane: il contatto con il suolo sacro, l’invocazione di supplica e la protezione
divina forzavano gli astanti, amici quanto ostili, a rispettare l’incolumità del supplice e a
concedere de facto un privilegio di asylìa, cioè la protezione dal diritto di rappresaglia, e in
97
Sul significato e gli aspetti diplomatici della pratica dell’hiketèia: GOULD 1973; DAVERIO ROCCHI 1993, pp.
190-193; SCHUMACHER 1993, pp. 55-57. Sugli aspetti morali ed emotivi della pratica e dell’istituzione cito a titolo
esemplificativo alcuni casi della letteratura omerica e della tragedia classica: Hom. Il. XXIV 158, 187, XXIV 485506; Aesch. Supp.; Suda, s.v. Fru/nixoj, F 762 Adler. FLACELIÈRE 1972, p. 44, 140; WINNINGTON INGRAM 1989,
pp. 512-515.
325
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
effetti l’immunità98. In questo senso l’hiketèia dunque impone un’interruzione a tutte le azioni
che potrebbero nuocere al supplice.
L’hiketèia non interessa esclusivamente l’ambito sacro e divino, ma coinvolge anche le
relazioni interpersonali e inter-comunitarie, poiché insieme alla inviolabilità sacrale della
divinità il supplice invoca l’ospitalità e l’effettiva protezione da parte dell’individuo o della
comunità presso cui ha luogo la supplica, a cui è negli effetti demandata la responsabilità di
accogliere il supplice e di rispettarne e farne rispettare l’incolumità. Per questa componente
dell’ospitalità e dell’accoglienza, in parte simile alle relazioni di xenìa, l’hiketèia era una
istituzione precipuamente
Utilizzata nei contatti fra stranieri appartenenti a poleis o anche a culture diverse99.
Conseguentemente l’hiketèia poteva funzionare come una procedura per chiedere
l’introduzione e l’integrazione entro la comunità familiare oppure civica dell’ospite. Ospitalità e
integrazione tramite hiketèia potevano applicarsi sia a livello delle relazioni interpersonali fra
individui e famiglie, sia nei contatti inter-comunitari e inter-statali fra un individuo e un gruppo
civico o anche fra due comunità politiche.
Tratto fondamentale dell’hiketèia era la relazione non paritaria fra le due parti; in questo
senso vige una profonda distinzione con la xenìa e in questo senso questa istituzione si integra
al verbo dìdomi tanto spesso usato nel passo erodoteo. Nel cercare il contatto e nel chiedere di
stringere una relazione, è la parte supplice a prendere l’iniziativa, ad abbisognare dell’alleanza e
del contributo della controparte, poiché si trova in circostanze svantaggiate o disperate;
nell’alleanza il supplice non ha nulla da offrire, non è in condizione di ricambiare
reciprocamente ai vantaggi che spera di ricevere dal proprio nuovo ospite, il quale invece
sosterrà caritatevolmente degli aggravi senza alcuna garanzia di ritorno. Perciò l’individuo o la
comunità che ascolta la supplica e ne accetta l’impegno è spesso definita euergétes, cioè
“benefattore”. Non diversamente da quanto avviene nei rapporti di reciprocità quali la xenìa o
la philìa, vi sono una richiesta e una concessione di aiuto, oppure di risorse, e si crea
conseguentemente il vincolo della riconoscenza e l’impegno a ricambiare; diversamente però
98
DAVERIO ROCCHI 1993, pp. 190-193; SCHUMACHER 1993, pp. 55s. sulla distinzione fra hiketèia e asylìa;
FURLEY 2007, p. 127 sull’hiktèia in ambito cultuale.
99
Si veda il caso dell’hiketèia di un gruppo di Lidi presso Policrate di Samo: Diod. X, 16.4. Sul valore para-statale
che può asusmere la xenìa: Hdt. I 22.4 il caso di Aliatte insieme a Mileto e l’alleanza e ospitalità con Aliatte e il
regno di Lidia; I 69.3 il caso dell’alleanza fra Sparta e Creso di Lidia; VI 21 il caso di Sibari e Mileto. DOPICO
CAINZOS 1997, p. 532; KONSTAN 1997, pp. 25-37; MITCHELL 1997, pp. 2-4, 54-55; PANESSA 1999, pp. xii, xvxviii, xxvs, 85-87; RAVIOLA 2005.
326
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
nell’hiketèia la relazione non nasce paritaria, ma piuttosto sbilanciata, e così tende a conservarsi
nel tempo100.
Il soggetto richiedente sceglie specificamente lo strumento diplomatico dell’hiketèia in
prima istanza per esprimere l’impellenza e la gravità della situazione in cui si trova e dunque
spronare ad una soluzione rapida, ma anche perché dichiara apertamente la propria condizione
di incapacità e di vulnerabilità101: dimostra di riporre la propria fiducia, oltreché le proprie
speranze, nella controparte affinché questa non scelga di approfittare della propria posizione di
forza.
Quest’analisi chiarisce dunque il senso profondo delle scelte lessicali di Erodoto del verbo
dìdomi (donare, concedere) e dell’azione di supplica; in base a quella specifica relazione che
scaturisce dall’hiketèia è inoltre pertinente, non solo storicamente ma anche istituzionalmente e
semanticamente, l’affermazione di Erodoto secondo cui gli Ateniesi avevano sostenuto
parecchie fatiche in favore dei Plateesi ed erano considerati euergétai (benefattori) dei
Plateesi102.
Infine è dall’impegno contratto in questa relazione che nacquero il sentimento di riconoscenza
dei Plateesi verso Atene e la riconosciuta superiorità di Atene nei confronti di Platea che
informano la storia delle due poleis nel corso di tutto il V secolo103.
In conclusione, dal lessico erodoteo si ricaverebbe un quadro istituzionale secondo cui nel
519 Platea si trovò in una condizione irrecuperabile di inferiorità politica e militare nei
confronti di Tebe; piuttosto che cadere entro la sfera di controllo di Tebe i Plateesi preferirono
invece entrare in contatto con Atene e gravitare verso l’area di influenza di quest’altra polis. IN
cambio del loro aiuto, agli Ateniesi e alla loro classe politica i Plateesi non ebbero altri vantaggi
da offrire se non una posizione egemonica e una libertà decisionale della quale le fonti non
danno una definizione.
Senz’altro l’hiketèia di Platea fu lo sprone per la stipula di una symmachìa, un’alleanza
militare, pur sbilanciata a favore di Atene, secondo la quale Platea si impegnò a conformarsi
alle scelte di politica estera dell’alleata e a provvedere secondo le proprie capacità alle sue
richieste di aiuto: questo è il quadro istituzionale implicato dal comportamento di Platea nella
narrazione di Erodoto del corso delle Guerre Persiane. È naturale che la posizione egemonica di
Atene abbia contemplato anche una qualche forma di libertà, o di concessione,
nell’occupazione e gestione del territorio frontaliero fra l’Attica e la Beozia, sul quale appunto
100
HERMAN 1987, pp. 56-58; DAVERIO ROCCHI 1993, pp. 190-193; JONES 1999, pp. 6-10;
FURLEY 2007, p. 127.
102
Hdt. VI 108.1. DAVERIO ROCCHI 1988, pp. 33s., 51, 61s., 79, 180-186, 205-207, 211-217.
103
Thuc. III 61.2. HORNBLOWER 1997, ad Thuc. III 61.2.
101
327
Università degli Studi di Padova, Scuola di Dottorato in Scienze Storiche, indirizzo Storia, ciclo XXIV
Dott. Matteo F. Olivieri
La politica internazionale dei tiranni nella Grecia arcaica: il caso di Atene
Parte VI: la tirannide di Ippia (527-510-490)
insisteva la chòra di Platea. La supposizione nasce dalla constatazione del comportamento
militare di Atene nella difesa di Platea: quando infatti Atene ottemperò all’alleanza
contrattaccando all’avanzata di Tebe, una volta messo in rotta l’esercito nemico, perseguì
l’avanzata ampliando il confine del territorio plateese al fiume Asopo. Questa scelta andò oltre
l’impegno difensivo pattuito con l’alleata e dimostra un chiaro interesse nel fissare capisaldi
territoriali difendibili e riconoscibili, nel limitare territorialmente l’azione politica di Tebe e in
genere nell’affermare una propria presenza militare sicura sulla frontiera beotica104. Mi pare del
tutto condivisibile l’induzione che Atene non avrebbe sostenuto quello sforzo militare ad
esclusivo vantaggio della recente alleata, ma che stava necessariamente perseguendo degli
interessi propri nella zona. A complemento di questa ricostruzione si consideri che per tutta
l’epoca arcaica, come in molte circostanze durante il V secolo, proprio la zona di frontiera fra
Attica e Beozia fu caratterizzata da particolare fluidità.
D’altro canto il lessico impiegato da Tucidide nel riferire delle relazioni istituite e poi
vigenti fra Platea e Atene mette in luce tutt’altri strumenti diplomatici e una situazione
istituzionale in parte diversa. Escluse le specifiche impostazioni storiografiche dei due autori, le
loro peculiarità stilistiche e la possibilità che avessero sfruttato fonti diverse, la ricostruzione
storica della forma istituzionale dell’alleanza fra Atene e i Plateesi del 519 deve
necessariamente risultare da un’analisi, comparazione e integrazione delle due narrazioni.
Nella narrazione di Tucidide, in occasione dei discorsi tenutisi davanti ai giudici spartani
nel 427, è lo stesso delegato plateese a spiegare che nel 519 i Plateesi avevano ottenuto benefici
da Atene e, dietro loro stessa richiesta, avevano ottenuto da Atene un’alleanza e la concessione
della cittadinanza (ἄλλως τε καὶ οὓς εὖ παθών τις καὶ αὐτὸς δεόµενος προσηγάγετο ξυµµάχους
καὶ πολιτείας µετέλαβεν) e che dunque sul fondamento di quei privilegi i Plateesi avevano
sempre seguito Atene nelle sue azioni militari e nelle sue scelte politic