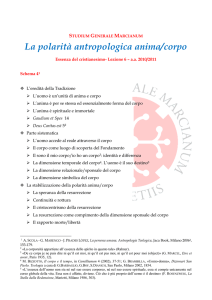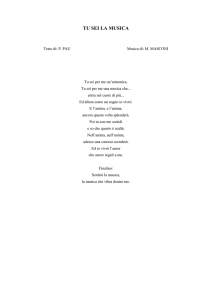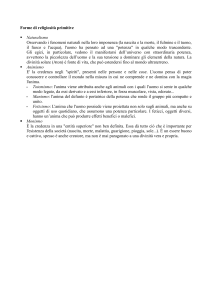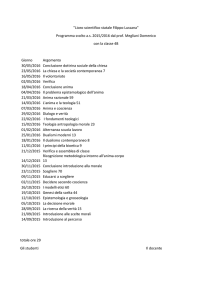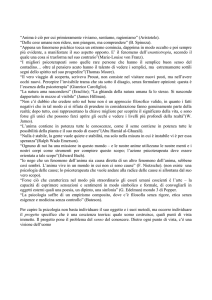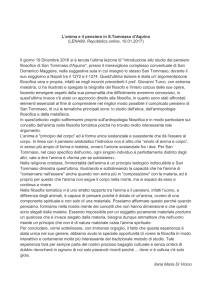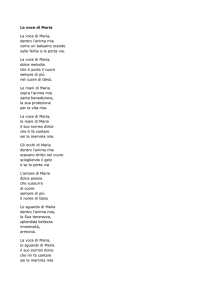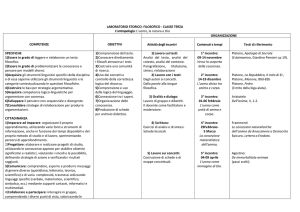Arcidiocesi di Fermo
ISTITUTO SUPERIORE DI
SCIENZE RELIGIOSE
“SS. Alessandro e Filippo”
Concetti chiave per il corso di
Metafisica-gnoseologia
Dispensa per gli studenti
Docente: Sac. Giordano Trapasso
1
Concetti chiave per il corso di metafisica-gnoseologia
Significato di metafisica
“Metafisica” non è un termine aristotelico: è nato in occasione della edizione delle opere di
Aristotele fatta da Andronico di Rodi nel I sec. a. C. oppure è stato coniato dagli aristotelici.
Aristotele usava l’espressione “filosofia prima” o “teologia”.
La metafisica indaga:
a. Le cause o i principi primi o supremi
b. L’essere in quanto essere
c. La sostanza
d. Dio e la sostanza
Ricerca delle cause prime
a. Causa formale (forma o essenza delle cose: anima per gli animali, i rapporti formali per le
figure geometriche, struttura per i diversi oggetti artistici …)
b. Causa materiale (materia che costituisce le cose: ciò di cui è fatta una cosa, …)
c. Causa efficiente o motrice da cui provengono il mutamento e il movimento delle cose
(padre per un figlio, artista per l’opera d’arte, volontà per azioni, colpo per un corpo che si
muove …)
d. Causa finale (costituisce il fine o lo scopo delle cose e delle azioni, ciò in vista di cui o in
funzione di cui una cosa è e diviene, il bene di ogni cosa)
Le prime due cause bastano a spiegare l’essere da un punto di vista statico, le altre due lo
considerano nel suo prodursi, nel suo svolgimento, nel suo divenire, nel suo corrompersi.
2
Significati dell’essere
L’essere non può essere detto in maniera univoca, altrimenti dovrebbe essere unico,
assolutamente identico a se stesso. Con gli Eleati, Zenone, Melisso si è raggiunta
l’immobilizzazione del Tutto.
Per Aristotele l’essere ha significato polivoco, si dà secondo un’originaria molteplicità di significati.
L’essere non è univoco, ma neanche equivoco nella molteplicità delle sue forme. Tutti i molteplici
significati fanno riferimento ad un unico principio.
L’essere non si identifica con un genere, né con una specie, ma è concetto trans-generico e transspecifico.
Anche se l’essere si dice e in molti modi, ha come riferimento unico la sostanza. Tutti i significati
dell’essere sono detti in relazione alla sostanza. Dunque dire l’essere in quanto essere non
significa esprimere un ens generalissimum, ma i molteplici significati dell’essere nella relazione che
li lega formalmente e che ad ognuno conferisce significato di essere. In questa espressione si dà
una dialettica tra unità e pluralità.
a. L’essere si dice nel senso dell’accidente, è essere accidentale o casuale. È ciò che all’ente
accade di essere, un puro accadere, un mero accidente (l’uomo è geometra …)
b. All’essere accidentale si oppone l’essere per sé, ciò che è essenzialmente e non per altro.
L’essere per sé per eccellenza è la sostanza
c. L’essere è significato anche come vero. Ad esso si contrappone il non essere come falso. Si
tratta dell’essere logico, dell’essere presupposto dal giudizio vero mentre l’essere come
falso conduce al giudizio falso. Tale essere sussiste solo nella ragione e nella mente che
pensa
d. Abbiamo anche l’essere come atto e potenza. Tale significato si estende anche ai tre
precedenti e si può estendere anche a tutte le categorie.
L’essere accidentale non ha un suo corrispettivo non essere, mentre lo hanno gli altri tre
significati.
I significati primi e fondamentali dell’essere sono dati dalle figure delle categorie, dei significati in
cui originariamente si divide l’essere, i significati originari ossia le supreme divisioni dell’essere. Le
categorie sono i modi in cui originariamente l’essere è predicato, cioè detto, perché sono i modi
fondamentali di essere degli enti. Esse sono:
1. Sostanza o essenza
3
2. Qualità
3. Quantità
4. Relazione
5. Azione o agire
6. Passione o patire
7. Dove o luogo
8. Quando o tempo
9. Avere
10. Giacere
La molteplicità di significati si dà per ogni gruppo di significati.
La questione della sostanza
Tale questione risponde a due interrogativi: che cos’è la sostanza? E quanti tipi di sostanze
esistono?
Per rispondere alla prima domanda Aristotele è partito dalle sostanze sensibili.
Per sostanza possono intendersi a diverso titolo: la forma, la materia, il composto di materia e
forma.
a. Sostanza è in un certo senso la forma, in quanto essa non è la figura esteriore, ma l’intima
natura delle cose, il che cos’è o l’essenza intima delle medesime. Le cose sono conoscibili
solo nella loro essenza e quando le definiamo facciamo riferimento ad essa
b. Anche la materia può dirsi in un certo senso sostanza, perché senza di essa le essenze non
avrebbero esistenza nel tempo e nello spazio. D’altra parte, se non ci fosse la forma, la
materia non sarebbe nulla di determinato.
c. La sostanza è il sinolo, la concreta unione di materia e forma, tale che la materia è fatta per
ricevere la forma e la forma è fatta per essere ricevuta dalla materia. Tutte le cose concrete
sono sinoli, unioni concrete di materia e forma.
Ora, per comprendere cosa in maniera più appropriata sia sostanza, ricordiamo che:
1. Può chiamarsi sostanza solo ciò che non inerisce ad altro e non si predica di altro, ma è
soggetto di inerenza e di predicazione di tutti gli altri modi di essere
4
2. È sostanza solamente un ente che può sussistere di per sé o separatamente dal resto,
dotato di una forma di sussistenza autonoma
3. Può chiamarsi sostanza solo ciò che è alcunché di determinato: non può essere sostanza un
attributo generale, né alcunché di universale o astratto
4. Sostanza deve essere qualcosa di intrinsecamente unitario, non un mero aggregato di parti
o qualsiasi molteplicità organizzata
5. È sostanza solo ciò che è atto o in atto.
Alla luce di questi requisiti, la materia possiede solo il primo dei requisiti, la forma e il sinolo
possiedono tutti i requisiti.
In sé e per natura sostanza per eccellenza è la forma, in rapporto a noi sostanza per eccellenza è il
sinolo. Se quest’ultimo fosse in sé sostanza per eccellenza, le sostanze puramente spirituali non
potrebbero essere tali.
La forma aristotelica non è l’universale astratto, ma è l’immanente struttura ontologica della cosa.
Atto e potenza interpretano il divenire, la sua dignità ontologica. L’atto ha assoluta priorità
ontologica sulla materia.
Si distinguono fin dall’antichità due forme fondamentali di metafisica:
a. La metafisica come teologia perché considera l’essere più alto e perfetto dal quale
dipendono tutti gli altri e le cose del mondo. In virtù del suo oggetto la metafisica ha la
priorità su tutte le altre scienze
b. La metafisica come ontologia che studia i caratteri fondamentali dell’essere che ogni essere
ha e non può non avere. Essa ha come oggetto specifico la sostanza ed ha la priorità sulle
altre scienze in quanto ognuna di esse studia la sostanza in qualcuna delle sue
determinazioni (la fisica si dedica alla sostanza in movimento, la matematica alla sostanza
come quantità …).
Questo secondo tipo di metafisica a partire dal sec. XVII cominciò ad essere contrassegnata col
nome di ontologia. Essa è avvertita più vicina all’esperienza e comincia ad essere considerata
come l’esposizione ordinata e sistematica di quei caratteri fondamentali dell’essere che
l’esperienza rivela in modo ripetuto e costante. Wolff (1659-1754) dette all’ontologia la forma
sistematica che le garantì successo per un discreto tempo. Il pensiero comune possiede già in
maniera confusa le nozioni che l’ontologia espone in maniera distinta e sistematica. Esiste una
ontologia naturale costituita dalle confuse nozioni ontologiche volgari, dal complesso delle nozioni
confuse che rispondono ai termini astratti coi quali esprimiamo i giudizi generali intorno all’essere
e che acquistiamo con l’uso comune della facoltà della mente. Esiste poi un’ontologia artificiale o
scientifica, che si distingue dalla prima come la logica si distingue dai procedimenti naturali
5
dell’intelletto. È una scienza dimostrativa il cui oggetto è costituito dalle determinazioni che
appartengono a tutti gli enti, sia assolutamente sia sotto determinate condizioni. Entra così
nell’ontologia un’esigenza descrittiva ed empirica per eliminare il contrasto tra l’apriorismo
deduttivo della metafisica e l’esperienza. Wolff distingueva dall’ontologia tre discipline metafisiche
speciali, la teologia, la psicologia e la fisica (di cui la cosmologia è una parte). A sua volta
distingueva una psicologia empirica nella quale si stabiliscono in base all’esperienza i principi che
possono rendere ragione di tutto ciò che può accadere nell’anima umana dalla psicologia razionale
come scienza di tutte le cose che sono possibili nell’anima umana. Gli illuministi hanno apprezzato
la metafisica wolffiana, stando alle seguenti parole di D’Alambert: “Poiché sia gli esseri spirituali
sia quelli materiali hanno proprietà generali in comune, come l’esistenza, la possibilità, la durata, è
giusto che questo ramo della filosofia, dal quale tutti gli altri rami prendono in parte i loro principi,
si denomini ontologia, ossia scienza dell’essere o metafisica generale” (Discours preliminare &7). Si
sostiene una metafisica creata più per noi, più vicina e attaccata alla terra, le cui applicazioni si
estendano alle scienze naturali e ai diversi rami della matematica. Ogni scienza ha la sua
metafisica, intesa come l’insieme dei principi generali su cui è costruita una determinata dottrina.
Kant introduce un terzo significato di metafisica: essa è lo studio di quelle forme o principi
conoscitivi, che per essere costitutivi della ragione umana, anzi di ogni ragione finita in generale,
condizionano ogni sapere e ogni scienza; dal loro esame possono ricavarsi i principi generali di ogni
scienza. La metafisica può essere il sistema della ragion pura, cioè l’intera conoscenza filosofica sia
vera che apparente che deriva dalla ragion pura in connessione sistematica o l’intera filosofia della
ragion pura compresa la critica. Egli si oppone alla metafisica dogmatica tradizionale ma mantiene
l’ontologia secondo il significato critico-soggettivistico. La metafisica kantiana è una scienza dei
concetti puri, che abbraccia le conoscenze che possono essere ottenute indipendentemente
dall’esperienza, sul fondamento delle strutture razionali della mente umana.
Dalla seconda metà del sec. XIX assistiamo ad un attacco nei confronti della metafisica:
a. Agli occhi di Nietzsche la metafisica crea un oltre-mondo rispetto al mondo reale in cui è
proiettato l’intero valore mentre quest’ultimo viene svilito. Con la sentenza “Dio è morto”
egli vuole dichiarare la fine della tradizione ontoteologica dell’Occidente. Il superuomo
deve mantenersi fedele alla terra e in virtù della volontà di potenza devono essere
capovolti tutti i valori
b. Per i neoempiristi o neopositivisti logici gli unici discorsi sensati sono le tautologie logicomatematiche o le proposizioni suscettibili di verifica fattuale. La proposizioni della
metafisica sono senza senso, un insieme di pseudo questioni fondate su un cumulo di
pseudo proposizioni costituite da un ammasso di pseudo concetti. Il metafisico non dice il
falso, semplicemente non afferma nulla. Per gli autori più radicali essa è l’opposto della
scienza, un errore o una malattia derivante da un uso scorretto del linguaggio.
6
c. Per Heidegger la metafisica occidentale si è concentrata sull’ente ed è stata espressione di
oblio dell’essere. La metafisica pronuncia necessariamente e costantemente l’essere ma
non lo porta al linguaggio, perché non lo pensa nella sua verità. Essa erra di ente in ente e
in realtà si configura come una fisica. La metafisica è ontoteologia perché, indagando
l’ente, approda a Dio come ente sommo. Nell’ente l’essere si svela ma anche si nasconde, e
considerato in rapporto all’ente, l’essere, nella sua differenza ontologica, è ni-ente. La
metafisica in quanto tale è il nichilismo autentico. Nietzsche ne è la conferma, in quanto
anch’egli è interno alla tradizione metafisica, è al suo culmine. In lui rinveniamo una
metafisica della volontà di potenza, un discorso che tende a oggettivare e manipolare
l’ente, che continua a parlare in termini di valori. La metafisica non è comunque il frutto di
una scelta umana, ma è il modo in cui l’essere stesso si è dato e si è sottratto nella storia
del pensiero. L’oblio dell’essere, in senso proprio, è un essere abbandonati dall’essere.
All’uomo non rimane che affidarsi ad un pensiero rammemorante e poetante in grado di
prepararlo all’accoglimento dell’evento dell’essere, puramente imprevedibile e gratuito.
D’altra parte egli riconferma il carattere primario dell’ontologia: “Il problema dell’essere
tende non solo alla determinazione delle condizioni a priori della possibilità delle scienze
che studiano l’ente in quanto ente così e così e che perciò si muovono già sempre in una
comprensione dell’essere, ma bensì anche alla determinazione delle condizioni e delle
possibilità delle ontologie che precedono e fondano le scienze ontiche (cioè empiriche)”
(Essere e Tempo, & 3).
Nel sec. XX ci sono tentativi di riabilitazione parziale della metafisica:
a. Per Popper la metafisica non appartiene all’area della scienza perché non è falsificabile, ma
le sue tesi sono razionalmente criticabili. Essa inoltre ha funzionato da supporto psicologico
e da stimolo storico al lavoro scientifico. Dal punto di vista psicologico non c’è scienza
senza la fede in idee che hanno una natura puramente speculativa, che determinano quali
problemi esplicativi sceglieremo di affrontare e quali tipi di risposte potremo considerare
idonee, soddisfacenti, accettabili. Storicamente la metafisica rappresenta la fonte da cui
rampollano le teorie delle scienze empiriche.
b. Alcuni filosofi analitici si concentrano sugli usi e le funzioni generali del discorso metafisico.
Secondo i filosofi di Oxford il linguaggio è costituito da una serie di giochi linguistici
diversificati e il significato di un enunciato non è costituito dal metodo della sua verifica,
ma dall’uso che se ne fa. Per Wisdom la metafisica non è una descrizione scientifica
dell’universo, ma è pur sempre una visione del mondo capace di evidenziare aspetti inediti
della realtà. Le metafisiche tentano di forzare la rete semantica del linguaggio ordinario per
esplorare nuove possibilità teoriche e offrire una nuova e più potente visione delle cose.
c. Nell’epistemologia postpositivistica autori come Kuhn, Lakatos e Feyerabend ritengono
che nei paradigmi e nei programmi di ricerca delle scienze sono all’opera determinati
assunti teorici di natura metafisica e metodologica, che informano gli scienziati circa gli
7
elementi che costituiscono la realtà, o i problemi da affrontare, o le euristiche da seguire.
Per Feyerabend la scienza di oggi può esistere e conservarsi come tale solo a patto di
incorporare in se medesima la metafisica, cioè la disponibilità a contraddire se stessa e le
proprie teorie.
d. Il filone di filosofia analitica postempiristica riconsidera la metafisica come ontologia
generale, come un’indagine volta allo studio di quei concetti che stanno alla base del
nostro pensiero (essenza, identità, contingenza, necessità, …) e che vengono presupposti
dalle più svariate discipline scientifiche.
e. Movimenti come il neotomismo o la neoscolastica riprendono la metafisica e considerano
la domanda intorno all’essere la questione essenziale della filosofia.
8
Analogia e partecipazione
Il termina “analogia” è usato originariamente secondo due significati:
-
Uguaglianza di rapporti nell’uso matematico
-
Estensione probabile della conoscenza mediante l’uso di somiglianze generiche che si
possono addurre tra situazioni diverse.
Platone usa l’analogia per istituire rapporti tra diversi tipi di conoscenza: come l’essere sta al
divenire, così l’intelligenza sta all’opinione: come l’intelligenza sta all’opinione così la scienza sta
alla credenza e la dianoia (conoscenza discorsiva che ricava conclusioni da premesse) sta alla
congettura.
Anche Aristotele la usa nel senso di uguaglianza di rapporti e proporzione.
La Scolastica ha fatto della parola un uso metafisico-teologico e l’ha utilizzata per distinguere e
connettere l’essere di Dio e l’essere delle creature. Tale uso presuppone un concetto di Dio quale
causa efficiente e finale della realtà finita, mediante il rapporto di “creazione”. Dio è l’essere
necessario, che non può non essere, mentre le realtà finite costituiscono l’essere possibile, che
potrebbe anche non essere, e perciò ha bisogno dell’essere necessario per sussistere.
Per S. Tommaso l’essere delle creature è creato, finito, perché separabile dalla propria essenza
mentre l’essere di Dio è identico con la propria essenza e dunque necessario. Questi due significati
di essere, possibile e necessario, non sono univoci e neanche equivoci, ma analoghi: se permane
una certa somiglianza, altrettanta e anche maggiore è la dissomiglianza. Tale rapporto permette di
dire qualcosa di Dio per analogia, senza poterlo esaurire nel concetto, nel rispetto anche della
theologia negativa. Possiamo attribuirgli qualità finite, ma impropriamente, in maniera ineffabile,
via eminentiae. Dell’uomo e di Dio posso predicare la sapienza: nell’uomo si tratta di una
perfezione distinta dalla sua essenza ed esistenza e fa comprendere ciò che vuole significare,
mentre in Dio si tratta di una perfezione identica alla sua essenza e al suo essere ma lascia fuori di
sé la cosa significata perché trascende i limiti dell’intendimento umano.
Uno stesso termine può avere un diverso significato a seconda della realtà cui viene attribuito
(analogia di attribuzione).
Tommaso aggiunge l’analogia di proporzionalità che si riferisce all’analogicità di significato tra
l’essere di Dio e l’essere delle creature, evidenziandone la somiglianza e rimarcandone la
dissomiglianza legata alla trascendenza divina.
Duns Scoto si oppose a tale distinzione tomista e, rifacendosi ad Aristotele, ripropone una nozione
di essere comune a tutte le cose esistenti, a Dio come alle cose create. Tale nozione ritorna ad
essere univoca per permettere di conoscere qualcosa di Dio e predicare di Lui alcuni attributi.
Mentre nel tomismo la metafisica era suddivisa in scienza dell’essere creato (metafisica) e in
9
scienza dell’essere necessario (teologia), per Scoto la metafisica ritorna ad essere unica scienza
dell’essere e la teologia si tramuta in scienza pratica, in scienza che guida l’uomo sulla via della
salvezza.
Nella filosofia moderna Locke nel Saggio sull’Intelletto Umano include l’analogia tra i quattro gradi
dell’assenso: essa è l’unico aiuto di cui disponiamo per raggiungere una conoscenza probabile o
degli esseri materiali finiti fuori di noi o degli esseri che non sono percepibili da noi o della maggior
parte delle operazioni di natura che si celano alla diretta esperienza umana. Leibniz considerò
l’analogia la grande regola della probabilità: ciò che non può essere attestato dall’esperienza può
sembrare probabile a seconda di quanto sia concorde con la verità stabilita.
In questo senso gli scienziati hanno fatto uso dell’analogia: Huygens, affidandosi ad essa, ritenne
lo stato degli altri pianeti simile a quello della terra, salvo per le differenze prodotte dalla loro
diversa distanza dal sole.
Kant considera l’analogia su questa scia: è una forma di prova teoretica, l’identità del rapporto tra
principi e conseguenze, tra cause ed effetti, in quanto ha luogo nonostante la differenza specifica
delle cose e delle qualità in sé, che contengono il principio di conseguenze simili. Egli presenta tre
analogie dell’esperienza:
a. il principio della permanenza della sostanza, ossia “In ogni cangiamento dei fenomeni la
sostanza permane e la quantità di essa nella natura non aumenta né diminuisce”
b. il principio della serie temporale secondo la legge di causalità, ossia “Tutti i cangiamenti
avvengono secondo la legge del nesso di causa – effetto”
c. il principio della simultaneità secondo la legge dell’azione reciproca, ossia “Tutte le sostanze in
quanto possono essere percepite nello spazio come simultanee, sono tra loro in azione reciproca
universale”.
Mentre in matematica le analogie sono formule che esprimono l’uguaglianza tra due rapporti
quantitativi e sono dunque costitutive, in filosofia l’analogia è un’uguaglianza tra due rapporti
qualitativi: se sono dati tre termini della proporzione, non è dato ipso facto il quarto termine,
come in matematica, ma un certo rapporto con essi. Dunque le analogie diventano regole per
cercare un termine nell’esperienza o segni per indicarlo. I tre principi menzionati da Kant non
costituiscono gli oggetti di esperienza, ma valgono solo per scoprirli e situarli nell’ordine universale
della natura. Tali principi sono a priori, certi in maniera indubitabile, ma privi di evidenza intuitiva.
L’analogia rimane uguaglianza tra rapporti qualitativi, non più nel senso della Scolastica (rapporto
tra diverse dimensioni dell’essere) ma nel senso che sono dati non oggetti, ma relazioni che
permettono di scoprirli e ordinarli in unità. L’analogia è uno strumento fondamentale per
estendere la conoscenza dei fenomeni naturali sulla guida delle loro connessioni determinanti.
10
Nella logica e nella metodologia della scienza dell’800 si è stati abbastanza diffidenti verso
l’analogia, considerata come un’estensione della generalizzazione induttiva al di là dei limiti nei
quali essa offre garanzie di verità. Per J. Stuart Mill il ragionamento per analogia consiste
nell’inferenza che ciò che è vero in un certo caso è anche vero in un caso in qualche modo simile
ma non esattamente parallelo, cioè non simile in tutte le circostanze materiali. Un esempio di tale
analogia può essere: “Siccome il pianeta terra è abitato, i pianeti sono abitati”. Tale modo di
argomentare può accrescere in grado non determinabile e modesto la probabilità della
conclusione, ma espone a molte fallacie.
Nella logica e nella metodologia del ‘900 si è avuta minore diffidenza nei confronti della analogia
considerata come uguaglianza di rapporti. Essa permette di creare “simboli” (cfr modelli
meccanici) più o meno somiglianti con le situazioni reali, ed è considerata come condizione o
elemento integrante nella costruzione delle ipotesi e nelle teorie scientifiche.
La partecipazione è uno dei due concetti che Platone ha usato per definire il rapporto tra le cose
sensibili e le idee: “Nient’altro rende bella una cosa se non la presenza o la partecipazione del bello
in sé, quali siano la via o il modo nei quali presenza o partecipazione abbiano luogo” (Fedro, 100 d).
L’altra categoria è dunque “presenza”. In un secondo tempo Platone ha inteso la partecipazione
come imitazione: “A me pare che le Idee stiano come esemplari nella natura; e che gli altri oggetti
somiglino ad esse e ne siano copie; e che questa partecipazione delle cose alle Idee non consiste in
altro che nell’essere immagini di esse” (Parmenide, 132 d).
Tale concetto ha un’importanza capitale nel pensiero di S. Tommaso perché, a suo parere, è il
nome del principio di causalità: il partecipato è la causa e il partecipante è l’effetto. “Quando una
cosa riceve in maniera parziale ciò che appartiene ad altri in maniera totale, si dice che ne è
partecipe. Per esempio, si dice che l’uomo partecipa all’animalità, perché non esaurisce il concetto
di animalità in tutta la sua estensione; per la stessa ragione si dice che Socrate partecipa
all’umanità; parimenti si dice che la sostanza partecipa all’accidente e la materia alla forma in
quanto la forma, sostanziale o accidentale, che, considerata in se stessa, è comune a molti, viene
determinata a questo o a quell’oggetto particolare; similmente si dice che l’effetto partecipa alla
causa, soprattutto quando non ne adegua il potere; un esempio di questa partecipazione si ha
quando si dice che l’aria partecipa alla luce del sole” (Commentarius in Boetium De Hebdomadibus
lec. 2, n. 24). Chiamare il rapporto di causalità con il nome di partecipazione significa istituire un
nuovo tipo di rapporto, più stretto, più intimo, più profondo tra causa ed effetto. Sussiste una
somiglianza tra causa ed effetto, in quanto l’effetto possiede la stessa qualità della causa, ma è
mantenuta anche una differenza perché l’effetto possiede solo una parte della realtà della causa:
“quando qualcosa riceve in parte ciò che a un altro appartiene universalmente, si dice che vi
partecipa” (ibid.). La partecipazione fonda così la dottrina dell’analogia che sottolinea la
somiglianza e dissomiglianza tra cause ed effetto, Dio e creature. Dio esaurisce il concetto
dell’essere in tutta la sua estensione, è l’essere, mentre le creature hanno l’essere per
partecipazione. Tutti gli enti che noi sperimentiamo non sono l’essere per essenza, ma
11
partecipano dell’essere. L’essere è perfezione di tutte le perfezioni, attualità di tutti gli atti, è
infinito e non può comportarsi come i partecipanti che sono sempre finiti: “L’essere può venire
partecipato dalle altre cose, ma non può esso stesso partecipare a nessuna cosa. Invece ciò che è,
ossia l’ente, partecipa all’essere, non come il più comune partecipa al meno comune, ma partecipa
all’essere come il concreto partecipa all’astratto” (ibid.). Il grado di partecipazione di un ente
all’essere, che gli permette di distinguersi da un altro ente, è l’essenza: “Le cose non si distinguono
le une dalle altre in ragione dell’essere, perché questo è comune a tutte. Se dunque differiscono
realmente tra loro, bisogna o che l’essere stesso sia specificato da alcune differenze aggiunte, in
maniera che cose diverse abbiano un essere specificatamente diverso, oppure che le cose
differiscano perché lo stesso essere compete a nature specificatamente diverse. Il primo caso è
impossibile, perché all’essere non si può far aggiunta in quel modo in cui si aggiunge la differenza
specifica al genere. Bisognerà allora ammettere che le cose differiscano a cagione delle loro diverse
nature o essenze, per le quali si acquista l’essere in modi diversi” (Contra Gentiles, I, c. 26). La
partecipazione all’essere degli enti materiali e degli enti immateriali non avviene allo stesso modo:
“Si deve considerare che ogni realtà partecipa dell’essere secondo la relazione che la lega al primo
principio dell’essere. Ora, una cosa composta di materia e forma ha l’essere solamente in
conseguenza della sua forma, dunque è tramite la sua forma che essa è in relazione con il primo
principio dell’essere. Ma poiché in una cosa generata la materia preesiste alla forma dal punto di
vista cronologico, ne deriva che quella data cosa non si trova sempre nell’accennata relazione con
il principio primo dell’essere; e non si trova in tale relazione neppure in concomitanza con il suo
essere materia, ma solamente dopo, al sopraggiungere della forma” (In De causis, prop. 25).
D’altra parte tutte le forme limitano l’essere, quindi nessuna di esse si identifica con l’essere, ma
ciascuna, distinguendosi dalle altre, è un modo particolare di partecipare all’essere. Con l’uso della
categoria di partecipazione Tommaso risolve tutti gli enti nell’essere: “Tutto ciò che è qualcosa per
partecipazione rimanda a un altro che sia la stessa cosa per essenza, come a suo principio
supremo. Per esempio, tutte le cose calde per partecipazione si riducono al fuoco il quale è caldo
per essenza. Ora, dato che tutte le cose che sono partecipano all’essere e sono enti per
partecipazione, occorre che in cima a tutte le cose ci sia qualcosa che sia essere in virtù della sua
stessa essenza, ossia che la sua essenza sia l’essere stesso. Questa cosa è Dio, il quale è causa
sufficientissima, degnissima e perfettissima di tutte le cose: da lui tutte le cose che esistono
partecipano all’essere” (Commento al Vangelo di Giovanni, Prologo n. 5).
12
Atto di essere
S. Tommaso assegna il ruolo di atto principale e primario non alla forma, ma all’essere, attualità di
ogni atto e perfezione di ogni perfezione. Fra tutte le cose l’essere è la più perfetta, e l’essere
sostanziale di una cosa è l’attualità di ogni forma esistente. Aristotele aveva applicato il rapporto
di atto e potenza alle coppie materia – forma e sostanza – accidente. Tommaso aggiunge la coppia
essenza – atto di essere. Negli enti finiti essenza ed essere non coincidono, a differenza di Dio che
è l’esse ipsum subsistens. Come si realizza la composizione dell’essenza con l’essere, come può
l’essenza attuarsi? Tale composizione è nuova, diversa da quella di materia e forma e sostanza e
accidente, perché qui l’essenza svolge il ruolo di potenza rispetto all’essere. L’essenza riceve la
perfezione dell’essere ma poi la limita; per questo nessun ente finito ha la perfezione infinita
dell’essere. La composizione di essenza e atto di essere (essere ricevuto che attua l’essenza ma
che si limita in essa) è profondamente diversa da quella di materia e forma: “Primo, perché la
materia non è l’essenza stessa della cosa, altrimenti avremmo che tutte le forme sarebbero
accidentali come ritenevano gli antichi naturalisti; la materia invece è una parte dell’essenza.
Secondo, perché l’essere stesso (ipsum esse) non è l’atto proprio della materia, ma della sostanza
tutta intera; infatti l’essere è l’atto di ciò che si può dire che è. Ma l’essere non si dice della
materia, bensì del tutto. Perciò non si può dire della materia che essa sia, ma ciò che veramente
esiste è la sostanza. Terzo, perché neppure la forma è l’essere (né delle cose materiali né di quelle
immateriali) … Perciò, negli enti composti di materia e forma, né la materia né la forma si possono
dire essenza ed essere. Tuttavia la forma si può dire ciò per cui la cosa è, in quanto è principio
dell’essere; ma tutta quanta la sostanza è ciò che è (quod est) e l’essere è ciò per cui la sostanza si
dice ente. Invece, nelle sostanze intellettuali o separate, che non sono composte di materia e forma
ma nelle quali la stessa forma è sostanza sussistente, la forma è ciò che esiste; mentre l’essere è sia
atto sia ciò per cui esiste la forma” (Contra Gentiles, II, c. 54). Tommaso risolve così il problema
della creaturalità e finitezza degli angeli, senza comprometterne l’assoluta spiritualità. L’angelo
non è composto di materia e forma, ma neanche si identifica con l’essere, ma si rapporta all’essere
che è atto a mo’ di potenza. Dio è infinito e perfetto perché si identifica con l’essere.
13
Trascendentali dell’essere
A partire dal sec. XIII con questo termine vengono indicate le proprietà comuni a tutte le cose, che
perciò trascendono o eccedono la diversità dei generi in cui tutte le cose si distribuiscono. Sono
proprietà fondamentali dell’ente che lo accompagnano sempre e dovunque, perciò appartengono
a tutti gli enti.
Già Aristotele aveva insegnato che l’unità, la verità e la bontà sono qualità che appartengono
all’ente in quanto tale. L’unità, la verità e la bontà si riferiscono analogicamente a tutti gli enti, sia
alle sostanze sia agli accidenti, sia alle realtà materiali sia a quelle immateriali.
S. Tommaso li ha definiti come quelle proprietà che si aggiungono all’ente in quanto esprimono un
modo di esso che non viene espresso dal nome dell’ente: ens, res, unum, aliquid, bonum, verum. In
Tommaso tali proprietà si collocano in un ripensamento del concetto di essere in senso intensivo,
come attualità di ogni atto e perfezione di tutte le perfezioni. Unità, verità e bontà diventano in
modo eminente proprietà prima di tutto dell’esse ipsum subsistens. Dio diventa allora la misura di
tutto ciò che possiede unità, bontà, verità. All’essere in quanto essere, e all’ente che ne è
partecipe, competono di diritto tutte quelle proprietà che si possono “convertire” con esso, cioè
quelle proprietà che sono coestensive con l’essere, anche se non hanno la medesima
connotazione, per cui non si distinguono realmente dall’essere (ente), ma concettualmente.
Riguardo i cinque trascendentali sopra elencati, l’Angelico insiste su unità, verità e bontà mentre
considera res e aliquid semplici sinonimi di ens, più che proprietà dell’essere. Unità, verità e bontà
aggiungono all’ente qualche cosa senza imporre restrizioni al suo contenuto. Sono aggiunte di
ordine logico, cioè connotazioni come la negazione (essere indiviso), e la relazione (con l’intelletto
nel caso della verità e con la volontà nel caso della bontà). Quindi l’essere (ente) è detto uno
perché indiviso in se stesso, vero e buono perché conforme all’intelletto e alla volontà. La
conformità come modalità dell’essere (ente) è possibile per l’esistenza dell’anima, che in certo
qual modo è tutte le cose. Siccome l’anima è composta della facoltà appetitiva e di quella
conoscitiva il termine bene esprime la conformità dell’essere (ente) alla facoltà appetitiva e il
termine vero la conformità alla facoltà conoscitiva. Vista l’applicazione dei Trascendentali anche a
Dio in essi si distinguono una misura e un misurato: l’essere uno, vero, buono per essenza e
l’esserlo per partecipazione.
Qualcuno ha considerato incompleto l’elenco di S. Tommaso. Mancano la bellezza, il valore e il
sacro. Ma possono essere integrati, partendo dal presupposto che il trascendentale esprime una
relazione dell’ente (essere) con se stesso e con le facoltà dell’anima e, d’altra parte, riconoscendo
che l’anima possiede anche la facoltà estimativa, il sentimento, il timore. Dunque la bellezza
scaturisce dalla relazione con il sentimento di ammirazione, il valore dalla relazione con la facoltà
estimativa, il sacro dalla relazione con il timore. Sui trascendentali possono fondarsi la gnoseologia
(il vero), l’etica (il bene), l’estetica (il bello), l’assiologia (il valore), la religione (il sacro); questo
testimonia come non siano un semplice corollario nell’indagine sull’essere, ma vanno posti a
fondamento metafisico.
14
Tale concetto è stato ripreso lungo la tradizione filosofica.
In Kant il termine trascendentale assume un nuovo significato: “Chiamo trascendentale ogni
conoscenza che si occupa non degli oggetti, ma del nostro modo di conoscere gli oggetti, in quanto
è possibile a priori”. Quindi trascendentale non è più ciò che è al di là di ogni esperienza, ma
piuttosto ciò che antecede l’esperienza (a priori) pur non essendo destinato ad altro che a rendere
possibile la semplice conoscenza empirica.
Fichte con tale termine designa la dottrina della scienza per mostrare che tutti gli elementi del
conoscere rientrano nell’Io, cioè nella coscienza: “Questa scienza non è trascendente, ma resta
trascendentale nella sua più intima profondità. Essa spiega certo ogni coscienza come qualcosa che
esiste indipendentemente da ogni coscienza, ma anche in questa spiegazione non dimentica di
conformarsi alle sue proprie leggi, ed appena vi riflette sopra, quel termine indipendente diventa di
nuovo un prodotto della propria facoltà di pensare, quindi qualcosa di dipendente dall’Io in quanto
deve esistere per l’Io nel concetto dell’Io”.
Anche per Schelling trascendentale è l’atto del sapere che assorbe l’oggetto come tale, è un
sapere puramente soggettivo
Nella filosofia contemporanea il concetto di trascendentale designa ciò che appartiene al soggetto
o alla coscienza in quanto è condizione dell’oggetto e della realtà stessa. Nella coscienza
soggettiva ci sono le condizioni di ogni realtà.
15
Trascendenza – immanenza
Con il platonismo e il neoplatonismo la trascendenza indica lo stato o la condizione del Principio
divino o dell’essere che è al di là di ogni cosa, di ogni esperienza umana (in quanto esperienza di
cose) o dell’essere stesso. Platone aveva già detto che il Bene, principio supremo di tutto ciò che
è, paragonabile al sole che fa vivere e rende visibili tutte le cose, è al di là della sostanza. Plotino
ripete che l’Uno è al di là della sostanza, e anche al di là dell’essere. Di conseguenza è anche al di là
della mente. Esso è trascendente rispetto a tutte le cose pur producendole e tenendole in essere
lui stesso. Proclo ribadisce: “al di là di tutti i corpi c’è la sostanza dell’anima, al di là di tutte le
anime, la natura intellegibile, al di là di tutte le sostanze intellegibili, c’è l’Uno”.
La Scolastica classica, riconoscendo la analogicità dell’essere, non pone Dio al di là dell’essere
stesso.
Scoto Eriugena usa il termine “super essente” per indicare la trascendenza assoluta per cui Dio è al
di sopra di tutte le determinazioni concepibili.
La teologia negativa o mistica pone Dio al di là dell’essere fino a farne, rispetto all’essere, un
“nulla”.
Jaspers contrappone la trascendenza all’esistenza: la trascendenza è ciò che è al di là di ogni
possibilità di esistenza, è l’essere che non si risolve mai nel possibile e che per l’uomo rimane
impossibile da raggiungere. La Trascendenza si rivela sotto forma di cifra nelle situazioni limite e
non può essere contrassegnata come divinità, pena il cadere nella superstizione. La cifra è il
simbolo mediante il quale l’essere trascendente può essere presente all’esistenza umana senza
tuttavia acquistare caratteri oggettivi e senza entrare a far parte dell’esistenza soggettiva. Una
cosa, una persona, una dottrina, una poesia possono valere come simboli o cifre della
Trascendenza, così come le situazioni limite. Ogni situazione incita e ostacola, è infida, insicura,
limita e distrugge; le situazioni limite sono immutabili, definitive, incomprensibili. In esse l’uomo si
trova come contro un muro contro cui urta senza speranza. Esse sono: l’esistere necessariamente
in una situazione determinata, il non poter vivere senza lotta e dolore, il dover prendere su di sé la
colpa, l’essere destinato alla morte. In tali situazioni si rivela in modo negativo la trascendenza.
Nella filosofia contemporanea alcuni indirizzi realistici mantengono la trascendenza dell’essere
rispetto alla coscienza e all’oggetto conoscitivo immanente.
Abbiamo anche un secondo significato di trascendenza, intesa come un rapporto che non significa
unità o identità dei suoi termini, ma ne garantisce bensì l’alterità. Possiamo individuare un tale
rapporto nella contemplazione, così come è concepita da Plotino: essa è per colui che è andato al
di là di tutto. S. Agostino dice: “Se troverai mutevole la tua natura, trascendi te stesso … Ricordati
che nel trascendere te stesso, trascendi un’anima razionale e che pertanto devi mirare al punto da
cui dipende ogni luce di ragione” (De vera religione, 39).
16
Nella filosofia contemporanea trascendente è stata chiamata, in senso attivo, la coscienza, o l’atto
di conoscenza. Husserl distingue la percezione trascendente, che ha per oggetto la cosa e rispetto
alla quale la cosa stessa è trascendente, dalla percezione immanente che ha per oggetto le stesse
esperienze coscienti le quali sono immanenti alla percezione stessa. N. Hartmann così scrive: “La
conoscenza non è un semplice atto di coscienza, come il rappresentare o il pensare, ma un atto
trascendente. Un atto simile s’attacca al soggetto soltanto con una sua parte, con l’altra ne sporge
fuori; con quest’ultima s’attacca all’esistente che, mediante esso, diviene oggetto. La conoscenza è
relazione tra un soggetto e un oggetto esistente. In questa relazione l’atto trascende la coscienza”.
Heidegger ha definito trascendente il rapporto tra l’uomo (Dasein, Esserci) e il mondo. “L’esserci
che trascende non oltrepassa né un ostacolo anteposto al soggetto in modo tale da costringerlo a
restare dapprima in se stesso (immanenza) né un fosso che lo separerebbe dall’oggetto. Da parte
loro gli oggetti (gli enti che gli sono presenti) non sono ciò verso cui l’oltrepassamento si attua. Ciò
che viene oltrepassato è proprio e unicamente l’ente stesso, cioè qualsiasi ente che possa essere
svelato o svelarsi all’Esserci e quindi anche proprio quell’ente che l’Esserci è, in quanto esistendo, è
se stesso” (Sull’essenza del fondamento, 1929, II). L’atto di trascendenza è quello per cui l’uomo,
come ente nel mondo, si distingue dagli altri enti ed oggetti e si riconosce come se stesso. La
trascendenza è il significato dell’essere nel mondo. “Colui che oltrepassa e quindi va oltre, deve
come tale sentirsi situato nell’ente. L’Esserci, in quanto si sente tale, è incluso nell’ente in modo
che, ricompreso in esso, viene da esso accordato a se stesso. La trascendenza è un progetto del
mondo tale che colui che progetta è dominato dall’ente che trascende ed è già in accordo con esso.
Con questo essere incluso dell’Esserci, connesso con la Trascendenza, l’Esserci ha preso base
nell’ente, ha ottenuto il suo fondamento”. La trascendenza si appiattisce sugli oggetti trascesi, il
progetto sul suo punto di partenza, il possibile sull’effettuale, il futuro sul passato. Tale ricaduta o
appiattimento è chiamato deiezione o effettività. Sartre riprende tale concetto di trascendenza
affermando che la coscienza (il per sé), trascendendo verso l’essere (in sé), si annulla per rivelare e
affermare, attraverso di sé, l’essere stesso.
Anche l’immanenza può avere diversi significati.:
La presenza del fine dell’azione all’azione stessa o del risultato di un’operazione qualsiasi
alla stessa operazione. Gli Scolastici parlavano così di un’azione immanente, cioè che
rimane nell’agente, come l’intendere, il sentire, il volere. Essa è distinta dall’azione
transitiva che è quella che dall’agente passa in una materia esterna, come il segare, lo
scaldare … . Tale distinzione riprende quella che Aristotele aveva fatto tra movimento e
attività nel libro IX della Metafisica. Il movimento è l’azione che ha il suo fine fuori di sé e
l’attività è l’azione che ha in se stessa il suo fine. Per definire l’attività Aristotele riprende il
verbo enyparchein, che significa inerire come parte essenziale o costitutiva. Spinoza
adoperò l’aggettivo nello stesso senso applicandolo a Dio per dire che Dio è causa
immanente, non già transitiva di tutte le cose, intendendo dire che Dio è causa delle cose
che sono in Lui e che non c’è nulla fuori di Dio. I wolfiani, in particolare Baumgarten,
17
riprendono la distinzione aristotelica. L’immanenza dice il permanere, nell’agente, del fine,
risultato o effetto di un’azione.
Il secondo significato è quello in cui Kant adopera il corrispondente aggettivo chiamando
immanenti i principi la cui applicazione si tiene in tutto e per tutto nei limiti dell’esperienza
possibile, che sono perciò contrapposti ai principi trascendenti che sorpassano questi limiti.
In questo senso l’immanenza significa la limitazione dell’uso di certi principi al dominio
dell’esperienza possibile e la rinuncia ad estenderli al di là di esso.
Un terzo significato si configura nell’idealismo post – kantiano. Scrive Fichte: “Nel sistema
critico, la cosa è ciò che è posto nell’Io; nel dogmatico, ciò in cui l’Io stesso è posto, il
criticismo è perciò immanente perché pone tutto nell’Io; il dogmatismo è trascendente
perché va ancora oltre dell’Io” (Wissenschafslehre, 1794, I, &3, D). Questa terminologia,
seguita anche da Schelling, dà all’aggettivo immanente la caratteristica del punto di vista
assoluto, per il quale nulla c’è fuori dell’Io. E’ tuttavia evidente l’analogia di questo
significato con quello spinoziano per il quale l’azione di Dio è immanente perché non va
oltre Dio stesso. In questo senso l’immanenza è l’inclusione di tutta la realtà nell’Io (o
Assoluto o Coscienza) e la negazione di ogni realtà al di fuori dell’Io. Nello stesso senso
Gioberti parlava di pensiero immanente e insiste sull’immanenza il pensiero italiano tra le
due guerre.
I tre significati hanno in comune il concetto che immanente è ciò che, facendo parte della sostanza
di una cosa, non sussiste fuori di essa. In questo senso si parla di “giustizia immanente” per
indicare quella giustizia che è inerente alla successione stessa degli eventi o di “pericolo
immanente” per indicare il pericolo proprio di una certa situazione.
È stata introdotta anche l’espressione “filosofia dell’immanenza” da Wilhelm Schuppe (18361913), per indicare la prospettiva secondo la quale il mondo è nella coscienza, ma la coscienza non
è quella individuale, bensì la coscienza in generale, cioè il contenuto comune delle coscienze
individuali.
Blondel ha introdotto invece il metodo dell’immanenza, un metodo di apologetica religiosa il
quale tende a mostrare che il divino è in qualche modo immanente nell’uomo, almeno sotto forma
di bisogno, di aspirazione o esigenza. Le Roy ha parlato di principio di immanenza esprimendolo
nella forma che “tutto è interno a tutto, e che nel minimo dettaglio della natura o della scienza
l’analisi ritrova tutta la natura e tutta la scienza”.
Infine esiste anche la posizione dell’immanentismo, la dottrina che nega ogni realtà o essere al di
fuori della coscienza o dell’autocoscienza. L’idealismo gnoseologico, quello romantico e tutte le
forme di coscienzialismo sono dottrine immanentistiche.
18
L’essere
Prima di tutto distinguiamo due usi del termine essere:
L’uso predicativo per il quale si dice: Socrate è un uomo, la rosa è rossa
L’uso esistenziale per il quale si dice: “C’è Socrate”, “C’è una rosa rossa”
Platone, nel Parmenide (137c; 142b), distingue il senso dell’ipotesi “L’uno è uno” è “L’uno è”: nel
secondo caso la copula esprime la partecipazione all’essere. Aristotele riprende la stessa
differenza, tra l’è come terzo predicato e l’è come secondo predicato, tra l’è predicato per
accidente (cfr. Omero è poeta) e l’è predicato per sé (Omero è), come differenza tra essere
qualcosa ed essere assolutamente.
La differenza tra questi due significati di essere rimane fissata nella tradizione filosofica dopo
Aristotele. Dice S. Tommaso: “Essere ha due significati: in un modo significa l’atto di essere, in un
altro significa la composizione della proposizione che l’uomo trova congiungendo il predicato con il
soggetto” (De ente 1).
Nella logica terministica medievale si distingueva il verbo essere come secondo costituente
(secondo adiacens) della proposizione dal verbo essere che ricorre come terzo costituente (tertio
adiacens), cioè in funzione predicativa o di copula. (Guglielmo di Ockam).
Kant distingue la posizione predicativa o relativa, espressa dalla copula di un giudizio, e la
posizione assoluta o esistenziale, con cui si pone l’esistenza della cosa.
Nella filosofia moderna e contemporanea la distinzione è un luogo comune, anche se non viene
sempre esplicitamente formulata.
Il significato predicativo è stato declinato secondo tre dottrine fondamentali:
Secondo la dottrina dell’inerenza, essere, nel rapporto predicativo, significa appartenere o
inerire. “Socrate è uomo” significa che l’essenza uomo inerisce a Socrate; “la rosa è rossa”
significa che la qualità rosso appartiene alla rosa. I rapporti di inerenza esprimibili col
verbo essere sono chiariti e distinti grazie alla dottrina della sostanza di Aristotele:
occorre tenere presenti i rapporti tra la sostanza e la sua essenza necessaria e la sostanza
e le sue altre determinazioni categoriali o accidentali. Precisa Aristotele: “Sono cose
diverse l’inerire, l’inerire necessariamente e la possibilità di inerire”. L’inerenza necessaria
è quella dell’essenza necessaria, espressa dalla definizione, alla cosa di cui è l’essenza;
mentre il semplice inerire o l’inerire possibile è riferimento alla cosa di una qualità o
quantità o qualsiasi altra determinazione categoriale, non incluse nella definizione della
cosa o puramente accidentali. Questa è la distinzione aristotelica tra l’essere necessario e
l’essere accidentale: “In senso accidentale, noi diciamo che il giusto è musico, che l’uomo è
musico e che il musico è uomo o diciamo che il musico costruisce quando capita che il
19
costruttore è un musico o che il musico è un costruttore: in tutti questi casi dire <<Questo è
quello>> significa <<a questo capita quello>>”. All’opposto, l’inerenza necessaria o per sé
non ha carattere accidentale e pur specificandosi secondo le categorie ha per suo
fondamento privilegiato la sostanza. Dice sempre Aristotele: “Come l’è inerisce a tutte le
cose però non allo stesso modo ma ad alcune in modo primario ad altre secondariamente;
così il che cosa (l’essenza) inerisce assolutamente alla sostanza e solo in certo modo alle
altre cose. Noi possiamo anche chiederci di una qualità che cosa essa sia, perciò anche una
qualità è un esempio di essenza, ma non assolutamente. Così alcuni dicono che
logicamente il non essere è: tuttavia non è semplicemente, ma solo come non essere: così è
per la qualità”. Pertanto secondo Aristotele l’essere predicativo esprime l’inerenza al
soggetto o della sua essenza necessaria o di determinazioni categoriali che, pur non
facendo parte dell’essenza, dipendono da essa o di determinazioni accidentali. Questo
significato dell’essere ha un suo senso privilegiato che è l’inerire sostanziale, cioè l’inerire
dell’essenza necessaria, espressa dalla definizione, alla sostanza definita. “Socrate è
animale bipede” è un caso di inerenza predicativa privilegiata se “animale bipede” è la
definizione dell’uomo, perché è l’inerenza dell’essenza necessaria alla sostanza. Le altre
determinazioni come “Socrate è filosofo” o “Socrate è in casa” costituiscono casi di
inerenza secondaria o accidentale. In questo concetto predicativo, l’essere è ridotto a un
unico tipo di rapporto, qualificato come appartenenza o inerenza e il privilegio viene
accordato al rapporto di inerenza necessaria che intercorre tra la sostanza e l’essenza. La
tradizione logica medievale conserva tale dottrina dell’inerenza, ed essa è in qualche
modo ripresa anche da autori moderni. Scrive Leibniz: “Ogni vero predicato ha qualche
fondamento nella natura delle cose, e quando una proposizione non è identica, cioè
quando il predicato non è compreso espressamente nel soggetto, bisogna che vi sia
compreso virtualmente: è ciò che i filosofi chiamano in – esse, dicendo che il predicato è nel
soggetto”. Allo stesso modo per Hegel il significato predicativo dell’essere è l’identità
dell’individuale e dell’universale, cioè quella stessa relazione tra sostanza ed essenza in cui
Aristotele vedeva il caso privilegiato del rapporto predicativo: “la copula è viene dalla
natura del concetto, che è di essere identico con sé nel suo estrinsecarsi: l’individuale e
l’universale sono, come suoi momenti, determinazioni che non possono essere isolate”. Il
giudizio tende ad esprimere in modo mediato o riflesso l’unità del predicato col soggetto,
cioè l’unità di un concetto unico che, attraverso il giudizio stesso, e più completamente
attraverso il sillogismo, si articola nelle sue determinazioni necessarie. Alcuni hegeliani
inglesi sostengono che l’essere predicativo significhi riferimento di un concetto al sistema
totale della realtà, dunque il concetto è, nel giudizio, una qualifica essenziale della realtà
universale.
Secondo la dottrina dell’identità o supposizione, la copula significa l’identità dell’oggetto al
quale si riferiscono o in luogo del quale stanno soggetto e predicato della proposizione.
Nell’espressione “Socrate è bianco” la copula indicherebbe semplicemente che il soggetto
Socrate e il predicato Bianco sono riferiti allo stesso soggetto esistente: che perciò può
20
essere qualificato con l’uno e con l’altro dei due termini. L’origine di tale dottrina è
probabilmente nello logica stoica, nella quale è fondamentale il riferimento di ogni
enunciato ad una situazione di fatto immediatamente presente. Ma essa si chiarisce
pienamente nella logica del sec. XIII, in polemica con la teoria dell’inerenza: “Proposizioni
come <<Socrate è un uomo>> o <<Socrate è un animale>> non significano che Socrate ha
l’umanità o l’animalità. Né significano che l’umanità o l’animalità è in Socrate, né che
l’uomo o l’animale è in Socrate, né che l’uomo o l’animale è una parte della sostanza o
dell’essenza di Socrate o una parte del concetto o della sostanza di Socrate. Ma significano
che Socrate è in realtà un uomo ed è in realtà un animale: non nel senso che Socrate sia
questo predicato <<uomo>> o questo predicato <<animale>> ma nel senso che c’è
qualcosa per la quale questi due predicati stanno; come quando accade che questi
predicati stanno per Socrate” (Guglielmo di Ockam). Hobbes riprende la stessa dottrina:
“La proposizione è un discorso che consta di due nomi congiunti, mediante il quale colui
che parla intende dire che egli pensa che il secondo nome è un nome della stessa cosa della
quale è nome il primo: o, che è lo stesso, che il primo nome è contenuto nel secondo. Per
esempio, il discorso <<L’uomo è animale>> nel quale i due nomi sono congiunti dal verbo è,
è una proposizione perché chi la enuncia intende dire che egli crede che il secondo nome
<<animale>> è il nome della stessa cosa di cui è nome <<uomo>>. Stuart Mill riprende e
rilancia tale dottrina, distinguendo le affermazioni “essenziali”, cioè generali, che non
fanno altro che spiegare l’essenza nominale di una cosa dalle proposizioni “reali” le quali
implicano sempre l’esistenza del soggetto cui si riferiscono. Nel caso di un soggetto non
esistente, la proposizione non avrebbe nulla da asserire. L’aspetto qualificante di tale
dottrina dell’identità o supposizione è il riferimento alla realtà immediatamente data o
intuita. Nel nominalismo i logici hanno addirittura affermato la falsità di proposizioni
tautologiche come “la chimera è chimera” quando in essa il soggetto sta per un oggetto
inesistente. Il secondo aspetto qualificante è l’identità del riferimento oggettivo dei
termini della proposizione: l’identità della cosa in luogo della quale stanno soggetto e
predicato.
Secondo la dottrina della relazione la copula è esprime una relazione tra termini,
interpretata come oggettiva (in re) o soggettiva (istituita dal soggetto). L’interpretazione
dell’Essere predicativo come di una relazione che sia atto od operazione del soggetto
pensante ha come presupposto il principio cartesiano che l’oggetto immediato della
conoscenza umana è solo l’idea. Proprio da questo punto di vista la proposizione appare
come giudizio e comincia ad assumerne il nome: giacché il giudizio è per l’appunto l’atto
con cui lo spirito sceglie o decide. Dice Cartesio: “Tra i miei pensieri, alcuni sono quasi le
immagini delle cose e a questi soltanto conviene propriamente il nome di idea: come
quando mi rappresento un uomo o una chimera o il cielo o un angelo o Dio stesso. Altri
pensieri hanno, oltre che questa, altre forme; per es. quando voglio, temo, affermo, nego,
concepisco bensì qualcosa come l’oggetto dell’azione del mio spirito, ma aggiungo anche,
con questa azione, qualche altra cosa all’idea di quell’oggetto; e di questo genere di
21
pensieri, alcuni sono chiamati volontà o emozioni, altri giudizi”. Il giudizio è pertanto,
secondo Cartesio, un’azione dello spirito per la quale si aggiunge qualcosa all’idea che si
ha di un oggetto: è, in altri termini, un atto di unificazione o di sintesi. Questa nozione è
chiaramente espressa nella Logica di Arnauld: “Quando dico <<Dio è giusto>>, Dio è il
soggetto di questa proposizione, giusto è l’attributo; e la parola <<è>> segna l’azione del
mio spirito che afferma, cioè che lega insieme le due idee di Dio e di giusto come
convenienti l’una all’altra”. Locke, definendo la conoscenza come percezione del legame e
della concordanza o della discordanza e del contrasto fra le nostre idee esprime la stessa
tesi: “Tutto ciò che sappiamo o possiamo affermare nei riguardi di una qualunque idea sta
in questo, che essa è, o non è, uguale a qualche altra; che sempre coesiste o non coesiste
con qualche altra idea nello stesso soggetto; che ha questo o quel rapporto con qualche
altra idea o che ha un’esistenza reale o fuori dello spirito”. Il verbo essere, anche nel suo
uso esistenziale, non fa che esprimere relazioni: relazioni percepite dallo spirito, che
hanno nel soggetto conoscente, anche se non solo in esso, la loro realtà. Kant, affermando
che l’atto del giudizio, che è l’attività propria dell’intelletto, è la sintesi, esprime lo stesso
concetto: “Intendo per sintesi, nel senso più generale di questa parola, l’atto di unire
diverse rappresentazioni e comprendere la loro molteplicità in una sola conoscenza”.
L’idealismo muove su questo punto da Kant e attribuisce all’attività sintetica, al potere
sintetico dello spirito, alla sintesi a priori un significato enfatico e creativo: esse
continuano a mantenere il carattere soggettivo dell’attività sintetica che non può operare
se non tra idee o rappresentazioni, cioè tra elementi o stati del medesimo soggetto. Il
limite di questa impostazione sta nel fatto che un’asserzione qualsiasi mira a stabilire un
rapporto, non già tra due idee, o rappresentazioni, o concetti, ma tra gli oggetti cui essi
fanno riferimento. Quando si dice “Socrate è uomo” non si intende che sia uomo la
rappresentazione Socrate ma l’individuo reale cui il nome si riferisce. L’interpretazione
invece della relazione espressa dalla copula come oggettiva è stata presentata per la prima
volta da De Morgan (Logica formale, 1847, cap. 3) e poi fatta propria dal fondatore della
logica matematica, Boole. Per quest’ultimo la logica ha a che fare con due specie di
relazioni, le relazioni tra le cose e le relazioni tra fatti o tra proposizioni. La relazione
espressa dalla copula rimane la stessa in tutte le forme proposizionali non perché la sua
natura sia espressa nella proposizione ma perché è stabilita per convenzione. La copula
può allora esprimere una relazione qualsiasi. Essa è chiamata copula astratta. In generale
oggi si distinguono una copula di appartenenza che designa il rapporto tra un individuo e
una classe e una copula di inclusione che designa il rapporto tra una classe e un’altra
classe. La caratteristica fondamentale di tale concezione dell’essere predicativo è la sua
massima generalità: le altre interpretazioni della copula possono essere considerati come
casi speciali di relazione. In tale concezione della copula la proposizione è funzione: per
essa infatti il predicato diventa la funzione e il soggetto la variabile della funzione stessa.
Il significato esistenziale dell’essere a sua volta si distingue nell’essere come esistenza in generale
e nell’essere come esistenza privilegiata.
22
L’essere può significare in primo luogo l’esistenza in generale. Tale significato è
indeterminato ma specificabile o definibile in base a un criterio qualsiasi. Per questo
Aristotele dice che l’essere si dice in molti modi e che si può perfino dire che il non
essere non è.
In secondo luogo l’essere può significare l’esistenza privilegiata o primaria, cioè
l’esistenza nella sua modalità primaria e fondamentale, dalla quale dipendono tutte le
sue manifestazioni determinabili. L’essere si dice in molti modi, ma uno solo è il suo
significato primario e fondamentale. Questo è il punto di vista di Aristotele. Il significato
ultimo e fondamentale a cui devono essere ricondotti i molteplici significati dell’essere
costituisce il cosiddetto problema dell’essere, il problema del significato primario
dell’essere, di quel significato unico e semplice che si presume l’essere abbia ma che
rimane più o meno nascosto nella molteplicità dei suoi aspetti apparenti. La ricerca
metafisica, nella sua impostazione classica, si concentra su questo problema. Il
significato primario dell’essere è quello che esprime più chiaramente l’esistenzialità
dell’essere e che per gli altri significati, ad esso riconducibili, può essere fondamento o
principio. Platone, nel Sofista, ci parla della “battaglia dei giganti” nella quale, di fronte
ai giganti, o “figli della terra” che affermano che ogni realtà è corpo, stanno gli dei, che
affermano l’incorporeità dell’essere e lo riducono alle sue forme ideali. Un significato
dell’essere non è difatti sufficientemente stabilito dal carattere di corporeità o dalla
negazione di tale carattere: giacché un essere che si ritenga corporeo può avere gli
stessi caratteri formali di un essere che si ritenga incorporeo. È ben vero che i caratteri
formali dell’essere, quelli che si mettono in evidenza come soluzione del problema
dell’essere, cioè come determinazione del significato primario dell’essere, sono
costantemente ricavati dalla considerazione di una sfera particolare dell’essere, o
almeno di un gruppo di enti o di un ente che in qualche modo si privilegia e si pone
come esemplare. Ma è pur vero che in ogni caso si può ottenere una risposta al
problema dell’essere solo se tra i caratteri della sfera o del gruppo o dell’ente
considerato, si sceglie quello suscettibile di generalizzazione, cioè adatto ad essere
riferito anche alle altre sfere o gruppi o enti. In questo senso Platone obiettava ai
materialisti che essi devono dire che cosa c’è di comune fra le cose corporee e quelle
incorporee, posto che si dica che entrambe sono. Ma se nel problema dell’essere si
scorge la ricerca di un significato primario formale – cioè generalizzabile – dell’essere
stesso, si può dire che ogni soluzione del problema non fa che privilegiare, cioè
assumere come primaria e fondamentale, una modalità determinata dell’essere. Ora,
poiché le modalità secondo cui l’essere può essere enunciato o asserito sono tre, cioè
la necessità, la possibilità e l’assertorietà, tre pure sono in teoria le possibili soluzioni
del problema dell’essere. Essendo l’assertorietà riconducibile alla necessità, possiamo
riscontrare due soluzioni fondamentali. Per la prima di esse, l’essere primario è la
necessità. Tale interpretazione è prevalente nella metafisica classica. Per Parmenide
l’essere è e non può non essere: la necessità consiste nel non poter non essere, che
23
rispetto al tempo è eternità, rispetto al molteplice è unità, rispetto al divenire è
immutabilità. Anche Aristotele privilegia il significato della necessità. Il principio di
contraddizione, da lui posto a fondamento della filosofia prima, cioè della scienza
dell’essere in quanto essere, è da lui inteso come il principio che postula la necessità
dell’essere e che si realizza nella sostanza. Dice Aristotele: “Se la verità ha un
significato, necessariamente chi dice uomo dice animale bipede: giacché questo
significa uomo. Ma se questo è necessario, non è possibile che l’uomo non sia animale
bipede: la necessità significa infatti proprio questo, che è impossibile che l’essere non
sia”. L’aspetto per cui è necessario che un essere sia (che è il solo aspetto per cui
l’essere è oggetto di scienza giacché dell’essere accidentale non c’è scienza) è la
sostanza dell’essere. Dice sempre Aristotele: “Uno solo è il significato dell’essere e
questo è la sostanza di esso. Indicare la sostanza di una cosa non è altro che indicare
l’essere proprio di essa”. La sostanza è il senso primario e fondamentale dell’essere a
cui tutti gli altri suoi significati possono essere ricondotti. Ogni distinta o distinguibile
determinazione dell’essere è un aspetto o manifestazione della sostanza. Il significato
prevalente della necessità rimane oltre Aristotele, con gli attributi che esso reca con sé,
come immutabilità, eternità, unità, etc. Anche quando tali attributi sono riferiti non più
alla struttura formale dell’essere ma ad un ente privilegiato, e cioè non a tutte le
sostanze ma alla sostanza più alta che è Dio, la derivazione delle altre sostanze da
questa o la loro partecipazione ad essa è stata intesa come derivazione e
partecipazione della necessità e dei suoi attributi. La metafisica di S. Tommaso non è
una semplice riedizione della metafisica di Parmenide, perché il suo concetto
dell’essere è totalmente diverso da quello del filosofo di Elea. Mentre il primo ha un
concetto univoco e monistico (che esclude il divenire e la partecipazione), il secondo ha
un concetto analogico e pluralistico, che riconosce la creazione e la partecipazione. Per
Tommaso i significati dell’essere sono: l’essere come essenza della cosa, l’essere come
atto dell’essenza (il vivere è l’atto dell’anima), l’essere come copula. A proposito
dell’essere come atto dell’ente o dell’essenza egli distingue tra esse commune o esse
universale e esse absolutum o esse divinum. Il primo designa un minimo di realtà
indispensabile a tutte le cose per uscire dalle tenebre del nulla e appartenere all’ordine
degli enti. Il secondo termine esprime l’intensità massima di realtà, tale per cui vi è
racchiusa ogni perfezione. Egli precisa questo di fronte a chi obietta che non è corretto
definire Dio come essere e identificare la sua essenza con l’essere e ribadisce che c’è il
concetto di essere comune, il concetto più astratto di tutti, che è indifferente a tutte le
aggiunte perché suscettibile di qualsiasi aggiunta, e il concetto di essere specialissimo
che già include tutte le determinazioni e perciò esclude ogni aggiunta. Nella seconda
accezione di essere possiamo definire Dio come essere e identificare la sua essenza con
l’essere stesso: “L’espressione <<qualche cosa cui non si può aggiungere niente>> si può
intendere in due maniere. Prima maniera: qualche cosa che (positivamente) di sua
natura importi l’esclusione di aggiunte (o determinazioni) … Seconda maniera: qualche
24
cosa che non riceva aggiunte o determinazioni perché di suo non le include (né le
esclude) … Essere senza aggiunte nella prima maniera è proprio dell’essere divino;
invece essere senza aggiunte nella seconda maniera è proprio dell’essere comune” (S.
Th I, q.3, a.4, ad.1). Mentre l’esse commune è un’astrazione, la massima di tutte le
astrazioni, che riguarda quel minimo di realtà che è comune a tutte le cose, l’esse
divinum, invece, detto anche esse ipsum, è concretissimo e individualissimo, in quanto
abbraccia tutte le determinazioni: “Ciò che è comune a molte cose non è nulla fuori di
esse se non per astrazione … Quindi se Dio fosse l’essere comune, egli non avrebbe
alcuna esistenza reale, ma soltanto nell’intelletto (che lo pensa). Ora, abbiamo visto in
precedenza che Dio è una realtà che non esiste solo nella nostra mente, ma nella natura
delle cose; perciò non può essere l’essere comune di tutte le cose” (Contra Gentiles I,
c.26, n.241). “Dio è qualche cosa di determinato in se stesso, altrimenti non si
potrebbero escludere da lui le condizioni degli altri enti … Il nome di Dio <<Colui che è>>
designa l’essere assoluto … e significa una specie di pelago infinito della sostanza, come
se fosse senza confini” (I Sent., I, d.8, q.4, a.1; I, d.8, a.1, ad.4). Tommaso menziona poi
altre divisioni del concetto di essere, che coincidono quasi sempre con le divisioni
dell’ente: essere sostanziale ed essere accidentale, essere per essenza ed essere per
partecipazione, essere assoluto ed essere relativo, essere in atto ed essere in potenza,
essere infinito ed essere finito. Egli aggiunge anche una divisione in esse naturae ed
esse gratiae: “C’è un doppio essere: l’essere di natura e l’essere di grazia. La prima
creazione è avvenuta quando le creature sono state prodotte <<ex nihilo>> da Dio nel
loro <<esse naturae>>. La creatura era allora nuova ma è stata invecchiata dal peccato
… E’ stata perciò necessaria una nuova creazione per la quale le creature sarebbero
state prodotte nel loro <<esse gratiae>>, e anche questa è una creazione <<ex nihilo>>”
(In Ep. II ad Cor., 5,17, lect. 4). L’originalità di Tommaso è nella sua proposta del
concetto intensivo di essere: cioè l’essere è inteso non come perfezione comune, ma
come perfezione assoluta, non come perfezione minima cui si possono aggiungere
tutte le altre perfezioni, e neppure semplicemente come perfezione somma (come
Platone ha concepito la bellezza, Plotino l’unità, Dionigi l’Areopagita la bontà), bensì
come perfezione piena e intensissima che racchiude tutte le altre. Egli evidenzia così: a.
il primato dell’atto di essere, in quanto a differenza della forma che è atto ma non può
sussistere per conto proprio, l’atto di essere può sussistere per conto proprio perché è
atto per essenza: “L’atto primo è l’essere sussistente per conto proprio. Perciò ogni cosa
riceve l’ultimo completamento mediante la partecipazione all’essere. Quindi l’essere è il
completamento di ogni forma. Infatti la forma arriva alla completezza solo quando ha
l’essere, e ha l’essere solo quando è in atto. Sicché non esiste nessuna forma se non
mediate l’essere. Per questo affermo che l’essere sostanziale di ogni cosa non è un
accidente, ma è l’attualità di ogni forma esistente, tanto dotata quanto priva di
materia” (Quodlib., XII, q.5, a.1). Primo nell’ordine dell’attualità, l’essere diviene anche
la sorgente di tutto ciò che in qualche modo è in atto, e quindi la sorgente e la causa di
25
tutti gli enti, che partecipano all’atto di essere: “Tra le cose l’essere è la più perfetta
perché verso tutte sta in rapporto di atto. Niente infatti ha l’attualità se non in quanto
è; perciò l’essere stesso è l’attualità di tutte le cose, anche delle stesse forme” (I, q.4,
a.1, ad.3). b) pregnanza singolarissima dell’essere, ossia l’essere non è soltanto
perfezione somma ma è anche il ricettacolo di tutte le perfezioni, per cui tutte le
costellazioni di perfezioni che riempiono l’universo non sono altro che irradiazioni della
stessa e unica perfezione dell’essere: “Tra tutte le cose l’essere è la più perfetta. Ciò
risulta dal fatto che l’atto è sempre più perfetto della potenza. Ora qualsiasi forma
particolare si trova in atto solo se le si aggiunge l’essere. Infatti l’umanità o l’igneità
possono considerarsi come esistenti o nella potenza della materia o nella capacità
dell’agente, oppure nella mente: ma ciò che possiede l’essere diviene attualmente
esistente. Conseguentemente ciò che chiamo essere è l’attualità di ogni atto e quindi la
perfezione di qualsiasi perfezione” (De Pot., q.7, a.2, ad.9). E ancora: “Ogni nobiltà di
qualsiasi cosa appartiene a essa in forza dell’essere; poiché sarebbe nulla la nobiltà che
viene all’uomo dalla sapienza, se per essa non fosse effettivamente sapiente; e così
delle altre perfezioni. Pertanto il grado di nobiltà di una cosa corrisponde al grado di
nobiltà con cui possiede l’essere, poiché si dice che è più o meno nobile secondo che il
suo essere si restringe più o meno a qualche grado speciale di nobiltà. Quindi se vi è
qualcuno cui appartenga tutta la virtù dell’essere, non può mancargli nessuna nobiltà
che trovasi negli altri” (Contra Gentiles, I, c.28, n.260). E ancora: “L’essere è più nobile di
qualsiasi altro elemento che lo accompagni. Perciò, in assoluto, l’essere è più nobile
anche del conoscere, supposto che si possa pensare il conoscere facendo astrazione
dall’essere. E quindi ciò che è più perfetto nell’essere in sede assoluta, è più nobile di
qualsiasi altra cosa che sia più perfetta solamente in rapporto a qualche altro aspetto
che accompagna l’essere” (I Sent., d.17, q.1, a.2, ad 3). Pertanto l’essere è veramente la
perfezione assoluta e la radice di ogni altra perfezione. L’essere è ciò che vi è di più
perfetto nella realtà, anzi è il completamento di tutte le altre perfezioni che così non
diventano altro che aspetti dell’essere, ed è la sorgente di tutti gli enti, che non sono
altro che partecipazioni dell’essere. L’eccellenza dell’essere risulta proprio dal fatto
che, mentre nessun’altra perfezione e nessun ente è concepibile senza che partecipi
all’essere, questo si può pensare in assoluta autonomia, come a sé stante, come
sussistente, come solitario senza che per questo nulla perda della sua ricchezza, della
sua pienezza, della sua intensità c) l’intimità dell’essere, ossia l’essere è ciò che nelle
cose vi è di più intimo e di più profondo. L’essere penetra nelle cose fino a toccare le
zone più recondite, fino a raggiungere le fibre più segrete. Tutta la trama che
costituisce l’ente, tutto il suo sviluppo e la sua espansione provengono dall’essere e
vanno verso l’essere: “Tra tutte le cose l’essere è quella che più intimamente e
immediatamente conviene agli enti; perciò, avendo la materia l’essere in atto mediante
la forma, è necessario che la forma, dando l’essere alla materia, si unisca a essa più
intimamente di qualsiasi altro elemento” (De Anima, a.9). E ancora: “Pertanto nell’ente
26
l’elemento più intimo è l’essere; dopo l’essere (in ordine di intimità) viene la forma, per
la cui mediazione la cosa è in possesso dell’essere; infine viene la materia, che pur
costituendo il fondamento della cosa, si trova tuttavia più distante dall’essere della cosa
di qualsiasi altro elemento” (De natura accidentis, c.1, n.468). L’essere non solo
rappresenta la sorgente di tutti gli enti, ma costituisce anche il loro traguardo finale.
L’essere è il fine di ogni azione, ogni azione e ogni movimento sono ordinati in qualche
modo all’essere sia per la sua conservazione nella specie o nell’individuo, oppure
perché esso venga acquistato di nuovo. L’essere è l’ultimo atto verso cui tende qualsiasi
divenire; in quanto il divenire naturale tende verso ciò che naturalmente si desidera,
occorre che l’essere sia l’atto ultimo cui anela ogni cosa. Tommaso ripercorre anche le
tappe del percorso storico – filosofico che conduce alla scoperta dell’essere: 1) i
Presocratici furono piuttosto grossolani perché ritenevano che non esistessero altro
che corpi sensibili. Essi accettavano il moto solo sotto certi aspetti accidentali, come la
rarefazione o la condensazione, l’associazione o la dissociazione. Per tali trasformazioni
accidentali indicarono l’amicizia, la lite, l’intelligenza o altre cose del genere 2) Platone
e Aristotele distinsero razionalmente la forma sostanziale dalla materia che ritenevano
increata; e capirono che nei corpi avvengono delle trasformazioni di forme sostanziali.
Di tali trasformazioni stabilirono delle cause universali, cioè il circolo obliquo per
Aristotele e le Idee per Platone. Tuttavia entrambi hanno considerato l’ente sotto un
aspetto particolare, o in quanto appartenente a una determinata specie o in quanto
determinato dai suoi accidenti. Quindi costoro assegnarono alle cose solamente delle
cause efficienti particolari 3) la scoperta del principio unico e universale di tutte le
cose, l’essere, ed è la via percorsa da S. Tommaso: “Essendo necessario che esista un
principio primo semplicissimo, il suo modo di essere non va concepito come qualcosa
che partecipi dell’essere, bensì come quello dell’essere sussistente stesso. E poiché
l’essere sussistente non può essere che uno solo, ne consegue che tutte le altre cose che
traggono origine da esso, esistano come partecipanti all’essere. Occorre pertanto una
risoluzione comune per tutte le forme di divenire (accidentale, sostanziale, esistenziale),
dato che tutte implicano nel loro concetto due elementi, l’essenza e l’essere. E quindi
oltre al modo di divenire della materia col sopraggiungere della forma, occorre
riconoscere in precedenza un’altra origine delle cose, grazie alla quale l’essere viene
dato a tutto l’universo reale dall’ente primo, che si identifica con l’essere” (Sub. Sep.,
c.9, n.94). S. Agostino aveva notato che Dio ha scelto l’essere come suo nome proprio,
ma non ha sviluppato la densità semantica del concetto di essere. Tommaso ha
scrutato l’ente non solo sotto qualche aspetto particolare ma in quanto ente, cioè
partecipe della perfezione dell’essere. Egli ha così colto il valore singolarissimo
dell’essere, cioè che è solo l’essere a fare dell’ente qualcosa di reale, di attuale, che è
solo l’essere a conferire attualità, nobiltà, perfezione e dinamismo all’ente.
Avicenna esprime così il significato primario dell’essere come necessità: “se una cosa
non è necessaria in rapporto a se stessa, bisogna che sia possibile in rapporto a se
27
stessa, ma necessaria rispetto a una cosa diversa” (Met. II, 1,2). Ciò che è possibile ha
bisogno di un’altra cosa che lo faccia esistere in atto. Ciò che esiste in atto esiste
sempre necessariamente, anche se talvolta la necessità gli deriva da altro (cfr. gli enti
finiti).
Nel mondo moderno il concetto dell’essere come necessità trova le sue riaffermazioni
principali in Spinoza e in Hegel. Spinoza ha concepito l’essere di Dio nella necessità: egli
è necessariamente e opera secondo la necessità della propria natura, e l’essere delle
cose è necessario in quanto modi dell’unica sostanza, in quanto derivano
necessariamente dalla sostanza divina (Ethica I,8, scol. II). Ed Hegel ha espresso lo
stesso concetto nel suo aforisma famoso che è alla base della sua filosofia: “Ciò che è
razionale è reale; ciò che è reale è razionale”. La razionalità del reale è la sua necessità
per la quale esso, nelle sue determinazioni fondamentali, non può essere che quello
che è. Perciò Hegel dice che “intendere ciò che è è il compito della filosofia poiché ciò
che è, è la ragione” (Prefazione della Filosofia del diritto). Perciò, ancora, non c’è un
dover essere, un ideale, una perfezione che sia diversa dall’essere e nel cui nome si sia
autorizzati a criticare e a dar lezioni all’essere stesso: “Ciò che sta tra la ragione come
spirito autocosciente e la ragione come realtà presente, ciò che differenzia quella
ragione da questa e in questa non lascia trovare l’appagamento, è l’impaccio di qualche
astrazione, che non si è liberata e non si è fatta concetto” (ibid.). In altre parole solo per
una falsa astrazione si distingue ciò che dovrebbe essere da ciò che è, la razionalità
dall’essere reale: il che vuol dire che l’Essere reale è tutto quel che deve essere e che la
sua modalità, il suo senso primario, è questa necessità. D’altronde l’intera filosofia di
Hegel è diretta appunto a mostrare la necessità delle determinazioni dell’Essere: cioè a
mostrare come l’Essere è, nella sua realtà, tutto ciò che deve essere. La necessità
rimane il carattere primario dell’essere in concezioni filosofiche disparate. Quando
Fichte dice che l’essere e l’attività dell’Io sono la medesima cosa, egli riconosce come
carattere essenziale di questa attività la necessità con cui essa pone se stessa e il non
io. Che l’Essere si concepisca come Coscienza o come Materia, non fa differenza: le
determinazioni qualitative non influiscono sulla sua determinazione formale primaria.
L’Assoluto degli idealisti (Green, Bradley etc.) come la materia dei materialisti sono
entrambi Essere necessario. Necessaria è la Storia di cui parla Croce, come necessario è
l’Atto Puro di cui parla Gentile: “La necessità dell’essere coincide con la libertà dello
spirito” (Teoria generale, XII, & 20). Lo stesso Rosmini, che aveva posto l’idea
dell’essere intesa come “essere possibile”, a fondamento della conoscenza umana,
vede nella necessità e nell’universo i caratteri primari dell’Essere. E Husserl afferma con
molta energia la necessità di quell’essere che egli riconosce come primario, cioè
dell’essere come coscienza: “Alla tesi del mondo, che è accidentale, si contrappone la
tesi del mio puro io e del vivere dell’io, che è necessaria e indubitabile. Ogni data cosa,
anche se è presente in carne e ossa, può non essere; ma un’esperienza vissuta data in
28
carne ed ossa non può non essere. Questa è la legge essenziale che definisce questa
necessità e quella accidentalità” (Ideen, I, &46).
Un teorema fondamentale di questa concezione dell’essere necessario è
l’identificazione di essere e razionalità assunta da Hegel come principio della sua
filosofia. Talvolta questa identificazione è stata intesa come immanentismo
intendendosi con questa parola l’immanenza dell’essere nella coscienza. Per quanto
anche questa sia una tesi hegeliana, non ha tuttavia nulla a che fare con l’altra. Quella
fu espressa per la prima volta da Parmenide che, appunto in questo senso, identificò
l’essere con il pensare. Certamente in Parmenide questa tesi non ha nulla a che spartire
con l’immanentismo, in quanto la nozione di coscienza non era ancora comparsa: essa
esprimeva soltanto il carattere razionale della necessità ontologica e il fatto che il
pensiero è coestensivo all’essere. Aristotele confermava questo carattere affermando
che la determinazione fondamentale della sostanza è l’essenza necessaria, che è la
ragion d’essere della cosa. E Rosmini considerava l’Essere possibile come la forma
stessa della ragione. Il teorema dell’identificazione essere-razionalità esprime la
necessità dell’essere e postula un corrispondente concetto della ragione in generale.
Anche assumendo come significato primario dell’Essere l’effettualità (N. Hartmann),
quest’ultima è riconducibile alla necessità. Ciò che è realmente possibile è anche
realmente effettuale (essere così e non altrimenti), ciò che è realmente effettuale è
anche realmente necessario, ciò che è realmente possibile è anche realmente
necessario. Il primato dell’assertorietà non ha un significato diverso dal primato della
necessità.
La concezione dell’essere primario come possibilità è stata per la prima volta formulata da
Platone. Essa è presentata dal medesimo come rispondente a due esigenze fondamentali:
in primo luogo a quella che si renda conto perché si dice che sono sia le cose corporee sia
quelle incorporee (Sofista, 247d); e in secondo luogo che si tenga conto del fatto che
l’essere è o può essere conosciuto. La prima esigenza esclude che la materialità o
l’immaterialità possano entrare nella definizione dell’Essere. La seconda esclude che
possano entrare nella definizione dell’Essere determinazioni necessarie (che l’essere sia
necessariamente immobile o necessariamente in movimento …). Posto ciò Platone afferma
che l’essere non è altro che possibilità (dynamis) e che pertanto si deve dire che è qualsiasi
cosa si trovi in possesso di una qualsiasi possibilità o di fare o di subire, da parte di qualche
altra cosa, anche insignificante, una azione anche minima e anche per una sola volta (ibid.,
247e). Tale significato di possibilità non ha nulla a che fare con la potenza di Aristotele, che
è tale solo nei confronti dell’atto. Per Platone l’essere primario è possibilità, e possibilità
sono i rapporti reali tra gli enti: questi non si mescolano tutti insieme, né evitano
assolutamente di mescolarsi ma presentano determinate possibilità di rapporti. Ciò
avviene per le lettere dell’alfabeto e per i suoni, che alcuni possono mescolarsi e altri no,
così avviene anche per tutte le cose: sicché è compito della filosofia non già enunciare la
29
tesi universale della necessità o dell’impossibilità della comunicazione, ma studiare in
particolare quali sono le cose che possono unirsi tra loro e quali no. Questa concezione non
dà luogo ad una metafisica simmetrica e opposta a quella che interpreta l’essere come
necessità. Non dà luogo ad alcuna metafisica. Questo è il suo tratto caratteristico. Difatti,
se l’essere è possibilità, esso non ha determinazioni univoche necessitanti. Non è
necessario che esso sia uno e non molti, immutabile e non mutevole, immobile e non in
movimento, eterno e non temporale, etc. Di due determinazioni opposte o contraddittorie
non è necessario che una gli appartenga e l’altra no: entrambe possono appartenergli in
determinate ma diverse condizioni. Non è possibile, quindi, elencare, una volta per
sempre, le determinazioni univoche dell’essere. Platone aveva raggiunto questa
conclusione nel Parmenide: in questo dialogo si mostra che l’essere non è uno o molti, ma
uno e molti assieme, nel senso che può essere uno come può essere molti (144e); e che lo
stesso vale per le altre sue determinazioni eventuali. La sconcertante chiusura di questo
dialogo è che “l’uno, sia o non sia, esso stesso e le altre cose,rispetto a se stesso e tra loro,
tutte, e in tutto, sono e non sono, appaiono e non appaiono” (166c). queste parole
riconoscono la possibilità di determinazioni opposte dell’Essere ed escludono che esso
possa dirsi “uno” o “molti” o anche semplicemente essere in un senso unico e assoluto. Da
questo punto di vista la metafisica come elenco delle determinazioni univoche ed assolute
dell’essere è manifestamente un non senso. In questa concezione dell’essere come
possibilità sono impossibili formulazioni sistematiche corrispondenti a quelle della
metafisica classica. Questa concezione tende ad affacciarsi ogniqualvolta la determinazione
delle caratteristiche universali e necessarie dell’essere tende a cedere il posto alla ricerca
empirica: quest’ultima è ricerca di possibilità, non di determinazioni necessarie. Da questo
punto di vista possiamo dire che la tradizione empiristica della filosofia è l’erede e la
rappresentante maggiore di questa concezione dell’essere come possibilità. Una possibilità
può essere determinata unicamente sulla base dell’esperienza, cioè dell’osservazione dei
fatti, mai per via puramente razionale o a priori. Attribuire all’essere il significato della
possibilità significa aprire la via ad indagini specifiche, dirette a determinare, in ogni caso,
di quale possibilità si tratti. Gli Stoici vedevano il significato dell’essere nella possibilità di
agire o di subire un’azione e perciò chiamavano enti solamente i corpi. Tale principio li
indirizzò verso il materialismo, ma non costituì per essi la base di un empirismo coerente.
L’empirismo invece si affaccia tutte le volte che compare la negazione del teorema
fondamentale della riducibilità dell’essere a predicato. Sul finire della Scolastica Ockham
formulava la tesi che l’essere o il non essere si può attingere solo con una “conoscenza
intuitiva” che è la stessa esperienza; in tal modo affermava l’irriducibilità dell’essere a una
determinazione concettuale e il suo significato di possibilità. “Alla questione se la cosa
esista, si può rispondere solo quando si conosca se la cosa esiste: il che accade se si conosce
una proposizione nella quale l’essere esistenziale sia predicato del soggetto. Ora una tale
proposizione dubitabile … in nessun modo si può conoscere con evidenza, se la cosa
significata dal soggetto non si conosce intuitivamente ed in sé; per esempio, se essa non è
30
percepita da un senso particolare o se non è un intellegibile non sensibile che sia visto
dall’intelletto in modo analogo a quello in cui la facoltà visiva esterna vede l’oggetto
visibile. Sicché nessuno può conoscere con evidenza che il bianco è o può essere se non ha
visto un qualche oggetto bianco; e sebbene io possa credere a coloro che mi raccontano che
c’è il leone o il leopardo e così via, non conosco tuttavia con evidenza queste cose”, precisa
Ockam. In queste parole il senso primario dell’essere è posto nella possibilità
dell’esperienza. Egli riconosce la necessità solo alle proposizioni condizionali (se l’uomo è,
l’uomo è un animale ragionevole), mentre nega che una qualsiasi proposizione affermativa
possa essere necessaria. Tutte le proposizioni affermative sono contingenti, condizionate
all’esistenza empirica dell’ente di cui si predica qualcosa. L’essere non può essere ridotto a
un predicato, ma è una possibilità che può essere espressa solo da una proposizione
contingente. La modalità primaria dell’essere è la possibilità. L’empirismo classico del ‘600‘700 si attiene a questa stessa modalità. Locke contrappone la certezza delle proposizioni
universali, che però non riguardano la realtà, alla contingenza delle proposizioni particolari
che concernono l’esistenza: “Le proposizioni universali, della cui verità o falsità possiamo
avere una conoscenza certa, non riguardano l’esistenza; le affermazioni o negazioni
particolari, che non sarebbero certe se venissero rese generali, si riferiscono soltanto
all’esistenza, dichiarando esse soltanto l’accidentale unione o separazione delle idee in cose
esistenti, idee che, nella loro natura astratta, non hanno tra loro nessuna unione o
ripugnanza conosciuta” (Saggio sull’intelletto umano, IV, 9, 1). Pertanto, con la sola
eccezione dell’esistenza di Dio, conosciuta attraverso la dimostrazione, cioè attraverso il
rapporto che essa ha con altre esistenze, l’esistenza è conosciuta, secondo Locke, in modo
contingente e immediato, attraverso un rapporto diretto con l’oggetto: rapporto che è
intuizione nel caso dell’esistenza del proprio io, sensazione nel caso dell’esistenza delle
cose. Ciò esclude che l’esistenza sia un predicato o che comunque possa essere ridotta a
una determinazione concettuale: “Non essendovi nessuna connessione necessaria di
qualsiasi altra esistenza, tranne quella di Dio, con l’esistenza di alcun uomo particolare, ne
consegue che nessuno in particolare può conoscere l’esistenza di un altro essere se non
quando, operando questo su di lui, fa in modo di essere da lui percepito. Il fatto che si abbia
l’idea di una cosa nella nostra mente non dimostra l’esistenza di quella cosa più che il
ritratto di un uomo faccia testimonianza dell’essere egli nel mondo o che le visioni di un
sogno costituiscano di per sé una storia veridica” (ibid., IV, 11, 1). Questo concetto della
sensazione come organo della conoscenza di ciò che esiste non è altro che il vecchio
concetto stoico della rappresentazione catalettica: che è quella che deriva da un ente
sussistente ed è impressa e marcata da esso in modo da essere conforme con esso. La
dottrina equivale a definire l’essere delle cose come possibilità del manifestarsi di esse alla
percezione o della percezione medesima. La concezione dell’essere come possibilità viene
ripresa dalla filosofia tedesca del ‘700, in particolare da Wolff, che dice: “Ente è ciò che può
esistere e conseguentemente la cui esistenza non ripugna”. Ma poiché ciò che può esistere
è possibile, ciò che è possibile è l’ente. Ma che cosa significa l’essere possibile? Wolff
31
riprende un concetto che risale a Duns Scoto e si trova già formulato in Leibniz: “possibile è
ciò che non implica contraddizione, vale a dire ciò che non è impossibile” (Theodicea, II,
&224). Da questo punto di vista, la possibilità era definita come semplice assenza
dell’impossibilità, cioè come necessità negativa. La concezione dell’essere in termini di
possibilità era pertanto, in questa dottrina, una semplice apparenza. Kant ha, con molta
fermezza, visto che cosa si nascondeva dietro a questa apparenza: “Il gioco di prestigio per
cui la possibilità logica del concetto (che non si contraddice) si scambia con la possibilità
trascendentale delle cose (per cui al concetto corrisponde un oggetto) può gabbare e
contentare soltanto gli inesperti”. La possibilità reale è invece quella data in una intuizione
sensibile, cioè dall’esperienza attuale o possibile (Critica della Ragion Pura, Analitica dei
principi, cap. III). Per conseguenza “essere non è un predicato reale, cioè un concetto di
qualche cosa che si possa aggiungere al concetto di una cosa … Se io dico Dio è o c’è un Dio,
non affermo un predicato nuovo del concetto di Dio, ma soltanto il concetto in sé con tutti i
suoi predicati e l’oggetto in relazione col mio concetto. Entrambi devono avere esattamente
lo stesso contenuto e però nulla si può aggiungere di più al concetto che esprime
semplicemente la possibilità quando ne penso l’oggetto come dato con l’espressione <<Egli
è>>” (ibid., L’Ideale della Ragion Pura, sez. IV). Da questo punto di vista risulta chiaro il
carattere limitato e condizionale di ogni possibilità o essere, e pertanto il carattere fittizio o
fantastico di una “possibilità assoluta”, cioè di una possibilità che valga sotto ogni aspetto.
Nella filosofia contemporanea fanno riferimento a questa interpretazione dell’essere le
seguenti dottrine: a. le teorie che nella matematica, nella fisica e in generale nella scienza
definiscono l’esistenza come modo d’essere particolare, per esempio come assenza di
contraddizione o possibilità di costruzione o possibilità di verificazione. È così evidente la
modalità non necessaria dell’essere; b. le forme dell’empirismo che riconoscono l’essere
soltanto agli oggetti di esperienza possibile. La possibilità della sperimentazione e
dell’osservazione definisce in questo caso il significato dell’essere; c. le teorie filosofiche
che affermano il primato della possibilità. Tali teorie trovano un precedente nella filosofia
di Kierkegaard che per primo ha proposto una interpretazione dell’esistenza umana in
termini di possibilità. Dall’altro lato lo stesso punto di vista si può riconoscere in qualche
aspetto della fenomenologia di Husserl e nelle dottrine che si rifanno ad essa. Per quanto
quest’ultimo privilegi l’essere della coscienza e lo ritenga, a differenza della realtà delle
cose, necessario, l’analisi fenomenologica è per lui un’analisi di possibilità: per essa, come
ha detto Heidegger, la possibilità sta più in alto della realtà. Scrive Husserl: “Il fatto che una
natura, che un mondo della cultura e degli uomini, con le loro forme sociali etc, esistano per
me significa che le esperienze corrispondenti mi sono possibili, cioè che, indipendentemente
dalla mia esperienza reale di questi oggetti, io posso a ogni istante realizzarli e svilupparli in
un certo stile sintetico. Questo significa poi che altri modi di coscienza che corrispondono a
queste esperienze come atti di pensiero indistinto, etc., sono possibili per me e che la
possibilità di essere confermate o invalidate per mezzo di esperienza di un tipo che è
stabilito in anticipo, è inerente a questi atti” (Meditazioni Cartesiane, &37). Come risulta da
32
queste parole l’analisi fenomenologica è un’analisi in termini di possibilità, il che vuol dire:
la possibilità è il significato primario che essa attribuisce all’essere. Troviamo la stessa
concezione in Heidegger: “L’esserci, in quanto comprensione, progetta il suo essere in
possibilità” (Essere e Tempo, &32). In realtà tutte le analisi di Heidegger hanno per loro
tema le possibilità dell’Esserci le quali costituiscono il tema dell’Analitica esistenziale. Allo
stesso modo, per Jaspers, le possibilità oggettive costituiscono l’esistenza stessa
(Philosophia, &18). Sartre afferma che “il possibile è una struttura del per sé, cioè della
coscienza” (L’essere e il Nulla, p. 34). Per Sartre da questa struttura si distingue l’essere in
sé, cioè l’essere del fenomeno che non sarebbe né possibile né necessario, ma
semplicemente esistente. Senonché Sartre attribuisce a questo stesso essere il carattere
della contingenza e non ritiene possibile una analisi dell’essere in sé se non a partire
dall’essere per sé, cioè dalla coscienza: ritorna evidente il primato della possibilità.
La riflessione novecentesca sull’essere è stata condizionata dalla critica neopositivistica alla
metafisica (che ha operato da freno inibitorio) e dalla ripresa heideggeriana della Seinsfrage (la
questione dell’essere).
1. Se i neokantiani hanno scorto nell’idea di essere una nozione arcaica di natura pre-critica e
pre-trascendentale (cfr Cassirer), i neopositivisti (Schlik, Carnap, Neurath, Reichembach …)
l’hanno considerata uno dei tanti pseudoconcetti che popolano la metafisica (principio,
Dio, non-ente …), denunciandone gli equivochi linguistici e semantici, dovuti al fatto che la
maggior parte dei metafisici, fin dall’antichità, si è lasciata trarre in inganno dalla forma
verbale, cioè predicativa, della parola “essere”, così da formulare pseudo proposizioni
come “io sono” o “Dio è”.
2. All’opposto, Heidegger ha insistito invece, fin da Essere e Tempo (1927), sulla necessaria ed
esplicita riproposizione del problema dell’essere: “Abbiamo oggi una risposta alla
domanda intorno a ciò che propriamente intendiamo con la parola “essente”? Per nulla. È
dunque necessario riproporre il problema del senso dell’essere” (Essere e Tempo, p.50). Fra
le tesi di fondo che hanno ispirato la sua complessa e tortuosa meditazione evidenziamo:
a. l’essere non è l’ente o un ente (neppure l’ente supremo) ma ciò che entifica l’ente e lo rende
accessibile. L’essere è la radura, l’accadere di un’apertura o di una illuminazione all’interno
della quale gli enti diventano visibili. È la tesi della differenza ontologica
b. l’essere non è una statica presenza o una stabile struttura, ma uno storico accadere, cioè un
evento che si dà, di volta in volta, in impronte destinali diverse. È la teoria dell’Ereignis
(evento)
c. uomo ed essere sono strettamente congiunti, anzi coessenziali, poiché se l’uomo è in quanto
appartiene all’essere, quest’ultimo, a sua volta, è di per se stesso riferito all’uomo, poiché
soltanto presso il Dasein l’essere può essere come essere
33
d. l’evento con cui l’essere si consegna all’uomo ha la forma di un accadere linguistico che si
concretizza nel binomio chiamata – ascolto
e. l’essere è la storia dell’essere, in quanto esso non è mai qualcosa di diverso dal suo specifico
modo di darsi epocale: “C’è essere ogni volta soltanto in questa o in quella impronta destinale:
Physis, Logos, En, Idea, Energheia, sostanzialità, oggettività, soggettività, volontà, volontà di
potenza, volontà di volontà” (Identità e Differenza, p.32).
f. la storia dell’essere coincide con l’oblio dell’essere, ossia con la metafisica e la sua storia
g. la metafisica, intesa come quel pensiero che crede di parlare dell’essere mentre, in realtà,
sta parlando dell’ente, è, in quanto tale, il nichilismo autentico
h. l’oblio dell’essere, che raggiunge il suo culmine nella tecnica, non è dovuto a un errore o a
una dimenticanza umani, ma all’accadere dell’essere stesso, il cui presentarsi nell’ente
coincide con il suo assentarsi in se medesimo
i. il superamento della metafisica e del nichilismo non dipendono da una decisione dell’uomo,
ma dal destino dell’essere.
Dal pensiero di Heidegger evinciamo che quanto più la nozione di essere si impone, tanto più essa
si svela insoddisfacente. Come mostra la cancellatura cruciforme del termine Sein (che allude alla
necessità di difendersi dal modo di pensare metafisico) e il passaggio dalla questione dell’essere
(Seinsfrage, che è la maniera in cui la metafisica pone il problema dell’ente, scambiato per essere)
alla Frage nach dem Sein (che è invece il problema dell’essere come tale). Infatti “la parola Sein,
come ogni altra parola, attraversata con il particolare approccio etimologico di cui Heidegger si
serve, si rivela senza fondo o senza possibile fondamento: si frammenta e si inabissa in se stessa, in
qualche modo si cancella. Non è più afferrabile in un concetto, non si può indicarla, tenerla a
distanza. Così, nel secondo Heidegger, al vocabolario di Essere e Tempo, nuovo ma ancora
abbastanza interno alla tradizione filosofica, viene sostituendosi un vocabolario in abituale, fatto di
parole per dir così sperimentali e aperte, difficilmente traducibili” (P. A. Rovatti). In altri termini,
poiché l’essere si dà solo in un intreccio sfuggente di luce ed ombra, presenza e assenza, se non si
vuole correre il pericolo di entificare l’essere, di esso, secondo Heidegger, non si può più
discorrere per giudizi affermativi e definizioni concettuali rigorose, ma solo per negazioni,
analogie, costellazioni metaforiche ecc.
Dopo Heidegger diverse filosofie, nonostante l’interdizione neopositivistica, sono tornate a parlare
dell’essere. Ne ricordiamo alcune.
1. L’eterologia di Levinas. In Totalità e Infinito (1961) Levinas accusa il pensiero tradizionale
sull’essere di aver ingabbiato il molteplice e il diverso nell’ambito di una totalità unitaria
soffocatrice di ogni alterità e trascendenza: “La filosofia occidentale è stata per lo più
un’ontologia: una riduzione dell’Altro al Medesimo” (ibid., 41). Rifiutandosi di ridurre la
filosofia a egologia, cioè a un tautologico gioco del Medesimo (avente la sua figura
34
primordiale nell’Uno parmenideo), il nostro autore elabora una prospettiva volta a fare, di
essa, una enterologia, ossia un tipo di indagine che scorge, nel rapporto con l’Altro, la
struttura stessa della realtà: “L’Essere si produce come multiplo e come scisso in Medesimo
e in Altro. Questa è la sua struttura ultima. È società, e quindi tempo” (ibid., 277). In
Altrimenti che essere o al di là dell’essenza (1974), che raccoglie il frutto più maturo delle
sue ricerche, egli distingue tra l’Essere (o l’essenza) e l’altrimenti che essere (o al di là
dell’essenza). Il primo coincide con l’evento dell’essere e si identifica con l’interesse,
ovvero con quel conatus essendi che fa tutt’uno con la lotta infernale degli egoismi. Il
secondo coincide con il trascendimento dell’essere autocentrico e si identifica con
l’apertura all’alterità e alla fratellanza. L’altrimenti che essere si identifica a sua volta con
l’orizzonte di Dio e della religione. Alla vecchia ontologia del conflitto e della violenza, che
per fare dell’uomo il custode dell’essere lo ha distolto dalla responsabilità di farsi custode
dei propri fratelli, Levinas oppone l’etica come nuova filosofia prima. Ne segue che la
“metafisica” alla quale egli si appella è, in realtà, una “post-metafisica”, mentre l’ontologia
di cui egli parla coincide, di fatto, con la metafisica.
2. Gadamer si ispira ad Heidegger ma procede oltre il suo maestro. Egli afferma: “L’essere,
che può venir compreso, è linguaggio” (Verità e Metodo, 1960, 542). Egli non intende solo
evidenziare, tautologicamente, come all’uomo risulti intellegibile ciò che è strutturato
come linguaggio, ma intende dire, più profondamente, che l’Essere è linguaggio e come
tale può venire esperito e compreso, ossia che tutte le forme di vita sono linguaggio e
risultano comprensibili come linguaggio. Heidegger si era spinto fino ad affermare che il
linguaggio, in particolare il linguaggio dei poeti come Holderlin, è la casa dell’essere. Il
linguaggio, per Gadamer, è la sede del manifestarsi dell’Essere, il luogo e l’orizzonte entro il
quale soltanto possiamo incontrare noi stessi e le cose del mondo, senza alcuna possibilità
di trascenderne i confini, in quanto ogni presunto rifiuto di esso è destinato a muoversi
all’interno del linguaggio stesso. Questa identificazione dell’essere con il linguaggio, che in
altri autori tende a risolversi in una dissoluzione dell’Essere nel linguaggio (si pensi alla
fagocitazione del reale per opera del simbolico in Lacan o alla rivendicazione pantestualista
del primato della scrittura in Derrida) si configura, nel nostro autore, come la condizione
stessa dell’ermeneutica. Infatti, dire che l’essere è linguaggio significa dire che l’essere in
generale e l’essere umano in particolare – che sussiste concretamente sotto forma di
discorsi, libri, opere d’arte etc. – è interpretazione. Un’interpretazione che al pari del gioco
del mondo, risulta sempre aperta e mai conclusa. Luigi Pareyson con la sua ontologia
dell’inesauribile si inserisce su questa scia affermando: “La risposta alla domanda <<che
cosa è l’Essere?>> non consiste in una definizione oggettiva, esplicita e compiuta, ma in
un’interpretazione personale e continuamente approfondibile: il discorso sull’essere è
interpretativo, e come tale indiretto e interminabile” (Esistenza e persona, 20).
3. Gianni Vattimo sviluppa l’ermeneutica in senso nichilistico e approda a un pensiero debole
strutturato nei termini di una ontologia dell’attualità. Rifacendosi ad Heidegger, egli
35
contesta la concezione della realtà come struttura massiccia, stabile, eterna, facendosi
portavoce di una radicale storicizzazione ed eventualizzazione dell’Essere, basata sulla
persuasione secondo cui l’Essere è nient’altro che l’insieme delle aperture epocali in cui le
varie umanità storiche fanno esperienza del mondo: “Non si dà Essere se non come evento,
come accadere di orizzonti storico-linguistici entro cui gli enti ci divengono accessibili,
l’Essere è solo questo accadere e il suo tramandarsi”. Tale Essere, ermeneuticamente
prospettato come trasmissione, e invio, viene spogliato dei tratti forti (unità, assolutezza,
etc.) della tradizione metafisica e qualificato con i tratti deboli e postmoderni della
pluralità, della temporalità e della finitezza. Da ciò la vocazione tendenzialmente etica
dell’ontologia antifondazionalista di Vattimo, per il quale l’indebolimento dell’Essere si
configura come destino e come compito al tempo stesso: “L’Essere non è più forte, l’Essere
ha il destino di indebolirsi, e io, se voglio corrispondere a questo destino, devo fare molto,
moltissimo, per ridurre il dominio di quelle categorie metafisiche che sempre, di nuovo,
ritornano nella nostra cultura, nevroticamente, nostalgicamente”.
4. Emanuele Severino opta invece per un ritorno a Parmenide. Egli giudica contraddittorio il
divenire: il divenire non esiste e l’essere, ogni ente e tutto l’essere, è eterno, un perenne e
statico nunc che non conosce né passato né futuro: “la verità è l’apparire dell’eternità di
ogni ente – di ogni cosa, gesto, istante, sfumatura, situazione” (La tendenza fondamentale
del nostro tempo, 184). Ciò che l’Occidente nel suo nichilismo inconscio sente come
evidenza originaria – la realtà del divenire e il niente dell’ente – è solo follia estrema, ossia
il parto deleterio di una volontà di potenza che trova, nell’Apparato tecnologico, la sua
manifestazione conclusiva.
5. Nel ‘900 continuano a sussistere seguaci della metafisica classica, che concepiscono la
filosofia come scienza dell’essere in quanto essere (o dell’ente in quanto ente) e la
interpretano come un tipo di discorso argomentativo che si interroga sull’essere in
generale, per poi pervenire a quell’Esse Ipsum (Dio) che coincide con la causa trascendente
di ogni realtà.
6. Anche la filosofia analitica ultimamente si è soffermata sull’essere e sui suoi modi
(sostanza, accidente, etc.).
7. Luigi Pareyson elabora una ontologia della libertà in cui identifica l’essere con la libertà.
L’essere è liberta: è in quanto, di fronte alla possibilità del nulla, si è scelto ab aeterno in
maniera definitiva. L’essere è scelta libera di sé, è la forza con cui si è scelto. Tale ontologia
si misura, nella concezione di Dio, con il problema del negativo. Anche Dio è libertà: Egli è
in quanto, dall’eternità, di fronte alla possibilità radicale del nulla assoluto, Egli ha scelto di
essere. In tal senso l’origine del negativo risiede in Dio, o, più precisamente, in quel “Dio
prima di Dio” (per intendere la libertà originaria dell’Assoluto) che, nell’atto di voler essere,
istituisce inevitabilmente, insieme alla realtà del bene, la possibilità del male (sia pure a
titolo di possibilità non scelta e non voluta). Ciò non dovrebbe comportare alcune
36
demonizzazione o satanizzazione della divinità, perché tale possibilità è vinta in eterno.
Infatti, pur essendo il presupposto ontologico del male, Dio non ne è l’autore (poiché il
male si identifica proprio con ciò che egli non vuole e non fa). Il vero autore del negativo,
cioè l’essere che ridesta il male dormiente in Dio, facendolo passare dalla possibilità alla
realtà, è l’uomo: “La negazione, nata già vinta dalla libertà divina, solo dalla libertà umana
può trarre nuova vita e vigore nuovo” (Filosofia della libertà, 26).
37
Dio
Due sono le qualifiche fondamentali che i filosofi, e non solo, hanno attribuito e attribuiscono a
Dio:
quella di Causa, per la quale Dio è principio che rende possibile il mondo o l’essere in
generale.
quella di Bene, per la quale Dio è la fonte o il garante di tutto ciò che di eccellente c’è nel
mondo, e soprattutto nel mondo umano.
Si tratta di qualifiche assai generiche che acquistano un senso preciso solo nell’ambito delle
particolari filosofie che le adoperano.
In secondo luogo la divinità può essere concepita come partecipabile da più enti, sia come
propria di un ente solo e poiché, d’altro canto, si possono ammettere varie vie di accesso
dell’uomo a Dio, si possono assumere altri due modi per distinguere le concezioni di Dio, e cioè
rispetto al rapporto con se stesso, e cioè con la sua divinità,
rispetto agli accessi possibili dell’uomo a Dio.
Questi quattro modi di distinguere le concezioni di Dio storicamente emerse nella storia della
filosofia occidentale ci permettono di seguire con sufficiente fedeltà le articolazioni storiche del
concetto di Dio, e i punti su cui si basano anche le maggiori contrapposizioni polemiche.
1. Dio e il mondo.
L’essere causa è l’aspetto fondamentale di Dio: le forme di ateismo storicamente configuratesi
negano proprio la causalità come qualifica di Dio. È anche vero che tale causalità divina è stata
intesa almeno in tre modi diversi.
a. Dio come creatore dell’ordine del mondo. Questa concezione è probabilmente la più
antica nella storia della filosofia; il primo ad enunciarla fu Anassagora che considerò
l’Intelletto (il nous) come la divinità che ordina il mondo. Il carattere creatore dell’Intelletto
si riconosce dal fatto che questo autore negava l’esistenza di un destino necessitante; ciò
rimanda alla considerazione dell’Intelletto stesso come causa libera, quindi creatrice. Ma
non si tratta in questo caso di una creazione dal nulla. Similmente possiamo dire della
dottrina del Demiurgo platonico, l’Artefice del mondo, la cui potenza creatrice è però
limitata dal modello che egli imita e che è il mondo delle Idee, o sostanze, o verità eterne, e
dalla materia (chora) che preesiste alla sua attività plasmatrice e anche resiste ad essa per
il suo carattere di necessità. Le caratteristiche della divinità platonica sono, oltre la potenza
superiore ma non illimitata, l’intelligenza e la bontà. Quest’ultima fa della creazione un atto
38
libero, che ha in vista la moltiplicazione del bene: “Ma se questo mondo è bello e l’Artefice
è buono, è evidente che Egli ha guardato all’esemplare eterno; e se, invece, l’Artefice non è
tale, ciò che non è neppure permesso a qualcuno di dire, ha guardato all’esemplare
generato. Ma è evidente a tutti che Egli guardò all’esemplare eterno: infatti l’universo è la
più bella delle cose che sono state generate, e l’Artefice è la migliore delle cause. Se,
pertanto, l’Universo è stato generato così, fu realizzato dall’Artefice guardando a ciò che si
comprende con la ragione e con l’intelligenza e che è sempre allo stesso modo … Egli
(l’Artefice) era buono e in un buono non nasce mai nessuna invidia per nessuna cosa.
Essendo dunque lungi dall’invidia, Egli volle che tutte le cose diventassero il più possibile
simili a Lui. E chi ammettesse questo principio della generazione del mondo come
principale, accettandolo da uomini saggi, l’ammetterebbe assai rettamente. Infatti Dio,
volendo che tutte le cose fossero buone, e che nulla, nella misura del possibile, fosse
cattivo, prendendo quanto era visibile e che non stava in quiete, ma si muoveva
confusamente e disordinatamente, lo portò dal disordine all’ordine, giudicando questo
totalmente migliore di quello. Infatti non è lecito a chi è ottimo di fare se non ciò che è
bellissimo” (Timeo 29 a.e-30 a). Negli ultimi dialoghi Platone insiste sul concetto di Dio
come Primo Motore e Guida di tutte le cose che si muovono: “Ma il volgere sempre se
stesso da sé, forse, non è possibile a nessuno, tranne a chi è la guida di tutte le cose che a
loro volta si muovono; ma a costui non è lecito muovere ora in un modo e poi di nuovo in
modo contrario” (Politico 269 e). Da tale concetto muove anche Aristotele per la sua
teologia. Costui definisce Dio come il primo motore al quale necessariamente ricondurre la
catena dei movimenti e la prima causa alla quale ricondurre le serie causali compresa
quella delle cause finali. Dio in quanto causa finale è il creatore dell’ordine del mondo:
“Tutte le cose sono ordinate l’una rispetto all’altra, ma non tutte allo stesso modo: i pesci,
gli uccelli, le piante hanno ordine diverso. Tuttavia nessuna cosa sta rispetto a un’altra
come se nulla avesse a che fare con l’altra, ma tutte sono coordinate a un unico essere.
Questo è, per esempio, ciò che accade in una casa dove gli uomini liberi non possono fare
ciò che a loro piace ma tutto o, almeno, la maggior parte delle cose, avviene secondo un
ordine; mentre gli schiavi e gli animali solo per poco contribuiscono al benessere comune e
molto fanno per caso” (Metafisica, XII, 10, 1075 a 12). E ancora, il bene di un esercito
consiste “insieme nel suo ordine e nel suo comandante, ma specialmente in quest’ultimo:
giacché egli non è il risultato dell’ordine, ma piuttosto l’ordine dipende da lui” (ibid., 1075 a
13). Dio è quindi il comandante di un esercito o il capo di una casa: colui che produce e
mantiene l’ordine che costituisce la bontà dell’insieme. Aristotele ripropone la stessa
dottrina platonica al di fuori del mito teogonico. Egli chiarisce e determina maggiormente
alcune caratteristiche che Platone aveva già riconosciuto alla divinità. Prima di tutto, Dio
non solo è il primo motore, ma è motore immobile, eterno e separato dalle cose sensibili,
senza grandezza, indivisibile e senza parti, dotato della potenza necessaria a muovere il
mondo per un tempo infinito: “Da quanto abbiamo detto risulta quindi con evidenza che
esiste una sostanza eterna e immobile e separata dagli esseri sensibili, e noi abbiamo anche
39
dimostrato che questa sostanza non può avere grandezza alcuna, ma è priva di parti e
indivisibile (essa, infatti, produce il movimento per tutta l’infinità del tempo, mentre
nessuna cosa che sia finita possiede un potere infinito, e perciò, dato che ogni grandezza
non potrebbe essere se non o infinita o finita, questa sostanza non potrebbe possedere una
grandezza finita; ma d’altra parte non potrebbe avere neppure una grandezza infinita,
poiché non esiste assolutamente alcuna grandezza che sia infinita); ma noi abbiamo anche
dimostrato che una tale sostanza non è soggetta a passione e ad alterazione, giacché tutti
gli altri movimenti sono posteriori a quello locale” (ibid., XII, 7, 1073 a). Platone aveva detto
che Dio è intelletto, Aristotele precisa che è pensiero di pensiero, intelletto che è sempre in
atto e che per oggetto la realtà più alta ed eccellente, cioè se stesso: “E’ questo, dunque, il
principio da cui dipendono il cielo e la natura. Ed esso è una vita simile a quella che, per
breve tempo, è per noi la migliore. Esso è, invero, eternamente in questo stato (cosa
impossibile per noi!), poiché il suo atto è anche piacere (e per questo motivo il ridestarsi, il
provare una sensazione, il pensare sono atti molto piacevoli, e in grazia di questi atti anche
speranze e ricordi arrecano piacere). E il pensiero, nella sua essenza, ha per oggetto ciò che,
nella propria essenza, è ottimo, e quanto più esso è autenticamente se stesso, tanto più ha
come suo oggetto ciò che è ottimo nel modo più autentico. L’intelletto pensa se stesso per
partecipazione dell’intellegibile, giacché esso stesso diventa intellegibile venendo a
contatto col suo oggetto, e pensandolo, di modo che intelletto ed intellegibile vengono ad
identificarsi … l’atto della contemplazione è cosa piacevole e buona al massimo grado … Se,
pertanto, Dio è sempre in quello stato di beatitudine in cui veniamo a trovarci solo
qualvolta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine di Dio è ancora maggiore, essa è
oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio è, appunto, in tale stato! Ed è sua
proprietà la vita, perché l’atto dell’intelletto è vita, ed egli è appunto quest’atto, e l’atto
divino, nella sua essenza, è vita ottima ed eterna. Noi affermiamo, allora, che Dio è un
essere vivente, sicché a Dio appartengono vita e durata continua ed eterna: tutto questo,
appunto, è Dio!” (ibid., XII, 7, 1072 b). Nell’uomo, l’intelletto può sonnecchiare e avere per
oggetto cose inferiori a se stesso: l’intelletto divino è al di sopra di queste eventualità.
Aristotele, nell’interpretazione del divenire, distingue tra potenza e atto, ribadendo il
primato dell’atto. La potenza non è ancora atto, ed è grazie e in vista dell’atto. Dio è allora
atto puro, cioè attualità assolutamente priva di materia o di potenzialità: “Il primo motore,
dunque, è un essere necessariamente esistente e, in quanto la sua esistenza è necessaria, si
identifica col bene e, sotto questo profilo, è principio … Esso è, invero, eternamente in
questo stato (cosa impossibile per noi!), poiché il suo atto è anche piacere … c’è qualcosa
che produce il movimento senza essere, esso stesso, mosso ed essendo in atto, non è
possibile che questo qualcosa sia mai altrimenti da come è” (ibid., XII, 7, 1072 b). Aristotele
fonda così in maniera più rigorosa e filosofica l’incorporeità dell’Intelligenza divina. Egli ha
poi chiarito il concetto della beatitudine divina: “Dio prova sempre un piacere semplice ed
unico perché l’attività (cui il piacere si accompagna) non consiste soltanto nel movimento
ma anche nell’immobilità e il piacere si trova piuttosto nel riposo che nel movimento” (Etica
40
Nicomachea, VII, 14, 1154 b 26). Infine, in quanto perfetto, Dio è autosufficiente; a
differenza dell’uomo, non ha bisogno di amici: “La causa ne è che a noi il bene viene da
altro ma Egli è a se stesso il suo bene” (Etica Eudemia, VII, 12, 1245 b 17). La struttura
sostanziale dell’universo è, per Aristotele come per Platone, al di là dei limiti della
creazione divina. Aristotele, rispetto a Platone, abbandona l’immagine della divinità che
assume come modello della sua azione creatrice il mondo delle sostanze eterne ma la
struttura sostanziale dell’universo è, per entrambi, eterna, cioè insuscettibile di principio e
di fine. Solo la cosa individuale composta di materia e forma è suscettibile di nascita e
morte, mentre la sostanza, che è forma o ragion d’essere, o quella che è materia, non
nasce né perisce. Dio è eterno perché è sostanza, e ogni sostanza è eterna: l’unica
differenza tra Dio e le sostanze finite è nella perfezione della vita, non nella realtà o
nell’essere, perché nessuna sostanza è più o meno sostanza di un’altra. Dio è solamente
causa finale del mondo, è principio del movimento solo in quanto è oggetto di attrazione
per tutta la realtà. Egli non ha nessun rapporto di tipo transitivo con le altre sostanze. A
tale nozione di Dio come creatore dell’ordine del mondo si possono ricondurre le
concezioni di Dio che nel mondo moderno tendono a riconoscere una limitazione dei poteri
della divinità e ad escludere da essa i caratteri dell’assoluto e dell’infinito. Ritroviamo ciò
nella concezione di Dio di alcuni autori illuministi, ed in Voltaire: “Ogni opera che ci mostra
i mezzi ed un fine, rivela un artefice: dunque questo universo composto di mezzi ognuno dei
quali ha il suo fine, rivela un artefice potentissimo ed intelligentissimo” (Dictionnaire
philosophique, art. Dieu). Ma la qualifica di artefice è poi anche la sola che, per costui, si
può attribuire a Dio. Egli si rifiuta di ammettere un qualsiasi intervento di Dio nell’uomo e
nel mondo morale. Dio è soltanto l’autore dell’ordine del mondo; il bene e il male non sono
comandi divini, ma attributi di ciò che è utile o dannoso alla società. Nell’800 J. Stuart Mill
sosteneva che l’esperienza del mondo conduce all’idea di un creatore del mondo inteso
come un Dio finito, limitato nella sua potenza dalla materia e dalla forma che ha adoperato
(Three essays on Religion, 1874). Anche Peirce, più recentemente, ha riproposto un
concetto analogo di Dio: egli non lo considera in senso proprio onnisciente e onnipotente,
egli non lo definisce come l’Assoluto, ma come la parte di un sistema la cui funzione non è
dissimile da quella delle altre parti più piccole e perciò dalla nostra. Dio ha un ambiente,
esiste nel tempo e opera nella storia come noi stessi. Egli perciò sfugge alla statica
intemporalità del perfetto assoluto, all’estraneità rispetto a tutto ciò che è umano (A
Pluralistic Universe, 1909). Rispetto a Platone ed Aristotele, a Dio vengono attribuiti da
questi autori anglosassoni maggiori caratteri umani; rimane l’idea di fondo di una potenza
divina limitata da certe strutture sostanziali.
b. Dio come natura del mondo. Sotto questa dicitura possiamo raggruppare tutte le
concezioni di Dio che ammettono un suo intrinseco, sostanziale ed essenziale rapporto col
mondo, sicché il mondo sia inteso come la continuazione o il prolungamento della vita di
Dio. Tracce di questa idea sono presenti anche nella concezione di cui sopra: Platone
chiama il mondo “il Dio generato” (Timeo, 34 b)e Aristotele riporta con approvazione la
41
credenza comune che i corpi celesti siano dèi e che il divino abbraccia l’intera natura
(Metafisica, XII, 8, 1074 b 2). Ma questa connessione diventa più stretta ed essenziale nella
concezione designata col nome di panteismo. In essa il legame che avvince il mondo a Dio
e Dio al mondo è necessario: Dio non sarebbe tale senza il mondo così come il mondo non
sarebbe tale senza Dio. Ciò non implica la perfetta identità e coincidenza tra Dio e mondo;
o meglio tale identità o coincidenza si verifica solo nel senso che va dal mondo a Dio, non in
quello che va da Dio al mondo. In altri termini, il mondo non è tutto Dio: esso è incluso
nella vita divina come suo elemento necessario ma non la esaurisce. L’esigenza affacciata
dal cosiddetto panenteismo è in realtà propria di tutte le forme di panteismo storico. La
caratteristica del panteismo si può esprimere dicendo che esso non stabilisce alcuna
differenza tra la causalità divina e la causalità naturale. Nell’interno del panteismo si
possono distinguere tre modi principali di connettere il mondo e Dio: a. il mondo è
emanazione di Dio b. il mondo è la manifestazione o la rivelazione di Dio c. il mondo è la
realizzazione di Dio. Primo e secondo modo, come secondo e terzo, spesso sono connessi
mentre non si trovano insieme il primo e il terzo. Il panteismo ha raggiunto per la prima
volta una forma compiuta nella dottrina degli Stoici. Diogene Laerzio ci riferisce che
costoro chiamavano mondo lo stesso Dio che è la qualità propria di ogni sostanza,
immortale e ingenerato, creatore dell’ordine universale, e che secondo i cicli dei tempi
consuma in sé tutta la realtà e di nuovo da sé la genera. Dio pervade tutto l’universo e
prende vari nomi a seconda delle materie diverse in cui penetra. Tali autori ritenevano
pure che Dio è corpo perché solo il corpo può essere causa, cioè agire: tale dottrina ritorna
in Tertulliano e in Hobbes. Il riconoscimento della causalità di Dio nel mondo rende in
questo caso Dio stesso partecipe della condizione generale della causalità mondana, cioè
della corporeità. I precedenti di questa dottrina potrebbero essere rinvenuti nella dottrina
del Logos o Fuoco divino che pervade tutto di Eraclito e nella identificazione operata da
Senofonte di Colofone di Dio con l’Uno e col Tutto. Ma la più matura espressione del
panteismo si deve scorgere nel neoplatonismo, in particolare in Plotino. Egli elabora, sia
pure in forma immaginifica, quella nozione di emanazione che doveva diventare
indispensabile al panteismo, permettendo di intendere il modo in cui da Dio deriva un
mondo che non si stacca da Dio. In virtù di questa nozione, il rapporto tra Dio e il mondo
viene così chiarito: a. il mondo deriva da Dio necessariamente, come necessariamente
emana il profumo dal corpo odoroso e la luce dalla sua sorgente b. per questo legame di
necessità, il mondo è parte o aspetto di Dio sebbene sia una parte diminuita o inferiore di
lui, giacché il profumo o la luce che si allontanano dalla propria sorgente sono inferiori alla
sorgente stessa c. Dio è superiore al mondo per quanto sia identico con esso nella misura
in cui possiede ordine, perfezione e bellezza. Questi sono i caratteri che Plotino attribuisce
a Dio. Dio è l’Uno in confronto dei molti che da lui emanano: “Egli è la potenza di tutto; è al
di sopra della vita e causa della vita; l’attività della vita, che è tutto, non è la realtà prima,
ma deriva dall’Uno come da una sorgente” (Enneadi, III, 8, 10). Dall’Uno emana in primo
luogo l’Intelligenza nella quale risiedono le strutture sostanziali dell’essere e che perciò
42
Plotino identifica con l’essere stesso; e in secondo luogo l’Anima, che pervade e governa il
mondo (ibid., V, 1, 6). Il mondo, emanato dall’Intelligenza e governato dall’Anima, è copia
perfetta della divinità emanatrice ed è eterno e incorruttibile come il modello (ibid., V, 8,
12). Il mondo è un dio beato che basta a se stesso (ibid., III, 5, 5). La nozione
dell’emanazione, per la quale l’essere generato esiste necessariamente insieme col suo
generatore e non è separato da lui se non dalla propria alterità, fa del mondo una parte
integrante di Dio e di Dio, come origine unica del processo emanativo, qualcosa di
superiore al mondo e inesprimibile nei termini del mondo stesso. Dio, propriamente, non è
né l’essere o la sostanza, né la vita né l’intelligenza, perché è superiore a queste cose: esse,
tuttavia, come sue emanazioni, fanno parte di lui. Proclo conia le parole apposite: “Dio è
super-sostanziale, super-vitale e super-intelligente” (Elementatio Thelogica, 115). Esse
ritornano agli inizi della Scolastica cristiana in Scoto Eriugena per il quale Dio non è
sostanza ma super-sostanza, non è verità ma super-verità etc. Ma, nel contempo, il mondo
è Dio stesso, o meglio, come precisa questo autore, manifestazione di Dio, o teofania. Il
processo della teofania va da Dio al Verbo, dal Verbo al mondo, e dal mondo ritorna a Dio.
Dio è sopra tutte le cose e in tutte; egli solo è la sostanza di tutte le cose perché egli solo è;
e pur essendo tutto in tutte, non cessa di essere tutto al di fuori di tutte. Il tratto
caratteristico della divinità, in queste concezioni, è la sua supersostanzialità, il suo essere al
di sopra dell’essere e di ogni specie di realtà. Dio, già in Plotino, appare accessibile solo ad
uno slancio eccezionale o soprannaturale, cioè all’estasi mistica (Enneadi VI, 7, 35). Dio non
può essere oggetto di una scienza positiva, che ne determini la natura, ma solo di una
teologia negativa la quale aiuti a comprendere determinando ciò che Egli non è. Il concetto
di teologia negativa, presente in Proclo (Theologia platonica II, 10-11) viene diffuso nella
filosofia cristiana dallo Pseudo Dionigi Areopagita con la sua Theologia mistica. Il concetto
di Dio come super-sostanza emanante, l’ascesa mistica culminante con l’estasi e la
teologia negativa, sono i tre aspetti fondamentali del concetto panteistico di Dio come
comprendente in sé il mondo e identico con la sua ultima natura. Una qualsiasi di queste
determinazioni, quando fa la sua apparizione storica, in genere coimplica anche le altre
due. Teologia negativa e misticismo furono le caratteristiche del panteismo di Amalrico di
Bène e di Davide di Dinant nel sec. XII, che hanno definito Dio l’essenza o forma delle cose
(il primo) o la materia delle cose stesse. E gli stessi tratti compaiono nella mistica di
Maestro Eckhart nel sec. XIV, per il quale Dio è un’Essenza super-essenziale e un Nulla
super-essente, sicché di Lui non si può dir nulla tranne che è una quiete deserta, mentre al
tempo stesso bisogna riconoscerlo come la vera essenza delle creature: “Se Dio per un
momento si distogliesse da loro, esse si ridurrebbero al nulla” (Deutsche Mystiker, ed.
Pfeiffer, II, p 136). Giordano Bruno a sua volta utilizza la tesi neo-platonica e mistica della
trascendenza e inconoscibilità di Dio, per limitarsi a considerare Dio come natura. Come
natura, Dio è la causa e il principio del mondo: causa nel senso di determinare le cose che
costituiscono il mondo, rimanendo distinto da esse; principio nel senso di entrare a
costituire l’essere stesso delle cose naturali (De la causa, II). In ogni caso, non si distingue
43
dalla natura: “La natura o è Dio stesso o è la virtù divina che si manifesta nelle cose stesse”
(Summa termino rum metaphisicorum, in Opp. Lat. IV, 101). E quasi contemporaneamente
Jakob Boehme considerava Dio da un lato come “un nulla eterno” (Mysterium magnum,
I,2), dall’altro come la radice stessa del mondo naturale, che non è stato creato dal nulla
ma da Dio stesso e non è altro che la rivelazione o l’esplicazione dell’essenza divina (De
tribus principiis, 7, 23). Non hanno un significato molto diverso le formule con cui Schelling
nel sec. XIX ha espresso il concetto di Dio dal punto di vista della sua filosofia della natura.
Dio è l’unità, l’identità o l’indifferenza dello spirito e della natura, della libertà e della
necessità, della consapevolezza e dell’inconscio (Werke, I, III, pp. 578 ss.). Questa identità o
indifferenza non è altro che l’identità panteistica tra il mondo e Dio: “Dio e l’universo sono
una sola cosa o sono aspetti distinti di un’unica e stessa cosa. Dio e l’universo considerato
dal lato dell’identità ed è il tutto perché è tutto il reale, fuori di cui non c’è nulla” (ibid., I, IV,
128). La concezione schellinghiana implica la nozione che il mondo non solo è la rivelazione
di Dio, ma anche la sua realizzazione. Questo concetto è di origine spinoziana, deriva dal
razionalismo geometrizzante di Spinoza. Dio si identifica non già col mondo, ma con
l’ordine del mondo, e precisamente con l’ordine razionale, geometricamente esplicabile,
del mondo stesso: “Nulla c’è di contingente nelle cose, ma tutto è dalla necessità della
natura divina determinato ad esistere e ad operare in un certo modo” (Ethica I, 29). Per
quanto si possa distinguere tra natura naturante che è Dio e natura naturata che sono le
cose derivanti da Dio, in realtà la natura non è che l’ordine necessario delle cose e
quest’ordine è Dio: “Comunque concepiamo la natura o sotto l’attributo dell’estensione o
sotto l’attributo del pensiero o sotto qualsiasi altro, sempre troveremo un solo e medesimo
ordine, una sola e medesima connessione di cause, cioè di una sola e medesima realtà”
(ibid. II, 7, scol.). Dio non è dunque per Spinoza l’unità ineffabile dalla quale scaturiscono le
cose per emanazione, né la Causa creatrice dell’ordine, ma l’ordine stesso nella sua
necessità. La derivazione necessaria delle cose del mondo l’una dall’altra, secondo l’ideale
della razionalità geometrica, è la stessa realizzazione di Dio. Il Romanticismo fa suo ed
esplicita questo assunto spinoziano, per il quale nella necessità razionale del mondo si
rivela e simultaneamente si realizza Dio. Hegel insiste sulla necessità della rivelazione di
Dio: “Quando nella religione si piglia sul serio la parola <<Dio>>, anche da lui, che è il
contenuto e il principio della religione, può e deve cominciare la determinazione del
pensiero; e se a Dio si nega la Rivelazione non resterebbe altro contenuto da attribuirgli che
l’invidia. Ma se la parola Spirito deve avere un senso, essa significa la rivelazione di sé”
(Enciclopedia dello Spirito, & 564). Se Dio non si rivelasse, sarebbe un Dio invidioso. Tale
rivelazione è anche la realizzazione di Dio come l’autocoscienza di sé che egli raggiunge
nell’uomo: “Dio è Dio solo in quanto sa se stesso; il suo saper se stesso è inoltre la sua
autocoscienza nell’uomo e il sapere che l’uomo ha di Dio che progredisce fino al sapersi
dell’uomo in Dio” (ibid.). Da questo punto di vista la distinzione della “Essenza eterna” dalla
sua manifestazione è uno stadio provvisorio, che viene superato dal ritorno della
manifestazione all’essenza eterna e dalla realizzazione della loro unità. Hegel distingue tre
44
momenti del concetto di Dio: “in ciascuno dei quali il contenuto assoluto si rappresenta: a)
come contenuto eterno che resta in possesso di sé nella sua manifestazione; b) come
distinzione dell’essenza eterna dalla sua manifestazione la quale, mediante questa
distinzione, diventa il mondo della apparenza in cui entra il contenuto; c) come infinito
ritorno e conciliazione del mondo estraniato con l’essenza eterna, come il tornare di questa
dall’apparizione all’unità della sua pienezza” (ibid., &566). La realtà piena di Dio consiste
nel riconoscersi realizzato nel mondo e attraverso il mondo. Tale pensiero contrassegna
anche il panteismo contemporaneo. Bergson identifica Dio con lo sforzo creatore della vita
(Le due fonti della religione e della morale, 235), cioè col movimento per cui la vita procede
al di là delle sue forme statiche e definite, verso la creazione di nuove forme più perfette.
Dall’amore mistico per l’umanità, che è la punta avanzata dello slancio vitale, egli si
attende il rinnovamento della medesima e la ripresa della funzione essenziale
dell’universo, che è una “macchina per fare gli dei” (ibid., 234). Tale espressione è molto
significativa in quanto esprime bene la credenza che attende dal mondo la realizzazione di
Dio. In altri filosofi ritornano le vecchie formule come quella del mondo come “corpo di
Dio”, ma ritornano col nuovo significato che solo incorporandosi Dio si realizza come tale.
Dice Alexander: “Dio è l’intero mondo in quanto possiede la qualità della deità. Di questo
essere, l’intero mondo è il corpo, la deità è lo spirito. Ma il possessore della Deità non è
reale ma ideale: come un esistente reale Dio è il mondo infinito nel suo nisus verso la deità,
o, per adottare una frase di Leibniz, in quanto è gravido della deità” (Space, Time and Deity,
II, 535). È dunque al mondo che spetta partorire Dio; o fuor di metafora è sulla via
dell’evoluzione naturale che apparirà ad un certo punto quella qualità della deità che
troverà sostanza in un certo numero di esseri. Questo stesso rapporto tra Dio e il mondo è
stato espresso da Whitehead con le seguenti antitesi: “E’ vero che Dio è permanente e il
mondo fluente, sia che il mondo è permanente e Dio è fluente. E’ vero che Dio è uno e il
mondo molti, sia che il mondo è uno e Dio molti. È vero sia che il mondo, in confronto di
Dio, è eminentemente reale, sia che Dio, in confronto col mondo, è eminentemente reale. È
vero sia che il mondo è immanente in Dio, sia che Dio è immanente nel mondo. È vero sia
che Dio trascende il mondo, sia che il mondo trascende Dio. È vero sia che Dio crea il
mondo, sia che il mondo crea Dio” (Process and Reality, 527-528). Queste antitesi
significano che, se Dio attende dal mondo la sua realizzazione, il mondo attende da Dio la
sua unità: “Il mondo è la molteplicità delle attualità finite che cercano una perfetta unità.
Né Dio né il mondo raggiungono un completamento statico. Entrambi sono nella morsa
dell’ultimo fondamento metafisico, l’avanzamento creativo verso il nuovo. Ognuno di essi,
sia Dio che il mondo, è lo strumento della novità dell’altro” (ibid., 529). Anche per il vecchio
panteismo il mondo, come emanazione o rivelazione di Dio, condizionava in qualche modo
la realtà stessa di Dio: “Dio non c’era prima di creare tutte le cose”, afferma Scoto Eriugena
(De divisione naturae, I, 72), difendendo la coeternità del mondo e di Dio. E difatti che cosa
sarebbe un corpo odoroso che non emanasse profumo o una luce che non spandesse
all’intorno i suoi raggi? La nozione stessa di emanazione fa del mondo, e in generale di
45
tutto ciò che viene emanato da Dio, parte integrante di Dio e condizione della sua realtà.
Tuttavia solo nel mondo moderno, e a cominciare dal Romanticismo (che ha fatto tesoro
della lezione di Spinoza) si afferma esplicitamente che Dio è, in qualche modo, la creazione
del mondo. Talvolta, come in Hegel, Dio è già reale nel mondo, in tutte le determinazioni
del mondo, perché è lo spirito stesso, cioè la razionalità autocosciente, che si realizza in
esso come tale. Talaltra, Dio è il termine del processo evolutivo, la fase nella quale tale
processo raggiunge l’unità o la perfezione. In ogni caso, il panteismo contemporaneo ha
invertito il punto di vista tradizionale: non è Dio che dà corpo, sostanza o realtà al mondo,
ma è il mondo che dà corpo, sostanza o realtà a Dio.
c. Dio come creatore. Per la concezione di Dio come causa creante, Dio non è soltanto il
primo Motore e la causa prima del divenire e dell’ordine del mondo, ma anche l’autore
della struttura sostanziale del mondo stesso. Tale struttura, costituita dalle sostanze, forme
o ragioni ultime delle cose, non è coeterna con Lui (come invece nella concezione classica)
ma da Lui stesso prodotta. Ed è prodotta non per via di un processo necessario ma con una
causalità libera per la quale il mondo si stacca da Dio nell’atto stesso di derivare da Lui il
suo essere. Dall’altro lato, in questa concezione, Dio non è più il super-essere, ma l’essere
stesso da cui ogni altro essere deriva. Le caratteristiche della divinità derivano, in questa
concezione, dalla nozione di creazione, nel suo significato proprio e specifico. Questo
significato è stato elaborato solo attraverso il tentativo di distinguerlo polemicamente
dall’ordinazione e dall’emanazione. Le parole che in ebraico, greco e latino significano
creare hanno, come nelle lingue moderne, un senso generico per il quale possono riferirsi
indifferentemente all’opera di un artefice come a quella di un creatore; solo attraverso
l’elaborazione filosofica la nozione arriva perciò a configurarsi nelle sue caratteristiche.
Essa inizia con Filone di Alessandria (sec. I d.C.), il quale attraverso l’interpretazione
allegorica dell’A.T., definì il concetto di Dio talvolta in polemica con le dottrine elaborate
dalla filosofia greca, talvolta in dipendenza da esse. Per primo egli affermò che Dio ha
tratto il mondo “dal non essere all’essere” (De vita Mosis, III,8) e che egli è stato non solo il
Demiurgo, ma anche veramente il fondatore del mondo stesso (De somniis, I,13). Ma
neppure egli intese troppo rigorosamente questo concetto, giacché a volte assimila la
creazione all’imposizione dell’ordine ad una materia disordinata ed amorfa (L’erede delle
cose divine, 32). Più chiaramente la nozione di Dio creatore si viene determinando nella
polemica cristiana contro gli Gnostici: Ireneo, per esempio, afferma che Dio non ha bisogno
di intermediari per la creazione (Adversus haereses II, 1, 1). A sua volta Lattanzio negava
che Dio avesse bisogno, nella creazione, di una materia preesistente (Istituzioni divine, II,9).
Contro l’emanatismo Origene affermava che Dio non può essere considerato né come il
tutto né come una parte del tutto perché il suo essere è omogeneo, assoluto e indivisibile
(Contra Celsum, I,23) ed è superiore alla stessa sostanza giacché non ne partecipa: si
partecipa di Dio ma Dio non partecipa di nulla (De Principiis VI,64). Inoltre l’unicità di Dio,
sulla quale i filosofi cristiani insistono, sia per la polemica contro il politeismo pagano, sia
per eliminare dalla nozione di Trinità ogni appiglio ad una molteplicità di divinità, li porta
46
ad accentuare il distacco di Dio dal mondo: giacché se Dio, in qualunque maniera,
partecipasse del mondo, parteciperebbe altresì della molteplicità e della diversità che lo
costituiscono. Per lo stesso motivo viene accentuata l’eternità, cioè la immutabilità di Dio,
di fronte alla mutevolezza e temporalità del mondo. Per Agostino Dio, in quanto è l’Essere,
è il fondamento di tutto ciò che è, il creatore di tutto. Difatti la mutevolezza del mondo che
ci sta intorno dimostra che esso non è l’essere: ha dovuto dunque essere creato da un
Essere eterno (Confessioni, XI,4). Prima della creazione non c’era tempo e non c’era
neppure un “prima”: non ha senso perciò domandarsi che cosa Dio facesse “allora”.
L’eternità è al di sopra di ogni tempo e in Dio nulla è il passato e nulla è il futuro. Il tempo è
stato creato insieme con il mondo (ibid., XI,13). Nel sec. XI Anselmo riassumeva nel
Monologhion i risultati di un lavoro già secolare, chiarendo i caratteri della creazione dal
nulla come “un salto dal nulla a qualche cosa” (n.8) e insistendo sull’impossibilità di
ammettere che la materia o altra realtà qualsiasi preesista all’opera della creazione divina.
Le cose sono solo per partecipazione all’essere; il che vuol dire che derivano la loro
esistenza unicamente da Dio (n.7). Egli ammetteva nella mente divina il modello o l’idea
delle cose prodotte: ma anch’esso, pur precedendo la creazione del mondo, è stato creato
da Dio (n.11). Contravveniva invece ad uno dei caratteri di Dio creatore (la libertà di creare)
la dottrina di Abelardo secondo la quale la creazione è un atto necessario di Dio, cioè un
atto che non può non aver luogo dato che Dio non può non volere il bene e che la
creazione è un bene (Theologia cristiana, V, P.L., 178, col. 1325). La caratteristica
fondamentale della dottrina della causa creante è che Dio, per essa, è l’essere da cui
dipende ogni altro essere. Ma solo attraverso il neoplatonismo arabo si fece strada il
corollario implicito in questa concezione e si raggiunse la determinazione di un attributo
che doveva poi, nei limiti di essa, rimanere primo e fondamentale; la necessità dell’essere
divino. Difatti, se le cose del mondo traggono il loro essere da Dio, Dio invece non lo trae
che da se stesso: cioè Dio è l’essere per natura o per essenza sua, mentre le cose hanno
l’essere per partecipazione o per derivazione da Dio. Si viene così a determinare una
scissione nell’essere: da un lato l’essere di Dio, ossia l’essere per sé, l’essere necessario,
dall’altro l’essere delle creature, ossia l’essere per partecipazione, l’essere possibile. La
distinzione fu introdotta da Al Farabi (sec. IX); da Avicenna (sec. XI) fu fatta prevalere nella
Scolastica araba e cristiana, per la quale divenne uno dei principi fondamentali. Avicenna
interpreta il rapporto tra necessità e possibilità nei termini del rapporto aristotelico tra
forma e materia. La forma, come esistenza in atto, è necessità, la materia è possibilità. Ciò
che non è necessario di per sé è necessariamente composto di potenza e di atto, quindi
non è semplice. Tale è l’essere delle creature. Invece l’essere che è necessario di per sé è
assolutamente semplice, privo di possibilità e di materia; è Dio (Metaphisica II, 1,3). La
distinzione tra essere necessario ed essere possibile e la definizione di Dio come essere
necessario venivano introdotte nella Scolastica cristiana da Guglielmo di Alvernia (De
Trinitate, 7); e furono il fondamento della teologia di Alberto Magno e di Tommaso
d’Aquino. Quest’ultimo affronta la questione di Dio secondo questo ordine: in primo luogo,
47
studia ciò che di Dio è già accessibile alla ragione, senza il soccorso della Rivelazione:
esistenza, natura, attributi e operazioni di Dio; successivamente passa a studiare quanto di
Dio è diventato manifesto attraverso la Rivelazione. Ecco come egli stesso schematizza la
trattazione della seconda questione della Summa: “L’indagine intorno a Dio comprenderà
tre parti. Considereremo: primo, le questioni spettanti la divina essenza; secondo, quelle
riguardanti la distinzione delle persone; terzo, quelle che riguardano la derivazione delle
creature da Dio. Intorno all’essenza divina poi dobbiamo considerare: primo, se Dio esista;
secondo, come Egli sia o, meglio, come non sia; terzo, studiare le cose spettanti alla sua
operazione, cioè la scienza, la volontà e la potenza” (Summa I, q. 2, prol.). Alcuni interpreti
distinguono quindi nel nostro autore una teologia naturale da una teologia dogmatica. Pur
vivendo in un clima di profonda religiosità, Tommaso non ignora che, quanto meno in
passato, ci sono stati degli atei e che la posizione dell’ateismo ha dalla sua qualche
argomento che merita di essere preso in considerazione. Tutte le obiezioni contro
l’esistenza di Dio si possono ridurre alle seguenti: il fenomeno del male, la possibilità di
spiegare tutto con la scienza e con la libertà umana. Scrive Tommaso: “Sembra che Dio non
esista. Infatti: 1) nel nome Dio si intende affermare un bene infinito. Dunque se Dio
esistesse non dovrebbe esserci più il male. Viceversa nel mondo c’è il male. Dunque, Dio non
esiste. 2) Ciò che può essere compiuto da un ristretto numero di cause, non si vede perché
debba compiersi da cause più numerose. Ora tutti i fenomeni che avvengono nel mondo
potrebbero essere prodotti da altre cause, nella supposizione che Dio non esistesse: poiché
quelli naturali si riportano, come a loro principio, alla natura, quelli volontari alla ragione o
volontà umana. Nessuna necessità, quindi, della esistenza di Dio” (I, q. 2, a. 3, obb. 1-2).
Come suo stile, il nostro autore non replica immediatamente alle obiezioni, ma prima si
preoccupa di far vedere che, nonostante tutte le difficoltà degli atei, ci sono argomenti
molto solidi e decisivi a favore dell’esistenza di Dio. Così riesce a liquidare, quanto meno
indirettamente, le loro obiezioni. Tra gli innumerevoli argomenti che già la filosofia greca e
successivamente la filosofia cristiana aveva imbastito per dimostrare l’esistenza di Dio, il
Dottore angelico ricorda il celebre argomento con cui S. Anselmo aveva preteso di
dimostrare l’esistenza di Dio muovendo dalla sua essenza, intesa come “ciò di cui non si
può pensare nulla di più grande” (id quo maius cogitari nequit). Egli disapprova l’argomento
anselmiano e fa vedere che la via che pretende di discendere dall’essenza divina fino
all’esistenza non è percorribile, per il semplice fatto che prima di provare l’esistenza di Dio
la nostra mente non può avere che una definizione nominale e non reale di Dio; e in
secondo luogo perché anche supposto che noi avessimo un concetto reale di Dio, si
tratterebbe sempre di un concetto essenzialmente negativo, perché Dio non è tanto colui
di cui non si può pensare nulla di maggiore, quanto semplicemente colui che non si può
pensare affatto: “Dico dunque che questa proposizione Dio esiste in se stessa è di per sé
evidente, perché il predicato si identifica col soggetto; Dio, infatti, come si vedrà in seguito,
è il suo stesso essere: ma siccome noi ignoriamo l’essenza di Dio, per noi non è evidente, ma
necessita di essere dimostrata per mezzo di quelle cose che sono a noi più note, ancorché di
48
per sé siano meno evidenti, cioè mediante gli effetti” (I, q. 2, a. 1). Perciò, visto che non
abbiamo nessuna intuizione di Dio, né della sua essenza, né della sua esistenza, per
provare la sua esistenza occorre procedere a posteriori, prendendo in esame i fenomeni
che ci circondano (compreso l’uomo) e verificare se questi, per essere spiegati
esaustivamente, non esigano l’esistenza di Dio. Nella Summa Tommaso allarga fino a
cinque gli argomenti per dimostrare l’esistenza di Dio, che nelle altre opere non superano
mai il numero di quattro. L’esistenza di Dio può essere provata partendo da cinque
fenomeni noti a noi tutti: il divenire o movimento, le cause seconde, la contingenza, i gradi
di perfezione, l’ordine dell’universo. Nessuno di questi fenomeni è originario e incausato,
bensì ognuno è originato e causato, manifestando una dipendenza e una carenza
ontologica. Di qui sorge la necessità di ricercare la loro causa. La ricerca, che non vuole
essere un regressus ad infinitum, si conclude sempre necessariamente con l’approdo a Dio.
La struttura delle cinque vie è uniforme e semplice. Essa consiste di quattro momenti: 1. Si
attira l’attenzione su un determinato fenomeno di contingenza 2. Si evidenzia il carattere
relativo, dipendente, contingente, causato di ogni singolo fenomeno 3. Si mostra che la
realtà effettiva, attuale, di un fenomeno contingente non si può spiegare facendo
intervenire una serie infinita di fenomeni contingenti 4. Si conclude dicendo che l’unica
spiegazione plausibile del contingente è Dio, motore immobile, causa incausata, essere
necessario, sommamente perfetto, intelligenza ordinatrice suprema. Passiamo alle cinque
vie.
Prima via: “La prima e la più evidente si desume dal moto. È certo infatti e consta ai sensi,
che alcune cose mutano in questo mondo. Ora tutto ciò che muta o diviene è mutato da
altri … Se dunque ciò da cui deriva il mutamento muta a sua volta, sarà necessario che
anch’esso sia mutato da un terzo e questo da un quarto, ma in ciò non si può procedere
all’infinito … Dunque è necessario arrivare a una prima ragione del mutamento che non
muti affatto: e questo è ciò che tutti gli uomini intendono per Dio” (I, q. 2, a. 3).
L’argomento parte dal moto e, constatando che ciò che si muove è mosso da altri, giunge al
Motore immobile. Il moto di cui qui si parla non è il moto locale bensì il moto sostanziale
ed entitativo, cioè il divenire.
Seconda via: “Vediamo nelle cose che cadono sotto i sensi un ordine di cause efficienti;
tuttavia non si vede né è possibile che una cosa sia causa efficiente di se stessa poiché, se
così fosse, una cosa dovrebbe essere prima di se stessa, il che è impossibile. Ma non è
possibile che nelle cause efficienti si proceda all’infinito … Dunque è necessario porre una
prima causa efficiente che tutti chiamano Dio” (I, q. 2, a. 3). L’argomento parte dalle cause
seconde e, constatando che ogni causa seconda, strumentale, è a sua volta causata,
approda a Dio come Causa prima incausata. La serie di cause seconde cui qui ci si riferisce
non è una serie di cause dipendenti tra loro accidentalmente, che può essere più o meno
lunga e persino indefinita, bensì di cause collegate necessariamente in vista dell’effetto
(per es. la falce, il manico, la mano, il corpo per la falciatura del fieno … ).
49
Terza via: “Tra le cose (di questo mondo) noi ne troviamo di quelle che possono essere e
non essere; infatti alcune cose nascono e finiscono, il che vuole dire che possono essere e
non essere. Ora, è impossibile che tutte le cose di tale natura siano sempre state, perché
ciò che può non essere un tempo non esisteva. Se dunque tutte le cose (esistenti in natura
sono tali che) possono non esistere, in un dato momento niente ci fu nella realtà. Ma se
questo è vero, anche ora non esisterebbe niente, perché ciò che non esiste non comincia a
esistere se non per qualche cosa che è. Dunque, se non c’era ente alcuno, è impossibile che
qualche cosa cominciasse ad esistere, e così anche ora non ci sarebbe niente, il che è
evidentemente falso. Dunque non tutti gli enti sono contingenti, ma nella realtà occorre che
ci sia qualcosa di necessario … Dunque bisogna concludere all’esistenza di un essere che sia
di per se stesso necessario, e non tragga da altri la propria necessità, ma sia causa di
necessità agli altri. E questo tutti dicono Dio” (ibid., a. 3). Si parte dalla contingenza e,
percorrendo la via del possibile, si constata che il possibile riceve l’essere dal necessario e
si giunge a Dio come essere necessario. Abbiamo a che fare con la necessità nell’ordine
dell’essere, e non in quello dell’essenza.
Quarta via: nelle cose si riscontrano diversi gradi di perfezione: le cose sono più o meno
buone, più o meno vere, più o meno belle … “Ma il grado maggiore o minore si attribuisce
alle diverse cose secondo che si accostano di più o di meno ad alcunché di sommo e di
assoluto … Vi è dunque un qualche cosa che è massimamente vero, massimamente buono,
massimamente bello, e di conseguenza qualche cosa che è il supremo ente … E questo
chiamiamo Dio” (ibid.). Si parte dalla constatazione di diversi gradi di perfezione e si
percorre la via secondo la quale la perfezione è partecipata dal Massimo. Il riferimento è
alle perfezioni semplici, non alle perfezioni miste.
Quinta via: “Noi osserviamo che alcune cose prive di conoscenza, cioè i corpi fisici, tuttavia
operano per un fine, come risulta dal fatto che esse operano sempre o quasi sempre allo
stesso modo per conseguire la perfezione; donde appare che non a caso, ma per una
predisposizione, raggiungono il loro fine. Ora, ciò che è privo di intelligenza non tende al
fine se non perché è diretto da un essere conoscitivo e intelligente, dal quale tutte le cose
naturali sono ordinate ad un fine: e quest’essere chiamiamo Dio” (ibid.). Si parte dalla
constatazione di un mondo ordinato e si procede avendo presente che l’ordine richiede
sempre intelligenza per approdare all’Intelligenza Suprema ordinatrice. Qui il riferimento
non va solo agli esseri materiali (acqua, aria) ma anche agli esseri viventi privi di
intelligenza (i fiori, le piante) nelle cui operazioni il finalismo è quanto mai palese.
Le cinque vie non sono legate a nessuna teoria cosmologica particolare: i fenomeni che
sono presi in considerazione e i principi che sono invocati non sono legati né a Platone, né
ad Aristotele, né a Tolomeo etc., ma appartengono all’esperienza ordinaria, e i principi
della causalità e dell’assurdità di un regressus ad infinitum non sono legati a nessuna
scienza e a nessuna visione cosmologica, ma sono principi primi della metafisica. Il
50
principio di causalità non va inteso come mera successione e concatenazione necessaria di
eventi, come accade nella filosofia e nella scienza moderna con Hume, che non a caso li
confuta, e con Kant. Esso è comunicazione della propria perfezione da parte della causa
all’effetto, è comunicazione di essere e non mera successione (è la comunicazione di realtà
che avviene dal melo alla mela, dalla mucca al vitellino, e non la successione che si verifica
dal lampo al tuono). Tale principio ha valore assoluto come il principio di non
contraddizione e funge da validissimo supporto alle argomentazioni di Tommaso. Il
pensiero moderno e contemporaneo ha cercato di esplorare anche altre vie che partono
dall’uomo, anziché dal cosmo (cfr. Pascal).
Dopo aver dimostrato l’esistenza di Dio percorrendo le cinque vie, il Dottore Angelico
replica agli argomenti degli atei. 1. Costoro direbbero: “Se uno dei due contrari è infinito,
l’altro sarebbe totalmente distrutto. Ma col termine Dio si intende un bene infinito; dunque,
se Dio ci fosse non ci sarebbe il male; e invece il male nel mondo c’è; dunque Dio non esiste”
(I, q. 2, a. 3, ob. 1). A tale argomento che fa forza sull’esistenza del male risponde così:
“Come dice S. Agostino: <<Dio, essendo sommamente buono, non permetterebbe in nessun
modo che nelle sue opere ci fosse del male, se non fosse tanto potente e tanto buono, da
saper trarre il bene anche dal male>>. Sicché appartiene all’infinità bontà di Dio il
permettere che vi siano dei mali per trarne dei beni” (I, q. 2, a. 3, ad 1). Sembra una replica
troppo secca e troppo comoda. In queste parole egli ha ridotto la sua critica all’osso e
affronta più analiticamente la questione della natura e delle cause del male nella Quaestio
disputata de malo. Nel mondo classico l’unico filosofo che si è posto seriamente il
problema del male è Plotino, definendolo come privazione o mancanza di bene. Per lui la
materia è la causa della carenza di bene. S. Agostino ha fatto suo il concetto plotiniano del
male come privatio boni ma si rifiutò di identificare il male con la materia perché tra
Plotino e Agostino c’è appunto la teologia della creazione. Anche la materia è creata da Dio
e, in quanto tale, è necessariamente e intrinsecamente buona, perché Dio, Sommo Bene,
non può creare che cose buone. Approfondendo la natura del male, Agostino rileva che
esso non può essere una sostanza, perché l’essere, per quanto in piccolo grado, in virtù
della creazione, è un bene in sé. Il male consiste essenzialmente nel disordine, ossia
nell’allontanamento da Dio, nella aversio a Deo e nella conversio ad creaturas:
allontanamento dal Sommo Bene per attaccarsi a beni inferiori. Di tale disordine causa
esclusiva è il libero arbitrio. A monte di ogni male sta il disordine morale della volontà: dal
disordine morale discende anche il disordine materiale, cioè il male fisico. Tommaso ha
vissuto con meno angoscia il mistero dell’esistenza del male, ma ha scrutato attentamente
tale problema. Il male si può presentare sotto due forme: come mancanza di un elemento
naturale (fisico) o come mancanza di un ordinamento al fine proprio, liberamente voluta da
una creatura razionale. Nel secondo caso abbiamo la colpa (malum culpae), nel primo
abbiamo la pena o male fisico (malum penae) che nelle sue forme come la corruzione, il
dolore, la morte è conseguenza della colpa o del peccato. Per lui il male non può essere
preso necessariamente come argomento contro l’esistenza di Dio come pretendono gli
51
atei. Oltre alla risposta che abbiamo incontrato il nostro autore aggiunge che è
conveniente che esistano gradi inferiori di creature, nei quali le perfezioni create sono
contenute più limitatamente, solo per un periodo di tempo o con la possibilità di non
giungere alla loro debita pienezza. È errato pensare che Dio dovrebbe aver fatto solo i gradi
più perfetti di essere, dando per es. ai mortali l’immortalità, agli imperfetti la perfezione, ai
mobili l’immobilità: “Nulla vincola la Provvidenza di Dio a concedere a un ente particolare
tanta bontà quanta a tutto l’universo, o a dare una cosa situata in un grado inferiore la
perfezione propria di un grado superiore” (De divinis nominibus, VIII, lect. 4). E aggiunge:
“Dio e la natura, così come qualunque causa agente, fanno il meglio nell’insieme, non il
meglio in ogni parte, ma in ordine al tutto … Ed è meglio e più perfetto che in tutta
l’universalità delle creature siano contenuti degli enti che possano declinare dal bene, e che
perciò a volte lo facciano. Questo, Dio non lo impedisce, poiché non è proprio della
Provvidenza distruggere la natura, bensì conservarla” (I, q. 48, a. 2, ad 3). Un universo
ideale senza corruzioni naturali, con corpi immortali, nel quale gli animali non morissero né
lottassero tra loro, nel quale non ci fossero convulsioni naturali, sarebbe teoricamente
possibile, ma non sarebbe effettivamente l’universo migliore, perché includerebbe,
assolutamente parlando, meno perfezioni di un universo che contempli anche la presenza
di imperfezioni. Infatti, la presenza di esseri corruttibili, oltre a quella dei puri spiriti,
conferisce all’universo maggiore ricchezza di contenuto di quella che avrebbe se
esistessero solo angeli: “Un universo nel quale non ci fosse alcun male non conterrebbe
tanta bontà come questo universo, poiché non ci sarebbero in esso tante nature buone
come in questo, in cui esistono alcune nature buone alle quali non aderisce il male, e altre
alle quali aderisce. Ed è meglio che esistano entrambe le creature piuttosto che una sola di
esse” (I Sent., d. 44, q. 1, a. 2, ad 5). In linea con Agostino egli afferma che “se si sottraesse
il male a qualche parte dell’universo, la sua perfezione sminuirebbe notevolmente, poiché la
sua bellezza sorge dall’ordinata congiunzione dei beni e dei mali, dato che i mali
provengono da certi beni deficienti e tuttavia da essi procedono altri beni per la
provvidenza divina, così come l’interposizione di silenzi rende più piacevole la melodia”
(Contra Gentiles, III, c. 71). Il bene e il male fanno parte del piano universale voluto da Dio:
ciò non implica che Dio stesso sia causa del male. Infatti una causa può dare origine al male
o perché è causa a sua volta difettosa, o perché dispone di una materia difettosa, o perché
è capace di trarre da un difetto parziale un bene maggiore. Dio, ossia la causa prima, si può
dire causa del male soltanto nel terzo senso, perché nel suo operare non presuppone
nessuna materia né ha in sé difetto alcuno, poiché è pienezza dell’essere. È poi prerogativa
della libertà finita essere fallibile: proprio in quanto finita può decadere dall’orizzonte del
bene assoluto e infinito e può lasciarsi catturare e rinchiudere dentro i confini di beni finiti
(del proprio essere o di altre cose). Il male morale consiste proprio nel preferire beni
particolari al Bene universale. Neppure il male morale, per quanto grave, scompagina e
infrange l’ordine universale. Infatti, nell’atto moralmente cattivo, anche nei casi in cui si
agisce formalmente contro il bene divino, non si arriva mai a un’opposizione frontale
52
all’ordo universalis, poiché in questo caso la volontà sarebbe cattiva per natura e
tenderebbe al male in se stesso, e così si trasformerebbe nel contrario di Dio e nel male per
essenza, il che è assolutamente impossibile: “in quanto la volontà tende naturalmente al
bene conosciuto come al proprio oggetto e al proprio fine, è impossibile che una qualche
sostanza intellettuale abbia una volontà malvagia secondo natura a meno che il suo
intelletto non erri circa il giudizio sul bene … è impossibile però che vi sia un intelletto che
venga meno per sua natura nel giudizio del vero. Perciò è impossibile che vi sia una qualche
sostanza intellettuale che abbia una volontà naturalmente malvagia” (Contra Gentiles, III,
c. 107). Il male morale si costituisce dunque non nella natura della volontà che è
naturalmente buona, bensì nell’atto della scelta, cioè nel libero arbitrio. Il peccato, ossia il
male morale, altro non è che riporre la propria felicità in qualche cosa che non può dare la
vera felicità; è una forma di “idolatria”, un mettere qualche bene finito al posto di Dio,
come se fosse Dio. Una tale deficienza della volontà, impossibile in universali, è purtroppo
possibile in particulari: “Ogni mente razionale naturalmente desidera la felicità in modo
indeterminato e universale, e riguardo a questo non può venir meno; ma nel particolare
non c’è un determinato movimento della volontà della creatura a cercare la felicità in
questo o in quello. E così nel desiderare la felicità qualcuno può peccare, se la cerca dove
non deve cercarla, come colui che cerca nei piaceri la felicità; e lo stesso è rispetto a tutti gli
altri beni finiti” (De veritate, q. 24, a. 7, a. 6). Quando la creatura pecca perde la
beatitudine che consiste nell’unione con Dio, e fallisce così la piena realizzazione della sua
capacità infinita, ma non perde né il proprio essere né una parziale realizzazione di sé.
Perdendo l’unione elettiva con il fine ultimo, sminuisce la pienezza della sua bontà e resta
unita a Dio solo come una cosa naturale, senza che la sua volontà partecipi attivamente a
questa relazione. Ogni male è un indebito rimpicciolimento del bene, come una restrizione
di un bene che avrebbe dovuto essere più totale. Il peccato consisterebbe nel passare
dall’unione finita con il Bene infinito (Dio), che la creatura razionale è chiamata a scegliere,
all’unione con un bene finito che non può colmare la volontà. Ma la ragione ultima cui il
nostro autore si appella per fare rientrare il male nell’ordo universalis non è tanto quella
che il male non è mai totalmente male ma piuttosto un bene rimpicciolito, bensì il principio
per cui “tutto quello che succede nel mondo, anche se è male, ricade in bene dell’universo”
(In Epistulam ad Romanos, VIII, lect. 6, n. 696). Il male resta così non soppresso, ma
reintegrato nell’armonia dell’universo. Seguendo gli alvei stabiliti nell’ordine cosmico, i
mali finiscono per confluire nel bene della totalità dell’universo e nel bene personale delle
creature spirituali: “La Provvidenza di Dio fa buon uso dei mali, a volte per l’utilità degli
stessi che li patiscono, come quando per opera di Dio le infermità corporali o persino
spirituali ricadono a vantaggio di coloro che le soffrono; altre volte a vantaggio di altri, in
un duplice modo: o per il vantaggio particolare di qualcuno, come quando, per la
penalizzazione di uno, un altro si emenda, o per l’utilità di tutti, come la punizione dei
delinquenti è ordinata alla pace sociale” (De divinis nominibus, IV, lect. 23). Secondo S.
Tommaso tutto ciò che succede nell’universo finisce sempre per contribuire al bene dei
53
giusti, di coloro cioè che lottano per salvaguardare l’ordine morale in ogni loro azione,
poiché tutti e ciascuno di essi costituiscono le parti più essenziali dell’universo: “Tutto ciò
che accade a essi o alle altre cose ridonda a loro bene” (In Epistolam ad Romanos, VIII, lect.
6). Le apparenze di questa vita suscitano l’impressione che i beni e i mali siano distribuiti
indifferentemente, quasi casualmente tanto ai buoni quanto ai cattivi, anzi con una
preferenza per i secondi. Ma la nostra conoscenza dei dettagli del piano provvidenziale è
molto superficiale, e non ci riesce facile giudicare se qualcosa è per il bene o per il male, se
un avvenimento avverso sia stato alla fine più conveniente o, al contrario, un successo
strepitoso abbia in fondo preparato una disgrazia. L’ordine profondo degli avvenimenti, in
particolare degli avvenimenti storici, sfugge ai poteri della ragione umana, ma questa
compie cosa saggia se ripone la sua fiducia nella saggezza infinita della provvidenza di Dio.
2. All’obiezione che rende non necessaria l’esistenza di Dio perché la scienza spiega le
operazioni della natura mediante le leggi naturali, il nostro autore replica: “Certo, la
natura ha le sue operazioni, ma siccome le compie per un fine determinato sotto la
direzione di un agente superiore, è necessario che siano attribuite anche a Dio, come a loro
causa prima” (I, q. 2, a. 3, ad 2). 3. All’obiezione relativa alla libertà umana, la risposta è la
seguente: “Similmente gli atti del libero arbitrio devono essere ricondotti ad una causa più
alta della ragione e della volontà umana, perché queste sono mutevoli e defettibili e tutto
ciò che è mutevole e tutto ciò che può venir meno deve essere ricondotto a una causa prima
immutabile e di per sé necessaria, come si è dimostrato” (ibid.).
Negli scritti di S. Tommaso ci sono poi tre prove dell’esistenza di Dio perfettamente
sintonizzate con la sua filosofia dell’essere e che, essendo tutte centrate sull’essere,
possono a buon diritto essere chiamate “prove ontologiche”, anche se in un senso diverso
da quella anselmiana, perché sono a posteriori, muovono cioè da alcune osservazioni
relative alle condizioni ontologiche degli enti che noi possiamo agevolmente constatare. Le
tre constatazioni che fungono da punto di partenza sono: gli enti hanno l’essere per
partecipazione, negli enti c’è distinzione reale tra l’essenza e l’atto di essere e c’è quindi
composizione; la perfezione dell’essere si trova negli enti per gradi. Riguardo la via della
partecipazione, egli scrive: “Tutto ciò che è qualcosa per partecipazione rimanda a un altro
che sia la stessa cosa per essenza, come a suo principio supremo. Per es., tutte le cose calde
per partecipazione si riducono al fuoco che è caldo per essenza. Ora, dato che tutte le cose
che sono, partecipano all’essere e sono enti per partecipazione, occorre che in cima a tutte
le cose ci sia qualcosa in virtù della sua stessa essenza, ossia che la sua essenza sia l’essere
stesso. Questa cosa è Dio, il quale è causa sufficientissima, degnissima e perfettissima di
tutte le cose: da Lui tutte le cose che esistono partecipano all’essere” (In Joannem, Prol. N.
5). Riguardo la via della distinzione tra essenza ed essere egli scrive: “Tutto ciò che
conviene a qualche cosa o è causato dai principi della sua natura, come la risibilità
nell’uomo, o le compete in virtù di qualche principio estrinseco, come la luce dell’aria per
influsso del sole. Ora non si può dire che l’essere di una cosa sia causato dalla sua stessa
forma o essenza, intendendo come da causa efficiente, perché così una cosa sarebbe causa
54
di se stessa o produrrebbe se stessa, cosa del tutto impossibile. È necessario quindi che ogni
cosa in cui l’essere è diverso dalla sua natura, abbia l’essere da un altro. E poiché tutto ciò
che è in virtù di un altro esige come causa prima ciò che è per sé, ci deve essere qualche
cosa che sia causa dell’essere in tutte le altre, appunto perché essa è soltanto essere;
diversamente si andrebbe all’infinito nelle cause, avendo ogni cosa, che non è solo essere,
una causa, come si è visto” (De ente, c. 4, n. 27). Riguardo la via della gradualità della
perfezione dell’essere negli enti, scrive: “L’essere è presente in tutte le cose, in alcune in
modo più perfetto e in altre in modo meno perfetto; però non è mai presente in modo così
perfetto da identificarsi con la loro essenza, altrimenti l’essere farebbe parte della
definizione dell’essenza della cosa, il che è evidentemente falso, giacché l’essenza di
qualsiasi cosa è concepibile anche prescindendo dall’essere. Pertanto occorre concludere
che le cose ricevono l’essere da altri e (retrocedendo nella serie delle cause) è necessario
che si arrivi a qualche cosa la cui essenza sia costituita dall’essere stesso, altrimenti si
dovrebbe andare indietro all’infinito” (II Sententiae, d. 1, q. 1, a. 1).
Accertata l’esistenza di Dio, Tommaso passa a studiare la sua essenza e la sua natura. La
questione dell’essenza e della natura di Dio per la ragione è ancora più ardua e più
impegnativa rispetto alla dimostrazione della sua esistenza. Se infatti non è difficile risalire
dalla contingenza delle cose alla dimostrazione della sua esistenza come necessaria, non
troviamo nella contingenza tracce tali da permetterci un’identificazione e una definizione
adeguata della realtà di Dio, della sua essenza, della sua persona, delle sue proprietà e
attributi. Infatti dal mondo non è possibile ricavare concetti precisi, chiari e distinti del suo
autore, come dalle orme lasciate da un elefante non è possibile farsi un’idea adeguata
dell’elefante che le ha impresse. Le perfezioni infinite di Dio si manifestano sempre nella
mente dell’uomo per speculum et in aenigmate, sia perché sono spezzettate e frantumate
in tante piccole dosi, sia perché la nostra capacità di apprenderle è quella di un’intelligenza
finita, limitata, condizionata dalla materia e dalla storia. Tuttavia questo non elimina la
legittimità e la necessità di fare un discorso anche sulla natura, sugli attributi e sulle
operazioni di Dio, dal momento che se ne conosce l’esistenza. Alcuni aspetti dell’essere di
Dio risultano già chiari dalle conclusioni delle varie vie: l’immutabilità, l’efficienza, la
necessità, la perfezione, l’intelligenza. Ma sappiamo che, oltre le cinque vie, Tommaso è
asceso a Dio anche in altri modi, in particolare percorrendo la via dell’essere. Proprio
questa conduce a scoprire quell’aspetto di Dio che costituisce la differenza specifica
rispetto a tutte le creature, e quindi a individuare perfettamente la sua essenza. La
differenza specifica non consiste nel possesso delle qualità summenzionate, cui possiamo
aggiungere la bontà, la verità … . Ciò che distingue Dio dalle creature è di non avere
l’essere per partecipazione, bensì per essenza: è l’identificazione in Lui dell’essenza con il
suo essere. Ecco quindi raggiunto il concetto più adeguato di Dio, la definizione più precisa:
Dio è l’esse ipsum subsistens. Tale espressione può applicarsi soltanto a Dio, perciò non è
affatto un titolo anonimo, ma è personalissimo: anzi, è il nome proprio di Dio. Spiega il
nostro autore: “Anzitutto per il suo significato. Infatti non esprime già una qualche forma o
55
modo particolare di essere, ma lo stesso essere … In secondo luogo per la sua universalità.
Tutti gli altri nomi sono meno vasti e universali … Infine, perché il nome Colui che è è più
proprio di Dio dello stesso nome Dio, sia per la derivazione del termine, che è l’essere, sia
per l’universalità del significato” (I, q. 13, a. 11). L’essenza di Dio, in sede filosofica, consiste
nel suo possesso pieno dell’essere, proprio perché è l’essere a costituire la sua essenza.
Questo privilegio compete esclusivamente a Dio: “Ciò che è l’essere, non è incluso
perfettamente nel concetto di nessuna creatura; infatti in qualsiasi creatura l’essere è
distinto dalla sua essenza; per questo motivo non si può dire di nessuna creatura che il suo
esistere è qualche cosa di necessario e di evidente (per se notum et secundum se) in forza
dei suoi stessi principi. Ma in Dio l’essere è incluso nel concetto della sua essenza, perché in
Dio l’essere e l’essenza si identificano, come dicono Boezio e Dionigi” (De Veritate, q. 10, a.
12). Il concetto intensivo dell’essere è il filo conduttore di tutti gli attributi di Dio che il
Dottore Angelico ha disseminato nelle sue opere. Egli prende una perfezione, la confronta
con l’essere, controlla se si basa sull’essere stesso o se invece ottiene l’essere solo quando
si incarna in una determinata essenza. Nel primo caso abbiamo un attributo di Dio, nel
secondo no. Il primo attributo di Dio è la semplicità: “Colui che conferisce l’essere a tutti gli
altri, per quanto concerne l’essere stesso non può dipendere da nessun altro; infatti chi per
esistere dipende da un altro, deve ricevere l’essere da quello, e non può certamente essere
colui che dà l’essere a tutti gli altri. Ma Dio è colui che conferisce l’essere a tutti: quindi il
suo essere non dipende da altri. Ma l’essere di ogni composto dipende dai suoi componenti:
togliendo i componenti viene meno il composto sia come cosa sia come idea (secundum
rem et secundum intellectum). Quindi Dio non è composto. Inoltre, colui che è il principio
primo dell’essere (primum principium essendi) lo possiede in modo eccellentissimo, perché
ogni cosa è presente in maniera più eccellente nella causa che nel causato. Ma il modo più
eccellente di possedere l’essere è quello per cui una cosa è identica all’essere. Quindi Dio è il
suo essere (est suum esse), mentre nessun composto è il suo essere, perché il suo essere
dipende dai componenti e nessuno dei componenti è l’essere stesso. Dunque Dio non è
composto. Ciò deve essere ammesso assolutamente” (I Sent., d. 8, q. 4, a. 1). Il secondo è la
perfezione: “In Dio si ritrovano le perfezioni di tutte le cose. Perciò è anche detto
universalmente perfetto (universaliter perfectus), perché non gli manca nessuna delle
perfezioni che si possono incontrare in qualsiasi genere di cose, come dice il Commentatore.
E questo si può arguire da quanto abbiamo già dimostrato, che cioè Dio è l’essere stesso
per se sussistente (ipsum esse per se subsistens): di qui la necessità che egli contenga tutta
la perfezione dell’essere (totam perfectionem essendi). È chiaro infatti che se un corpo
caldo non ha tutta la perfezione del caldo, ciò avviene perché il calore non è partecipato in
tutta la sua perfezione; ma se il calore fosse per se sussistente, non gli potrebbe mancare
niente di ciò che forma la perfezione del calore. Ora, Dio è lo stesso essere per sé
sussistente; quindi niente gli può mancare della perfezione dell’essere. Ma le perfezioni di
tutte le cose fanno parte della perfezione dell’essere (omnium autem perfectiones pertinent
ad perfectionem essendi), essendo perfette le cose a seconda del modo con cui partecipano
56
all’essere. Di qui ne segue che a Dio non può mancare la perfezione di nessuna cosa” (I, q. 4,
a. 2). Il terzo è l’infinità: “Infinita si dice una cosa perché non è finita (limitata). Ora, in certa
maniera la materia viene limitata dalla forma e a sua volta la forma dalla materia. La
materia è limitata dalla forma in quanto la materia, prima di ricevere la forma, è in potenza
a molte forme; ma dal momento che ne riceve una, da quella viene delimitata. La forma poi
è limitata dalla materia, perché la forma, considerata in se stessa, è comune a molte cose,
ma dal momento in cui è ricevuta nella materia, diventa forma soltanto di una determinata
cosa. Se non che, la materia riceve la sua perfezione dalla forma che la determina, e perciò
l’infinito attribuito alla materia racchiude imperfezione, perché è come una materia senza
forma. La forma, invece, non viene perfezionata dalla materia, ma ne riceve piuttosto la
restrizione della sua ampiezza illimitata; quindi l’infinito che si attribuisce alla forma non
delimitata dalla materia importa essenzialmente perfezione. Ora, come abbiamo già
veduto, l’essere stesso tra tutte le cose è quanto di più formale si possa trovare (maxime
formale omnium est ipsum esse). Quindi, siccome l’essere divino non è ricevuto in un
soggetto, ma Dio è il suo proprio essere sussistente, come si è precedentemente
dimostrato, resta provato chiaramente che Dio è infinito e perfetto” (I, q. 7, a. 1). Il quarto è
l’onnipresenza: “Essendo Dio l’essere stesso per essenza, bisogna che l’essere creato sia
l’effetto proprio di Lui, come bruciare è l’effetto proprio del fuoco. E questo Dio lo causa
nelle cose non soltanto quando cominciano ad esistere, ma fintanto che perdurano
nell’essere; come la luce è causata nell’aria dal sole finché l’aria rimane illuminata. Fino a
che dunque una cosa ha l’essere, è necessario che Dio le sia presente nella proporzione in
cui essa possiede l’essere. L’essere poi è ciò che nelle cose vi è di più intimo e di più
profondamente radicato (magis intimum et profundius), poiché, come si è già detto,
l’essere è l’elemento formale rispetto a tutti i principi e i componenti che si trovano in una
data realtà. Necessariamente dunque Dio è in tutte le cose e in maniera intima (Deus est in
omnibus rebus, et intime)” (I, q. 8, q. 1). Il quinto è l’immutabilità: “Da quanto è stato
precedentemente esposto si dimostra che Dio è assolutamente immutabile … Infatti tutto
ciò che si muove acquista qualcosa in forza del suo movimento e arriva a ciò cui prima non
arrivava. Ora, Dio, essendo infinito e racchiudendo in se stesso in modo perfetto e
universale la pienezza di tutto l’essere (plenitudinem perfectionis totius esse), nulla può
acquistare né estendersi a qualcosa cui prima non arrivava; in nessun modo quindi a lui
conviene il movimento. Ecco perché anche tra gli antichi, alcuni, quasi costretti dalla stessa
verità, affermarono l’immutabilità del primo principio” (I, q. 9, a. 1). Il sesto è l’eternità: “La
nozione di eternità nasce dall’immutabilità, come quella di tempo deriva da movimento,
come risulta da ciò che è stato detto. Quindi, essendo Dio sommamente immutabile, a lui in
modo assoluto compete di essere eterno. E non è soltanto eterno, ma è anche la sua stessa
eternità, mentre nessun’altra cosa è la propria durata, perché non è il proprio essere. Dio
invece è il suo stesso essere uniforme (Deus est suum esse uniforme), e perciò com’è la sua
essenza così è la sua eternità” (I, q. 10, a. 2). Il settimo è l’unità: “L’uno è l’ente indiviso.
Perciò perché una cosa sia massimamente una occorre che sia massimamente ente e
57
massimamente indivisa. Ora, l’una e l’altra condizione si verifica in Dio. Egli, infatti, è
massimamente ente, perché non è ente per avere un essere determinato da una qualche
natura (o essenza) alla quale sia stato unito, ma perché è lo stesso essere sussistente,
illimitato in tutti i sensi (est ipsum esse subsistens, omnibus modis indeterminatum). È poi
massimamente individuo, in quanto non è divisibile per nessun genere di divisione né in atto
né in potenza, essendo semplice sotto tutti gli aspetti, come fu già dimostrato. È quindi
evidente che Dio è sommamente uno”(I, q. 11, a. 4). L’ottavo è la bontà: “Il bene è definito
egregiamente da Aristotele come <<ciò che tutti desiderano>>. Ora, tutte le cose
desiderano di esistere nella loro piena attualità, secondo il modo loro proprio, come risulta
dalla ripugnanza naturale che hanno alla distruzione; quindi, l’esistenza in atto (esse actu)
costituisce la ragione essenziale del bene. Per questo, dalla privazione dell’atto nella
potenza consegue un male, come dimostra Aristotele (Met IX, lect. 19). Ma Dio è ente
totalmente in atto, non in potenza come si è visto sopra. Dunque è veramente buono …
Anzi, da questo può ricavarsi che Dio è la stessa bontà. Infatti, per qualunque cosa la
pienezza dell’essere, ossia l’essere in atto, è ciò che costituisce il suo bene; ora Dio non
soltanto è un ente in atto, ma è il suo stesso essere come si è dimostrato sopra. Perciò egli
non soltanto è buono, ma è la stessa bontà” (Contra Gentiles, I, cc. 37-38).
A questo punto S. Tommaso si chiede in che modo conosciamo Dio, per trattare poi dei
nomi di Dio. Egli tenta una verifica critica di quanto l’uomo può fare con i suoi concetti e
con le sue parole, applicandoli a Dio. Egli collega inequivocabilmente la conoscenza e il
linguaggio umano all’esperienza sensibile. Anche le prove dell’esistenza di Dio derivano da
essa. La conoscenza che l’uomo acquisisce di Dio e i nomi che può assegnargli hanno un
mero valore analogico. Nessun concetto e nessuna parola possono esprimere
direttamente e adeguatamente ciò che Dio è in se stesso. Neppure il suo nome più proprio,
Ipsum Esse Subsistens, consente di acquisire un concetto adeguato di Dio. Esso deve
passare attraverso il filtro molto stretto della via negativa, la quale alla fine salva la res
significata ma distrugge completamente il modus significandi. Dichiara a proposito il nostro
autore: “Noi non possiamo parlare di Dio se non partendo dalle creature, come più sopra
abbiamo dimostrato. E così qualunque termine si dica di Dio e delle creature si dice per il
rapporto che le creature hanno con Dio come principio e causa, nella quale preesistono in
modo eccellente tutte le perfezioni delle cose” (I, q. 13, a. 5). E ancora: “Noi neghiamo
anzitutto a Dio tutto quanto è corporeo e, secondariamente, quanto è intellettuale e
mentale, almeno nel senso in cui questo elemento si trova nelle creature viventi, come, per
es., bontà e sapienza. E allora resta nella nostra mente solo che Dio è e nulla più. Infine
rimuoviamo anche l’idea dello stesso <<essere>>, così come questa idea di essere si trova
presente nelle creature, e allora Dio rimane nell’oscura notte dell’ignoranza, ed è in questa
ignoranza che noi ci avviciniamo a Dio nella nostra vita, come dice Dionigi. Infatti in questa
nebbia, dicono, abita Dio” (I Sent., d. 8, q. 1, a. 1, ad 4). Il nostro autore assume una
posizione intermedia tra un eccessivo apofatismo, che concede che di Dio si possa dire solo
ciò che non è, e un baldanzoso catafatismo, troppo fiducioso nelle capacità umane di
58
capire e di esprimere ciò che Dio è in se stesso. A Maimonide, massimo esponente
dell’apofatismo in quei tempi, Tommaso replica che nella sua teoria “sparisce ogni
differenza tra dire che Dio è sapiente e dire che Dio si adira o che Dio è fuoco … Ma ciò
contrasta con la posizione dei santi e dei profeti che hanno parlato di Dio, i quali approvano
l’attribuzione a Dio di determinate cose, mentre altre le escludono, concordano che Dio è
vivo, sapiente e così via, me negano che sia un corpo, oppure soggetto a passioni. Secondo
la teoria di Maimonide si può dire e negare indiscriminatamente tutto, senza nessuna
distinzione” (De Potentia, q. 7, a. 5). Ma la cosa peggiore è che, se seguiamo la teoria di
Maimonide fino in fondo, prima della creazione oppure nel caso che Dio non avesse creato
il mondo, di lui non si potrebbe dire né che è buono, né che è sapiente, né che è vivo ecc. A
coloro che invece credono di sapere tutto su Dio perché su di lui riusciamo a fare
innumerevoli discorsi, Tommaso ricorda che è impossibile predicare qualcosa in maniera
univoca di Dio e delle creature: “Poiché ogni effetto non è proporzionato alla potenza della
causa agente, ritrae una somiglianza dell’agente non secondo la stessa natura, ma
imperfettamente; in maniera che quanto negli effetti si trova diviso e molteplice, nella
causa è semplice e uniforme; così il sole mediante un’unica energia produce nelle cose di
quaggiù forme molteplici e svariate. Allo stesso modo, come si è detto, tutte le perfezioni
delle cose, che nelle creature sono frammentarie e molteplici, in Dio preesistono in semplice
unità. Così, dunque, quando un nome che indica perfezione si applica a una creatura,
significa quella perfezione come distinta da altre, secondo la nozione espressa dalla
definizione: per es., quando il termine sapiente lo attribuiamo all’uomo, indichiamo una
perfezione distinta dall’essenza dell’uomo e dalla sua potenza e dalla sua esistenza e da
altre cose del genere. Quando invece attribuiamo questo nome a Dio, non intendiamo
indicare qualche cosa di distinto dalla sua essenza, dalla sua potenza e dal suo essere …
Quindi è chiaro che il termine sapiente si dice di Dio e dell’uomo non secondo un identico
concetto formale. E così è per tutti gli altri nomi. Perciò nessun nome si attribuisce in senso
univoco a Dio e alle creature” (I, q. 13, a. 5). Operando una sintesi tra la teologia negativa di
ispirazione platonica e la teologia positiva di ispirazione aristotelica, egli conclude che
“tutto ciò che è conosciuto può anche essere espresso in parole … Ma poiché di Dio noi
possediamo una conoscenza imperfetta, ci è possibile nominarlo solo imperfettamente,
quasi balbettando” (I Sent., d. 22, q. 1, a. 1).
Accertati anche l’essenza e gli attributi di Dio, Tommaso studia la sua vita e le sue opere. Si
tratta di una vita intensissima e di una serie di operazioni eccellenti, che si addicono al suo
essere immateriale, semplice, infinito, perfetto, buono, immutabile etc. Ci sono operazioni
ad intra, che costituiscono la vita intima di Dio, come il conoscere ed il volere, e ce ne sono
altre ad extra, che riguardano i rapporti di Dio col mondo, e precisamente la creazione, la
provvidenza e la conservazione.
Riguardo la conoscenza, lo spirito per natura sua è intelligente e libero, e comunica con gli
altri in perfetta autonomia. La materia è cieca, tenebrosa e impenetrabile, incatenata a
59
leggi immutabili. Invece lo spirito è luminoso e mobilissimo, va dove vuole, è libero. È dalla
condizione stessa della natura spirituale, che compete a Dio in modo sommo, che il
Dottore Angelico deriva immediatamente la sua dottrina sulla conoscenza e sulla volontà di
Dio. In quanto spirito assoluto, sciolto da qualsiasi rapporto con la materia, Dio è
sommamente conoscitivo: “A chiarimento di ciò bisogna considerare che gli esseri
conoscitivi si distinguono dagli esseri non conoscitivi in questo, che i non conoscitivi non
hanno che la propria forma; mentre quelli dotati di conoscenza sono fatti per avere anche
la forma di altre cose, giacché in chi conosce si trova l’immagine dell’oggetto conosciuto …
Ma la limitazione viene dalla materia … Quindi, essendo Dio all’apice della immaterialità,
come risulta chiaramente da ciò che precede, ne viene che egli sia anche all’apice del
conoscere” (I, q. 14, a. 1). Mentre nell’uomo il conoscere è altra cosa dall’essere (l’uomo
ora conosce, ora non conosce), in Dio essere e conoscere coincidono perfettamente: Dio è
sempre in atto di esistere e di conoscere e, conseguentemente, non può avere che sé
medesimo come oggetto intellegibile, adeguato e sempre presente: perciò Dio conosce sé
in se stesso. E si conosce perfettamente, cioè conosce totalmente se stesso. Conoscendosi
perfettamente, Egli conosce anche ciò a cui può estendersi la sua virtù, conosce quindi
tutte le cose, essendone la causa, e le conosce non con cognizione generica, ma distinta e
propria, e in se stesso vede anche tutte le cose insieme, mentre l’uomo conosce le cose
una dopo l’altra, con scienza discorsiva. Dio sa tutto quello che può fare Lui e anche quello
che possono fare, dire, pensare le creature; e, siccome Dio è eterno e per lui tutto è
presente, egli conosce con scienza di visione quello che è presente, o fu, o sarà; invece
conosce con scienza di semplice intelligenza quello che non è presente e neppure fu o sarà,
ma resta soltanto possibile. Conoscendo il bene, Dio conosce anche il male, che è o
corruzione del bene o mancanza del bene. In Dio la conoscenza delle cose, in quanto le si
aggiunge la volontà, è causa delle cose in quanto Dio le conosce perché esistono.
A Dio compete anche il volere, visto che ogni essere possiede l’inclinazione verso ciò che
giova alla propria autorealizzazione: “Questa tendenza al bene negli esseri privi di
conoscenza si chiama appetito naturale. E così anche gli esseri intelligenti hanno una simile
inclinazione al bene appreso mediante una specie intellegibile, in maniera che quando
hanno questo bene, vi si riposano, quando non l’hanno lo ricercano. Questa duplice
operazione appartiene alla volontà. Quindi, in ogni essere che ha l’intelletto, c’è la volontà,
come in ogni essere dotato di senso c’è l’appetito sensitivo. Perciò è necessario ammettere
che in Dio vi è la volontà, essendovi l’intelletto. E come il suo conoscere coincide con
l’essere, così è per il suo volere” (I, q. 19, a. 1). In un altro passo scrive ancora: “A Dio
compete avere volontà, essendo dotato di intelligenza. Ora, siccome egli intende mediante
la sua essenza, come s’è provato in precedenza, così ancora vuole. Pertanto la volontà di
Dio è la sua stessa essenza” (Contra Gentiles, I, c. 73). Se Dio si diletta nel conoscere prima
di tutto se stesso, allo stesso tempo prima di tutto vuole l’infinita ricchezza del proprio
essere. Dio si compiace e gusta le perfezioni superlative e meravigliose del proprio essere:
“Infatti oggetto della volontà è il bene conosciuto. Ora il primo oggetto conosciuto da Dio è
60
l’essenza divina. Dunque l’essenza divina è il termine a cui principalmente si dirige la
volontà divina … Inoltre, per qualsiasi essere volente, l’oggetto principale voluto è il suo fine
ultimo; poiché il fine è voluto in se stesso, e per esso si vogliono le altre cose (i mezzi). Ora
l’ultimo fine è Dio stesso, perché è il sommo bene; quindi egli è il principale oggetto voluto
dalla sua volontà” (Contra Gentiles, I, c. 74). Ma Dio non vuole e non ama soltanto se
stesso; con un unico atto Egli vuole e ama oltre che se stesso anche le cose, ma non allo
stesso modo. Come infatti conosce le cose solo come imitazioni della divina essenza, così
vuole e ama le cose come partecipazioni della divina bontà. Mentre però Dio vuole se
stesso necessariamente, vuole le cose liberamente: “La volontà divina ha un rapporto
necessario con la sua bontà, la quale è il suo oggetto proprio. Dio vuole dunque
necessariamente che esista la sua bontà, come la nostra volontà necessariamente vuole la
felicità. Tutte le altre cose Dio le vuole in quanto sono ordinate alla sua bontà, come a loro
fine … Siccome però la bontà di Dio è assolutamente perfetta in se stessa e può stare senza
tutto il resto, non traendo da esso nessun accrescimento di perfezione, ne segue che volere
le cose distinte non è necessario per Dio di una necessità assoluta. Tuttavia può divenire
necessario in forza di un’ipotesi: supposto infatti che Dio le voglia, non può non volerle,
perché la sua volontà non può mutare” (I, q. 19, a. 3). In rapporto alla volontà di Dio si
ripropone il tormentoso problema del male. Tommaso riafferma il principio che il male non
può essere voluto per sé ma solo in quanto congiunto con qualche bene. Questo principio
si applica anche a Dio. Pertanto Dio, volendo la sua bontà sopra tutto, rigetta il male di
colpa che è ad essa direttamente contrario; quanto agli altri mali, volendo Dio le altre cose
in ordine a sé, può volere il male di pena in ordine alla giustizia e il male naturale in ordine
alla Provvidenza.
Dopo Tommaso la caratteristica della necessità diventa fondamentale per tutte le dottrine
di Dio. Cusano definisce Dio come necessità assoluta (De docta ignorantia I, 22). Cartesio
assume tale caratteristica come punto di partenza della prova ontologica: “l’esistenza
necessaria è contenuta nella natura o nel concetto di Dio, sicché è vero dire che l’esistenza
necessaria è in Dio, o che Dio esiste” (Secondes Reponses, prop. I, Démonstration). Anche
chi nega la legittimità di tale prova mantiene il concetto di necessità per definire Dio, come
nel caso di Leibniz: “Bisogna cercare la ragione dell’esistenza del mondo che è la totalità
delle cose contingenti e bisogna cercarla nella sostanza che porta la ragione della sua
esistenza con sé e che perciò è necessaria ed eterna” (Theodicea, I, &7). Dio è sostanza
necessaria (Monadologia, 38). Anche nel panorama della filosofia contemporanea, a
proposito del Dio creante, si assume il carattere della necessità come punto di partenza per
una dimostrazione ontologica (cfr. spiritualismo contemporaneo). Invece secondo
Kierkegaard il rapporto tra Dio e il mondo è incomprensibile. Esso può essere chiarito solo
negativamente mediante la nozione di una differenza assoluta, di un salto tra il mondo e
Dio. Egli, perciò, non si serve della categoria di causa per determinare il rapporto tra
mondo e Dio e non applica a Lui la categoria della necessità. Dio è Colui al quale tutto è
possibile e la fede è il fondamento della fiducia in Colui che può sempre trovare, per
61
l’uomo, una possibilità di salvezza: la fede non trova il fondamento nella necessità della
natura divina. In questa prospettiva la qualifica di Dio come creatore del mondo diventa
incomprensibile, e diventa indifferente affermarla o negarla. Jaspers qualifica la
trascendenza dell’essere con gli attributi tradizionalmente attribuiti a Dio. Alla fine egli
annulla la distanza tra la trascendenza e l’uomo, e quindi annulla la trascendenza come
tale. L’unica cifra o segno della trascendenza è lo scacco che l’uomo subisce nel tentativo di
raggiungere la trascendenza stessa. La trascendenza viene in realtà negata da ogni
tentativo di renderla vicina e accessibile, pensandola coi termini tradizionali della divinità
(Philosophia III, 3).
2. Dio e il mondo morale
Possiamo distinguere le concezioni di Dio anche nel rapporto con la dimensione morale.
Rarissime sono le dottrine che non conferiscono a Dio nessuna funzione in ordine al mondo
morale. Esse sono forme di semi-ateismo. Un esempio è riscontrabile in Voltaire, peraltro
ostile all’ateismo. A suo parere la divinità si disinteressa completamente della condotta degli
uomini. La natura segue comunque il suo corso: “Ma se un montone andasse a dire ad un lupo:
Tu manchi al bene morale, Dio ti punirà, il lupo gli risponderebbe: Io faccio il mio bene fisico e vi
è l’apparenza che Dio non si curi troppo che io ti mangi o no” (Traité de métaphisique, 9). Tale
punto di vista, condiviso anche da qualche altro autore illuminista, è molto raro nella storia del
pensiero secondo la quale il rapporto tra Dio e l’ordine morale si modella in analogia a quello
tra Dio e il mondo fisico. Possiamo distinguere tre concezioni fondamentali.
a) Dio è il garante dell’ordine morale del mondo. L’ordine morale è indipendente da Dio, ma
Egli concorre in modo più o meno efficace a mantenerlo o a realizzarlo, facendosene
garante. Secondo Platone e Aristotele, mentre Dio è la causa dell’ordine naturale, non ha
nessuna responsabilità nell’ordine morale che è affidato agli uomini, e si limita ad
appoggiarlo e incoraggiarlo con proprie sanzioni. Nel mito di Er, la Parca Lachesi si rivolge
così alle anime che stanno per scegliere un nuovo ciclo di vita: “La virtù non tollera padroni;
ognuno ne parteciperà più o meno, a seconda che più o meno la onorerà. Ciascuno è
imputabile della sua scelta: la divinità non è imputabile” (Repubblica X, 617e). In realtà il
Demiurgo predispone ogni cosa “per non essere causa della futura malvagità dei singoli
esseri” (Timeo, 42d). La virtù come il vizio, e dunque la totalità dell’ordine morale, rientra
nella sfera di causalità degli esseri causati. Tuttavia chi è virtuoso è anche amico della
divinità, è simile alla divinità stessa: “La divinità è per noi la misura di tutte le cose molto
più di quanto lo può essere un uomo, come invece dicono ora” (Leggi, IV, 716c). Anche per
Aristotele la divinità esplica la sua funzione soltanto nel mondo naturale e solo da questa
funzione rimangono determinati i suoi attributi fondamentali (Motore Immobile, Causa
prima, Pensiero di pensiero …). Tuttavia anche Aristotele ammette, conformemente alle
credenze popolari, che “se gli dei si preoccupano in qualche misura delle faccende umane,
62
come sembra, è verosimile che si compiacciano che vi sia negli uomini qualcosa di
eccellente e che abbia con essi la maggiore affinità, il che non può essere che l’intelligenza”
(Etica Nicomachea, X, 9, 1179 a. 24). La caratteristica negativa di questa concezione è
l’assenza della nozione di Provvidenza, cioè di un ordine razionale creato da Dio o che sia
Dio stesso, in cui debbano trovare posto gli uomini e i loro comportamenti. La sua
caratteristica positiva è che Dio è garante dell’ordine morale per quanto non stabilisca egli
stesso le vie e i modi della realizzazione di esso. Queste caratteristiche si ritrovano nel
mondo moderno presso i sostenitori della religione naturale, cioè di una religione senza
rivelazione da parte di Dio e affidata alle sole forze della ragione. Grozio, per esempio,
afferma che gli enunciati della religione naturale sono quattro: “Il primo è che Dio esiste ed
è uno. Il secondo che Dio non è nessuna delle cose che si vedono ma è molto superiore ad
esse. Il terzo è che le cose umane sono curate da Dio e giudicate con perfetta equità. Il
quarto è che dio stesso è l’artefice di tutte le cose esterne” (De iure belli, II, 20, 45). In Kant
e Rousseau trova la migliore espressione la credenza che nelle cose umane sia assente un
ordine provvidenziale, pur non escludendo l’aiuto e la garanzia divina. Per Rousseau Dio
interviene a far valere le leggi dell’ordine universale facendo in modo che coloro che in
questa vita si comportano giustamente e sono infelici siano ricompensati nell’altra. È
importante garantire l’ordine morale che diventa l’unico motivo ragionevole per credere
all’immortalità dell’anima (Emilio, IV). Ordine morale e immortalità dell’anima nella
modernità sono legati a doppia mandata: senza l’uno non si giustifica neanche l’altro. Per
Kant l’esistenza di Dio è un postulato della ragion pratica perché solo Dio rende possibile
quella unione necessaria di virtù e felicità in cui consiste il sommo bene, che è l’oggetto
proprio della legge morale (Critica della Ragion Pratica, I, cap. 2, &5): “In questo modo la
legge morale mediante il concetto del sommo bene conduce alla religione, cioè alla
conoscenza di tutti i doveri come comandamenti divini; non come sanzioni, cioè decreti
arbitrari e per se stessi accidentali di una volontà estranea, ma come leggi essenziali di ogni
volontà libera per se stessa, che però devono essere considerati come comandamenti
dell’Essere supremo, perché soltanto da una volontà moralmente perfetta (santa e buona)
e nello stesso tempo onnipotente, possiamo sperare il sommo bene che la legge morale ci
fa un dovere di porre come oggetto dei nostri sforzi, e quindi possiamo sperare di
raggiungerlo mediante l’accordo con questa volontà perfetta”. Dio è per Kant
1 Creatore onnipotente del cielo e della terra, cioè, dal punto di vista morale, legislatore
santo;
2.Conservatore del genere umano come suo benevolo reggitore e curatore morale
3. Custode delle sue proprie leggi, cioè giusto giudice.
Il potere morale di Dio è così limitato a una garanzia che non determina in alcun modo
l’azione degli uomini, e che in qualche modo è richiesta per la stessa autonomia di questa
azione.
63
b) Dio come l’ordine morale del mondo. Questa concezione poggia sul concetto di
Provvidenza: cioè sul concetto di un ordine razionale che comprende in sé non solo gli
eventi del mondo ma anche le azioni umane, ordine il quale o è Dio stesso o è da Dio. Gli
Stoici furono i primi a formulare il concetto di provvidenza: esso è sinonimo di destino e
indica il governo razionale del mondo, cioè “la ragione secondo la quale le cose passate
avvennero, le presenti avvengono, le future avverranno” (Stobeo, Ecloghe, I, 79). Gli Stoici
identificarono questa ragione o destino con Dio stesso “presente nelle cose e nei fatti tutti
e così adoperante tutte le cose secondo la loro natura all’economia del tutto” (Alessandro,
De fato, 22). A partire da questa identificazione non dovrebbe nascere il problema della
libertà umana: essa o dovrebbe essere identificata con la necessità stessa del disegno
provvidenziale o negata come impossibile. L’azione dell’uomo non può che adeguarsi
all’ordine razionale del tutto, perché l’uomo è una parte di questo tutto. E infatti gli Stoici
riconoscevano la necessità dell’agire umano: solo Crisippo faceva intervenire come fattore
concomitante l’assenso volontario dell’uomo, paragonandolo alla forma del cilindro che
contribuisce a far rotolare il cilindro stesso sul piano inclinato (Cicerone, De fato, 41-43).
Plotino riprende lo stesso concetto di provvidenza: “Da tutte le cose si forma un essere
unico e una sola provvidenza: a cominciare dalle cose inferiori essa è dapprima il destino; in
alto è soltanto provvidenza. Tutto, nel mondo intellegibile, è o ragione o, al di sopra della
ragione, Intelligenza ed Anima pura. Tutto ciò che discende di là è provvidenza: cioè tutto
ciò che è nell’Anima pura e tutto ciò che viene dall’Anima agli esseri animati” (Enneadi, III,
3,5). L’azione emanante di Dio coincide con la sua azione provvidenziale: gli esseri traggono
da Dio non solo l’essere e la vita, ma anche l’ordine delle azioni in cui il loro essere e la loro
vita si esplicano. Egli cerca di non ricondurre all’ordine provvidenziale il male attribuendolo
ad una specie di aggiunta accidentale che alcuni esseri fanno all’ordine stesso della
provvidenza. Per Plotino provvidenza e Dio si identificano, giacché “dal Principio che resta
immobile in se stesso procedono gli esseri particolari come da una radice, che resta fissata
in se stessa, proviene la pianta: è una fioritura multipla che mette capo alla divisione degli
esseri ma in cui ciascuno porta l’immagine del Principio” (ibid., III, 3, 7). La negazione della
libertà umana, o la sua interpretazione come necessità, è uno dei corollari di questa
concezione. Giordano Bruno afferma che, per quanto le preghiere non possano influire sui
decreti del destino, che è inesorabile, il destino stesso vuole che lo si preghi di fare ciò che
ha stabilito di fare: “Ancora il fato vuole questo che, benché sappia il medesimo Giove che
quello è immutabile, e che non possa essere altro che quel che deve essere e sarà, non
manchi di incorrere per cotali mezzi il suo destino” (Opere italiane, I, 31). Spinoza nega che
Dio sia causa libera nel senso che possa agire diversamente da come agisce: egli è libero
solo nel senso che agisce “per le sole leggi della sua natura” (Ethica, I, 17). La nozione di
provvidenza si identifica con la nozione di necessità, la necessità secondo la quale ogni cosa
deriva dalla stessa natura di Dio, come unica e sola Causa perfetta e onnipotente (Ethica I,
33, scol. 2). Fichte ripropone la tesi spinoziana nello scritto del 1798 Sul fondamento della
nostra fede nel governo divino del mondo che gli procurò l’accusa di ateismo. Ivi egli
64
identifica Dio col vivente e operante ordinamento morale, negando però che Egli fosse una
particolare sostanza diversa da tale ordinamento. Tale identificazione prosegue come
fondamento del Romanticismo. Scrive Hegel: “Il vero bene, la ragione divina e universale è
anche potenza di realizzazione di sé medesima. Nella sua rappresentazione più concreta,
questo bene, questa ragione è Dio … Ciò che la filosofia scorge ed insegna è che nessuna
forza ha il sopravvento su quella del bene, cioè di Dio, in modo da impedirle di farsi valere:
Dio prevale, e la storia del mondo non rappresenta altro che il piano della Provvidenza. Dio
governa il mondo: il contenuto del suo governo, l’esecuzione del suo piano è la storia
universale” (Philosophie der Geschichte, ed. Lasson, p. 55). Dio è la ragione che abita il
mondo e tale ragione è la stessa realtà storica. Tale dottrina è stata ripresa e definita come
dottrina della “Provvidenza immanente”.
c) Dio come creatore dell’ordine morale. Tale concezione è caratterizzata dalla distinzione
tra Dio e la sua azione provvidenziale: Dio, dunque, è causa libera dell’ordine morale. In
secondo luogo, essa vuole salvare la libertà dell’uomo. Anche in questo caso si parte dalla
nozione di provvidenza quale è stata elaborata dagli Stoici e dai Neoplatonici. Boezio la
distingue da quella di destino: “La provvidenza è la stessa ragione divina costituita come
principio sovrano di tutto, che ordina ogni cosa, mentre il destino è l’ordine che regola le
cose nel loro movimento e per la via del quale la provvidenza le connette dando a ciascuna
il posto che le compete” (De Consolatione Philosophiae, IV, 6, 10).Questa distinzione non è
una separazione: in ultima analisi provvidenza e destino vengono a coincidere perché l’uno
è l’unità dell’ordine visto dall’intelligenza divina, l’altro è questo ordine stesso in quanto si
realizza nel tempo. L’uno e l’altro danno origine al problema del libero arbitrio. Boezio
cerca di risolverlo affermando che le azioni umane sono incluse, proprio nella loro libertà,
nell’ordine provvidenziale (ibid., V, 6). S. Tommaso ripropone la Provvidenza come la
sollecitudine paterna e amorosa con cui Dio segue le sorti delle singole creature e di tutto
l’universo. Egli presta loro una assistenza costante perché possano raggiungere quella
piena realizzazione del proprio essere (felicità) cui sono chiamate: “Siccome Dio è causa
delle cose mediante l’intelletto e quindi la ragione di ogni sua opera preesiste
necessariamente in Lui, ne viene di necessità che l’ordinamento delle cose al loro fine
preesiste nella mente divina. Ora, la Provvidenza consiste precisamente in questo
predisporre gli esseri al loro fine” (Summa Theologiae, I, q. 22, a. 1). La provvidenza divina
si affianca alla creazione e la completa. Mentre la creazione porta all’essere tutto ciò che
ne è privo, la provvidenza interviene per dare un ordine alle creature e per conservarlo. La
provvidenza non indica soltanto la cooperazione, il concorso con cui Dio mantiene
nell’essere le proprie creature, ma implica anche la ragione di scopo, il progetto: è il
concorso di Dio teso a realizzare quel progetto che Egli stesso ha predisposto sia per le
singole creature, sia per l’universo intero. Tommaso incontra il concetto di provvidenza
innanzitutto come verità di fede che Dio rivela di sé attraverso la storia della salvezza, ma
poi esso ha assunto anche un solido e robusto spessore razionale grazie alla assidua e acuta
speculazione dei Padri della Chiesa e degli Scolastici. Così la provvidenza è diventata tema
65
costante della filosofia cristiana (Clemente Alessandrino, Origene, Gregorio Nisseno,
Ambrogio, Agostino, Boezio, S. Bernardo, S. Bonaventura, Alberto Magno). Il Dottore
Angelico affronta in particolare le seguenti questioni: a. se in Dio possa esserci
provvidenza, b. se tutte le cose sono soggette alla divina provvidenza, c. se la divina
provvidenza si occupa immediatamente di tutte le cose, d. se la provvidenza rende
necessario tutto quello a cui provvede. Riguardo la prima questione, Dio, essendo creatore,
è anche provvidente. Se Egli è causa di tutte le cose mediante il suo intelletto, è necessario
che preesista nella sua mente la ragione dell’ordine delle cose verso il fine. La provvidenza
comprende dunque due aspetti: la ragione dell’ordine, o provvidenza propriamente detta,
e l’esecuzione dell’ordine che è il governo delle cose. Dio provvede a tutte le cose senza
distinzione concedendo a ciascuna quella assistenza che è conforme alla sua natura: “Dio
provvede immediatamente a tutto, perché nella sua mente ha l’idea di tutti gli esseri, anche
dei più piccoli, e a tutte le cause che ha prestabilito per produrre gli effetti ha dato la
capacità di produrre quei dati effetti” (I, q. 22, a. 3). Il rapporto di provvidenza è
coestensivo al rapporto di causalità: “La causalità di Dio, il quale è l’agente primo, si
estende a tutti gli esseri non solo quanto ai principi della specie, ma anche ai principi
individuali, sia delle cose incorruttibili, sia delle cose corruttibili. Quindi è necessario che
tutto ciò che in qualsiasi modo ha l’essere, sia da Dio ordinato al suo fine” (ibid., a. 2).
Affermata la provvidenza divina, dal mondo non scompaiono il contingente e il libero, il
fortuito e il casuale. Il disegno stesso di Dio prevede che alcuni effetti siano fortuiti rispetto
le loro cause prossime. La provvidenza divina con l’efficacia della propria causalità fa essere
nelle cose anche il fortuito e il casuale. Anche quest’ultimo è un modo di essere, che deriva
dalla fonte prima dell’essere. Il male non mette in discussione l’esistenza dell’azione
provvidenziale di Dio, perché esso non è un modo di essere, ma privazione di entità e di
ordine al fine. Può entrare nei disegni della provvidenza universale in vista di una somma
maggiore di bene nel creato. Pur essendo disordine, è fatto servire a un ordine superiore:
“Sebbene il male, in quanto esce dall’agente proprio, sia cosa disordinata, e sotto questo
aspetto si definisca come privazione di ordine, ossia disordine, nulla impedisce che da un
superiore agente sia introdotto in un ordine; ed è così che cade sotto la provvidenza” (De
veritate, q. 5, a. 4). Neanche la libertà umana costituisce un argomento contro la
provvidenza: quanto all’essere essa dipende totalmente da Dio, che assiste l’uomo senza
far violenza alla propria libertà. Proprio della provvidenza divina è il governo di tutte le
creature secondo la loro natura conforme al disegno preconcepito. Ci sono nell’universo
effetti necessari, perché Dio ha voluto e ha posto nell’essere cause necessarie, e ci sono
effetti liberi perché Dio ha voluto e posto nell’essere cause che operano liberamente:
“Effetto della provvidenza divina non è soltanto che una cosa avvenga in un modo qualsiasi;
ma che avvenga in modo contingente o necessario. Perciò quello che la divina provvidenza
dispone che avvenga infallibilmente e necessariamente, avviene infallibilmente e
necessariamente; quello che il piano della provvidenza divina esige che avvenga in modo
contingente, avviene in modo contingente” (S. Th., I, q. 22, a. 4, ad 1). Anche se l’ordine
66
della provvidenza è certo e infallibile, perché certezza e infallibilità sono proprie dell’essere
di Dio, esso non intacca minimamente le condizioni proprie e le qualifiche specifiche delle
varie creature che possono essere sia necessarie sia contingenti (libere). Le cose cadono
sotto l’ordine della provvidenza secondo il loro essere sostanziale e secondo il proprio
modo di essere. Contingente e necessario sono due modi di essere conseguenti all’essere
creato e le cose cadono sotto l’ordine della provvidenza sia secondo l’uno che l’altro modo
di essere. Per questo l’ordine della provvidenza è certo e immobile. Nel tempo questa si è
presentata sempre come una soluzione non priva di difficoltà nel coniugare la perfezione di
un disegno universale affidata alla causalità universale della scienza e della volontà di Dio e
l’arbitrarietà di volontà finite, la persistenza, anche se in minima parte, del comportamento
imprevedibile di un fattore arbitrario. Ciò renderà difficile soprattutto la riflessione sulla
questione del male: tra l’insufficienza e una nuova riproposizione delle tesi tradizionali per
inquadrare in un determinismo non necessitante la volontà umana, nel contesto di un
ordine provvidenziale. Tale concezione di Dio come creatore dell’ordine morale porta con
sé il concetto di un ordine provvidenziale, desunto dall’identificazione di Dio col mondo o
col suo ordine, il concetto di Dio come sostanza necessaria, di origine araba, e il concetto di
Dio come causa libera, tratto dall’humus ebraico-cristiano. L’armonizzazione di questi tre
concetti non è priva di difficoltà.
3. Dio e la divinità
Le concezioni di Dio possono essere distinte anche in base al rapporto di Dio con se stesso o con la
divinità. A seconda che Dio si identifichi o si distingua dalla divinità, abbiamo le due alternative
fondamentali del politeismo e del monoteismo. Se Dio si distingue dalla divinità, la relazione è
simile a quella tra l’uomo e l’umanità: come ci sono molti uomini, ci possono essere molti dei. Se
invece Dio si identifica con la divinità, c’è un solo Dio come c’è una sola divinità.
a. Il politeismo. Sono politeistiche tutte le dottrine che ammettono una distinzione tra la
divinità e Dio giacché la divinità non può essere partecipata da un numero indefinito di
enti. Per Platone nel Timeo Il Demiurgo delega ad altri dei, da lui stesso creati, parte delle
sue funzioni creatrici (Timeo 40d) e nelle Leggi l’espressione “Dio” designa la divinità in
generale che trova realtà in una molteplicità di dei. Oltre gli dei, vengono riconosciuti altri
esseri divini, che sono i demoni: “Dopo gli dei, l’uomo intelligente onora i demoni, dopo di
loro gli eroi” (Leggi, 717b). Secondo Aristotele, la stessa dimostrazione che vale per
l’esistenza del Primo Motore vale anche per l’esistenza di tanti motori quanti sono i
movimenti delle sfere celesti. Secondo Eudosso il numero delle sfere era di 47, secondo
Callippo era di 55, egli ammette 47 o 55 divinità che, per quanto subordinate al Primo
Motore, hanno lo stesso suo rango. D’altronde egli parla costantemente di “dei” e,
alludendo alla convinzione popolare che il divino abbraccia l’intera natura, ritiene uno degli
insegnamenti più preziosi che la tradizione ha salvato il fatto che “le sostanze prime sono
67
tradizionalmente ritenute dei” (Metafisica, XII, 8, 1074 a. 38). La sostanza divina è
partecipata da molte divinità: in ciò la credenza popolare e la filosofia concordano.
Conosciamo di Plotino la dottrina dell’Uno: ma l’unità di Dio non va confusa con l’unicità di
Dio. Dio è l’Uno perché è l’unità del mondo e la sorgente dalla quale scaturiscono o
emanano tutti gli ordini di realtà. Ma proprio per questo non è solo: l’unità non elimina la
molteplicità ma la raccoglie in se stessa. La molteplicità degli dei è anzi per Plotino la
manifestazione della potenza divina: “Non restringere la divinità ad un unico essere, farla
vedere così molteplice come essa si manifesta, ecco ciò che significa conoscere la potenza
della divinità, capace, pur restando quella che è, di creare una molteplicità di dei che si
connettono con essa, esistono per essa e vengono da essa” (Enneadi II, 9,9). La molteplicità
di dei in cui la divinità si moltiplica e si espande, senza rimanere veramente divisa, non
esclude una gerarchia e la funzione preminente di uno di essi (il Demiurgo o il Motore di
Platone, il Primo Motore di Aristotele, il Bene di Plotino); ma il riconoscimento della
gerarchia e di un capo della gerarchia non significa minimamente la coincidenza di divinità
e Dio e non è quindi un monoteismo. Anche dopo l’elaborazione cristiana del monoteismo
alcune forme di politeismo si riproporranno: sia in dottrine che riproducono lo schema
neoplatonico, sia nelle interpretazioni trinitarie meno riuscite. Per certi versi, ogni forma di
panteismo, antico o moderno, tende ad essere un politeismo: giacché tende a diffondere il
carattere della divinità su un certo numero di enti, indebolendo nello stesso tempo la
separazione tra questi enti e mantenendo la distinzione tra divinità e Dio. Per Hegel le
istituzioni storiche nelle quali si realizza la ragione autocosciente, e in primo luogo lo Stato,
sono vere e proprie divinità: “Lo Stato è la volontà divina in quanto attuale spirito
esplicantesi a forma reale e a organizzazione di un mondo” (Filosofia del diritto, & 270).
Bergson, Alexander, Withehead affidano al mondo il potere di realizzare la divinità: essa,
al momento della realizzazione, si concreterà in una molteplicità di enti divini. Da un altro
punto di vista Hume aveva dato una valutazione positiva del politeismo: esso, ammettendo
naturalmente che anche altri dei di altre sette o nazioni partecipano della divinità, rende
compatibili le varie deità e rende impossibile l’intolleranza; sia perché esso è più
ragionevole in quanto consiste “solo di una moltitudine di storie le quali, per quanto prive
di fondamento, non implicano alcuna assurdità espressa e contraddizione dimostrativa” (La
storia naturale della religione, sez. XI e XII, in Essays, II, 336. 352). Renouvier difendeva
esplicitamente il politeismo come l’unico correttivo del fanatismo religioso e
dell’assolutismo filosofico: “Il progresso della vita e della virtù popola l’universo di persone
divine e saremo fedeli a un sentimento religioso antico e spontaneo quando chiameremo
dei quelle tra loro di cui crediamo di poter onorare la natura e benedire le opere”
(Psicologia razionale, 1859, cap. XXV, ed. 1912, p. 306). Questo politeismo non è
inconciliabile con l’unità di Dio perché il Dio uno sarebbe allora la prima delle persone
superumane.
b. Il monoteismo. Esso è caratterizzato non dalla presenza di una gerarchia degli esseri e di
un capo di questa gerarchia, ma dal riconoscimento che la divinità è posseduta solo da Dio
68
e che Dio e la divinità coincidono. Esso compare in Filone di Alessandria il quale afferma
che “Dio è solitario e uno in se stesso e niente è simile a Dio … egli è nell’ordine dell’Uno e
della Monade o piuttosto è la monade nell’ordine del Dio uno: giacché ogni numero è più
recente del mondo e così il tempo, ma Dio è l’anziano e il Demiurgo del mondo” (Legis
allegoria, II, 1-3). Nelle discussioni trinitarie dell’età patristica e della Scolastica l’identità di
Dio e della divinità fu il criterio dirimente per riconoscere e combattere quelle
interpretazioni che inclinavano verso il triteismo. Certamente la Trinità è presentata
costantemente come un mistero che la ragione può appena sfiorare. Ma ciò che è
importante rilevare è che l’unità divina è ritenuta intaccata solo quando, con la distinzione
tra Dio e la divinità, si ammette, implicitamente o esplicitamente, la partecipazione della
divinità stessa da parte di due o più esseri individualmente distinti. S. Tommaso così
ricapitola una lunga tradizione: “E’ evidente che ciò per cui qualcosa di singolare è questo
singolare in nessun modo è comunicabile ad altre cose. Per esempio, ciò per cui Socrate è
uomo, si può comunicare a molti altri esseri; ma ciò per cui egli è questo uomo si può
comunicare a questo soltanto. Se dunque Socrate fosse uomo in base a ciò per cui è questo
uomo, come non vi può essere più di un Socrate, così non vi potrebbe essere più di un uomo.
Ma questo è proprio il caso di Dio, giacché Dio è la sua stessa natura sicché esso, nello
stesso rispetto, è Dio, e questo Dio; è impossibile pertanto che vi sia più di un Dio” (Summa
Theologiae, I, q. 11, a. 3). Questo è il motivo per cui i teologi medievali insistono sulla
semplicità della natura divina: tale semplicità significa infatti nient’altro che
l’incomunicabilità di quella natura e pertanto l’impossibilità che essa sia partecipata da più
di un Dio. Dopo S. Tommaso la decadenza della speculazione teologica ha reso i filosofi
meno sensibili alla loro precisione, sicché molto spesso le qualifiche di politeismo e
monoteismo vengono adoperate a caso e si limita il politeismo ad una manifestazione della
mentalità primitiva, laddove esso è, come si è visto, un’alternativa filosofica che ha per sé
l’intera tradizione classica e molti dei tentativi moderni di innovare il concetto di Dio.
4. La Rivelazione di Dio
Un altro modo di distinguere le concezioni di Dio parte dal modo in cui l’uomo trova o meno
accesso alla sua conoscenza. Su questo aspetto verte la distinzione e la polemica tra teismo e
deismo: esse si differenziano per il motivo che una attribuisce a Dio l’iniziativa di farsi conoscere
mentre il secondo attribuisce all’uomo la possibilità razionale di conoscerlo. Questi due punti di
vista possono trovarsi congiunti nella prospettiva che vede la rivelazione di Dio come conclusione
e compimento dello sforzo naturale dell’uomo di conoscere Dio.
a. Il deismo del ‘700. Esso ha il suo precedente storico nella dottrina della religione naturale
del ‘500-‘600 (Tommaso Moro, Herbert di Cherbury, Locke), che contrappone alla
rivelazione storica quella naturale che avviene attraverso l’opera della ragione; e giunge,
con Mattew Tindal, a vedere nel Vangelo soltanto “una ripubblicazione della legge di
69
natura” (Il cristianesimo vecchio come la creazione, 1730). Ovviamente una divinità che si
rivela alla ragione non ha né può avere che caratteri razionali; perciò il deismo restringe gli
attributi della divinità a quelli che possono essere determinati dalla ragione a partire dal
rapporto tra Dio e il mondo. Di fronte ad esso, il teismo, come dice Kant, “crede in un Dio
vivente, cioè in un Dio i cui attributi possono essere determinati secondo l’analogia con la
natura e sul fondamento della Rivelazione” (Critica della Ragion Pura, Dialettica, cap. III,
sez. VII). Occorre tuttavia rilevare che nella terminologia filosofica comparsa dopo il
Romanticismo e che è adoperata soprattutto dal panteismo, la rivelazione di Dio non è un
fatto storico, ma la progressiva manifestazione di Dio nella realtà naturale e storica del
mondo. Questo significato domina, oltre che le filosofie di Schelling ed Hegel, buona parte
delle filosofie dell’800 che obbediscono alla stessa ispirazione. Rosmini pone a fondamento
della filosofia, e in generale del sapere umano, l’idea dell’essere, che è la rivelazione
diretta, alla mente dell’uomo, dell’attributo fondamentale di Dio (Nuovo saggio, & 1055).
Gioberti analogamente considera come base della conoscenza l’intuito che è la rivelazione
immediata di Dio all’uomo (Introduzione, II, p. 46,1). Questa idea circola in dottrine
disparate e si può da ultima vedere presente anche in quelle che accentuano fino al limite
la trascendenza di Dio e pertanto vedono la sua sola rivelazione possibile nella sua
irraggiungibilità. Per Jaspers lo scacco inevitabile dell’uomo, nel suo tentativo di
raggiungere la Trascendenza, diventa l’unica possibile rivelazione, la cifra della
Trascendenza stessa (Filosofia III, p. 134).
b. Il teismo è espresso in tutta chiarezza in Pascal: “E’ il cuore che sente Dio, e non la ragione”
(Pensées, 278). E aggiunge: “La fede è un dono di Dio” (ibid., 279). L’autentica Rivelazione di
Dio al cuore dell’uomo è esclusivamente un’iniziativa divina, un’iniziativa che l’uomo può
bensì favorire, domando le proprie passioni, ma non sollecitare o provocare.
c. La posizione intermedia è instaurata dalla Patristica, che ha considerato la rivelazione
cristiana come compimento della filosofia greca. Quest’ultima, come compimento della
ragione, cioè del Logos che è il primogenito di Dio, contiene verità o germi di verità che il
cristianesimo porta allo sviluppo compiuto. Il principio che la Rivelazione non annulla o
rende inutile la ragione, dominò tutta la filosofia Scolastica e fu messo in dubbio solo dalle
ultime manifestazioni di essa nel sec. XIV. Nel Rinascimento esso viene invertito: la
rivelazione non giunge da ultima a compiere l’opera della ragione, ma la ispira e la sorregge
dall’inizio: la ragione non fa che trasmettere e illustrare la verità che Dio ha rivelato in
tempi remoti. In genere l’opera della ragione e della rivelazione collaborano insieme e non
sono antitetiche.
Un’attenzione particolare merita la riflessione su Dio nella seconda metà del ‘900.
a. Un primo indirizzo risente dell’attacco neopositivistico alla metafisica e dagli sviluppi del
pensiero epistemologico. Carnap ha contestato radicalmente il termine Dio, ritenendo che
esso, come la maggior parte dei termini specificatamente metafisici (l’Idea, l’Assoluto,
70
l’Incondizionato) sia senza significato. Tale parola ha avuto un senso in una fase storica
passata, ossia in quella contrassegnata dal pensiero mitico, quando si pensavano ancora gli
dei come nature fisiche, esistenti sull’Olimpo, in Cielo o nel mondo sotterraneo. Invece, dal
momento in cui la metafisica ha sottratto Dio da ogni rapporto con la realtà fisica, essa ha
perduto il suo significato originario, senza riceverne un altro (Il superamento della
metafisica mediante l’analisi logica del linguaggio, 1932-33, tr. it. in AA.VV., Il
neoempirismo, Utet, Torino 1969; 512-513). Ayer afferma a sua volta: “Non vi possono
essere verità trascendenti di fede religiosa, poiché gli enunciati cui il teista ricorre per
esprimere tali verità non hanno significato letterale” (Linguaggio, verità e logica, 1936, tr.
it., Feltrinelli, Milano 1961, p. 154). Tale ateismo semantico si distingue sia dall’ateismo
tradizionale, sia dall’agnosticismo corrente: “Perché, se l’asserzione dell’esistenza di Dio è
un non senso, allora l’asserzione ateistica della inesistenza di Dio è altrettanto un non senso
… Non neghiamo che <<C’è un Dio trascendente>> e <<non c’è un Dio trascendente>>
esprimano due proposizioni di cui una sia effettivamente vera e l’altra falsa, ma non
abbiamo mezzi per decidere quale di esse sia la vera” (ibid., 152). Rimane valido, a
proposito di Dio, il monito del primo Wittgenstein: “Su ciò di cui non si può parlare, si deve
tacere” (Tractatus logico-philosophicus, 7: tr. it., Einaudi, Torino 1995, 109). A differenza di
Carnap e di Ayer, Popper ritiene che il discorso metafisico sia dotato di senso. Ma la sua
posizione verso la teologia non è più favorevole. Essa non appartiene al campo delle
proposizioni falsificabili, cioè smentibili in linea di diritto e di fatto, perciò è destituita di
ogni valore scientifico e conoscitivo. Essa, cercando di salvare ad ogni costo l’idea di Dio,
riesce a mantenersi in vita solo in virtù di continue strategie di immunizzazione. A. Flew
illustra questa tesi con un racconto tratto da J. Wisdom: “Una volta due esploratori
giunsero in una radura sulla giungla. Nella radura crescevano molti fiori e molte erbacce.
Uno degli esploratori dice: <<Ci deve essere un giardiniere che ha cura di questa radura>>.
L’altro dissente: <<Non c’è nessun giardiniere>>. Allora alzano le tende e organizzano turni
di sorveglianza. Non si vede mai nessun giardiniere. <<Ma forse si tratta di un giardiniere
invisibile>>. Drizzano allora un recinto di filo spinato, vi fanno passare la corrente elettrica,
perlustrano il recinto con i segugi. Si ricordano, infatti, che L’uomo invisibile di H. G. Wels si
poteva odorare e toccare, anche se non si poteva vedere. Ma nessuno grida mai di aver
ricevuto la scarica elettrica. Nessun movimento del reticolato rivela qualcuno che tenta di
oltrepassarlo. I segugi non abbaiano mai. Eppure il credente non è ancora convinto. <<C’è
un giardiniere invisibile, impalpabile, insensibile alle scariche elettriche, un giardiniere che
non ha odore e non fa rumore, un giardiniere che viene di nascosto per aver cura del
giardino che ama>>. Lo scettico alla fine dispera: <<Ma che cosa rimane della tua
asserzione originaria? Vuoi dirmi in che cosa il tuo giardiniere invisibile, impalpabile,
eternamente sfuggente differisce da un giardiniere immaginario o anche da un giardiniere
inesistente?>>” (Teologia e confutazione, in AA.VV., Nuovi saggi di teologia filosofica, 1955,
1963; tr. it., Dehoniane, Bologna 1973, 132). Il significato di tale parabola atea è chiaro: se
l’affermazione dell’esistenza di Dio (simboleggiata dall’invisibile giardiniere) viene sottratta
71
a qualsiasi controllo empirico non le si può attribuire alcun senso e Dio muore davvero,
come dice Flew, “della morte di mille qualificazioni”.
b. In un noto passo della Gaia Scienza Nietzsche proclama la morte di Dio, ossia il tramonto
epocale di tutte le certezze metafisiche, morali e religiose escogitate dall’umanità
attraverso i secoli per esorcizzare il fluire caotico delle cose e per dare un ordine
rassicurante alla vita: “Avete sentito di quell’uomo folle che accese una lanterna alla chiara
luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: <<Cerco Dio! Cerco
Dio!>>? E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio,
suscitò grandi risa: <<Si è forse perduto?>> disse uno. <<Si è smarrito come un bambino?>>,
fece un altro. <<Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? È emigrato?>>,
gridavano e ridevano in una gran confusione. L’uomo folle balzò in mezzo a loro e li
trapassò con i suoi sguardi: “<<Dove se n’è andato Dio?>>, gridò, <<ve lo voglio dire!
L’abbiamo ucciso – voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto? Come
abbiamo potuto vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci ha dato la spugna
per strofinare via l’intero orizzonte? Che mai facemmo per sciogliere questa terra dalla
catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli?
Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste
ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla?
Non alita su di noi lo spazio vuoto? – Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire notte,
sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i
becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo ancora nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo
della divina putrefazione? Anche gli dei si decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E
noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto
di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi si è dissanguato sotto i nostri
coltelli – chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo lavarci? Quali riti
espiatori, quali sacre rappresentazioni dovremo inventare? Non è troppo grande, per noi, la
grandezza di questa azione? Non dobbiamo anche noi diventare dei, per apparire almeno
degni di essa? Non ci fu mai un’azione più grande – e tutti coloro che verranno dopo di noi
apparterranno, in virtù di questa azione, a una storia più alta di quanto mai siano state
tutte le storie fino ad oggi!>>. A questo punto l’uomo folle tacque, e rivolse di nuovo lo
sguardo sui suoi ascoltatori: anch’essi tacevano e si guardavano stupiti. Finalmente gettò a
terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. <<Vengo troppo presto>>, proseguì,
<<non è ancora il mio tempo>>. Questo enorme evento è ancora sulla strada e sta facendo
il suo cammino – non è ancora arrivato alle orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono
tempo, la luce delle stelle vuole tempo, le azioni vogliono tempo, anche dopo essere state
compiute, perché siano viste e ascoltate. Quest’azione è ancor sempre più lontana dagli
uomini delle stelle più lontane – eppure son loro che l’hanno compiuta!>> - Si racconta
ancora che l’uomo folle abbia fatto irruzione, quello stesso giorno, in diverse chiese e quivi
abbia intonato il suo Requiem Aeternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato, si dice che si
fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo modo: <<Che altro sono ancora queste
72
chiese, se non le fosse o i sepolcri di Dio?” (af. 125, in Opere, ed. Colli-Montinari, Adelphi,
Milano 1965, n.e. riveduta 1991, vol. V, t. 2, pp. 150-152). Nietzsche fa coincidere la morte
di Dio con la nascita del superuomo. Solo chi ha avuto il coraggio di guardare in faccia la
realtà crudele del mondo è ormai maturo per varcare l’abisso che divide l’uomo
dall’oltreuomo. Ne segue che la morte di Dio costituisce sì un “trauma”, ma solo in
relazione ad un “uomo non ancora superuomo”. Viceversa, il superuomo, se ha dietro di
sé, come condizione necessaria del suo essere, la morte di Dio e la vertigine da essa
provocata, ha davanti a sé il “mare aperto” delle possibilità connesse ad una libera
progettazione della propria esistenza al di là di ogni struttura metafisica data: “noi filosofi e
<<spiriti liberi>>, alla notizia che <<il vecchio Dio è morto>>, ci sentiamo come illuminati dai
raggi di una nuova aurora; il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di meraviglia, di
presagio, di attesa – finalmente l’orizzonte torna ad apparirci libero, anche ammettendo
che non è sereno, finalmente possiamo di nuovo sciogliere le vele alle nostre navi, muovere
incontro a ogni pericolo; ogni rischio dell’uomo della conoscenza è di nuovo permesso; il
mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto dinanzi, forse non vi è mai stato un mare così
<<aperto>>” (af. 343, tr. it. cit., 240). Dalla profezia di Nietzsche, scorgendo nel tramonto
degli assoluti metafisici ed assiologici l’evento centrale e onnipervadente della modernità,
le varie correnti dell’ateismo novecentesco (esistenzialistiche, marxiste …) hanno ritenuto
di dover annunciare anch’esse, ognuna a suo modo, la morte inequivocabile di Dio e la
mondanizzazione totale dell’esistenza: “Vedi tu questo vuoto sulle nostre teste? Questo
vuoto è Dio. Vedi l’apertura nella porta? Io ti dico: essa è Dio. Vedi questo buco in terra? Il
silenzio è Dio. L’assenza è Dio, la solitudine dell’uomo è Dio … Non più cielo! Non più
inferno! Nient’altro che la terra” (SARTRE, Il diavolo e il buon diavolo, Paris 1951, 267-268).
Negli anni sessanta, in seguito ad un processo di de-sostanzializzazione del divino, la
formula nietzschana è divenuta l’insegna di un modo di fare teologia – la cosiddetta
<<teologia della morte di Dio>> - che, paradossalmente, non si occupa più di Dio, ma
piuttosto della sua assenza. E ciò in vista di una rinnovata prassi dell’amore in grado di
permettere all’uomo di essere totalmente uomo e alla storia di essere integralmente
umana (W. HAMILTON, The new Essence of Christianity, 1961; Th. ALTIZER, The Gospel of
Christian Atheism, 1966). Di “morte di Dio” hanno anche parlato gli autori che si ispirano ad
Auschwitz, scorgendo, nei suoi “campi della morte”, il simbolo più drammatico della
situazione dell’uomo orfano di Dio. In uno dei libri-testimonianza più significativi, E. Wiesel,
raccontando dell’impiccagione di tre prigionieri, fra cui un bambino dagli occhi tristi, scrive:
“Dov’è dunque Dio? … Dov’è? Eccolo: è appeso lì a quella forca” (La notte, tr. it. Giuntina,
Firenze 1980, pp. 66-67). L’idea di un Dio morente sulla forca di Auschwitz sta anche alla
base del messianismo deluso di R. Rubenstein: “l’escatologia è una malattia, con la quale
l’uomo dissimula a se stesso il volto tragico e in definitiva disperato del suo fato. C’è un solo
messia che ci redime dall’ironia, dal lavoro e dalle angustie dell’esistenza umana. Egli verrà
sicuramente. Ma egli è l’Angelo della morte” (After Auschwitz, Bobbs-Merrill, New York
1966, p.225). E già prima, in uno dei documenti più espressivi della cosiddetta letteratura
73
delle macerie (che aveva come sottotitolo <<dramma che nessun teatro vuole
rappresentare e nessun pubblico vuole vedere>>) W. Borchet, descrivendo l’esperienza
angosciante del silenzio di Dio, aveva parlato di un “Dio nel quale nessuno più crede”
(Draussen vor der Tur, 1947, Reimbek 1973, pp. 41-43). Da ciò la tesi di Adorno, ripresa da
Jonas, secondo cui “nessuna parola risuonante dall’alto, neppure teologica, ha un suo
diritto d’essere immodificata dopo Auschwitz” (Dialettica negativa, 1966, tr. it., Einaudi,
Torino 1970, p. 332). Secondo Heidegger l’ontoteologia occidentale sorge sullo sfondo di
un originario oblio dell’essere (concepito come ni-ente di ogni ente) e mette capo
all’immagine di Dio come il più essente tra gli essenti, ovvero alla rappresentazione
dell’Assoluto come di una astratta ratio del mondo – una causa sui – imparentata con il
pensiero calcolante della tecnica. A questo Dio “l’uomo non può né rivolgere preghiere né
offrire sacrifici … davanti alla causa sui l’uomo non può ne cadere in ginocchio pieno di
reverenza, né produrre musica e danzare. Così, il pensiero privo di un Dio, il pensiero che
deve fare a meno del Dio della filosofia, del Dio come causa sui, è forse il più vicino al
divino” (Identità e differenza, 1957, tr. it., <<aut-aut>>, n.187-188, 1982, pp. 35-36). Con la
denuncia della sostanza irreligiosa della metafisica e con la distinzione tra il Dio filosofico e
il Dio divino, Heidegger, indipendentemente dal ruolo effettivo che tali nozioni rivestono
all’interno del suo pensiero – che sul problema di Dio è rimasto piuttosto aperto – ha
contribuito ad avvalorare l’ipotesi, presenta in ampi settori della cultura novecentesca, che
Dio non sia come lo si è filosoficamente rappresentato lungo i secoli (ossia attraverso i
parametri concettuali dell’ontologia greca e medievale). Alla luce di queste prese di
posizione, la teologia filosofica, cioè l’indagine razionale su Dio e sulla sua essenza
nascosta, è apparsa radicalmente impossibile, o perché destituita di qualsiasi valore
cognitivo e linguistico, o perché priva di oggetto reale, o perché fondata su di un equivoco
metafisico derivante da una ipostatizzazione ontica del divino. Diversi filoni della teologia
evangelica del ‘900 hanno preso le mosse da tale impostazione, ritenendo che l’unica via di
accesso a Dio sia la fede. A Fichte, il quale aveva affermato che “soltanto nella suprema
fatica del pensiero si manifesta Dio” (Die Answeisungzum seligen Leben, 1806, tr. it.,
Introduzione alla vita beata, Lanciano 1913, p. 86), Barth oppone che la ragione umana è di
per se stessa “cieca nei confronti della verità di Dio” (Nein! Antwort an Emil Brunner,
Minchen 1934, p. 34) e Bultmann che “ogni discorso umano su Dio, condotto al di fuori
della fede, non porta a Dio, bensì al diavolo” (Glauben und Verstehen in Gesammelte
Aufsatze, Bd I, Tubingen 1933, p. 303). Di conseguenza i teologi (Tillich, Rahner,
Pannemberg …) e i filosofi che, a discapito di ogni proclamazione di ateismo semantico e di
irrazionalismo fideistico, hanno continuato a credere in una qualche forma di teologia
filosofica o di “filosofia di Dio”, si sono trovati di fronte alla legittimità di dover legittimare
le loro ricerche mediante un confronto critico con l’epistemologia, l’ateismo e
l’heideggerismo. Tale confronto si è incarnato nell’imperativo di “parlare di Dio oltre Dio”,
cioè in maniera alternativa rispetto a una bi millenaria tradizione filosofica e teologica
incentrata su categorie vetero-metafisiche come “causa ordinante”, “causa creante”,
74
“causa immanente” etc. In particolare, contro le strettoie del verificazionismo e del
falsificazionismo, si è affermato che il discorso filosofico su Dio, concepito come un gioco
linguistico significante, dotato di una specifica portata cognitiva (e non puramente come
pratico- emotiva, secondo la tesi di Hare, Ramsey, van Buren), possiede delle peculiari
modalità di controllo dei propri asserti, i quali non vengono elaborati nel vuoto, ma in
rapporto a una realtà (di cui Dio costituisce l’ipotesi esplicativa) che può confermarli o
smentirli, sia pure in un modo certo e definitivo. Contro le varie forme di ateismo, si è
affermato che la presunta “morte di Dio” coincide, di fatto, con la morte delle
rappresentazioni tradizionali di Dio e con l’avvento di nuove maniere – postmetafisiche,
postnichilistiche, postsessiste etc. – di rapportarsi all’Assoluto. Maniere che partono dal
presupposto del carattere inevitabilmente storico e locale, cioè prospettico e fallibile, del
discorso umano su Dio, il quale si concretizza in una pluralità insopprimibile di voci,
nessuna delle quali, in omaggio al principio postmoderno della “priorità della democrazia
sulla teologia” può pretendere di azzerare le altre. Contro Heidegger si è affermato che
l’essere acquista un senso soltanto in riferimento a Dio (e non viceversa) in quanto Dio non
è un ente, ma l’essere stesso. La necessità di “pensare Dio altrimenti” si è concretizzata sia
nelle nuove teologie, ossia in quelle correnti teologiche che hanno perseguito l’ideale di un
“parlare credibile di Dio”, che tenga conto delle inquietudini e dei quadri mentali dell’uomo
contemporaneo, sia in nuovi modelli filosofici che hanno affrontato il problema di Dio dal
punto di vista dell’Altro, dell’ingiustizia del mondo, del mistero del male, dell’evento
Auschwitz, della postmodernità, della differenza sessuale.
In rapporto all’Altro, Levinas parte dal concetto di una radicale trascendenza dell’Assoluto
e sostiene che Dio, inteso non come l’essere sommo dell’ontoteologia, ma come
l’inoggettivabile volto di tutti i volti, non si manifesta in qualche Gelassenheit (calma,
tranquillità) di tipo mistico-quietistico, ma nella concretude della relazione etica fra il Moi e
l’Autre: “La dimensione del divino si apre a partire dal volto umano … Non può esserci
alcuna conoscenza di Dio a prescindere dalla relazione con gli uomini” (Totalità e Infinito,
1961, tr. it. Jaca Book, Milano 1980, pp. 73. 76-77). Questa idea di una divinità che, anziché
venire tematizzata, richiede di essere testimoniata, vien fatta coincidere con
l’insegnamento più alto della Bibbia, che il nostro autore rilegge in termini di Kerigma
etico: “Mosè e i profeti non si dan pena dell’immortalità dell’anima, ma del povero, della
vedova, dell’orfano, dello straniero” (Difficile libertà, 1963, 1976, tr. it. parz., La Scuola,
Brescia 1986, p. 76).
In rapporto all’ingiustizia del mondo, l’ultimo Horkheimer afferma che Dio non è una
certezza, ma una speranza, in quanto si identifica con la nostalgia e il desiderio (Sehnsucht)
che, nonostante tutta la disarmonia che caratterizza il mondo “non possa avvenire che
l’ingiustizia possa essere l’ultima parola” e che “l’assassino possa trionfare sulla vittima”
(La nostalgia del totalmente altro, 1970, tr. it. Queriniana, Brescia 1972, 74-75). Tale
75
speranza deve rimanere tale, poiché se Dio, inteso come dogma positivo e oggetto di
sapere, ha un effetto di separazione, inteso come nostalgia, unisce e affratella.
Dal 1975 al 1985 Luigi Pareyson passa dall’ontologia dell’inesauribile all’ontologia della
libertà. La filosofia logico – razionale ha manifestato la sua insufficienza ad affrontare i
problemi esistenziali della libertà, del male e di Dio, negandone di fatto la realtà. Egli
filosofa a partire dalla sua opzione esistenziale per il cristianesimo considerato come “fatto
eterno” e assumendo la meditazione schellinghiana sul carattere tautegorico del simbolo: il
simbolo esprime una tensione dialettica tra fisicità e trascendenza, tra presenza e
ulteriorità, tra identità e alterità. Il pensiero filosofico è chiamato ad uscire da sé per
trasformarsi in ermeneutica del linguaggio simbolico. I saggi su Dostoevskij costringono
Pareyson a prendere sul serio la realtà positiva del male: esso non può essere ricondotto
solo a semplice ignoranza o fragilità umane, o a ridimensionamento dell’essere e del bene.
Esso è positiva negazione, ribellione, rifiuto, rivolta, nulla attivo, forza travolgente e
distruttiva. Prendendo poi in considerazione l’esperienza della libertà, prima di tutto risalta
il suo carattere illimitato e dialettico. Nulla precede la libertà, che è inizio a se stessa. Per
l’altro verso ha un carattere dialettico: non può scegliere il bene se non avendo presente
anche la possibilità del male, e viceversa. Ciò fa sì che nella storia dell’uomo il bene è
sempre mescolato con il male, le buone intenzioni intrecciate con le cattive.
Nell’esperienza cristiana di Dio il male rivela tutto il suo carattere misterioso e profondo e
la libertà acquista un peso decisivo e tragico. Proprio a partire dallo scandalo del dolore
innocente, nel saggio La sofferenza inutile in Dostoevskij, del 1982, Pareyson nota come
l’autore russo ritrova Dio attraverso la massima rigorizzazione dell’ateismo, ritrova il
mondo attraverso le forme più vistose della sua negazione, ritrova il valore della vita
attraverso il nichilismo più totale. Lo scandalo della sofferenza degli innocenti è superato
da uno scandalo più grande: la sofferenza di Cristo, uomo-Dio, che accoglie liberamente,
pur essendo innocente, la sofferenza. Scrive il nostro autore: “L’idea del Dio sofferente è
l’unica che possa resistere all’obiezione della sofferenza inutile come dimostrazione
dell’assurdità del mondo … L’idea fondamentale di Dostoevskij è che se per un verso
l’umanità è liberata dalla sofferenza perché la stessa sofferenza è portata in Dio, per l’altro
verso il senso della sofferenza dell’umanità è la con sofferenza col Redentore che col suo
dolore ha soppresso quello dell’umanità (1 Pt 2, 19.21-24)” (Dostoevskij. Filosofia, romanzo
ed esperienza religiosa, Einaudi, Torino 1993, 211). Ora col Cristo sofferente nasce il
concetto di un Dio dialettico, che ha in se stesso l’antinomia e la contraddizione,
l’opposizione e il contrasto, il dissidio e il conflitto. Ma qual è l’origine prima del male? Il
nostro autore qualifica Dio come libertà, inizio assoluto e scelta tra positivo e negativo. In
quanto inizio assoluto, la libertà di Dio non è preceduta da nulla, perché è essa stessa il
principio dell’essere di Dio: Egli è perché vuole essere e come vuole essere, senza essere
costretto né ad essere, né ad essere in un certo modo. La filosofia della libertà prende
dunque le distanze dalla concezione di Dio come essere necessario, in cui essenza ed
esistenza coincidono: “L’essere necessario non esiste, e il vuoto immane lasciato dalla sua
76
inesistenza non può essere riempito che dall’abisso della libertà” (Esistenza e persona, Il
Melangolo, Genova 1985, 29). Tutta la realtà, Dio compreso, è senza fondamento, pura
gratuità perché è vertiginosamente sospesa sull’abisso della libertà. La libertà pone se
stessa, risiede in tale atto di auto posizione e non rimanda ad altro da sé. La libertà di Dio è
anche scelta tra positivo e negativo, libero arbitrio. L’inizio, infatti, è come tale già una
scelta, perché la libertà potrebbe non cominciare, cioè non uscire dal non essere, o
potrebbe cessare, cioè entrare nel non essere da cui è emersa. La libertà è
simultaneamente la libertà della scelta e la scelta della libertà: essa può affermare se
stessa o ricadere nel suo nulla. In principio era la scelta. La filosofia della libertà, oltre che
riferirsi a diversi filosofi, è l’ermeneutica filosofica dell’esperienza ebraico – cristiana di Dio.
Il Dio della Bibbia è il Dio vivente, “il quale agisce liberamente, fa tutto quel che vuole, è
libertà assoluta e arbitraria” (Ontologia della libertà, Mursia, Milano 132). L’unica necessità
presente in Dio è l’irrevocabilità della sua scelta di essere, dell’atto di libertà. Così va
interpretata l’irreversibilità dell’essere. Dunque l’atto eterno della creazione è stato
preceduto, in Dio, dall’atto eterno del suo auto originarsi. Tale inizio assoluto introduce
nell’eternità di Dio una specialissima temporalità, espressa dalla formula paradossale di
“Dio prima di Dio”. Se Dio è libertà, Egli è al tempo stesso prima e dopo di sé. Tale
scansione o simbolismo temporale nell’eternità è una sorta di storia eterna che si scandisce
in diverse epoche dell’eternità o eoni, indeducibili l’uno dall’altro perché introdotti da
altrettanti atti di libertà del tutto imprevedibili. In secondo luogo, nel momento in cui Dio
sceglie di essere e si origina, simultaneamente istituisce l’alternativa tra il positivo scelto e
il negativo scartato, tra il bene cui si dà inizio e il male che viene vinto. Nel cuore stesso
della libertà originaria di Dio nasce così la dialettica tra essere e non essere, tra bene e
male, tra essere e bene reali e non essere e male possibili. Il fatto che Dio esista significa
che all’origine e nel cuore stesso della realtà vi è questa scelta definitiva e originaria del
bene, senso primo e ultimo di tutto. Allo stesso tempo tale scelta originaria del bene è
indisgiungibile dall’instaurarsi della possibilità del male. Esso è vinto e sconfitto ab aeterno,
ma rimane un’alternativa possibile, istituita dalla libertà divina nel momento stesso in cui è
scelta come libertà positiva. Ciò è significato dall’espressione temeraria “il male in Dio”,
definita come metafora – simbolo sintetica, per indicare il senso indicibile e paradossale
della dialettica di positivo e negativo intima al Dio – libertà. Il “male in Dio” non attribuisce
una realtà effettiva al male in Dio, né esso è uno sfondo oscuro o natura abissale da cui Dio
dovrebbe progressivamente emergere per diventare propriamente se stesso (Schelling),
né è un momento necessario del processo dialettico in cui Dio si realizza e il bene si
afferma (Hegel). Tale dialettica di positivo e negativo in Dio non è una dialettica della
necessità ma una dialettica della libertà: il male, in Dio, è una possibilità vinta e superata
fin dall’inizio, e mai è stata una realtà effettiva. In Dio vi è l’origine della possibilità del male
che l’uomo con la sua libertà può ridestare e rendere realtà effettiva. Solo l’uomo può
essere nella storia l’autore del male. Tale dialettica originaria di positivo e negativo
corrisponde all’esperienza religiosa di Dio, in cui Egli si presenta allo stesso tempo fonte di
77
salvezza e di perdizione, di misericordia e di ira, di gioia beatificante e di sconvolgente
terrore. A parte hominis in Dio vi è qualcosa che per un verso è fonte di rassicurazione e
per altro verso è fonte di inquietudine. L’interpretazione filosofica di tale esperienza
religiosa rientra nella categoria di ambiguità di Dio. Se in Dio il male è presente solo come
vinto, la caduta non è un fatto necessario e ciò apre la speranza che la vittoria sul male
possa essere operante anche nella storia e dopo la storia. La stessa positività di Dio, che è
tale in quanto vittoria ab aeterno sulla negatività, può presentarsi all’uomo come
provocazione alla ribellione. Il successivo atto della storia eterna della libertà è la
creazione: essa è un atto di libertà – liberalità, in cui Dio mostra tutta la sua
condiscendenza e generosità; per l’altro verso essa è un ritirarsi o contrarsi di Dio per far
posto alla libertà dell’uomo, un primo momento della kenosi di Dio. Con la caduta, l’uomo
ha ridestato il male sepolto dall’eternità in Dio. Il peccato originale è ribellione alla
positività di Dio e realizzazione della negatività in Lui originariamente vinta. Esso è allo
stesso tempo atto libero della storia eterna e inizio della storia temporale umana. Per
questo in quest’ultima il male è più che una possibilità, è una presenza reale, una forza che
combatte contro il bene e potrebbe anche avere l’ultima parola. La dialettica storica si
differenzia profondamente dalla dialettica eterna: nella seconda nel momento della scelta
del positivo è istituita la possibilità del negativo, vinta definitivamente, la prima è una
dialettica tra il bene e il male reali, è contraddizione, lotta e tensione dei contrari. Essa non
è la dialettica hegeliana, in cui il negativo in realtà non è perché tolto, ma è innescata dalla
libertà e l’ultima parola non sarà mai la conciliazione o il superamento o la mediazione,
bensì essa è contraddizione, lotta, tensione. Il libero intervento redentivo di Dio nella storia
inaugura un’ulteriore dialettica: la dialettica della sofferenza. Tale dialettica aggiunge alla
comune solidarietà nella colpa la comune solidarietà nell’espiazione. Tale dialettica, che
culmina nel Dio crocifisso, istituisce un nesso tra la dialettica eterna e la dialettica
temporale. La sofferenza espiatrice è il perno della rotazione dal negativo al positivo:
“L’idea del Dio sofferente approfondisce il significato dell’ambiguità di Dio e imprime un
nuovo dinamismo alla dialettica divina” (ibid., 223). Il male in Dio, prima incontrato come
possibilità istituita dalla scelta eterna e definitiva del bene e, dunque, vinta, dal principio,
ora è un male reale, liberamente assunto da Dio, fino a patire e morire. La dialettica di ira e
misericordia, crudeltà e benevolenza ora diventa dialettica di onnipotenza e impotenza, in
quanto Dio vince il male positivo con la sua sofferenza e impotenza. Tale interpretazione
filosofica del cristianesimo è “pensiero tragico”: esso supera non tanto l’alternativa tra
ateismo e cristianesimo, ma quella tra il nichilismo, che cancella sia Dio che il male ed è
consolatorio, e il cristianesimo tragico che afferma simultaneamente l’esistenza di Dio e del
male, fino ad individuare la presenza del male e del dolore in Dio stesso. L’ultima tappa
della storia eterna in Dio è l’escatologia. Pareyson la divide in escatologia del giudizio e in
apocatastasi: entrambi i momenti implicano un salto imprevedibile, un nuovo intervento
della libertà divina. Egli opta per l’avvento di una salvezza universale e definitiva, umana e
cosmica. Anche l’apocatastasi è un evento dialettico, secondo una dialettica più
78
antinomica, contraddittoria e impensabile. Per Hegel nello stadio finale della storia dello
Spirito tutte le contraddizioni saranno superate. Per il nostro autore, invece, nella
conclusione finale, che sta al di là della storia senza continuità con essa, le contraddizioni
esploderanno al massimo grado: devono essere tenute insieme la totalità e la libertà, la
libertà umana e la definitività del bene, la trascendenza di Dio e la sua identificazione con
tutte le cose, il compimento di Dio senza che vi sia stato un vero processo in Dio, la
spiritualità di Dio e la sua incarnazione nell’intero mondo corporeo. Abbiamo un nodo
inestricabile di contraddizioni, che sfugge alla filosofia e su cui tace la teologia, ma anche
una profondità abissale altamente speculativa, da cui può sgorgare nuova luce per
intendere il senso della vicenda del mondo. La speranza escatologica si identifica con la
speranza che il bene alla fine vincerà nuovamente e in modo definitivo sul male, per
quanto quest’ultimo possa essere grande nella storia. Nell’eternità di Dio l’escatologia
coincide con la protologia ma ciò non avviene, come vorrebbe Hegel, con un processo
necessario. Anche la prospettiva escatologica è appesa alla libertà, quindi priva di ogni
fondamento razionale. Ciò vuole anche dire che essa è del tutto incomprensibile per la
nostra ragione. L’ontologia della libertà è un’interpretazione filosofica del cristianesimo
come fatto eterno, che cerca di cogliere lo “spirito” di questo fatto, quella dimensione di
pensiero che porta con sé e può parlare a tutti. Lo spirito del cristianesimo è il pensiero
della libertà, la scelta della dialettica della libertà rispetto alla dialettica della necessità di
derivazione greca. Il pensiero della libertà è pensiero tragico, perché sottolinea
particolarmente il momento del negativo che caratterizza la dialettica della libertà. Se Dio
ha vinto il negativo assumendolo e sopportandolo, il cristianesimo attuale può vincere il
nichilismo sopportandolo, portandolo al proprio interno come cristianesimo tragico.
L’impostazione pareysoniana sembra ancora debitrice di una concezione sacrificale –
espiatoria del dolore: il dolore appare come il passaggio necessario perché il negativo si
volga in positivo. La dialettica della sofferenza sembra spesso appiattirsi alla dialettica del
dolore, mentre va distinta da essa, introducendo, tra l’una e l’altra, la mediazione della
dialettica dell’amore, cioè della libera assunzione del dolore che il male ci infligge in vista
della vittoria sul male e del suo capovolgimento in bene. Non è il dolore in sé che volge il
negativo in positivo, ma la forza dell’amore. La testimonianza di un amore che assume su di
sé il dolore attesta la conversione della libertà dalla scelta del male alla scelta del bene. La
dialettica dell’amore, nella quale si rivela il vero volto di Dio, è il culmine sia della dialettica
divina della libertà di scelta tra positivo e negativo sia della dialettica divina della
sofferenza.
H. Jonas ritiene che di fronte al male nel mondo – e a quel male di tutti i mali che è
Auschwitz - non si possano più sostenere simultaneamente in Dio la bontà, la
comprensibilità e l’onnipotenza. Infatti in rapporto al male un Dio onnipotente “o è privo di
bontà o è totalmente incomprensibile” (Il concetto di Dio dopo Auschwitz, Il Melangolo,
Genova 1990, 34). Ma un Dio privo di bontà cessa di essere Dio, mentre un Dio totalmente
incomprensibile è qualcosa di cui non possiamo neppure discorrere. Non resta quindi che
79
abbandonare il problematico concetto di onnipotenza (per quanto scandalosa possa essere
percepita questa scelta, soprattutto per chi è abituato a pensare Dio con la mano forte e il
braccio teso). In altri termini, se vogliamo continuare a discorrere di Dio in modo sensato
rapportando il nostro discorso al mistero del male, dobbiamo ammettere che Egli non è
intervenuto ad impedire Auschwitz “non perché non lo volle, ma perché non fu in
condizione di farlo” (ibid., 35). Infatti, concedendo all’uomo la libertà, Dio ha rinunciato alla
sua potenza. Siamo in una concezione finitista di Dio, che riesce a conciliare la bontà e
comprensibilità dell’Assoluto, senza cadere nella teologia manichea dei due dei.
I postmoderni sono convinti che il cambiamento di statuto del sapere verificatosi nelle
società post – industriali (Lyotard) implichi un parallelo cambiamento di quella forma
peculiare che è il sapere su Dio. Secondo O. Maquard, il pluralismo postmoderno ha, come
inevitabile risvolto teologico, il venir meno della tradizionale idea di un Dio unico come
“figura agente centrale”. E ciò a favore di un “politeismo disincantato” che fa tutt’uno con
il passaggio dalla monomiticità alla polimiticità (Apologia del caso, Il Mulino, Bologna 1987,
52-56). Vattimo identifica il Dio della metafisica con un Dio violento, cioè con una divinità
che possiede quei caratteri di onnipotenza, autorità e trascendenza che gli sono attribuiti
dalle teologie naturali. A questa divinità egli contrappone un Dio non violento e non
assoluto, ovvero un Dio postmetafisico avente come suo tratto distintivo quella “vocazione
all’indebolimento di cui parla la filosofia di ispirazione heideggeriana” (Credere di credere,
Garzanti, Milano 1996, 31). Nella postmodernità consideriamo anche la corrente del nuovo
ateismo (Dawkins, Harris, Hitchens). Costoro postulano quattro verità a loro dire evidenti:
a) il presupposto della vita umana è trovare la felicità ma molte persone nel mondo
conducono vite inutilmente miserevoli. La sofferenza e la morte fanno parte del cammino
necessario dell’evoluzione, ma dobbiamo impegnarci per alleviare alcune afflizioni,
allungare la vita e per garantire una forma di benessere superiore a tutte le altre alla
maggior parte degli individui; b) la causa di tanta angoscia inutile è la fede, in particolare
nella forma della fede in Dio. La fede è credere senza prove, inammissibile per una
mentalità scientifica: ciò è assurdo e avvelena ogni cosa. Basare la conoscenza su prove è
necessario da un punto di vista cognitivo, ma è anche moralmente essenziale; c) il modo
oggi per evitare la sofferenza inutile è abolire la fede sulla faccia della terra, realizzare un
mondo in cui mutilazioni e assassinii nel nome di Dio diventino veramente impensabili; d) il
modo di eliminare la fede e di liberarsi della sofferenza consiste nel seguire la sacra via
del metodo scientifico. Per costoro la fede nell’esistenza di Dio è un’ipotesi che, per i
credenti, svolge la stessa funzione di un’ipotesi scientifica per gli scienziati. La fede è un
tentativo intellettualmente erroneo per arrivare a qualcosa che somigli alla comprensione
scientifica, è credere senza prove. Nella scienza un’ipotesi è il contesto che rende
intellegibile una gamma di osservazioni e di esperimenti intellegibili. Altri autori “teisti”
ricorrono a qualcosa di simile all’ipotesi Dio per spiegare la complessità biologica: l’ipotesi
del disegno intelligente. I nuovi atei hanno deciso che la teologia non conta e va esclusa
dall’attuale discussione, insieme all’ipotesi “Dio”. Costoro si adoperano per dimostrare che
80
non ci sono prove a supporto dell’ipotesi Dio. Il problema fondamentale della fede è che
essa non si basa su prove, o su prove sufficienti, pertanto deve essere rifiutata in tutte le
sue forme. La scienza, al contrario, può fare riferimento a innumerevoli osservazioni
riproducibili a supporto delle proprie ipotesi, e mentre un bravo scienziato abbandona o
modifica un’ipotesi, se gli esperimenti lo richiedono, i fedeli si aggrappano alla loro ipotesi
di Dio senza curarsi dell’inesistenza di prove. Infine la scienza ha dimostrato che l’ipotesi di
Dio è una violazione del “rasoio di Occam”. Quest’ultimo è un assioma della scienza che
afferma che non si dovrebbe mai fare ricorso a una spiegazione complessa quando ne
basta una più semplice. Di conseguenza, se la scienza può spiegare la complessità biologica
in modo semplice, a cosa serve la dottrina più complessa della creazione divina? L’ipotesi
Dio è un tentativo pseudoscientifico di fare ciò che la scienza ora può fare molto meglio da
sola. Tutte le persone ragionevoli dovrebbero quindi rifiutare l’ipotesi Dio e abbracciare la
scienza come la via più sicura per orientare i propri pensieri e la propria vita. Occorre
estirpare l’idea di Dio dalla mente dell’uomo. L’evoluzione darwiniana prova ovviamente
che la natura non era stata progettata in modo intelligente, perciò l’ipotesi Dio è stata alla
fine respinta. Parole come queste esprimono bene la posizione del nuovo ateismo: “La
religione non ha ormai più scusanti. Grazie al telescopio e al microscopio, non fornisce più
alcuna spiegazione di qualche importanza” (C. HITCHENS, Dio non è grande. Come la
religione avvelena ogni cosa, Einaudi, Torino 2007, 270). Il rasoio di Occam, così designato
dal nome di Guglielmo di Occam, monaco e filosofo del tardo Medio Evo, sostiene che se
più spiegazioni valide concorrono tra loro, dovremmo scegliere la più semplice. Tale
criterio è noto anche come “la legge della parsimonia”, il principio che ci avverte che
quando cerchiamo di scegliere tra due ipotesi concorrenti, è buona norma scegliere quella
che formula il minor numero di ipotesi, e questo sembra un buon consiglio. Perché, si
chiedono i nuovi atei, cercare una spiegazione teologica quando disponiamo di una
spiegazione naturale della moralità e della religione (illusione infantile e immorale)? Stando
al corretto contenuto del rasoio di Occam, non può essere applicato alla religione come
vorrebbero gli esponenti del nuovo ateismo. Esso fu pensato per essere applicato a diverse
ipotesi che concernono un medesimo livello di realtà. Ma le motivazioni evoluzionistiche e
quelle teologiche si trovano su livelli logicamente diversi, non sono in competizione e non
rendono necessaria l’applicazione del rasoio. In realtà questi filosofi hanno assunto il
monismo esplicativo: la legge evoluzionista darwiniana è la ricetta più semplice per
spiegare la complessità della vita, combinando i tre ingredienti delle variazioni casuali, della
selezione naturale cieca di tali variazioni e di un lunghissimo periodo di tempo. L’ipotesi Dio
è liquidata così velocemente anche perché l’idea di divinità è ridotta a quella di legislatore,
ingegnere cosmico o progettista intelligente. Il mistero divino infinito è così ridotto a causa
scientifica finita. Questi autori, in realtà, hanno a che fare con una caricatura di Dio di cui
gli stessi teologi ben volentieri farebbero a meno.
Il variegato schieramento del pensiero al femminile, che contesta la monopolizzazione
maschile della filosofia e il linguaggio monosessuale e andromorfico della teologia, si batte
81
per la morte del “Dio maschio” e “patriarcale” e per l’avvento di un Dio postsessista che,
invece di ridurre le donne alla condizione di cadaveri riconoscenti, funga da strumento di
liberazione delle loro potenzialità represse. Alcune autrici si muovono all’interno della
tradizione cristiana, altre sono approdate ad una filosofia radicale postcristiana. M. Daly
ritiene il femminismo cristiano una sorta di mostro logico e ha elaborato un’immagine di
Dio come Assoluto in divenire, cioè come verbo, non come sostantivo.
Ci sono anche le filosofie dell’essere di ispirazione classica che, pur cercando di recuperare
al loro interno talune istanze della riflessione del ‘900 su Dio, continuano a rifarsi a modelli
ontologici di matrice greca e medievale, ritenendo che “se Dio entra nella filosofia, anzi
nella metafisica, vi entra … come il principio, il fondamento, il senso stesso dell’essere” (E.
BERTI, Introduzione alla metafisica, Utet, Torino 1993, 113). A differenza degli studiosi per i
quali la filosofia può parlare di Dio solo indirettamente, e tramite l’esperienza del mito e
della religione, per cui il Dio dei filosofi non esiste (cfr. Pareyson), questi autori sostengono
che la filosofia, oltre che occuparsi a pieno titolo, cioè in modo argomentativo, della
divinità, ha il compito primario di dimostrarne l’esistenza (mediante le prove tradizionali o
una loro rielaborazione aggiornata).
Altri autori (W. Weischedel, M. Ruggenini), pur scorgendo in Dio l’oggetto più alto del
domandare filosofico – concepito come domandare radicale – intendono contrapporre, alla
metafisica rappresentazione della filosofia come scienza di Dio, una postmetafisica
immagine di essa come custode del mistero di Dio (e della sua differenza dall’uomo). In
altri termini, nell’epoca del nichilismo e del disincantamento del mondo, il compito della
filosofia non sarebbe quello di provare Dio, ma quello di mantenere vivo il problema di Dio,
sia nei confronti di ogni forma di indifferenza teoretica (la quale ritenga di non doversi
curare di Dio), sia nei confronti di ogni presunta soluzione metafisica o dogmatica (la quale
ritenga di aver chiuso i conti con Dio).
82
Anima.
In generale si intende per anima il principio della vita, della sensibilità e delle attività
spirituali, in quanto costituente un’entità a sé o sostanza. Un certo insieme di operazioni, di
eventi detti psichici o spirituali, costituirebbero le manifestazioni di un principio autonomo,
irriducibile, per la sua originalità, ad altre realtà, anche se in relazione con esse. L’anima è
comunque considerata sostanza, sia che venga considerata come incorporea, sia che le sia
attribuita la stessa costituzione delle cose corporee. Considerare l’anima in quanto
sostanza significa intenderla come una realtà a sé, cioè che esiste indipendentemente dalle
altre. Il riconoscimento della realtà Anima sembra fornire un solido fondamento ai valori
connessi con le attività spirituali umane, i quali, senza di essa, sembrerebbero sospesi nel
nulla; sicché la sostanzialità dell’anima viene considerata, dalla maggior parte delle teorie
filosofiche tradizionali, come una garanzia della stabilità e della permanenza di quei valori:
garanzia che viene talora rafforzata dalla credenza che l’Anima è, nel mondo, la realtà più
alta e ultima o, qualche volta, lo stesso principio ordinatore e governatore del mondo.
Spesso i concetti con cui un filosofo qualifica la realtà sono usati anche per l’anima. Per
Anassimene e Diogene di Apollonia l’Anima è aria, visto che è il principio delle cose. Per i
Pitagorici, che consideravano tale il numero, l’Anima è armonia, visto che la struttura del
cosmo è ravvisabile nell’armonia scandita numericamente. Per Eraclito l’Anima è fuoco
visto che il medesimo è il principio universale; per Democrito è formata di atomi rotondi,
che possono più agevolmente penetrare nel corpo e muoverlo, e così via.
Platone afferma che l’Anima si muove da sé e la definisce sulla base di questa
caratteristica: “Ogni corpo a cui il muoversi è impresso da fuori è inanimato; ogni corpo che
si muove di per sé dal di dentro è animato; e tale appunto è la natura dell’Anima” (Fedro,
245d). L’anima è quindi la causa della vita e pertanto è immortale giacché la vita costituisce
la sua stessa essenza: “Allora dimmi: che cosa si deve generare in un corpo perché sia vivo?
Si deve generare l’anima, rispose … Allora l’anima, qualunque cosa occupi, entra portandovi
sempre la vita … E non è forse vero che l’anima non potrà mai accogliere il contrario di ciò
che essa apporta, come si è concordemente ammesso in base a ciò che prima si è detto?
Assolutamente così, disse Cebete” (Fedone, 105d). Con tali categorie, frutto anche della
Seconda Navigazione, Platone distingueva nettamente la realtà dell’Anima, semplice,
incorporea, che si muove da sé, che vive e dà vita, dalla realtà corporea, che ha i caratteri
opposti.
Aristotele considera l’anima come sostanza del corpo. Essa è definita come “l’entelechia
(l’atto finale primo) di un corpo che ha la vita in potenza”. L’Anima sta al corpo come l’atto
della visione sta all’organo visivo: è la realizzazione della capacità che è propria di un corpo
organico. Come ogni strumento ha una sua funzione, che è l’atto o l’attività dello
strumento, così l’organismo come strumento ha la funzione di vivere e pensare; l’Anima è
l’atto di questa funzione. Perciò l’Anima non è separabile dal corpo o almeno non sono
83
separabili dal corpo quelle parti dell’Anima che sono attività delle parti del corpo: giacché
nulla impedisce che siano separabili quelle parti dell’Anima che non sono attività del corpo.
Con questa restrizione, Aristotele allude alla parte intellettiva dell’Anima, che egli chiama
“un altro genere di anima”, e ritiene la sola separabile dal corpo (De anima II, 1, 412a 10;
413a 4sg; II, 2, 413b 26). Come atto o attività l’Anima è forma e, come forma, è sostanza in
una delle tre determinazioni della sostanza che può essere o la forma o la materia o il
composto di materia e forma. La materia, infatti è potenza, la forma è atto e ogni essere
animato è composto di queste due cose; ma mentre il corpo non è l’atto dell’Anima,
l’Anima è l’attività di un corpo determinato, cioè la realizzazione della potenza che è
propria di questo corpo; onde si può dire che essa non esiste né senza il corpo né come
corpo. Queste determinazioni aristoteliche, per lunghi secoli, hanno costituito l’intero
progetto della “psicologia dell’Anima”. A seconda degli interessi prevalenti, in essa si è
insistito sull’una o sull’altra delle determinazioni aristoteliche. Di queste le più importanti
sono: a. l’anima è sostanza come realtà nel senso forte del termine; b. l’anima è causa,
principio indipendente di operazioni. Tali determinazioni garantiscono un solido sostegno
alle attività e ai valori spirituali. Due altre determinazioni sono quelle della semplicità e
indivisibilità, che hanno lo scopo di garantire l’impassibilità dell’Anima, nei confronti di
mutamenti corporei e, per il tramite dell’indecomponibilità, la sua immortalità. La terza
determinazione importante è il suo rapporto col corpo, definito da Aristotele come
rapporto della forma con la materia, dell’atto con la potenza. La determinazione dell’anima
come sostanza non è negata neanche dai materialisti.
Epicuro, che ritiene l’anima composta di particelle sottili, diffuse in tutto il corpo come
soffio caldo, ritiene tuttavia che l’Anima abbia la capacità causativa della sensazione, che
viene preparata dal corpo e di cui il corpo partecipa, ma che è in una certa misura
indipendente dal corpo stesso: giacché quando l’Anima si distacca da esso, il corpo non ha
più sensibilità (Epistola a Erodoto, 63 sg). In questo modo l’Anima non è semplice né
immortale (essa si dissolve nelle sue particelle con la morte del corpo); ma è tuttavia una
realtà a sé, dotata di una propria capacità causativa, indispensabile alla vita stessa del
corpo.
In modo analogo gli Stoici ritengono che l’Anima è un soffio congenito in noi: che, come
tale, è corpo, perché se non fosse corpo non potrebbe né unirsi al corpo né separarsi da
esso; ma che può tuttavia essere immortale, com’è certamente immortale l’Anima del
mondo , di cui sono parti quelle degli esseri animati, e le Anime dei saggi (Diogene Laerzio,
VII, 156-157). Qui la corporeità dell’Anima non toglie a essa né la semplicità né
l’immortalità: come non la toglie alla concezione di Tertulliano che la considera come un
soffio o flatus di Dio, perciò generata, corporea e immortale (De anima, 8 sgg).
L’accettazione quasi universale della dottrina aristotelica dell’anima ha una eccezione in
Plotino. Egli critica sia la concezione della corporeità dell’Anima sia la concezione
dell’Anima come forma del corpo (Enneadi, IV, 7, 2 sgg; IV, 7, 8, 5). Egli non vuole che
84
l’anima abbia un qualsiasi legame con il corpo e l’unica sua preoccupazione è quella di
definirne la realtà proprio nei termini della sua indipendenza dal corpo e da tutte le
determinazioni corporee. Per questo accetta i caratteri divini dell’Anima: la sua unità e
indivisibilità, la sua ingenerabilità e incorruttibilità. Essi sono caratteri negativi come quelli
che egli attribuisce a Dio. Ma quale via di accesso abbiamo alla realtà dell’Anima? Plotino
risponde che per esaminare la natura di una cosa bisogna considerare la medesima nella
sua purezza, in quanto ciò che le è aggiunto è un ostacolo alla sua conoscenza. Bisogna
togliere all’Anima tutto ciò che le è estraneo, cioè bisogna guardare a se stessi e ritirarsi
nella propria interiorità. Inizia così il progressivo prevalere della nozione di coscienza,
intesa come introspezione o ripiegamento su se stesso, o riflessione interiore, sulla nozione
di anima. L’Anima stessa viene ridotta al movimento dell’introspezione: “Non è uscendo
dall’Anima che si può vedere la saggezza e la giustizia; l’Anima vede queste cose in se
stessa, nella sua riflessione su se stessa; nel suo stato primo le vede in sé come statue piene
della ruggine del tempo, che essa pulisce. È come se si trattasse di un oro che avesse
un’Anima e si liberasse di tutto il fango che lo coprisse: esso sarebbe dapprima
nell’ignoranza di sé, non si vedrebbe come oro; e in seguito ammirerebbe se stesso
vedendosi isolato e non desidererebbe di avere altra bellezza estranea, ma sarebbe tanto
più forte quanto più lo si lasciasse a se stesso” (Enneadi IV, 7, 10). Tali parole aprono l’altra
alternativa della dottrina dell’Anima, cioè quella per la quale essa finirà per essere
soppiantata dal concetto di coscienza. Qui il ritirarsi in se stesso, l’essere lasciato a se
stesso, lo sguardo alla propria interiorità, l’atteggiamento della riflessione su di sé sono
espressioni che servono a definire un tipo di ricerca che prescinde completamente dal
corpo e, perciò, anche da ciò con cui il corpo pone in relazione, cioè le cose e gli altri
uomini (ibid., V, 3,1-2).
I Neoplatonici e i Padri della Chiesa orientale ripetono le determinazioni neoplatoniche:
l’immaterialità e l’unità dell’Anima sono i caratteri fondamentali riconosciuti a essa da
Porfirio e da Proclo, nonché da Gregorio di Nissa.
Ma è soprattutto Agostino che raccoglie l’eredità del neoplatonismo e la trasmette al
mondo cristiano, col riconoscimento dell’interiorità spirituale come via d’accesso
privilegiata alla realtà propria dell’anima. Essa consiste nell’esperienza interiore, nella
riflessione sulla propria interiorità, nella “confessione” come riconoscimento della propria
realtà intima; in una parola ciò che nel linguaggio moderno si chiama coscienza. Nei
Soliloqui Agostino dichiara di non voler conoscere altro che “Dio e l’Anima” (I,2). Ma Dio e
l’Anima non richiedono due indagini parallele o comunque diverse, giacché Dio è
nell’Anima e si rivela nella più riposta interiorità dell’Anima stessa: “Non uscire da te,
ritorna in te stesso, nell’interno dell’uomo abita la verità; e se troverai mutevole la tua
natura, trascendi anche te stesso” (De vera religione, 39). Riguardo l’origine dell’anima, egli
era partito da quattro ipotesi: la preesistenza, l’origine per discendenza (traducianesimo),
l’origine per caduta, la creazione individuale. Alla fine rimane con le ipotesi del
85
traducianesimo e della creazione individuale senza riuscire a fare una scelta definitiva: “Per
quello che riguarda l’origine dell’anima, sapevo che era stata fatta per essere unita al
corpo, ma non sapevo allora (al tempo del Contra Academicos) come non so adesso, se essa
discenda dal primo uomo oppure se continuamente venga creata singolarmente per
ciascun individuo” (Ritrattazioni, 1,1).
Tale atteggiamento diede i suoi frutti più tardi, a cominciare dalla tarda Scolastica. La
Scolastica nel suo complesso è dominata dalla dottrina aristotelica dell’Anima, riproposta
negli stessi termini a partire da Scoto Eriugena sino a Duns Scoto, il quale ultimo si limita
ad aggiungere che, poiché l’Anima è la forma del corpo, essa non può sussistere quando il
corpo è distrutto e che pertanto l’immortalità è pura materia di fede.
S. Tommaso si schiera apertamente per Aristotele, distaccandosi dalla linea
dell’agostinismo e del platonismo e, riguardo la dottrina dell’Anima, presenterà sostanziali
novità e preziosi arricchimenti. L’anima è di natura immateriale, cioè spirituale. Ma per
scoprire la spiritualità dell’anima non basta l’introspezione, la semplice autocoscienza,
bensì occorre una “diligens et subtilis inquisitio” (Summa Theologiae I, q.87, a.1), occorre
cioè dimostrarla. Il punto di partenza è dato dalle operazioni dell’anima, infatti “eo modo
aliquid operatur quo est”, il modo di operare di una cosa corrisponde al suo modo di
essere. Ora, “il principio intellettivo, chiamato mente o intelletto, ha un’attività sua propria
in cui non entra il corpo. Ma niente può operare per se stesso, se non sussiste per se stesso.
L’operazione, infatti, non compete che all’ente in atto; tanto è vero che le cose operano
conformemente al loro modo di esistere. Per questo non diciamo che il calore riscalda; chi
riscalda è la sostanza calda. Rimane dunque dimostrato che l’anima umana, la quale viene
chiamata mente o intelletto, è un essere incorporeo e sussistente” (ibid., I, q. 75, a. 2). Però
S. Tommaso sa bene che anche le operazioni più squisitamente spirituali dell’anima, come
la conoscenza intellettiva e il libero arbitrio, non sono esenti da qualche legame con la
materia. Ma, a suo giudizio, ciò non compromette l’intrinseca spiritualità dell’anima,
perché la sua dipendenza dal corpo non è soggettiva (non tocca cioè l’ordine della
causalità efficiente), ma oggettiva (riguarda l’ordine della causalità formale). Si tratta infatti
di operazioni che “richiedono il corpo non come strumento, ma solo come oggetto. Infatti
l’intendere (intelligere) non si attua mediante un organo corporeo, ma ha bisogno di un
oggetto corporeo” (In I De Anima, lectio II, n. 19). “Si deve dire che l’intendere è operazione
propria dell’anima se si considera il principio da cui nasce l’operazione; non nasce infatti
dall’anima per mezzo di un organo corporeo come la vista mediante l’occhio; il suo legame
col corpo riguarda l’oggetto: infatti i fantasmi, che sono gli oggetti dell’intelletto, senza il
concorso degli organi corporei non possono esistere” (De Anima I, ad. 12). Oltre che sulle
singole operazioni dell’intelletto e della volontà, per dimostrare la spiritualità
(incorporeità) dell’Anima S. Tommaso fa leva su un altro importante fenomeno, quello
dell’autotrascendenza: tutto l’agire umano, preso globalmente, tende verso l’infinito.
“L’anima razionale possiede una certa infinità sia da parte dell’intelletto agente, con cui
86
può fare tutto, sia da parte dell’intelletto possibile con cui può diventare tutto … e questo è
argomento evidente della immaterialità dell’anima, perché tutte le forme materiali sono
finite” (II Sententiae, d. 8, q. 2, a. 2, ad 2). Mentre l’intelletto divino è totalmente in atto,
ossia tutti gli intellegibili stanno eternamente sotto il suo sguardo, l’intelletto umano,
all’inizio, è totalmente in potenza (è una tabula rasa); né ciò che è in potenza è in grado di
passare all’atto per sua iniziativa (come la materia non può darsi le forme): pertanto è
necessario ammettere nell’anima oltre la disposizione attiva anche un potere attivo, e
questo è per l’appunto l’intelletto agente. In che modo la medesima sostanza dell’anima
possa avere i due intelletti, possibile e agente, S. Tommaso lo spiega così: “Una cosa può
essere rispetto ad un’altra simultaneamente in potenza e in atto sotto punti di vista diversi.
Ora, i fantasmi rispetto all’anima sono in potenza in quanto non sono astratti dalle
condizioni individuanti ma tuttavia astraibili; e sono in atto, in quanto sono similitudini di
determinate cose. C’è dunque nell’anima nostra potenzialità rispetto ai fantasmi in quanto
sono rappresentativi di determinate cose, e ciò appartiene all’intelletto possibile, il quale in
sé è in potenza a tutti gli intellegibili, ma è determinato a questo o a quello mediante le
specie attratte dai fantasmi. Ma c’è nell’anima anche una virtù attiva immateriale, che
astrae i fantasmi dalle condizioni materiali; e ciò appartiene all’intelletto agente il quale è
quasi una virtù partecipata di una sostanza superiore, cioè da Dio” (De anima, a. 5).
Un’altra proprietà che conta moltissimo, soprattutto nella prospettiva tomistica, è la
sostanzialità. La dimostrazione di questa proprietà consente di uscire dalle strettezze e
ambiguità dell’antropologia aristotelica. Tommaso ricorda a proposito due tesi che giudica
inammissibili: il materialismo da una parte, che non riconosce nell’anima alcun carattere
sostanziale ma la equipara alle altre forme naturali, e il platonismo dall’altra, che non si
accontenta di affermare che l’anima è una sostanza, ma pretende che basti da sola a
definire la realtà umana, senza alcun riferimento al corpo. Contro i materialisti gli è
sufficiente ribadire quanto abbiamo già riferito a sostegno della spiritualità: “E’ necessario
che l’anima intellettiva agisca per conto proprio, avendo un’operazione propria senza
l’aiuto di un organo corporeo. E poiché ciascuno agisce in quanto atto, occorre che l’anima
intellettiva abbia l’essere per sé non dipendente dal corpo” (De anima 1, resp.). Tuttavia,
pur affermando la sostanzialità dell’anima, egli non intende passare dalla parte dei
platonici (gli agostiniani) che identificavano l’essere dell’anima con l’essere dell’uomo.
L’Aquinate mostra che l’anima non fa specie a sé e che pertanto da sola non esaurisce la
realtà umana: “Occorre perciò concludere che l’anima, pur potendo sussistere per sé, non è
tale da formare una specie completa, ma entra nella specie umana come forma del corpo.
Così si può dire dell’anima sia che è forma sia che è sostanza” (ibid.). Rispondendo a
un’obiezione che riguarda la composizione ontologica dell’anima, egli fa l’importante
precisazione che l’anima, come gli angeli, pur essendo semplice, spirituale e dotata di un
proprio atto di essere, è anch’essa soggetta alla differenza ontologica che distingue ogni
realtà finita dall’Essere sussistente: anche l’anima è composta di essenza e atto di essere, e
di conseguenza è composta di atto e potenza, infatti “la sostanza dell’anima non è il suo
87
essere, ma si rapporta a esso come la potenza all’atto” (De Anima 1, ad. 6). Assicurate la
spiritualità e la sostanzialità dell’anima, Tommaso fa sua la tesi aristotelica dell’unione
sostanziale dell’anima col corpo, e per dare espressione a questa verità fa suo il linguaggio
ilemorfistico, assegnando all’anima il ruolo di forma sostanziale e al corpo il ruolo di
materia: “L’anima è ciò per cui il corpo umano possiede l’essere in atto e questo è proprio
della forma. Perciò l’anima umana è forma del corpo” (De Anima 1, resp.). A sostegno
dell’unione sostanziale egli adduce due argomenti: l’unione dell’anima col corpo non può
essere accidentale perché quando l’anima scompare, nel corpo non rimane più nulla di
umano se non l’apparenza: “Perciò se l’anima fosse nel corpo come il marinaio nella nave,
non conferirebbe la specie al corpo né alle sue parti; invece la dà; prova ne sia che,
recedendo l’anima, le singole parti non mantengono che in modo equivoco il nome
primitivo. Es.: il nome <<occhio>>, parlando di quello di un morto, è equivoco, come quello
scolpito sulla pietra o dipinto; così dicasi delle altre parti” (De Anima 1, resp.). L’unione col
corpo giova all’anima stessa sia nell’ordine dell’essere sia in quello dell’agire: “L’anima è
unita al corpo per la sua perfezione sostanziale, cioè per completare la specie umana, e
anche per la perfezione accidentale, per perfezionare cioè la conoscenza intellettiva che
l’anima acquisisce attraverso i sensi; infatti questo modo di intendere è connaturale
all’uomo” (De Anima 1, ad. 7). Se l’anima è l’unica forma sostanziale del corpo, Tommaso
può disfarsi della teoria insegnata da Platone, e largamente condivisa dai suoi
contemporanei, della molteplicità delle anime. Nell’uomo si dà una sola anima, quella
razionale, che svolge anche le operazioni delle anime inferiori, vegetativa e sensitiva:
“Essendo l’anima forma sostanziale, che costituisce l’uomo in una determinata specie di
sostanza, non c’è un’altra forma sostanziale intermedia tra l’anima e la materia prima, ma
l’uomo dalla stessa anima razionale è perfezionato secondo i diversi gradi di perfezione, in
modo da essere corpo, corpo animato e anima razionale” (De Anima, a. 9). L’anima
razionale, in quanto forma più perfetta, è in grado di assolvere anche le funzioni espletate
dalle forme (anime) meno perfette. Infatti “pur essendo semplice quanto all’essenza,
l’anima è potenzialmente molteplice in quanto è principio di svariate operazioni; e poiché la
forma perfeziona la materia in ordine non solo all’essere ma anche all’agire, è necessario
che l’anima, benché sia forma unica, perfezioni le parti del corpo in svariati modi, come
conviene a ogni singola operazione” (ibid., 9, ad 14). L’anima razionale ha due facoltà:
l’intelletto e la volontà. Il primo presiede al mondo del conoscere, la seconda al mondo del
volere, dello scegliere e del desiderare. All’intelletto spetta anche la memoria, perché
quando esso si è impossessato di un’idea, può ritornarvi sopra e conservarla più
tenacemente della memoria sensitiva. Tale memoria intellettiva non è una potenza distinta
dall’intelletto, non essendovi diversità di oggetto, ma è funzione conservativa dell’intelletto
che si è impossessato delle idee (Summa Theologiae I, q. 79, aa. 6-7). Nemmeno la ragione
è una potenza diversa dall’intelletto, ma è un’altra funzione dell’intelletto, il quale,
nell’uomo, non attinge gli oggetti intuitivamente, immediatamente, ma argomentando,
gradatamente. Né sono due diverse potenze l’intelletto speculativo e l’intelletto pratico,
88
che però si distinguono secondo ché dell’uno è proprio l’apprendere, dell’altro è proprio
l’indirizzare all’opera ciò che è appreso. La volontà è la facoltà con cui l’uomo tende al
bene, e in definitiva al bene universale, perché solo questo bene la può appagare
pienamente (I, q. 82, a.1). Alla volontà appartiene il libero arbitrio, grazie al quale essa è
padrona dei propri atti e anche degli atti compiuti dalle altre facoltà. La volontà è libera
perché l’uomo è dotato di intelletto e ragione, che gli fanno conoscere il grado di bontà
degli obiettivi che intende perseguire e, dato che in concreto nessun obiettivo corrisponde
al bene universale ma resta sempre un bene particolare, egli può sempre disporne
liberamente: “La ragione, in tutti i beni particolari, può osservare l’aspetto buono oppure le
sue deficienze di bene, che si presentano come un male; e in base a ciò può apprendere
ciascuno di tali beni come degno di elezione o di fuga” (I-II, q.13, a.6). Il libero arbitrio sta
alla volontà come la ragione sta all’intelletto, perché come intelletto è l’intendere
semplicemente e ragione è l’intendere con ragionamento, così la volontà è volere
semplicemente, libero arbitrio è volere con scelta; perciò come la ragione non è una
potenza diversa dall’intelletto, così il libero arbitrio non è una potenza diversa dalla
volontà. Sulle due facoltà primarie – intelletto e volontà – Tommaso innesta una serie di
abiti (virtù e vizi) che qualificano l’agire spirituale dell’anima in svariati modi. I principali
abiti intellettivi sono la scienza (la conoscenza della cosa mediante le sue cause, di
aristotelica memoria) e la sapienza (il retto giudizio delle cose divine), mentre i principali
abiti morali sono le virtù cardinali. Riguardo la questione dell’origine dell’anima, ciò che in
Agostino era rimasto sospeso, ai tempi del Dottore Angelico si era risolto a favore della
creazione diretta di ogni singola anima da parte di Dio, e questa è stata anche la tesi da lui
seguita. Egli dimostra che è la natura spirituale dell’anima scelta a esigere che la sua origine
sia dovuta a un intervento diretto di Dio. Infatti l’anima non può essere prodotta da
preesistente sostanza materiale, essendole superiore, né può essere prodotta da
preesistente sostanza spirituale, perché le sostanze spirituali non si trasmutano l’una
nell’altra; perciò deve essere prodotta dal niente, cioè creata, e poiché creare spetta a Dio
solo, deve essere creata immediatamente da Dio; e inoltre essendo parte della natura
umana, viene creata insieme col corpo. Tommaso riflette sull’anima umana anche da una
prospettiva storica e teologica. L’anima di Adamo, prima del peccato, godeva di alcuni doni
soprannaturali (grazia santificante) e preternaturali (piena conoscenza delle cose naturali,
dominio delle passioni, dominio delle altre cose, possesso di tutte le virtù). Nel primo uomo
c’era la soggezione del corpo all’anima, delle forze inferiori alla ragione e della ragione a
Dio. Dopo il peccato originale l’anima di Adamo, oltre la perdita della grazia santificante, ha
accusato anche la perdita di tutti i doni preternaturali, nonché un indebolimento delle sue
facoltà naturali, a causa dello scompiglio delle forze inferiori del corpo. Per i
contemporanei del Dottore angelico, che seguivano l’indirizzo platonico agostiniano,
l’immortalità dell’anima non costituiva un vero problema, in quanto nella loro antropologia
l’anima era concepita come una sostanza spirituale completa e, di conseguenza, esente da
tutte le vicissitudini del corpo, inclusa la morte. Il problema dell’immortalità dell’anima
89
sussisteva invece per coloro che avessero voluto sposare le teorie di Aristotele, in
particolare nella versione che ne aveva dato Averroè, il quale aveva negato l’immortalità
personale. Tommaso fa sue le linee fondamentali dell’antropologia aristotelica, senza però
compromettere la tesi dell’immortalità dell’anima. L’anima è forma del corpo e le compete
uno statuto ontologico particolare, in quanto possiede l’atto dell’ essere in proprio,
direttamente, senza dipendere dal corpo. Ciò la rende incorruttibile e immortale. Di fatto
abbiamo due tipi di forme sostanziali: 1. Forme alle quali l’essere sopravviene nel
momento in cui si costituisce il composto 2. Forme alle quali l’atto dell’essere compete
ancor prima che si realizzi il composto. Le prime sono corruttibili; le seconde sono
incorruttibili: “Se dunque esiste una qualche forma che è avendo l’essere, è necessario che
la medesima forma sia incorruttibile” (De Anima, a. 14). Questo è il caso dell’anima umana.
Infatti “non si separa l’essere da una cosa che ha l’essere se non in quanto si separa la
forma da essa; pertanto se ciò che ha l’essere è la stessa forma, è impossibile che l’essere
sia separato da essa. Ora è manifesto che il principio per cui l’uomo svolge l’attività
intellettiva è forma avente l’essere in sé e non solo come ciò per cui una cosa è … Dunque il
principio intellettivo per cui l’uomo intende è forma avente l’essere in proprio; onde è
necessario che sia incorruttibile” (ibid.). Egli supera le difficoltà di coloro che considerano
l’anima mortale se unita sostanzialmente al corpo. Tali assertori dimenticano che “Alcuni,
identificando l’anima col corpo, negarono addirittura che essa sia forma e ne fecero un
composto di materia e forma. Altri, sostenendo che l’intelletto non differisce dal senso, di
conseguenza ammisero che anche la sua attività si svolge mediante un organo corporeo, e
così non avrebbe l’essere elevato sopra la materia, onde non sarebbe forma avente l’essere
in proprio. Infine altri ancora, considerando l’intelletto una sostanza separata, esclusero
che l’attività intellettiva appartenga all’anima stessa. Ma tutte queste teorie sono false,
come abbiamo già mostrato in precedenza. Perciò l’anima umana è incorruttibile” (ibid.).
L’immortalità dell’anima è dote naturale essenziale, diretta conseguenza della sua
spiritualità, pertanto non può essere intaccata dal peccato originale. Infatti “il peccato
toglie totalmente la grazia, ma nulla rimuove dell’essenza della cosa; rimuove qualcosa
circa l’inclinazione o capacità della grazia … ma non è mai tolto il bene di natura, perché
sotto disposizioni contrarie rimane sempre la potenza, benché si allontani sempre di più
dall’atto” (De Anima 14, ad. 6). Neppure Dio, che pure ha il potere di ridurre al nulla tutto
ciò che ha condotto all’essere, priva l’anima dell’immortalità annichilendola, perché Dio,
nel suo sapiente governo delle cose, non va mai contro le disposizioni naturali di cui le ha
dotate. La concezione dell’anima nell’Aquinate poggia sulla sua concezione intensiva
dell’essere, come ciò che conviene alle cose, come la realtà più immediata e più intima.
L’essere è atto immediato e diretto dell’anima ancor prima che questa se ne faccia
mediatrice al corpo: sarà essa a comunicare al corpo l’essere in cui essa stessa sussiste.
La Scolastica agostiniana presenta una sola novità, in contrasto con l’indirizzo aristotelico –
tomistico della stessa Scolastica: l’introduzione di una forma corporeitatis come realtà che
il corpo umano possiede, come corpo organico, indipendente dalla sua unione con l’Anima
90
(Duns Scoto, Ockham). Quest’ammissione è legata al riconoscimento che la materia in
generale non è pura potenza ma possiede, già come materia, una certa realtà attuale che è
appunto la forma corporeitatis. Ockham ci offre un’innovazione assai più radicale: il dubbio
sulla realtà dell’anima intellettiva. Sostiene infatti Ockham che, se si intende per Anima
intellettiva “una forma immateriale e incorruttibile che è tutta in tutto il corpo e tutta in
ciascuna parte, non si può conoscere con evidenza, né con la ragione né con l’esperienza,
che una tale Anima sia forma del corpo e che l’intendere sia proprio di una tale sostanza”
(Quodlibet, I, q. 10). Le ragioni che si possono addurre per la dimostrazione di una tale
forma sono dubbie; e, quanto all’esperienza, tutto ciò che noi sperimentiamo sono
l’intellezione, la volizione, ecc.:operazioni che possono ben essere proprie di una “forma
estesa, generabile e corruttibile”, cioè del corpo stesso. Egli perciò relega tra le materie di
fede non solo l’immortalità dell’anima (come già aveva fatto Duns Scoto) ma la realtà
stessa dell’Anima intellettiva come supposto soggetto delle operazioni spirituali di cui
abbiamo esperienza. Questa negazione è fatta proprio sulla base dell’esperienza che si ha
dei propri atti spirituali (intellettivi e volitivi): esperienza che, per Ockham, è una
conoscenza intuitiva di natura spirituale (cognitio intuitiva intellectiva) per la quale sono
immediatamente presenti, nella loro singolarità e nelle loro relazioni reciproche, gli atti o le
operazioni spirituali. Con queste notazioni il concetto di un’esperienza interna, diversa
dall’esperienza sensibile o esterna, veniva introdotto nella storia della filosofia, proprio
mentre la realtà, cui tale esperienza dovrebbe dare accesso, cioè la realtà dell’Anima,
veniva messa in dubbio. L’esperienza interna doveva diventare con Cartesio il punto di
partenza della filosofia moderna.
La nozione dell’Anima come sostanza sopravvive alla crisi del Rinascimento. Né il
materialismo di Telesio e di Hobbes costituiscono vere e proprie negazioni della
sostanzialità dell’anima. Telesio ammette una sostanza intellettiva, direttamente creata e
infusa da Dio nell’uomo, solo per spiegare la vita religiosa dell’uomo, la sua aspirazione al
Trascendente; ma lo stesso “spirito animale”, di cui egli si avvale per spiegare la sensibilità,
l’intelligenza e anche la vita morale dell’uomo, pur essendo di natura corporea e prodotto
dal seme, è da lui considerato come realtà a sé, come sostanza (De rerum natura, V, 2. 10).
Quanto a Hobbes egli dichiara illegittimo il passaggio operato da Cartesio dalla
proposizione “Io sono una cosa che pensa”, che è indubitabile, alla proposizione “Io sono
una sostanza pensante”: giacché non è necessario che la cosa che pensa sia pensiero, ma
può essere il corpo stesso (III Objections, 2). Che l’Anima sia una cosa, cioè una realtà, non
viene negato dall’interpretazione materialistica di essa.
Per ciò che riguarda la nozione di anima nel mondo moderno, abbiamo uno sviluppo
decisivo con Cartesio. Egli riafferma la realtà dell’Anima e riconosce una via di accesso
privilegiata a tale realtà. Questa via di accesso è il pensiero o, per meglio dire, la coscienza.
Il cogito ergo sum rivela in modo evidente la sostanza pensante, cioè rivela “un essere
l’esistenza del quale ci è più conosciuta di quella degli altri in modo che può servire come
91
principio per conoscerli” (Lettre à Clercelier, in Oeuvres, IV, 443). Ora il cogito comprende
“tutto ciò che è in me e di cui sono immediatamente cosciente”: cioè il dubitare, il capire, il
concepire, l’affermare, il negare, il volere, il non volere, l’immaginare, il sentire ecc. Sicché
la coscienza è una via di accesso privilegiata perché sicura al punto di essere assolutamente
indubitabile, ad una realtà, la sostanza Anima, che è a sua volta privilegiata perché può
servire come principio per conoscere le altre realtà. E difatti è la stessa coscienza, in
quanto testimonia il carattere passivo della facoltà sensibile, che fa pensare a una sostanza
o realtà diversa dall’Anima e che agisca sull’Anima: cioè a una sostanza corporea o estesa,
che poi il principio della veridicità divina rende certa. Il nostro autore ha determinato la
svolta soggettivistica dell’interpretazione dell’Anima come sostanza. Gli attributi
dell’Anima anche per lui rimangono quelli tradizionali (semplicità, immortalità, unità ecc.)
ma la via di accesso alla realtà dell’Anima ha il privilegio di essere la più certa perché
possiede la certezza del Cogito. Rispetto a questa certezza, quella delle altre cose, cioè
delle sostanze estese, è secondaria e derivata, perché mediata appunto dalla coscienza.
Spinoza e Leibniz traducono il concetto cartesiano dell’anima secondo il loro concetto di
realtà.
Per Spinoza l’anima è “l’idea di un corpo singolo esistente in atto” (Ethica, II,11); cioè la
coscienza correlativa a un corpo organico. Essa non può essere sostanza, perché la
sostanza è unica ed è Dio. Come idea, l’anima è parte dell’intelletto infinito di Dio, cioè è
una manifestazione necessaria della sostanza divina (ibid., II, 9), quindi è eterna.
Per Leibniz l’Anima è una sostanza spirituale, una monade che, come uno specchio,
rappresenta in sé tutto il mondo ma è in se stessa semplice, cioè senza parti e
indecomponibile (Monadologia, & 1,56). A differenza delle altre monadi, che sono gli atomi
spirituali che compongono tutte le cose dell’universo (comprese quelle corporee), l’Anima
è spirito, cioè ragione, in quanto possiede le verità necessarie e può così elevarsi agli atti
riflessivi che costituiscono gli oggetti principali dei nostri ragionamenti (Theodicea, pref.;
Monadologia &30). Ma si tratta di una differenza di grado, più che di qualità: l’Anima è
soltanto una monade più attiva e perfetta nella quale le appercezioni, cioè le percezioni
chiare e distinte, hanno una parte maggiore di fronte alle piccole percezioni o percezioni
oscure e confuse. La dottrina di Leibniz rappresenta così una riduzione al limite, nel senso
spiritualistico, del principio cartesiano che privilegiava la coscienza.
La psicologia razionale di Wolff, che formò l’oggetto specifico della critica di Kant, non è
che l’espressione sistematica della dottrina di Leibniz. A partire da Cartesio il concetto di
“coscienza”, cioè di totalità o mondo dell’esperienza interna, comincia gradualmente ad
aver la meglio sul concetto tradizionale dell’anima. Già Cartesio e Leibniz, pur riferendosi
alle determinazioni tradizionali dell’Anima come sostanza, finiscono per interpretare a loro
modo la nozione di sostanza: la realtà che essi attribuiscono all’Anima è quella rivelata e
92
testimoniata dagli atti, o dall’atto fondamentale della coscienza come pensiero,
appercezione, ecc.
Locke, che riteneva inconoscibile la sostanza spirituale (come d’altronde quella materiale)
(Saggio sull’Intelletto umano, II, 23,30), ha ritenuto certa, in modo privilegiato, la
conoscenza che l’uomo ha della propria esistenza, attribuendola ad una “conoscenza
intuitiva” che non è se non la coscienza dei propri atti spirituali (ibid., IV, 9,3). Inoltre egli
ha riconosciuto nell’esperienza interna o riflessione una delle fonti della conoscenza e l’ha
intesa come “la percezione delle operazioni che il nostro spirito compie intorno alle idee
che ha dall’esterno”. Tali operazioni sono quelle di percezione, pensiero, dubbio,
conoscenza, volontà, ecc., cioè in generale tutti gli atti dello spirito di cui si è coscienti:
“Questa sorgente di idee risiede internamente nell’uomo; e per quanto non sia un senso
perché non ha niente a che fare con gli oggetti esterni, pure è simile a un senso e può essere
propriamente chiamato senso interno” (ibid., II, I, 4). Con ciò Locke ha ammesso due vie di
accesso parallele e indipendenti a due realtà presupposte indipendenti e parallele, cioè i
corpi e l’anima.
Hume non ha presupposto la distinzione di queste due realtà, né, per conseguenza, ha
ammesso la distinzione tra le due vie di accesso rispettive. La realtà sostanziale, sia quella
delle cose materiali, sia quella dell’Anima o dell’io, è una costruzione fittizia, che prende lo
spunto dalle relazioni di somiglianza e di causalità delle percezioni tra di loro (Trattato sulla
natura umana, I, 4, 2). Gli ingredienti elementari di tali costruzioni, il solo dato certo
dell’esperienza, sono costituiti da impressioni e da idee, cioè sono forniti dall’esperienza
interna, o coscienza. Sicché, mentre realizza la dimensione scettica della nozione di anima
come realtà o sostanza, il nostro autore contribuisce in pari misura a stabilire la supremazia
della coscienza i cui dati sono riconosciuti come i soli elementi certi della conoscenza
umana.
Kant, con la sua critica alla psicologia razionale, critica la concezione tradizionale di anima
con i suoi attributi di sostanzialità, semplicità, unità e possibilità di rapporti col corpo
(Critica alla Ragion Pura, Dialettica Trascendentale, Paralogismi della ragion pura). L’intera
psicologia razionale si fonda su un paralogisma, cioè su di un errore formale di
ragionamento o su un equivoco, nel senso che assume come oggetto di conoscenza, cui
applicare la categoria di sostanza, quell’ “Io penso” che è semplice coscienza e che è la
condizione prima dell’uso stesso delle categorie: “L’unità della coscienza, che è a
fondamento delle categorie, viene qui presa per intuizione del soggetto, preso come
oggetto, e le si applica la categoria di sostanza” (ibid.). La coscienza è quella espressa dalla
proposizione empirica “Io penso” la quale contiene in sé la proposizione “Io esisto”, e cioè
la coscienza della propria esistenza come determinabile da parte di un contenuto empirico
dato, e cioè come spontaneità intellettuale che non può operare se non su un materiale
fornito dall’esperienza. Essa è quindi diversa dalla conoscenza di se stesso che, come ogni
93
altra conoscenza, è possibile solo mediante l’applicazione delle categorie a un contenuto
empirico ed è perciò anch’essa conoscenza fenomenica. Stando ciò, la critica kantiana alla
psicologia razionale e al concetto dell’Anima su cui essa si impernia, consiste nel dichiarare
illegittima la trasformazione della coscienza in sostanza e perciò nell’eliminare la nozione
stessa di Anima come realtà di per sé sussistente. La divaricazione tra coscienza e Anima è
al culmine: l’una è presa come condizione di possibilità dell’oggetto di conoscenza, l’altra
viene scartata.
Da Kant in poi, anche quando si parla ancora di anima, si intende di fatto la coscienza. La
coscienza, da via di accesso alla realtà anima, si trasforma nella medesima. Hegel considera
l’anima come il primo grado dello sviluppo dello Spirito, che è la coscienza nel suo grado
più alto, cioè autocoscienza; e la configura come Spirito soggettivo, cioè come spirito
nell’aspetto della sua individualità. Egli descrive così tale processo: “Nell’Anima si desta la
coscienza; la coscienza si pone come ragione che si è immediatamente destata alla
consapevolezza di sé; e la ragione, mediante la sua attività, si libera col farsi oggettività,
coscienza del suo oggetto” (Enciclopedia delle scienze filosofiche, §387). L’anima è il primo
di questi momenti, cioè il destarsi della coscienza. Ad essa il nostro autore riconosce le
caratteristiche tradizionali (sostanzialità, immaterialità), ma in un senso in cui queste
caratteristiche possono essere riferite alla coscienza: “L’anima non è immateriale soltanto
per sé ma è l’immaterialità universale della natura, la sua semplice vita ideale. Essa è la
sostanza e quindi il fondamento assoluto di ogni particolarizzazione e individualizzazione
dello spirito, di modo che lo spirito ha nell’anima ogni materia della sua determinazione e
l’Anima resta l’idealità identica e prevalente di questa. Ma in tale determinazione ancora
astratta l’Anima è soltanto il sonno dello spirito, il nous passivo di Aristotele, che, sotto
l’aspetto della possibilità, è tutto” (ibid., § 389). In altri termini, che l’Anima sia immateriale
significa soltanto che la materia non esiste perché la verità della materia è lo spirito; e che
l’Anima sia sostanza significa soltanto che lo spirito è anche individualità, cioè coscienza
individuale. Le determinazioni tradizionali sono qui ricondotte a significati diversi,
condizionati dalla riduzione dell’Anima alla prima fase dello spirito cosciente.
Il Positivismo riprende la dottrina dell’empirismo classico, in particolare di Hume. Il
tentativo è di preparare e di fondare una “scienza dei fatti psichici” che avesse lo stesso
rigore delle scienze della natura. In questa direzione già il termine Anima appare improprio
e viene spesso sostituito dal termine “spirito”; in questo senso John Stuart Mill dice che lo
spirito è la serie delle nostre sensazioni con, in più, un’infinita possibilità di sentire, o, più
semplicemente, ciò che sente. Oggetto della psicologia diventano i fenomeni psichici o gli
stati di coscienza, che vengono spiegati mediante il vario associarsi dei loro elementi più
semplici. Tale psicologia senza Anima presiedette agli inizi della psicologia scientifica e fu
l’insegna polemica per l’eliminazione, dal campo di essa, della nozione tradizionale
dell’anima come sostanza. Il termine, tuttavia, fu ed è ancora usato per indicare l’insieme
delle esperienze psichiche in quanto sono raccolte in una qualche unità. Wundt per unità
94
intese l’unità della coscienza. Dewey scrive: “In conclusione si può affermare che la parola
Anima, quando è liberata da tutte le tracce del tradizionale animismo materialistico,
denota la qualità delle attività psico-fisiche, in quanto sono organizzate in unità. Alcuni
corpi hanno Anima in modo eminente come altri hanno eminentemente fragranza, colore e
solidità … Dire enfaticamente di una persona particolare che essa ha un’Anima o una
grande Anima, non significa pronunziare una frase fatta applicabile ugualmente a tutti gli
esseri umani. Esprime invece la convinzione che l’uomo o la donna in questione possiede in
grado notevole le qualità di una sensibile, ricca e coordinata partecipazione a tutte le
situazioni della vita. Così le opere d’arte, la musica, la pittura, l’architettura hanno Anima,
mentre altre sono morte, meccaniche” (Esperienza e Natura, 293 sgg.). Ma l’Anima in
questo senso non è più un abitante del corpo, ma designa un insieme di capacità o di
possibilità di cui ogni singolo uomo o cosa partecipa più o meno. Ryle ha battezzato la
concezione di Anima, che fa risalire a Cartesio, come quella dello “spettro nella macchina”.
In realtà la nozione è molto più antica e deve la sua forza, più che alle sue capacità
esplicative, alle garanzie che essa fornisce o sembra fornire a determinati valori. Ryle
ritiene che la nozione sia frutto di un errore categoriale per il quale i fatti della vita mentale
sono considerati appartenenti a un tipo o categoria (o classe di tipi o categorie) logica (o
semantica) diversa da quella cui essi appartengono. Tale errore è simile a quello di chi,
dopo aver visitato aule, laboratori, biblioteche, musei … che costituiscono un’Università, si
domandi che cosa sia o dove risieda l’Università stessa. L’università non è un’unità che si
aggiunga agli organismi o ai membri che la costituiscono e che possegga quindi una realtà a
parte da tali organismi o membri. Così pure l’Anima non ha realtà a parte dalle
manifestazioni singole, dai comportamenti particolari superiori che la parola serve a
designare nel loro complesso.
In conclusione, anche assai prima di quest’ultima condanna, la nozione tradizionale di
anima come una specie di realtà a sé, principio e fondamento degli eventi detti mentali,
era stata abbandonata e ridotta alla nozione di un’unità funzionale o di una qualche specie
di coordinazione e di sintesi tra quegli eventi. In questa forma la nozione rinvia a quella di
coscienza.
95
Gnoseologia
Per conoscenza, in generale, si intende una tecnica per l’accertamento di un oggetto qualsiasi, o la
disponibilità o il possesso di una tecnica siffatta. Per tecnica di accertamento va intesa una
qualsiasi procedura che renda possibile la descrizione, il calcolo e la previsione controllabile di un
oggetto; e per oggetto va intesa qualsiasi entità, fatto, cosa, realtà o proprietà, che possa essere
sottoposto a una tale procedura. Tecnica, in questo senso, è l’uso normale di un organo di senso
come la messa in opera di complicati strumenti di calcolo: entrambi questi procedimenti
consentono infatti accertamenti controllabili. Non possiamo presumere che tali accertamenti
siano infallibili ed esaurienti: non esiste una tecnica di accertamento tale che, una volta adoperata
nei confronti di una conoscenza x, renda inutile il suo ulteriore impiego nei confronti della stessa
conoscenza, senza che questa perda nulla della sua validità. La controllabilità delle procedure di
accertamento, grossolane o raffinate che siano, significa la ripetibilità delle loro applicazioni,
sicché una conoscenza accertabile o più semplicemente una conoscenza, rimane tale solo finché
sussiste la possibilità dell’accertamento. Le tecniche di accertamento possono avere, tuttavia, i più
diversi gradi di efficacia e possono, al limite, avere efficacia minima o nulla: in questo caso,
decadono di diritto dal rango delle conoscenze. La “conoscenza di x” significa infatti una procedura
che è in grado di fornire qualche informazione controllabile intorno a x, cioè che consenta di
descriverlo, calcolarlo o prevederlo in certi limiti. La disponibilità o il possesso di una tecnica
conoscitiva designa la partecipazione personale a questa tecnica. “Io conosco x” significa (salvo
limitazioni) che sono in grado di porre in opera una procedura che rende possibile la descrizione, il
calcolo o la previsione di x. Il significato personale o soggettivo di conoscenza è perciò da ritenersi
secondario e derivato: il significato primario è quello oggettivo e impersonale su esposto. Questo
significato primario consente di distinguere la credenza dalla conoscenza: la credenza è l’impegno
alla verità di una nozione qualsiasi, anche non accertabile; la conoscenza è una procedura di
accertamento o la partecipazione possibile a una tale procedura. Come procedura di
accertamento, ogni operazione conoscitiva è diretta a un oggetto e tende a instaurare con
l’oggetto stesso un rapporto dal quale emerga una caratteristica effettiva di esso. Le
interpretazioni della conoscenza sono le formulazioni del rapporto tra operazione conoscitiva e
oggetto.
Secondo una prima interpretazione il rapporto conoscitivo consiste in una identità o somiglianza
(identità debole o parziale) e l’operazione conoscitiva è una procedura di identificazione con
l’oggetto e di riproduzione di esso.
Nella prima fase l’identità o la somiglianza con l’oggetto viene intesa come identità o somiglianza
degli elementi della conoscenza con gli elementi dell’oggetto, la somiglianza dei concetti o delle
rappresentazioni con le cose. Così la dottrina della conoscenza come identificazione è apparsa nel
mondo antico. I presocratici la espressero con il principio che “il simile conosce il simile”, per cui
Empedocle affermava che conosciamo la terra con la terra, l’acqua con l’acqua (frammento 105,
Diels). Varianti di questo principio possono essere considerate sia l’affermazione di Eraclito “ciò
96
che si muove conosce ciò che si muove” (Aristotele, De Anima, I, 2, 405 a 27) sia quella di
Anassagora secondo la quale “l’anima conosce il contrario con il contrario” (Teofrasto, De sensu,
27). Quest’ultima sembra alludere più ad una condizione della conoscenza – che presuppone la
diversità, come dirà Aristotele (De Anima II, 5, 417 a 16) - che allo stesso atto conoscitivo, come
indica la giustificazione che gli viene data: “il simile infatti non può subire l’azione del simile”.
Platone e Aristotele stabilirono su solide basi tale interpretazione della conoscenza. Platone spiega
i processi conoscitivi con i concetti dell’incontro del simile con il simile e di omogeneità: conoscere
significa rendere simile il pensante al pensato (Timeo 45 c, 90 c-d). Per questo i gradi di
conoscenza si modellano sui gradi dell’essere: non si può conoscere con certezza, cioè con
saldezza, ciò che non è saldo perché la conoscenza non fa che riprodurre l’oggetto; sicché “ciò che
assolutamente è, è assolutamente conoscibile, mentre ciò che non è in nessun modo, in nessun
modo è conoscibile” (Repubblica, 477 a). In tal modo Platone fece corrispondere all’essere la
scienza, che è la conoscenza vera; al non essere l’ignoranza e al divenire, che è tra l’essere e il non
essere, l’opinione che sta in mezzo tra la conoscenza e l’ignoranza. E distinse i seguenti gradi della
conoscenza: la supposizione o congettura che ha per oggetto ombre ed immagini delle cose
sensibili; l’opinione creduta ma non verificata che ha per oggetto delle cose naturali, gli esseri
viventi e in generale il mondo sensibile; la ragione scientifica che procede per via di ipotesi ed ha
per oggetto gli enti matematici; l’intelligenza filosofica che procede dialetticamente ed ha per
oggetto il mondo dell’essere (ibid., 509-510). Ognuno di questi gradi di conoscenza è la copia
esatta del suo oggetto rispettivo: per Platone conoscere è stabilire in ogni caso con l’oggetto un
rapporto di identità o che si avvicini quanto più possibile all’identità.
Secondo Aristotele la conoscenza in atto è identica con l’oggetto conosciuto: è cioè la stessa
forma sensibile dell’oggetto, se si tratta di conoscenza sensibile; è la stessa forma intellegibile, o
sostanza, dell’oggetto se si tratta di conoscenza intellegibile (De anima, II, 5, 417a). La facoltà
sensibile e l’intelletto potenziale sono semplici possibilità di conoscere; ma quando queste
possibilità si realizzano, per l’azione delle cose esterne la prima, per l’azione dell’intelletto attivo la
seconda, s’identificano con i rispettivi oggetti e, per es., l’udire un suono (sensazione in atto)
s’identifica con il suono stesso come l’intendere una sostanza si identifica con la sostanza stessa.
Egli può affermare in generale che “la scienza in atto è identica al suo oggetto” (De anima III, 7,
431a 1). Questa dottrina aristotelica si può considerare come la forma tipica dell’interpretazione
della conoscenza come identità con l’oggetto. Tale interpretazione domina, con l’eccezione degli
Stoici, il corso ulteriore della filosofia greca.
Epicuro ritiene che il flusso dei simulacri (eidola) che si staccano dalle cose e si imprimono
sull’anima serve appunto a garantire la somiglianza delle immagini con le cose (Epistola a Erodoto,
51).
E Plotino si avvale dello stesso concetto per chiarire la natura della conoscenza. La conoscenza si
ha quando la parte dell’anima con cui si conosce si unifica e fa tutt’uno con l’oggetto conosciuto.
Se l’anima e quest’oggetto rimangono due, l’oggetto rimane esterno all’anima stessa e la
97
conoscenza di esso rimane inoperante. Solo l’unità dei due termini costituisce la conoscenza vera
(Enneadi, III, 8, 6).
Nella filosofia cristiana la stessa interpretazione prevale, ed è anzi il fondamento delle più
caratteristiche speculazioni teologiche e antropologiche.
Secondo Agostino l’uomo può conoscere Dio in quanto egli stesso è immagine di Dio. Memoria,
intelligenza e volontà, nella loro unità e distinzione reciproca, riproducono nell’uomo la Trinità
divina di Essere, Verità e Amore (De Trinitate X, 18). Questa nozione dominò l’intera teologia
medievale e fu anche il fondamento dell’antropologia. Ma da essa derivava una conseguenza
importante per la conoscenza che l’uomo ha delle cose inferiori a Dio. Il riconoscimento
dell’origine divina dei poteri umani (in quanto immagini dei poteri divini) rende i poteri umani
relativamente indipendenti dagli altri oggetti conoscibili e accentua l’importanza del soggetto
conoscente. Se per Aristotele la facoltà sensibile e l’intelletto potenziale non sono che i loro stessi
oggetti “in potenza” e non hanno nessuna indipendenza di fronte a questi oggetti, per Agostino
“ogni conoscenza deriva insieme dal conoscente e dal conosciuto” (ibid., XIX, 12), mettendo così
sullo stesso piano l’oggetto conosciuto e il soggetto conoscente come condizione della
conoscenza.
Tommaso articola la questione della conoscenza secondo questi pilastri:
il realismo per il quale la conoscenza non è una creazione della mente umana (idealismo) e
neppure un’interpretazione meramente soggettiva dei dati dell’esperienza (empirismo,
fenomenismo), ma è una rappresentazione della realtà, che può essere vera o falsa nella
misura in cui si conforma o non si conforma alla realtà
l’importanza dell’esperienza sensitiva, che costituisce il punto di partenza di ogni
conoscenza. Anche la conoscenza intellettiva viene ricavata dall’esperienza sensitiva. Egli fa
sua la tesi aristotelica dell’astrazione e respinge la dottrina platonico – agostiniana
dell’illuminazione. L’uomo stesso è autore di tutte le sue conoscenze tranne quelle della
fede. Così nella visuale tomistica l’uomo è padrone di se stesso (dei propri atti) non solo
nell’ambito della volontà, ma anche in quello dell’intelletto
l’armonia tra fede e ragione, tra il mondo delle cose che l’uomo riesce ad acquisire con la
laboriosa indagine e il mondo delle verità che gli vengono offerte dalla Parola di Dio.
Egli così definisce la conoscenza: “Si ha cognizione perché l’oggetto conosciuto viene a trovarsi nel
conoscente” (S. Th., I, q. 59, a. 2), oppure: “la conoscenza ha luogo nella misura in cui il conosciuto
è nel conoscente” (I, q. 12, a. 4). L’oggetto conosciuto si trova nel conoscente secondo il modo
dell’assimilazione: “Omnis cognitio fit per assimilationem cognoscentis ad cognoscitum” (Contra
Gentiles I, c. 65, n. 537). L’assimilazione dà come risultato la formazione nel conoscente di
un’immagine dell’oggetto conosciuto: “Omnis cognitio fit secundum similitudinem cogniti in
cognoscente” (ibid., II, c. 77, n. 1581). Con una formula più elaborata e completa la conoscenza
98
viene così descritta: “Qualsiasi conoscenza avviene mediante qualche specie, grazie alla cui
informazione ha luogo l’assimilazione del conoscente alla cosa conosciuta” (I Sent., d. 3, q. 1, a. 1,
ob. 3).
Tommaso divide la conoscenza umana in due tipi, sensitiva e intellettiva: “L’anima ha una duplice
potenza conoscitiva. Una è atto d’un organo corporeo. E ad essa è connaturale conoscere le cose
secondo che sono nella materia individuale: cosicché il senso non conosce che i singolari. L’altra
potenza conoscitiva dell’anima è l’intelletto, il quale non è atto o funzione di alcun oggetto
corporeo. Perciò, mediante l’intelletto ci è connaturale conoscere nature (o essenze) le quali
veramente non hanno l’essere che nella materia individuale; tuttavia non sono percepite da noi in
quanto esistenti nella materia, ma in quanto ne sono astratte dall’intelletto che le considera.
Cosicché noi possiamo conoscere intellettualmente tali cose con una conoscenza universale: il che
supera la capacità del senso” (S. Th., I, q. 12, a. 4).
La conoscenza sensitiva si suddivide a sua volta in due gruppi: a. quella dei sensi esterni (vista,
udito, gusto, odorato e tatto) e quella dei sensi interni (senso comune, memoria, fantasia ed
estimativa o istinto), che unifica, conserva e magari modifica le percezioni isolate dei sensi esterni
(I, q. 78, aa. 3 e 4).
Tra i sensi interni e l’intelletto Tommaso introduce un’altra facoltà a cui dà il nome di cogitativa, la
quale ha la funzione di saldare in qualche modo il concetto universale con le immagini particolari.
Essa svolge nell’uomo la stessa funzione che negli animali viene svolta dall’istinto: “Perciò quella
potenza che negli animali è chiamata estimativa naturale (istinto), nell’uomo viene detta
cogitativa, perché raggiunge queste immagini intenzionali mediante una specie di ragionamento”
(I, q. 78, a. 4). Già riconosciuta da Aristotele, la cogitativa è stata più attentamente studiata dai
filosofi arabi, specialmente da Averroè, di cui il Dottore Angelico riprende le tesi principali.
Secondo costui, alla cogitativa, detta anche ratio particularis, competono le seguenti funzioni: a)
apprendere i contenuti di valore o intentiones insensatae, quali la bontà o la malizia di un oggetto
(I, q. 78, a. 4); b) giudicare dei sensibili comuni e dei sensibili propri (De veritate, I, q. 11); c)
preparare il phantasma da cui l’intelletto possa astrarre la conoscenza dell’essenza (Contra
Gentiles, II, c. 60); d) percepire in concreto quelle nozioni ontologiche fondamentali (realtà,
sostanza, causa, relazione e gli altri predicamenti) che l’intelletto afferra poi nell’universalità
dell’astrazione. La cogitativa apprende l’individuo in quanto esistente sotto la natura comune, e
ciò avviene in quanto essa si collega con l’intelletto nello stesso soggetto; così essa conosce questo
uomo in quanto è questo uomo e conosce questo legno in quanto è questo legno. La cogitativa
opera quindi il raccordo tra l’intelletto e il senso sia nella funzione discendente come in quella
ascendente e parimenti tra la volontà deliberante e l’appetito concupiscibile e irascibile; in essa
quindi si viene raccogliendo ciò che forma la materia delle attuazioni superiori dello spirito, la
scienza e la virtù: “La cogitativa rappresenta il massimo grado della parte sensitiva, dove attinge in
qualche modo la parte intellettiva tanto da diventare partecipe di ciò che spetta alla parte
intellettiva, ossia il grado minimo del discorso razionale, come prescrive la regola di Dionigi
99
l’Areopagita” (De Veritate, q. 14, a. 1, ad 9). La cogitativa unisce saldamente l’attività dei sensi con
quella della ragione e dell’intelletto e viceversa, sicché non si registra nessuna spaccatura tra il
mondo dei sensi e quello dell’intelletto, ma una continuità naturale e ininterrotta.
All’intelletto Tommaso assegna tre attività principali: l’astrazione, il giudizio, il ragionamento. Il
nostro autore recupera, dunque, a proposito dell’attività intellettiva, la teoria aristotelica
dell’astrazione, preferendola alla teoria agostiniana dell’illuminazione. L’astrazione, per Aristotele
come per Tommaso, è l’attività con cui l’intelletto ottiene le idee universali derivandole dai dati
particolari proposti dall’immaginazione: “E’ proprietà dell’intelletto umano conoscere le forme che
hanno una sussistenza individuale nella materia, ma non in quanto sono una determinata materia.
Ora, conoscere ciò che esiste in una determinata materia, non però come si trova in quella materia,
significa astrarre la forma dalla materia individuale rappresentata dai fantasmi (le immagini della
fantasia). Dunque è necessario concludere che il nostro intelletto conosce le cose materiali
mediante l’astrazione dai fantasmi, e che da una siffatta conoscenza delle cose materiali possiamo
raggiungere una certa conoscenza delle cose immateriali” (I, q. 85, a. 1). Fino agli inizi del sec. XIII
la dottrina corrente tra gli scolastici per spiegare l’origine della conoscenza intellettiva era quella
della illuminazione, teorizzata da S. Agostino. Secondo tale dottrina, le conoscenze che hanno
valore assoluto, le cosiddette verità eterne non sono frutto della ricerca umana bensì della
illuminazione divina; perché, a parere di Agostino e dei suoi seguaci, la contingenza delle cose e la
fragilità dell’intelletto non consentono alla nostra mente di giungere a tali altezze con le sue sole
forze. Ma, nel sec. XIII, in seguito alla riscoperta di Aristotele e delle sue dottrine psicologiche,
gnoseologiche e metafisiche, si prospetta ai latini un nuovo modo di concepire la conoscenza, che
elimina qualsiasi intervento divino e la fa dipendere esclusivamente dalla attività della mente
umana. Questa dottrina, per certi aspetti, poteva sembrare dissacrante, antireligiosa e pagana. E,
in effetti, essa costituiva una delle principali ragioni per cui Aristotele era stato ripetutamente
proscritto dall’università di Parigi e dalle altre scuole filosofiche e teologiche della Francia,
dell’Italia e dell’Inghilterra. Tommaso, ottimo conoscitore e commentatore di Aristotele, nota che,
in sede strettamente teoretica, la dottrina dell’astrazione è molto più solida di quella
dell’illuminazione. La seconda è insostenibile, almeno per due ragioni: “Prima, perché se l’anima
possiede una nozione naturale di tutte le cose, non sembra possibile che cada in tale oblio di
questa conoscenza naturale, da ignorare persino di possedere tale conoscenza. Nessuno, infatti,
dimentica quello che conosce per natura, per es., che il tutto è maggiore della parte e altre verità
del genere … Seconda, la falsità di tale teoria appartiene chiaramente dal fatto che, quando
abbiamo la mancanza di un dato senso, viene a mancare la scienza di quelle cose che sono
percepite per mezzo di esso; così il cieco nato non può avere nessuna nozione dei colori. Ora,
questo non avverrebbe, se nell’anima fossero innati i concetti di tutte le cose intellegibili” (I, q. 84,
a. 3). Ma c’è anche una terza ragione che il Dottore Angelico ha ben presente quando difende la
causalità delle creature: è che se si sottrae all’iniziativa umana, per rimetterla nelle mani di Dio,
l’azione della conoscenza intellettiva, la quale inizia con l’astrazione, si svilisce l’uomo stesso, in
quanto lo si priva di ciò che maggiormente lo nobilita e lo innalza al di sopra degli animali.
Tommaso mette a confronto la situazione della mente prima dell’astrazione delle idee con quella
100
della mente dopo l’astrazione. Prima la mente è in possesso solo dei fantasmi di cose singole e
della facoltà intellettiva di accogliere le idee (intelletto passivo o possibile). Dopo l’astrazione
l’idea viene registrata e conservata dall’intelletto passivo. Ora, perché il fantasma assurga allo
stato di idea e, a sua volta, l’intelletto sia in grado di acquisirla e conservarla, occorre far
intervenire un’operazione che il nostro autore si rifiuta di attribuire a qualche agente estraneo alla
mente umana, sia il Dio illuminatore di Agostino, o il Dator formarum di Avicenna, e la attribuisce
all’intelletto agente. Pertanto, egli scrive, “occorre ammettere anche un intelletto agente. Infatti,
essendo l’intelletto possibile in potenza rispetto agli intellegibili, è necessario che siano gli
intellegibili stessi ad attuare l’intelletto possibile. Ma ciò che non esiste non può attuare qualcosa.
Ora, l’intellegibile, per quanto dipende dall’intelletto possibile, non ha un’esistenza propria, ossia
non diviene esistente come intellegibile. Infatti ciò che l’intelletto possibile apprende è l’astratto di
molte cose e si trova esistente in molte di esse. Ma una cosa simile non si trova sussistente nella
natura delle cose. Dunque, se l’intelletto possibile deve essere mosso dall’intellegibile, questo deve
diventare prima intellegibile mediante l’intelletto. E non potendo questo esser fatto dall’intelletto
possibile, bisogna porre, oltre all’intelletto possibile, anche un intelletto agente che elabori gli
intellegibili in atto, i quali muovono l’intelletto possibile. L’intelletto agente genera gli intellegibili
astraendoli dalla materia e dalle condizioni materiali che sono i principi di individuazione” (De
anima, a. 4). “E’ quindi evidente che l’intelletto agente costituisce la causa principale che produce
la rappresentazione delle cose nell’intelletto possibile. Invece i fantasmi che sono ricevuti dalle cose
esterne costituiscono la causa strumentale. Quanto all’intelletto possibile, rispetto alle cose di cui
acquista cognizione è da considerarsi come un paziente che coopera con l’agente” (Quodl., VIII, q.
2, a. 2). I fantasmi sono sempre l’oggetto su cui cade il lume dell’intelletto agente nel momento in
cui pensa, astraendola, una determinata idea. In continuità con l’incarnazione dell’anima nel
corpo, a livello conoscitivo si realizza l’incarnazione dell’intelletto nella fantasia. Attraverso tre
gradi di astrazione si ottengono tre grandi classi di idee: le idee fisiche, le idee matematiche e le
idee metafisiche. Le prime si ottengono prescindendo dalla materia sensibile particolare; le
seconde prescindendo dalla materia sensibile, ma non da quella intellegibile; le ultime
prescindendo da qualsiasi specie di materia: “Ci sono infine degli oggetti che non dipendono dalla
materia neppure per esistere: infatti possono esistere senza la materia. Di tali oggetti, alcuni non
esistono mai nella materia, come Dio e gli angeli; altri esistono ora con la materia ora senza, come
la sostanza, la qualità, la potenza, l’unità, la molteplicità e simili, di cui tratta la teologia o scienza
divina, cosiddetta perché il suo oggetto principale è Dio. Essa viene chiamata anche metafisica o
ultrafisica, dato che noi dobbiamo arrivare a realtà non sensibili. Si dice anche filosofia prima in
quanto le altre scienze vengono dopo, derivando da essa i loro principi” (In De Trinitate, lect. 2, q.
1, a. 1). Dopo che mediante l’astrazione la mente si è formata delle idee, essa può procedere verso
la formulazione dei giudizi e questi li può ordinare in maniera tale da formare un’ipotesi scientifica
oppure una scienza. Facendo sua la teoria dell’astrazione Tommaso abbraccia logicamente anche
la teoria del doppio intelletto: agente (o attivo) e paziente (o passivo), liberandola tuttavia dalle
incertezze dello Stagirita che avevano consentito ad Averroè di sostenere che ci sono tanti
intelletti passivi individuali ma un unico intelletto agente universale. Anche gli intelletti agenti
101
sono molteplici, secondo Tommaso: ogni persona è dotata del proprio intelletto sia agente sia
passivo, e così diviene responsabile di tutto il proprio mondo conoscitivo.
Il giudizio è la seconda operazione dell’intelletto. Esso si realizza sia componendo sia separando i
concetti. Si dà giudizio affermativo nel primo caso, negativo nel secondo: “L’altra operazione
appartiene all’intelletto in quanto unisce o divide” (In I Periherm., Prooem.). L’attività del giudizio
consiste esattamente nel giudicare, ossia nell’affermare oppure nel negare qualche cosa (una
qualità, una proprietà) rispetto a una determinata cosa (soggetto). Pertanto il giudizio procede per
via di unificazione oppure separazione di idee. E viene logicamente al secondo posto, tra le attività
dell’intelletto, in quanto già presuppone l’apprensione (astrazione) delle idee. Nel giudizio il nostro
autore sottolinea due funzioni: una riguarda il piano logico ed è l’enunciazione della verità; l’altra
riguarda il piano ontologico ed è la significazione dell’essere. Spetta al giudizio attestare la
corrispondenza o non corrispondenza tra due concetti e non all’astrazione, la quale si limita a
cogliere l’essenza di qualche cosa: “Nella prima operazione la mente si forma semplicemente l’idea
dell’essenza di qualche cosa, per es., l’essenza dell’uomo o dell’animale: e in questa operazione non
c’è ancora verità o falsità. Nella seconda operazione l’intelletto compone e divide, affermando e
negando; ed in questa operazione si ha il vero e il falso” (De Veritate, q. 14, a. 1). Collegata
direttamente con la prima funzione è la seconda: la significazione dell’essere. La seconda
operazione consiste infatti nel trasportare la mente dal piano delle pure essenze al piano reale
degli esistenti, attestandone l’essere o il non essere, o l’esistenza o la non esistenza di una qualità
in un determinato soggetto: “La prima operazione riguarda l’essenza della cosa; la seconda
riguarda il suo essere. E poiché il concetto di verità si fonda nell’essere e non nell’essenza, ne
consegue che la verità e la falsità propriamente parlando si trovano nella seconda operazione” (I
Sent., d. 19, q. 5, a. 1, ad 7). Oltre che nell’ambito speculativo, per il Dottore Angelico il giudizio
occupa un posto di grande rilievo anche in quello pratico: nell’esercizio dell’atto libero. Questo
comprende sempre due elementi, uno propriamente intellettivo e l’altro volitivo. Quello volitivo è
costituito dalla scelta (electio); mentre quello intellettivo è costituito dal giudizio pratico.
La terza operazione dell’intelletto è il ragionamento. Esso consiste in qualsiasi operazione
discorsiva con cui, muovendo da una o più premesse, si ricava una conclusione, che può essere
vera o falsa, certa o probabile, a seconda della natura delle premesse. Il ragionamento si suddivide
in due tipi principali: deduttivo (quando almeno una delle due premesse è universale), oppure
induttivo (quando ciò che fa da premessa è un elenco più o meno esteso di dati particolari). La
forma più perfetta del ragionamento deduttivo è il sillogismo. Aristotele, nell’Organon, ha
studiato e fissato per primo la struttura e le regole del ragionamento. Tommaso fa sua la teoria
aristotelica del ragionamento, del quale dà una precisa definizione nei termini seguenti:
“Ragionare significa procedere da una conoscenza a un’altra, nel conoscere la verità … Il ragionare
umano secondo il metodo di indagine o di invenzione, parte da semplici intuizioni, quali sono i
primi principi; e finalmente ritorna (col metodo deduttivo) o per via di giudizio ai primi principi, alla
cui luce esamina le conclusioni raggiunte” (I, q. 79, a. 8). Speciale attenzione egli poi riserva al
ragionamento pratico, a causa della sua grande rilevanza per la morale, alla quale spetta fornire
102
indicazioni chiare su ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è lecito o illecito, ciò che è doveroso e
ciò che non lo è. La morale deve dire a un individuo senza ambiguità ciò che deve fare in un caso
concreto particolare, e non semplicemente fornire elenchi di principi universali astratti. L’uomo
prudente, l’autentico moralista secondo S. Tommaso, è esattamente colui che sa cosa è giusto fare
nel caso singolo e decide rettamente (III Sent., d. 33, q. 3, a.1, sol. 3). Ma come si passa dai principi
universali al caso concreto? Lo si fa attraverso il sillogismo pratico. Come esempio di questo tipo di
ragionamento, Tommaso cita un caso di adulterio. Si può dimostrare la sua malizia ragionando
così: a. qualsiasi male va evitato; b. ma l’adulterio è male perché è vietato da Dio (oppure perché
è ingiusto e disonesto); c. quindi questo adulterio va evitato perché è cattivo. Tommaso ricorda
che il ragionamento pratico è più esposto all’errore del ragionamento speculativo, e questo non
tanto perché spesso si deve ricorrere a principi che non sono naturalmente evidenti, ma
soprattutto perché vi si possono facilmente intromettere le passioni che legano il giudizio della
ragione in quel caso particolare.
Tommaso ha affrontato con grande impegno il problema del valore della conoscenza soprattutto
nel Commento al libro IV della Metafisica, nel De Veritate e in varie Distinzioni nel Commento alle
Sentenze. La conoscenza umana ha un valore, perché adempie la sua funzione di esibire una
rappresentazione sostanzialmente fedele alla realtà delle cose. La conoscenza ha un valore perché
la rappresentazione che dà delle cose è vera. L’intelletto umano non arriva immediatamente a
conoscere la verità delle cose mediante l’intuizione, ma col processo raziocinativo, un processo
suscettibile di errore che, spesse volte, dà luogo a dubbi e perplessità. Ed è proprio l’esperienza
dell’errore – in particolare gli errori dei sensi e gli errori dei filosofi – a mettere in crisi la
conoscenza e a far sorgere il problema del suo valore. I Sofisti e gli Scettici (accademici) avevano
dato a questo problema una soluzione negativa: avevano negato che la conoscenza umana abbia
la capacità di raggiungere con certezza la verità, qualsiasi verità. Alle obiezioni dei Sofisti aveva
replicato Aristotele mostrando l’irrefutabilità del principio di non contraddizione; alle obiezioni
degli Scettici aveva risposto S. Agostino con il celebre assunto: “Si fallor, sum”. Tommaso segue da
vicino Aristotele, facendo vedere che c’è almeno una verità, quella del principio di non
contraddizione che resiste all’assalto di qualsiasi dubbio, e demolendo uno per uno tutti gli
argomenti (in particolare quello degli errori dei sensi) a cui si aggrappavano i Sofisti e gli Scettici
per contestare il valore della conoscenza. Agli Scettici, che fanno leva sugli errori dei sensi, per
mettere in dubbio che la mente umana abbia il potere di raggiungere la verità, Tommaso replica:
“E’ cosa strana che essi dubitino se la verità sia coma appare ai dormienti o come appare alle
persone sveglie. Infatti nei dormienti i sensi sono assopiti e perciò il loro giudizio concernente le
cose non può essere libero, come è invece libero il giudizio delle persone sveglie, i cui sensi sono
liberi. Un siffatto dubbio è strano, perché le persone che dicono di averlo, in pratica, nelle loro
azioni, non mostrano affatto di dubitare e non considerano egualmente veraci i giudizi del malato
e del sano, dell’addormentato e di chi è sveglio … Tutti i dubbi di cui si è parlato in queste pagine,
hanno lo stesso valore e hanno un’unica radice: quella di voler fornire prove di carattere
dimostrativo per tutto. È evidente infatti che i Sofisti che avanzano questi dubbi pretendono di
scoprire un principio che possa servire loro da regola per discernere tra l’ammalato e il sano, tra
103
l’addormentato e chi è sveglio. E non si accontentano affatto che la regola sia presentata loro in
qualche maniera, ma vogliono che sia dimostrata. Che però in questo siano in errore è chiaramente
provato dalla loro condotta, come s’è già detto. Quindi, la loro posizione è falsa. Infatti se il
giudizio di chi dorme e di chi è sveglio avesse lo stesso peso, il comportamento degli uomini
sarebbe identico in tutti e due i casi; e questo è evidentemente falso” (IV Met., lect. 14-15).
L’intelletto, mediante un vigile controllo dei sensi, può garantirsi la formazione di rappresentazioni
veridiche delle cose.
Altrettanto ferma e vigorosa è la difesa, fornita da S. Tommaso, del valore del principio di non
contraddizione, difesa indiretta e non diretta, ma indubbiamente efficace. Come per gli errori dei
sensi, l’Angelico fa vedere che ciò che può essere sostenuto a parole è poi contraddetto dai fatti,
dal comportamento della vita quotidiana. Basta che uno pronunci anche una sola parola sensata,
per es. che dica “piove”: pronunciando questa parola non potrà allo stesso tempo voler dire: “non
piove”. Aggiunge il nostro autore: “Però ciò si può fare soltanto nel caso che colui che mette in
dubbio la validità di tale principio dica qualche cosa, ossia esprima qualche cosa a parole. Perché
se non dice niente è ridicolo fornire delle spiegazioni a chi rifiuta di far uso della ragione” (VI Met.,
lect. 6). L’intelletto umano, pur avendo come obiettivo proprio e specifico la verità e pur essendo
in grado di prendere coscienza del suo possesso quando l’attinge, tuttavia è esposto all’errore e
non di rado vi incorre. Quali sono le ragioni di tali deviazioni? La prima è data dalla complessità
dell’oggetto: “L’intelletto creato, non essendo in grado di cogliere tutta la realtà simultaneamente,
può errare in quanto giudica una cosa conveniente considerandola da un particolare punto di vista,
mentre non sarebbe affatto conveniente se la considerasse da un altro. Per es., un medico giudica
una medicina opportuna per curare in un ammalato una malattia che è a sua conoscenza, mentre
non è affatto conveniente per curare un’altra malattia che o non conosce o non tiene presente” (II
Sent., d. 5, q. 1, q. 1, ad. 4). La seconda è la precipitazione: “La precipitazione si dice degli atti
dell’anima metaforicamente, per una certa somiglianza col moto corporeo. Ora, nel caso del moto
corporeo si dice che una cosa precipita quando scorre dall’alto al basso o per impulso proprio
oppure per la spinta proveniente da terzi senza passaggio graduale e ordinato. Nell’anima il punto
più alto è la ragione, il punto più basso sono le operazioni eseguite mediante il corpo. I gradini
intermedi per i quali bisogna scendere ordinatamente sono la memoria delle cose passate,
l’apprensione delle presenti, la solerzia nel prendere in considerazione le cose future, il
ragionamento con cui si confronta una cosa con un’altra, la docilità con cui si ascoltano le opinioni
altrui. Chi non vuole errare discende per questi gradini con ordine. Chi invece si lascia trasportare
all’azione o dalla volontà o dalla passione senza percorrere tali gradini si lascia prendere dalla
precipitazione … L’attenzione è d’obbligo soprattutto nel giudizio. E perciò la mancanza di retto
giudizio è da attribuirsi soprattutto alla mancanza di attenzione. Infatti si manca di giudicare
rettamente perché si disprezza o si trascura di fare attenzione a quelle cose da cui nasce il giudizio
adeguato” (S. Th., II-II, q. 53, aa. 3-4). La terza è data dalle passioni: queste non sono soltanto
causa della precipitazione, ma inducono anche la mente a formulare giudizi errati in quanto
assorbono talmente l’intelletto da impedirgli di considerare le cose serenamente, oggettivamente,
imparzialmente. Pertanto, per attingere la verità, non bastano lo studio assiduo, l’attenzione
104
vigile, la ricerca paziente; è anche necessario tenere a bada le passioni e impedire loro di
pronunciare giudizi affrettati, interessati e parziali (II Sent., d. 5, q. 1, a. 1, ad 4).
Essendo l’anima umana dotata di due potenze conoscitive, quella sensitiva e quella intellettiva,
Tommaso distingue due specie di oggetti: le cose corporee singolari, che formano l’oggetto della
conoscenza sensitiva, e le essenze universali, tratte dalle cose sensibili, che costituiscono l’oggetto
della conoscenza intellettiva. Riguardo alla conoscenza intellettiva, egli distingue due oggetti, un
oggetto proprio e un oggetto adeguato. L’oggetto proprio sono le essenze delle cose materiali; la
loro conoscenza è raggiunta mediante l’astrazione dai dati sensitivi. Questo è l’oggetto proprio
perché corrisponde perfettamente a quella capacità conoscitiva di cui è dotato l’uomo, che
essendo legato sostanzialmente al corpo e vivendo in un mondo corporeo, ricava necessariamente
tutte le sue conoscenze dal mondo materiale, con l’aiuto dei sensi e della fantasia: “L’oggetto
proprio dell’intelletto umano unito al corpo sono le essenze o nature che hanno la loro sussistenza
nella materia corporea; e mediante queste essenze delle cose visibili l’uomo può salire a una certa
conoscenza delle cose invisibili. Ma la nozione stessa di queste nature esige che esse abbiano
concreta sussistenza in determinati individui; e ciò non può verificarsi senza la materia. Così la
nozione della natura della pietra richiede la sussistenza concreta di essa in questa determinata
pietra; e quella della natura del cavallo richiede la sussistenza concreta in un determinato cavallo e
così via. Non si può quindi conoscere in maniera completa e vera la natura della pietra o di
qualsiasi altro essere materiale, se non la si conosce nella sua esistenza particolare e concreta.
Oggi noi raggiungiamo il particolare mediante il senso e l’immaginativa. Perciò, affinché l’intelletto
possa conoscere il proprio oggetto, è necessario che si volga ai fantasmi e apprenda così la natura
universale sussistente in ogni cosa particolare” (S. Th., I, q. 84, a. 7). L’oggetto adeguato
dell’intelletto umano è l’essere in tutta la sua estensione e intensione (densità). Nella prospettiva
specifica di Tommaso abbiamo l’essere intensivo, l’actualitas omnium actuum. Solo l’essere
intensivo con la sua perfezione e attualità infinite è in grado di colmare, attuandola, l’infinita
apertura dell’intelletto. E poiché in sede metafisica l’essere intensivo coincide, nella sua piena
attuazione, con l’esse ipsum subsistens, Tommaso conclude logicamente che soltanto Dio può
appagare veramente la sete di verità dell’intelletto umano, e così, quando l’uomo non conosce più
Dio per speculum et in enigmate, ma lo vede faccia a faccia e lo contempla esteticamente, allora
raggiunge la pienezza della beatitudine. In conclusione, la ragione è naturalmente portata a
conoscere la verità e a conoscere tutta la verità: quella relativa al mondo materiale come quella
attinente al mondo spirituale, quella speculativa come quella pratica, quella che riguarda la
politica, la morale, la religione ecc. Sennonché l’intelletto umano incontra sulla sua strada
innumerevoli difficoltà: le passioni, la fretta, gli interessi particolari, la stessa fantasia, la
complessità e la sublimità dell’oggetto, che possono impedirgli il raggiungimento della felicità. Ciò
accade soprattutto nel caso delle verità più elevate e impegnative, quelle di ordine metafisico,
morale e religioso: verità come l’esistenza di Dio, l’immortalità dell’anima, la legge morale. Quanto
a Dio, secondo Tommaso, la ragione ha la capacità di conoscere che egli esiste e che possiede
determinati attributi (unicità, semplicità, sapienza, onnipotenza, bontà ecc.). Di fatto però una
conoscenza solida intorno a Dio è conseguita soltanto da poche menti eccezionali. D’altra parte, si
105
tratta di una conoscenza che riveste somma importanza per la vita umana, perché questa, anche
da un punto di vista puramente razionale, ha come suo ultimo traguardo Dio: “Lo scopo della vita
umana è conoscere Dio anche secondo i filosofi” (II Sent., d. 24, q. 1, a. 3, qc. 3, sol. 1, ad 1). Ciò
spiega perché Dio, amorosamente attento ai bisogni dell’uomo, sia intervenuto egli stesso
direttamente per fornire all’umanità una più chiara conoscenza del proprio essere mediante una
speciale Rivelazione: “Sebbene la ragione sia già in grado di indagare intorno a Dio, tuttavia fu
necessario che l’uomo fosse ammaestrato per divina rivelazione, perché una conoscenza razionale
di Dio non sarebbe stata possibile che per parte di pochi, dopo lungo tempo e con mescolanza di
molti errori; eppure dalla conoscenza di tali verità dipende tutta la salvezza dell’uomo, che è
riposta in Dio. Per provvedere alla salvezza degli uomini in modo più conveniente e più certo fu
perciò necessario che rispetto alle cose divine fossero istruiti per divina rivelazione” (S. Th., I, q. 1,
a. 1).
S. Bonaventura, pur rimanendo fedele al principio agostiniano di un lumen directivum che l’uomo
riceve direttamente da Dio e da cui derivano certezza e verità, ammette che il materiale della
conoscenza è costituito da specie che sono immagini, similitudini o “quasi pitture” delle cose
stesse (In Sent., I, d. 17, a. 1, q. 4).
Il Rinascimento conserva in generale l’interpretazione della conoscenza come identità e
somiglianza.
Cusano dice esplicitamente che l’intelletto non intende se non si assimila a ciò che deve intendere
(De mente, 3; De ludo globi, 1; De venatione sapientiae, 29) e Ficino dice che la conoscenza è
l’unione spirituale con qualche forma spirituale (Theologia platonica, III, 2). I naturalisti non si
esprimono in modo diverso: Bruno riprende il principio presocratico che ogni simile si conosce col
simile; e Campanella afferma che “noi conosciamo ciò che è, perché ci rendiamo simili a esso”
(Metaphisica, I, 4, 1). Il pitagorismo dei fondatori della nuova scienza, Leonardo, Copernico,
Keplero, Galilei ha un presupposto analogico: il procedimento matematico della scienza si
giustifica perché la natura stessa ha struttura matematica: nel senso che, come Galilei dice, i
caratteri in cui è scritto il libro della natura sono triangoli, cerchi, ecc. (Opere, VI, p. 232).
Nella filosofia moderna, la dottrina che il conoscere è un’operazione di identificazione assume tre
forme principali.
a. L’idealismo critico e poi Romantico e le sue diramazioni contemporanee hanno affermato
la tesi che conoscere significa porre, cioè produrre e creare, l’oggetto: tesi la quale
consente di riconoscere nell’oggetto stesso la manifestazione o l’attività del soggetto.
Nell’idealismo critico il soggetto pone, unificando nel giudizio, l’oggetto della conoscenza,
ma il contesto metafisico è il realismo. Nell’idealismo romantico il soggetto pone se stesso
e, dunque, tutta la realtà. Fichte così afferma: “La rappresentazione in generale è
inconfutabilmente un effetto del Non-io. Ma nell’io non può esserci assolutamente nulla che
sia un effetto; perché l’Io è quel che esso si pone e non v’è nulla in lui che non sia posto da
106
lui. Quindi quello stesso Non-io dev’essere un effetto dell’Io, anzi dell’Io assoluto e così non
abbiamo un’azione sull’Io dal di fuori, ma solo un’azione dell’Io su se stesso”
(Wissenschaftslehre, 1794, III, § 5, 1). Da questo punto di vista il Non-io, cioè l’oggetto, non
è che l’Io stesso, cioè il soggetto: l’identità con l’oggetto è così garantita dalla stessa
definizione della conoscenza. Essa è una definizione arbitraria che non ha effetto sulla
riuscita o meno degli effettivi atti di conoscenza e non serve però né a dirigere né a chiarire
questi atti. Il principio affermato da Fichte fu un pilastro del movimento romantico; e uno
dei luoghi comuni più perniciosi e stucchevoli, il “potere creativo dello spirito”, trova in
esso la sua origine. Di esso Schelling non faceva che chiarire il significato quando
affermava: “Nello stesso fatto del sapere – quando io so – l’oggettivo e il soggettivo sono
così uniti che non si può dire a quale dei due tocchi la priorità. Non c’è qui un primo e un
secondo: sono entrambi contemporanei e costituiscono un tutto unico” (System des
transzendentalen Idealismus, Intr., § 1). Il concetto del conoscere come processo di
unificazione domina anche la filosofia di Hegel. La protagonista di questa filosofia, l’Idea, è
la coscienza che si realizza, gradualmente e necessariamente, come unità con l’oggetto.
Scrive Hegel: “L’Idea è in primo luogo uno degli estremi di un sillogismo in quanto è il
concetto che ha come scopo innanzitutto se stesso come realtà soggettiva. L’altro estremo
è il limite del soggettivo, il mondo oggettivo. I due estremi sono identici nell’essere
dell’Idea. L’unità loro è in primo luogo l’unità del concetto che nell’uno di essi è soltanto per
sé, nell’altro soltanto in sé; in secondo luogo la realtà è astratta nell’uno, mentre nell’altro
è nella sua esteriorità completa. Questa unità viene ora posta per mezzo del conoscere”
(Wissenschaft der Logik, III, 3, cap. II; tr. it., p. 282). Il conoscere è così il processo che
unifica il mondo soggettivo con il mondo oggettivo; o meglio che porta alla coscienza
l’unità necessaria dei due. Tutte le forme dell’Idealismo contemporaneo si attengono a
questa dottrina. Croce la introduce chiamando “concreto” il concetto: per il qual carattere
si dovrebbe escludere che esso sia “universale e vuoto”, “universale e inesistente”, ed
ammettere che esso comprende in sé “l’atto logico universale” e il “pensamento della
realtà” che è poi la stessa realtà (Logica, 4° ed., 1920, p. 29). Gentile affermava: “Conoscere
è identificare, superare l’alterità come tale” (Teoria generale dello Spirito, 2, §4). A sua
volta Bradley, più criticamente, considerava questa identificazione come un ideale – limite
irrealizzabile in noi, ma realizzato nella Coscienza assoluta nella quale coscienza ed essere,
verità e realtà coincidono (Appearance and Reality, pag. 181).
b. Lo spiritualismo moderno in tutte le sue manifestazioni considera il conoscere come un
rapporto interno della coscienza, cioè come un rapporto della coscienza con se stessa.
Questa interpretazione garantisce l’identità del conoscere con l’oggetto: giacché l’oggetto,
da questo punto di vista, non è che la coscienza stessa o almeno un suo prodotto o una sua
manifestazione. Schopenhauer così esprimeva questa dottrina: “Nessuno può mai uscire da
sé per identificarsi immediatamente con cose diverse da sé: tutto ciò di cui egli ha
conoscenza sicura, quindi immediata, si trova dentro la coscienza” (Die Welt, II, cap. I).
Coscienza, senso intimo, introspezione, intuito, intuizione, sono i termini che la filosofia
107
moderna, a partire dal Romanticismo, adopera per indicare la conoscenza caratterizzata
dall’identità con il suo oggetto, perciò privilegiata nella sua certezza. La considerazione di
base è qui che, se il soggetto non può conoscere ciò che è altro da sé, la sola certezza vera
e originaria è quella che esso ha di se stesso. Su questa base Maine De Biran vedeva nel
“senso intimo” la sola conoscenza possibile e ne interpretava le testimonianze come verità
metafisiche (Essais sur les fondements de la psicologie, 1812). Altre volte la coscienza,
anche detta intuito o intuizione, è interpretata come la rivelazione che Dio fa all’uomo o di
un suo attributo fondamentale (per es. dell’essere, come afferma Rosmini, Nuovo Saggio,
§ 473), o del suo stesso processo creativo, come fa Gioberti (Introduzione allo studio della
filosofia II, pag. 183). In modo analogo, l’intuizione, di cui parla Bergson come “visione
diretta dello spirito da parte dello spirito” (La Pensée et le Mouvant, pag. 37) è una
procedura privilegiata di conoscenza nella quale il termine oggettivo è identico con il
soggettivo. E quando Husserl ha voluto chiarire il modo di essere privilegiato della
coscienza, ha chiamato “percezione immanente” quella che la coscienza ha delle proprie
esperienze vissute: perché l’oggetto di essa appartiene alla stessa corrente di coscienza a
cui appartiene la percezione (Ideen, I, § 38). La percezione immanente, cioè la coscienza, è,
su questa base, considerata da Husserl assoluta e necessaria: in essa “non vi è posto per
discordanza, apparenza, possibilità di essere altra cosa. Essa è una sfera di assoluta
posizione” (ibid., § 46).
c. Il Positivismo logico ha paradossalmente trasportato nel linguaggio, in cui esso vede la
vera e propria operazione conoscitiva, la dottrina del carattere identificatorio di questa
operazione. Wittgenstein afferma che “la proposizione può essere vera o falsa solo in
quanto è una immagine (Bild) della realtà” (Tractatus, 4.06). Egli prova così questa
affermazione: “Io infatti vengo a conoscere la situazione da essa rappresentata se capisco
la proposizione. E capisco la proposizione senza che il suo senso mi venga spiegato” (ibid.,
4.021). A prima vista, egli aggiunge, “non sembra che la proposizione, così come, ad
esempio, è stampata sulla carta, sia un’immagine della realtà di cui tratta. Ma anche la
notazione musicale non sembra a prima vista una immagine della musica né la nostra
scrittura fonetica (a lettere) sembra un’immagine del nostro linguaggio parlato. Eppure
questi simboli si dimostrano, anche nel senso ordinario del termine, come immagini di ciò
che rappresentano” (ibid., 4.011). L’insistenza sulla nozione di immagine indica
chiaramente che egli condivide la vecchia interpretazione del conoscere come operazione
di identificazione. Egli infatti dice: “Ci deve essere qualcosa di identico nell’immagine e
nell’oggetto raffigurato affinché quella possa essere l’immagine di questo” (ibid., 2.161).
Ma questo qualcosa di identico è la “forma di raffigurazione” (ibid., 2.17). E la forma di
raffigurazione è “la possibilità che le cose stiano una rispetto all’altra come stanno tra loro
gli elementi dell’immagine” (ibid., 2.151). E questo sembra rinviare all’interpretazione del
rapporto identificatorio che emerge in una seconda fase.
108
La seconda fase della dottrina della conoscenza come identificazione nasce con la filosofia
moderna, precisamente con Cartesio. Il principio cartesiano che l’idea è il solo oggetto immediato
della conoscenza e che perciò l’esistenza dell’idea nel pensiero non dice nulla sull’esistenza
dell’oggetto rappresentato, metteva ovviamente in crisi la dottrina del conoscere come
identificazione con l’oggetto: l’oggetto è, infatti, in questo caso, chiaramente irraggiungibile.
Cartesio aveva continuato a concepire l’idea come “quadro” o “immagine” della cosa (Meditazioni
Metafisiche, III); ma già in lui compare una tendenza (cfr. Regulae, V) a scorgere nella conoscenza,
più che l’assimilazione o l’identità dell’idea con l’oggetto conosciuto, l’assimilazione e l’identità
dell’ordine delle idee con l’ordine degli oggetti conosciuti. Malebranche, il quale ammette che
l’uomo vede direttamente in Dio le idee delle cose e considera perciò fortemente problematica la
realtà delle cose stesse, ammette tuttavia questa realtà come fondamento dell’ordine e della
successione delle idee nell’uomo: ordine e successione non avrebbero senso se non coincidessero
con l’ordine e la successione delle cose cui le idee si riferiscono (Entretien sur la Métaphysique, I,
6-7). Spinoza che ammette tre generi di conoscenza (la percezione sensibile e l’immaginazione, la
ragione con le sue nozioni comuni e universali, la scienza intuitiva) ritiene che solo i due ultimi
consentano di distinguere il vero dal falso perché tolgono l’idea dal suo isolamento e la collegano
con le altre idee, situandola nell’ordine necessario che è la stessa Sostanza divina (Ethica II, 44).
Locke che definisce la conoscenza come “la percezione dell’accordo e del legame o del disaccordo
e del contrasto delle idee tra di loro” (Saggio, IV, 4, 8) e perciò definisce la verità come “l’unione o
separazione dei segni, secondo che le cose significate da esse concordino o discordino tra loro”
(ibid., IV, 5, 2). Egli ritiene che questo riferimento ad oggetti reali non sia indispensabile alla
conoscenza matematica e a quella morale, mentre lo è alla “conoscenza reale” che ha per oggetto
sostanze (ibid. IV, 4, 12). Per Leibniz accanto alla conoscenza a priori, fondata sui principi
costitutivi dell’intelletto, c’è una conoscenza rappresentativa la quale consiste nella somiglianza
delle rappresentazioni con la cosa. Ma l’una e l’altra conoscenza fanno dell’anima “uno specchio
vivente, perpetuo dell’universo” perché entrambe sono formate sul legame che tutte le cose
create hanno tra loro sì che “ciascuna sostanza semplice ha rapporti che esprimono tutti gli altri”
(Monadologie, 56). In tutte queste notazioni, sebbene non venga negato il carattere di somiglianza
o di immagine degli elementi conoscitivi, la conoscenza viene intesa propriamente come identità
con l’ordine oggettivo. L’oggetto di essa è propriamente quest’ordine e il conoscere è l’operazione
che tende a identificare o identificarsi con esso e non già con gli elementi singoli tra i quali
intercede. A questo proposito la “rivoluzione copernicana” di Kant non consiste nell’innovare
radicalmente questo concetto di conoscenza, quanto nell’ammettere che l’ordine oggettivo delle
cose si modella sulle condizioni della conoscenza e non viceversa. Le categorie sono infatti
considerate da Kant come “concetti che prescrivono leggi a priori ai fenomeni e perciò alla natura
come insieme di tutti fenomeni” (Critica della Ragion Pura, § 26). I fenomeni, non essendo “cose in
se stesse” ma “rappresentazioni di cose” devono per essere tali essere pensati e così sottostare
alle condizioni del pensiero che sono appunto le categorie. L’ordine oggettivo della natura non è
quindi altro, secondo Kant, che l’ordine stesso dei procedimenti formali del conoscere in quanto
quest’ordine si è incorporato in un contenuto oggettivo che è il materiale sensibile dell’intuizione.
109
Da questo punto di vista il conoscere non è un’operazione di assimilazione o di identificazione, ma
di sintesi; e come tale va considerato sotto l’altra interpretazione, la conoscenza come
trascendenza. Tutta questa fase della dottrina della conoscenza come assimilazione, per cui
l’oggetto dell’assimilazione è l’ordine, si può considerare come situata tra la prima e la seconda
interpretazione principale del conoscere: cioè tra l’interpretazione del conoscere come
assimilazione e l’interpretazione del conoscere come trascendenza.
La seconda interpretazione fondamentale vede la conoscenza come un’operazione di
trascendenza. Secondo questa dottrina, conoscere significa venire in presenza dell’oggetto,
puntare su di esso o, col termine preferito dalla filosofia contemporanea, trascendere verso di
esso. La conoscenza è allora l’operazione in virtù della quale l’oggetto stesso è presente: o
presente per così dire in persona o presente in un segno che lo renda rintracciabile o descrivibile o
prevedibile. Questa interpretazione non si fonda su alcuna assunzione di carattere assimilatorio o
identificatorio: i procedimenti del conoscere non mirano, per essa, a convertirsi con l’oggetto
stesso del conoscere. Mirano piuttosto a rendere presente questo oggetto come tale o a stabilire
le condizioni che rendono possibile la sua presenza, cioè consentono di prevederla. La presenza
dell’oggetto o la predizione di questa presenza sarebbero la funzione effettiva della conoscenza.
Tale interpretazione compare per la prima volta negli Stoici. Essi chiamavano evidenti le cose che
“vengono di per se stesse alla nostra conoscenza” come, per esempio, l’essere giorno; e
chiamavano oscure quelle che sfuggono solitamente alla conoscenza umana. Tra queste ultime,
distinguevano poi quelle oscure per natura, che non cadono mai sotto la nostra evidenza, e quelle
oscure momentaneamente ma evidenti per natura (per esempio, la città di Atene per coloro che
non vi risiedono). Queste due ultime specie di cose si comprendono per mezzo di segni; mediante
segni indicativi le cose oscure per natura (come, per esempio, il sudore si assume come segno
degli invisibili pori) e mediante segni rammemorativi le cose evidenti per natura ma oscure
momentaneamente (come il fumo è un segno del fuoco) (Sesto Empirico, Adversus dogmaticos, II,
141). Sono riconoscibili in questa impostazione due tesi fondamentali:
1. La conoscenza evidente consiste nella presenza della cosa, per cui la cosa si manifesta da sé
o si comprende da sé, cioè si comprende come cosa, quindi come altro da chi la
comprende.
2. La conoscenza non evidente avviene per mezzo di segni che rinviano alla cosa stessa senza
avere una qualsiasi identità o somiglianza con essa.
Questa dottrina degli Stoici è rimasta per lunghi secoli inoperante, come una possibilità che la
storia della filosofia ha trascurato. Comincia a riaffacciarsi soltanto nella Scolastica del ‘300, coi
pensatori che criticano la dottrina della species come intermediaria della conoscenza. La species,
come si è visto, è lo strumento che indirizza la mente all’oggetto conosciuto, è l’immagine
intenzionale grazie alla quale la mente è cosciente dell’oggetto conosciuto, non di essa. Essa è una
tesi tipica della dottrina dell’assimilazione: essa è infatti insieme l’atto della conoscenza e l’atto
110
dell’oggetto (come forma o sostanza di quest’ultimo). Ma Duns Scoto aveva distinto una
conoscenza “che astrae dall’esistenza attuale della cosa” e che chiamava astrattiva, e una
conoscenza della cosa in quanto esiste ed è presente nella sua esistenza attuale che aveva
chiamata intuitiva (Opus Oxoniensis, II, d. 3, q. 9, n. 6). Ora la conoscenza intuitiva (che da un lato è
quella sensibile, dall’altro quella intellettuale che ha per oggetto la sostanza o natura comune, per
esempio la natura umana) non ha bisogno di specie perché ad essa è direttamente presente la
cosa in persona. Solo la conoscenza astrattiva, cioè la conoscenza intellettuale dell’universale, ha
bisogno di specie. A questa dottrina fa riferimento la Scolastica del ‘300. Durando di St. – Pourcains afferma che la specie è inutile perché l’oggetto stesso è presente al senso, e, attraverso il
senso, anche all’intelletto (In Sententiis, II, d. 3, q. 6, n. 10); e che pertanto la conoscenza
universale non è che conoscenza confusa, nel senso che chi ha la conoscenza universale, per
esempio, della rosa, conosce confusamente ciò che è intuito distintamente da chi vede la rosa che
gli è presente (ibid., IV, d. 49, q. 2, n. 8). Per Pietro Aureolo l’oggetto della conoscenza è la stessa
cosa esterna che assume, per opera dell’intelletto, un essere intenzionale e obiettivo che non è
diverso dalla stessa realtà individuale della cosa (In Sententiis, I, d. 9, a. 1). Ockam a sua volta
trasforma la teoria scolastica della conoscenza intuitiva in una teoria dell’esperienza e afferma
l’immediata presenza della cosa alla conoscenza intuitiva: “In nessuna conoscenza intuitiva, né
sensibile né intellettiva, la cosa si costituisce in un essere intermedio tra la cosa stessa e l’atto di
conoscere; ma la cosa medesima immediatamente e senza intermediario tra sé e l’atto, è vista e
appresa” (In Sententiis, I, d. 27, q. 3, 1). La conoscenza intuitiva perfetta, che ha per oggetto una
realtà attuale o presente, è l’esperienza (ibid., II, q. 15, H); quella imperfetta, che concerne un
oggetto passato, deriva sempre da un’esperienza (ibid., q. 12, Q). A sua volta, la conoscenza
astrattiva, che prescinde dalla realtà o irrealtà dell’oggetto, deriva da quella intuitiva ed è una
intentio o signum. Ockham riproduce così l’interpretazione degli Stoici: quando la realtà non è
presente alla conoscenza “in persona”, si annuncia o si manifesta nel segno. La validità del segno
concettuale, che a differenza di quello linguistico non è arbitrario o convenzionale, ma naturale,
deriva dal fatto che esso è prodotto naturalmente, cioè causalmente, dall’oggetto stesso, sicché la
sua capacità di rappresentare l’oggetto non è altro che questa sua connessione causale con esso
(Quodl., IV, q. 3). Ockham si avvale poi, per illustrare la funzione logica, del segno di quel concetto
della suppositio che era stato elaborato dalla logica del ‘200. Nel sec. XVII i capisaldi di questa
dottrina venivano riprodotti da Hobbes: per il quale la sensazione, che è il fondamento di ogni
conoscenza, è il manifestarsi della cosa attraverso il movimento da essa impresso all’organo di
senso (Leviatano I,1; De corpore, 25, §2). Alla causalità della cosa esterna, cui questi filosofi
attribuiscono la conoscenza, Berkeley sostituiva la causalità di Dio: la teoria che le cose conosciute
sono segni mediante i quali Dio parla ai sensi o all’intelligenza dell’uomo per istruirlo su ciò che
deve fare è una trascrizione teologica di questa dottrina della conoscenza (Principles of
Knowledge, § 108-09). Nel frattempo, con il cartesianesimo e specialmente con Locke, si era
venuto formando il concetto della conoscenza come operazione unificatrice: unificatrice di idee,
cioè di stati che cadono dentro la coscienza, ma il cui collegamento corrisponde o deve
corrispondere a quello delle cose. Eliminata da Berkeley la sostanza materiale e da Hume ogni
111
specie di sostanza, il collegamento tra le idee veniva ad esaurire la funzione dell’attività
conoscitiva. Così Hume ritiene che ogni operazione conoscitiva sia un’operazione di connessione
tra le idee:
a. operazione di connessione è il ragionamento per il quale si mostra il legame che le idee
hanno tra loro, indipendentemente dalla loro esistenza reale;
b. operazione di connessione tra le idee è la conoscenza della realtà di fatto.
Nel primo caso la connessione è certa perché non dipende da nessuna condizione di fatto; nel
secondo caso si fonda sulla relazione di causalità. Ma questa stessa relazione non ha altro
fondamento che la ripetizione di una certa successione di eventi e l’abitudine che tale ripetizione
determina nell’uomo.
Questo concetto della conoscenza come operazione di connessione o di collegamento, che non ha
più niente a che fare con l’identificazione o l’assimilazione con l’oggetto, è detta da Kant
operazione di sintesi. La sintesi in generale è “l’atto di riunire diverse interpretazioni e
comprendere la loro molteplicità in una conoscenza” (Critica della Ragion Pura § 10). Ma la sintesi
conoscitiva non è solo, per Kant, un’operazione di collegamento tra rappresentazioni: è anche
un’operazione di collegamento con l’oggetto di queste rappresentazioni per il tramite
dell’intuizione. Scrive Kant: “Se una conoscenza deve avere una realtà oggettiva, cioè riferirsi a un
oggetto e avere in esso significato e senso, l’oggetto deve, in un modo qualsiasi, poter essere dato.
Senza di questo, i concetti sono vuoti, e se anche con essi si pensa, di fatto questo pensiero non
conosce nulla ma soltanto gioca con le rappresentazioni. Dare un oggetto, se questo a sua volta
non deve essere opinato indirettamente ma rappresentato immediatamente nell’intuizione, non è
altro che connettere la sua rappresentazione con l’esperienza (sia questa reale o possibile)” (ibid.,
Analitica dei principi, cap. II, sez. II). Pensare un oggetto e conoscere un oggetto non sono dunque
la stessa cosa: “La conoscenza comprende due punti: in primo luogo un concetto per cui in generale
un oggetto è pensato (la categoria) e in secondo luogo l’intuizione con cui esso è dato” (ibid., § 22).
L’intuizione ha questo privilegio: che essa si riferisce immediatamente all’oggetto e che per mezzo
di essa l’oggetto è dato (ibid., § 1). Sicché non c’è dubbio che l’operazione del conoscere tenda a
rendere presente l’oggetto nella sua realtà: un oggetto, s’intende, che è fenomeno, giacché la cosa
in sé è, per definizione, estranea a ogni rapporto conoscitivo. Senza questa limitazione
relativistica, che a Kant, come a tutta la filosofia illuministica, era suggerita dall’impostazione
cartesiano – lockiana della analisi della conoscenza, il concetto della conoscenza come
dell’operazione del riferirsi o del rapportarsi con l’oggetto e perciò pure del processo per cui
l’oggetto si offre o si presenta in persona, diventa, nella filosofia contemporanea, proprio della
fenomenologia e delle correnti che ad essa fanno capo. Scrive Husserl: “Ad ogni scienza
corrisponde un campo oggettivo come dominio delle sue indagini e a tutte le sue conoscenze, cioè
ai suoi corretti enunciati, corrispondono determinate intuizioni che ne costituiscono il fondamento
di legittimità; in quanto in esse gli oggetti del campo si presentano in datità personale e, almeno
parzialmente, in datità originaria” (Ideen, I, § 1). Così l’esperienza che abbraccia tutta la
112
conoscenza naturale, è un’operazione intuitiva attraverso la quale un oggetto specifico, la cosa, è
data nella sua realtà originaria. L’esperienza è in questo senso un atto fondante, non sostituibile
da un semplice immaginare. Dall’altro lato, la conoscenza geometrica, che non ricerca realtà ma
possibilità ideali, ha come suo atto fondante la visione dell’essenza: tale visione, esattamente
come la percezione empirica, rende attuale e presenta in persona un oggetto, che però non è la
cosa dell’esperienza, ma l’essenza (ibid., § 8). Considerando la conoscenza da un punto di vista più
generale si può dire che “ogni specie di essere ha per essenza i suoi modi di darsi e quindi il suo
metodo di conoscenza” (ibid., § 79); e la ricerca fenomenologica è, nel progetto di Husserl, l’analisi
di questi modi di essere come “modi di datità”. In modo analogo, per N. Hartmann, la conoscenza
è un processo di trascendenza che ha il suo termine nell’essere “in sé” (Metafisica dei costumi,
1921, 4° ed., 1949, p. 43 ss). In questa impostazione la contrapposizione tra attività e passività
nella conoscenza (contrapposizione che, nata da Kant, era stata assunta come motivo polemico dal
Romanticismo a cominciare da Fichte) ha perduto ogni significato. Non è più questione di
distinguere nel conoscere l’aspetto attivo, che Kant chiamava spontaneità intellettuale,
dall’aspetto passivo che per Kant era quello della sensibilità. Non si tratta neppure di ridurre
l’intera conoscenza alla attività dell’Io come ha fatto Fichte e con lui l’intera filosofia romantica,
che ha considerato come “infinita”, cioè senza limiti e quindi creatrice, questa attività e come tale
l’ha esaltata. La prospettiva storica, che lo stesso Romanticismo ha fatto prevalere, del contrasto
tra la concezione classica, cioè antica e medievale, per la quale l’operazione del conoscere sarebbe
dominata dall’oggetto, di fronte a cui il soggetto è passivo; e la concezione moderna o romantica,
per la quale la conoscenza sarebbe attività del soggetto e manifestazione del suo potere creatore,
questa prospettiva stessa appare ora fittizia. Si tratta infatti di una prospettiva interna al
Romanticismo e di un contrasto che esso ha teorizzato come motivo polemico. Né la filosofia
antica né le moderne concezioni oggettivistiche pretendono stabilire o presuppongono la
“passività” del soggetto conoscente. Al soggetto conoscente appartiene certamente l’iniziativa del
conoscere, anzi questa iniziativa definisce per l’appunto la sua soggettività. Ma questo non implica
né attività né passività nel senso stabilito da Fichte. L’iniziativa del soggetto è invece diretta
proprio a rendere presente o manifesto l’oggetto, a rendere evidente la realtà stessa, a far parlare
i fatti. Ciò che si chiama, con termine abbreviativo, conoscere, è un insieme di operazioni, talora
molto diverse tra loro, che in campi diversi mirano a far emergere, nelle loro caratteristiche
proprie, certi oggetti specifici. Da questo punto di vista lo stesso “problema della conoscenza”,
come si è venuto configurando nella seconda metà dell’800, sulla base dell’impostazione
romantica o della polemica contro di essa, come problema dell’attività o della passività dello
spirito o dei caratteri di quella sua “categoria eterna” che sarebbe l’attività teoretica, è un
problema che si è dissolto sotto l’azione della fenomenologia da un lato e della filosofia della
scienza e del pragmatismo dall’altro lato. Nell’ambito della fenomenologia, Heidegger parla infatti
di un annullamento del problema della conoscenza. Il conoscere non può essere inteso come ciò
per cui l’Esserci (cioè l’uomo) “va da un dentro a un fuori della sua sfera interiore, sfera in cui
sarebbe in un primo tempo incapsulato: al contrario l’Esserci, conformemente al suo modo di
essere fondamentale è già sempre fuori, presso l’ente che gli viene incontro in un mondo già
113
sempre scoperto” (Essere e Tempo, § 13). Secondo il nostro autore il conoscere è un modo di
essere dell’essere – nel – mondo, cioè del trascendere del soggetto verso il mondo. Esso non è mai
soltanto un vedere o un contemplare: “L’essere nel mondo, in quanto prendersi cura, è penetrato e
stordito dal mondo di cui si prende cura” (ibid.). Il conoscere è in primo luogo la sospensione del
prendersi cura, cioè delle attività comuni della vita di ogni giorno, come il manipolare, il
commerciare ecc.. Questa sospensione rende possibile il semplice “osservare che è di volta in volta
il soffermarsi presso un ente, il cui essere è caratterizzato dal fatto che è presente, che è qui”. In
questo fermarsi di ogni commercio e utilizzazione, si realizza la percezione della semplice
presenza. Il percepire si concretizza nelle forme dell’interpretare e del discutere intorno a
qualcosa in quanto qualcosa. Sul fondamento di questo interpretare in senso larghissimo, il
percepire si fa un determinare. Il percepito o il determinato può essere espresso in proposizioni,
nonché ritenuto e conservato in quanto asserito. Questo ritenimento percettivo d’una asserzione
intorno a … è una maniera di essere nel mondo e non può essere considerato come un
procedimento in virtù del quale un soggetto riceverebbe immagini da qualche cosa, immagini che
sarebbero di conseguenza sperimentate come “interne” sì da far sorgere il problema della loro
concordanza con la realtà “esterna” (ibid.). Il problema della conoscenza e il problema della realtà
come formulati dalla filosofia dell’800 sono quindi eliminati da Heidegger. Tutte le manifestazioni
o i gradi del conoscere (l’osservare, il percepire, il determinare, l’interpretare, il discutere, il
negare e l’asserire) presuppongono il rapporto dell’uomo con il mondo e sono possibili solo sulla
base di questo rapporto.
Questa convinzione è oggi condivisa da filosofi di provenienza diversa, per quanto venga spesso
rivestita da terminologie differenti. Il fondamento che la suggerisce è sempre lo stesso:
l’abbandono del presupposto che gli “stati interni” (idee, rappresentazioni ecc.) siano gli oggetti
primari di conoscenza e che solo a partire da essi possano essere (se mai) inferiti oggetti di altra
natura. La rinuncia a questo presupposto è esplicita nel pragmatismo di Dewey, per il quale la
conoscenza è semplicemente il risultato di un’operazione di ricerca o più precisamente è
l’asserzione valida cui tale operazione mette capo. Da questo punto di vista, l’oggetto della
conoscenza non è un’entità esterna da raggiungere o da inferire ma è “quel gruppo di distinzioni o
caratteristiche connesse che emerge come costituente definito di una situazione risolta ed è
confermato nella continuità dell’indagine” (Logica, cap. XXV, II; tr. it, p. 666). Poiché
frequentemente vengono usati, in una certa indagine, oggetti costituiti in indagini precedenti,
questi ultimi sono talora intesi come oggetti esistenti o reali indipendentemente dall’indagine
stessa. In realtà sono indipendenti dall’indagine in cui ora entrano, ma sono oggetti solo in virtù di
un’altra indagine di cui sono il risultato. Eppure, questo semplice equivoco è, secondo il nostro
autore, la base della concezione rappresentativa della conoscenza: “L’atto di riferirsi a un oggetto,
che è un oggetto conosciuto solo in virtù di operazioni affatto indipendenti dall’atto stesso di
riferimento, è considerato ai fini di una teoria della conoscenza come costituente per se medesimo
un caso di conoscenza rappresentativa” (ibid., pag. 667). Queste idee hanno agito e continuano ad
agire potentemente nella filosofia contemporanea e sono alla base di quella dissoluzione del
problema della conoscenza che è una delle sue caratteristiche. La dissoluzione di questo problema
114
si è operata in favore da un lato della logica, dall’altro della metodologia delle scienze.
Quest’ultima, specialmente, è l’erede, nella filosofia contemporanea, di quanto rimane di valido in
problemi che venivano solitamente trattati dalla teoria della conoscenza.
Dagli anni ’70, segnatamente dalla pubblicazione di Groundless Belief (1977) di Michael Williams e
di Philosophy and the Mirror of Nature (1979) di Richard Rorty, l’idea che il problema della
conoscenza non sia più proponibile nei termini cartesiani e kantiani di una secolare tradizione è
condivisa da molti, e trova ampie consonanze con i progetti di “secolarizzazione” della filosofia da
parte dell’odierna ermeneutica. Le fonti in base a cui alcuni autori contemporanei parlano
letteralmente di “morte dell’epistemologia” e di “dissoluzione” del problema della conoscenza
sono ancora il pragmatismo di James e Dewey, e quindi gli scritti di Wittgenstein, Quine, Sellars,
Austin e Davidson, un certo storicismo di ritorno, e alcune suggestioni che vengono dalle filosofie
di Nietzsche, Heidegger e Derrida. Rorty sostiene che le annose, insolubili questioni intorno alla
distinzione tra soggetto e oggetto del conoscere, tra forme e contenuti, tra convenzioni e verità di
fatto, sono state generate dalla concezione “rappresentazionale” delle credenze e dal suo fido
alleato che è la concezione “corrispondentista” della verità (secondo Rorty, genealogicamente
riconducibili all’epistemologia “cartesiana – lockeana – kantiana e soprattutto, nel ‘600, alla
frapposizione di un “velo delle idee” tra soggetto e mondo). L’idea che vi sia una realtà
indipendente dalla mente che il soggetto conoscente deve cercare di “rispecchiare” è un’idea
metafisica legata ad un complesso di assunzioni psicologiche e epistemologiche che, secondo i
critici dell’epistemologia, sono oggi decisamente soppiantate da concezioni “pragmatiche” e
“comportamentiste”, le quali non richiedono alcuna idea di “rappresentazione” e, alla fine,
vanificano, in quanto erroneamente posto, ogni sforzo di far combaciare schemi concettuali e
“fatti”.
Anche se attinge a molta letteratura “continentale” – soprattutto Heidegger, il decostruzionismo
di Derrida e molta filosofia postmoderna – il referente polemico di Rorty, come anche di Williams
e oggi di Stephen Stich (The Fragmentation of Reason, 1990), è un tipo di impostazione della
filosofia della conoscenza che appartiene in senso stretto alla tradizione analitica anglo –
americana. Tale tradizione è caratterizzata da un approccio alla conoscenza i cui tratti salienti
sono:
1. il privilegiare i problemi inerenti alla conoscenza proposizionale (“io so che p” dove p è
un’entità linguistica e non una cosa nel mondo);
2. la risposta alle varie sfide che lo scetticismo ha avanzato contro le nostre pretese di
conoscenza;
3. l’analisi dei concetti epistemici ordinari, quali quelli di “credenza”, “verità”,
“giustificazione”
4. la valutazione e la riforma delle pratiche comuni di ragionamento.
115
Il punto di partenza dell’analisi della conoscenza da parte di tale tradizione è stata spesso
l’assunzione che la conoscenza potesse essere definita, nei termini del Menone di Platone, come
credenza vera giustificata. La conoscenza, dunque, viene in questo caso considerata come
credenza + qualcosa; e questo qualcosa è dato soprattutto da una adeguata teoria della
giustificazione, articolata in un sistema di regole o principi atti a valutare quali stati cognitivi sono
epistemicamente giustificati e quali no, oppure, nelle accezioni cosiddette “affidabiliste”,
dall’individuazione di un processo di acquisizione delle nostre conoscenze che possa garantirle
come tali. La tradizione analitica, come rimprovera Rorty, ha preso davvero sul serio le sfide
scettiche e ha soprattutto drammatizzato, cercando le vie per una ricomposizione, quella che
Wilfrid Sellars (Science, Perception, and Reality, 1963) ha icasticamente definito come la divisione
tra “immagine scientifica” e “immagine manifesta” del mondo. I suoi tentativi di risposta si sono
spesso articolati intorno a una definizione della conoscenza e delle sue componenti necessarie e
sufficienti. Se i problemi che tale impostazione privilegia hanno una precisa origine storica – che,
peraltro, sarebbe corretto analizzare meno genericamente di come ha fatto Rorty – non è affatto
assodato che tale genealogia li abbia ipso facto resi inattuali, né che le obiezioni
comportamentiste, pragmatiste e deflazioniste avanzate da Rorty (ma anche da Quine, Davidson e
da altri rappresentanti della filosofia postanalitica) ai problemi della conoscenza e della verità
siano a loro volta immuni da critiche. Lo stesso concetto di “rappresentazione”, per esempio,
centrale nell’epistemologia tradizionale e ritenuto da Rorty decisamente fuorviante, appare invece
oggi al centro di un rinnovato interesse da parte delle “scienze cognitive”; mentre molti problemi
della conoscenza – relativi a una distinzione tra innato e acquisito, relativi ai limiti della
conoscenza, e anche relativi all’esplicazione di molti concetti intrinsecamente connessi alla
conoscenza –, seppur datati storicamente, mantengono un’attualità che va oltre la contingenza
delle loro premesse.
Un modo diverso di considerare i problemi della conoscenza, anche se per molti versi in
consonanza con le dissoluzioni postmoderne, è quello proposto dalle cosiddette “epistemologie
naturalizzate”, le quali non li reputano più problemi trattabili filosoficamente, con un approccio
trascendentale o fondazionale, e li vedono invece come posti e resolubili all’interno delle scienze
empiriche stesse (la psicologia, la biologia, la sociologia ecc.). Se, comunque, una diffusa tendenza
al superamento dell’impostazione tradizionale dei problemi della conoscenza si può verificare
all’interno di molte correnti filosofiche contemporanee, dall’esistenzialismo, all’ermeneutica, alla
filosofia post – analitica, essa testimonia soltanto del condiviso riconoscimento che una filosofia di
tipo “fondazionale” aristotelico (quella esemplarmente riscontrabile negli Analitici secondi),
teorizzata in parte anche da Cartesio (vedi soprattutto la lettera – prefazione all’edizione francese
dei suoi Principia philosophiae), alla ricerca di principi primi da cui dedurre e giustificare le verità
delle varie scienze, è forse definitivamente tramontata; mentre non ha affatto decretato che altre
forma di “fondazionalismo”, come quelle di derivazione kantiana (anche se liberate dall’idea
kantiana del sintetico a priori e di principi necessariamente veri) e neopositivista, concentrate sui
fondamenti teorici delle nostre attuali conoscenze, abbiano esaurito la loro funzione di
sistemazione e di analisi filosofiche della conoscenza.
116
117