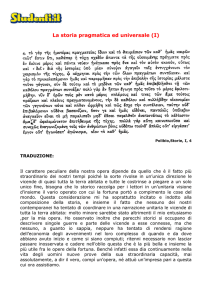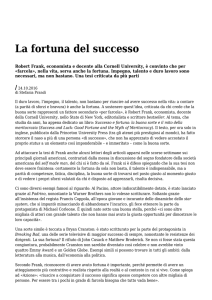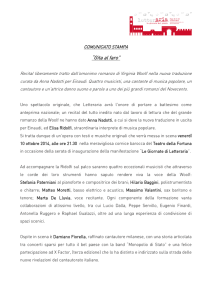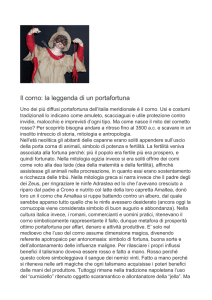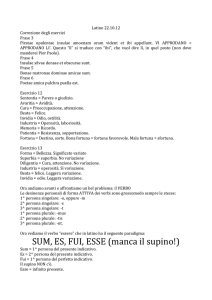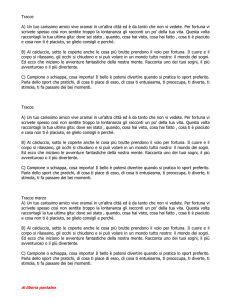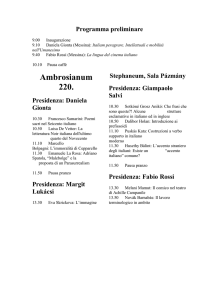5.
Il tema della fortuna e della virtù a Roma
Non è certo che la visione alternativa, molto sentita nell’epoca classica specialmente
sotto l’influenza dell’ellenismo, di un uomo in preda ai capricci di un destino più o
meno cieco, sia stata percepita come tale nella Roma arcaica. Infatti Roma conobbe
assai per tempo la Fortuna, onorata sotto diversi nomi, secondo le funzioni, le azioni e i
momenti di intervento attraverso i quali si manifesta nella vita della città: fortuna virilis,
muliebris, virgo, privata, publica, equestris ecc. Questa Fortuna in epoca arcaica ha una
fisionomia estremamente ambigua – come lo è sempre il pensiero mitico –, ora
maschile, ora femminile, talvolta dotata di bisessualità, talvolta vergine e donna, o
doppia, come le «Vere Sorelle» di Anzio, una delle quali porta il casco e l’altra il
diadema. A volte la Fortuna sembra avere forme di azione così concrete che ci si può
domandare se si tratti realmente di una divinità. La più ambigua di queste raffigurazioni
è forse la Fortuna latina onorata a Preneste prima che, durante la seconda guerra punica,
il suo culto venga ufficialmente introdotto a Roma. Essa porta il nome di Fortuna
Primigenia e, nelle numerose dediche nel suo tempio, si trova associata a Giove
bambino, puer, lattante. Ora, stando ad altri documenti – in particolare a un’iscrizione
del III secolo a.C. –, la Fortuna di Preneste appare figlia di Giove: «Io, Orsevia, sposa di
Numerius, a seguito di un parto felice ho fatto questo dono a Fortuna Primigenia, figlia
di Giove». Chi è dunque questa Fortuna, figlia e insieme nutrice di Giove, il cui culto
pare essere stato a Preneste in rapporto con la maternità e aver assunto aspetti oracolari?
È merito di G. Dumézil averci dato, mediante un’analisi comparativa, la soluzione
dell’enigma1. La primordialità implicita nell’appellativo Primigenia e la funzione
sovrana di Giove sono qui espresse con l’uso di termini di filiazione. Ora, si conosce
l’esistenza di una dea vedica, Aditi, madre di otto dei primordiali, Aditya. Essa è dunque
la madre per eccellenza, ma è anche la figlia di uno di questi dei.
La sua caratteristica principale è l’indeterminazione: Aditi è ciò che non è stabile: essa è il
1
cielo, l’atmosfera, la madre, il padre, i figli, essa è tutti gli dei, ciò che è nato e ciò che
deve nascere (Rg. Veda, X, 72, 4). La formula enigmatica di Preneste può dunque
interpretarsi così: ciò che nell’ordine cronologico è primo, non lo è nell’ordine della
sovranità, e viceversa. Gli dei primordiali non sono gli dei sovrani. Ciò che resta, nel culto
di Preneste, di questa eredità mitica indiana, si riassume in due funzioni: la protezione
materna e una funzione oracolare che diviene predominante. Una tale articolazione tra
una dea primordiale e una personalità oracolare non ha nulla di sorprendente. Nel mondo
greco infatti, funzionarono sino all’epoca classica alcuni oracoli di Gaia, la Terra Madre.
Ma in ambito romano ci mancano punti di riferimento per meglio comprendere come
questa funzione oracolare si sia innestata nella personalità di Fortuna. Solamente la
Fortuna d’Anzio, raffigurata dalle due sorelle maestre di verità, può offrire un valido
termine di confronto; ma sulla sua duplice personalità siamo male informati. In ogni caso,
ci colpisce il fatto che ciò che interessa i Romani, nel culto di queste Fortunate arcaiche,
non è assolutamente la loro condizione mitica, bensì la loro capacità di rendere delle
sortes, degli oracoli, che, nella misura in cui tali culti sono estranei al territorio di Roma,
passeranno sempre per grossolani e popolari.
In realtà, il concetto di Fortuna è sempre stato inteso dai Romani in funzione di
interventi molto localizzati nel tempo e nello spazio. Si parlerà della «fortuna» di un
combattimento e di quella di un generale. Vale a dire che il concetto astratto di Fortuna
sarà sempre specificato al livello della sua manifestazione: in ciò si riconosce
l’intelligenza pragmatica e prudente dell’uomo romano, che vive prima di tutto nel
presente dell’azione. La Fortuna di un giorno non è quindi un dato immutabile, fissato a
priori. Non si tratta di un destino determinante, che costringe l’uomo ad agire in un solo
modo. È caratteristico della mentalità romana il fatto che questa ambiguità di Fortuna,
quale l’aveva trasmesso la mitologia vedica, non diviene positiva o negativa, favorevole
o contraria, se non quando è trasformata dall’azione dell’uomo.
Così, in occasione della disfatta inflitta dai Galli ai Romani sull’Allia – e il cui cocente
1
. G. Dumézil, Déesses latines et mythes védiques, coll. Latomus, 25, 1956.
2
ricordo era commemorato da un dies religiosus – la Fortuna aveva accecato gli uomini
in seguito a errori commessi dai consoli: violazione dello ius belli, errori di strategia,
battaglia ingaggiata senza che fossero stati presi gli auspici e compiuti i sacrifici
preliminari2. Il corollario è evidente: per l’uomo l’obiettivo principale è dunque quello
di conoscere questa Fortuna, grazie a un empirismo creatore che respinge l’idea di un
fatum, di un destino universale al quale sarebbero soggette le sorti dell’uomo.
Ritroveremo quest’arte di vivere nelle figure di capi carismatici, sia che si tratti di
Servio Tullio, di Camillo, di Silla o di Pompeo. È del resto sorprendente constatare che
Plutarco riconosca in un trattato dedicato alla Fortuna dei Romani che la Fortuna
romana è una divinità la cui funzione essenziale è quella di promuovere le qualità
personali dell’individuo. Essa interviene per salvare Roma suscitando le iniziative di
uomini dotati di capacità particolari, in una congiuntura ben precisa. Fortuna ci appare
dunque un concetto teologico sfaccettato, non certo a causa di una sorta di incapacità
religiosa dei Romani, ma conseguentemente alla loro inclinazione a vedere nella forza
divina prima di tutto i suoi momenti precisi di intervento. Cosa dobbiamo pensare
dell’ipotesi secondo cui la Fortuna romana sarebbe l’erede di una Fortuna etrusca?
L’epopea romana attribuisce la fondazione del culto di Fortuna a Roma a Servio Tullio, re
che la critica moderna identifica con un condottiero chiamato Mastarna, che si era messo
al servizio dei fratelli Vibenna a Vulci, prima di passare al servizio di Tarquinio. Ora, gli
Etruschi erano maestri nell’arte della divinazione. Ci possiamo chiedere se non sia da
ravvisarne qui un’eredità specifica, tanto più che è ben nota l’importanza dei legami
commerciali e culturali tra Roma e l’Etruria. Ma si tratta solo di supposizioni, tanto più
che la religione etrusca pare essere stata dominata, molto più della religione romana, dalla
nozione di un fatum pressoché sovrano. Resta il fatto che i Romani non hanno molto
creduto a un destino a lungo termine e alla sua forza vincolante e hanno preferito vedere
in Fortuna una divinità il cui intervento occasionale poteva essere vantaggioso quando gli
uomini che decidevano di agire avevano una virtus sufficiente a influenzare il destino in
loro favore.
2
(M. Meslin, L'uomo romano, Mondadori, Milano, 1981)
. Cfr. Tito Livio, V, 37-38.
3