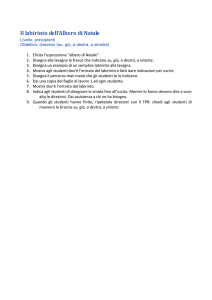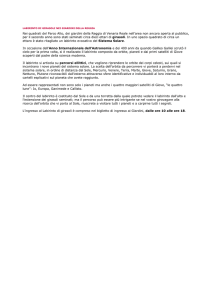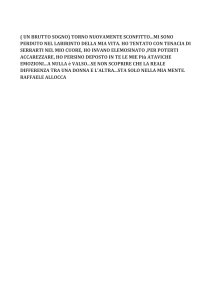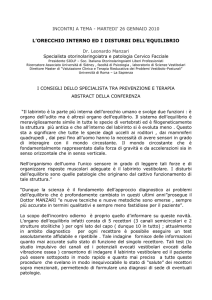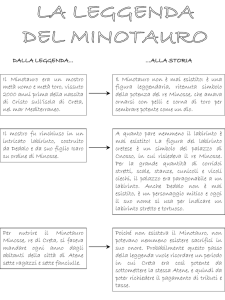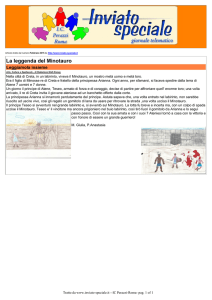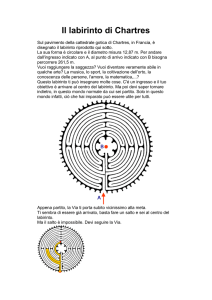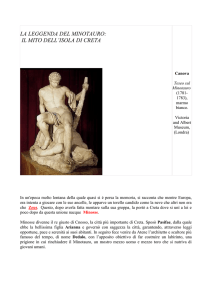Un filo di Arianna
di Luigi Lombardi Satriani
Irretiti nel labirinto delle nostre città, non siamo illuminati, come lo fu Teseo, dall’amore di Arianna e il
nostro vagare si svolge prevalentemente nell’oscurità. Costruttori noi stessi, come Dedalo, del
labirinto, quando restiamo rinchiusi con i nostri figli in esso, ci è estremamente difficile, a differenza
del costruttore ateniese, fabbricare delle ali di penne e cera per sottrarci con il volo alla chiusa datità
labirintica. Ove questo ci riuscisse, anche noi, a somiglianza di Icaro, rischieremmo di avvicinarci
troppo al sole e pagheremmo l’imprudenza, la temerarietà precipitando in mare.
L’itinerario di Teseo ha intenso valore emblematico. «Teseo entra nel labirinto che, nei suoi meandri,
secondo Colli, è emblema del logos. Ma anche il filo, che gli permette di procedere senza perdersi, il
simbolo dello stesso logos, che presenta dunque, nel suo affacciarsi nel mito, un duplice aspetto,
un’ambigua esistenza: il luogo del pericolo, dell’ombra e degli anfratti e, al contempo, è lo strumento
della vittoria della luce sulla tortuosa oscurità e sui mostri che essa contiene e nasconde. Ma il simbolo
non è ancora compiuto: si completa e si fa profetico del potere del logos nell’immagine della spada
implacabile che Teseo stringe nel pugno, che perfeziona e rende micidiale, col suo filo tagliente, il filo
di Arianna. Con la spada Teseo ucciderà il Minotauro. Con la spada egli dovrebbe dunque rendere
inutile l’esistenza stessa del labirinto. La spada taglia e apre il varco che dovrebbe annientarlo. Ma è
veramente così? [...] Ogni volta che esso [il mito] viene raccontato, ripreso in tutte le sue possibili
varianti, la narrazione fa rinascere il tortuoso labirinto, le sue buie volute e i suoi ciechi meandri, e, al
centro ancora una volta il terribile e disperato muggito del Minotauro.
L’oscurità non è mai vinta per sempre. Sempre si riaffaccia davanti ai nostri occhi. La luce, che
credevamo conquistata, scrive sull’orizzonte del nostro sguardo le sue cifre di ombra. […] La
conoscenza stessa questo stesso superamento che ci fa pervenire allo “stato d’animo contrario” alla
meraviglia. Il geometra non si meraviglia più di fronte all’immagine dei meandri del labirinto, “ma se
la diagonale è commensurabile al lato” (Met., 1, 2, 983 A): se, cioè, l’esito della sua ricerca non
corrisponde ai postulati razionali della stessa»1 .
Alcuni monumenti romani sottolineano il nesso labirinto e tomba. Lo ha ben visto Kàroly Kerényi, per
il quale «al primo posto andrà collocato Castel Sant’Angelo, il Mausoleum Hadriani. […] in questa
possente opera edilizia l’ingresso conduce, attraverso un percorso a spirale che si avvolge verso
sinistra, fino alla camera mortuaria; si tratta di un vero e proprio labirinto in salita, costituito dalle
doppie mura del tamburo, il quale s’innalza al di sopra di una base quadrata, e circoscrive a sua volta
una torre quadrata: questa congiunzione del cerchio e del quadrato trasforma l’immenso mausoleo,
proprio come il mondo intero, in un’espressione della totalità. Quanto agli altri due monumenti, uno era
già noto nella letteratura scientifica, ma acquista un valore decisivo solo alla luce in cui tento qui di
interpretarlo. Si tratta di un monumento di marmo che si fregia di un’ iscrizone greca.
Il luogo in cui il monumento si trovava in origine viene chiamato con particolare insistenza labyrintbos.
“Per i vivi - dice l’iscrizione - questa è una strada ingannevole. Voi amici, dovete sempre gioire del
labirinto”. […] Pare davvero che i Marmorarii siano perfettamente coscienti del fatto che il labirinto
non è una “strada ingannevole” bensì un passaggio sicuro, così per i morti come per loro stessi: e
infatti, proprio come i morti, anch’essi, nella loro comunità cultuale, vengono condotti a salvamento da
Serapide.
L’ultimo monumento è un mosaico che produce un labirinto; è stato scavato e riportato alla luce nei
pressi della piramide di Cestio, dove probabilmente dovevano trovarsi anche dei resti di monumenti
sepolcrali. Le sue dimensioni dovevano essere cospicue; la parte conservata (forse un quarto
dell’intera opera) è stata restaurata e ricondotta al livello attuale. Presenta una combinazione del tardo
schema dell’intrico di strade a meandri (quello che oggi è conosciuto semplicemente come “labirinto”
[...]. Sul luogo del suo ritrovamento, nella parte più vecchia del cimitero protestante, nella stessa zona
in cui si trova anche la tomba di Keats, sullo sfondo della piramide, spicca con la fissità di un gesto
arrestato sul nascere: un gesto che indica la strada che passa - come è noto - accanto alla tomba di
Cestio, e che a quella stessa strada accenna e rinvia con le parole: “Giù, giù, fino all’Orco, con passo
lento!”2.
Nelle culture classiche il labirinto, dunque, non era strada ingannevole per i morti e, dal momento che
si era consapevoli di questo, non lo era neanche per i vivi, che ne intendevano il linguaggio, denso di
valenze sacrali. Non meraviglia, dunque, che quando tali significati si attenuano, possiamo ritrovare il
labirinto «come decorazione pavimentale o come terreno di gioco per bambini (in pavimentis
puerorumque ludicri campestribus)»3, sino a che diventa prevalente il motivo ludico, dai giardini a
labirinto ai labirinti tascabili, giocattoli con una piccola biglia che deve essere fatta giungere al centro.
A noi, lontani non solo temporalmente da siffatta temperie, il labirinto può trasmettere prevalentemente
la sensazione di un’estrema complessità e una notevole angoscia per il timore di non riuscire a
padroneggiarlo.
La città contemporanea si pone come gigantesco labirinto, nel quale nessuna fonte di luce o filo
amoroso ci garantisce dal pericolo di un definitivo smarrimento. Essa si costituisce come luogo del
massimo investimento simbolico e contemporaneamente e contraddittoriamente ma é contraddizione
della realtà - come luogo della massima indecisione e dello smarrimento.
Anche la cultura folklorica tradizionale conosceva punti critici dello spazio; ad esempio, i crocicchi,
con la pluridirezionaltà da essi proposta, venivano percepiti come luogo di indecisione in cui la
presenza poteva smarrirsi. L’inquietudine territoriale era annullata però, in tale cultura, da elaborate
strategie atte a superare il pericolo di smarrimento e a rafforzare, contro tale pericolo, la presenza
dell’uomo, del soggetto, la sua costituiva capacità vincere la datità trascendendola nel valore, direi con
esplicita terminologia demartiniana. Mariano Meligrana e io ci siamo soffermati su tali strategie con
particolare riferimento all’ideologia della morte nella società contadina del Sud, individuando l’insieme
di localizzazioni materiali e simboliche che «costituisce il linguaggio spaziale della morte, struttura un
codice di significati che si articola in una “natura” umanizzata, in un paese reale e nella sua proiezione
simbolica». In questa prospettiva, abbiamo notato come «contiguo allo spazio realistico, già esso
solcato dall’ideologia della morte, si ponga quindi nell’orizzonte culturale popolare un modello mitico,
abitato dai morti, con i suoi percorsi, i suoi passaggi, i suoi spazi articolati secondo una topografia
metafisica. La pluridimensionalità spaziale comporta, inoltre, una pluridimensionalità temporale, per
cui non solo abbiamo due tempi reali diversi per le iniziative dei morti e dei vivi, ma anche una
interazione fra tempo reale e tempo mitico»4.
La cultura urbanocentrica contemporanea non ha elaborato adeguate strategie per fronteggiare il
pericolo dello smarrimento, dell’alienazione, per cui siamo singolarmente inermi dinanzi a esso. La
realtà contemporanea, inoltre, è caratterizzata da un complesso intersecarsi di etnie, tratti culturali,
modelli di diversa origine, sistemi normativi che investono l’uomo contemporaneo, situandolo in una
condizione per la quale non sono state predisposte tecniche efficaci di comprensione e
padroneggiamento.
«Nella vita sociale contemporanea sembra quasi di poter notare un doppio movimento: la chiusura, il
ripiegamento verso il piccolo gruppo, verso il sé stesso accarezzato e blandito dallo stesso soggetto sino
all’esasperazione narcisistica ed egocentrica, con una comunicazione che tende alla comunicazione
esoterica: nello stesso tempo - contemporaneamente più che alternativamente - alla chiusura, al
ripiegamento, si affianca l’ansia di universalizzare, di vivere dinamicamente il proprio tempo e i propri
spazi, di scambiarsi esperienze, idee, linguaggi, beni e valori. La città della nostra epoca […] appare a
un tempo una metafora di questa coesistenza e un luogo privilegiato di analisi: essa dispiega da un lato
la settorialità della chiusura, con i suoi molteplici villaggi, connotati ognuno da specificità e disparità
con le sue organizzazioni a modello tribale che si ergono a difendere da ogni intrusione quartieri e
strade e spazi; dall’altro lato tuttavia la città è il crogiuolo di informazioni, parole, immagini, idee, che
si spandono senza rispettare territori e confini. Così la città contemporanea è luogo della solitudine
gregaria, ma è anche il luogo di elaborazione di un nuovo ordine simbolico che privilegia
l’intensificarsi dei rapporti, che rende fluidi ruoli e status, che mostra ad ognuno di noi la fragilità
dell’io e l’illusione che l’identità sia un valore permanente di ogni società»5.
Il nostro rapporto con la città è profondamente mutato, in misura non dissimile dalle trasformazioni che
ha subito il rapporto con il nostro stesso corpo, inerenza soggettiva e oggettiva, realtà che si iscrive sul
piano dell’ essere e che viene percepita anche sul piano dell’ avere. Anche se con riferimento riduttivo
a una città nettamente circoscritta e percorribile «completamente a piedi», è stato notato come si possa
«affermare senza dubbio che la città è la parte estroflessa, il “fuori” del corpo: è la solidificazione,
nello spazio vissuto, delle relazioni sociali di largo raggio, relazioni che sono concretamente praticate
in modo corporeo, perché appunto la città si percorre (dalla casa alla bottega, dal mercato alla chiesa al
palazzo civico) completamente a piedi in tempi di ore e giorni, senza la necessità di aggiunta di protesi
meccaniche per aumentare le possibilità di spostamenti del corpo. Non solo, ma la città è usata
interamente, nel corso di una vita, dalla casa in cui si nasce alla scuola in cui si apprende al mercato in
cui si compra alla chiesa in cui si celebra al cimitero in cui si viene seppelliti. Ma, approfondendo
l’analisi, ci rendiamo conto che il rapporto della città con il corpo può essere descritto anche in termini
non più materiali, cioè anche in termini più segretamente simbolici. Cosicché, in seconda istanza,
possiamo descrivere la città anche come un doppio e un sosia del corpo: simile cioè ad esso, e non
solamente come struttura, ma anche, più o meno velatamente, come immagine. Infatti la città è una
figura che si staglia rispetto a uno sfondo, perché si riconosce in un ambiente più generale che
chiamiamo paesaggio. Ha chiaramente, un confine, le mura, che funziona verso l’esterno con un limite
di massa, verso l’interno come limite di spazio, ed assolve nel definire la nostra individualità: in
qualche modo le mura delle città sono l’equivalente di ciò che la nostra pelle è per il nostro corpo,
qualcosa che appartiene alla sfera prossemica più intima, quella della nozione del sé, qualcosa che
contemporaneamente ci dà il senso della separazione di noi stessi dal mondo e il senso della possibilità
di osmosi e di comunicazione tra noi stessi e il mondo. Vorrei sottolineare che la pelle - potenziata
dagli strati “culturali” fabbricati come abbigliamento - è anche organo di difesa, e di rappresentazione
di sé nel mondo. In quanto oggetto confinato, la città è un corpo organizzato: non a caso
nell’urbanistica si usano continuamente tutta una serie di metafore biologiche: si parla di cellule, di
tessuti, di organi, di sistemi di organi, di sistemi di sistemi. Anche questo sta a testimoniare che noi
viviamo la città come un corpo e come simile al nostro corpo. La città si può penetrare profondamente:
se ne può praticare il “cuore”. E da essa si può uscire facilmente: si possono varcare le sue porte. C’è
quindi, tra il corpo della città e il corpo dei suoi abitanti, un rapporto duale, di reciproca appartenenza,
di reciproca indipendenza»6. La città contemporanea è difficilmente delimitabile da confini, frontiere,
sì che risulti chiaramente individuato lo spazio dell’appaesamento, continuamente realizzantesi
attraverso il conferimento di senso. Oggi non possiamo non essere consapevoli delle molteplici
frontiere invisibili della città. «La grande metropoli odierna è attraversata da una miriade di linee di
confine, riconoscibili appena, per segni incerti e mutevoli, solo dall’occhio esercitato del nuovo
viaggiatore metropolitano. Questi confini invisibili tracciano una geografia strana e talvolta pericolosa,
tagliano in modo apparentemente insensato strade, quartieri, crocicchi. Dividono anche gli abitatori del
giorno dagli abitatori della notte. Delimitano territori di caccia e di rapina e luoghi di tregua e di
quiete, in cui cacciatori e prede alla fine si posano inquieti, nell’attesa di una nuova fuga e di un nuovo
inseguimento [... ]. Ma nessuno può ritenersi a lungo garantito da esse [frontiere]. Nessuno le conosce
una volta per tutte. La loro caratteristica, ciò che le rende appunto invisibili, il loro continuo mutare, la
metamorfosi del disegno che esse via via tracciano, continuamente diverso, quasi ogni notte
modificato»7. È difficile, pertanto, dissentire da Massimo Ilardi, che sottolinea come sia «una
presunzione degli urbanisti e un’illusione dei filosofi pensare di presentarsi alle porte della città e
discutere di essa. La città non ha più porte e la metropoli non si sa dove comincia e dove finisce.
Sappiamo solo quello che l’esperienza di tutti i giorni ci ha dimostrato: e cioè che la metropoli
rappresenta il momento determinante dell’esistenza moderna; e che, dietro questo mondo in perenne
movimento e mutamento, non si nasconde alcun ordine naturale, alcun paesaggio fatto di calmi
ambienti, di ritmi costanti e regolari, di pace, di tranquillità; e che, infine, davanti non esiste alcuna
“città futura” a partire dalla quale si potrà giudicare la città presente. [...] Il passato, il futuro: sono
tempi che l’individuo metropolitano non coniuga più. Egli appartiene alla superficie del mondo ed è
plasmato dalla mobilità, dai conflitti, dal consumo. Un individuo che rifiuta di autointerpretarsi sulla
base di altri ambiti semantici e assiologici (Dio, la Politica, il Lavoro), e si pone invece come forza di
riappropriazione del proprio destino.
Sono dunque la mobilità, il conflitto, il consumo che ci consentono di definire, seppure
approssimativamente, le nuove figure sociali. Ma non è detto che queste figure durino per il fatto che
hanno lottato. La metropoli allora non ha solo lo spazio scenico di queste lotte, anche il “luogo” di
sparizione dei soggetti, un “luogo” assolutamente fantasmatico di eventi che si accendono e si
spengono come cerini»8.
Anche il paesaggio sonoro della città moderna e postmoderna appare profondamente modificato
rispetto alle scansioni e ai linguaggi della vita concretamente dispiegantesi nelle fasi storiche
precedenti. Luigi Russolo, in epoca futurista, notava: «attraversiamo una grande capitale moderna, con
le orecchie più attente che gli occhi, e godremo nel distinguere i risucchi d’acqua d’aria o di gas nei
tubi metallici, il borbottio dei motori che fiatano e pulsano con una indistinguibile animalità, il
palpitare delle valvole, l’andirivieni degli stantuffi, gli stridori delle seghe metalliche, i balzi del tram
sulle rotaie, lo schioccar delle fruste, il garrire delle tende delle bandiere. Ci divertiremo ad orchestrare
idealmente insieme il fragore delle saracinesche dei negozi, le porte sbatacchianti, il brusio e lo
scalpiccio delle folle, i diversi frastuoni delle stazioni, delle ferriere, delle filande, delle tipografie, delle
centrali elettriche e delle ferrovie sotterranee»9.
La città è stata oggetto di notazioni narrative e rappresentazioni filmiche, con tutta la loro carica di
suggestione, gli esempi potrebbero essere particolarmente numerosi; ci si limiterà ad alcuni di essi,
scelti essenzialmente per il loro valore emblematico.
Per Victor Hugo, «nella città si poteva scomparire con facilità, ma con la stessa facilità si poteva cadere
in trappole imprevedibili. Essa comprendeva una molteplicità di miniere, di “uomini oscuri”, di spettri,
di larve. C’é la miniera religiosa, la miniera filosofica, la politica, l’economica e la rivoluzionaria [ ...].
Chi scava con le idee, chi con le cifre, chi con la collera, e si richiamano e si rispondono da una
catacomba all’altra […]. Voltaire, sotto Voltaire Condorcet, sotto Condorcet c’é Robespierre, sotto
Robespierre Marat, sotto Marat Babeuf; e l’elenco continua […]. Più giù in modo confuso, sul limite
che divide l’indistinto dall’invisibile, si scorgono altri uomini oscuri che forse non esistono ancora.
Quelli di ieri sono spettri, quelli di domani larve […]. Saint-Simon, Owen, Fourier ci sono anch’essi,
ma in escavazioni laterali […]»10. Val la pena ricordare, a questo proposito, le osservazioni di Gilbert
Durand: «Bachelard cita altrove un passaggio del W. Shakespeare di V Hugo nel quale il ventre in
generale è considerato come “l’otre dei vizi”. La psicanalisi del poeta viene a confermare il ruolo
negativo che ricopre in Hugo la cavità, ventre o fogna. È la famosa fogna del romanzo I Miserabili,
ventre della città dove si cristallizzano le immagini del disgusto e dello spaventevole “polipo tenebroso
tortuoso... da dove si sprigionano le pesti... fauci… del drago che soffia l’inferno sugli uomini”. La
Corte dei Miracoli, in Notre-Dame de Paris, la fogna della capitale, così nei Lavoratori del mare la
corte infetta e brulicante della Jacressade. In tutta l’opera di Hugo il bassofondo morale richiama il
simbolismo della fogna, dell’immondizia e le immagini digestive e anali. Il labirinto, seguendo
l’isomorfismo teriomorfo delle immagini negative, ha tendenza ad animarsi, diventando Drago o
“scolopendra di quindici piedi di lunghezza”. L’ intestino, fogna vivente, unisce l’immagine del Drago
mitico e divora in un capitolo dei Miserabili che si intitola l’intestino del Leviatano, luogo del peccato,
otre di vizi, “apparato digestivo di Babilonia”. L’uomo che ride riprende a sua volta l’isomorfismo
anale dell’abisso, la fogna vi è descritta come un “budello tortuoso”, e il romanziere, ben conscio dei
temi immaginari che lo trascinano, nota: “tutti i visceri sono tortuosi”. Infine, se passiamo dal romanzo
alla poesia, vediamo il fiume infernale, simbolo alla seconda potenza dell’acqua nera e nefasta,
assimilata alla “fogna”, Stige dove piove l’eterna immondizia11.
In Dark Laugtber è detto: «la mia città è un mormorio di voci che escono da un abisso»12.
Italo Calvino tra le sue «città invisibili» ci presenta la città di Tamara. «Ci si addentra per vie fitte
d’insegne sporgono dai muri. L’occhio non vede cose ma figure cose che significano altre cose: la
tenaglia indica la casa del cavadenti, il boccale la taverna, le alabarde il corpo guardia, la stadera
l’erbivendola. Statue e scudi rappresentano leoni delfini torri stelle: segno che qualcosa chissà cosa ha per segno un leone o delfino o torre o stella. Altri segnali avvertono di ciò che in un luogo è proibito
- entrare nel vicolo con i carretti, orinare dietro l’edicola, pescare con la canna dal ponte - e di ciò che è
lecito - abbeverare le zebre, giocare a bocce, bruciare i cadaveri parenti. Dalla porta dei templi si
vedono le statue de dei, raffigurati ognuno coi suoi attributi: la cornucopia, clessidra, la medusa, per cui
il fedele può riconoscere e volgere loro preghiere giuste. Se un edificio non porta nessuna insegna o
figura, la sua stessa forma e il posto che occupa nell’ordine della città bastano a indicarne la funzione:
la reggia, la prigione, la zecca, la scuola pitagorica, il bordello. Anche le mercanzie che i venditori
mettono mostra sui banchi valgono non per se stesse ma come segni d’altre cose: la benda ricamata per
la fronte vuol dire eleganza, la portantina dorata potere, i volumi di Averroè sapienza, il monile per la
caviglia voluttà. Lo sguardo percorre le vie come pagine scritte: la città dice tutto quello che devi
pensare, ti fa ripetere il suo discorso, e mentre credi di visitare Tamara non fai che registrare i nomi con
cui essa definisce se stessa e tutte le sue parti.
Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga o nasconda, l’uomo
esce da Tamara senza averlo saputo. Fuori s’estende la terra vuota fino all’orizzonte s’apre il cielo
dove corrono le nuvole. Nella forma che il caso e il vento dànno alle nuvole l’uomo è già intento a
riconoscere figure: un veliero, una mano, un elefante...»l3.
Ancora Calvino, «se nascosta in qualche rocca o ruga di questo slabbrato circondario esista una
Pantasilea riconoscibile e ricordabile da chi c’è stato, oppure se Pantasilea è solo periferia di se stessa
e ha il suo centro in ogni luogo, hai rinunciato a capirlo. La domanda che adesso comincia a rodere è
nella tua testa è più angosciosa: fuori da Pantasilea esiste un fuori? O per quanto ti allontani dalla città
non fai che ... da un limbo all’altro e non arrivi a uscire?»14.
Infine, « dal mio discorso avrei tratto la conclusione che la vera Berenice una successione nel tempo di
città diverse, alternativamente giuste e ingiuste. Ma la cosa di cui volevo avvertirvi è un’altra: che tutte
le Berenici future sono già presenti in questo istante, avvolte l’una dentro l’altra, strette pigiate
indistinguibili»15.
Anche la cinematografia ha rivolto il proprio sguardo alla città, rappresentandola secondo ottiche e
tagli ideologici estremamente differenziati. In numerosi film dei decenni precedenti «la città è un a
priori topografico - visivo, sul cui sfondo dobbiamo immaginare il successivo svolgersi degli eventi.
Molti film della classicità hollywoodiana cominciano così. Quelli di John Huston, ad esempio. O
alcuni di quelli di Howard Hawks. Ma anche quelli di molti cineasti europei si rifanno al medesimo
stereotipo: Sous les toits de Paris di René Clair inizia con una lunga carrellata sui tetti della città, fino a
raggiungere la strada dove sta cantando il protagonista.
In tutti questi casi, il percorso dello sguardo va dall’universale al particolare, dall’insieme a una delle
parti o dei dettagli che lo costituiscono. La città così presupposta, in genere, una città solida, ordinata,
massiccia, razionale. I brividi di irrazionalità che la attraversano la sfiorano appena. Il disordine non le
è consustanziale. Se c’è, è dovuto agli eventi o ai personaggi che la popolano, e i conflitti che vi si
svolgono sono indipendenti dalla sua morfologia. Da Scarface (Howard Hawks, 1932) a Giungla
d’asfalto (John Huston, 1950) la città é leggibile ed estranea. Esterna. Sfondo solido e imperturbato di
intrighi che si generano a prescindere da lei. La città del cinema contemporaneo, al contrario, una città
magmatica, fluida, informe, mutante. Non tale per effetto dei conflitti che la dilaniano. È la sua forma
(o assenza di forma) a produrre e generare conflitti, disorientamenti, derive. La città teatro di
macroconflitti diventa “macchina” per la produzione di conflitti diffusi e parcellizzati. Anche il modo
di approccio cambia. O forse la città stessa che cambia col mutare dell’approccio visivo che lo sguardo
del cinema realizza nei suoi confronti. La città del cinema contemporaneo non la si osserva più nel suo
insieme, la si penetra. La si conosce consumandola. Standovi dentro agendo nel suo tempo (e nei suoi
ritmi) più che nel suo spazio statico e definito una volta per tutte.
[…] È la città replicante di Blade Runner (Ridley Scott, 1982) oceano di luce pulviscolare che si
riflette nell’occhio, nebulosa multimediale e polifonica di messaggi, impulsi, codici che si incrociano e
si sovrappongono, la città del cinema contemporaneo non può essere contemplata né ipotizzata, ma
soltanto agita, percorsa, attraversata. La sua fruizione inevitabilmente dinamica. La sua struttura
polimorfa, dispersiva, puntiforme. […] La città […] sembra avviata a uno strano destino: quello di
ridursi a svolgere le funzioni che un tempo erano svolte da una sua parte. Fuga da New York tutta
Manhattan è ridotta a carcere. L’ implacabile: tutta la città è ridotta a stadio-circo in cui si svolgono i
giochi neogladiatori televisivi. Robocop: l’intera metropoli diventa un quartiere da demolire. Street
Trash: l’intera New York diventa l’immondezzaio discarica di rifiuti. Questo processo di transizione
metonimica, per cui una parte si identifica con il tutto, ovviamente sconvolge i nostri consueti codici di
fruizione e consumo cinematografico della città. Grande il disordine sotto il cielo: nessun punto di
vista dall’alto ci può dare un quadro chiaro, unitario, coeso. Perfino gli angeli wendersiani di Il Cielo
sopra Berlino (1987) scendono sulla terra e fruiscono l’urbano per frammenti, o per visioni parziali,
approssimative.
[...] In questo quadro, l’immagine della città diventa caotica, magmatica, confusa, non ci sono più
mappe che ne sappiano fissare la pianta una volta per tutte, fornendo utili indicazioni topografiche o
punti di riferimento.
In questa città di flussi e di movimenti le mappe non servono più. Servono piuttosto attraversarle in
fretta, consumarle, usarle. Ce l’ha insegnato, definitivamente, ancora una volta John Carpenter in quel
film “aurorale” che è 1997, Fuga da New York. Il personaggio che nel film si chiama Mente (Henry
Dean Stanton) e che evoca fin dal nome la “vecchia razionalità” salta per aria su un ponte minato di cui
credeva di possedere la mappa. Si salva invece l’eroe-serpente (Jena Plissken), che si muove nella città
spinto dall’ossessione del tempo più che da quella dello spazio, e che fa del suo sguardo bendato e
monoculare […] l’unica bussola di orientamento possibile»16.
La letteratura scientifica si è a lungo esercitata sulla città, sulle trasformazioni della sua realtà e delle
sue rappresentazioni.
R. Park ha notato: «Le città in generale e le città americane in particolare comprendono un
caleidoscopio di genti, di cultura e di modi di vita molto diversi, tra cui spesso c’è solo il contatto più
debole, la più grande indifferenza, la più larga tolleranza, occasionalmente l’aspra contesa, ma sempre
il più acuto contrasto»17.
Il rapporto tra rappresentazioni e pratiche della città esce senz’altro, come è stato sottolineato, dal
dominio delle carte mentali, per quanto costruite con la massima raffinatezza; se non altro queste carte
mentali della città assumono il loro senso attraverso modi di abitare, modelli culturali e non solo
attraverso atti visivi. La rappresentazione della città s’iscrive dunque in un’etnostoria, così come la
critica delle ideologie. Essa accorda ampio spazio ai comportamenti dei gruppi sociali, al modo in cui si
trasmettono o si acquisiscono le abitudini, gli atti le rappresentazioni; si preoccupa dell’accumularsi dei
gesti e dei riti, ancorati nell’inconscio; esse s’interessano alle giustificazioni sociali date da queste
pratiche, alla valorizzazione connessa ai luoghi, alla combinazione degli spazi e degli avvenimenti, a
tutto quanto nella città è “memoria”»18 .
Per quanto riguarda le discipline demo-etno-antropologiche, basti ricordare come nel loro ambito si sia
andato sviluppando uno specifico settore di studi l’antropologia urbana, che ha elaborato prospettive
critiche, tagli metodologici, ipotesi interpretativi di tale complessa problematica19.
Alberto Sobrero si sofferma su Images of City di Kelvin Lynch rilevando come, per questo autore, «la
pianta della città si disegna nella mente dei suoi abitanti per “percorsi”, “confini”, “nodi”, “quartieri”.
Ognuno mette in atto il riconoscimento della città, stende sulla città una sorta di “rete”. Si badi bene,
tuttavia, che non è solo una questione di interpretazione, i ‘percorsi’ sono realmente “i canali lungo i
quali l’osservatore si muove abitualmente, strade, vie pedonali, linee di trasporti pubblici” […]; i
margini sono “interruzioni lineari di continuità […] barriere più o meno penetrabili che dividono una
zona dall’altra.[…]”; i nodi sono “punti, luoghi strategici, nei quali un osservatore può entrare, fuochi
intensivi verso i quali e dai quali si muove […]”. Nell’imageability gli elementi fisici e la loro
interpretazione si intrecciano in modo tale che è difficile dire dove finiscano gli uni e dove cominciano
gli altri. È sulla fisicità della città, sulla forma reale delle sue piazze, dei suoi quartieri, dei suoi
sobborghi, dei suoi ghetti, che si distende l’interpretazione dei suoi abitanti. Non c’è autore che quanto
Lynch mal sopporti la fuga delle interpretazioni, la mitica del labirinto e del piacere del perdersi. C’é
ovviamente qualche pregio nell’illusorietà, nel labirinto, nella sorpresa di un ambiente. Molti di noi
amano la Casa degli Specchi, e le strade tortuose di Boston posseggono un certo fascino. Questo è
vero, ma solo a due condizioni. La sorpresa deve capitare in seno a uno schema generale: lo
sconcertamento deve essere limitato a piccole parti di un insieme leggibile. E in secondo luogo, il
labirinto o il mistero devono possedere in se stessi qualche forma che può venir esplorata e un po’ alla
volta appresa. Il caos completo senza traccia alcuna di connessione non è mai piacevole»20.
Massimo Cacciari ha affermato: «La nostra vita urbana non può che svolgersi oltre ogni limite
tradizionale, ogni confine dell’urbs. Non sarà mai più geometricamente circoscrivibile. Non sarà mai
più “terranea”. La sua dimensione mentale»21.
Alberto Sobrero opportunamente aggiunge: «apparentemente solo mentale, la dimensione della
differenza riesce a celarsi, a simularsi, fino al punto di negare in ambito urbano la stessa esistenza
dell’alterità. Ancora possiamo riconoscere le radici della differenza quando abbiamo a che fare con il
diverso per provenienza, per razza - benché il rimescolamento sia oramai così esteso e di dimensioni
tanto crescenti, che, anche in questo caso, la discriminante sarà sempre meno fisica e sempre più
mentale e ideologica. E certo - passando al secondo livello - più mentale che terranea la stessa ragione
che spinge ad aggregarsi: non perché l’essere giovani, l’essere barboni, o semplicemente “vicini”, non
sia prima di tutto una condizione fisica, ma perché è evidente che passare da quella ragione fisica a
“quella mentalità” è in primo luogo una scelta e un atto di adesione di valori.
Difficile, comunque, riconoscere una qualche terraneità nei fenomeni della modernità dispiegata che
abbiamo collocato nell’ultima delle nostre rubriche. In base a quali riferimenti di classe, o di ceto, in
base a quali logiche dell’insediamento urbano o di generazione, è possibile ricondurre a una qualche
fisica della società il consumo dei mass media, l’universalità del pensiero, la moda, e i loro rispettivi
fantasmi, le leggende urbane, il razzismo, il narcisismo? Ogni sensazione di naturalità del
comportamento è persa. Sembra di trovarsi, per un verso, di fronte a puri sistemi di regole, di fronte a
sistemi di convenzioni sociali che non hanno altra ragione di esistere che non sia l’accettazione
generale, e, per altro verso, di fronte alla tentazione di barare, al timore, al rischio e alla paura che
qualcuno venga meno alle regole del gioco.
A quest’ultimo livello la differenza è più difficile da isolare e controllare: bisogna conoscere le regole
e sapersi mascherare, bisogna sapere entrare e uscire dai ruoli, simulare, cambiare mille vesti, vestire
mille volti: “Il camaleontismo diventa un tratto saliente del vivere contemporaneo. Si fa avanti il
paesaggio di un corpo che assorbe come una porosa spugna l’eterogeneità dell’esistente […]...»22. In
una prospettiva così delineata, lo studioso ritiene di potere affermare: «La città come totalità, come
civitas, come urbs è persa irrimediabilmente e con essa anche la città come etbos, come unità culturale.
Ciò non toglie che almeno in tre direzioni si delinei l’oggetto di un’antropologia possibile:
a)
in direzione delle moltiplicate etnicità e dei nuovi e non conosciuti esiti dei futuri sincretismi
culturali;
b)
lungo le nuove reti di rapporti, di comportamento e di valori, nei nuovi vicinati, nelle nuove
solidarietà, in quella periferia sempre più estesa che nella vita di ognuno si oppone alla centralità
fagocitante della metropoli;
c)
in direzione della stessa mancata realizzazione della cultura della modernità, delle sue paure, dei
contrasti che genera, delle sue ansie. [...] La città sollecita le fughe interpretative. Dal crollo delle
teorie meccanicistiche e della cultura come rispecchiamento, dalla rinnovata consapevolezza che il
piano dell’interpretazione è un piano obbligato attraverso cui passare per comprendere la novità e
l’originalità dell’organizzazione del mondo contemporaneo, si è scivolati, nella scienza come nel senso
comune, verso la convinzione che la regola non ci sia, verso la convinzione che tutto sia possibile, che i
beni siano infiniti, che si tratti solo di una questione di scelte, che volendo si possa tornare indietro, che
la stessa dimensione del tempo, dello spazio della vita sia solo una questione mentale.[...] Sentiamo il
fascino del labirinto, se per esso si intende la sollecitazione al viaggio, all’esperienza, al rischio
intellettuale, ma nella convinzione di Kevin Lynch, nella convinzione che il non conosciuto deve
possedere in se stesso qualche forma che può venir esplorata e un po’ alla volta appresa e nella
sensazione che il caos completo senza traccia alcuna di connessione non è mai piacevole»23 .
Non è un caso che luoghi, realistici o simbolici, culturalmente plasmati per l’incontro e il dialogo,
spesso, nella temperie attuale, si trasformino in incontri fittizi e in monologhi truccati. Marc Augé ci
ha invitato da tanto a dedicare la nostra attenzione anche ai nonluoghi, sottolineando che nella realtà
concreta del mondo di oggi, i luoghi e gli spazi, «i luoghi e i nonluoghi si incastrano, si compenetrano
reciprocamente. […] Luoghi e non luoghi si oppongono (o si evocano) come i termini e le nozioni che
permettono di descriverli»24. Pertanto […] il labirinto si dilata, borgesianamente, sino a coincidere con
l’universo, spazio nel quale sperimentiamo il nostro “essere gettati” senza un saldo ancoraggio di
finalità e senso. Ma comunque il nostro labirinto, nel quale è irretita, e non può non esserlo, la nostra
vita. Il re degli arabi dice al re di Babilonia, dopo averlo portato nel deserto: «“In Babilonia mi volesti
perdere in un labirinto di bronzo con molte scale, porte e muri; ora l’Onnipotente ha voluto ch’io ti
mostrassi il mio dove non ci sono scale da salire, né pone da forzare, né faticosi corridoi da percorrere,
né muri che ti vietano il passo.” Poi gli sciolse i legami e lo abbandonò in mezzo al deserto dove quegli
morì di fame e di sete»25.
In questa prospettiva, anche il labirinto può dispiegarsi, ambivalentemente, come spazio dell’incubo e
della rassicurazione. «Il labirinto è spesso tema di incubo, ma la casa è labirinto rassicurante, amato
malgrado la qualità di leggera paura che può sustissistere nel suo mistero»26.
Non sorprende allora l’invocazione di Pasolini
Stupenda e misera città,
che m’hai insegnato ciò che allegri e feroci
gli uomini imparano bambini…
La nostra realtà puntuale non è dissimle da quella descritta dai versi brechtiani:
Le nostre città hanno sotto le fogne
dentro nulla e di sopra lo smog. Nulla abbiamo goduto e
ancora le abitiamo:
esse lentamente, noi rapidamente deperiamo.
eppure non sembra illegittimo, […] ritenere possibile anche per noi, nonostante questo nostro tempo e
questa nostra condizione, i versi montaliani:
nel futuro, che s’apre le mattine
sono ancorato come barche in rada.
note
1
F. Rella, Le soglie dell’ombra. Riflessioni sul mistero, Milano, Feltrinelli, 1994, pp. 7-8.
2
K. Kerény, Nel labirinto, a cura di C. Bologna, Torino, Bollati Boringhieri, 1983, pp. 95-96.
3
lvi, p. 53.
4
L. M. Lombardi Satriani - M. Meligrana, Il ponte di San Giacomo. L’ideologia della morte
nella società contadina del Sud, Palermo, Sellerio, 1982, p. 12.
5
M. Callari Galli, Lo spazio dell’incontro, Roma, Meltemi, 1996, pp. 101-102.
6
D. Mazzoleni, Ciclope, in M. Galbati, Proiezioni urbane. La realtà dell’immaginario, Milano,
Tranchida Ed., 1989, pp.39-57, pp. 45-46.
7
F. Rella, Metamorfosi, Milano, Feltrinelli, 1984, p. 67.
8
M. Ilardi, L’individuo tra le macerie della città, in Id. (a cura di), La città senza luoghi.
Individuo, conflitto, consumo nella metropoli, Genova, Costa & Nola1990, pp. 13-34, 13-15
9
L. Russolo, L’arte dei rumori, in G. F. Maffina, Luigi Russolo e l’arte dei rumori. Con tutti gli
scritti musicali, Torino, Martano, 1978, pp. 129-131, cit. in R. M. Schafer, Il paesaggio sonoro,
Milano, Unicopli, 1985, p. 159.
10
V. Hugo, I Miserabili, Roma, Ed. Paoline, 1959, p. 756.
11
G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia
generale, Bari, Dedalo, 1972, pp. 111-112.
12
S. Anderson, Dark Laugtber, 1925.
13
I. Calvino, Le città invisibili. Romanzi e racconti, coll. I Meridiani, 2 voll., Milano,
Mondadori, 1992, vol. 1, pp. 357-498, pp. 367-368.
14
Ivi, p. 492.
15
Ivi, p. 496.
16
G. Canova, Lo sguardo sulla città, in M. Galbiati, op. cit., pp. 78-85, 79-84.
17
R. Park, The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in tbe Urban
Environment in «The America journal of Sociology», 5, 1915, trad. it. The City, Milano, Comunità,
1967.
18
M. Roncayolo, Città, in Enciclopedia, vol. 111, Torino, Einaudi, 1978, pp. 3-84, p. 77.
19
Della vastissima letteratura, oltre ai testi già citati mi limito a segnalare: R. Basham, Urban
Antropology: Tbe Cross-CulturalStudy of Complex Societtes, Palo Alto Mayfield Pulishing Company,
1978; M. Canevacci, La città polifonica. Saggio sull’antropologia della comunicazione urbana, Roma,
Ed. SEAM, 19942; P. Chiozzi (a cura di), Antropologia urbana e relazioni interetniche, Firenze,
Pontecorboli, 1991; E. Eames - J. Goode, The Antropology of tbe City: An Introduction to Urban
Antropology, Englewood Cliffs (NJ.), Prentice Hall, 1977; E. Eddy (ed.), Urban Antropology
Research, Perspectives, Strategies, Athens, University of Gerorgia Press, 1968; B. Glowczewshi- J.F.Matteudi, La cité des Cataphiles. Mission anthropologique dans les sotterrains de Paris, Paris,
Librairie des méridiens, 1983; J. Gulik, Urban Antropology: Its Present and Future, in New York
Academy of Sciences, vol. 25, 1962; P. Gutwirth, Bibliografy on Urban Antbropology, in A. Southafl
(ed.), Urban Antbropology, New York, Oxford University Press, 1973; P. Gutkind (ed.), Urban
Anthropology: Perspectives on Third World, Urbanization and Urbanisml, New York, Bames &
Noble, 1974; J. Gutwirth, Jalons pour l’anthropologie urbaine, in “L’Homme”, 4, 1982 - l. Gutwirth C. Ptonet (eds.), I Chemins de la ville: enqutes ethnologiques, Paris, Ed. du Comit des Travaux
historiques et scientifiques, 1987; U. Hannerz, Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, a
cura di A. Bagnasco, Bologna, Il Mulino, 1992; C. Pitto (a cura di), Antropologia urbana, Milano,
Feltrinelli, 1980; L. Rodwin - R. M. Hollister, City of tbe Mind, New York-London, Plenum Press,
1984; J. Rykwert, Tbe Idea of tbe City, Princeton, Princeton University Press, 1976 (trad. it. L’idea
della città, Torino, Einaudi, 1981); A. Signorelli (a cura di), Antropologia urbana, numero
monografico de “La ricerca folklorica”, n. 20, 1989; T. Tentori-P. Guidicini, Borgo, quartiere, città,
Milano, Angeli, 1972; D. Uzzel - R. Provencher, Urban Antbropology, Dubuque (Iowa), William C.
Brown, 1976; M. Weber, Die Staadt, in Wirtschft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1922 (trad. it. La
città, Milano, Comunità, 1950); L. Wirth, The Ghetto, Chicago, University of Chicago Press, 1928
(trad it. Il ghetto, Milano, Comunità, 1966; S. Zukin, Landscapes of Power-from Detrott to Disey
World, Berkeley - Los Angeles, University of California Press, 1993.
20
A. M. Sobrero, Antropologia della città, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993 (rist.), p. 224;
il brano citato dall’autore di K. Lynch, Image of the City, Cambridge, MIT Presse, 1960 (tr. it.
L’immagine della città, Padova, Marsilio, 1964).
21
M. Cacciari, Ethos e Metropoli, in “Micromega”, 1990, 1.
22
A. M. Sobrero, op. cit., pp. 228-229. Il brano citato dall’autore è tratto da A. Castellani,
Contaminati dalla merce, in M. Ilardi (a cura di), op. cit., pp. 143 -168.
23
Ivi, pp. 231-234.
24
M. Augé, Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Eluthera,
1993, pp. 97-98.
25
L. Borges, I due re e i due labirinti, in L’ Aleph, Milano, Feltrinelli, 1985, pp. 134-135.
26
G. Durand, op. cit., p. 244.