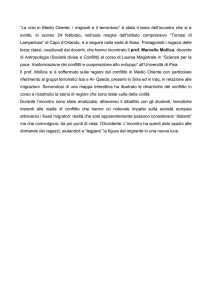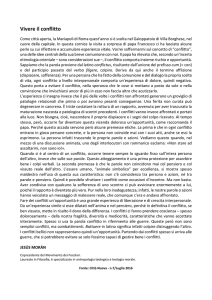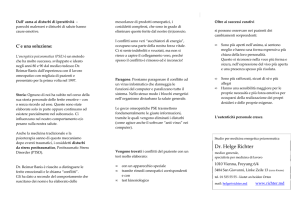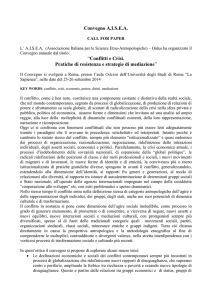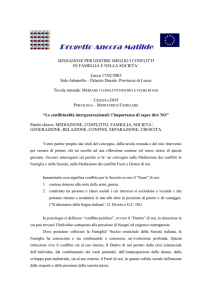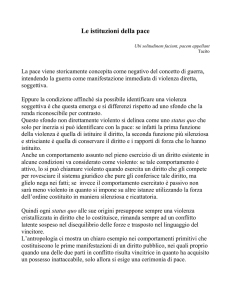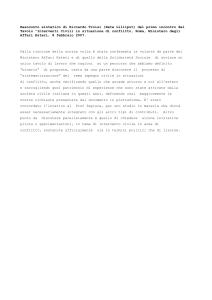Sui conflitti. Primi appunti e citazioni di Franco Cazzola Indice I.- I conflitti nelle realtà sociali L’uso della parola oggi L’importanza del conflitto I diversi significati della parola nelle scienze sociali II.- Le teorie del conflitto Premessa Le domande per ogni teoria I processi che attivano conflitto I partecipanti Gli effetti Le teorie: Machiavelli e Hobbes Le teorie: da Marx a Simmel Le teorie: Carl Schmitt Le teorie: I funzionalisti Le teorie: Alain Touraine Le teorie: Ralf Dahrendorf In chiusura 1: le società liberali e le società totalitarie di fronte al conflitto In chiusura 2: La politica e i conflitti III.- Tipologie dei conflitti: Pizzorno e Dahrendorf I soggetti L’estensione Le modalità: intensità e violenza La soluzione IV.- I conflitti violenti Che cosa si intende per violenza: alcune definizioni (Nieburg, Heritier, Ruggiero) Alcune teorie sulla violenza(Hobbes, Bentham, Durkheim, Elias, Arendt) Potere, autorità, forza, violenza Le forme della violenza Violenza istituzionale Violenza anti-istituzionale Dalla protesta alla guerra V.- La “limitazione” della violenza La legittimazione della guerra Lo ius ad bellum nelle epoche pre moderne Sant’Agostino e san Tommaso Machiavelli ed Erasmo da Rotterdam L’età moderna: Hobbes Kant Lo ius ad bellum in epoca moderna La rivoluzione francese: da Constant a Hegel Marx Il XIX secolo: le guerre coloniali Il XX secolo: Kelsen Lo ius belli: tra forma e sostanza La violenza senza limiti: i terrorismi VI.- I conflitti violenti dal 1946 In premessa: uno sguardo ai conflitti 1800-1945 L’analisi dei conflitti dal 1946 Le cause - Sociali ed economiche, Politiche, Etniche, Religiose I soggetti - Tra soggetti “legittimi” 1. Guerre tra stati 2. Scontri di confine 3. Guerre di intervento (o “per missione) - Contro soggetti “legittimi” 1. Sommosse e rivolte 2. Attentati 3. Golpe 4. Guerre di indipendenza 5. Guerre di secessione, religiose, etniche - Contro soggetti “illegittimi”: repressione I luoghi - Africa - Medio Oriente - Asia - Russia ed ex Urss - Ex Jugoslavia - Europa est - Mediterraneo orientale - Resto dell’Europa - America del nord - America centrale e meridionale I modi - La guerriglia - Il “Terrore” di Stato - Il “Terrorismo” illegittimo VII.- Tipi di conflitti e tipi di regimi Le diverse cause I diversi tipi I diversi effetti I.- I conflitti nelle realtà sociali L’uso della parola oggi E’ una specie di parola pas partout, si usa nel linguaggio comune come nei linguaggi più o meno specialistici; serve a indicare fenomeni molto diversi, è un termine, per dirla in breve, ambiguo, super utilizzato, che evoca prevalentemente “cose” negative. Ci richiama alla mente, come termini che si accostano a questo, la parola violenza, forza, la guerra, scontri a fuoco, tra civiltà, ecc. Eppure, come si vedrà, questa parola ha anche altri significati, molto meno cruenti, più quotidiani nella nostra vita, nel privato come nel pubblico. Fatto sta che oggi è una fra le parole più usate anche nel linguaggio della informazione. Proviamo a verificare quanto sovente si scrive “conflitto” in uno dei massimi quotidiani italiani (“la Repubblica”). Tra il 1984 e il 2007, cioè in un arco di 24 anni, il termine “conflitto” appare in circa 29.000 articoli, in altrettanti appare la parola “violenza”, in 9.000 casi si parla di “competizione”, in 90.000 di “guerra”. Termini, che potremmo chiamare opposti, quali “pace”, “”coesione”, “armonia” compaiono rispettivamente in 43.000, in 2.000, in 1.500 articoli. “Consenso” è presente in poco meno di 17.000 articoli e “dissenso” in 7.000. Se guardiamo le riviste di scienze sociali (Archivio JSTOR) abbiamo il seguente andamento relativo al numero di saggi riportanti i termini “conflitto” o “violenza”: Conflitto Violenza 1900-1945 9.803 2.926 1946-1955 6.078 2.342 1956-1965 9.420 3.493 1966-1975 16.098 6.717 1976-1985 22.123 8.445 1986-1995 25.049 11.679 1996-2000 12.942 7.301 La letteratura, come la musica, il cinema o il teatro, ci narrano, e non da ieri, di grandi e piccoli conflitti, tra singoli, tra generi, tra etnie, tra gruppi, tra religioni, tra generazioni. Ma che cosa significa questa parola? Si può cercare di renderla meno equivoca? E ancora: quale è il ruolo del conflitto non solo nella storia dell’umanità, ma anche in quella del pensiero politico e sociale? L’importanza del conflitto Diversi studiosi hanno sottolineato come il conflitto accompagni tutta la storia dell’umanità, come possa variarne l’intensità, la portata, ma come questo sia sempre presente, a livello di relazioni tra singoli, come tra gruppi, collettivi, società. Come ha scritto Alessandro Pizzorno (1993) “con l’idea di conflitto continuiamo a pensare tanta parte della realtà sociale contemporanea. E’ un’idea che abbiamo ricevuto da una ben radicata tradizione del pensiero politico occidentale, e non possiamo non fare i conti con essa” (pp. 187-188). Più precisamente si può ricordare che: “tra i concetti centrali degli studi sociali, quello di conflitto occupa certamente un posto più che rilevante. Abbondantemente utilizzato nelle discipline psicosociologiche, ed in ognuna di queste conservando purtroppo un significato specifico, il concetto di conflitto ha dato persino luogo a tentativi d’elaborazione d’una vera e propria teoria generale, suscettibile d’inglobarne ad un tempo le diverse dimensioni e tutte le varietà d’applicazioni possibili, nonché, ovviamente, le più correnti utilizzazioni al livello micro - e/o macrosociale. (…) i numerosi tentativi di generalizzazione e sistematizzazione compiuti negli ultimi quarant’anni non sono mai andati al di là, invero, della descrizione degli attori, in situazione di conflitto, delle forme che i conflitti possono assumere, dei fattori che direttamente o indirettamente li determinano, e talvolta anche delle funzioni che assolvono nella società e nella biografia degli attori, individuali e collettivi. Le tensioni, gli stereotipi, i pregiudizi, il razzismo, il colonialismo, gli scioperi, le rivolte, la guerra e le guerriglie, e molte forme di contestazione si sono così inestricabilmente fuse nel concetto, ormai vago ed incerto, di conflitto tra gruppi, oppure di conflitto tra supergruppi. (…) Benché tutte le definizioni finora elaborate ammettano, più o meno nettamente, l’esistenza d’un comune, generico denominatore – la cosiddetta relazione antagonistica –, nessuna di esse arriva tuttavia a rendere convenientemente conto, ad un tempo, delle specificità e delle generalità in ogni tipo di relazione antagonistica, e soprattutto a mettere in evidenza i processi, i meccanismi, le forme attraverso cui le volontà e le posizioni degli attori, diventando strutturalmente incompatibili, danno luogo a conflitti; e perché poi questi stessi conflitti siano ora funzionali e ora disfunzionali, talvolta integratori e talaltra disintegratori, oggi negativi e domani positivi” (G. Busino, Conflitto, in AA.VV., Enciclopedia, vol. 3, Einaudi, Torino, 1978, p. 757). I diversi significati della parola nelle scienze sociali I dizionari ci servono poco, partiamo quindi da un classico. Max Weber accosta la parola “conflitto” alla parola “lotta” (kampf), e questa al concetto di potere: “Una relazione sociale può essere definita lotta quando l’agire è orientato in base al proposito di affermare il proprio volere contro la resistenza di un altro o di altri individui. Debbono venir chiamati mezzi di lotta ‘pacifici’ quelli che non consistono nell’esercizio attuale della violenza fisica. La lotta ‘pacifica’ deve essere definita ‘concorrenza’ quando essa viene condotta come ricerca, formalmente pacifica, di un proprio potere di disporre di possibilità a cui anche altri individui aspirano (…) Dalla lotta sanguinosa, che mira ad annientare la vita dell’avversario e che rifiuta ogni legame di regole di lotta, fino alla lotta cavalleresca regolata convenzionalmente e al gioco agonistico conforme a certe regole (lo sport), dalla ‘concorrenza’ priva di regole, quale quella che si manifesta nel tentativo di conquistare il favore di una donna, e dalla concorrenza per lo sfruttamento – dipendente dall’ordinamento del mercato – di certe possibilità di scambio, fino alle forme di ‘concorrenza’ regolate artificiosamente o alla ‘lotta elettorale’, vi è una serie ininterrotta di passaggi. L’isolamento concettuale della lotta violenta si giustifica con il carattere specifico dei mezzi ad essa normali, e per i particolari aspetti, a questo legati, delle conseguenze sociologiche del suo presentarsi” (M. Weber, Economia e società, vol. I, Edizioni di Comunità, Milano, 1961 (1922), pp. 35-36). Conflitto come lotta, non necessariamente violenta, per imporre ad altri (ma sappiamo che ciascuno di noi vive di conflitti all’interno della propria, singola, personalità) ciò che ci interessa, singolarmente considerati o meno. La definizione weberiana è alla base di tantissime altre interpretazioni, per non farla lunga prendo in esame solo quelle di Ralf Dahrendorf (che ritroveremo anche più avanti) e di Charles Tilly. “Nel linguaggio corrente, alla parola ‘conflitto’ colleghiamo di regola l’idea di scontri particolarmente violenti. Se adottassimo questo linguaggio tradizionale, dovremmo indicare come conflitto uno sciopero, non una trattativa tariffaria, le lotte politiche interne, non i dibattiti parlamentari. Ma la definizione di conflitto da noi accettata è in contraddizione con quest’uso ristretto del termine. Il concetto di conflitto deve innanzi tutto indicare qualsiasi rapporto tra elementi che si possa caratterizzare mediante contrasti oggettivi (‘latenti’) o soggettivi (‘manifesti’). Quando due concorrenti lottano per una posizione, siamo di fronte ad un conflitto così come quando due partiti lottano per il potere, o due partners del mercato del lavoro lottano per la ripartizione dei profitti, o due squadre lottano per la supremazia, o due gangs criminali per conquistare un settore, o due nazioni si scontrano sul campo di battaglia, o due persone non si possono soffrire tra loro, e così via. Il contrasto tra gli elementi ogni volta in causa (che di frequente – se non sempre – può essere indicato anche aspirazione comune a limitati ‘valori’) può essere consapevole o soltanto desumibile, voluto o condizionato dalla situazione; anche il grado di consapevolezza non è rilevante per definire conflitti i rapporti (…) Un conflitto può essere poi definito sociale se può essere dedotto dalla struttura di unità sociali, cioè quando è sovraindividuale. Il conflitto del medico tra le aspettative dei suoi pazienti e quelle dell’ente mutualistico è un conflitto sociale; esso infatti esiste indipendentemente dalla personalità del medico in questione. Lo stesso vale, di regola, per i conflitti tra partiti politici, tra imprenditori e sindacati, tra città e campagna, tra confessioni e così via. Un conflitto tra due individui basato unicamente sulla loro reciproca antipatia non è invece un conflitto sociale” (R. Dahrendorf, Uscire dall’utopia, il Mulino, Bologna, 1971 (1967), pp. 249-250). Charles Tilly (1992) si concentra sul conflitto sociale, e così lo definisce: “Vi è conflitto sociale quando una persona o un gruppo avanza pretese di segno negativo nei confronti di altre persone o gruppi, pretese che, qualora venissero soddisfatte, danneggerebbero l’interesse altrui, cioè l’altrui probabilità di raggiungere una situazione desiderabile. Le pretese di segno negativo implicano tanto minacce quanto attacchi veri e propri. Quando esse comportano una diretta presa di possesso, oppure un danno alle persone o alle cose, gli osservatori utilizzano spesso la parola ‘violenza’. Un conflitto può essere asimmetrico, nel senso che una sola delle parti in causa, e non l’altra, può avanzare pretese di segno negativo: in questo caso si parla di ‘coercizione’. Accade più spesso, tuttavia, che nel conflitto ci si avvicini a una situazione di simmetria, con ciascuna delle due parti che avanza almeno lacune pretese per neutralizzare quelle dell’altra. Il conflitto è un caso particolare di ‘competizione’: due o più parti cercano simultaneamente di ottenere dei vantaggi (o di evitare degli svantaggi) che si escludono a vicenda. La normale competizione diventa conflitto quando un concorrente avanza in maniera esplicita delle pretese potenzialmente lesive dell’altrui interesse; fare un’offerta maggiore rispetto a quella del proprio vicino, per un pezzo di terra desiderato da entrambi, non può essere di per sé configurato come conflitto, ma si configura come tale il minacciare il proprio vicino di attaccarlo qualora egli rilanci l’offerta. In base a tale definizione, l’ingaggiare una gara con qualcuno è un comportamento che si situa ai margini del conflitto, poiché, se per i due concorrenti perdere non implica alcuna differenza sostanziale, il conflitto non si scatena; se invece una delle parti ha interesse a vincere, la competizione si trasforma in conflitto. In ogni caso, l’atto di ostacolare l’avversario per indurlo a rallentare identifica chiaramente la gara come un conflitto. Il conflitto è complementare alla cooperazione, in cui unità sociali differenti avanzano istanze positive le une nei confronti delle altre; i cooperanti, cioè, offrono promesse e ricompense piuttosto che minacce e attacchi. Le relazioni sociali che implicano minacce esplicite o attacchi condotti da una delle parti nei confronti dell’altra rappresentano il terreno naturale del conflitto. Per questo motivo, individui e gruppi che esercitano il controllo su mezzi di coercizione – armi, soldati, simboli sovrannaturali, accesso alla pubblicità negativa e così via – giocano nel conflitto un ruolo senza paragoni; essi diventano degli specialisti nella formulazione di pretese di segno negativo, e dispongono di basi migliori per sostenerle. Tra tutti costoro, i più importanti sono gli Stati, i quali si specializzano non soltanto nell’accumulazione e nell’impiego di mezzi coercitivi, ma anche nel controllo dell’uso che, all’interno dei rispettivi territori, altre persone fanno della coercizione. Il conflitto sociale comprende tutte quelle forme d’interazione all’interno delle quali degli individui o dei gruppi si minacciano o si attaccano a vicenda, e in molte situazioni conflittuali gli Stati entrano in gioco o come partecipanti attivi, o come il terzo polo del conflitto, oppure con funzioni di arbitrato” (C. Tilly, Conflitto sociale, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. II, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1992, p. 259). Non sono poche le differenze tra Dahrendorf e Tilly, qui voglio sottolinearne un paio. In primo luogo: per Dahrendorf qualunque forma di ‘competizione’ equivale a un qualche tipo di conflitto; per Tilly solo quelle relazioni nel corso delle quali si minaccia o si ostacola l’altro. Primo commento: che cosa vuol dire ‘ostacolare’? Probabilmente Tilly si riferisce a comportamenti “fuorilegge”, quali ad esempio il colpire il pugile avversario sotto la cintola, oppure non rispettare le leggi di guerra (delle quali si parlerà più avanti), oppure comprare subdolamente i voti per l’elezione alla carica di presidente della società bocciofila di Petralia Soprana. Se è così, il problema si sposta, o meglio: chiama in causa, il “chi” fa le regole, e quindi il tipo di regime politico di quella data situazione. Facciamo un esempio: uno sciopero in Cina oggi è un tipo di conflitto sia per Dahrendorf sia per Tilly; uno sciopero in Italia è un conflitto per Dahrendorf ma non per Tilly. Problema: una campagna elettorale per la conquista del governo, condotta nel pieno rispetto delle regole, è un conflitto o solo una competizione? II.- Le teorie del conflitto Premessa Fin dall’antichità troviamo tracce di tentativi di teorizzare il conflitto (come nasce, come si sviluppa, il peso che ha nelle trasformazioni delle società, ecc.). Come è stato sottolineato se ne trovano tracce in Eraclito, nei sofisti, in Ibn Khaldun e poi in Machiavelli, come vedremo, in Hobbes, e in tanto altri studiosi delle varie discipline. “Anche Hegel ha riconosciuto il carattere d’universalità del conflitto, ne ha sottolineato la sostanziale positività e la sua funzione determinante per il cambiamento e soprattutto per la storia. L’assenza di conflitti genera l’immobilismo, elimina i dinamismi sociali, distrugge la storicità dei gruppi sociali. Le società sono dunque attraversate costantemente dai conflitti; ma questi poi come si configurano?” (G. Busino, cit., p. 766). Al di là di chi se ne è occupato, è necessario ricordare che, almeno in occidente, il problema del conflitto è stato oggetto di analisi e di teorizzazioni in due diversi momenti storici o, per meglio dire, in relazione a due tipi di occasioni: “ da una parte trattando dell’unità politica nello stato; dall’altra, trattando della natura e del destino dei soggetti di azione collettiva che hanno radici all’esterno dello stato. Nel primo caso ci si è chiesti quale posto possa essere fatto ai conflitti tra parti che nascono come portatrici di interessi privati, ma che mirano al potere nello stato. Nel secondo ci si è interrogati sui meccanismi che producono fini i quali si pongono come superiori, o in ogni caso estranei, ai fini dello stato. I primi sono stati detti conflitti politici; i secondi, conflitti sociali. Come si formi, e come poi sembri chiudersi, nella tradizione, la risposta al primo interrogativo, lo si può leggere in Machiavelli, Hobbes e Carl Schmitt. La costruzione del secondo interrogativo apparirà chiaramente nel passaggio da Machiavelli a Marx” (A. Pizzorno, 1993, p. 188). Una storia lineare, quella del pensiero politico sui conflitti? Oppure anche questo tipo di elaborazione teorica ha risentito e risente (o riflette) l’andamento della storia stessa? E’ ancora Pizzorno a chiarire bene il punto: “L’interesse per i conflitti sociali e i loro problemi è passato, nella sociologia moderna, attraverso una vicenda singolare. Nella misura in cui il pensiero sociale dell’inizio del XIX secolo si è ispirato, in maniera più o meno diretta, essenzialmente a Marx o a Darwin, l’attenzione ai fenomeni di conflitto è dominante. Se si dovessero fare i nomi dei sociologi che hanno dedicato esplicite trattazioni a questo tipo di problemi, ricorrerebbero i maggiori della sociologia di allora, da Simmel a Small, da Ratzenhofer a Sumner a Oppenheimer e molti altri, senza contare il filone dei marxisti di stretta osservanza (e si pensi solo all’uso originale che del conflitto ha fatto Sorel). A un certo punto, però, la nozione di conflitto passò in secondo piano e finì per essere dimenticata. Nello stesso periodo si andò elaborando, prima in maniera quasi inconsapevole, poi sempre più formalmente e rigorosamente, la teoria dell’integrazione sociale, consacrata alla fine nell’opera degli strutturalfunzionalisti ed essenzialmente di Talcott Parsons” (A. Pizzorno, Introduzione a Dahrendorf, 1971, p. VII-VIII). Quali le ragioni di questa “obsolescenza” dell’idea di conflitto? Pura casualità? Manifesta incapacità delle teorie precedenti a dire alcunché di utile per la comprensione dei fenomeni sociali? O che altro? Alcuni studiosi (in primo luogo Lewis Coser)hanno cercato di spiegare questo andamento facendo riferimento al pubblico al quale si rivolgevano sociologi e scienziati sociali in genere: i grandi riformatori sociali degli anni pre primo conflitto mondiale, i riformatori locali (soprattutto negli Stati Uniti) per il miglioramento delle condizioni di vita nelle grandi metropoli, per l’abolizione degli slums negli anni Venti e Trenta del Novecento, i grandi committenti pubblici e privati che chiedevano ai sociologi risposte, o almeno indicazioni, per risolvere i loro micro-problemi di politica “aziendale”. “A questo punto i sociologi non parlarono più di conflitto, ma tutt’al più di anomia; non più di contraddizioni, ma di tensioni, di inadattamenti, ecc.” (ivi). Contro questa interpretazione, possiamo riferirci ai grandi avvenimenti storici generali e in primo luogo alle guerre mondiali: “che hanno rappresentato il conflitto calato sulla società in misure impensate, non più origine di un regolato mutamento, ma minaccia alla stessa esistenza sociale. E’ comprensibile che dopo tali avvenimenti si potesse manifestare una abdicazione a capire razionalmente e sistematicamente i grandi rivolgimenti sociali e insieme un’esitazione ad evocare, con l’idea di conflitto, una realtà incontrollabile e irrazionale. A portata di mano stavano piuttosto le risoluzioni di problemi minori, e in relazione ad essi ‘l’ordine’, ‘l’integrazione sociale’ potevano porsi come fine cui mirare, oltre che come modello con cui interpretare il funzionamento della società” (ibidem, p. IX). Le domande per ogni teoria Qualunque teoria del conflitto (così come le cosiddette metateorie) dovrebbe essere in grado di rispondere ai seguenti quesiti: quali sono i processi sociali che producono conflitto?; come e per quali ragioni si formano i gruppi che danno vita a un conflitto?; come si spiegano le varie forme di conflitto?; quali effetti producono su una data società i conflitti? Prima di passare ad analizzare brevemente alcune delle principali teorie del conflitto, diamo un’occhiata ad alcune primissime e generiche risposte a questi interrogativi. I processi che attivano conflitto. Charles Tilly ci ricorda che: “Le spiegazioni generali del conflitto sociale si dividono secondo due direttrici fondamentali. La prima concerne le relazioni sociali implicate nel conflitto, e precisamente: a) quelle relazioni che connettono gli individui alla società presa nel suo insieme, e b) quelle relazioni che connettono un individuo o un gruppo a un altri individuo o gruppo (…) La seconda distinzione concerne i processi sociali che producono conflitto: a) il cattivo funzionamento degli ordinari meccanismi di regolazione, o b) l’attivazione di interessi contradditori” (C. Tilly, 1992, p. 260). Per Tilly abbiamo quindi quattro diverse concezioni (che chiama metateorie ossia insiemi di idee non verificabili in se stesse, ma che costituiscono tuttavia una utile guida per la ricerca). Relazione sociale tra Gruppo-Società Processo sociale Gruppo-Gruppo Cattivo funzionamento dei meccanismi di regolazione Conflitto Fisiologico Conflitto per pregiudizio Attivazione di interessi contradditori Conflitto Patologico Conflitto di classe Gli autori che ci possono aiutare a comprendere le diverse spiegazioni sono, a titolo di esempio, Durkheim, Marx, Lorenz, gli “educatori”. Relazione sociale tra Gruppo-Società Processo sociale Cattivo funzionamento dei meccanismi di regolazione Attivazione di interessi contradditori Gruppo-Gruppo Durkheim Educatori Lorenz Marx “Secondo Durkheim, se la divisione del lavoro supera la capacità, propria di una determinata società, di mantenere l’integrazione dei suoi membri, questi perdono il proprio attaccamento alla società stessa, prevalgono l’anomia e uno stato di disordine, che contiene in sé il conflitto (…). Agli occhi di Marx tutti gli individui e i gruppi hanno degli interessi determinati dalla posizione da essi occupata entro il sistema produttivo; interessi contradditori sono inerenti a quasi tutti i sistemi produttivi, e situazioni di aperto conflitto scaturiscono prevalentemente da interessi contradditori (…) Konrad Lorenz (1963) presenta l’aggressività come profondamente radicata nella biologia umana e promossa da una selezione genetica che affina la capacità di lottare. Brian Crozier (1974) deriva la sua conclusione che il conflitto è inevitabile, e tuttavia dev’essere represso, dai seguenti assiomi: l’uomo è per natura invidioso e aggressivo; la sua natura non è soggetta a modificazioni; il suo comportamento è comunque suscettibile di cambiamenti in meglio o in peggio; l’uomo, infine, ha un fortissimo bisogno di ordine (…) La metateoria delle relazioni tra gruppi |che ho etichettato con il termine: conflitto da pregiudizio| postula comunemente che i conflitti nascano da pregiudizi, incomprensioni o errate valuazioni, che l’informazione, l’educazione, la persuasione o un prolungato contatto elimineranno |per certi aspetti si potrebbe dire che questa è anche la posizione di Jurgen Habermas|” (ibidem, p. 261). I partecipanti. Anticipando quanto verrà più specificamente chiarito più avanti, parlare di “partecipanti” vuol dire entrare già in una delle tante tipologie dei conflitti che si possono enucleare. In breve, i conflitti possono avere come attori: Stato contro Stato (guerra, conquista); Stato contro non-Stato (ribellione, rivoluzione, guerra di indipendenza, repressione); Non-Stato contro non-Stato (conflitto industriale, scontri tra gruppi etnici, tra gruppi religiosi, tra tifoserie). Le forme. Anche per questo punto anticipo molto sommariamente quanto verrà presentato più avanti. E’ ovvio ed è noto che il conflitto sociale assume una molteplicità di forme a seconda, anche, della struttura sociale in cui si presentano, degli attori, degli scopi che questi si prefiggono, ecc. Ma, è ancora Tilly a sottolinearlo: “In confronto alla molteplicità di attività conflittuali possibili almeno in teoria, una qualsiasi coppia di attori che s’impegna in un conflitto prolungato tende ad attuare una serie estremamente limitata di comportamenti, adottando sempre gli stessi per più volte, con variazioni di secondaria importanza. All’interno degli Stati capitalisti contemporanei, i conflitti organizzati tra padroni e operai assumono la forma di scioperi, serrate, consigli di fabbrica, dimostrazioni, richieste d’intervento statale, sabotaggi ecc. (…) Nei paesi occidentali, a partire dalla seconda guerra mondiale, è diventata abbastanza comune una forma di conflitto fino a quel momento piuttosto rara: un gruppo s’impadronisce di un luogo, di una persona o di un oggetto importanti per il loro valore simbolico, tenendoli in ostaggio nel corso delle trattative con un altro gruppo. Rientrano in questo schema i dirottamenti aerei, le occupazioni delle fabbriche e i sit-in negli uffici o nelle pubbliche piazze (…) Una delle parole con cui si indica l’insieme dei mezzi usati in un conflitto da una qualsiasi coppia (o gruppo più ampio) di attori è ‘repertorio’. La metafora teatrale suggerisce che si tratta di un numero limitato di procedure relativamente differenziate e implicanti interazione tra alleati e nemici, che sono messe in atto dai partecipanti in base a norme negoziate, sono più o meno note a tutti i partecipanti, variano di volta in volta e tendono ad essere manipolate dagli attori a proprio esclusivo vantaggio (…) I repertori del conflitto variano secondo la struttura e la storia delle relazioni sociali nel cui contesto essi sono situati. Questo è uno dei motivi che sta alla base delle differenze sussistenti tra i conflitti Stato/Stato, Stato/non-Stato e non-Stato/non-Stato: nella loro interazione, gli Stati creano una serie di modelli conflittuali standard, gli Stati e i loro oppositori interni ne elaborano altri, gli avversari al di fuori dello Stato altri ancora” (ibidem, pp. 266-267). Gli effetti. A seconda degli studiosi del conflitto possiamo avere, in genere, effetti di innovazione e progresso, oppure effetti devastanti per la struttura sociale nella quale si verificano. Per alcuni il conflitto in sé è devastante, per altri è sempre portatore di mutamento positivo. Ma di questo si parlerà più diffusamente a proposito delle diverse teorie del conflitto. Qui preme solo sottolineare come, a prescindere dalla valutazione positiva o negativa del conflitto, l’idea di conflitto ci rimandi a quelle di consenso, di coercizione, di equilibrio e di forza, di ‘politica’, in ultima istanza. Ovvero: “i sistemi sociali sono fondati sulla coercizione di certi individui su altri, o sulla formazione di un consenso su certi valori fra i membri della società? Se si assume che i rapporti sociali, o una parte importante di essi, siano rapporti di coercizione, lo studio del conflitto diventa fondamentale per ogni scienza sociale” (A. Pizzorno, cit., p. X). Detto con altre parole: “A prima vista, un paese in cui l’esercizio del potere avviene senza attrito in nome e con l’appoggio dell’intera società, potrebbe apparire senz’altro attraente. Le decisioni politiche sono essenzialmente l’espressione di una volontà comune e quindi generale. Il potere non è un concetto equivalente a una somma di zeri, ma una moneta cui ogni cittadino ha una parte. Un sistema universale di partecipazione, il flusso indisturbato delle comunicazioni determina la realtà. Ma vale la pena esaminare più da vicino questa piacevole immagine. Cosa succede per esempio se un infelice non concorda con la presunta volontà comune? Questo è un caso che non dovrebbe verificarsi, ma che cosa succede se, tuttavia, esso si verifica? Se la teoria (dell’equilibrio) viene elevata a dogma, il deviante deve essere perseguitato; se non viene perseguitato, la teoria è respinta. Che cosa succede se qualcuno sviluppa una sua idea con cui potrebbe ordinare le cose meglio di come stanno, e se trova appoggi a tali progetti?”. (Dahrendorf, 1971, p. 331). disputando Le teorie: Machiavelli e Hobbes In Machiavelli, noi troviamo, secondo Pizzorno, una vera e propria teoria dei conflitti (intendendo per conflitti: discordie, inimicizie, disunioni e tumulti e levate di popolo): “cioè di un insieme di proposizioni indicanti perché i conflitti nascano, quali effetti essi producano, e in quali circostanze essi siano vantaggiosi alla cosa pubblica, e quando invece le nuocciano” (Pizzorno, 1993, p. 188). In Machiavelli la teoria è questa: “I conflitti giovano alla cosa pubblica quando sono volti a conquistare in favore di una parte, fino allora esclusa, il diritto di essere presente nel governo della città e non invece quando mirano ad annientare la parte avversa. Quando si manifestano disputando, non invece con violenza e all’ultimo sangue. Quando sono volti a generare nuove leggi e, in genere, innovazioni istituzionali, invece che esili della parte perdente (Discorsi, I, 2-4, e Istorie Fiorentine, III, 1). In altre parole, lo scopo delle parti, o ,piuttosto, di quella che muove alla lotta, è concepito in questi casi come quello di farsi riconoscere e accettare dalla parte avversa, e giungere a condividere i supremi onori con essa – o almeno di stabilire con certezza i suoi diritti. Stabiliti questi, il conflitto si quieta. Tre vantaggi conseguono a questo tipo di conflitto. Anzitutto esso tende a generare innovazioni istituzionali che allargano l’accesso alla cosa pubblica. Secondo, garantisce la libertà dei cittadini: infatti tutte le leggi che in una repubblica si fanno in favore della libertà dei cittadini ‘nascono dalla disunione di popoli e grandi’. Infine, il conflitto fomenta la partecipazione alla cosa pubblica, mobilita quindi le energie della collettività, che possono poi rivolgersi verso conquiste esterne. Nuocciono invece alla cosa pubblica i conflitti i quali si terminano con la parte vincente che resta unica al governo, che legifera secondo le sue ambizioni private, e annienta o manda in esilio il vinto. Sembra poi inevitabile che quando questo succede, la parte vincente si divida a sua volta, e si riaccendano così altre lotte. Simili conflitti nascono quando è in gioco non l’onore del pubblico, bensì la ‘roba’, non riconoscimento di diritti, bensì il possesso di ricchezze” (ibidem, p. 189). In Hobbes abbiamo il ribaltamento del ragionamento di Machiavelli: lo stato non può accettare l’esistenza di conflitti, in quanto questi portano alla guerra civile; i conflitti non portano alla libertà dell’individuo in quanto questi diventa prigioniero di una delle due parti in lotta e quindi perde la sua libertà. “Rispetto a Machiavelli non siamo qui soltanto di fronte a giudizi che sono diversi perché si valutano diversamente le possibili conseguenze dei conflitti. La condanna di Hobbes nasce da una nuova teoria dello stato e della funzione che esso svolge per la sopravvivenza degli individui e per le relazioni che si costituiscono tra questi. Affinché gli individui si accettino l’uno l’altro pacificamente, si riconoscano cioè degni di coesistere, lo stato deve mantenere per sé non soltanto il monopolio della forza, ma, per dir così, il monopolio della certezza. E’ infatti l’incertezza che rende impossibile la coesistenza, e che va quindi abolita” (ibidem, p. 190). In realtà, Hobbes si riferisce a conflitti sconosciuti all’epoca di Machiavelli, Hobbes si riferisce ai conflitti della sua epoca, cioè prevalentemente a conflitti religiosi, a conflitti tra contrapposte “verità” e che, quindi, producevano incertezza quanto alla “vera” verità. Di qui il ruolo dello stato: definire la verità delle persone, “cioè la loro identità sociale, il modo come esse debbono identificarsi pubblicamente l’un l’altre, le opinioni che esse possono pubblicamente manifestare. Qualunque divergenza o conflitto a questo proposito va abolita. Costituirebbe una minaccia alla certezza dei rapporti” (ibidem, p. 190). Ma questa idea hobbesiana presenta due difficoltà: “Una emerge se distinguiamo fra le credenze (religiose, ideologiche) che entrano in conflitto con la certezza dello stato (del suo diritto), e quelle che invece vengono generate all’interno dell’attività dello stato stesso. Hobbes prende in considerazione solo le prime, le vede le une con le altre inconciliabili, e le espelle. Lo sviluppo storico le mostra invece permanere, ma uscire dalla cosa pubblica, i conflitti pubblici in loro nome attenuarsi, circoscriversi nel foro interno della persona. E il loro posto nella cosa pubblica esser preso da credenze non più sulla verità eterna, bensì sulla natura delle istituzioni. I conflitti, poi, provocati da questo secondo tipo di credenze diventano istituzione stessa dello stato. Su questo fondamento si forma la visione liberale del conflitto. La seconda difficoltà si pone in un certo senso come uguale e contraria alla prima. Come sarà possibile che i singoli cittadini arrivino a sopportare sacrifici – anche della vita – che il conflitto tra gli stati comporta, se il principio del conflitto in nome di credenze riguardanti la verità è stato negato? I conflitti per la fede potevano condurre sino alla perdita della vita, perché di quella fede era fatta l’identità della persona. Perdendo le ragioni della fede si perdeva l’identità della persona e senza identità riconosciuta la vita non era vivibile. Come può lo stato, nato per assicurare la sopravvivenza, generare la stessa solidarietà di fronte alla morte quale genera una fede religiosa?” (ibidem, p. 191). Due teorie decisamente contrapposte: ma si tratta di due teorie vere e proprie? In realtà, sia Machiavelli che Hobbes lasciano insoluti diversi problemi e, quindi, si è di fronte a “teorie” per lo meno incomplete. E’ ancora lo stesso Pizzorno a enuclearle con chiarezza: “Si ritorni per un momento alle differenze tra Machiavelli e Hobbes. Per il primo i conflitti erano tra parti private, che usavano risorse di origine privata (ricchezze, nessi di amicizia o parentela, devozione a un capo). Dove venissero prodotte tali risorse, e che conseguenze nascessero dal loro esser prodotte in un certo modo, non veniva indagato. Per Hobbes, invece, ciò che contava era una natura nuova dei conflitti, non più d’interesse, di ‘roba’, come avrebbe detto il Fiorentino, bensì portanti sulla verità. Di fronte alla minaccia rappresentata da questo tipo di conflitti intestini, lo stato doveva essere tale che, al di fuori di esso, contro il suo decreto, non doveva potersi dare enunciazione pubblica di verità. Né l’una né l’altra di queste due posizioni era, per esprimersi così, in equilibrio. A chi avesse voluto completare il oro senso si presentavano alcuni problemi ardui, e di portata assai radicale. Il primo era il problema di indicare quali meccanismi producessero le risorse oggetto e arma dei conflitti che avevano radici al di fuori della cosa pubblica (problema per chi legga Machiavelli). Il secondo era di esaminare la natura dei conflitti che avevano per posta la verità. Il terzo consisteva nel domandarsi che modi di teoria fossero possibili una volta che si volesse spiegare la presenza di conflitti portanti sulla verità. Ovverosia che rapporto potesse darsi in questi casi tra l’esser parte di un conflitto, e l’esser osservatore e teorico di esso (problemi, il secondo e il terzo, per chi legga Hobbes)” (ibidem, pp. 194-195). Le teorie: da Marx a Simmel Una prima risposta ai tre problemi lasciati insoluti da Machiavelli e da Hobbes, la troviamo in Marx. E’ nei rapporti di produzione che si producono le risorse oggetto del conflitto; è il sistema dei rapporti di produzione che genera conflitti sistematicamente a prescindere dalle singole volontà; e lo stato “sta all’interno dei conflitti. Non è in grado, quindi, di risolverli o sopprimerli, almeno non a lungo. Questi conflitti, poi, sono connotati da quella componente che Hobbes per primo aveva individuato: essi hanno per posta la verità. Le parti in conflitto sono portatrici di verità contrapposte quanto all’interpretazione della realtà sociale” (ibidem, p. 195). Per dirla con altre parole (Simmel) la risposta di Marx “tiene conto delle motivazioni intrapersonali ed interpersonali, delle cause esogene e di quelle endogene, ma ha la particolarità di collegare l’analisi dei conflitti allo studio complessivo dei sistemi sociali concepiti dinamicamente, nel senso che l’analisi non fa mai astrazione dai rapporti di classe che caratterizzano i detti sistemi” (G. Simmel, I conflitti della cultura moderna, Bulzoni, Roma, 1976 (1908), p. 134). Simmel valuta positivamente i conflitti, in quanto ritiene che essi producano effetti positivi per la collettività e per i singoli individui costituenti tale collettività. Andiamo per ordine. “Di fatto sono i fattori dissociativi – odio e invidia, bisogno e desiderio – le cause del conflitto. Ma una volta esploso per causa loro, esso è una forma di ausilio per risolvere i dualismi divergenti; è un modo di raggiungere un qualche genere di unità, anche se attraverso l’annullamento di una delle parti in conflitto (…) Un gruppo che sia centripeto ed armonico in senso assoluto, una pura ‘unificazione’, non solo è empiricamente irreale, ma non potrebbe offrire alcun processo vitale vero e proprio. La società dei santi che Dante vede nella Rosa del Paradiso può comportarsi così, ma è anche sottratta ad ogni mutazione e sviluppo; mentre già la santa assemblea dei Padri della Chiesa nella ‘Disputa’ di Raffaello si presenta, se non come un vero e proprio conflitto, almeno come una considerevole differenziazione di opinioni e direzioni di pensiero, dalla qual cosa fluisce tutta la vitalità e la reale struttura di quell’insieme. Proprio come l’universo ha bisogno di ‘amore e odio’, cioè di forze attrattive e repulsive, per avere una forma, così anche la società, per ottenere una determinata configurazione, necessita di un qualche rapporto quantitativo di armonia e disarmonia, di associazione e concorrenza, di tendenze favorevoli e sfavorevoli” (ibidem, pp. 87 e 89). Per questo studioso, quindi, il conflitto non è solo necessario per il mutamento di una società, ma è anche sempre presente, non potendosi dare una società terrena totalmente armonica. Non tutti i conflitti, tuttavia, ed è chiaro già nella citazione di sopra, hanno effetti positivi: a seconda del tipo di conflitto prevalgono elementi coesivi o elementi distruttivi. “Naturalmente ci sono conflitti che sembrano escludere tutti gli altri elementi: per esempio tra il ladro, il delinquente e la sua vittima. Se un tale conflitto tende all’annientamento, esso si avvicina al caso limite dell’assassinio, in cui la partecipazione di elementi coesivi è divenuta uguale a zero. Nei limiti in cui, tuttavia, è presente un qualsiasi ritegno, un limite dell’atto violento, esiste anche un momento socializzante, anche se soltanto come determinazione della violenza. Kant ha osservato che ogni guerra in cui i belligeranti non si impongono un qualche limite nell’uso dei possibili mezzi di lotta, necessariamente, già per ragioni psicologiche, deve diventare guerra di sterminio. Infatti dove non ci si astiene almeno dall’assassinio, dal venir meno alla parola data, e dall’istigazione al tradimento, si distrugge quella fiducia nelle intenzioni del nemico che rende possibile poi una qualche pace. Dopo aver conquistato l’Italia nel VI secolo i Longobardi imposero ai vinti il tributo di un terzo del raccolto, ed essi fecero in modo che ogni singolo individuo tra i conquistatori dipendeva dal tributo pagatogli da un ben determinato individuo trai vinti. In questa situazione, l’odio dei vinti per i conquistatori sarà altrettanto forte e forse più forte che durante la guerra stessa e si rinnoverà con non minore intensità anche nei conquistatori: sia perché l’odio contro chi ci odia è una misura istintiva di difesa, sia perché, notoriamente, odiamo coloro ai quali abbiamo fatto del male. Tuttavia la situazione aveva un elemento comunitario. La stessa circostanze che aveva generato l’ostilità, cioè la forzata partecipazione dei Longobardi alle attività degli indigeni portò al tempo stesso ad un innegabile parallelismo di interessi. Su questo punto divergenza e armonia si legarono strettamente (…) Questo tipo formale di relazione si è realizzato nella maniera più ampia col ridurre in schiavitù anziché uccidere il nemico catturato. Anche se molto spesso la schiavitù rappresenta il caso limite di una totale ostilità interna, la sua realizzazione produce nondimeno un rapporto sociologico e con ciò, molto spesso, la sua stessa attenuazione. Così l’acuirsi delle contrapposizioni può essere provocato direttamente dalla volontà di diminuirle, e non solo dal voler accentuare la violenza, fiduciosi che l’antagonismo, una volta che abbia raggiunto un certo limite, finirà per esaurimento o per l’acquisita coscienza della sua insensatezza. Ma può anche accadere un fatto simile a quello che talvolta nelle monarchie porta i principi a capo dell’opposizione. Da ciò l’opposizione ne esce rafforzata e questo nuovo contrappeso porta ad essa elementi che altrimenti ne sarebbero rimasti fuori. Ma al tempo stesso l’opposizione viene contenuta in questo modo entro certi limiti. Nel momento in cui il governo apparentemente di proposito rinforza l’opposizione, con questo venirle incontro le spezza le punte”. (ibidem, pp. 100-102). Le teorie: Carl Schmitt Per Schmitt, situazioni di conflitto (effettive o potenziali) si hanno quando si costituisce un’identità collettiva. “Un’identità collettiva si costituisce: a) quando si danno altri da essa che la riconoscono; b) quando coloro che non la riconoscono vengono trattati come nemici, e contro di essi non vale più l’interdizione di uccidere; c) quando a loro volta gli individui che si riconoscono appartenere a quel soggetto collettivo sono disposti a morire, se ciò è necessario perché quel soggetto venga riconosciuto” (ibidem, p. 192). Vediamo, in breve e per passaggi semplificati, il suo ragionamento sul conflitto politico. “La specifica distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici, è la distinzione di amico e nemico. Essa offre una definizione concettuale, cioè un criterio, non una definizione esaustiva o una spiegazione del contenuto. Nella misura in cui non è derivabile da altri criteri, essa corrisponde, per la politica, ai criteri relativamente autonomi delle altre contrapposizioni: buono e cattivo per la morale, bello e gruppo per l’estetica e così via (…) Il significato della distinzione di mico e nemico è di indicare l’estremo grado di intensità di un’unione o di una separazione, di un’associazione o di una dissociazione; essa può sussistere teoricamente e praticamente senza che, nello stesso tempo, debbano venir impiegate tutte le altre distinzioni morali, estetiche, economiche o di altro tipo. Non v’è bisogno che il nemico politico sia moralmente cattivo, o esteticamente brutto; egli non deve necessariamente presentarsi come concorrente economico e forse può anche apparire vantaggioso concludere affari con lui. Egli è semplicemente l’altro, lo straniero e basta alla sua essenza che egli sia esistenzialmente, in un senso particolarmente intensivo, qualcosa d’altro e di straniero, per modo che, nel caso estremo, siano possibili con lui conflitti che non possano venir decisi né attraverso un sistema di norme prestabilite né mediante l’intervento di un terzo ‘disimpegnato’ e perciò ‘imparziale’ (…) Nemico non è il concorrente o l’avversario privato che ci odia in base a sentimenti di antipatia. Nemico è solo un insieme di uomini che combatte almeno virtualmente, cioè in base ad una possibilità reale, e che si contrappone ad un altro raggruppamento umano dello stesso genere. Nemico è solo il nemico pubblico, poiché tutto ciò che si riferisce ad un simile raggruppamento, e in particolare ad un intero popolo, diventa per ciò stesso pubblico. Il nemico è l’hostis, non l’inimicus in senso ampio (…) La contrapposizione politica è la più intensa ed estrema di tutte, e ogni altra contrapposizione concreta è tanto più politica quanto più si avvicina al punto estremo, quello del raggruppamento in base ai concetti di amico-nemico (…) Che l’essenza dei rapporti politici consista nel riferimento ad una contrapposizione concreta è reso palese dallo stesso linguaggio corrente, là dove è andata del tutto perduta la coscienza del ‘dato estremo’. Ciò risulta quotidianamente in due fenomeni che devono essere subito messi in luce. In primo luogo: tutti i concetti, le espressioni e i termini politici hanno un senso polemico; essi hanno presente una conflittualità concreta, la cui conseguenza estrema è il raggruppamento in amiconemico e diventano astrazioni vuote e spente se questa situazione viene meno. Termini come Stato, repubblica, società, classe, e inoltre: sovranità, Stato di diritto, assolutismo, dittatura, piano, Stato neutrale o totale e così via sono incomprensibili se non si sa chi in concreto deve venir colpito, negato e contrastato attraverso quei termini stessi. Il carattere polemico domina soprattutto l’impiego linguistico dello stesso termine ‘politico’, sia che si qualifichi l’avversario come ‘non politico’ (nel senso di estraneo al mondo, carente sul piano concreto) sia invece che lo si voglia al contrario denunciare e squalificare come ‘politico’, al fine di sollevare poi sé stessi sopra di lui come ‘non politici’ (nel senso di puramente concreti, puramente scientifici, puramente morali, puramente giuridici, puramente estetici, puramente economici, o sulla base di analoghe purezze polemiche). In secondo luogo: nell’uso della polemica quotidiana all’interno dello Stato, ‘politico’ viene oggi spesso usato nello stesso senso di ‘politico-di partito’; l’inevitabile ‘mancanza di obbiettività’ di tutte le decisioni politiche ch è solo il riflesso della distinzione amico-nemico immanente ad ogni comportamento politico, si manifesta nelle forme e negli orizzonti meschini della conquista dei posti e delle prebende in base alla politica di partito: la necessità che in tal modo sorge di una ‘spoliticizzazione’ significa solo il superamento del ‘politico-di partito’, e così via” (C. Schmitt, Il concetto di ‘politico’, in Le categorie del ‘politico’, il Mulino, Bologna, 1972 (1932), pp. 109-115). Chi si rifà, anni più tardi, a Carl Schmitt è un altro studioso tedesco: Julien Freund. Vediamo la ricostruzione del suo pensiero nelle parole di Busino: “Lo scopo della politica è il raggiungimento della concordia all’interno e della sicurezza all’esterno. Ora, per imporre l’ordine all’interno, per difendersi contro i nemici reali e virtuali all’interno e all’esterno, la politica-potere deve necessariamente possedere il monopolio della coercizione incondizionata. La politica presuppone necessariamente: a) la relazione di comando e di obbedienza; b) la relazione di privato e di pubblico; c) la relazione di amico e di nemico. La relazione a) è unificatrice. Comandare significa decidere e fare eseguire gli ordini in maniera sovrana e assoluta. Poiché la politica non governa tutto l’uomo (vi sono anche l’economia, la religione, la morale, la scienza e l’arte), poiché governa una sola parte dell’attività umana globale – quella del settore pubblico – tutto ciò che non fa parte della protezione dei membri della collettività è dunque di pertinenza della relazione b), costituisce in altri termini il privato. E’ la specificità del privato che salva la libertà e permette di sfuggire al totalitarismo. La relazione c) sta ad indicare che c’è politica laddove c’è un nemico. Il caso più tipico di questa relazione è il conflitto bellico e tutti gli altri tipi di guerra. Violenza e inimicizia s’implicano reciprocamente. La politica è il luogo privilegiato dell’abuso del dominio dell’uomo sull’uomo. Il solo rimedio a queste situazioni di fatto è il ribaltamento della violenza, la sua sottomissione alla ragione mercé il diritto. Il conflitto è la rottura d’uno stato giuridico, positivo o naturale, d’un diritto scritto o non-scritto. Rompendo le regole e/o le convenzioni stabilite, il conflitto tenta di far valere un diritto leso o misconosciuto. Al centro stesso del conflitto c’è dunque un diritto. Per Freund il conflitto è un affrontamento tra due volontà, individuali o collettive, le quali manifestano l’una rispetto all’altra intenzioni ostili a causa d’un diritto. Appunto allo scopo di proteggere o d’ottenere questo diritto le parti in conflitto tentano di spezzare, eventualmente col ricorso alla violenza, la resistenza dell’altro. Gli antagonisti non sono degli avversari, bensì dei nemici; per questa ragione il conflitto non è mai né un gioco né una disputa. Nelle società moderne il diritto, per ragioni complesse, assolve sempre meno le sue funzioni. Perciò le cause dei conflitti sono sempre più numerose; perciò i conflitti sorgono simultaneamente in settori fra loto molto diversi e distanti. Regolarmente i fattori esterni d’ordine economico, sociale, ecc. si sovrappongono ai fattori interni d’ordine psicologico, morale, ideologico, religioso. A causa di queste confuse ed inestricabili sovrapposizioni, i conflitti appaiono fluttuanti, imprecisi, indeterminati, non suscettibili di specificazioni nette: poche sono le loro forme specifiche; la loro autoperpetuazione e capacità di metamorfosi sono invece notevolissime. La maggior parte delle crisi si trasforma in conflitti; non tutti i conflitti però possono risolversi, oppure essere superati e regolati mediante norme, convenzioni ed istituzioni. La simultaneità dei conflitti, l’aumento delle contraddizioni, delle discordie e delle incompatibilità, il fatto stesso che la società sia oggi divenuta il punto focale e l’oggetto stesso del conflitto, obbligano gli attori sociali a gestire la conflittualità, che è ormai impossibile mediare, a vivere nei conflitti e coi conflitti” (G. Busino, cit., pp. 773-774). Le teorie: i funzionalisti Con la teoria del conflitto come forza motrice del mutamento il filone sociologico prevalente negli anni ’60, era rappresentato dai teorici (funzionalisti) dell’equilibrio. Per Elton Mayo (ad esempio), lo stato normale di una società è rappresentato dall’equilibrato funzionamento del sistema, nel quale ogni attore (individuale o collettivo) e ogni istituzione hanno il loro posto e la loro funzione. Il tutto con modalità armoniche. E’ vero che nelle società industriali i vari gruppi che si formano hanno frequentemente un atteggiamento ostile l’uno verso l’altro. Ma ciò deriva da cause patologico-individuali (cioè da turbamenti psicologici di coloro che fanno esplodere questi conflitti) e, inoltre, può avere conseguenze negative, e portare quella società, se non riesce a trasformare l’ostilità in cooperazione, alla rovina (Mayo, 1945). Un secondo studioso (funzionalista) è Robert K. Merton, per il quale i conflitti esistono necessariamente, non sono cioè il prodotto di soggetti “malati”, ma sono “disfunzionali” al buon funzionamento armonico di una società in quanto diminuiscono l’adattamento del sistema, la sua integrazione. Esistono per Merton diversi modi o livelli di adattamento, alcuni dei quali sono “funzionali” e altri “disfunzionali”: “1. conformità, in quanto riconoscimento dei valori e mezzi vigenti; 2. innovazione, in quanto rifiuto dei mezzi istituzionali vigenti come norme culturali condivise, cioè ‘protestantesimo’ in senso stretto; 3. ritualismo, come mero conformismo esteriore ai mezzi socialmente prescritti, senza contemporaneo riconoscimento dei valori vigenti; 4. rifiuto o rinuncia tanto dei valori vigenti quanto dei mezzi istituzionali da parte di ‘veri e propri estranei’ della società (visionari, paria, reietti, mendicanti, vagabondi, drogati cronici); 5. ribellione. Ribellione e rinuncia non si distinguono affatto per la loro posizione rispetto al sistema dei fini e mezzi della società; la loro unica diversità consiste nel carattere socialmente attivo della ribellione”. Si potrebbe affermare, con Merton (1962 ?), che il primo e il terzo favoriscono l’equilibrio, il secondo l’adattamento del sistema ai mutamenti tecnologici o sociali, il quarto è curabile (come per Mayo), il quinto implica l’uso legittimo della forza e della violenza da parte delle istituzioni (politiche, cioè dello stato). Un terzo autore funzionalista, che però si discosta notevolmente dagli altri, è Lewis Coser, per il quale, rifacendosi a Simmel, i conflitti sociali possono essere distruttivi (disfunzionali) ma non sempre lo sono: “i conflitti possono servire a rimuovere gli elementi disgregatori di un rapporto ristabilendone così l’unità. Nella misura in cui il conflitto dissolve la tensione tra gli antagonisti, ha funzioni stabilizzatrici e diviene così una componente integratrice del rapporto. L’interdipendenza di gruppi antagonistici e l’incrociarsi dei conflitti che provocandone la vicendevole elisione contribuiscono a tenere insieme il sistema sociale, impediscono di conseguenza che si verifichi una frattura lungo un’unica linea di divisione” (L. Coser, 1967 (1956), p. 90). Ovvero, semplificando al massimo: se Tizio è conflittuale con Caio su un dato tema, e con Sempronio su un altro tema, e Caio è anch’esso conflittuale con Sempronio, allora i conflitti possono (o sono) integranti. Se Tizio e Caio si trovano sempre su fronti contrapposti allora si ha disfunzionalità. Ma vi è un altro elemento che per Coser ‘fa la differenza’ tra i vari conflitti: la maggiore o minore rigidità della struttura sociale nell’affrontare i conflitti: “Non tutti i sistemi sociali nei quali gli individui partecipano in modo non integrale alla vita dei gruppi permettono la libera espressione di rivendicazioni antagonistiche. Infatti i sistemi sociali tollerano o istituzionalizzano il conflitto in misura differente, e non c’è d’altra parte alcuna società nella quale sia consentita l’espressione immediata di ogni e qualsiasi rivendicazione antagonistica. Le società dispongono di meccanismi adatti a incanalare il malcontento e l’ostilità pur conservando intatto il rapporto nel cui ambito l’antagonismo sorge. Tali meccanismi di frequente operano per mezzo di istituzioni che funzionano come valvole di sicurezza, fornendo oggetti sostitutivi sui quali dirottare i sentimenti di ostilità, come pure mezzi di ‘abreazione’ di tendenze aggressive (…) Il nostro esame della distinzione fra tipi di conflitti, e fra tipi di strutture sociali, ci porta a concludere che il conflitto tende ad essere antifunzionale per una struttura sociale nella quale la tolleranza e l’istituzionalizzazione dei fenomeni conflittuali manchino completamente o siano insufficienti. L’intensità di un conflitto che minacci di avere effetti disgregatori, e che attacchi la base consensuale di un sistema sociale è in connessione con la rigidità della struttura. Ciò che minaccia l’equilibrio di una tale struttura non è il conflitto in quanto tale, ma la rigidità stessa la quale fa sì che i sentimenti ostili si accumulino e, scoppiato il conflitto, confluiscano a contrapporsi lungo una sola linea di frattura” (L. Coser, cit., pp. 177-178) Le teorie: Alain Touraine Complessa e articolata, ma anche complicata, è la teoria dei conflitti di Alain Touraine (1970 ?). Forse è più semplice e chiara la ricostruzione che ne fa Busino: “Nelle società d’oggi le cause e le ragioni dei conflitti sono generali: esse non risparmiano né la scienza, né la tecnica, né la vita privata. Certo, il conflitto primario è quello tra capitale e lavoro, tra governanti e governati; ma, data la compenetrazione fra Stato e mercato, date le nuove istituzioni ed i processi di controllo, una serie d’altri scontri, d’altri affrontamenti, d’altri conflitti agita lo spazio sociale. Il controllo sociale, senza il quale non è possibile né lo sfruttamento delle risorse naturali, né l’organizzazione stessa del lavoro, né, infine, l’accumulazioneinvestimento, è contestato globalmente da quegli attori che rifiutano il campo attuale dei rapporti di forza e mirano a procurarsi la padronanza delle funzioni sociali in senso lato, pubbliche e private. I conflitti attraversano tutti i settori della società; sono quindi multipli, simultanei ed addizionali, si organizzano e si esprimono contro apparati di dominazione sempre più integrati. La contestazione è fatta da attori che sono essenzialmente delle minoranze. Devianza e contestazione tendono a coincidere. Anzi, Touraine riduce i conflitti a marginalità e interpreta poi la marginalità in termini di conflitti., di lotta per il controllo della direzione del processo storico. Il conflitto è dappertutto, dal momento che ovunque esistono contraddizioni incompatibili fra gli orientamenti di coloro che dirigono e quelli di coloro che rifiutano questa direzione. La società è conflitto, è lotta di classe, affrontamento fra classi aventi orientamenti radicalmente opposti sugli investimenti, sui consumi, sulla divisione del prodotto sociale, sull’informazione, sulla nozione di bene comune, sulla vita quotidiana (…) Conflitto come creazione del nuovo e come libertà; conflitto come azione sociale creatrice di senso e di significati; conflitto come emergenza di nuovi orientamenti normativi attraverso i quali si costruisce e si costituisce l’esperienza creatrice e s’afferma la relazione tra l’uomo e le sue opere; conflitto come generatore di cambiamento e di mutamenti, di status nascenti e di nuovi valori? Nella sociologia o filosofia sociale di Alain Touraine il conflitto è tutto questo nello stesso tempo” (G. Busino, cit., p. 772) Le teorie: Ralf Dahrendorf Nel fondare la sua teoria del mutamento sociale (in contrapposizione con i funzionalisti teorici dell’equilibrio sociale), Dahrendorf sottolinea come “La grande forza creativa che porta avanti il mutamento è il conflitto sociale. Può essere sgradevole e conturbante il pensiero che esiste un conflitto dovunque troviamo vita sociale: ciò nondimeno è indispensabile per comprendere i problemi sociali (…) E’ sorprendente e anormale non già la presenza ma l’assenza di conflitti; e abbiamo buoni motivi di sospetto qundo troviamo una società o organizzazione sociale che, stando alle apparenze, non rivela nessun conflitto. Naturalmente, non dobbiamo assumere che i conflitti siano sempre violenti e incontrollati” (R. Dahrendorf, 1967, p. 221-222). Abbiamo qui una prima differenziazione tra tipi di conflitti, sulla quale si ritornerà più avanti: conflitti non violenti e conflitti violenti. Poco più avanti, Dahrendorf puntualizza un altro aspetto relativo alla presenza di conflitti nelle società: “Può essere considerato empiricamente ovvio che le società non siano affatto compagini armoniche ed equilibrate, ma rivelino sempre anche contrasti tra gruppi, valori ed aspettative inconciliabili. Il conflitto appare un dato sociale universale, forse anzi è addirittura un elemento indispensabile di ogni vita sociale” (ibidem, p. 227) Il punto da chiarire non è dunque se esistono i conflitti, ma quali sono le cause strutturali che fanno sì che i conflitti (sociali) siano dei fenomeni permanenti. Dahrendorf espone così la sua tesi: “La mia tesi è che il compito permanente, il significato e la conseguenza del conflitto sociale consistono nel mantenere e stimolare il mutamento di intere società e delle loro parti. Se si vuole, si potrebbe definire tutto ciò come la ‘funzione’ del conflitto sociale. Ma allora il concetto della funzione viene usato in un senso del tutto neutrale, vale a dire senza nessun riferimento e un ‘sistema’ rappresentato come equilibrato (…) I conflitti divengono comprensibili nelle loro ripercussioni e nel loro significato soltanto se li rapportiamo al processo storico delle società umane. Come fattore nel processo onnipresente del mutamento sociale, i conflitti sono profondamente necessari. Là dove essi mancano, e anche dove vengono soffocati o apparentemente risolti, il mutamento viene rallentato ed arrestato. Là dove i conflitti sono riconosciuti e regolati, il processo del mutamento viene conservato come sviluppo graduale. Ma nei conflitti sociali risiede sempre una notevole forza creatrice di società. Proprio perché vanno al di là delle condizioni ogni volta esistenti, i conflitti sono un elemento vitale della società, come del resto il conflitto in generale è un elemento della vita intera. Non è questa una tesi nuova. Marx e Sorel, proprio come prima di essi Kant ed Hegel e dopo di essi molti sociologi di tutti i paesi, fino ad Aron, Gluckman e Mills, hanno riconosciuto la fecondità dei conflitti sociali e individuato il loro riferimento al processo storico” (ibidem, p. 238). Circa le cause dei conflitti sociali, Dahrendorf sottolinea che: “L’esplosività di ruoli sociali contenenti aspettative contradditore, l’inconciliabilità delle norme vigenti, le differenze regionali e religiose, il sistema della disuguaglianza sociale e la barriera universale tra dominanti e dominati sono tutti elementi della struttura sociale che conducono di necessità a conflitti. Ma da tali conflitti promanano sempre energici impulsi sul ritmo, la radicalità e la direzione del mutamento sociale”. (ibidem, p. 239). Il contrasto con i funzionalisti non potrebbe essere più netto. E, infatti, Dahrendorf prima di esporre la sua teoria del conflitto, presenta i punti fondamentali della teoria del consenso. In questo modo: “La teoria del consenso, dell’integrazione sociale, che domina largamente la teoria sociologica funzionale, nella sua forma pura poggia sulle quattro ipotesi seguenti circa l’essenza delle società umane: 1) Ogni società è una compagine (‘relativamente’) stabile e duratura di elementi (ipotesi della stabilità). 2) Ogni società è una compagine bene equilibrata di elementi (ipotesi dell’equilibrio). 3) Ogni elemento di una società ha una funzione, cioè fornisce un contributo al suo funzionamento (ipotesi della funzionalità). 4) Ogni società si conserva grazie al consenso di tutti i suoi membri su determinati valori comuni (ipotesi del consenso). Contro tale orientamento, è pensabile una teoria della coercizione dell’integrazione sociale che parta da ipotesi diverse e magari opposte sulle società umane. Con una formulazione altrettanto approssimativa, si possono delineare queste ipotesi come segue: 1) Ogni società e ognuno dei suoi elementi sono soggetti in ogni periodo ad un processo di mutamento (ipotesi della storicità). 2) Ogni società è una compagine in sé contraddittoria ed esplosiva di elementi (ipotesi dell’esplosività). 3) Ogni elemento di una società fornisce un contributo al suo mutamento (ipotesi della disfunzionalità o produttività). 4) Ogni società si conserva mediante la coercizione esercitata da alcuni suoi membri su altri membri (ipotesi della costrizione).” (ibidem, pp. 256-257). A questo punto si tratta di passare alla parte costruttiva del discorso e, quindi, a precisare come arrivare a una teoria generale del conflitto: “Una teoria generale del conflitto sociale dovrebbe rispondere ai seguenti quesiti: 1) Che cosa si deve intendere in particolare per conflitto sociale, e quali tipi di conflitti possiamo distinguere nelle società storiche? 2) Con quale immagine della società i conflitti si rivelano all’intervento razionalizzatore della teoria scientifica? 3) Come possono essere determinate le situazioni strutturali di partenza di dati tipi di conflitto sociale? 4) In quale modo i conflitti sociali si sviluppano sullo sfondo di determinate relazioni sociali di struttura? Questo è il problema della formazione dei gruppi conflittuali e delle loro norme e, più in generale, della manifestazione dei conflitti sociali. 5) Quali sono le dimensioni della variabilità di dati tipi di conflitto sociale, e a quali condizioni le forme del conflitto variano in queste dimensioni? La risposta consente di comprendere la crescente e decrescente intensità e violenza dei conflitti sociali e quindi di determinare i punti in cui, almeno in linea di principio, sembra possibile intervenire per regolarli. 6) In quale modo si possono regolare i conflitti sociali? ”. (ibidem, pp. 247-248). In chiusura 1: le società liberali e le società totalitarie di fronte al conflitto “Che la classe dominante delle società totalitarie non veda affatto di buon occhio i conflitti sociali è comprensibile. Ogni dissidio interno minaccia la sua posizione di potere e viene perciò represso. Ma anche le società liberali di oggi non amano più il conflitto. Ciò è dimostrato già dallo stesso cambiamento di significato del termine ‘liberale’. Nell’era del primo capitalismo, questo termine indicava il riconoscimento dell’esistenza di interessi contrastanti nella società, mentre oggi anche i ‘liberali’ tollerano entro limiti assai ridotti le divergenze di opinione. Nel mondo attuale eterodiretto, la lotta per realizzare i propri interessi è considerata volgare. Nel conflitto, parecchi vedono perciò di preferenza non la propria realtà, ma il male altrui. In questo rifiuto dei conflitti sociali si cela quindi un doppio, fatale errore: chi considera il conflitto una malattia, misconosce del tutto la peculiarità delle società storiche; chi lo attribuisce in primo luogo ‘agli altri’, rivelando così di ritenere possibili società senza conflitti, consegna la realtà e la sua analisi a fantasticherie utopistiche. Ogni società ‘sana’, sicura di sé e dinamica conosce e ammette conflitti nella propria struttura; infatti la loro negazione ha conseguenze altrettanto gravi per la società quanto ne ha per il singolo la rimozione dei conflitti interiori: non chi parla di conflitto ma chi cerca di tacerlo corre il pericolo di perdere così la propria sicurezza”. (R. Dahrendorf, Uscire dall’utopia, il Mulino, Bologna, 1971 (1967), p. 245). Lo stesso Pizzorno tratta del problema del ruolo del conflitto nella concezione liberale dello stato. “La formazione di vaste unità statali centralizzate e l’erodersi delle identità e distinzioni territoriali tradizionali comportano un attenuarsi dei sentimenti di appartenenza collettiva. L’identià nazionale, che può essere intesa durante i momenti di formazione rivoluzionaria dello stato e durante i confronti col nemico, è sostenuta, nella quotidianità, da una ritualità troppo intermittente, poco intensa, facilmente disertabile, insufficiente quindi a soddisfare bisogni più circoscritti e continui di riconoscimento di identità e di costituzione di solidarietà. Proprio nel conflitto tra parti politiche durare – che i fondatori delle repubbliche democratiche avevano giudicato negativamente – sembrano invece ricostituirsi possibilità di riconoscimenti forti, quotidianamente ripetuti e quindi forme di solidarietà attiva che pur non essere i limiti costituzionali della solidarietà collettiva più ampia. Sembrerebbe quasi di poter suggerire che per capire il meccanismo dei rapporti tra individuo e collettività nelle società liberali, a quello che si rappresenta come il paradosso dei ‘visi privati, pubbliche virtù’ generato dalla concorrenza sul mercato, andrebbe aggiunto il paradosso degli ‘odi privati, pubblica amistade’ generato dalla competizione tra le parti politiche. Non quindi l’allargamento delle basi della rappresentanza, bensì la risposta positiva al bisogno di ricostituire solidarietà forti e vedere riconosciute le corrispondenti identità collettive, sarebbe alla base della dialettica associativo-competitiva nella concezione liberale dello stato” (A. Pizzorno, cit., pp. 193-194). In chiusura 2: La politica e i conflitti In gran parte sulla scia di Carl Schmitt, netto è il pensiero di Mario Tronti sul rapporto tra politica e conflitto: “La grande politica è questa: organizzare il conflitto senza scatenare la guerra. La piccola politica è quella: per amore di pace, annullare, comprimere, mascherare i conflitti. La piccola politica rende alla fine inutile, rende superflua, la politica. Senza conflitto, niente politica” (M. Tronti, La politica al tramonto, Einaudi, Torino, 1998, p. 47). Più recentemente, Chantal Mouffe ha sostenuto una tesi analoga, affermando che “le questioni squisitamente politiche comportano sempre decisioni che ci impongono di scegliere tra alternative in conflitto” (C. Mouffe, Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti, Bruno Mondadori, Milano, 2007 (2005), p. 11). Ovvero: negare il carattere ineliminabile dell’antagonismo in politica, nelle scelte, nelle valutazioni politiche, significa semplicemente negare la politica. Significa negare la natura pluralistica delle società, negare il pluralismo dei valori, delle prospettive: è impossibile pensare pluralismo senza conflitto. “Si può ritenere che la distinzione amico/nemico (di Carl Schmitt) sia solo una delle possibili forme di espressione della dimensione antagonistica costitutiva del politico. Pur ammettendo che la possibilità dell’antagonismo è sempre presente, possiamo anche immaginare altre modalità politiche di costruzione della demarcazione noi/loro. Se seguiamo questa strada, ci renderemo conto che per una politica democratica la sfida consiste nel cercare di mantenere entro certi argini l’emergere dell’antagonismo, istituendo in un modo diverso il rapporto noi/loro. Da queste riflessioni possiamo trarre una prima conclusione teorica. Possiamo affermare che la distinzione noi/loro, che è la condizione perché si possa formare un’identità politica, può sempre diventare il luogo dell’antagonismo. Poiché tutte le forme di identità politica implicano una distinzione noi/loro, ne consegue che la possibilità che emerga l’antagonismo è ineliminabile. E’ perciò un’illusione credere nell’avvento di una società dalla quale sia stato sradicato l’antagonismo (…) Uno dei compiti principali della politica democratica consiste nel disinnescare il potenziale antagonismo insito nei rapporti sociali. Se assumiamo che non lo si possa fare prescindendo dal rapporto noi/loro, ma solo strutturandolo in un modo diverso, allora si tratta di capire come si potrebbe configurare una forma ‘addomesticata’ di antagonismo, quale forma di rapporto noi/loro implicherebbe. Per essere accettato come legittimo, il conflitto deve assumere una forma che non distrugga l’associazione politica. Ciò significa che deve esistere tra le parti in lotta qualche genere di vincolo comune, in modo che gli oppositori non vengano trattati cone nemici da annientare in quanto fautori di posizioni illegittime, che è esattamente quello che accade nel rapporto antagonistico amico/nemico. In ogni caso, gli oppositori non possono essere visti come meri avversari i cui interessi possono essere trattati mediante un negoziato o composti attraverso la deliberazione, perché in questo caso l’elemento antagonistico sarebbe stato semplicemente eliminato. Se vogliamo riconoscere da un lato il permanere della dimensione antagonistica del conflitto, e dall’altro ammettere la possibilità del suo ‘addomesticamento’, dobbiamo prospettare un terzo tipo di relazione. Mentre l’antagonismo è una relazione noi/loro nella quale le due parti sono nemici che non condividono nessun terreno comune, l’agonismo è una relazione noi/loro nella quale le parti in conflitto, pur consapevoli che non esiste una soluzione razionale al loro conflitto, nondimeno riconoscono la legittimità dei loro oppositori. Ciò significa che, benché in conflitto, si considerano come appartenenti alla medesima associazione politica, come parti che condividono uno spazio simbolico comune entro il quale ha luogo il conflitto. Possiamo affermare che il compito della democrazia è di trasformare l’antagonismo in agonismo (…) La posta in gioco nella lotta agonistica è la configurazione stessa dei rapporti di potere intorno a cui una certa società è strutturata: è una lotta tra progetti egemonici che si contrappongono e che non possono essere conciliati razionalmente(…) L’approccio agonistico nega la possibilità di una politica democratica senza lotta fra avversari e critica coloro che, ignorando la dimensione del ‘politico’, riducono la politica a una serie di procedure neutrali e di presunte mosse tecniche” (C. Mouffe, cit., pp. 18, 22-24, 38). III.- Tipologie dei conflitti Innumerevoli sono le tipologie elaborate dai vari studiosi: a seconda delle variabili prese in considerazione possiamo avere diverse tipologie o classificazioni. In premessa: ogni tipologia costituisce una ‘semplificazione’ della realtà, e che, in ogni caso, i diversi conflitti ‘reali’ possono venire incasellati solo privilegiando un elemento, una componente di essi anche se altre componenti risultano presenti (in forma attenuata certo, ma pur tuttavia presenti). Una prima tipologia è stata fondata sul ‘perché’, inteso come scopo, dei conflitti: Conflitti di riconoscimento. “in essi una parte sociale ci appare entrare in conflitto essenzialmente allo scopo di imporre il riconoscimento di una sua identità distinta. Ci potrà essere consapevolezza più o meno chiara che questo sia ciò che si vuole. Sarà un conflitto che esclude, fino a che non sia concluso, ogni negoziato, o lo ammette solo se è strumentale alla conduzione della lotta. Per definizione l’identità non è negoziabile. Del resto, se gli altri accettano di negoziare con noi, già in qualche modo ci riconoscono, è già una vittoria. L’osservazione che precede permette di distinguere, entro tali ipi di conflitto, quelli in cui l’identità che si mira a fare riconoscere poggia su riferimenti che sono distinguibili prima e indipendentemente dal conflitto stesso: nazionali, etnici, linguistici, culturali in genere. E quelli, invece, in cui la comunanza fra gli appartenenti a un’unità collettiva è nata dal conflitto stesso, o, in genere, nell’azione collettiva in vista di un obiettivo.. In più di un caso, infatti, è attraverso il conflitto stesso che si mira a costituire un’identità collettiva. Può essere perché il movimento è ancora agli inizi e vuol farsi (ri)conoscere; o perché l’obiettivo è stato conseguito, ma si vuol capitalizzare la solidarietà formatasi nella lotta, e quindi far durare l’unità collettiva, e farne quindi riconoscere l’identità in quanto tale; oppure perché il movimento verso un un obiettivo si sta indebolendo e rischia di estinguersi, e la solidarietà va rinforzata con lotte fini a se stesse, cioè miranti a confermare e ravvivare il riconoscimento dell’identità. Dev’essere infatti chiaro che il riconoscimento di un’identità collettiva da parte degli esterni a essa serve a rafforzare il riconoscimento reciproco che gli appartenenti danno gli uni agli altri di essere portatori della stessa identità. L’evocazione, da parte di un governo, di minacce esterne, più o meno artificialmente esagerate, risponde alla stessa logica” (Pizzorno, cit., pp. 196197). Conflitti d’interesse. “In questi le parti appaiono mosse da obiettivi determinati comportanti benefici per i loro membri. Affinché tale tipo di conflitto sia possibile occorre ovviamente che le parti valorizzino gli stessi obiettivi. In questo caso vorrà dire che esse appartengono al medesimo sistema di relazioni entro il quale quegli obiettivi ricevono valore. Il conflitto si potrà quindi anche chiamare conflitto distributivo, e vittoria e sconfitta consisteranno essenzialmente in conquista o perdita di posizioni di potere relativo all’interno di un sistema. In questi conflitti potranno star di fronte o parti che si formano ad hoc, cioè in vista di un obiettivo specifico, e che si dissolvono una volta che i loro membri hanno ottenuto i benefici attesi, oppure ne hanno perso la speranza. O invece parti che hanno durata propria. Conflitti di questo tipo, infine, faranno parte, almeno potenzialmente di un universo pluralistico. Essi, cioè,non saranno esclusivi, non coinvolgeranno globalmente la persona, chi è parte in uno potrà essere anche parte in altri. I conflitti, come le appartenenze, si intersecheranno” (ibidem, p. 198). Conflitti ideologici. “Si tratta di una situazione conflittuale nella quale una, o entrambe le parti si presentano, per così dire, con presunzione universalistica. Si proclama, cioè, di avere di mira una situazione in cui tutti gli appartenenti al genere umano – in quanto persone spogliate dei loro ruoli e interessi singoli – possano, conoscendola nella sua verità, desiderare di trovarsi. Viene proposto un conflitto che è globalizzante, cioè coinvolgente la persona nella sua interezza, e in cui chi partecipa è convinto di essere portatore di una verità che deve valere per tutti. Da qui il tratto proprio di tale conflitto, il proselitismo. La volontà di proselitismo diventa connaturata con l’esser parte in un conflitto, quando questa parte è guidata da una teoria di come trasformare la realtà, e si fonda su tale teoria per convertire chiunque sia possibile convertire” (ivi). L’altra tipologia che vorrei qui ricordare è quella di Dahrendorf. Si tratta di una serie di classificazioni dall’insieme delle quali si possono ricavare più tipologie a seconda dell’intento dell’analista. Per Dahrendorf, i conflitti possono essere distinti in base a: - la loro evidenza, cioè in base al fatto che siano: solo latenti o già manifesti; - l’estensione: tra singoli ruoli sociali, all’interno di singoli gruppi, tra gruppi settoriali regionali o istituzionali, tra gruppi che abbracciano l’intera società, tra entità nazionali - la gerarchia degli attori: tra pari rango, tra superiori e inferiori, tra una parte e la totalità - la dimensione: intesa come grado di intensità o di partecipazione con una variazione da totalizzante a parziale; e come forme e grado di violenza (dalla discussione fino alla guerra) - la soluzione: soppressione, risoluzione, regolazione. Vediamo in particolare gli ultimi due elementi distintivi: la dimensione e la soluzione dei conflitti sociali. In merito al grado di intensità e alle forme della violenza, Dahrendorf chiarisce che: “La dimensione della violenza si riferisce alle forme in cui si manifestano i conflitti sociali. Vogliamo cioè alludere ai mezzi scelti dai partiti in lotta per fare valere i propri interessi. Delineiamo qui soltanto alcuni punti della scala della violenza che è possibile costruire. La guerra, la guerra civile, lo scontro generalmente armato con pericolo di vita per i partecipanti, indicano presumibilmente uno degli estremi; la discussione, il dibattito e la trattativa condotta pubblicamente con ogni correttezza da parte dei partecipanti, caratterizzano l’altro estremo. Nel mezzo troviamo un gran numero di forme più o meno violente di scontri tra gruppi: lo sciopero, la competizione, il dibattito aspro, il litigio, il tentativo di ingannarsi reciprocamente, la minaccia, l’ultimatum etc. I rapporti internazionali del dopoguerra offrono a sufficienza esempi di differenziazione della violenza dei conflitti, dallo ‘spirito di Ginevra’ alla ‘guerra fredda’ per Berlino fino alla ‘guerra calda’ in Corea. La dimensione dell’intensità si riferisce al grado di partecipazione degli interessati a determinati conflitti. L’intensità di un conflitto è grande se, per i partecipanti, molto dipende dal suo esito, cioè se i costi della sconfitta sono alti. Quanto maggiore importanza i partecipanti annettono ad uno scontro, tanto più esso è intenso. Anche qui, alcuni esempi possono meglio illustrare il concetto: lo scontro per la presidenza di una società di calcio può rivelarsi vivace e perfino violento; ma, di regola, per i partecipanti esso non ha la stessa importanza del conflitto tra imprenditori e sindacati (dal cui risultato dipende il livello del salario) o addirittura di quello tra ‘oriente’ e ‘occidente’ (dal cui risultato dipendono le possibilità di sopravvivenza). L’intensità indica pertanto sempre l’energia investita dai partecipanti, cioè il peso sociale di determinati conflitti. Ora, quindi, ci si deve chiedere: a quali condizioni i conflitti sociali acquistano una forma più o meno violenta, più o meno intensa? Quali fattori sono in grado di influenzare la violenza e l’intensità dei conflitti? Su che cosa si basa dunque la variabilità dei conflitti sociali rispetto alle dimensioni qui distinte? Un primo gruppo di fattori risulta dalle condizioni di organizzazione dei gruppi conflittuali e altresì dalla manifestazione di conflitti. Il pieno manifestarsi dei conflitti (è) già sempre un passo avanti per l’attenuazione delle loro forme. Molti scontri raggiungono poi il massimo d’intensità e violenza quando una delle parti interessate è capace di organizzarsi, cioè quando esistono le condizioni sociali e tecniche, ma tale organizzazione le è impedita, cioè quando mancano le condizioni politiche. Se ne possono fornire esempi storici tanto nel campo dei rapporti internazionali (guerra partigiana e di guerriglia) quanto in quello di conflitti interni alla società (scontri industriali prima del riconoscimento legale dei sindacati). Il più pericoloso è sempre il conflitto non del tutto individuabile, visibile solo a metà, che si esprime poi in esplosioni rivoluzionarie o quasi rivoluzionarie. Quanto all’intensità dei conflitti, più importante ancora sembra essere l’insieme dei fattori della mobilità sociale. Nella misura in cui la mobilità – e soprattutto tra le parti in lotta – è possibile, i conflitti perdono d’intensità, e viceversa. I conflitti nazionali acquistano d’intensità nella misura in cui le frontiere tra le nazioni vengono sbarrate (e, all’inverso, i viaggi mitigano l’intensità dei conflitti nazionali). Si può forse sostenere la tesi che i conflitti basati su posizioni di età e di sesso saranno sempre più intensi di quelli basati su posizioni occupazionali, oppure che gli scontri a carattere confessionale sono di regola più intensi di quelli a carattere regionale. Uno dei più importanti gruppi di fattori che possono influenzare l’intensità dei conflitti sta nella dimensione di ciò che si potrebbe impropriamente definire pluralismo sociale, e più esattamente sovrapposizione, oppure divisione di campi sociali di struttura. Ogni società conosce un gran numero di conflitti sociali. Questi – ad esempio quello tra confessioni, tra regioni, tra governanti e governati - possono presentarsi separatamente, cosicché le parti di ciascun conflitto singolo compaiono in quanto tali soltanto in esso; ma possono anche sovrapporsi, cosicché gli stessi fronti ricompaiono in conflitti diversi, vale a dire la confessione A, la regione Q, e i gruppi dominanti si fondono in un unico grande “partito”. In ogni società esiste una pluralità di ordinamenti istituzionali: stato ed economia, diritto ed esercito, scuola e chiesa. Questi ordinamenti possono del pari essere relativamente indipendenti tra loro, cosicché i gruppi dirigenti politici, economici, giuridici, militari, scolastici e religiosi hanno ciascuno una propria identità; ma anche qui è tuttavia possibile una certa sovrapposizione, grazie alla quale uno stesso gruppo dà il tono in tutti i campi. Dunque, nella misura in cui questi e analoghi fenomeni di sovrapposizione si presentano in una società, cresce l’intensità dei conflitti. Con la sovrapposizione di differenti settori sociali, ciascun conflitto equivale a una lotta per il tutto; chi voglia attuare qui un’esigenza in campo economico dovrà modificare nel contempo i rapporti politici di autorità. A questi tre fattori bisogna poi aggiungerne un altro, che si riferisce alla violenza dei conflitti sociali: quello della regolazione dei conflitti”. (R. Dahrendorf, cit., pp. 267-270). Infine, in merito alle forme di “controllo” dei conflitti sociali, Dahrendorf sottolinea come si abbiano, storicamente, tre posizioni: 1) La soppressione del conflitto. “La soppressione è un modo non soltanto immorale ma inefficace di trattare i conflitti sociali. Nella misura in cui si cerca di sopprimere i conflitti sociali, si accresce la loro virulenza potenziale, rendendo così necessaria una repressione ancor più violenta. Il metodo della soppressione non può dominare i conflitti sociali. 2) Risoluzione del conflitto. Per “risoluzione” dei conflitti si deve intendere qui ogni tentativo di eliminare i contrasti alle radici. Ma anche questo tentativo è sempre fallito. 3) Regolazione dei conflitti. E’ il mezzo decisivo per attenuare la violenza di quasi tutti i tipi di conflitti. Con la regolazione i conflitti invero non scompaiono; neppure divengono necessariamente meno intensi; ma nella misura in cui si riesce a regolarli, diventano controllabili e la loro forza creativa viene posta al servizio di un graduale sviluppo delle strutture sociali. La regolazione efficace dei conflitti ha comunque una serie di presupposti. Tra di essi vi sono: a. Il fatto che conflitti in generale come pure singoli contrasti, vengano riconosciuti inevitabili, anzi legittimi e opportuni da tutti i partecipanti; b. Che qualsiasi intervento nei conflitti si limita alla regolazione delle sue forme e rinunzia al vano tentativo di eliminarne le cause; c. Quando determinati scontri vengono canalizzati secondo procedure obbligate; d. Che i partecipanti si accordino su determinate ‘regole del gioco’, secondo le quali intendono decidere i loro conflitti.” (R. Dahrendorf, 1971 (1967), pp. 271-273). IV.- I conflitti violenti Che cosa si intende per violenza: alcune definizioni Secondo i vari studiosi che si sono occupati, nelle rispettive discipline, di violenza, ci troviamo di fronte a un fenomeno e a un concetto estremamente ambiguo e anch’esso da “storicizzare”, ovvero da inserire nel contesto storico (o se si preferisce: nel periodo storico) al quale si applica. Vediamo innanzitutto alcune definizioni. “Come molte cose, la violenza è fondamentalmente ambigua in tutti i suoi aspetti, e implica tendenze funzionali e disfunzionali, suscettibili di risultati positivi e negativi. Dal punto di vista di chi la commette, qualsiasi violenza è una reazione, una fuga; è il desiderio di aprirsi combattendo la strada per uscire dalla trappola. La violenza non è solamente l’estrema risorsa disponibile nello spettro della contrattazione, ma è anche una potenzialità o una minaccia che di fatto cambia la stessa equazione di contrattazione. In un certo senso essa rappresenta la prova ultima, senza appello, della vitalità dei valori e delle forme di agire tradizionali. Le definizioni sono gli elementi primi del ragionamento e della discussione. Esse contengono sempre elementi di arbitrio e di tautologia. Per di più, in virtù di un processo di limitazione e di selezione, le definizioni predeterminano frequentemente la formulazione dei problemi e quindi ne contengono in nuce tutta la discussione e le sue conclusioni”. (H.L. Nieburg, La violenza politica, Guida, Napoli, 1974 (1969), pp. 11-13). “Chiameremo violenza ogni costrizione di natura fisica o psichica che porti con sé il terrore, la fuga, la disgrazia, la sofferenza o la morte di un essere animato; o ancora qualunque atto intrusivo che ha come effetto volontario o involontario l’espropriazione dell’altro, il danno o la distruzione di oggetti inanimati. Alcune violenze si presentano come legittime: sono quelle della legge e delle pene communate a coloro che la violano; a seconda della loro natura e diversità, queste violenze pongono la questione delle condizioni di legittimità della ribellione e della insubordinazione” (F. Heritier, Prefazione a Sulla violenza, Meltemi, Roma, 1997 (1996), p. 13). La violenza politica “contiene la distinzione tra forza autorizzata e forza non autorizzata, la prima come violenza perpetrata dall’autorità, la seconda come espressione della sfida rivolta all’autorità. La forza autorizzata consiste in violenza innovativa, legiferante, e può essere fondativi, quando per esempio stabilisce nuobi sistemi e designa nuove autorità. Ma può anche presentarsi come violenza di pura conservazione, quando protegge la stabilità dei sistemi e rafforza l’autorità costituita. Entrambi questi tipi di violenza verranno definiti violenza istituzionale (o violenza dall’alto). Userò il termine violenza antistituzionale (o violenza dal basso) per designare la forza non autorizzata rivolta contro l’autorità” (V. Ruggiero, La violenza politica, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. V). Alcune teorie sulla violenza “Una prima corrente di pensiero è centrata sulla tematica dell’ordine e della pacificazione sociale, sulla necessità di garantire che la libertà individuale non sfoci in abusi e in forme di violenza negative per la collettività, sulla fiducia o meno che questo sia possibile senza introdurre nuove forme di violenza legittimata e istituzionalizzata. Una seconda corrente orienta i suoi interessi allo studio del legame tra il concetto di violenza e quello di potere, rappresentando una visione forse più pessimistica riguardo al ruolo della violenza nelle relazioni umane e introducendo continuamente il sospetto che questa si nasconda tra le pieghe delle interazioni sociali. Una terza corrente di pensiero è legata soprattutto alle teorie contemporanee centrate sull’etica, il rispetto dell’alterità e della differenza come alternativa alla violenza, vicine quindi a una prospettiva di rispetto dell’Altro nell’ambito della relazione, specie di quella tra identità collettive differenti” (P. Rebughini, cit., p. 9). Ancora una volta si parte da Thomas Hobbes, per il quale: “La violenza è una risorsa importante a disposizione degli esseri umani nello stato di natura, uno stato dove ci si imbatte nelle ‘tre principali cause di contesa’, competizione, diffidenza e gloria, che motivano rispettivamente la ricerca di guadagno, sicurezza e reputazione. La prospettiva del guadagno, secondo Hobbes, spinge a impadronirsi delle mogli, dei bambini e del bestiame degli altri; la diffidenza impone di difendere le proprie cose dal prossimo; la reputazione, infine, scatena battaglie innescate da un nulla, una parola, un sorriso, un’opinione diversa o qualsiasi altro segnale irrispettoso diretto alla persona o a individui contigui, agli amici, al proprio paese o alla propria professione (V. Ruggiero, cit., pp. 5-6). Per Bentham si tratta innanzitutto di distinguere tra violenza e violenza, ovvero è necessario partire dai “reati” per arrivare ai diversi tipi di violenza: “Nella sua suddivisione dei reati Bentham chiarisce come la violenza politica vada classificata: vi sono crimini privati, semipubblici, autocentrati e pubblici. I primi offendono, in prima istanza, persone specifiche diverse da chi li commette. Abbiamo un esempio del secondo tipo quando vi sono persone che vengono danneggiate dal reato, ma che non sono singolarmente individuabili; i crimini sono perciò semipubblici quando colpiscono un vicinato o una comunità limitata. I crimini autocentrati sono, in primo luogo, di detrimento a chi li commette; infine, i crimini pubblici minacciano una ‘moltitudine indefinita’, una schiera di individui che compongono una comunità, anche se nessuno di loro può dirsi maggiormente colpito rispetto ad altri. Questi ultimi possono anche definirsi ‘crimini contro lo Stato’. Bentham riesce a estromettere la violenza di Stato da questa sua analisi, in maniera da associare la violenza politica esclusivamente ai ‘crimini contro i governi’. Mentre Beccaria cerca di persuadere le autorità a temperare il grado, o perlomeno la visibilità, della violenza autorizzata. Bentham sembra suggerire che tale violenza vada nascosta e allo stesso tempo che i criminali vengano resi più visibili. Da qui la sua idea del Panopticon” (V. Ruggiero, cit., p. 17). Un terzo autore da prendere in considerazione è Durkheim che introduce il problema del rapporto tra forza e diritto: “la religione, il nazionalismo e le convinzioni politiche particolarmente ferree generano violenza e omicidio. Più si ama lo Stato meno si amano gli esseri umani. Certo, Durkheim sottolinea anche che la forza è compagna inseparabile della legge, la seconda avendo incorporato lentamente la prima e originariamente, secondo questa ipotesi, la legge non è altro che forza capace di limitarsi per il proprio stesso interesse. Nel mondo fisico delle società arcaiche, allorché due forze collidono, il conflitto si conclude soltanto quando la parte più debole viene distrutta. ‘Ma non ci è voluto molto per rendersi conto che era più economico rinunciare alla completa distruzione dell’avversario’ (Durkheim, 1993: 85). Nelle società moderne, al contrario, la forza è solo l’ausiliaria, la serva del diritto; può accadere tuttavia che l’uso della forza, anziché sottomettersi ai limiti imposti dal diritto, distrugga quest’ultimo e ne crei uno totalmente nuovo: ‘Questo è quanto accade nei colpi di stato o nelle rivoluzioni; e questo uso della forza non può essere condannato sistematicamente, in nome di principi astratti. La legge non è qualcosa di sacro in se stessa; è solo un mezzo per raggiungere un fine. Ha valore solo se assolve alla propria funzione, cioè se assicura la vita della società. Cosa succede altrimenti? Diventa quasi naturale che la forza intervenga e rioccupi il posto che occupava in passato’ (ivi: 8586)” (V. Ruggiero, cit., pp. 70-71). Discorso più complesso e più ampio è quello svolto da Norbert Elias per il quale la violenza è un sintomo (effetto? causa?) della crisi del processo di civilizzazione: “Il processo di civilizzazione consiste, da un lato, nel progressivo emergere di uno Stato nazionale capace di garantire l’ordine interno e il monopolio della violenza e, dall’altro, nell’affermarsi delle ‘buone maniere’, ovvero di una generale attenuazione della violenza istintiva, di un progressivo nascondersi del lato oscuro dell’uomo. Elias si ricollega agli autori classici per identificare la violenza nel risultato degli istinti e delle passioni: civilizzazione e razionalizzazione portano alla capacità di controllare le reazioni emozionali, pulsionali e affettive, diminuendo le possibilità dell’esercizio della violenza individuale, mentre la creazione di uno Stato sovrano impedisce il verificarsi di una violenza anarchica di tutti contro tutti. La socializzazione alle buone maniere è dunque il principale antidoto alla violenza e garanzia per la pacificazione della società, anche se il progressivo affermarsi della civiltà non viene spiegato da Elias come un processo evolutivo limpido e inesorabile, ma al contrario come un movimento costellato di inversioni e retromarce” (P. Rebughini, cit., pp. 60-61). Per chiudere questa breve e parzialissima carrellata su alcune analisi della violenza, vediamo il contributo di Hannah Arendt innanzitutto ricordando che Arendt “si dichiarò a più riprese nettamente contraria alle giustificazioni della violenza rivendicativa, avanzate da altri autori suoi contemporanei, come ad esempio Sartre e Fanon. Per Arendt la violenza, qualunque sia il suo scopo o la sua giustificazione, segna il limite e la fine della politica” (P. Rebughini, cit., p. 57). Vediamo in modo più approfondito, quanto sosteneva la studiosa. “Credo che sia piuttosto triste constatare che la nostra terminologia non fa distinzione fra certe parole chiave come ‘potere’, ‘potenza’, ‘forza’, ‘autorità’ e, infine, ‘violenza’, ciascuna delle quali si riferisce a fenomeni diversi e distinti. Dietro la confusione apparente c’è un fermo convincimento alla luce del quale tutte le distinzioni avrebbero, nel migliore dei casi, un’importanza relativa. La convinzione che l’aspetto politico più sostanziale è, ed è sempre stato, la domanda: chi comanda a chi? Potere, potenza, forza, autorità, violenza non sono altro che parole per indicare i mezzi attraverso i quali l’uomo domina sull’uomo. E’ soltanto dopo che si sarà rinunciato a ridurre gli affari pubblici all’esercizio del dominio che i dati originali nel campo degli affari umani appariranno o, piuttosto, riappariranno, nella loro autentica diversità. Questi dati, nel nostro contesto, possono essere enumerati come segue: - Potere corrisponde alla capacità umana non solo di agire ma di agire di concerto. Il potere non è mai proprietà di un individuo; appartiene a un gruppo e continua a esistere soltanto finché il gruppo rimane unito. Quando diciamo di qualcuno che è ‘al potere’, in effetti ci riferiamo al fatto che è stato messo al potere da un certo numero di persone per agire in loro nome. – Potenza indica in modo inequivocabile qualcosa al singolare, un’entità individuale; è una proprietà inerente a un oggetto o a una persona e appartiene al suo carattere, che può dar prova di sé in rapporto ad altre cose o persone, ma è sostanzialmente indipendente da esse. – La forza, che spesso nel linguaggio quotidiano usiamo come sinonimo di violenza, specialmente se la violenza serve da strumento di coercizione, dovrebbe essere riservata, a rigor di termini, per le ‘forze della natura’ o la ‘forza delle circostanze’ (la force des choses), cioè per indicare l’energia sprigionata da movimenti fisici o sociali. – L’autorità, che si riferisce al più inafferrabile di questi fenomeni e che quindi, in quanto termine, è quello più frequentemente usato a sproposito, può risiedere nelle persone – c’è una cosa come l’autorità personale, per esempio nel rapporto fra genitore e figlio, fra insegnante e allievo – oppure può risiedere in cariche, come, per esempio, nel Senato romano (auctoritas in senatu) oppure nelle funzioni gerarchico della Chiesa (un prete può impartire un’assoluzione valida anche se è ubriaco). La sua caratteristica specifica è il riconoscimento indiscusso da parte di coloro cui si chiede di obbedire; non ci vuole né coercizione né persuasione. – La violenza, infine, si distingue per il suo carattere strumentale. Fenomenologicamente, è vicina alla forza individuale, dato che gli strumenti di violenza, come tutti gli altri strumenti, sono creati e usati allo scopo di moltiplicare la forza naturale finché, nell’ultimo stadio del loro sviluppo, possono prendere il suo posto (…) Bisogna ammettere che si è particolarmente tentati di pensare al potere in termini di comando e obbedienza, e quindi di mettere sullo stesso piano il potere e la violenza. Dato che nei rapporti con l’estero come negli affari interni la violenza appare come l’ultima risorsa per mantenere intatta la struttura di potere (di governo) contro singoli sfidanti – il nemico straniero, il criminale locale -, sembra in effetti che la violenza sia un prerequisito del potere e il potere nient’altro che una facciata, il guanto di velluto che o nasconde il pugno di ferro oppure si rivela come appartenente a una tigre di carta. A un esame più attento, però, questo concetto perde gran parte della sua plausibilità (…) Un governo basato esclusivamente sui mezzi di violenza non è mai esistito. Anche un dittatore totalitario, il cui principale strumento di violenza è la tortura, ha bisogno di una base di potere: la polizia segreta e la sua rete di informatori. Perfino la dominazione più dispotica che conosciamo, il dominio del padrone sugli schiavi, che erano sempre numericamente superiori a lui, non si basava su superiori mezzi di coercizione in quanto tali, ma su una superiore organizzazione del potere, cioè sulla solidarietà organizzata dei padroni. Gli uomini soli senza appoggio di altri non hanno mai potere a sufficienza per usare la violenza con successo. Quindi, negli affari interni, la violenza funge da ultima risorsa del potere contro i criminali o i ribelli, cioè contro i singoli individui i quali, in quanto tali, rifiutano di farsi sopraffare dal consenso della maggioranza (…) Il potere non ha bisogno di giustificazione, essendo inerente all’esistenza stessa delle comunità politiche; quello che invece gli serve è la legittimazione. Il fatto che comunemente queste due parole siano trattate come sinonimi non è meno fuorviante e ingannevole dell’equazione che si fa di solito fra obbedienza e sostegno. Il potere emerge ogni volta che la gente si unisce e agisce di concerto, ma deriva la sua legittimazione dal fatto iniziale di trovarsi assieme piuttosto che da qualche azione che ne può in seguito derivare. La legittimazione, quando è messa in discussione, si basa su un appello al passato, mentre la giustificazione è in rapporto con un fine che sta nel futuro. La violenza può essere giustificabile, ma non sarà mai legittimata. La sua giustificazione perde di plausibilità quanto più il fine ricercato si allontana nel futuro. Nessuno mette in discussione l’uso della violenza nell’autodifesa, perché il pericolo non solo è chiaro ma è anche presente, e il fine che giustifica il mezzo è immediato” (H. Arendt, Sulla violenza, Guanda, Parma, 1996 (1969), pp. 39-47 passim). Potere, autorità, forza, violenza “In termini umani, al livello bruto degli interventi fisici, il potere consiste nella capacità dell’uomo di imprigionare, deportare, immobilizzare, ledere o distruggere un proprio simile. Il crudo potere fisico diventa funzionale e legittimo nelle mani di una qualche autorità centrale, trasformandosi in strumento per assicurare la sicurezza interna ed esterna del gruppo. Possiamo considerare la forza come la disponibilità di riserva e il mezzo dell’esercizio del potere fisico. In una società stabile e ordinata, il possesso e l’impiego della forza da parte dei privati devono aver scopo puramente difensivo, così come il suo possesso e uso da parte dello stato deve essere esplicitamente finalizzato al sostegno dell’autorità di persuadere, prevenire e costringere di cui il sistema dispone. La forza dunque equivale a una minaccia di violenza o di contro-violenza. La violenza, se effettivamente esercitata, può costituire tutt’al più una dimostrazione di forza, un atto simbolico e limitato compiuto al fine di conferire all’efficacia e alla risolutezza delle azioni successive abbastanza credibilità da provocare dissuasione o conformità con costi e rischi minimi e con un residuo di paura e di resistenza ridotto al minimo. La violenza può essere definita senza mezzi termini come la forma più diretta e brutale di potere fisico. E’ la forza in azione. Esercitarla (sia lo stato a farlo, oppure gruppi di privati cittadini, o individui singoli) significa proseguire una contrattazione iniziata con strumenti di pressione diversi. Tutte le forme ‘morbide’, indirette e politicamente socializzate di potere vengono spazzate via. La minaccia della forza si fa azione, prendendo gradualmente le distanze dai comportamenti puramente dimostrativi (che sottintendono la volontà di proseguire il rapporto di contrattazione), per giungere infine al confronto diretto del rispettivo potere, attuato per mezzo di aggressioni e difese reciproche. Le formulazioni (delle definizioni di violenza e forza) che fanno leva sulla distinzione tra capacità, minaccia e dimostrazione sono applicabili ad una gamma di situazioni vasta e di conseguenza proficue. La forza equivale alla capacità e alla minaccia di agire; la violenza equivale a una dimostrazione di forza tendente ad una controdimostrazione e a nuovi atti di forza, o al contenimento e alla composizione della crisi. In tal modo, forza e violenza si mescolano impercettibilmente. La dimostrazione effettiva (forza in azione) deve ripetersi di tanto in tanto per dare credibilità alla minaccia del suo impiego; per questa via la minaccia acquista efficacia come strumento di trasformazione o di controllo sociale e politico. (Quindi) si può formulare la seguente definizione di violenza politica: atti di disgregazione, distruzione e offesa tali che il loro scopo, la loro scelta degli obiettivi o delle vittime, la loro esecuzione e/o i loro effetti abbiano rilevanza politica, cioè tendano a modificare il comportamento di terzi in una situazione di contrattazione che abbia conseguenze per il sistema sociale”. (H.L. Nieburg, cit., pp. 15-19). Forza e violenza “Nel linguaggio di tutti i giorni generalmente si intende con il concetto di forza un attributo tendenzialmente neutro che può essere utilizzato in modo negativo o in modo virtuoso; la violenza, invece, si distingue solitamente dalla forza perché, sebbene possa essere occasionalmente giustificata, non è mai veramente legittima. Nel caso della forza che ‘si impone’, questo termine è più volentieri utilizzato per definire chi interviene in modo legittimo, o con uno scopo che si presenta positivo, per esempio per ristabilire l’ordine. La violenza viene invece percepita essenzialmente in modo negativo, come atto arbitrario e non dialogico, come atto illegittimo di forza che si impone sul più debole. L’accostamento tra forza e violenza tende quindi a distinguere tra la legittimità della forza e l’illegittimità della violenza, per definizione mai considerata quest’ultima come un comportamento moralmente accettabile, anche se in alcuni casi viene invocata quale male necessario” (P. Rebughini, cit., pp. 13-14) “Legge e Ordine” “l’aspirazione al binomio ‘legge e ordine’, nella sua accezione più popolare, rappresenta il desiderio di ritorno al passato. L’ignoranza della normale dinamica della violenza politica ha provocato in noi uno stato di trauma e di allarme che, se non è giustificato dal reale pericolo, non è neppure giovevole per stornarlo. La popolazione, nella grande maggioranza, approva che si spari per strada sull’adolescente sorpreso a saccheggiare; essa aborre gli agitatori, i comunisti, i criminali, e persino gli individui che fanno realmente del loro meglio per curare alle radici i mali della società. Essa aborre tutto e tutti, tranne se stessa. Il motto ‘legge e ordine’ diventa uno slogan che incita a reprimere l’estremismo acutizzando il conflitto, invece che eliminandone le cause”. (H.L. Nieburg, cit., pp. 6-7). Le forme della violenza Abbiamo già visto come una delle principali distinzioni delle forme della violenza si rifaccia al soggetto (attore) che la pone in essere, ovvero all’esistenza di una legittimazione dell’uso della forza e anche della violenza. Si è parlato di violenza istituzionale e di violenza anti-istituzionale a seconda che questa sia posta in essere dallo Stato (unico soggetto, per la sua stessa natura, legittimato all’uso della violenza “pubblica” al fine di ridurre o annullare la violenza “privata”) oppure da soggetti “privati” (violenza tra “privati”, violenza di privati contro l’attore pubblico). Oltre alla violenza (decisa dall’alto) della guerra e del genocidio, alla violenza del terrorismo, la violenza “si può verificare anche a un livello sociale e politico diffuso senza intenti strumentali di ampio raggio, ma al contrario miranti al contesto di appartenenza o a scopi di tipo lucrativo. Rivolte urbane, risse, banditismo, rapine, furti e, per alcuni aspetti, la stessa criminalità organizzata costituiscono una costellazione di comportamenti a cui viene implicitamente riconosciuta una componente violenta” (P. Rebughini, cit., p. 38). La violenza istituzionale o “pubblica” (o dello Stato) può essere utilizzata, come abbiamo già visto, o a fini interni (al fine di far rispettare le regole, per il mantenimento dell’ordine, per reprimere tentativi sovversivi dell’ordine esistente o di singole parti di quest’ordine) oppure a fini esterni (per consolidare o ampliare i confini di un dato sistema politico, per garantire la “sicurezza” di quel dato sistema). In merito a quest’ultima Thomas Schelling distingue tra forza bruta (ad esempio: la guerra) da un lato e violenza coercitiva o diplomazia della violenza, dall’altro. Per quanto riguarda la violenza anti-istituzionale una prima distinzione estremamente semplice può essere la seguente: - protesta; - ribellione o rivolta; - guerra (v. oltre). Christopher Clapham (African Guerrillas, James Currey, Oxford, 1997, pp. 67) distingue, in base alle finalità, tra 4 tipi diversi di insurrezione: - per ottenere l’indipendenza - per ottenere il riconoscimento di una ‘identità’ (separatiste) - per la riforma radicale del sistema - per il cambio della leadership. Guardando, invece, alle cause, Clapham ne individua 5: - blocco delle aspirazioni (nessun spazio per la ‘voice’) - disperazione - resistenza nelle periferie alla centralizzazione (es. tasse) - struttura dei valori della società - debolezza dello stato - tradizione antica localistica e violenta Dalla potesta alla guerra Una tipologia delle varie forme di violenza è quella proposta da HARVARD che distingue tra 7 livelli o tipi in base a 10 variabili o indicatori: ampiezza dei soggetti attivi, ampiezza del territorio interessato, durata del conflitto, tipi di bersagli, finalità, risorse utilizzate, popolazione coinvolta, numero delle vittime (morti), tecnologie usate, effetti prodotti. Semplificandola si può prendere in considerazione quanto illustrato dalla tavola che segue. Categorie Definizione 1 2 Violenza politica sporadica Violenza politica limitata Territorio Durata Luogo preciso Tempo definito Persone interessate Vittime (morti) Tecnologie Poche per brevi periodi meno di 2 mila basso livello da 3 mila e 10 mila limitate Aree precise Brevi periodi Poche o numerose 3 Violenza politica grave Aree anche vaste A intermittenza Decine di migliaia da 10 mila a anche armi di 50 mila distruzione 4 Guerra grave Aree anche estese Limitata più di 100 mila armi di da 50 mila a distruzione di 100 mila basso livello 5 Guerra prolungata Alcune regioni Lunga più di 1 milione 6 Guerra estesa Indenni solo le aree cruciali Lunga più di 2 milioni 7 Guerra dilagante Tutto Lunga più di 5 milioni armi di da 100 mila a distruzione 500 mila anche di alto livello esteso uso di armi di da 500 mila a distruzione 1 milione aiuti esterni limitati esteso uso di armi di più di 1 distruzione milione aiuti esterni necessari e non limitati Per quanto riguarda le guerre, la individuazione più classica dei caratteri distintivi di queste, è quella operata da Bouthoul: “Siccome le forme di lotta e di competizione sono innumerevoli, proprio per questo il concetto di guerra deve essere chiaramente circoscritto e definito in confronto a tutte le forme di antagonismo conosciute o concepibili. Quali dunque saranno le principali caratteristiche che ci permetteranno di delimitare in modo preciso il ‘fenomeno guerra’? Anzitutto, il carattere che più ci colpisce è quello di essere un fenomeno collettivo. In questo senso la guerra deve essere nettamente distinta e separata da tutti gli altri atti di violenza individuale. Come possiamo determinare con esattezza questo carattere collettivo della guerra? Dovremo prendere in considerazione due elementi: uno è la natura del gruppo e cioè, per essere più precisi, della collettività che combatte, e l’altro è l’elemento soggettivo e cioè l’intenzionalità o, in altre parole, le finalità e gli scopi che perseguono quelli che hanno scatenato la guerra. Saremo costretti ad attenerci a un criterio molto elastico per quel che riguarda l’estensione dei gruppi che si affrontano in una guerra. Possono essere gruppi giganteschi ma possono anche essere gruppi minuscoli, senza che le loro lotte armate perdano perciò il carattere di guerra propriamente detta. Saremo costretti a dare una certa importanza anche al fattore soggettivo. Le finalità della guerra si distinguono da quelle del delitto e della violenza individuale. La guerra è a servizio degli interessi di un gruppo politico, il delitto e la violenza individuale non hanno in vista che l’interesse privato. Un altro carattere oggettivo della guerra è che essa consiste in una lotta a mano armata. Il fatto che essa sia molto o invece poco micidiale ha scarsa importanza. Un altro carattere della guerra è quello giuridico. Si è potuto dire che la guerra è un contratto. La guerra, non ci sono dubbi, è un atto di violenza, di violenza però organizzata. Ogni guerra ha un principio e una fine che in generale sono accompagnati da cerimonie o da solennità che hanno lo scopo di dare risalto in modo impressionante al passaggio dalla pace alla guerra o viceversa. Come hanno messo in evidenza parecchi scrittori, la guerra non è un combattimento perpetuo e una battaglia senza interruzione, è semplicemente lo stato di guerra, cioè essa è, in ultima analisi, un periodo durante il quale vengono applicate alcune regole che hanno valore giuridico e che sono di natura particolare. La seconda caratteristica giuridica della guerra è che essa consiste in un vero processo destinato a metter fine a una controversia, i cui motivi sono precedentemente indicati con esattezza” (G. Bouthoul, Le guerre. Elementi di polemologia, Longanesi, Milano, 1961 (1951), pp. 37-45 passim). Bonanate propone una ideale tavola classificatoria organizzata per genus e per species “ricorrendo alle forme che le guerre hanno assunto, alle modalità con cui sono state combattute e agli obiettivi che ciascuna di esse si pone: Tipi di guerre. La prima – e più elementare – distinzione da operare riguarda i soggetti coinvolti in un conflitto: può trattarsi di stati, ma anche di gruppi, cosicché distingueremo la guerra internazionale da quella interna (o civile, intestina). Entrambi i casi consentono una duplice manifestazione. Nel primo, potremo infatti avere sia una guerra diadica, cioè combattuta tra due stati, sia una guerra coalizionale, e quindi combattuta da due insiemi di stati alleatisi per la circostanza. Nel secondo caso, potremo avere una guerra partigiana, quando delle fazioni si scontrino tra loro in una condizione di totale assenza o dissoluzione di un’autorità centrale; e una guerra internazionalizzata, quando le parti in lotta mirino alla separazione e alla costituzione di nuove entità sovrane. Modi di combattere una guerra. Anche da questo punto di vista, alcune grandi distinzioni consentono di riassumere un più ampio insieme di casi; distingueremo innanzi tutto guerre regolari, ovvero combattute secondo comuni e condivise regole, ricorrendo prevalentemente ad apparati militari specialistici, e guerre irregolari, tra le quali rientreranno tutti quei casi che vedono il ricorso a strumenti anomali, come la guerra di corsa o per bande, o quella che più in generale chiamiamo “guerriglia”, ma anche come la guerra chimica o batteriologica. Si daranno, d’altro canto, guerre convenzionali, ovvero combattute con armi e strumenti di comune conoscenza, e guerre non-convenzionali (come quella atomica), in cui una o entrambe le parti ripongono in una qualche grande scoperta (prevalentemente tecnologica) le loro speranze di vittoria. Sia le une sia le altre potranno a loro volta essere classificate anche in base alle modalità delle operazioni militari, dando luogo alla guerra di movimento o a quella di posizione. Fini di guerra. Entriamo in questo caso in un ambito molto complesso e ricco, appartenendo a esso tanto la guerra di conquista quanto quella di liberazione (o di indipendenza); la guerra dinastica (o di successione) e la guerra di religione, la guerra rivoluzionaria e la guerra di difesa. Dimensioni della guerra. Ma anche una volta classificati quelli che risultano essere i principali modelli storicamente verificabili, la nostra capacità di dominare la complessità del fenomeno non è ancora granché cresciuta. Grandi o piccole, le guerre saranno tutte uguali? Quale, ad esempio, la differenza tra una scaramuccia di truppe lungo un confine e un conflitto protratto nel tempo? Potremo forse fare riferimento alle dimensioni materiali delle guerre, per delimitarne più specificamente il profilo? I criteri più intuitivi ai quali ricorrere sembrano essere la violenza esercitata (misurata in base alla mortalità determinatasi in ogni singolo conflitto), il numero degli stati partecipanti, l’estensione geografica dei campi di battaglia, nonché la durata (seppur quest’ultimo aspetto rischi di deformare le nostre immagini: conflitti di breve durata ebbero effetti ben più duraturi di altri, più lunghi, ma meno incisivi” (L. Bonanate, La guerra, Laterza, Bari-Roma, 1998, pp. 5-8). La tipologia delle guerre di Carl Schmitt si basa sui tipi di attori coinvolti (regolari e/o irregolari): Guerre combattute tra: Regolari vs. Regolari cioé gerarchia (responsabilità dei superiori anche verso terzi) contrassegni fissi e visibili armamento esibito apertamente rispetto delle regole e degli usi del diritto di guerra Regolari vs. Irregolari cioé Partigiano = senza divisa con forte motivazione politica con grande agilità radicato nella propria terra oppure = oppure = oppure = combattente resistente attivista clandestino sabotatore Equiparati ai regolari milizie corpi volontari se (Aja 1907) in unione con sollevazioni popolari spontanee movimento di resistenza organizzato (Ginevra 1949) V.- La “limitazione” della violenza Nel corso dei secoli si è formalmente tentato di limitare l’uso della violenza (vedi oltre). Per quanto riguarda la violenza interna (legittima) è facile ricordare il passaggio dallo stato assoluto allo stato costituzionale, allo stato di diritto, alla democrazia con la limitazione dei poteri del sovrano e la statuizione di una serie di diritti dei cittadini che ampliavano il ruolo di questi ultimi e riducevano gli ambiti di libertà del sovrano di turno (o del portatore di legittimità). Abbiamo intravisto come, nei secoli, si sia cercato di limitare la stessa guerra, cioè la forma più violenta (forse) della violenza. Prima di entrare più in dettaglio su questo punto, è necessario ricordare che in non pochi autori troviamo invece un’esaltazione della guerra in sé e per sé. Ad esempio per Hegel e Nietzsche la guerra favorisce il progresso morale in quanto nel corso di questa si sviluppano virtù quali lo spirito di sacrificio, il coraggio, la solidarietà. Per Carlo Cattaneo, invece, la guerra favorisce il progresso sociale mediante la comunicazione fra gli uomini: le civiltà si combattono ma al contempo imparano a conoscersi, si mescolano. Per Spencer la guerra è portatrice di progresso tecnico in quanto è per la guerra che si sviluppano le industria, è nel campo militare che si inventano in continuazione sempre nuovi strumenti di offesa o di conoscenza, che poi possono anche diventare di uso civile (vedi ad esempio internet). La legittimazione della guerra E’ innanzitutto necessario distinguere tra chi ha diritto (riconosciuto internazionalmente) a condurre la guerra e quali sono le regole nella conduzione di questa (in altre parole: legittimità e legalità della e nella guerra). Occorre cioè partire dalla distinzione tra il ius ad bellum e il ius belli. “In base al primo, la dottrina tradizionale della guerra ha distinto le guerre giuste dalle guerre ingiuste, analizzando e discutendo i vari casi in cui uno stato ha o non ha il diritto di intraprendere una guerra; in conformità delle regole stabilite dal secondo, si sono venute distinguendo le azioni belliche lecite da quelle illecite. Via via che il diritto internazionale, prodotto dalle potenze europee nell’età della formazione dei grandi stati, ha riconosciuto come diritto sovrano il diritto alla guerra, così eliminando ogni criterio di distinzione fra guerre giuste e ingiuste, la funzione limitatrice del diritto si è spostata dalla legittimità alla legalità della guerra, per usare la terminologia di Carl Schmitt, dal bellum iustum all’hostis iustus. Il diritto illimitato dello stato alla guerra trova il proprio limite nella guerra stessa, in cui l’uso della violenza è limitato da regole che hanno la funzione di definire chi è il nemico, vale a dire chi è colui sul quale è lecito esercitare la violenza, e entro quali limiti la violenza può essere esercitata”. (N. Bobbio, Guerra civile?, in “Teoria Politica”, VIII, n. 1-2, 1992, pp. 297-307, p. 302). Lo ius ad bellum nelle epoche pre moderne Il dibattito degli ultimi anni sulle possibili distinzioni tra le diverse guerre, in tema di maggiore o minore giustificazione di queste, ha solide radici nei secoli passati. Giuristi, filosofi e altri studiosi hanno già ripercorso le tappe di questo lunto discorso sulla guerra (per citarne solo alcuni: v. N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, il Mulino, Bologna, 1997; J. Keegan, La grande storia della guerra, Mondadori, Milano, 1994; C. Galli (a cura di), Guerra, Laterza, Roma-Bari, 2004). Come è già stato scritto esistono in merito tre grandi gruppi di teorie: quelle che giustificano tutte le guerre, quelle che non giustificano nessuna guerra e quelle che ne giustificano alcune e ne condannano altre sulla base di elementi i più diversi fra loro. Fermiamoci ad analizzare queste ultime, anticipando che, come si vedrà, le teorie si distinguono in base a due possibili criteri: il perché (il fine) della guerra e il chi fa guerra. Sant’Agostino e san Tommaso E’ prassi consolidato, in Occidente, partire da Agostino (354-430 d. C.) per il quale si poteva prendere parte alla guerra senza commettere peccato solo se: la causa fosse giusta, se la guerra fosse condotta con l’intenzione di pervenire al bene o di sconfiggere il male e, infine, se fosse condotta sotto l’autorità costituita (il sovrano). Si tratta sia di una giustificazione di alcune guerre (in contrasto con i dettami dei primi padri della chiesa per i quali la guerra era da condannare in modo assoluto sulla base del Vangelo), ma, al contempo, era anche un tentativo di limitare le tante guerre dei cristiani (anche fra di loro) e quindi di legittimare non qualunque guerra condotta da cristiani ma solo quelle che presentavano le caratteristiche sopra indicate. Per Tommaso d’Aquino (1221-1274) la guerra deve avere una legittimazione morale e giuridica che si ritrova nel diritto naturale razionale (inteso come giustizia): la guerra è giusta solo se risponde a precise e impegnative esigenze (la fede religiosa, ad esempio). Machiavelli ed Erasmo da Rotterdam Per Machiavelli (1469-1527) è intrinseca all’umanità e alla politica, nel senso che: “la coincidenza di ‘buone leggi’ e ‘buone arme’ implica la doverosità dell’esercizio rischioso del potere politico, ossia l’intrecciarsi di politica e guerra; e quest’ultima si legittima da sé come naturale manifestazione della finalità della politica – ossia la potenza e la gloria – tanto sulla base del modello romano-repubblicano di virtù, ossia di libera cittadinanza in armi, quanto, se le circostanze storiche e politiche lo richiedono, nella forma ‘abbreviata’ del ‘principe nuovo’” (C. Galli, cit., p. XII). Per Erasmo (1466-1536), la guerra pur essendo sempre presente fin dalle epoche primitive dell’uomo cacciatore nella storia dell’umanità, è contraria alla natura umana (pacifica e amichevole ricorda Carlo Galli) e non è assolutamente da collegare con la buona politica, ma al contrario è il suo netto contrario “nonché del cristianesimo (e qui c’è la condanna delle guerre civili di religione); non è umana, ma peggio che bestiale, e non è via alla gloria, ma è sempre degna di orrore e di ripulsa” (ivi). L’età moderna: Hobbes La conquista dell’America, da un lato, e la scissione del cristianesimo (la Rofrma), dall’altro, creano nuove condizioni e necessità. “La guerra di conquista spagnola del Messico comporta – all’interno delle dispute sullo statuto politico e morale del rapporto fra Vecchio e Nuovo Mondo, e sulle fonti di legittimazione delle pretese europee – la ripresa delle posizioni tomistiche. Queste – documentate attraverso pagine del domenicano spagnolo Vitoria – ripropongono l’esigenza di una legittimazione morale e giuridica della guerra, sulla base di un cattolicesimo declinato in modo tale da accogliere in sé il diritto naturale razionale (…) Da parte loro le guerre civili di religione che hanno insanguinato l’Europa per più di un secolo, nascono dall’affermazione unilaterale di una verità in nome della quale ciascun contendente si reputa legittimato a disobbedire al potere politico e a condurre una guerra interna contro il nemico, che è anche eretico (i riformati per i cattolici) o tirannico (i cattolici per i riformati). A questa situazione fanno fronte dapprima la teoria della ‘ragion di Stato’, ossia una ripresa del pensiero di Machiavelli, e poi la costruzione giuridica e teorica della moderna forma politica statuale, che sancisce il passaggio della guerra alla piena disponibilità dello Stato, il nuovo monopolista della politica e quindi anche il nuovo signore della guerra e della pace. Questo processo da una parte elimina tendenzialmente dalla società le guerre private, le faide, e neutralizza le guerre civili di religione, attirando la guerra interamente nell’orbita dello Stato; dall’altra, però, svincola la guerra da ogni legittimazione fondata su una giusta causa universalmente e razionalmente conoscibile, facendone un atto di sovranità. La guerra è quindi legittimata a partire non dalla causa che la scatena o dal fine che si prefigge o dal disvalore del nemico contro cui si combatte, ma dal soggetto che la muove, dal modo in cui è combattuta e dal rango politico-istituzionale del nemico. Su queste basi in età moderna si afferma progressivamente l’idea che la guerra – potestà esclusiva dello Stato, unico titolare dello ius ad bellum – è un evento possibile, che appartiene alla realtà di una scena politica popolata da Stati sovrani in lotta reciproca per la potenza, ma può essere rivolta solo all’esterno e solo contro un altro Stato e va combattuta solo fra militari” (C. Galli, cit., p. XIV). E’ ancora una volta Thomas Hobbes (1588-1679) il grande sistematore e teorizzatore della nuova situazione politica. “Hobbes mostra che la guerra, vista come naturale (cioè come espressione del disordine dell’essere) e sottratta a ogni valutazione teologica o morale, viene integralmente risucchiata – nell’ambito più generale della neutralizzazione delle guerre di religione, perseguita tanto contro l’individualismo protestante quanto contro l’auctoritas e la potestas indirecta del cattolicesimo – all’interno delle logiche dello Stato e lì sistematizzata e ridiretta verso l’esterno come azione di pertinenza del sovrano (…) L’impianto teorico di Hobbes ricapitola, sistematizza e radicalizza, spostandole a volte di segno, alcune tendenze già in precedenza resesi evidenti in altri autori: la prima è che la guerra ha a che fare con un’insuperabile continegnza che affligge la politica, con una violenza strutturalmente inerente l’esser-uomo, e può essere solo organizzata e limitata, non eliminata. E’ così esclusa la guerra eroica e nobiliare per la gloria e l’onore e rimane solo, come normale possibilità della politica, la guerra prosaica e borghese per autodifesa o per l’utilità dello Stato. La seconda tendenza è che la ripresa del diritto naturale – e gli sforzi di farlo valere come una sorta di diritto delle genti – non toglie che la legittimazione della guerra sulla base della iusta causa ceda il passo alla legittimazione fondata sullo iustus hostis” (C. Galli, cit., p. XV). Kant Contro le teorizzazioni della guerra come fatto inevitabile che è il pensiero di Immanuel Kant (1724-1804). Egli definisce la guerra dei suoi tempi: “un ‘crimine’ proprio perché la vede come un fatale sottoprodotto della colpevole e ingiustificata restrizione della ragione moderna begli angusti ambiti della sovranità statuale, dell’universale nel particolare (…) L’obiettivo modesto di neutralizzare la guerra interna e di limitare le guerra esterna è sostituito, in Kant, dalla finalità di eliminare la guerra, secondo la ragione universale. E ciò significa repubblica all’interno (ossia uguaglianza, libertà, legalità e cittadinanza informata), federazione di Stati, o di popoli all’esterno (ossia progressiva dismissione degli aspetti violenti ed egoistici della sovranità, e contemporanea trasformazione del diritto delle genti che deve perdere il proprio carattere di diritto alla guerra), e infine instaurazione del diritto cosmopolitico e quindi del divieto di considerare i popoli extraeuropei come passibili di colonizzazione (ossia critica dello ius publicum europaeum come struttura epocale fondata sulla differenza fra Europa e resto del mondo)” (C. Galli, cit., pp. XVII-XVIII). Lo ius ad bellum in epoca contemporanea Partiamo dal fondo: ovvero dalla legittimazione delle ultime guerre: quella della primavera del 1999 del Kosovo, la guerra in Afghanistan post attentato alle Torri gemelle dell’11 settembre del 2001 e la seconda guerra del golfo contro l’Iraq della primavera del 2003. “Nel primo caso, il ricorso alla forza fu legittimato in nome del principio di ingerenza umanitaria e della sua superiorità rispetto sia alle pretese alla sovranità della Federazione Jugoslava sia alla necessità stabilita dalla Carta delle Nazioni Unite di un’autorizzazione esplicita del Consiglio di Sicurezza (contraddizione esplicita tra legalità e legittimità). La seconda occasione, quella della guerra contro l’Afghanistan del 2001 si presentò a prima vista come molto più semplice. Per legittimare la guerra, gli Stati Uniti si guardarono bene dal richiamarsi a qualche principio “universale” di ingerenza o, almeno, a inscrivere la propria risposta in qualche contesto multilaterale, per appellarsi invece al più tradizionale degli attributi della sovranità, il diritto di autodifesa. In occasione della guerra contro l’Iraq, l’Amministrazione statunitense scelse come noto di invadere l’Iraq in nome di un presunto imperativo di sicurezza nazionale (impedire all’Iraq di Saddam Hussein l’acquisizione di armi di distruzione di massa e la continuazione dei legami con i gruppi terroristici) e attraverso uno strumento, quello della guerra preventiva, che la maggior parte degli altri stati e delle organizzazioni internazionali non approvava o condannava esplicitamente”. (A. Colombo, cit., pp. 8-9). La Rivoluzione francese: da Constant a Hegel Con le guerre della Rivoluzione francese si verifica una svolta profonda sia sul piano della teorizzazione che della pratica. La “neutralizzazione” della guerra entra in crisi profonda con l’ingresso dell’attore “popolo”. “Le finalità ideologiche del conflitto, la pretesa che la guerra realizzi una verità ideale, una libertà nuova, rendono la guerra nuovamente ‘giusta’ tanto verso il nemico interno quanto verso quello esterno. Che l’immane potenza della nazione in armi faccia giustizia di avversari privi di legittimità, che non sono iusti hostes ma ideologicamente squalificati, che la guerra da faccenda di Stato divenga fatto sociale e di popolo, serve a ridisegnare non le carte geografiche ma le carte costituzionali e ideologiche d’Europa, dentro e fuori la Francia, conferisce a questa nuova guerra un dinamismo, un’aggressività, un’assolutezza, una coralità, che costituiscono i cardini della ‘guerra assoluta reale’.” (C. Galli, cit., pp. XVIII-XIX). Se Benjamin Constant (1767-1830) contrappone alla guerra (caratteristica di una fase storica arretrata) il doux commerce (che fa progredire, avanzare, che produce benessere), per Hegel non vi è economia o politica senza conflitto. La guerra è coessenziale (Galli) alla sovranità, che è di per se stessa, contingente, instabile, esposta agli altri, così come accade per la sicurezza, i diritti dei cittadini. E’ il limite della ragione che fa nascere i morire gli Stati. Karl Marx E’ nota la tesi di Karl Marx (1818-1883): la vera contraddizione non è della politica, questa è solo il riflesso della contraddizione primaria: vale a dire il conflitto fra capitale e lavoro. “E’ questa contraddizione a produrre in primo luogo lo Stato moderno, che si pretende universale, con le sue leggi, mentre in realtà è frutto di una ‘parte’, della classe borghese, e che si pretende internamente pacifico quando in realtà esprime, col suo stesso esistere, il conflitto fra borghesi e proletari (…) la guerra decisiva è una guerra interna che a volte resta solo implicita e che altre volte invece divampa apertamente nella rivoluzione, la sintesi in atto di guerra e politica (o anche nelle guerre civili fra gruppi opposti di interessi capitalistici, com’è avvenuto nella guerra civile americana); le guerre tradizionali fra Stati sono solo il momento di conflitto fra borghesie nazionali. E infatti l’esperienza della Comune di Parigi – insurrezione antiborghese del popolo, alla cui repressione concorsero, in modi diversi, tanto le forze tedesche vincitrici quanto quelle francesi sconfitte, in un’alleanza antiproletaria che neutralizzava la pur cruenta rivalità fra la Prussia e la Francia – dimostra, agli occhi di Marx, che nella prospettiva futura ci sono meno le guerre tra Stati e più la guerra civile mondiale fra proletari uniti, da una parte, e capitalisti almeno momentaneamente uniti, dall’altra. Una visione della politica come guerra non più esterna ma come guerra civile interna allo Stato prima e a tutto il pianeta poi, che travalica la cronaca degli ultimi decenni del XIX secolo – caratterizzati dall’aspra competizione fra potenze capitalistiche europee (e nord-americana) per la spartizione coloniale del mondo, cioè all’andar di pari passo di ‘commercio’ e guerra, contro l’’assunto liberale – e che sovrappone alle guerre imperialistiche e interimperialistiche la prospettiva della guerra rivoluzionaria mondiale” (C. Galli, cit., pp. XXI-XXII). Il XIX secolo: le guerre coloniali Quattro brevi citazioni per un tipo di guerre che ha caratterizzato (dopo la conquista dell’America) l’età degli imperialismi (v: Hobsbawm). “Gli europei giustificarono le loro azioni (massacri di africani, distruzione dei loro raccolti e di ogni loro altro bene, prelevamento da i villaggi, con la violenza, di grandi quantità di ‘portatori’ per rifornire le truppe europee) sostenendo che essi stavano portando la civiltà nel continente e stavano estirpando i demoni della schiavitù, delle razzie e del commercio degli schiavi. Leopoldo del Belgio in merito alla conquista del Congo nel 1876 parlava di penetrare attraverso le tenebre che avvolgevano intere popolazioni. Una crociata degna di questo secolo di progressi. Per gli inglesi le guerre coloniali britanniche avevano il fine di consentire alle classi industriali europee di guadagnare il dovuto compenso per il contributo dei loro cervelli, capitali ed energie allo sviluppo delle risorse dell’Africa e nello stesso tempo aiutare le razze indigene nel loro progresso verso un più alto livello. Le guerre (contro la resistenza delle popolazioni autoctone) furono sentite non tanto come guerre, quanto come azioni di ordine pubblico, di pacificazione. La teoria francese dell’impero, invece, comprendeva la convinzione che i sudditi coloniali erano cittadini (francesi) potenziali, che potevano essere assimilati alla cultura francese(delle rivoluzioni del 1789 e del 1848. L’autoritarismo era giustificato dalla convinzione che l’assimilazione delle masse africane alla cultura e alla civiltà francesi era difficilmente attuabile nell’immediato futuro. Fintanto che gli africani si mantenevano attaccati ai loro usi, ai loro stili di vita e alle loro leggi civili, tradizionali o musulmane, difficilmente potevano diventare cittadini francesi. E quindi: poiché la cultura francese era superiore, era necessario procedere alla demolizione dei vari sistemi di governo (e culturali, ed economici) africani, non importa di quale tipo essi fossero” (J.D. Fage, Storia dell’Africa, Società Editrice Internazionale, Torino, 1995 (1988), pp. 383-385). Il XX secolo: Kelsen Con le guerre della prima metà del XX secolo il progetto di espellere dall’interno delle società le guerre e di affidarle solo agli Stati (Galli) fallisce miseramente. In queste guerre la società, le società sono tutte all’interno della guerra, questa non riguarda più essenzialmente la popolazione in uniforme, riguarda anche e in molti casi in primo luogo (v. più avanti) tutti i civili. Contro questa realtà di fatto Hans Kelsen (1881-1973) riprende le teorizzazioni di Kant nel tentativo di distinguere nuovamente fra tipi di guerre. “Kelsen fa della guerra un crimine imputabile e sanzionabile, non tanto con riferimento alla sovranità dello Stato, ma alle persone fisiche dei governanti che la dichiarano: questi devono essere sottoposti a un tribunale che trae la propria legittimità e la propria fonte normativa dal diritto internazionale. E’ questa una piena giuridificazione della guerra, che non è più solo limitata dalla razionalità politica dello Stato, né è lasciata libera di manifestarsi come essenza dell’epoca o come finalità progressiva della storia, ma è ricondotta all’interno della razionalità universale, non politica ma giuridica, del diritto internazionale, e sulla base di questo giudicata un crimine. In questo contesto, l’unica forma di sopravvivenza della guerra è, logicamente, che essa valga come sanzione contro gli Stati che vi ricorrono per primi, cioè che essa venga presentata come un atto di polizia internazionale, guidata da istituzioni che si legittimano nell’ideale universale della civitas maxima e non nella sovranità statale. Questa abolizione della guerra come diritto sovrano dello Stato, questa sua classificazione come ‘crimine’ e questa sua sopravvivenza come atto di polizia (come guerra giusta che ripara un torto) a disposizione di un’istituzione sopranazionale, significa che la pace è possibile come affermazione del diritto, se lo Stato è privato del monopolio della pace e della guerra” (C. Galli, cit., pp. XXVII-XXVIII). Con Kelsen si introduce l’idea di un “terzo” attore, giudice arbitro delle controversie internazionali. Ma chi è il “terzo” che può sanzionare una eventuale illiceità? Siamo di fronte al “Terzo Introvabile”, come lo ha definito Pier Paolo Portinaro in un libro di quasi vent’anni fa (Il Terzo. Una figura del politico, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 293). Un “Terzo” che abbia la forza di coercizione nei confronti di tutti gli stati, che abbia il potere di trasformare i rapporti di forza in obblighi giuridici, che abbia l’autorità (o la legittimazione) per far rispettare i patti, i trattati, le regole della guerra. Un “terzo” quindi superiore alle singole parti o, almeno, un primus inter pares. Ma “tra le massime potenze di un sistema bipolare non esiste, per definizione, un tertius inter pares che possa proporsi come autorevole mediatore: appartiene d’altro canto alla natura stessa della sovranità di tali potenze non solo l’essere, di fatto oltre che di diritto, superiorem recognoscentes, ma altresì la propensione ad operare secondo una logica di negoziazione bilaterale – o di contratto scambio – che non prevede il ricorso a mediatori”. Impossibile, quindi, avere il “terzo” in un sistema bipolare. Inutile cercarlo, forse, in un sistema “imperiale” o monopolare. Il sovrano unico deciderà quando è giusto fare una guerra e ciò che è giusto fare in guerra. Si potrebbe anche concludere questo punto con una citazione pessimistica: “una qualsiasi procedura giudiziaria è istituita allo scopo di far vincere chi ha ragione. Ma il risultato della guerra è proprio l’opposto: è quello di dar ragione a chi vince (N. Bobbio, cit., p. 59). Lo ius belli: tra forma e sostanza Come si vedrà più avanti, da sempre l’essere umano ha cercato di limitare le condotte di guerra, cioè ciò che è lecito fare nel corso di un conflitto bellico. Le prime Convenzioni internazionali risalgono a metà del XIX secolo (Ginevra). Con il trascorrere dei decenni l’elenco delle “cose che non si possono fare” in guerra è diventato sempre più lungo, ma è anche vero che tutto ciò nella stragrande maggioranza dei casi è rimasto lettera morta. In particolare si è cercato di porre limiti rispetto a: 1) le persone coinvolgibili (distinzione tra militari e civili o fra belligeranti e non belligeranti); 2) le cose (cioè la distinzione fra obiettivi militari e non); 3) i mezzi (cioè le armi usabili e quelle no, ad esempio il divieto di usare i vari tipi di gas); 4) i luoghi (delimitazione delle zone di guerra). Ma vediamo più specificamente quali possono essere i veri limiti alla conduzione della guerra. “Occorre chiedersi quali sono, in generale, le condizioni che rendono possibili le limitazioni della guerra e senza le quali, in qualunque contesto storico, la loro tenuta diventa problematica o impensabile. Tali condizioni possono essere raggruppate in due grandi insiemi: il potere e le istituzioni. Il potere o La soglia di accesso alla violenza: la guerra è limitata se e in quanto non tutti coloro che vorrebbero difendersi da sé o attaccare gli altri hanno concretamente la possibilità di farlo. Questo continua a valere per il monopolio statuale sulla violenza, che si impose a mano a mano che l’aumento dei costi e della complessità delle operazioni militari condusse alla “espropriazione dei detentori ‘privati’ indipendenti della potenza amministrativa” (Weber), facendo degli stati gli unici soggetti concretamente in grado di procurarsi le risorse necessarie a combattere la guerra e finanziarla. “E’ il monopolio (il potere) che produce la legittimità (il diritto) e non viceversa” (Miglio). Se, sul piano del diritto, la soglia di accesso al gioco ha stabilmente diviso gli stati dagli attori diversi dagli stati, sul piano del potere essa ha continuato a dividere pochi (o pochissimi) stati da tutti gli altri o La guerra è limitata se e in quanto le capacità dei contendenti sono limitate (cioè relazione circolare tra economia, tecnologia e guerra). o La guerra è limitata se e in quanto sono limitati gli obiettivi dei contendenti (rapporto tra guerra e politica). Per Clausewitz: si deve distinguere tra il sentimento ostile e l’intenzione ostile. Mentre il primo, l’odio “anche più selvaggio, quello che si avvicina all’istinto”, può essere separato dalla seconda, “esistono spesso intenzioni ostili non accompagnate, o almeno non essenzialmente accompagnate da inimicizia preconcetta”. Questa differenza spiega per Clausewitz la differenza tra il modo in cui la violenza viene impiegata presso “i popoli barbari”, dove “predominano i progetti basati sull’istinto”, e presso i “popoli civili” dove, al contrario, predominano quelli “basati sulla riflessione”. o La guerra è limitata se e in quanto le capacità e la volontà di ciascuno dei contendenti sono controbilanciate o trattenute dalle capacità e dalla volontà dell’altro. Qui, quello che conta è che le azioni dei contendenti sono trattenute dalla reciprocità o dalla simmetria tra “la reazione viva dell’avversario e la controreazione che ne risulta” (Clausewitz) o Le condizioni che facilitano o meno le limitazioni (v. pp. 100-115) - Le istituzioni o In che cosa la guerra può essere e, storicamente, è stata limitata da regole del gioco concordate implicitamente o esplicitamente tra gli avversari. Nessuna convenzione può evitare di rispondere ad almeno tre questioni elementari, senza le quali nessun’altra forma anche più “avanzata” di ritualizzazione della guerra si rivelerebbe possibile: chi ha diritto e a quali condizioni di ricorrere alla forza; in quali modi e contro chi ha diritto di impiegarla; in che cosa e attraverso quali procedure lo stato di guerra si differenzia dallo stato di pace, da un lato, e dalle altre forme di violenza dall’altro. o La prima preoccupazione di qualunque società internazionale è quella di limitare il diritto stesso di ricorrere alla guerra, vietando che chiunque possa farlo in qualunque momento e fino a qualunque esito – come nella batteria di criteri della dottrina tomista della guerra giusta: che la guerra sia dichiarata dalla autorità legittima”; che abbia una “giusta causa”; che sia combattuta con una “buona intenzione”; che costituisca un “estremo ricorso”; che, una volta vinta, non venga resa “ingiusta” dall’inflizione di una punizione eccessiva allo sconfitto. o Il secondo grappolo di restrizioni può assumere e, storicamente, ha assunto tanto una forma positiva quanto una forma negativa. Nel primo senso, più ambizioso ma, non a caso, anche più fragile, le regole della guerra possono giungere fino a prescrivere dove, quando, con quali armi, contro chi e fino a quale esito è lecito combattere. Le regole di contenuto negativo prescrivono dove, quando, con quali armi e contro chi non è lecito combattere La funzione di queste ultime è di stendere intorno alla guerra una rete di immunità che riguardano Il tempo: basti pensare al divieto, presente in molte culture arcaiche, di combattere nel corso della notte; o di muovere guerra durante la stagione dei raccolti nell’antica Cina; oppure alla lunga teoria delle immunità di natura religiosa (presenti anche in culture non occidentali come quella induista o islamica) I luoghi: tutti i tentativi di ritualizzazione della guerra si sono proposti di risparmiare dalla violenza anche determinati luoghi, perché dotati di un significato religioso, economico o generalmente sociale, come le chiese, gli ospizi, i beni culturali e le località sanitarie I destinatari della violenza: esigere che solo certi uomini e non altri possano essere legittimamente uccisi. Questa discriminazione può assumere forme diverse, politiche (la distinzione tra capi e seguito), morali (colpevoli e innocenti), istituzionali (stato e società) o specificamente militari (combattenti e non combattenti). (A. Colombo, cit., pp. 74 e pp. 125-133) La violenza senza limiti: i terrorismi In parte lo si è già visto: vi sono tanti modi di portare “violenza”. Una di queste modalità va sotto il nome, oggi piuttosto abusato, di “terrorismo”. Siamo di fronte a un concetto non condiviso. Vale a dire che sul piano internazionale, nonostante i vari tentativi fatti, non vi è ancora una definizione accettata da tutti (cioè giuridicamente vincolante) di azione terroristica, di “terrorista”. Guardando ai giorni nostri: in Iraq oggi siamo di fronte a una guerra di resistenza o di “partigiani” oppure solo ad azioni terroristiche? Quali sono i soggetti che perseguono il “terrore”? che creano “terrore”? E’ già stato scritto che tentativi per definire il terrorismo si sono avuti a più riprese a partire dal XIX secolo: “in particolare in occasione di: l’offensiva anarchica e nichilista degli ultimi vent’anni dell’Ottocento e dei primi dieci anni del Novecento; l’attentato di Marsiglia del 1934 costato la vita al re di Jugoslavia Alessandro e al primo ministro francese Barthou; la strage delle Olimpiadi di Monaco del 1972; l’attacco all’America dell’11 settembre 2001. Tutti i tentativi si sono arenati di fronte allo stesso problema: persino fra gli stati c’è sempre stato qualcuno che ha riconosciuto scusanti all’impiego della violenza da parte di soggetti diversi da loro. Tali scusanti sono cambiate profondamente nel corso del tempo, ispirandosi di volta in volta a principi diversi e spesso opposti – dal diritto di resistere e insorgere contro regimi oppressivi o tirannici, riconosciuto già nella seconda metà dell’Ottocento da paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, al rifiuto di includere nella definizione di terrorismo gli atti di violenza commessi nel corso delle guerre di liberazione nazionale. Sebbene profondamente diverse tra loro, tutte queste eccezioni si sono appoggiate al comune convincimento che, a certe condizioni, il monopolio dello stato sulla guerra potesse essere superato. Nella stessa epoca storica in cui la parola veniva coniata, cominciava anche ad erodersi la condizione normale da cui, come ogni eccezione, avrebbe dovuto ricavare il proprio significato. Qualora fosse rimasta viva l’idea che l’unica guerra legittima è la guerra tra stati, qualunque discussione su chi fosse partigiano e chi fosse terrorista avrebbe potuto essere facilmente accantonata: gli unici soggetti autorizzati a impiegare la violenza sarebbero rimasti gli stati e tanto sarebbe bastato a bollare come illegittimi tutti gli altri. L’emergere di differenze tra questi ultimi segnala già, invece, un indebolimento della distinzione principale. Se alcuni irregolari – i partigiani – possono figurare come più legittimi di altri – i terroristi – è perché la separazione tra regolari e irregolari si è già indebolita. Il monopolio statuale sull’uso della violenza organizzata ha perso in maniera apparentemente inarrestabile la propria effettività e, nella crescente incertezza sui principi costitutivi della convivenza internazionale, è stato sfidato sempre più spesso anche sul terremo della legittimità; le chiare distinzioni della guerra interstatale (combattenti/non combattenti, militari/civili, neutrali/non neutrali) hanno cessato di separare e, quindi, di preservare; la pace e la guerra sono andate confondendosi in un intrico sempre più imprendibile di esperienze e di metafore (guerra fredda, peace enforcing, “guerra infinita”)”. (A. Colombo, La guerra ineguale, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 66-70). - Il terrore fuori della battaglia “La minaccia e l’uso del terrore possono travalicare e, periodicamente, travalicano anche i limiti (della battaglia) per trascinare in guerra chi non può essere chiamato – perché non è “abile” a combattere – e chi non vuole esserlo, perché non vuole - - - - - - che la guerra sia combattuta o perché non vuole essere lui a combatterla La minaccia e l’uso del terrore costituiscono una delle modalità più ricorrenti nella conduzione delle guerre. E’ nella natura della violenza potere essere impiegata tanto per indebolire o sconfiggere il nemico in battaglia quanto per intimidirlo al di fuori di essa Questa “violenza intesa a costringere il nemico invece che indebolirlo militarmente” è ciò che Schelling definisce, come forma caratteristica di guerra, “terrorismo”. A differenza della violenza bruta, la cui efficacia si misura da quanto riesce a sopravanzare direttamente la volontà del nemico (fino all’estremo dell’annientamento), il successo del terrorismo dipende da quanto riesce a modificare i suoi interessi e, con essi, il suo comportamento (Nella minaccia o uso del terrore) ciò che conta non è la sofferenza inflitta, bensì quella latente – la violenza che può ancora essere trattenuta o inflitta. E’ la minaccia del danno, o di un danno maggiore in futuro, che può indurre l’altro a cedere o a piegarsi al nostro potere – nella stessa accezione delle scienze sociali e politiche, comportandosi diversamente da come si comporterebbe qualora non fosse sottoposto alla nostra influenza”. (A. Colombo, pp. 20-22) Il terrore nella modernità “Ben prima di essere riscoperto dai “gruppi terroristici”, il terrore è stato impiegato e teorizzato dagli stati – e, prima che tra loro, proprio contro individui e gruppi non statuali da disciplinare al proprio interno e combattere al proprio esterno Il tipo di guerra che in modo più sistematico e storicamente continuo ha visto il ricorso da parte degli stati alla minaccia e all’uso del terrore (sono state) le guerre contro le popolazioni senza stato e, in particolare, quelle condotte contro le popolazioni non occidentali, nell’ambito delle conquiste coloniali. Tali guerre hanno sempre avuto a che fare più con “spedizioni punitive” che con “genuini scontri militari” (Schelling) Anche nella fase discendente della vicenda coloniale, questo fu il modo in cui vennero impiegate l’aviazione britannica contro le tribù ribelli dell’Iraq negli anni Venti e Trenta, quella francese contro l’insurrezione araba in Siria, in Marocco e in Algeria e quella italiana nella conquista della Libia e dell’Etiopia. Mentre, tra il 1860 e il 1890, questo era stato anche il modo in cui gli Stati Uniti avevano combattuto le cosiddette guerre indiane. Ma se la minaccia e l’uso del terrore erano stati almeno progressivamente banditi dalle guerre interstatali dalla seconda metà del Settecento fino alla Prima guerra mondiale, anche tra gli stati essi ricomparvero stabilmente nelle guerre successive fino a diventare uno degli strumenti più comuni, sebbene non necessariamente più efficaci, di aggressione e contenimento del nemico. - Le origini di questo duplice sconfinamento del terrore – dal campo di battaglia, da un lato, e dalla violenza senza regole delle avventure coloniali dall’altro – sono fatte comunemente risalire alla marcia del generale Sherman attraverso la Georgia, nel pieno della guerra di secessione americana. Ma fu solo nel corso della Seconda guerra mondiale che la minaccia e l’uso del terrore contro i non combattenti vennero impiegati in modo sistematico da tutti i principali stati e in tutti i principali teatri della guerra. Tra il 1940 e il 1945, circa 60.000 cittadini inglesi morirono sotto i bombardamenti tedeschi, così come all’incirca 600.000 cittadini tedeschi e 900.000 giapponesi morirono sotto i bombardamenti angloamericani. ‘L’obiettivo politico della bomba non erano i morti di Hiroshima o le fabbriche nelle quali lavoravano, ma i sopravvissuti di Tokyo. Le due bombe erano nella tradizione di Sheridan contro i Comanches e di Sherman in Georgia’ (Schelling 1966)”. (A. Colombo, cit., pp. 24-28) - - - - - Il terrorismo come metodo “I tratti distintivi del terrorismo come metodo sono tre. Il primo è l’impersonalità o l’astrattezza. Diversamente dal fanatismo religioso o ideologico, il metodo terroristico aggira l’oggetto della sua ostilità politica; non lo colpisce direttamente, ma lo indebolisce colpendo altri oggetti. La sua struttura è triangolare invece che lineare: ogni atto terroristico comprende un soggetto che lo compie, un secondo vittima dell’attacco e un terzo destinatario dell’intimidazione Il secondo elemento è la parsimonia. La minaccia e l’uso del terrore si propongono (e si legittimano) come un metodo “economico”, capace di alterare a proprio vantaggio l’equilibrio tra i costi e i benefici della violenza (ottenendo il massimo con il minimo). Innanzitutto, in quanto forma particolare della guerra psicologica, la minaccia e l’uso del terrore promettono una sproporzione tra il risultato immediato delle azioni e le loro conseguenze psicologiche. In secondo luogo, essi introducono una seconda sproporzione, altrettanto vantaggiosa, tra i costi dell’attacco e i costi della difesa: l’attacco terroristico costa poco e, comunque, meno di ciò che costa cercare di prevenirlo o di pararlo, senza potere sapere dove e contro chi o che cosa sarà rivolto. Infine, l’economicità del metodo terroristico consente di compensare (almeno i parte) la sproporzione tra forti e deboli. Il terzo elemento, più comune ma anche più ambiguo, è la casualità o l’indiscriminatezza. Perché possa raggiungere lo scopo di diffondere la paura e intensificarle nel tempo, il metodo terroristico non può concentrarsi su categorie di individui o di luoghi specifiche, identificabili in anticipo con un regime, un partito o una politica. ‘Se nessuno è preso di mira, nessuno è al riparo’ (Aron)”. (A. Colombo, cit., pp. 40-42) Il terrorismo per la guerra o per la pace - - - - “1) Il terrorismo, oltre che per vincere, è stato e, dunque, può essere impiegato per provocare la guerra (in contesti interni come in contesti internazionali) 2) la minaccia e l’uso del terrore sono diretti non a provocare, ma a denunciare la guerra – una guerra già in corso, dunque, ma invisibile ai suoi possibili testimoni e, addirittura, a qualcuno dei contendenti (diretti o indiretti) (esempio: le imprese terroristiche di movimenti che agiscono in nome di una miriade di popoli e minoranze oppresse ma prive di riconoscimento internazionale) 3) la minaccia e l’uso del terrore sono stati e possono essere concretamente impiegati per l’obiettivo di limitare la guerra. In questo possibile uso sta anche la parentela tra metodo terroristico e rappresaglia (le minacce di Hamas a Israele per cercare di dissuaderlo dal proseguire certe operazioni militari; le incursioni di Israele contro i villaggi in Giordania per frenare le incursioni dei gruppi armati palestinesi). 4) La minaccia del terrore è stata e può essere impiegata per prevenire la guerra. “La pace di terrore è quella che regna tra le unità politiche, se ciascuna di esse ha la capacità di colpire mortalmente l’altra” (Aron). 5) Il potere di infliggere sofferenze alla popolazione civile può diventare un modo non di prevenire ma di sostituire la guerra, nel senso più compiuto della “diplomazia della violenza” (di Schelling): costringendo il nemico a scegliere tra l’accomodamento e la vita”. (A. Colombo, cit., pp. 47-51) Terrore e derivati: l’uso politico del termine “I tratti più significativi dell’uso politico della parola sono: 1) il primo e più fondamentale è già contenuto nel fatto che, a un certo punto della storia, la continuità del metodo terroristico abbia potuto finalmente essere trattenuta in una parola. Nella storia quando pratiche immemorabili diventano oggetto di acquisizione consapevole è perché diventano coerenti con i concetti, le metafore e le analogie dello stile di pensiero dominante. Se l’acquisizione consapevole del metodo terroristico poté finalmente avvenire alla fine del XVIII e diffondersi per tutto il XX secolo fu proprio perché, a quell’epoca, erano più o meno comunemente disponibili una nozione di pace e di guerra “normali”, nella quale il “terrorismo” e i suoi derivati trovarono la propria antitesi e, per ciò stesso, anche la propria definizione. Fu proprio la presenza di una nozione forte di che cosa avrebbe dovuto essere e normalmente era la convivenza “civile” (interna e internazionale) che consentì di concepire il terrorismo come l’esatto opposto di tale condizione. o Nella convivenza politica interna, questo ruolo di norma venne svolto sin dalla fine del Settecento dalla diffusione di pratiche disciplinate e sobrie di esercizio del monopolio statuale sulla violenza legittima, in antitesi alle quali potevano apparire “terroristici” sia l’uso improprio, abnorme del potere - sanzionatorio dello stato, sia l’uso extralegale della violenza da parte di soggetti “privati” del diritto di impiegarla. o Nella convivenza politica internazionale, invece, l’uso della parola “terrorismo” e dei suoi derivati rimase marginale fino a tutta la Prima guerra mondiale per diffondersi solo più tardi, a mano a mano che le offensive aeree contro le città, da un lato, e la diffusione e il rafforzamento della guerra partigiana dall’altro, misero apertamente in questione anche il modo in cui, fino allora, gli stati europei avevano normalmente praticato e concepito la guerra fra di loro: come uno scontro tra eserciti, egualmente impegnati a escludere tutti gli altri soggetti (sia come portatori, sia come vittime della violenza) da quel “centro di gravitazione della guerra” che era la battaglia. - 2) il secondo e più importante carattere della parola terrorismo mischia due eccezioni diverse. La prima è quella del progressivo superamento dell’hortus clausus dei combattenti, con l’impiego da parte di questi ultimi di strumenti “terroristici” contro il territorio e la popolazione dei propri nemici. La seconda, più radicale, è quella del progressivo indebolimento della “presa” degli stati sulla politica internazionale, con l’irruzione di portatori alternativi di violenza organizzata. Tutte e due le eccezioni hanno a che fare con la rottura dei limiti della guerra. Ma la prima presuppone un accordo su come e contro chi la guerra dovrebbe essere e normalmente è combattuta, mentre la seconda ne presuppone uno su chi dovrebbe essere e normalmente è a combatterla. Oltre che tardiva, la parola terrorismo si rivela costitutivamente e non casualmente ambigua. Mettendo sotto la stessa etichetta un metodo e dei soggetti, essa rischia di nascondere o deliberatamente nasconde il fatto che il primo non è necessariamente associato ai secondi mentre i secondi non sono necessariamente destinati al primo - A disinnescare sul nascere tale ambiguità ha provveduto la capacità normalizzatrice dello stato – il “Grande Definitore” della politica e del diritto moderni e, quindi, il produttore pubblico della coerenza tra le parole e le cose. - La nozione di terrorismo ha finito per designare non una generica eccezione alle “buone regole” della guerra, bensì un’eccezione più specifica e giuridicamente definibile alla guerra interstatale come modello esclusivo della competizione internazionale. Terrorismo, dal punto di vista dello stato e delle sue categorie politiche e giuridiche, è solo ciò che non rientra nella guerra “legale” tra gli stati: perché è perpetrato da soggetti che non sono autorizzati a impiegare la violenza e perché, anche quando tali soggetti si sentono in guerra, essi non hanno diritto di sospendere lo stato giuridico della pace - 3) Questo rapporto essenziale con l’equiparazione tra politica internazionale e politica interstatale è il terzo elemento della nozione corrente di terrorismo. Le conseguenze sul rapporto tra norma ed eccezione: o Se per il solo fatto di vedere trasgredito il proprio monopolio sulla guerra, gli stati tenderebbero già a considerare irrilevanti o, almeno, secondarie le differenze tra guerriglieri e terroristi, tale tendenza risulta rafforzata ogni volta che gli stessi soggetti ricorrono periodicamente sia all’uno che all’altro metodo – cioè concretamente quasi sempre. Non è possibile ricorrere a metodi terroristici senza assurgere, automaticamente, a “terroristi”; e non è possibile assurgere a terroristi senza che, da questo momento, anche tutti i pripri atti figurino coerentemente come “terroristici”. Di questa confusione, la nozione attuale di “terrorismo internazionale” costituisce la vera e propria apoteosi. o La seconda conseguenza tocca il fragile equilibrio tra legittimità e innocenza. Nello stesso momento in cui si definisce “terroristica” qualunque azione di guerra compiuta da soggetti non autorizzati, che sia rivolta contro militari o contro civili, si apre per i soggetti autorizzati uno sterminato spazio di innocenza, all’interno del quale può tornare ad apparire legittimo qualunque atto di guerra – compresi, in situazioni estreme, quelli diretti contro i civili. o Gli stessi atti sono definiti terroristici oppure no a seconda che siano commessi da attori non statuali o da stati. Più che distinguere troppo poco tra combattenti legittimi e illegittimi – tra partigiani e terroristi – essa distingue anche troppo tra regolari e irregolari. In un caso le violazioni sono racchiuse, se riconosciute, sotto l’etichetta di “crimini di guerra” e trattate dal diritto internazionale umanitario. Nell’altro caso sono definite come terrorismo e affidate al diritto penale”. (A. Colombo, cit., pp. 56-63). In breve: si possono avere 4 tipi di “terrorismo”: chi lo fa contro chi civili militari stati A B non stati C D VI.- I conflitti violenti dal 1946 In premessa: uno sguardo ai conflitti 1800-1945 Tipi di guerre post 1991 “Già a un primo sguardo, è facile constatare come le ostilità militari dell’ultimo quindicennio abbiano avuto forme eccezionalmente eterogenee, da guerre di impianto ancora tradizionale come quella del Golfo del 1991 a operazioni militari “chirurgiche”, cioè a costo zero per l’attaccante, come i bombardamenti sull’Iraq nel 1996 e nel 1998 e quelli sulla Jugoslavia nel 1999, da manifestazioni al massimo grado della sovranità del paese più forte a manifestazioni di collasso della sovranità (come le guerre di disgregazione territoriale nell’ex Unione Sovietica, nella ex Jugoslavia e in Africa centrale) fino alla riappropriazione di capacità militari e politiche da parte di soggetti non sovrani, come le imprese più recenti delle organizzazioni terroristiche. Ma quello che è più significativo è che a questa varietà di forme si è accompagnata una incertezza crescente sulla legittimità del ricorso alla guerra”. (A. Colombo, La guerra ineguale, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 7-8).