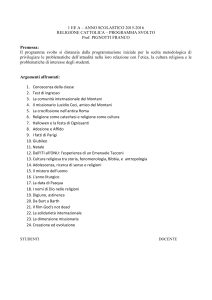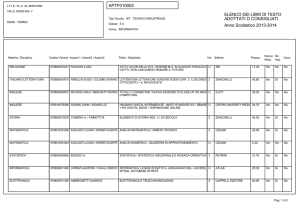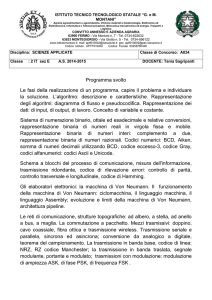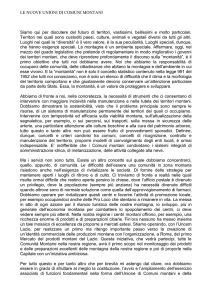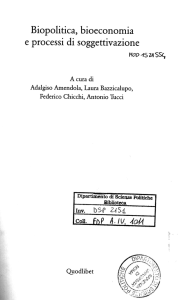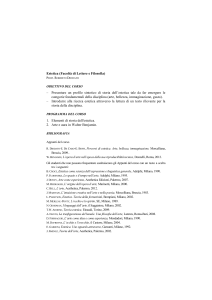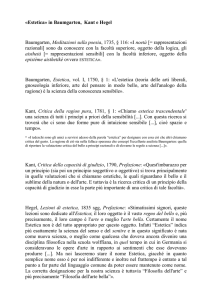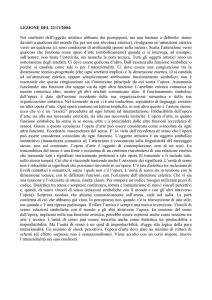Tecnica e filosofia nel pensiero
del novecento
Note per una discussione
Romeo Bufalo
Per Pietro Montani
1. Uno dei temi che hanno maggiormente caratterizzato le discussioni filosofiche (e non solo filosofiche) del secolo appena trascorso, e che continua ad animare il dibattito teorico del nuovo secolo, è
quello del significato da assegnare alla tecnica, della valutazione
della sua incidenza nella vita degli uomini all’interno del mondo
globalizzato contemporaneo (largamente dominato, come è noto,
da un impetuoso sviluppo tecnologico). Detto nei termini di una
prospettiva interculturale, che è quella dalla quale ci collochiamo:
che posto occupa il pensiero tecnico-scientifico (ed il pensiero sulle
tecno-scienze) nell’attuale organizzazione del sapere? In che modi,
e attraverso quali canali, la tecnica circola negli altri settori della
cultura contemporanea? Che rapporto è possibile individuare tra
tecnica e filosofia? Più in particolare: quale significato attribuire
alle immagini prodotte dalla tecnica nell’epoca della globalizzazione? Qual è il loro statuto teorico? Sono portatrici di un qualche
contenuto di verità? Quanto incidono queste immagini sulla nostra vita sensibile, oltre che sulla nostra intelligenza, ossia sulla
nostra aisthesis, oltre che sul nostro logos? E ancora: che tipo di impatto producono le nuove tecnologie informatiche e bioingegneristiche sul terreno politico quando incrociano questioni essenziali
che hanno a che fare con la vita (e con la morte) di ciascuno, ossia
con la sfera del bios? E da ultimo: è possibile, in tale quadro, dominato dalle ipertecnologie, assegnare ancora un posto (ed eventualmente quale) alle arti? E se sì, che ruolo può svolgervi un’estetica come teoria generale della sensibilità?
9
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
Si tratta, come si vede, di interrogativi rilevanti non solo dal
punto di vista teorico, ma soprattutto da quello pratico, perché
hanno a che fare con la nostra esperienza quotidiana, con la nostra
praxis, cioè con la nostra capacità di orientarci nel mondo e di compiere le scelte per noi più efficaci. Sono, in altri termini, questioni
rispetto alle quali, più che la completezza delle risposte, sarà filosoficamente interessante l’ampliamento problematico delle domande stesse.
Dopo aver enunciato le linee lungo le quali intendiamo muoverci, possiamo senz’altro partire. Ed il modo migliore per partire
è quello di prendere le mosse da alcune questioni teoriche e storiche generali.
Cominciamo allora col dire che la tecnica, come ha rilevato Hans
Jonas, ha sempre accompagnato l’esistenza dell’uomo. Ma, mentre
nelle epoche precedenti alla nostra, essa era subordinata alla natura, nel senso che ne imitava i comportamenti senza romperne gli
equilibri, l’epoca moderna rovescia radicalmente questo rapporto
mimetico. Oggi infatti non è più la natura a costituire il fine, lo
scopo, ma la tecnica (in cui una cosa strumentale sta al posto di
una finale)1.
Questa posizione di Jonas, che guarda con molto sospetto il
mondo della tecnica, considerata come un blocco unitario ed indifferenziato, esprime un atteggiamento molto diffuso nel pensiero
del Novecento. Si può anzi affermare che la maggior parte dei filosofi del secolo appena trascorso abbia manifestato una forte diffidenza nei confronti dell’onnipotenza della tecnica, e, soprattutto,
abbia teorizzato un’opposizione molto netta tra pensiero e tecnica.
Heidegger, per esempio, vede nella tecnica l’essenza del mondo
moderno (che è l’epoca dell’“immagine del mondo”). Questa essenza coincide con la metafisica, cioè con il nichilismo, il quale, a
sua volta, esprime, sul piano filosofico, lo smarrimento e l’oblio
dell’essere, rispetto al quale solamente ci può essere vero pensiero.
La preminenza della tecnica è il segno più evidente del fatto che
Cfr. Michela Nacci, Pensare la tecnica. Un secolo di incomprensioni, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 4.
1
10
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
noi non abbiamo ancora incominciato a pensare (laddove ‘pensare’
per Heidegger significa pensare l’essere, mentre la metafisica occidentale, di cui la tecnica è l’espressione più matura, è ancora attardata su un ‘pensiero degli enti’). La tecnica nel mondo contemporaneo, insomma, non è più, a parere di molti, subordinata alla natura, all’uomo, all’essere. Sono, viceversa, l’essere, la natura, l’uomo ad essere subordinati alla tecnica, la quale diventa un fine; anzi, il fine, ovvero il destino dell’Occidente.
In generale, però, come sostiene Michela Nacci2, i filosofi del
Novecento non hanno ben compreso il significato filosofico della
tecnica; o meglio, non ne hanno avuto un’immagine adeguata.
Hanno tutti, o quasi tutti, oscillato tra demonizzazione e divinizzazione della tecnica, tra apocalisse ed esaltazione entusiastica.
Raramente è stata percorsa la via di mezzo; quella per cui la tecnica, in sé, non è né buona né cattiva, né razionale né irrazionale.
Dipende, come al solito, dall’uso che se ne fa. Essa presenta sicuramente dei rischi, ma offre anche, qualora la si ‘decostruisca’ criticamente, notevoli opportunità. Da qui l’esigenza di un’opera preliminare di intelligenza della tecnica. O meglio, siccome essa ormai
pervade di sé tutto il mondo contemporaneo, da qui l’esigenza di
una nuova interpretazione del mondo, più che di un suo cambiamento, come prospetta acutamente Gunter Anders3, il quale rovescia i termini della celebre undicesima Tesi su Feuerbach di Marx
(gli uomini finora hanno variamente interpretato il mondo; si tratta di cambiarlo), perché sostiene che oggi non basta cambiare il
mondo. Lo facciamo continuamente; ed il mondo stesso cambia
per i fatti suoi anche senza il nostro intervento (e grazie alle ‘straordinarie’ prestazioni della tecnica). Nostro compito precipuo è
pertanto quello di interpretarlo. «E ciò precisamente – scrive Anders – per cambiare il cambiamento. Affinché il mondo non continui a cambiare senza di noi. E, alla fine, si trasformi in un mondo
senza di noi»4. Sarà questa la prospettiva dalla quale anche noi ci
collocheremo nel corso delle pagine che seguiranno.
Ivi, p. 6.
Gunter Anders, L’uomo è antiquato, Il Saggiatore, Milano, 1963.
4 Gunter Anders, in Michela Nacci, op. cit., p. 32.
2
3
11
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
2. Come si diceva all’inizio, nella nostra epoca la tecnica incide in
maniera prepotente e capillare su tutti gli aspetti della nostra vita,
del nostro bios. Per questa ragione, come ha sottolineato Tomàs
Maldonado5, essa ci pone interrogativi che non sono più di natura
solo filosofica, ma anche etica, estetica, economica, giuridica, socio-politica. Bisogna allora operare una profonda revisione del
modo di pensare la tecnica. Il che non vuol dire rifiutare in blocco
tutto ciò che di filosoficamente valido è stato detto su di essa. Significa invece, nella prospettiva di Maldonado, accorciare il più
possibile la distanza che separa la “tecnica mediata” (= il sapere
della tecnica, la sua teoria) dalla “tecnica immediata” (= la tecnica
nel suo uso empirico-contingente). A questo scopo, occorre convocare, in un dialogo polifonico interculturale, storici, etnologi, economisti, ingegneri, matematici, fisici, medici, scienziati del diritto,
psicologi e sociologi, oltre che filosofi.
In attesa che anche gli altri ‘specialisti’ elencati da Maldonado
prendano parte a questo dialogo polifonico, cominciamo a fare intanto la nostra parte, che è quella del contributo che la filosofia e
l’estetica possono apportare alla discussione.
Cerchiamo di vedere anzitutto in che modo la tecnica incida
sulla nostra sensibilità, vale a dire sulla nostra aisthesis, attraverso:
a) la produzione e il consumo di immagini tecnologiche e b) l’impiego
della complessa strumentazione bio-medico-ingegneristica in situazioni che hanno a che vedere con la vita e/o la sopravvivenza
delle persone in una prospettiva che possiamo definire biopolitica
(quando il potere politico si ‘prende cura’ della vita mediante la
regolamentazione normativa dell’impiego delle nuove tecnologie
si entra infatti nel territorio della biopolitica). Cominciamo dal primo punto.
È davvero stupefacente osservare come uno degli effetti più vistosi della tecnica contemporanea sia la progressiva scomparsa del
mondo esterno come insieme di esperienze contingenti ed imprevedibili. In un libro ironico e provocatorio, intitolato Il delitto perTomàs Maldonado, Memoria e conoscenza. Sulle sorti del sapere nella prospettiva
digitale, Feltrinelli, Milano, 2005.
5
12
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
fetto, il filosofo-sociologo francese Jean Baudrillard sosteneva, a
metà degli anni ‘90 del secolo scorso, che la realtà sta subendo un
lento processo di cancellazione ad opera della simulazione; la cosa
in carne ed ossa viene sostituita dalla sua rappresentazione prodotta
tecnicamente. Cosa vuol dire che la realtà sta scomparendo? Vuol
dire che oggi un’immagine digitale, un film, un videoclip non ha
più bisogno di attingere alla contingenza del mondo sensibile, alla
sua fisicità e materialità, ma può essere prodotto in laboratorio,
per così dire, attraverso una sorta di mimesis completamente simulacrale, come ha di recente osservato Pietro Montani nel suo importante libro Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell’età della
globalizzazione6 (un testo al quale faremo massiccio riferimento nel
corso di queste pagine). Tutto questo comporta sicuramente una
specializzazione della ‘sensibilità’ (interagire con le sofisticate macchine informatiche richiede competenza ed affinamento tecnologico notevoli) sia in chi produce sia in chi riceve tale tipo di rappresentazione virtuale. Ma lo specialismo si realizza via via che ci si
allontana (e proprio nella misura in cui ci si allontana) dal mondo
imprevedibile, vario, molteplice della contingenza. Basta guardarsi intorno per rendersene conto. Oggi infatti, scrive Montani, un
qualunque ragazzo di un qualunque paese mediamente industrializzato è più ‘sensibile’ all’ambiente simulato di un videogame che a
quello reale di un paesaggio naturale. Perché? Perché assieme alla
specializzazione tecnica si verifica in lui un livellamento dei tratti
del mondo sensibile considerati pertinenti. E c’è da scommettere
che da adulto quello stesso ragazzo garantirà prestazioni eccellenti
nell’ambiente simulato che l’azienda per la quale lavorerà avrà
preventivamente costruito selezionando quei tratti del mondo contingente che giudicherà più funzionali all’ottimizzazione della
produzione (la quale operazione, sia detto per inciso, non mancherà di ‘plasmare’, influenzandola ed orientandola, la stessa percezione delle cose, la percezione della realtà). È chiaro che, in tale quadro,
l’esperienza effettiva di costui perderà gran parte del tasso di conPietro Montani, Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell’età della globalizzazione, Carocci, Roma, 2007.
6
13
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
tingenza che dovrebbe normalmente caratterizzarla. Basti pensare
ai reality-show, in cui si accetta di programmare in anticipo la propria vita, la cui contingenza sarà ‘finta’, nel senso che si sa fin da
subito che tutto ciò che capiterà (per esempio dentro la casa del
Grande Fratello) non è quello che capita nella vita di ogni giorno,
ma in quella ‘rappresentata’ sotto l’occhio di una telecamera, ecc.
3. Come si può vedere da queste considerazioni, il tema della tecnica ha molto a che fare con il tema della ‘sensibilità’, cioè poi con
la sfera estetica. Ed entrambe, tecnica ed estetica, contraggono poi
un rapporto non superficiale con il mondo delle arti. Uno potrebbe
dire: «che c’entra l’arte?». L’arte c’entra molto, a patto, naturalmente, di non considerarla come una specie di zona dell’essere che si
ritaglia uno spazio franco e, per così dire, si tira fuori dal mondo
(come spesso si è creduto ed, ancora, si continua a credere da più
parti). Non c’è, insomma, un’arte in generale rispetto a cui i singoli
prodotti artistici sarebbero sue varianti storico-fenomeniche. L’insieme dei fenomeni che, almeno a partire dal Settecento, abbiamo
convenuto di chiamare ‘opere d’arte’ rispondono invece ai nostri
bisogni di configurare, in prodotti sensibili, la nostra attitudine e
la nostra esigenza di ricavare senso dall’interazione percettiva col
mondo. Il fatto che per alcuni secoli questo bisogno di ‘fare senso’,
di produrre e di organizzare la sensatezza, si sia condensato in quelle esperienze storiche particolari che chiamiamo opere d’arte non
garantisce affatto che tale compito continui ad essere assegnato alle arti anche per il futuro. Oggi, forse, può essere assegnato alle
immagini prodotte dalla tecnica.
A questa conclusione si arriva qualora la questione del senso in
genere venga precisata in quella, più stringente, della storicità ed
attualità di esso, ossia venga interrogato sotto l’aspetto della verità
storica, ossia del senso del presente storico. In questo caso le cose si
fanno più complicate. Perché il problema della verità storica (o del
senso del presente storico) si impone proprio a proposito delle
immagini e della loro capacità di dire la verità, di dare testimonianza.
Soprattutto, questo problema ci viene imposto non da un pensiero,
ma da un evento, un evento biopolitico: quello dei campi di stermi-
14
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
nio. Un evento, cioè, che ha segnato, come scrive ancora Montani,
una vera e propria catastrofe nell’ordine della rappresentazione,
dalla quale la stessa comprensione moderna dell’arte è stata profondamente segnata. (È la ragione per cui Theodor Adorno sosteneva che scrivere una ‘bella’ poesia dopo Auschwitz è un atto di
barbarie, perché la bellezza implica una conciliazione ed un’armonia col mondo che l’evento dei campi rende oggi impossibile; ed è,
anche, la ragione per cui le immagini, più che belle, devono presentarsi come ‘veritiere’).
4. Dovrebbe risultare evidente, da quello che si è detto fin qui, l’intreccio che, nel mondo contemporaneo, tiene insieme tecnica, estetica (come teoria del sensibile) e arte. Il filo che le unisce è rappresentato dalle immagini. Il problema delle immagini, infatti, ci porta al tema della tecnica che le produce, la quale, attraverso di esse (e non
solo attraverso di esse), incide in maniera consistente sull’orizzonte di senso del nostro tempo, ed ha effetti notevoli sulla costituzione del nostro ‘sentire’. Incidere sulla sfera del sentire significa influire su quel ‘senso’ che, secondo Kant, abbiamo in comune come
membri di una comunità, e che, secondo Hannah Arendt è il fondamento estetico di una teoria del giudizio politico e dello spazio
pubblico.
Ora, se uno degli effetti più potenti della tecnica è quello di contrarre e canalizzare la nostra sfera sensibile, quello cioè di anestetizzare quel senso comune (= il gusto) che è alla base della costituzione di una comunità, allora il compito di un’estetica all’altezza dei
tempi, come si suol dire, è quello di riattivare e riestetizzare quella
nostra capacità di sentire che ci consenta di risintonizzarci sulla lunghezza d’onda del mondo sensibile-contingente dentro cui siamo
immersi. È questo, forse, il senso (o uno dei sensi possibili) contenuto in quel movimento auspicato da Walter Benjamin a metà degli anni Trenta nel suo saggio su L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità tecnica, e che egli caratterizzava come “politicizzazione dell’arte”, da contrapporre alla “estetizzazione della politica”
tipica dei regimi dittatoriali (l’arte di regime come strumento di
organizzazione del consenso e di autolegittimazione del potere).
15
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
Riabilitare il sentire, però, significa anzitutto ricomprenderlo
nella sua intima connessione con la tecnica; e comporta anche un
mutamento del vocabolario tradizionale, per cui si passa da una
concettualità legata al “corpo” ad una legata alla “carne”. Il corpo,
infatti, delimitato e auto centrato, è un facile bersaglio dei dispositivi anestetici che cercano di ottimizzarne le prestazioni sensibili,
mentre la carne, aperta e ibrida, è refrattaria ad ogni ‘riduzione’
positiva, è un bersaglio troppo mobile e di difficile delimitazione7.
Con queste ultime considerazioni siamo entrati in un nuovo
territorio: quello della biopolitica. Di biopolitica ha cominciato a
parlare Michel Foucault nelle lezioni tenute al Collège de France a
partire dalla metà degli anni ‘70. Con questo termine egli intende
designare l’area di incontro tra la sfera del potere politico e la sfera
della vita. La biopolitica (ed il connesso biopotere, inteso come potere sulla vita) nasce e si sviluppa tra il XVII ed il XVIII secolo, e si
precisa come: a) gestione e controllo del corpo umano nell’economia e b) gestione e controllo dei processi biologici del corpo umano in vista di una biopolitica delle popolazioni.
La biopolitica, in altri termini, esprime la convergenza, tipica
del mondo globalizzato, delle pratiche del potere intorno ad un
governo generalizzato della vita attraverso un ‘disciplinamento’ giuridico dell’individuo biologico. La tecnica entra qui in gioco perché
essa incrocia la biopolitica nell’ambito delle biotecnologie.
La conseguenza di questo incontro è che oggi la “nuda vita” è
indissociabile dagli artefatti, da tutte quelle pratiche di manipolazione che richiedono un’attenzione normativa crescente di portata… ‘vitale’, è il caso di dire! Basti pensare al dibattito, molto acceso, sulla modificabilità tecnica del materiale genetico o a quello
sull’autonomia del singolo nella decisione circa il proprio morire,
quando il mantenimento in vita è legato al funzionamento di una
macchina (i recenti casi Welby ed Emanuela Englaro sono esemplari
al riguardo). Tecnica e biopotere, inoltre, convergono su un comune progetto di “assicurazione della vita”. Cosa vuol dire? Vuol
dire che la sfera politica si autoassegna il potere di tutelare il vi7
16
Ivi, pp. 12-14.
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
vente, di proteggerlo dalla sua naturale condizione di apertura alla
contingenza ed all’imprevedibilità del mondo. Come se l’individuo dovesse essere, in un certo senso “immunizzato”, per usare
l’espressione di Roberto Esposito8, ossia protetto da quella situazione di fragilità, di esposizione per eccellenza, che è propria della
vita umana.
Dunque, la componente tecnica della biopolitica manifesta una
ricaduta importante sulla sensibilità, sul senso comune, il quale viene trascinato nella zona di influenza di tutti quei dispositivi attraverso i quali il biopotere si autocomprende, si autolegittima e si autoriproduce. L’insieme di tali dispositivi dà vita a quella che Montani chiama bioestetica. Tali dispositivi, infatti, tendono ad anestetizzare, a comprimere, a ridurre l’esposizione della nostra sensibilità alla variabilità imprevedibile dell’esperienza quotidiana (la quale esperienza quotidiana, sia detto per inciso, nella sua singolarità
e contingenza, ci ‘costringe’ a rispondere, caso per caso, a tale variabilità empirica mediante quella soggettiva elaborazione di significati, di regole, in una parola, di predicati con cui costruiamo i nostri giudizi in occasione delle esperienze particolari, come sappiamo dalla terza Critica kantiana).
Si tratta di un processo di anestetizzazione che investe, in particolar modo, lo statuto delle immagini. In altri termini, il biopotere,
per autolegittimarsi, deve produrre immagini che impediscano
ogni apertura all’altro da sé; per esempio all’irrappresentabile o
all’inattestabile, con cui l’immagine ha contratto, specie dopo Auschwitz, un debito di testimonianza. Auschwitz è stato, da questo
punto di vista, un modello esemplare di biopotere; ma, cosa ancora più importante, la feroce logica biocratica del campo di sterminio – in cui la biopolitica si è rovesciata in tanatopolitica – è ricomparsa, dopo Auschwitz,
negli spazi fisici e giuridici in cui più apertamente il biopotere mostra il suo volto mortifero: negli stupri etnici in Bosnia
Roberto Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, Einaudi, Torino,
2002.
8
17
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
ed in Ruanda, nelle gabbie di Guantanamo, nelle carrette del
mare che si inabissano a largo di Palo Alto e nella palestra della scuola di Beslam, nel carcere di Abu Graib e nel Coliseum
di New Orleans9.
Di fronte a questo scenario inquietante e drammatico, il compito di
una bioestetica radicalmente alternativa a quella sopra descritta
consiste in una sorta di contro-movimento che, lavorando dentro il
dominio della tecnica, ossia sullo stesso terreno del biopotere, riesca,
da un lato, a neutralizzare gli effetti anestetizzanti di cui si parlava
prima e, dall’altro, ad individuare e ad attivare opportunità emancipative, possibilità di sviluppo delle nostre prestazioni sensibili
che un certo impiego delle tecnologie contemporanee comprime e
‘depista’.
5. Si deve ad Hannah Arendt10 la prima denuncia dell’involuzione
della politica moderna verso un governo della “nuda vita”. Un’involuzione che equivale, nella sua prospettiva teorica, ad un’antipolitica, ossia ad una forma politica che inclina verso esiti totalitari.
In questa prospettiva generale si inquadra la sua lucida ed originale rilettura della Critica della facoltà di giudizio di Kant. A suo avviso, quest’opera contiene, nella parte dedicata alla critica dei giudizi estetici, il nucleo della ‘vera’ filosofia politica di Kant, perché
contiene una discontinuità radicale rispetto alla filosofia morale
della seconda Critica. Quest’ultima delinea infatti un’etica normativa, mentre la teoria dei giudizi di gusto della terza Critica contiene
un’etica politica intersoggettiva. La Critica della facoltà di giudizio è,
insomma, un ripensamento importante dell’impianto critico-trascendentale, perché qui l’esperienza di cui si parla non è più
l’esperienza possibile, ma l’esperienza in atto, quella che effettivamente
stiamo per compiere. Dunque, c’è un passaggio da un pensiero sull’Uomo in generale ad un pensiero sugli uomini nella loro concretezza storica; trascendentale e contingente, condizione e condizionato si intrecciano in modo inestricabile.
9
Pietro Montani, Bioestetica, cit., p. 15.
Hannah Arendt, Teoria del giudizio politico, tr. it., Il melangolo, Genova, 1990.
10
18
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
In sostanza, Arendt ritiene che il giudizio estetico sia quello più
simile al giudizio politico, perché, come questo, esposto alla contingenza ed alla pluralità. Questi due tipi di giudizio guadagnano un
terreno più originario, né trascendentale né empirico; un terreno
che si colloca tra l’uno e l’altro, tra universale e particolare, tra riflessione e azione. È, in una parola, il terreno in cui si dispiega il
mondo dell’accadere storico.
Ora, il principio che, secondo Arendt, regola l’agire politico degli uomini come «creature legate alla terra, viventi in comunità e
bisognosi di comunità anche per pensare», è rappresentato dal senso comune, dal senso della comunità, il cui fondamento è quel sentire, quell’aisthesis che si manifesta in modo esemplare nel giudizio
estetico, e la cui condizione essenziale è l’esistenza di uno spazio
pubblico che è quello della polis. Il senso comune/comunitario non
sussisterebbe se tale spazio pubblico fosse rimosso da un’autorità,
dal potere politico, per esempio; o fosse trasformato nel territorio
asfittico dell’oikos, cioè dello spazio privato. Quando lo spazio pubblico viene ridotto ad oikos, allora la nostra sfera estetica subisce un
processo di contrazione; viene cioè ridotta ad intercettare solo le
forme della sussistenza biologica. Il che significa che l’aisthesis, da
sentimento denso di riflessione sul senso della comunità, si degrada a
pura sensazione (Empfindung) che si rinchiude in una sfera privata,
in un giudizio privato. Per queste ragioni Arendt considera la biopolitica delle società odierne una forma di impolitica.
6. Ma il biopotere può forse dar luogo ad altre interpretazioni, come quelle del già citato Michel Foucault, di Roberto Esposito, di
Giorgio Agamben.
Foucault considera la biopolitica come elaborazione di dispositivi di potere esercitati attraverso forme concrete di assoggettamento riferite allo spazio e al corpo. In tal modo, l’orizzonte del
politico viene sottratto ai concetti moderni di sovranità e di contratto sociale e sussunto sotto quello di biopolitica. In questa prospettiva, il biopotere è quella forma particolare di potere che si esercita
in una zona che è giuridicamente ‘estrema’, perché si traduce in
pratiche che prescindono dal vincolo del nomos sovrano, anzi lo
19
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
mettono in crisi perché mostrano che il potere non si ‘applica’ giuridicamente agli individui, ma li attraversa costituendoli come soggetti. Il biopotere è dunque un potere che si sgancia da ogni teoria
della sovranità, mentre fa entrare direttamente la vita ed i suoi
meccanismi nei progetti politici, ed il potere/sapere diventa un
agente di trasformazione della vita umana. La biopolitica è dunque, secondo Foucault, una trasformazione moderna del ‘politico’,
non una sua negazione ‘impolitica’ come per Hannah Arendt.
Giorgio Agamben riconosce a Foucault il merito di aver individuato nella politicizzazione della ‘nuda vita’ uno degli eventi decisivi della modernità. Rispetto a Foucault, però, Agamben vuole
trovare un terreno di intersezione in cui confluiscano le tecniche
politiche volte alla cura della vita da parte dello Stato, da una parte, e dall’altra quelle ‘tecnologie del sé’ con cui l’individuo produce la sua identità personale. Tale terreno ‘incrociato’ è, a suo avviso,
rispecchiato da un corrispondente incrocio o intersezione di modelli formali: quello giuridico-istituzionale e quello biocratico, sulla cui base il potere sovrano produce un corpo biopolitico. Dunque, sovranità e biopolitica sono inseparabili. Il problema che qui
si pone è semmai quello di vedere come mai la politica occidentale
si sia costituita escludendo la zoé, mettendo, cioè, la ‘nuda vita’,
l’animal laborans al bando della polis (dunque, considerandolo impolitico). Questa esclusione però non è una vera esclusione, perché,
dice Agamben, mentre esclude, in qualche modo include. È un’esclusione inclusiva, come attesta la figura giuridico-arcaica dell’homo sacer (un uomo che può essere ucciso in ogni momento, ma mai sacrificato o giustiziato; rientra dunque nell’ambito del diritto proprio tramite il fatto che ne viene escluso11). Qui emerge il significato della “messa al bando”, dello “stato di eccezione” e dunque del
concetto di “sovranità”. Sovrano, diceva Carl Schmitt, è chi decide
circa lo stato d’eccezione, cioè chi sospende la vigenza delle leggi.
Qualcosa di molto simile avviene nel rapporto tra zoé, pura animalità, e bios qualificato politicamente, cioè ‘forma di vita’. Il ‘bando’
Cfr. Giorgio Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi,
Torino, 2005.
11
20
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
della nuda vita sarebbe, in sostanza, ciò sulla cui esclusione-inclusiva si fonda la città degli uomini, la polis moderna. In altri termini,
nel corso della modernità l’eccezione diventa, via via, la regola; e
lo spazio della nuda vita, in origine ai margini della città, progressivamente coincide con lo spazio politico. Così, bios e zoé, inclusione ed esclusione, entrano in una zona di indistinzione, occupando
quel terreno incrociato di cui si parlava prima. Da questo punto di
vista, a parere di Agamben, la democrazia moderna è prevalentemente lo sforzo di trasformare la nuda vita in forma di vita. Ed alcuni eventi tipici della modernità, come la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo, ma anche altri più recenti come l’eugenetica nazista, il
dibattito giuridico sull’eutanasia o sull’interruzione dell’accanimento terapeutico, non rappresentano un’indebita intrusione di principi biologici e tecnologici dentro l’ambito del politico, ma acquistano un loro senso preciso se ricondotti nella sfera biopolitica.
Questo significa che il campo di sterminio come spazio biopolitico, in cui l’eccezione è stata la norma, diventa il paradigma dell’orizzonte politico della modernità (in cui restano indistinguibili
biopolitica e tanatopolitica). Cosa comporta tutto questo? Che oggi
vita e morte non sono più, propriamente, concetti scientifici, ma
politici, perché dipendono da una decisione connessa ad una manipolazione del vivente resa possibile dalla tecnica. Oggi infatti la
nuda vita può essere ‘prodotta’ e interamente ‘controllata’ dall’uomo e dalla sua tecnologia. Ma anche in questo caso, come nel precedente di Foucault, commenta Montani, la lucida ed originale analisi di Agamben non sembra cogliere, nella sfera biopolitica e nella
tecnica che l’attraversa, opportunità positive ed emancipative.
Opportunità che si trovano invece nella prospettiva di Roberto
Esposito, il quale situa il fenomeno biopolitico dentro un modello
che egli definisce “paradigma immunitario”. Anche Esposito cerca
di delineare un’area di intersezione che contenga la sfera della vita
e quella del diritto. In vista di questo, elabora il concetto di immunità nella sua valenza medica e giuridica insieme (= refrattarietà nei
confronti di una malattia ed esenzione di un soggetto da alcune
conseguenze giuridiche; v. l’immunità parlamentare, ecc.). Dal
concetto di immunità, egli deriva poi il concetto, vicino a quello di
21
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
esclusione inclusiva, di protezione negativa della vita. La protezione
immunitaria, infatti, contrasta il male includendolo nei suoi confini. L’idea di fondo qui è che la vita, per restare tale, deve, in un
certo senso, separarsi da sé inserendo qualcosa che la contraddica.
Qui davvero vita e morte sono strettamente legate; perché l’eccesso di protezione della vita si rovescia nel suo contrario (per esempio, nelle malattie autoimmuni, in cui il sistema immunitario
si rivolge contro l’organismo che dovrebbe difendere; ma anche in
alcuni eventi biopolitici contemporanei: per esempio, nelle eccessive misure di sicurezza antiterroristiche dopo l’11 settembre, in
cui l’ossessione del pericolo diventa essa stessa pericolosa, o nell’insicurezza sociale artificialmente dilatata al punto da produrre
spesso rimedi peggiori del male, ecc.).
Esposito scorge però delle opportunità positive all’interno dell’orizzonte biopolitico. A suo avviso, infatti, accanto ad una biopolitica intesa (e, soprattutto, praticata) come biopotere (potere sulla
vita), c’è una biopolitica intesa come politica della vita. È in quest’ultima che, per esempio, si profila una protezione positiva del diverso e dell’estraneo. È la tolleranza immunitaria che si realizza nel fenomeno della gravidanza e della nascita (v. il concetto di natalità di
H. Arendt). Qui, infatti, il sistema immunitario non solo non aggredisce il ‘diverso’ impiantato nell’organismo, ma lo accoglie e lo
protegge proprio in forza della sua provenienza esterna.
Dunque, una lettura ‘affermativa’ della biopolitica è possibile. È
col Nazismo che il governo della vita degenera. Il Nazismo trattò
infatti il popolo tedesco come un ‘corpo organico’ bisognoso di una
cura radicale consistente nell’asportazione ‘chirurgica’ di una sua
parte spiritualmente morta (l’“ebraicità”), in tal modo realizzando
una straordinaria convergenza di politica e tecnica.
7. Ma ritorniamo, dopo questa lunga parentesi, al discorso che era
stato avviato nelle pagine iniziali di questo lavoro, quello cioè relativo al rapporto tra téchne ed aisthesis. Non c’è dubbio, infatti, che il
progetto di assicurazione della vita, che nell’eugenetica nazista si rovescia in tanatopolitica, deve far ricorso ad una bioestetica, come si
è già accennato. In questo caso si tratta, però, come si è già detto,
22
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
di una bioestetica negativa, perché il suo compito consiste in un’opera di anestetizzazione e canalizzazione della nostra sfera sensibile.
C’è, però, accanto a questa, una bioestetica positiva; una bioestetica,
cioè, che si propone di contrastare la portata mortifera del biopotere attraverso un’opera di ‘sensibilizzazione’, come si suol dire, ossia di riabilitazione delle ragioni del sensibile che sono insite nei
concetti di corpo, nascita, individuo.
Come si può vedere, pertanto, è la sensibilità l’elemento fondante sia delle pratiche del biopotere che di una bioestetica ‘positiva’.
Si tratta, allora, di circoscrivere l’area in cui si stabilisce un rapporto ‘virtuoso’ tra l’oggetto dell’estetica e quello del biopotere.
Se il sentimento estetico è ciò che fonda l’essenza storica dell’uomo
(Schiller); e se il giudizio di gusto fonda, a sua volta, la comunità storica degli uomini (Kant), allora il giudizio di gusto acquista una
forte valenza biopolitica12. Il sentimento estetico così inteso è centrale nella prospettiva bioestetica delineata da Montani, perché esso rende possibile un’ampia apertura sull’estensione e la molteplicità delle forme e degli eventi della natura. Esso rappresenta la
dimensione attraverso cui ci sentiamo in sintonia con la varietà del
mondo perché esso ci consente di trasformare i dati e i segnali che
riceviamo in esperienze sensate e condivisibili. L’estetica è allora quell’importante spazio riflessivo che consente al sentire umano, all’aisthesis, di aprirsi alla praxis e di legarsi alla dimensione artificiale della tecnica. Ecco perché il sentimento estetico secondo Schiller
è quello su cui deve puntare l’educazione dell’umanità. Quando
infatti questo sentimento viene degradato, come, secondo Schiller,
succede nella modernità (proprio a causa dell’impetuoso sviluppo
delle tecnologie produttive), dove il gioco armonico (il ‘libero gioco’ kantiano) di sensibile e razionale è squilibrato a vantaggio di
una ragione astratta e calcolante, allora il compito storico di un’educazione estetica dell’uomo è quello di riattivare proprio le prestazioni sensibili di ciascuno, facendo uscire l’umanità dallo stadio di
barbarie cui l’ha condotta il degradarsi della sfera sensibile.
12
Pietro Montani, Bioestetica, cit., pp. 39 ss.
23
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
8. Si diceva prima del carattere operativo/artificiale del senso comune (cui è affidato il compito di costruire una comunità). Questo
ci riporta a parlare della tecnica.
La tecnica è coessenziale all’uomo. Nel senso che la vita è tecnica fin dalla sua origine. La vita infatti si esteriorizza attraverso un
prolungamento inorganico (= le protesi) che incide significativamente sull’organizzazione della sua sensibilità. Ora, questo essere
protesico dell’uomo riceve sempre più marcatamente una delega
tecnica, per cui si verifica una crescente dissociazione dell’uomo
dalle protesi, come se esse fossero dei semplici prodotti e non parte
del suo essere. Questa autonomia della tecnica incide, come si diceva, sulla dimensione sensibile perché trasforma l’ambiente estetico-percettivo (quello ‘concreto’, in carne ed ossa) in simulacri gestiti da un programma (videogames, mappe interattive sulle auto,
simulazioni di operazioni di guerra, ecc.). Tutto questo produce,
naturalmente, una forte riduzione della capacità della nostra sensibilità ad esporsi all’imprevedibilità contingente dell’accadere storico e di elaborarla in senso. Lo stesso universo tecno-globale, inglobando e fagocitando tutto, ma proprio tutto, cancella ogni ‘alterità’
ed ogni ‘fuori-campo’. In queste condizioni, la nostra aisthesis viene ‘ottimizzata’, nel senso che oggetti, ambienti, stimoli nei cui confronti dobbiamo essere sensibili vengono quasi imposti, ossia selezionati/costruiti artificialmente in anticipo; per cui li riconosciamo
senza sforzo, quasi passivamente ed acriticamente. È come se la nostra aisthesis venisse inflazionata, facendole invadere anche i territori
della nuda vita quotidiana (body-building, fitness, dietetica, ecc.).
Di fronte a questa realtà, l’arte ha il compito storico di riorientare criticamente la nostra esperienza. Solo che oggi, come sostiene
Montani, è venuto meno il valore ‘esemplare’ delle opere d’arte.
Nel senso che le questioni relative al senso non si raccolgono più
nell’opera d’arte, ma altrove, in altri territori. Questi territori sono
in gran parte tecnici. Passiamo allora a considerare, aiutati dalle
acute analisi di Montani, un altro importante aspetto del problema
che stiamo trattando: quello del rapporto tra le arti e le tecniche
nell’odierno universo globalizzato.
24
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
9. Prima di passare alle conclusioni del nostro discorso, è il caso di
soffermarsi distesamente su alcuni di quegli interrogativi che venivano enunciati all’inizio di queste considerazioni. Il tema del rapporto tecnica-filosofia, infatti, ci costringe ad interrogarci (e a reinterrogarci) su questioni cruciali che riguardano il nostro destino di
uomini e donne che vivono nell’era digitale, ossia in un mondo totalmente avvolto, e tendenzialmente imprigionato, dalla Rete di
cui ciascuno rischia di essere un terminale; in un mondo, cioè, ipertecnico in cui le emozioni, le passioni, i sentimenti, in una parola,
le identità soggettive, corrono il pericolo di essere tradotte in sequenze algoritmiche. Di fronte al dilagare della Grande Macchina Mondiale, si profila almeno la possibilità di salvarci, rifugiandoci in un
luogo ed in una pratica (per esempio, nel territorio delle arti) che
preservino e addirittura potenzino la nostra capacità critico-decostruttiva nei confronti della globalizzazione socio-economica e favoriscano l’affermarsi della nostra singolarità soggettiva? Questi interrogativi sono, per esempio, al centro di un altro libro recente curato da Pietro Montani assieme a Mauro Carboni13, il quale, come
si può intuire già da queste domande, non è una specie di resoconto nostalgico per la perdita di qualcosa (per es. della bellezza magico-sacrale propria dell’arte auratica, per introdurre subito la terminologia inaugurata da Walter Benjamin nel suo celebre saggio
su L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, su cui torneremo nel corso delle pagine finali); e dunque, meno che mai è il
tentativo di reinstallare uno spazio estetico inteso come spazio separato, destinato al ‘godimento’, all’evasione, al divertimento, ecc. È
invece il tentativo di ripensare molto seriamente i risvolti filosofico-estetici presenti nelle varie forme di alleanza e di conflitto che
hanno variamente segnato la storia dei rapporti fra arte e tecnica. I
temi affrontati nel libro ci consentono di discutere il problema del
rapporto arte/tecnica secondo una prospettiva che parte da Kant e
giunge alla situazione presente attraverso Heidegger e Benjamin.
Pietro Montani-Mauro Carboni, Lo stato dell’arte. L’esperienza estetica nell’era
della tecnica, Laterza, Roma-Bari, 2005.
13
25
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
Walter Benjamin rappresenta un punto di riferimento obbligato e
privilegiato di ogni discorso che oggi voglia affrontare in modo non
superficiale le complesse questioni teoriche racchiuse nel rapporto
arte-tecnica. È stato infatti Benjamin a scorgere, con molta lucidità
teorica e con una buona dose di quello che Diderot chiamava “spirito di divinazione”: a) la prevalenza sempre più marcata, nelle cosiddette opere d’arte, dei valori ‘espositivi’ sui valori ‘cultuali’ (legati all’unicità-irripetibilità dell’opera), e cioè i fenomeni dell’esteticità
diffusa, della fruizione distratta, della massificazione, ecc. che incidono profondamente sullo statuto delle opere d’arte contemporanee; b)
il carattere di riproducibilità tecnica che caratterizza la produzione di
immagini. Tale carattere non solo modifica significativamente il nostro apparato percettivo, ma, in qualche misura, modifica anche la
realtà che viene percepita, o meglio, i nostri modi di percepirla. Questa
prevalente funzione critico-conoscitiva insita nelle immagini riprodotte tecnicamente offre inedite possibilità di trasformazione politica della realtà stessa. All’autoestraneazione dell’umanità, che vive,
per esempio nella guerra, il proprio annientamento come un godimento estetico (v. l’esaltazione della ‘bellezza’ dei lanciafiamme o
delle mitragliatrici nell’arte futurista, che rappresenta molto bene
l’effetto dell’estetizzazione della politica operata dai regimi fascisti),
bisogna opporre la politicizzazione dell’arte.
In questi due aspetti della riflessione di Benjamin, contenuti nel
noto saggio sulla riproducibilità tecnica delle opere d’arte del 193614,
e che qui ho cercato di riassumere in forma estremamente schematica, si concentrano i nodi teorici più importanti che stanno, anche
oggi, alla base del rapporto arte-tecnica.
10. La relazione tra arte e tecnica è una relazione costitutiva e non
occasionale. Téchne in Grecia copriva i significati di entrambi i termini (téchne era sia l’arte del pittore, dello scultore, del musico, ma
anche quella del fabbro, del falegname, di chi guida un esercito o
governa una nave, ecc.). È solo con la nascita dell’estetica moderna
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, tr. it.
di E. Filippini, Einaudi, Torino, 1966.
14
26
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
che esse si separano, generando, proprio attraverso tale dissociazione, nuove forme di relazione. Una cosa comunque è fuori discussione, l’opposizione moderna (e contemporanea) tra arte e
tecnica non si fonda sulla bellezza. Ce lo mostra in modo esemplare colui che viene considerato il padre dell’estetica moderna, ossia
Kant.
In Kant il rapporto arte-tecnica si definisce, come ha mostrato
molto bene Montani, attraverso il rapporto di entrambe con un
terzo: e cioè con la natura. Mentre però in un primo tempo Kant
sembra mettere fuori gioco la natura in quanto causalità rigida,
meccanicità ed istintualità animale (v. l’esempio dell’alveare, che
può essere mirabilmente perfetto, ma rimane sempre l’esecuzione
di un programma genetico, differente, perciò, dalla tecnologia più
elementare dell’uomo in quanto questa presenta una componente
plastica, creativa, di libera riflessività razionale, progettuale che la
prima non ha), in un secondo momento recupera il concetto di natura nel significato greco di physis. «L’arte bella – scrive infatti
Kant nel § 45 della Critica della facoltà di giudizio – è téchne in quanto
pare essere, nello stesso tempo, natura». Qui viene messo in luce il
carattere tecnico dell’arte bella come ciò che riproduce, che rifà a
modo suo il processo autogenerativo, autopoietico della physis. La physis
è cioè vista come un venire alla luce, un apparire sensibile, un fenomenizzarsi di qualcosa, e, precisamente, un venire alla luce, un
venire ad essere degli enti. Dunque l’arte bella come tecnica, scrive
Montani, è il fenomenizzarsi, il far venire alla luce quegli enti che
non hanno la spontaneità della physis, che non ce la fanno a venire
alla luce da soli.
L’aspetto più importante di questa lectio difficilis che Montani
propone della distinzione kantiana tra arte e tecnica è una sorta di
definizione dell’arte bella per genere prossimo e differenza specifica. Arte e tecnica sono infatti accomunate dall’essere attività razionale umana, progettualità, trasformazione plastica delle esperienze, innovazione. La specificità dell’arte rispetto alla tecnica in genere sta allora nel fatto che l’arte, a differenza della tecnica, si incarica di esibire in modo esemplare proprio quella libera creatività, ossia
l’aspetto plastico innovativo con cui gli uomini riorganizzano le
27
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
loro esperienze per dare loro un senso. Questo è, per esempio, ciò
che fa il genio.
Un’altra conclusione importante, che si può trarre da Kant, è
che in lui è presente un modo di pensare la tecnica secondo cui
questa sarebbe un’aggiunta, qualcosa di non costitutivo della specificità umana dell’uomo (paradigma impersonato da Arnold Gehlen). L’altro paradigma (esemplificato da André Leroi-Gourhan)
è quello opposto secondo cui la tecnica è una sorta di prolungamento inorganico dell’organico, un sistema di protesi costitutivo
dell’essere umano, del suo operare in genere.
Il risvolto filosofico di questo secondo paradigma (la tecnica
come protesi essenzialmente umana) porta ad Heidegger, che abbiamo incontrato all’inizio del nostro discorso. E precisamente,
porta all’idea secondo cui la tecnica non è qualcosa di strumentale,
la sua essenza consistendo invece nel far apparire il mondo abitato
dall’uomo; la tecnica è cioè un modo di disvelamento degli enti,
ossia, nella prospettiva heideggeriana, verità, alétheia. Una verità
che consiste nel portare le cose all’apparire luminoso, mantenendole in un rapporto essenziale con il fondo oscuro da cui provengono. L’essenza veritativa della tecnica consiste allora in questa capacità poietica, in questo compito progettuale umano di far venire
all’essere quegli enti che, come si diceva prima, non ce la fanno a
venirci da soli perché non hanno la stessa forza autogenerativa
della physis. E qui Montani, rilavorando con molta finezza teoretica la distinzione kantiana arte-tecnica di cui ha proposto la lectio
difficilis sopra accennata, ne propone una versione heideggeriana
del seguente tenore: l’arte è téchne perché, nello stesso tempo, si
porta all’apparenza, cioè produce, come se fosse natura (physis). E
questo produrre è un poiein che rivela una essenziale inerenza al
mondo della physis. Dunque, l’arte si precisa come disvelamento,
anzi, come messa in opera di tale disvelamento, cioè della verità.
Questo significa che nell’arte il poiein non si esaurisce nel prodotto,
ma conserva una relazione molto stretta con qualcosa di non-prodotto. Questa inerenza a qualcosa di ancora non svelato fa del produrre un attingere ed un ricevere, oltre che un generare, inquadrandosi in tal modo in una poiesis ricettiva. E tuttavia, se andiamo a
28
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
vedere in che modo concretamente la poiesis artistica fa accadere la
verità nelle diverse contingenze storiche della contemporaneità,
Heidegger non ci dice poi molto. Si rifugia nella poesia come ‘linguaggio originario’ dell’Essere, come ‘ciò che fa essere’ le cose nominandole, e chi s’è visto s’è visto.
Il chiarimento del rapporto arte-tecnica richiede pertanto il ricorso ad un altro paradigma, che è quello offerto alla nostra riflessione dalle lucide analisi di Walter Benjamin sinteticamente richiamate prima. Le analisi di Benjamin sono molto importanti dal
punto di vista dal quale siamo partiti, non tanto perché, come si
accennava prima, mettono in luce i rischi ‘regressivi’ connessi alla
tecnica contemporanea, quanto perché individuano le notevoli
opportunità emancipative offerte dalla riproducibilità tecnica delle
arti contemporanee.
Ma anche Benjamin non ci dice molto. Non ci dice, in particolare, in che modo i nuovi valori espositivi dell’arte (che hanno soppiantato quelli cultuali della tradizione) offrano opportunità di contrasto della manipolazione delle coscienze e del processo di consolidamento di quella che Theodor Adorno chiamava l’industria culturale. Benjamin va pertanto ripreso e sviluppato. E va ripreso e
sviluppato in quello che è il luogo teoricamente più produttivo del
saggio sull’opera d’arte, cioè il tentativo di operare una ricognizione dello statuto dell’immagine così come questo si ridefinisce in
presenza della riproducibilità del mondo visibile, ossia in presenza
della fotografia e del cinema.
La prima conseguenza dell’irruzione della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte nel mondo contemporaneo è la messa in crisi
del concetto tradizionale di ‘opera’ così come questo si è via via
delineato nella tradizione occidentale (almeno a partire dalla Poetica di Aristotele) con i suoi requisiti di originalità, unità, coerenza,
ecc. che si trasformano, per effetto della tecnica, in discontinuità e
pluralizzazione. Una prova lampante di ciò è offerta dal cinema. Il
concetto e la pratica del montaggio comporta infatti la possibilità
di interrompere il testo filmico in ogni momento per aprire sviluppi reticolari imprevisti ed inediti che ‘aprono’ una pluralità di
direzioni.
29
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
Strettamente legato alla crisi del concetto di opera è un altro aspetto importante messo in luce da Montani (e nel quale risiede
l’originalità della sua lettura): quello per cui l’esperienza dell’immagine si apre su un terreno nuovo, in cui gli aspetti creativo-poietici (originalità, novità, ricchezza di senso, piacere ecc.) cedono il
passo a fenomeni nuovi, non riducibili all’ambito estetico moderno. Se infatti oggi c’è ancora qualcosa come l’arte, scrive Montani,
essa va ridefinendo il suo rapporto con la tecnica su un terreno che
è non più estetico-moderno (nel senso del piacere della fruizione,
della bellezza ed unicità dell’opera), ma etico-politico. Essa, cioè, non
ha più il compito di salvaguardare l’essenza poetica, veritativa della
tecnica (Heidegger), ma quello di far apparire le implicazioni etiche
contenute inavvertitamente o celate consapevolmente dalla tecnica
moderna. Così, mentre la creatività si va oggi standardizzando
nell’universo globalizzato dei media (ci sono ormai settori in cui ci
sono più ‘creativi’ che ‘operativi’), la poiesis, anche se non è certo
scomparsa, tuttavia dipende dagli aspetti etici del fare artistico, ossia
da pratiche produttive che mirano ad un’etica della forma 15.
In tal modo l’arte si carica di una forte istanza testimoniale che
cerca, proprio nella tecnica, le risorse per decostruire/interpretare
i processi di autolegittimazione dell’economia globalizzata (guerre
preventive, terrorismi, violazioni dei diritti dell’altro, ecc.). Cambia allora il destino dell’arte, che non è più quello di rappresentare,
di mettere in bella forma, di generare piacere, ma quello di trovare/costruire spazi inediti per l’esercizio della documentazione, della
riflessione critica, della testimonianza.
Questo aspetto del carattere etico dell’esperienza dell’arte, centrale nel saggio di Montani, che qui riprende e arricchisce con nuovi innesti teorici una prospettiva già presente nella parte finale de
L’immaginazione narrativa del 1999 e poi nel saggio introduttivo a
L’estetica contemporanea Il destino delle arti nella tarda modernità, del
200416, è presente anche nella seconda parte del libro di cui stiamo
Paolo Montani, in Paolo Montani-Mauro Carboni, Lo stato dell’arte, cit., pp. 16-17.
Paolo Montani, L’immaginazione narrativa. Il racconto del cinema oltre i confini
dello spazio letterario, Guerini e Associati, Milano, 1999; Paolo Montani (a cura di),
15
16
30
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
parlando, quella curata da Massimo Carboni. Il quale si chiede che
ne è oggi dell’esperienza artistica nell’epoca del digitale informatico e delle immagini virtuali. Di fronte alla smisurata potenza ipertecnologica, per cui la rete tende ad assorbire tutto il semantico ed
il qualitativo; in un’epoca in cui tutto si va risolvendo nel numerico-algebrico, realizzando il grande sogno di Cartesio, sarebbe ingenuo e fallimentare ogni tentativo, da parte delle arti, di rincorrere le ipertecnologie sul loro stesso terreno: il rischio più grave è infatti quello di far annegare l’arte nel grande mare informatico, trasformando il “www.” in una specie di odierna Opera d’Arte Totale che non lascia spazio all’imprevisto ed al casuale, al contingente
ed all’evento; in cui nulla di veramente nuovo accade, ma tutto è
già accaduto, giacché tutto era stato previsto che accadesse proprio
nel modo in cui accade. Ma un mondo in cui tutto è accaduto, è un
mondo in cui, in realtà, non accade nulla.
Dunque, la Megamacchina mondiale come esito finale dell’arte
(in cui questa realmente finisce)? Davvero non c’è più scampo? Forse no. Forse qualcosa si può fare. A patto, naturalmente, di non
pensare il rapporto arte-tecnica come un rapporto storico-cronologico, ma dialettico. Così come Benjamin pensò la tradizione non
come antecedente cronologico del moderno, ma come una sorta di
suo contrappunto mobile, allo stesso modo i linguaggi artistici (che
delimitano e preservano specificità operative) non devono precedere la loro totalizzazione cibernetica per essere risucchiati dal
grande vortice virtuale, ma devono persistere e riproporsi ad ogni
tappa come il contrappunto mobile, per dirla con Benjamin, dell’ipertecnica, come ciò che le sta costantemente di fronte senza farsi
risucchiare.
Di fronte alla rete che sta fasciando il pianeta, e che genera un
Unico Grande Intelletto, un Nous anonimo, privo di contingenza,
disincarnato e puramente algebrico; di fronte, cioè, a questa progressiva anestetizzazione della nostra vita sensibile, che riproduce,
come si vede, gli stessi deleteri effetti della bioestetica negativa di
L’estetica contemporanea. Il destino delle arti nella tarda modernità, Carocci, Roma,
2004.
31
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
cui si è parlato sopra, il compito dell’arte è quello di aiutarci a ritrovare, proprio dentro e attraverso la complessità della tecnica, il
senso della nostra contingenza e della nostra precarietà soggettiva,
il senso, cioè, del limite come ciò che ci è più proprio e che massimamente ci identifica, preservando la nostra vita analogica dalla
probabile dispersione digitale-numerica.
Noi ci percepiamo e ci sentiamo in quanto enti finiti. Sentire, allora, è sentire la differenza, ossia la finitezza, che, nella sua limitatezza, è perfetta: è la ‘perfezione del limite’, come dice Carboni. E l’opera d’arte è l’esempio di tale perfezione. L’arte si insedia allora su
questa aisthesis del limite, che dà voce al trascolorare impercettibile
delle differenze, delle singolarità e delle soggettività. Come? Per
esempio contrapponendo all’iperattivismo tecnologico l’inoperosità, il non-fare, l’otium come cifra non alienata del fare (che ha segnato l’itinerario di artisti come Duchamp, John Cage, Andy Warhol). Si tratta di un’opera in cui non c’è più forma in senso tradizionale, ma solo un comportamento come ethos, come tecnologia del
sé. In un’estetica dell’inoperosità, quale è quella prospettata da Carboni, l’arte può riacquistare un ruolo significativo se praticata come disciplina, movimento interno, prassi silenziosa di ascolto. In
un mondo on line che impone incessantemente di comunicare (non
importa cosa), il silenzio diventa più temibile della parola.
Inoperosità, silenzio, ascolto come nuovi criteri estetici richiedono
una nuova figura demiurgica che Carboni definisce “asceta ipertecnologico”. È un asceta, ma sarebbe meglio forse chiamarlo grande ironista, perché fa affiorare continuamente l’essenza non tecnica
della tecnica (v. Heidegger17), sta dentro e fuori, utilizza e dismette
le ultrasofisticate tecnologie; dice, al tempo stesso, sì e no. Questo
artista ipertecnologico è capace di una ubiquità operativa che rende impossibile localizzare la sua connessione con la tecnosfera
perché può attivarsi e azzerarsi in ogni luogo e in ogni momento. Un
esempio molto eloquente di ciò si ha nella musica postweberniana,
in Stockhausen, per esempio, nel quale c’è coincidenza di invenzioCfr. Martin Heidegger, La questione della tecnica, in Id., Saggi e discorsi, tr. it.
a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano, 1976, pp. 5-27.
17
32
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
ne ed esecuzione musicale. Una coincidenza che ci riporta alla percezione dell’originaria ricchezza del mondo sonoro e del singolo
suono nella sua concretezza fisico-acustica, per cui si assiste, come
sottolinea Luigi Rognoni, all’esperienza della genesi della sonorità
e ad un insperato ritorno alla natura via elettronica18.
Specie quest’ultimo passaggio (percepire l’esperienza della nascita, del venire alla luce, ecc.) chiama in causa il problema del soggetto, dell’identità personale, cioè della differenza. E, dunque, della
caducità/irripetibilità che segnano sì la nostra condizione ontologica, ma che rappresentano, al tempo stesso, la nostra risorsa.
Oggi la nostra autenticità, la nostra identità, sono messe seriamente in discussione. Di fronte alle biotecnologie ed all’ingegneria
genetica è veramente problematico identificare un sé che stia saldo
al fondo della nostra intimità. La possibilità di farlo è affidata a questa pratica artistica che consiste in un movimento, simile all’agostiniano in te ipsum redi, che è un risalire e ricondursi presso di sé,
un ritrovarsi a casa e, in tale intimità silenziosa, ascoltarsi. Solo in
tal modo riusciremo a superare l’inquietudine che fa tremare il cor
nostrum e ritrovare quel “cuore che non trema” della bella e rotonda verità di cui parlava il vecchio Parmenide.
Come si vede, la carne messa al fuoco è molta, e molto succulenta. I punti suscettibili di discussione sarebbero molti. Io mi limito qui a toccarne due, fra loro interconnessi, che mi sembrano di
particolare interesse: a) il problema della poiesis e dell’apparenza, su
cui si è soffermato soprattutto Montani, ma a cui anche Carboni
dedica considerazioni non marginali; b) il problema, strettamente
connesso al primo, del carattere ricettivo di questa poiesis e quello
(evocato da Carboni) dell’aisthesis come capacità di ascolto; ovvero, dell’arte come disciplina silenziosa con cui raggiungiamo la nostra inalienabile singolarità.
Per quanto riguarda il primo punto, riprendo e rilancio la posta
messa in gioco da Montani. Egli dice, giustamente, che la vecchia
poiesis, quella legata all’estetica moderna, o si sta consumando o si
è trasferita altrove, standardizzata nell’immaginario globalizzato
18
Cfr. Luigi Rognoni, in Paolo Montani-Mauro Carboni, op. cit, pp. 160-62.
33
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
dei media. E tuttavia, lo stesso Montani, quando parla della nuova
dislocazione territoriale dell’arte (non più estetica, ma etica), non
può fare a meno di evocare, come suo compito essenziale, quello
di “far apparire” qualcosa di decisivo nell’ambito delle implicazioni etico-politiche iscritte nella tecnica. Ora, far apparire qualcosa,
è operazione strettamente necessaria ad una poiesis. Questo vuol
dire che oggi l’arte, se dobbiamo continuare ad usare questo termine, è caratterizzata da una poiesis che, a contatto con la tecnosfera, si risignifica, come direbbe Aldo Trione; nel senso che non è più
quella inventiva e ri-creativa, fonte di godimento e di bellezza, di
armonia e consonanza, della tradizione moderna, ma è invece quella attestata da un’etica della forma. Ecco, questa espressione è il
cuore filosofico del ragionamento di Pietro Montani. Per questo
vale la pena di spendere qualche parola su di essa.
11. La domanda da cui partire è: cosa significa ‘etica della forma’?
Significa far vedere, far apparire istanze etiche non come contenuti
già dati che entrano poi in una forma la quale, proprio per questo,
si qualificherebbe come etica. La forma etica non è, insomma qualcosa che succede, che viene dopo, ma viene prima. La forma dell’arte, scriveva, per esempio, Benjamin nella versione del saggio sull’opera d’arte ritrovato fra le carte di Max Horkheimer e pubblicato solo nel 198919, è un Vormachen, un anticipare la natura, prefigura
immagini di cui ancora non si conoscono i fini. Analogamente, la
dimensione etica deve poter essere percepita ed, in qualche misura, anticipata dentro le procedure poietiche, tecnico-compositive
che si condensano in una forma. Ne La volontà di potenza Nietzsche
scriveva che si è artisti se si sente come un contenuto, come la cosa
stessa, ciò che i non artisti chiamano la forma. Si assiste così ad un
capovolgimento radicale e paradossale del tradizionale rapporto
forma-contenuto, perché il contenuto diventa qualcosa di puramente formale, compresa la nostra vita.
Di esso dà conto, con interessanti considerazioni, Clemens-Carl Härle (Clemens C. Härle, Arte e tecnica, rituale e gioco. Appunti per una rilettura de L’opera d’arte
di Benjamin, in «Forme di vita», nn. 2-3, 2004, pp. 150-163.
19
34
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
Un’etica della forma significa allora riassegnare alla poiesis, nell’epoca tecnologica, un nuovo primato, non più estetico in senso
moderno, ma etico. Un’etica della forma rinvia ad una poiesis che si
organizza con un corredo di figure adeguate al nuovo compito che
l’arte si incarica di svolgere: la riprovazione, il rifiuto, la condanna, o
il pudore, la dignità, la reticenza individuate dallo stesso Montani
commentando il film Sotto gli ulivi di Abbas Kiarostami in chiusura del libro su L’immaginazione narrativa citato prima20. L’essenziale
è però che tutte queste figure non siano il presupposto di giudizi
morali (altrimenti faremmo un trattato di etica e non gireremmo
un film), ma l’effetto di un movimento, anzi di una com-mozione,
di un pathos generato da una forma (un pathos nel senso in cui ne
parlava Hegel nelle Lezioni di estetica, dove si legge che il pathos è
una delle potenze universali che smuovono e muovono l’animo nelle
regioni più intime dell’uomo, nel senso che lo muovono all’azione).
Esso è cioè il centro autentico dell’arte, perché è il pathos che opera
essenzialmente nell’opera d’arte e nello spettatore. Pur essendo,
infatti, una forma sensibile, il pathos «tocca una corda che risuona
in ogni petto umano»21. Ci deve essere, in altri termini, un equivalente del piacere estetico come ‘molla’ che fa scattare il disaccordo, il
‘dire no’; che ci fa, come si suol dire, “infiammare di sdegno”, che
ci muove al rifiuto. E che richiede l’adesione soggettiva-singolare di
ciascuno, Qui sta la differenza tra ethos ed aisthesis; l’etica, come ha
sottolineato efficacemente anche Fabrizio Desideri22, è fondata su
un ‘noi’, l’estetica su un ‘io’, sulla singolarità.
Forse l’arte che oggi prende in carica questo compito di una
poiesis connotata eticamente è il cinema, come, del resto, lo stesso
Montani sostiene nel saggio su L’estetica contemporanea, citato prima. Perché il cinema è tenuto alla ‘giustezza’ delle immagini, prima ancora che alla loro ‘bellezza’. E l’immagine giusta è sì quella
che “rende giustizia”, come sostiene Serge Daney, perché attesta e
Paolo Montani, L’immaginazione narrativa, cit., pp. 103-119.
Giorgio G.F. Hegel, Estetica, tr. it. a cura di N. Merker, Einaudi, Torino, 1997,
pp. 261-2.
22 Cfr. Fabrizio Desideri, Forme dell’estetica, Laterza, Roma-Bari, 2005.
20
21
35
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
rappresenta anche in senso giuridico, ma il cinema può far questo
in quanto si incarica di inventare uno spazio figurale nuovo ed autonomo rispetto alla tradizione estetica.
Il riferimento al nuovo primato (etico) della poiesis, ed alla prevalenza in esso dell’aspetto ricettivo e patico, ci porta a fare qualche considerazione sull’interessante accenno di Carboni, il quale,
come si è visto, affida all’arte come autodisciplina e capacità di ascolto silenzioso il compito di opporsi alla chiacchiera assordante
dei mass-media. Un’arte fondata sull’aisthesis del limite, egli dice, è
una pratica che riesce a dar voce al trascolorare impercettibile delle
differenze mettendoci in sintonia con le singolarità degli eventi.
Ma questo risultato si ottiene se quella voce riusciamo a sentirla,
cioè ad ascoltarla. In altri termini, da quanto dicono Montani, via
Heidegger, sulla poiesis ricettiva, e Carboni sull’aisthesis dell’ascolto,
si può scorgere il delinearsi di un nuovo paradigma della filosofia.
L’estetica riceverebbe infatti oggi un nuovo mandato: quello di
impiantare, di insediare nel cuore della tecnica, e quasi favorito da
essa, un nuovo paradigma identitario della filosofia. Non più quello (che storicamente ha vinto) centrato sul theorein, ossia su un vedere, su un occhio che guarda e domina otticamente il mondo cogliendone le identità, assimilandolo a sé, eliminando le differenze,
assoggettandolo, come scrive Heidegger ne L’epoca dell’immagine del
mondo, ma su un acouein, ossia su un orecchio che acusticamente sente e ascolta, cioè che presta attenzione ripiegandosi su se stesso e
sulle cose, che si dispone ad accogliere, a farsi invadere dalle voci
con cui le cose che ci vengono incontro ci parlano. Per fare questo
bisogna avere orecchio, come recitava una vecchia canzone di Enzo Jannacci; bisogna, cioè, acuire lo sguardo, ossia, paradossalmente (ma la filosofia, come ha insegnato Emilio Garroni, si sviluppa
nel paradosso) far ascoltare l’occhio, il quale può costruire identità
buone solo se prima ha sentito le differenze (cose molto acute relativamente a questa sinestesia filosoficamente produttiva sono state
scritte, ad esempio, da Mikel Dufrenne ne L’occhio e l’orecchio)23.
Cfr. Mikel Dufrenne, L’occhio e l’orecchio, tr. it. a cura di C. Fontana, Editrice
Il castoro, Milano, 2004.
23
36
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
L’esperienza estetica è allora un’esperienza acuta, che si oppone
all’ottusità della Rete. Platone diceva che solo il sinottico (ossia chi
domina visivamente il mondo delle idee) è dialettico, cioè vero filosofo. Oggi possiamo dire che solo chi è acuto, chi riesce ad utilizzare un acouein, oltre che un theorein, è in grado forse di sparigliare le
carte del digitale informatico, di incunearsi, grazie alla sua plasticità e pieghevolezza, negli interstizi del compatto universo cibernetico per liberare spazi inediti all’esercizio della decostruzione e
della testimonianza, come auspica Montani, ma anche per trovare
nella capacità dell’ascolto, come prospetta Carboni, quella specifica
differenza che è alla base della singolarità delle cose e di ciascuno, per
trovare, cioè, quel parmenideo “cuore che non trema” che è al fondo di ciascuna singola soggettività.
È per questa ragione che forse le arti che più delle altre riescono
oggi a prendere in carico questa poiesis patica e questa estetica acuta
come capacità di rendere intelligibili le specifiche differenze della
singolarità, sono la musica e il cinema. Soprattutto il cinema. Perché quest’arte (come ha efficacemente mostrato Montani nel già
citato L’immaginazione narrativa) si insedia tra la datità delle cose ed
il loro senso. Non perlustra, non ‘narra’ le cose, ma delimita lo spazio che c’è tra le cose. Ciò che si dà, scrive Montani, ci chiama alla
rappresentazione, ci chiede di essere rappresentato. E questo darsi
e questo chiamare si uniscono in un pathos. Tale pathos, così credo
di poter sintetizzare il pensiero di Montani, si distende tra la forza
richiedente del dato e la capacità immaginativa di cor-rispondervi,
ossia di significarlo; e queste due cose avvengono quasi contemporaneamente, come il montaggio audiovisivo si incarica di mostrare
per opera di Eizensteijn.
12. L’accenno ad Eizensteijn ci consente di precisare meglio, in sede di considerazioni conclusive, alcune prospettive che una filosofia del nostro tempo, intesa come riflessione sullo status e sul destino della nostra ‘capacità di sentire’ nell’era digitale, può contribuire a delineare e rilanciare. Il punto di partenza è, come si può
intuire sulla base del discorso precedente, ancora una volta, Walter Benjamin. E precisamente, le sue lucide analisi circa le profon-
37
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
de modificazioni che le attuali condizioni tecniche di produzione
hanno apportato all’esperienza produttiva e ricettiva delle opere
d’arte. Le quali, come si è visto, registrano sicuramente una perdita (la perdita del loro carattere auratico, cultuale, singolare, irripetibile, ecc.), ma contengono anche delle nuove opportunità (opportunità critico-emancipative legate al loro nuovo carattere espositivo,
non più auratico-cultuale). Gli elementi auratici favoriscono, come
si è accennato, l’estetizzazione della politica, ossia la deriva in senso autoritario-dittatoriale del materiale ‘artistico’. Di fronte a questo pericolo, bisogna rivolgersi ad altri aspetti presenti nella rivoluzione tecnologica. Ad aspetti cui è connessa un’opportunità emancipativa; ossia una dimensione critica e riflessiva che restituisca
all’arte lo spazio della polis, lo spazio pubblico che le dittature europee degli anni Trenta (quelle che Benjamin aveva di fronte quando scriveva queste cose) avevano ‘estetizzato’, (arte di massa, propaganda di regime come strumento di canalizzazione del consenso, ecc.) comprimendo il senso comune come sentire collettivo ed
abbassandolo a mera sensazione.
Le opportunità critiche ed emancipative offerte dalla tecnica
sono inscritte nella sua capacità di riproduzione e rappresentazione cine-fotografica del reale. Tale dimensione tecnico-riproduttiva
o di riproducibilità tecnica (che connota il patrimonio genetico di
alcune arti contemporanee come il cinema e la fotografia) incide
significativamente sulle nostre attività percettive e valutative. Se è,
pertanto, vero che nella perdita dell’aura e nel conseguente formarsi di una sensibilità livellata e di massa sono presenti i rischi di
manipolazione politica e di derive totalitarie, ci sono tuttavia anche aspetti del mondo tecnico in grado di contrastare e rovesciare
questi rischi e queste derive.
Il valore espositivo delle opere tecnologicamente assistite, per
esempio, va nella direzione di una politicizzazione dell’arte (che si
contrappone alla estetizzazione della politica). Esemplare, da questo
punto di vista, è l’esperienza del regista russo degli anni Venti
Dziga Vertov e del suo Kinoglaz (letteralmente: cine-occhio), su cui
ha scritto cose molto interessanti Pietro Montani sia in Bioestetica
che ne L’immaginazione narrativa. Cos’era Kinoglaz? Era un cinema
38
Romeo Bufalo
Tecnica e filosofia nel pensiero del novecento
fondato esclusivamente sui valori espositivi delle immagini. Kinoglaz non era un’opera nel senso tradizionale del termine (dotata di
unità, coerenza interna, perfezione, ecc.). Era un ipertesto, una
specie di blog, ossia una serie aperta di immagini che poteva essere
interrotta in ogni punto da un utente interattivo, tecnicamente competente. Non c’era una trama, un’organizzazione narrativa, una sceneggiatura, ecc. Era lo scorrere della vita che veniva intercettato
dalla macchina da presa. Kinoglaz, in altri termini, realizzava un
tipo di montaggio in cui si verificava uno sdoppiamento dell’immagine in ‘soggetto’ ed ‘oggetto’ della visione. Dunque, come scrive Montani, era un occhio meccanico interno al mondo reale-vistoripreso; era l’organo di una carne protesica che si apriva all’iscrizione di tutto il contingente che vi transitava.
La dimensione del politico, dunque, che in Benjamin era solo
accennata nella parte finale del suo saggio del 1936, in Vertov assume un rilievo concettuale decisivo. Quella di Vertov è infatti
un’estetica (se la vogliamo chiamare ancora così) che si radica fortemente nell’esperienza differenziandosi in ‘senziente’ e ‘sentito’,
‘vedente’ e ‘visto’.
Tutto questo ci serve per orientarci oggi. Perché l’estetizzazione
della politica intravista da Benjamin si è talmente intensificata e
diffusa nella post-modernità da permeare di sé anche il terreno
biocratico del “governo della vita” attraverso le tecno-scienze e le
biotecnologie. Con la differenza, di non poco conto, che, mentre i
regimi totalitari fecero intenzionalmente ricorso ad un’auto-rappresentazione ‘estetica’ di sé producendo un’arte di regime, il dispositivo tecnico globale, invece, l’heideggeriano Gestell, fa un uso
‘fisiologico’ delle categorie estetiche che è legato al suo orizzonte
di senso (un orizzonte contratto e livellato verso il basso). In altri
termini, l’aspetto biocratico della tecnica ha bisogno di contenere,
di circoscrivere e di delimitare quel senso che abbiamo in comune
orientandolo verso pratiche iperinvestite (v. il liberismo esasperato
e le forme ‘creative’ della finanza), oppure verso oggetti del desiderio collettivo e del prestigio sociale (si pensi alla straordinaria
fortuna e notorietà di cuochi, sarti, stilisti, pubblicitari, sciamani
del benessere, ecc.). Insomma, si va da pratiche anestetiche a pratiche iperestetizzate.
39
Rivista quadrimestrale
Anno 2 n.s. gennaio/aprile 2011 - N. 1
Ora, come si è accennato sopra, quando il biopotere incrocia la
sfera dell’aisthesis produce quasi inevitabilmente una cattiva bioestetica. Perché le ipertecnologie contraggono, come si è detto, la
sfera del sentire, trasformando il sentimento estetico in semplice
sensazione, quando non in sensazionalismo. Ormai abbiamo di fronte
agli occhi casi di decisioni politiche (convertite in leggi) che si fondano esclusivamente su un sentimento inelaborato, su una sensazione (e non su un ‘sentire comune’): per esempio, la paura e il senso
(la sensazione, appunto) di insicurezza connesse alla (presunta) minaccia rappresentata dal ‘diverso’, dall’extracomunitario, ecc.
Si assiste, in altri termini, ad una regressione del ‘sentire’ in
sensazione inelaborata. Cos’altro è You Tube, dove tutto è orientato, nonostante i sofisticati procedimenti tecnici volti a captare il
contingente, verso quelle sensazioni elementari che non hanno bisogno di alcuna elaborazione concettuale? Di questo passo, i nostri
meccanismi cognitivi ed emotivi si atrofizzeranno sempre più,
perché i processi con cui percepiamo il mondo si riveleranno, in
misura crescente, degli eventi anestetici biocraticamente orientati.
Il compito di una nuova estetica, di un’estetica all’altezza dei
tempi, si precisa allora come un compito etico e politico insieme.
Perché deve contrastare la diffusività capillare della biocrazia tecnologica, la sua tendenza anestetica, e riqualificare e riattivare quel
sentimento estetico su cui si fonda, come diceva Heidegger commentando Schiller, l’essere storico dell’uomo. Questo implica la
capacità di elaborazione critica dell’essere-differente (del non appiattirsi su una ricezione acritica dell’identico). E, soprattutto, comporta la capacità di rigenerare e reimmettere nel campo del visibile
il fuori-campo dell’immagine, l’invisibile o l’irrappresentabile di cui
si è parlato nella prima parte. È quello che ha cercato di fare Vertov; ma è anche quello che, ai nostri giorni, hanno cercato di fare,
per esempio, Jean- Luc Godard con le sue Histoire(s) du cinéma (in
cui il fuori-campo sono i campi di sterminio) o il già citato Kiarostami con ABC Africa24.
24
40
Cfr. Paolo Montani, Bioestetica, cit., pp. 116-119.