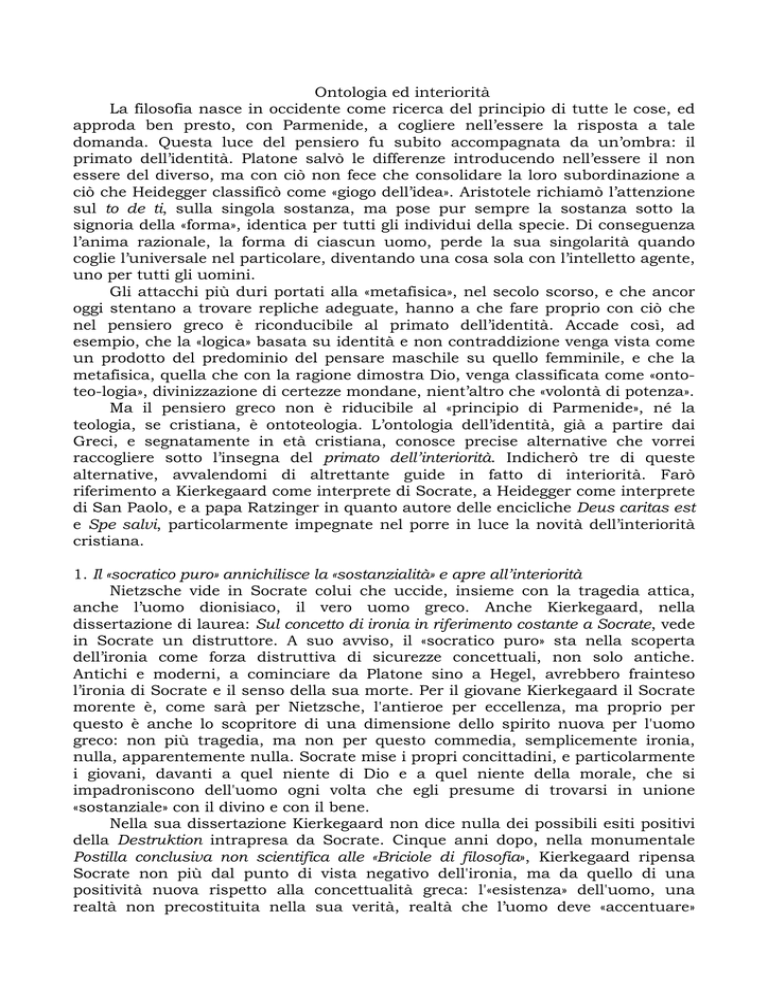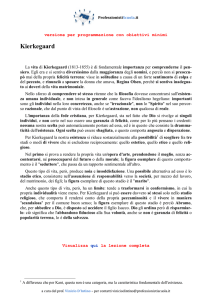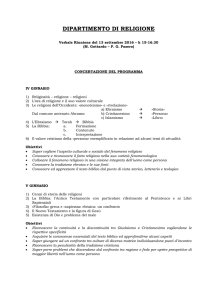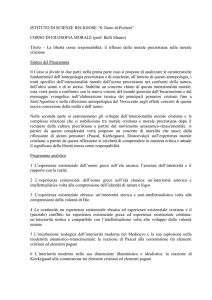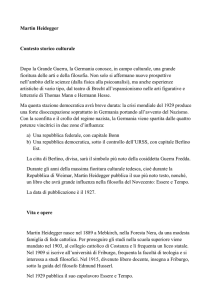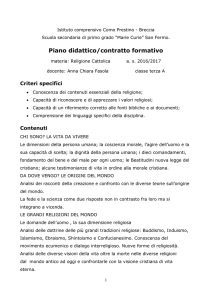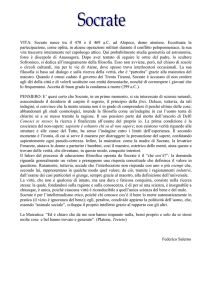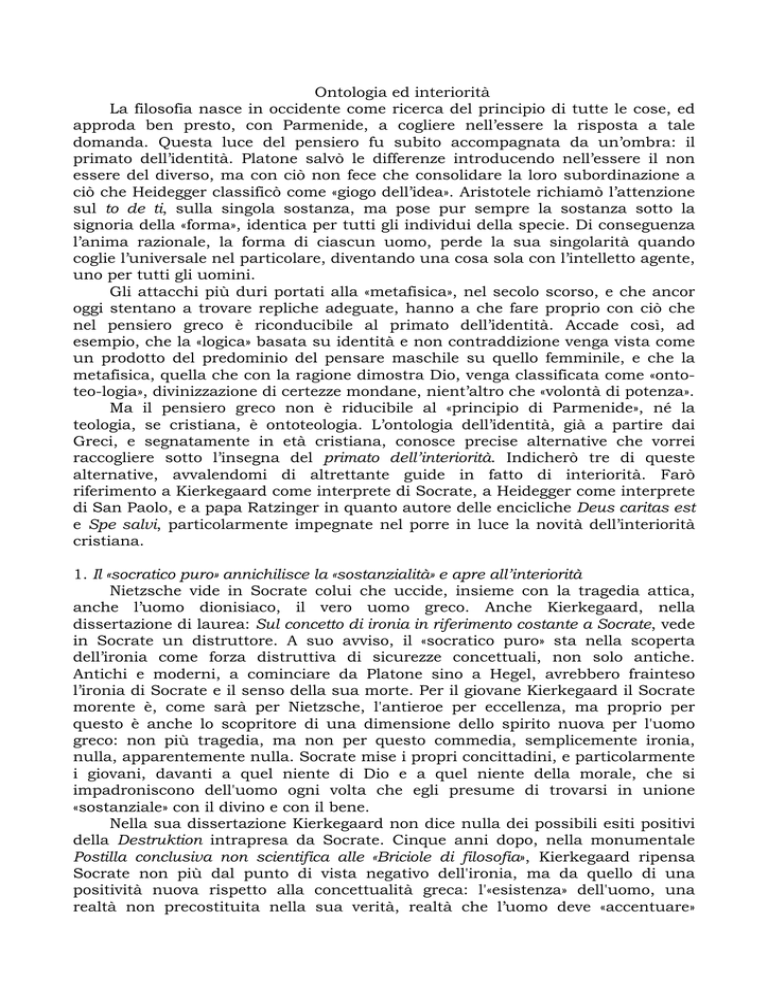
Ontologia ed interiorità
La filosofia nasce in occidente come ricerca del principio di tutte le cose, ed
approda ben presto, con Parmenide, a cogliere nell’essere la risposta a tale
domanda. Questa luce del pensiero fu subito accompagnata da un’ombra: il
primato dell’identità. Platone salvò le differenze introducendo nell’essere il non
essere del diverso, ma con ciò non fece che consolidare la loro subordinazione a
ciò che Heidegger classificò come «giogo dell’idea». Aristotele richiamò l’attenzione
sul to de ti, sulla singola sostanza, ma pose pur sempre la sostanza sotto la
signoria della «forma», identica per tutti gli individui della specie. Di conseguenza
l’anima razionale, la forma di ciascun uomo, perde la sua singolarità quando
coglie l’universale nel particolare, diventando una cosa sola con l’intelletto agente,
uno per tutti gli uomini.
Gli attacchi più duri portati alla «metafisica», nel secolo scorso, e che ancor
oggi stentano a trovare repliche adeguate, hanno a che fare proprio con ciò che
nel pensiero greco è riconducibile al primato dell’identità. Accade così, ad
esempio, che la «logica» basata su identità e non contraddizione venga vista come
un prodotto del predominio del pensare maschile su quello femminile, e che la
metafisica, quella che con la ragione dimostra Dio, venga classificata come «ontoteo-logia», divinizzazione di certezze mondane, nient’altro che «volontà di potenza».
Ma il pensiero greco non è riducibile al «principio di Parmenide», né la
teologia, se cristiana, è ontoteologia. L’ontologia dell’identità, già a partire dai
Greci, e segnatamente in età cristiana, conosce precise alternative che vorrei
raccogliere sotto l’insegna del primato dell’interiorità. Indicherò tre di queste
alternative, avvalendomi di altrettante guide in fatto di interiorità. Farò
riferimento a Kierkegaard come interprete di Socrate, a Heidegger come interprete
di San Paolo, e a papa Ratzinger in quanto autore delle encicliche Deus caritas est
e Spe salvi, particolarmente impegnate nel porre in luce la novità dell’interiorità
cristiana.
1. Il «socratico puro» annichilisce la «sostanzialità» e apre all’interiorità
Nietzsche vide in Socrate colui che uccide, insieme con la tragedia attica,
anche l’uomo dionisiaco, il vero uomo greco. Anche Kierkegaard, nella
dissertazione di laurea: Sul concetto di ironia in riferimento costante a Socrate, vede
in Socrate un distruttore. A suo avviso, il «socratico puro» sta nella scoperta
dell’ironia come forza distruttiva di sicurezze concettuali, non solo antiche.
Antichi e moderni, a cominciare da Platone sino a Hegel, avrebbero frainteso
l’ironia di Socrate e il senso della sua morte. Per il giovane Kierkegaard il Socrate
morente è, come sarà per Nietzsche, l'antieroe per eccellenza, ma proprio per
questo è anche lo scopritore di una dimensione dello spirito nuova per l'uomo
greco: non più tragedia, ma non per questo commedia, semplicemente ironia,
nulla, apparentemente nulla. Socrate mise i propri concittadini, e particolarmente
i giovani, davanti a quel niente di Dio e a quel niente della morale, che si
impadroniscono dell'uomo ogni volta che egli presume di trovarsi in unione
«sostanziale» con il divino e con il bene.
Nella sua dissertazione Kierkegaard non dice nulla dei possibili esiti positivi
della Destruktion intrapresa da Socrate. Cinque anni dopo, nella monumentale
Postilla conclusiva non scientifica alle «Briciole di filosofia», Kierkegaard ripensa
Socrate non più dal punto di vista negativo dell'ironia, ma da quello di una
positività nuova rispetto alla concettualità greca: l'«esistenza» dell'uomo, una
realtà non precostituita nella sua verità, realtà che l’uomo deve «accentuare»
infinitamente, già nel tempo, in ogni momento, se vuole vivere nella verità.
Kierkegaard, in precedenza, dal «briciolo di incertezza» rilevato nel Socrate del
Fedone circa le prove dell'immortalità dell’anima, aveva tratto «l'infinita
negatività» dell’ironia, ora quell'incertezza egli la fa propria, elevandola addirittura
a definizione della stessa verità: «La verità è l'incertezza oggettiva mantenuta
nell'appropriazione della più appassionata interiorità [den objektive Uvished,
fastholdt i den meest lidenskabelige Inderligheds Tilegnelse]»1. Sulla base di
questa definizione Socrate, il Socrate dello pseudonimo Climacus al quale in
quest'opera Kierkegaard delega il delicato compito di traghettare Socrate sulla
riva del cristianesimo, questo Socrate, non è più incerto se sia meglio vivere o
morire. Sceglie di vivere, o meglio di «esistere», perché proprio il vivere nel
«mantenimento dell'incertezza oggettiva» significa diventare sempre più se stessi.
Il compito non è più il «conosci te stesso» assegnato a Socrate dal dio delfico, ma
«l'accrescimento dell'interiorità», perché solo così ci si può «appropriare» di sé, solo
così si può vivere veramente, diventare veramente se stessi, o meglio, per usare
l'espressione del Nuovo Testamento con la quale Kierkegaard designa la metà
della sua produzione, solo così ci si può «edificare».
2. L’interiorità e il tempo cristiano
Nel semestre invernale 1920/21 Martin Heidegger tiene il corso
«Introduzione alla fenomenologia della religione», che egli intende come
l'«esplicazione fenomenologica dell'esperienza cristiana della vita», quale risulta
dalle Lettere di Paolo di Tarso, soprattutto dalle due Lettere ai Tessalonicesi.
Come mai? Nelle Lettere di Paolo Heidegger rileva un'esperienza nuova del tempo,
caratterizzata da un «senso di compimento» [Vollzugssin], ossia da
un’incondizionata radicalità nei confronti del «vissuto». La «fenomenologia» qui
proposta intende essere il giusto ed insostituibile approccio all'elemento «storico»,
l’obiettivo che finora sarebbe stato mancato dalla concettualità occidentale tutta,
sia da quella «scientifica», sia da quella più propriamente filosofica. Lo stesso
particolare interesse per la ricerca storica della cultura della sua propria epoca
spinge Heidegger a denunciarne la fondamentale carenza concettuale, da
imputarsi peraltro non agli studiosi del settore, ma alla natura stessa
dell'elemento storico. In ciò che è storico c'è infatti qualcosa che turba e frena, e così
finisce per allontanare da quel «vissuto» che dovrebbe essere il tema proprio del
sapere storico.
Impegnarsi filosoficamente con Paolo su ciò che è «storico» vuol dire
presupporre che Paolo ha fatto un'autentica esperienza del tempo e che ha posto
il massimo impegno nel testimoniarla e nel comunicarla autenticamente ai
cristiani da lui convertiti. Egli si propone appunto di portare alla luce non solo
questa esperienza, ma la possibilità di trarre dall'esperienza dell'«essere-divenuto»
[Gewordensein] cristiano, da parte di Paolo e dei destinatari delle sue lettere, una
concettualità idonea ad afferrare la vita nel suo divenire vivente e vissuto: e
Heidegger sostiene che solo la «temporalità cristiana» è il tempo giusto, il kairÕj,
per un divenire autenticamente vivente e vissuto. Ogni altro tempo, greco o
moderno, non è che un «ordinamento» [Einstellung] di fatti neutri all'interno di
un'«oggettività» estranea al divenire che è proprio della vita:
1 Søeren Kierkegaard, Afluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler, a cura
di N.J. Cappelørn, J. Garff, J. Knudsen, J. Knudsen, A. McKinnon, in Søren Kierkegaard Skrifter,
cit., Copenaghen 2002, vol. 7, p. 186, tr. it. a cura di C. Fabro, Postilla conclusiva non scientifica
alle Briciole di filosofia, in Briciole di filosofia e Postilla non scientifica, Bologna 1962, II, p. 17.
2
«La presente trattazione tocca il centro della vita cristiana: il problema escatologico.
Già alla fine del primo secolo l'elemento escatologico presente nel cristianesimo
venne nascosto. Più tardi tutti i concetti cristiani originari vengono fraintesi. Anche
nell'odierna filosofia le formazioni concettuali cristiane sono ancora nascoste dietro
l'impostazione greca» (104-105).
Nemmeno in Agostino, nonostante il libro XI delle Confessiones, Heidegger
riconosce la presenza dell'autentica temporalità cristiana. In «Augustinus und der
Neoplatonismus» (il corso tenuto nel successivo semestre estivo 1921), pur fra i
riconoscimenti per la nuova sensibilità nei confronti dei fenomeni interiori, egli
accusa Agostino di essere ancora succube proprio di quell'«oggettività» greca
contro la quale egli sta combattendo:
«Oggettività di Dio. Deus lux, dilectio, summum bonum, incommutabilis substantia,
summa pulchritudo. […] In definitiva l'esplicazione dell'esperienza di Dio in
Agostino è specificamente “greca” (nel senso in cui anche tutta la nostra filosofia è
ancora “greca”). Non si perviene a una problematizzazione critica radicale, a una
considerazione originaria (distruzione)»2.
Secondo il giovane Heidegger, Agostino rivela il bisogno di fare del tempo un
«oggetto», e finisce per collocare il tempo in un «ordine» al quale resta estraneo il
tempo vissuto da chi, «divenuto» cristiano, non vive nel tempo ma vive il tempo
nell'imminenza del ritorno glorioso di Cristo. Questo tempo non ha bisogno di
altro quadro di riferimento che non sia il tempo stesso di un'attesa che, proprio in
quanto non bisognosa di alcuna fissazione temporale, è già presenza, è già tempo
compiuto:
«La religiosità cristiana vive la temporalità come tale» (80). «L'esperienza cristiana
vive il tempo stesso (“vivere” inteso come verbum transitivum)» (82). «La religiosità
cristiana vive la temporalità. È un tempo senza un proprio ordine e senza posti
certi, ecc. Questa temporalità è impossibile incontrarla a partire da un qualsiasi
concetto oggettivo del tempo. Il “quando” non è in alcun modo comprensibile
oggettivamente» (104).
Heidegger si pone per così dire nei panni di uno dei Tessalonicesi convertiti
da Paolo, ma con la consapevolezza smaliziata di un giovane filosofo dell'inizio del
XX secolo, originalmente e criticamente conscio della carenza concettuale di più
di duemila anni di filosofia. In lui parla non il credente ma il filosofo, anche se in
questo corso universitario questo filosofo non prende mai le distanze dal
credente, tutt’altro: giunge ad affermare che solo sulla base della temporalità
cristiana è possibile una «filosofia della religione» [Religionsphilosophie]: possibile
per lui, Martin Heidegger, che si sente e vuol essere uomo del suo tempo, un
tempo che, se veramente vissuto, non può che essere quello di un vero cristiano.
Se, ad esempio, Paolo si congratula con i Tessalonicesi per il loro essersi
«allontanati dagli idoli per servire Dio» (1 Ts 1, 11), ecco che Heidegger può
cogliere, nel modo con cui avviene questa conversione, non tanto il semplice
passare dal culto degli idoli a quello del vero Dio, ma il vero modo di rapportarsi a
Dio. L'abbandono degli idoli è solo il corollario, e in questo senso non ciò che è
decisivo, di una conversione più profonda, che implica il non rapportarsi più a
Dio come a un «oggetto». Non gli dèi pagani in quanto tali, ma l’oggettivazione di
Dio è il vero idolo:
«Il rivolgersi a Dio è la cosa primaria. Da ciò, e insieme a ciò, si determina
l'allontanarsi dagli eŠdwla. Questo allontanarsi è secondario […]. Per l'esplicazione
si dà il compito di determinare il senso dell'oggettività di Dio. Se Dio viene inteso
2 Martin Heidegger, Augustinus und der Neuplatonismus, a cura di Claudius Strube, in Id.,
Phänomenologie des religiösen Lebens, cit., p. 292.
3
come oggetto della speculazione, allora siamo di fronte a una caduta dall'autentico
comprendere. Ciò lo si può percepire se si esegue l'esplicazione del contesto
concettuale. Ma questo non è mai stato tentato poiché la filosofia greca si è
introdotta nel cristianesimo. Solo Lutero ha fatto un tentativo in tale direzione, e da
questo ci si spiega il suo odio per Aristotele» (97).
Ma come «rivolgersi» a Dio tenendo al tempo stesso fermo che Dio non è
possibile come oggetto? Per Heidegger, pensare qualcosa come un «oggetto» vuol
dire inserirlo in un «ordinamento» [Einstellung], in una concettualità che non è
servizio alla verità, ma asservimento del pensare alle «tendenze per la sicurezza»
[Sicherungstendenzen] (45-52). Si tratta di un pensare tendenzioso in quanto
pauroso nei confronti dell'«esperienza fattuale» [faktische Erfahrung] del tempo,
della storia, della vita. Per Heidegger è particolarmente importante denunciare
subito l'inconciliabilità fra Dio e oggettività: «gli idoli», tutti, si sgretolano e non
meritano più uno sguardo non appena ci si «rivolge» a Dio senza farne un oggetto
«rassicurante». Quanto più l'uomo vivrà «storicamente» e tanto meno verrà tentato
dagli idoli. La storicità dell'esistere dell’uomo non è cosa diversa dalla sua
costitutiva apertura alla trascendenza di Dio. Non chi è, ma chi «diviene cristiano»
fa l’esperienza di un tempo di salvezza eterna, nel tempo e del tempo. Si ricordi a
questo proposito la forte espressione con cui Kierkegaard, al culmine della Postilla
conclusiva, distingue il cristianesimo da ogni altra religione: «[Il cristianesimo] è il
rapportarsi nel tempo all'Eterno-nel-tempo» [i Tiden til at forholde sig til det Evige i
Tiden 3
La parousia è il modo con cui Paolo «ha» la sua vita. Il «compimento» non può
infatti avere maggiore intensità temporale di quando ci si rapporta all'«apparire di
nuovo del messia già apparso» (102); qui ogni «quando» deve essere tutto vissuto
in ogni momento a prescindere dall'oggettività temporale e da ogni «sicurezza»
riposta in questa. La parousia è incompatibile con ogni fuga dal tempo vissuto.
Con ciò stesso essa diviene il criterio per la verifica dell'esperienza dell'«essere
divenuto» che è propria del cristiano: non si può essere veramente divenuti
cristiani e fraintendere la parousia facendone un evento fissabile in un «quando»
oggettivo, perché ciò equivarrebbe a chiudersi nell'immanenza delle proprie
sicurezze. Far calcoli sul «quando» dell'«apparire di nuovo del messia già apparso»
vuol dire non attenderlo più.
Heidegger non elaborerà alcuna filosofia della religione. Non si dimenticherà
tuttavia delle caratteristiche che temporalità e storicità debbono avere, se
autentiche. Non avrebbe potuto scrivere Sein und Zeit se non avesse rilevato nelle
Lettere di Paolo un'esperienza di un divenire radicalmente «vissuto», di un tempo
fenomenologicamente originario, di una storicità che costituisce il fondamento del
Dasein: la sua «autentica esistenza». Sein und Zeit rimase interrotto. Ma Heidegger
non cessò di tentare la via per aprire la temporalità e la storia ad una
trascendenza che non fosse solo autotrascendenza, solo esistenza, solo esistenza
sola. L'apertura del Da-sein all'inafferrabile «transitare dell'ultimo Dio»
[Vorbeigang des letzten Gottes] reca, nei postumi Beiträge zur Philosophie, la
testimonianza della continuità di questo anelito verso una trascendenza
irriducibile alle forme della soggettività.
3. La crescita dell’uomo interiore
Questa ricerca di autentica trascendenza trova una testimonianza indiretta
anche nella famosa accusa rivolta da Heidegger a tutta la metafisica, compresa
3
Opere, a cura di Cornelio Fabro, Sansoni, Firenze 1972, p. 577.
4
quella confluita nel cristianesimo: di non essere niente altro che onto-teo-logia,
ossia riduzione di Dio ad oggetto del pensiero calcolante. L’ontoteologia è
immanenza, e un cristianesimo ontoteologico è idolatrico. Come rompere il
cerchio dell’ontoteologia? Si può sfuggire alla logica dell’identità solo con l’agape,
l’unico amore non egoistico, e con la «grande speranza», quella che ha portata
«performativa» perché consente al cristiano di sperimentare già ora l’affidabilità
del suo sperare in un Dio che è Amore. Così papa Ratzinger, anch’egli, come
Heidegger, interprete di Paolo.
Nella Deus caritas est egli afferma che nell’inno alla carità contenuto nel
capitolo 13 della Prima lettera ai Corinti «sono riassunte tutte le riflessioni
sull’amore» svolte nell’Enciclica (n. 34). Si tratta di un amore che, come Paolo
afferma nella Lettera ai Galati (4, 6) è «operante», che cioè si traduce subito in
amore del prossimo, incondizionatamente:
«Il programma del cristiano – il programma del buon Samaritano, il programma di
Gesù – è “un cuore che vede”. Questo cuore vede dove c’è bisogno d’amore e agisce
in modo conseguente» (n. 31b). «La parabola del buon Samaritano rimane come
criterio di misura, impone l’universalità dell’amore che si volge verso il bisognoso
incontrato “per caso” (cfr. Lc 10, 31), chiunque egli sia» (n. 25 a-b).
Sul piano della carità il papa rivendica al cristiano un primato di competenza
e di impegno suffragato da una storia bimillenaria di diakonia, resa a sua volta
possibile dalla trasfigurazione, dovuta al cristianesimo, dell’eros in agape,
dell’amore possessivo in amore oblativo. Il cristiano è specialista in amore, in
amore agapico. Si apre una prospettiva nuova, una «vita nuova»: la possibilità
della vittoria dell’amore su ogni egoismo, una vittoria impossibile da conseguire
per l’uomo, se solo. Ogni sforzo che egli faccia per trascendere se stesso non
farebbe se non ampliare l’orizzonte dell’immanenza, che resterebbe allora
intrascendibile. Il comandamento di amare il prossimo è certamente cosa
umanamente impossibile. Ma proprio in nome del prossimo diviene per ogni
uomo possibile sottrarsi alla dittatura dell’immanenza.
Un’operazione analoga viene in luce nella Spe salvi. Il titolo dell’enciclica è
tratto da Rm 8, 24: «Nella speranza siamo stati salvati». Salvati da che cosa?
Salvati dalla disperazione, la «malattia per la morte», come definita da
Kierkegaard:
«La possibilità di questa malattia è il vantaggio dell’uomo sull’animale; essere
consapevole di questa malattia è il vantaggio del cristiano sull’uomo naturale,
essere guarito da questa malattia è la beatitudine del cristiano»4.
La speranza cristiana non è come la speranza di cui parla Platone. Un abisso
divide la elpìs greca, intesa come una valutazione umanamente corretta del
futuro, dalla speranza cristiana, che già ora rende la vita vittoriosa sulla morte,
perché fa già ora vedere al cristiano che i pericoli che si corrono nella vita sono
nulla in confronto al pericolo che si corre quando si vive da disperati senza sapere
di esserlo. Solo il cristiano sa cosa è in gioco nella vita, in ogni attimo; per questo
non può mai disperare, nemmeno quando tutto sembra giustificare il suo
disperare:
«[Abramo] ebbe fede sperando contro ogni speranza… Egli non vacillò nella fede, pur
vedendo già come morto il proprio corpo e morto il seno di Sara» (Rm 4, 18-19).
Proprio per evidenziare che la speranza cristiana è subito vittoriosa, il Papa
già nell’Introduzione la identifica con il coraggio della sicurezza. Anche l’enciclica
4 S. Kierkegaard, La malattia per la morte [Sygdommen til Døden], ed. it di E. Rocca, Donzelli,
Roma 1999, p. 17.
5
Spe salvi cita subito la Prima lettera ai Tessalonicesi per mettere in evidenza come
la speranza cristiana, in quanto basata sulla fede, sia un modo di vivere che
consente ai Tessalonicesi di non «affliggersi come gli altri che non hanno
speranza» (1 Ts 4, 13):
«Compare come elemento distintivo dei cristiani il fatto che essi hanno un futuro
[...]. Solo quando il futuro è certo come realtà positiva, diventa vivibile anche il
presente» (n. 2, p. 5).
«L’amore spera tutto» (1 Cor 13, 7) proprio perché presuppone amore negli
altri. Non teme delusioni, la sua attesa è strategica, sa che l’amore viene prima e
che nessuna delusione d’amore potrà mai portare alla disperazione: «L'amore non
è una qualità per sé, ma una qualità per la quale e nella quale tu sei per gli
altri»5.
Per i Greci né l’amore e tanto meno la speranza avevano portata strategica.
Non così l’amore e la speranza del cristiano. Kierkegaard dedica forse il più bello
ed impegnativo fra i Discorsi edificanti del 1843 al «rafforzamento dell’uomo
interiore», un’espressione tratta dalla Lettera agli Efesini (3, 16; cfr. 2 Cor 4, 16). Il
papa, nella Spe salvi, si avvale di questo stesso concetto per tracciare il confine
fra l’idea del progresso propria della modernità e quella che invece anima l’agape:
«Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica
dell’uomo, nella crescita dell’uomo interiore, allora esso non è un progresso, ma
una minaccia per l’uomo e per il mondo» (n. 22).
Il primato dell’identità nasconde una volontà che vuole sempre di più perché
dispera di riuscire mai a volere abbastanza per essere autenticamente se stessa.
L’uomo cresce nell’interiorità non per autoaffermazione ma davanti all’alterità.
«Dio è amore» (1 Gv 4, 16) - esordisce la Deus caritas est – ha amato l’uomo, per
primo; l’uomo non potrà mai uguagliare Dio in amore; anche in questa
limitazione va riconosciuto un atto d’amore da parte di Dio. L’uomo non deve
identificarsi a Dio, né da Dio viene assimilato; deve crescere di fronte a Dio,
«davanti a Dio», come Giobbe nella sua protesta. L’uomo deve diventare se stesso,
come ben sapevano anche i Greci. Ma allora non deve mai distrarsi da sé, mai
diventare esteriore a sé. L’interiorità non consiste in una ritirata ma in un
avanzamento nei confronti dell’alterità, in un’accentuazione non dell’esse ma
dell’inter-esse, nella doppia valenza, ontologica ed etica, che Kierkegaard, buon
latinista, sa mettere in luce in questo termine, in questa che è la nuova
semantizzazione dell’essere.
5
S. Kierkegaard, Kjerlighedens Gjerninger, p. 225.
6