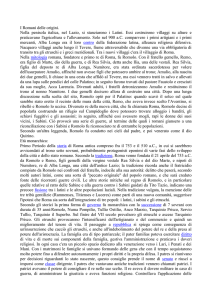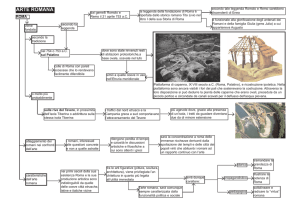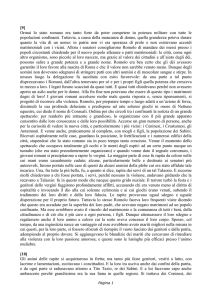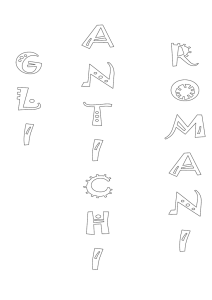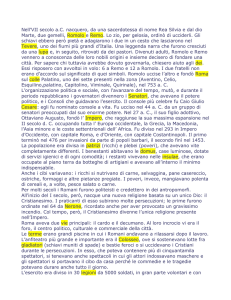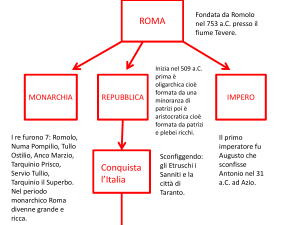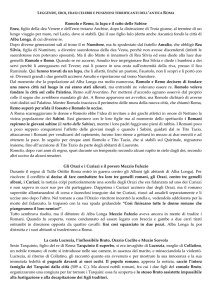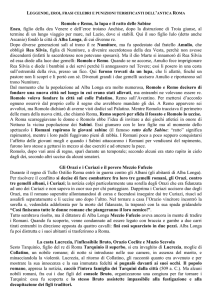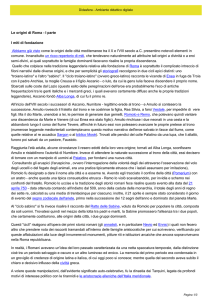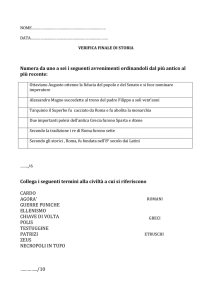ARIA TERRA ACQUA FUOCO: DA PAGUS AD URBS
Il Ratto delle Sabine
Fatta Roma, bisognava fare i Romani. Il primo problema che Romolo dovette
affrontare fu quello di popolare la sua neonata Città che era già «così potente da
poter rivaleggiare militarmente con qualunque popolo dei dintorni» (Livio, Ab
Urbe Condita). Poiché le risorse umane locali scarseggiavano, Romolo pensò
bene di creare sul Campidoglio l’Asylum, un luogo di rifugio dove potevano
trovare riparo fuorilegge, banditi, ladri, assassini e perfino schiavi fuggitivi, ai
quali veniva poi concessa la cittadinanza romana. Il problema, però, era ancora
irrisolto perché mancavano le donne: senza famiglie, senza posterità, la vita
sociale non era possibile. In un primo momento Romolo si comportò da
gentiluomo ed inviò ambascerie nei paesi vicini per cercare alleanze e
soprattutto mogli. Ma i popoli confinanti, già preoccupati per l’incipiente
grandezza di Roma, si rifiutarono di dare le loro figlie in spose a quegli uomini
che godevano di pessima fama e consigliarono i Romani di «aprire a Roma un
asilo anche per le donne, che allora sarà davvero un degno accoppiamento» (Livio,
Op. cit.). I Romani non la presero bene, ma fecero finta di nulla e ricorsero
all’astuzia: allestirono dei giochi solenni in onore del dio Conso e invitarono i
Sabini, i Ceninensi, gli Antemnati e i Crustumerii allo scopo di rapire le loro
donne nel bel mezzo dello spettacolo. Attratta dall’avvenimento, e curiosa di
vedere da vicino la nuova città, arrivò moltissima gente. La festa era in pieno
svolgimento quando, a un segnale convenuto, Romolo e i suoi uomini estrassero
le spade, catturarono le giovani donne prendendole in braccio e misero poi in
fuga i loro padri e fratelli. A parziale discolpa dei Romani, gli storici dell’epoca
riportarono che non venne rapita nessuna donna maritata, ad eccezione di
Ersilia della quale ignoravano la condizione di mater familias. Il numero delle
fanciulle rapite varia molto secondo gli autori: per Livio erano 30, per Varrone
527 e per Dionigi 683; Plutarco, invece, fa notare che l’usanza in uso ai suoi
tempi (ma anche ai nostri) di sollevare la sposa quando varca per la prima volta
la soglia di casa è per l’appunto un ricordo del ratto. Ovviamente, i parenti
maschi delle giovani rapite giurarono vendetta. Romolo cercò di placare gli
animi spiegando che era stato il dio Conso a consigliare il ratto, dato che i capi
dei popoli vicini si erano ingiustamente rifiutati di stipulare alleanze e
matrimoni con i Romani. La spiegazione non soddisfece gli offesi e, prima ancora
dei Sabini, mossero guerra ai Romani i popoli di tre città oggi scomparse:
Caenina (corrisponde alla zona di ponte Mammolo), Antemnae (nell’area di
Monte Antenne) e Crustumerium (a nord di Fidene, sulla riva sinistra del
Tevere). Romolo le sconfisse e dopo aver ucciso Acrone, re di Caenina, ne spogliò
il cadavere per dedicare le sue spolia opima a Giove. Le tre città furono distrutte
e i loro abitanti costretti a trasferirsi a Roma. Il Fondatore, poi, affrontò i Sabini,
guidati dal loro re Tito Tazio. Nonostante le forze soverchianti del nemico e
nonostante il tradimento di Tarpea, che permise ai Sabini di penetrare nell’Arx,
la Rocca Capitolina, i Romani, aiutati dal dio Giano e da Giove Statore (“che
resiste”, “che ferma”) affrontarono i Sabini guidati da Mezio Curzio e li
sconfissero nella battaglia che si svolse nella valle acquitrinosa (dove poi
sorgerà il Foro) fra il Campidoglio e il Palatino in un punto che sarà poi chiamato
Lacus Curtius1.
Sulla vittoria romana, tuttavia, influì non solo l’intervento divino ma soprattutto
quello delle donne rapite che, guidate da Ersilia, si gettarono fra i due eserciti
chiedendo la pace, con in braccio i figli avuti dai Romani. E pace ottennero.
Romolo e Tito Tazio cavalcarono insieme fino al Campidoglio e il tratto di strada
che percorsero fra i due popoli festanti fu per questo chiamato Via Sacra. Dopo
la battaglia del lago di Curzio, Romolo, sciolse il voto fatto a Giove Statore e gli
elevò un tempio nel Foro2. Poi, in segno di riconoscenza verso le donne, le onorò
istituendo le Matronalia.
La cittadinanza di Roma, così, si accrebbe inglobando i Sabini. Romolo e Tito
Tazio fusero i due popoli e stabilirono di regnare insieme regolando la loro
successione, alternativamente, fra un romano e un sabino.
Romolo, I Re di Roma
Stipulata la pace fra Romani e Sabini, Romolo e Tito Tazio condivisero il potere
nei primi anni di vita di Roma.
Sebbene uniti in un unico popolo, i Quiriti, Romolo lo divise in tre tribù: i
Ramnenses, i Romani, che prendevano il nome da Romolo; i Titientes, i Sabini, da
Tito Tazio; i Luceres, genti di varia provenienza3. I Sabini, detti anche Curiti in
quanto originari di Curi (Passo Corese), andarono a vivere sul Colle che da loro
prese nome di Quirinale4 e su questo Tito Tazio stabilì la sua regia. I Romani,
invece, continuarono a vivere sul Palatino e Romolo continuò a vivere vicino alla
capanna di Faustolo, in una altrettanto semplice capanna chiamata
pomposamente domus Romuli.
In campo religioso, Sabini e Romani partecipavano alle rispettive feste e riti
sacri, senza eliminare nessuno di quelli che ciascun popolo aveva fino a quel
momento celebrato singolarmente.
Poi, a detta di Plutarco, dopo cinque anni Tito Tazio cadde in un’imboscata a
Lavinio e Romolo rimase solo a governare in una forma di monarchia unica nella
storia del mondo: un re elettivo che saliva al trono perché scelto dal popolo e
non per diritto di successione.
Il Re divise ognuna delle 3 tribù in 10 curie5 (in totale 30 curie), ciascuna delle
quali si suddivideva a sua volta in 10 decurie che si riunivano in assemblee
(comizi curiati) nelle quali venivano prese a maggioranza le più importanti
decisioni circa la vita dei cittadini. Nel governo della Città, Romolo era
coadiuvato dal Consiglio degli Anziani (un organo che era anche responsabile
dell’elezione del Re), composto di 100 membri6 divisi in Patres (Patrizi), i capi
delle famiglie (gens, gentes) più importanti, che appartenevano al Consiglio per
diritto di nascita, e Coscripti (Aggiunti), scelti fra i plebei per particolari meriti.
In seguito sarà chiamato Senatus (da senex, “vecchio”). Le assemblee si riunivano
nel Comizio nella valle del Foro.
Ogni curia contribuiva all’esercito fornendo una centuria (100) di fanti e una
decuria (10) di cavalieri.
Romolo divise i cittadini in due grandi classi sociali: i Patrizi e la moltitudine dei
cittadini che poi, in epoca repubblicana, saranno chiamati Plebei (da plebs,
“moltitudine”, “calca”). Questi non avevano alcun diritto politico e la loro unica
forma di tutela era quella di diventare cliens, “cliente”, di un patrizio offrendogli
servizi in cambio di protezione.
La tradizione gli attribuisce la compilazione del primo calendario in base al
quale l’anno era composto di dieci mesi ed iniziava con il mese da Romolo
dedicato a Padre Marte: marzo.
Sebbene fortemente impegnato “a fare i Romani”, Romolo, tra riforme e
istituzioni, trovò anche il tempo di “fare Roma” più grande: conquistò Medullia
(nei pressi di Sant’Angelo Romano), Fidene (Castel Giubileo) e Cameria (nord est
di Roma) e sconfisse la città etrusca di Vejo che costrinse ad una tregua di cento
anni ottenendone in cambio i territori dei Septem pagi (“Sette villaggi”, ad ovest
del guado sul Tevere, la futura Isola Tiberina).
Plutarco, nella sua Vita di Romolo, narra che, inorgoglito delle vittorie, «con
grande arroganza abbandonò la precedente tendenza democratica per sposare un
modello di monarchia assoluta, opprimente ed intollerabile». Romolo,
abbandonate le semplici vesti di pastore, indossava un mantello purpureo e una
toga bordata di porpora, dava udienza assiso su un trono, attorniato da alcuni
giovani, chiamati celeres (“veloci”, una specie di guardia del corpo del re, poi
abolita da Numa Pompilio) e si faceva precedere da dodici littori (dal latino
lictores, da ligare, “legare”) recanti ognuno la scure, simbolo del potere
esecutivo, che spuntava dalle verghe di betulla “legate a fascio” con stringhe di
cuoio rosso. In realtà, l’istituzione dei littori derivava dagli Etruschi, ma Romolo
li stabilì in numero di dodici per alludere alla visione dei dodici avvoltoi che gli
aveva consentito di essere il Fondatore prescelto. Ormai il Consiglio degli
Anziani era tale solo di nome in quanto di fatto Romolo era il solo a governare e i
Patres avevano l’unico privilegio di essere informati per primi sulle decisioni
prese dal Re.
Romolo governò per 37 anni poi un giorno, il 5 o il 7 luglio del 716 a.C., all’età di
57 anni rese l’anima agli Dei e la sua morte, come la sua nascita, fu legata ad un
avvenimento prodigioso e sovrannaturale.
Romolo stava passando in rassegna l’esercito schierato alla Palus Caprae7 nel
Campo di Marte, quando si verificò una eclissi di sole, accompagnata da un
violento temporale. In quel buio improvviso, squarciato dai lampi, si
scatenarono un vento impetuoso e una pioggia torrenziale che costrinsero tutti a
darsi alla fuga, in cerca di riparo. Quando il temporale cessò e il sole tornò a
risplendere, tutti uscirono dai loro rifugi, tutti tranne Romolo, sparito nel nulla.
Alla plebe, inquieta per la sparizione del suo Re, fu detto che Romolo era stato
portato in Cielo dagli Dei, così come a suo tempo era accaduto ad Enea, ed era
divenuto un dio egli stesso. Per dare maggiore credibilità all’accaduto fu fatto
venire da Alba un vecchio compagno di Romolo, Proculo Giulio, il quale raccontò
che «stamattina o Quiriti, verso l’alba, Romolo, padre di questa citt{, è
improvvisamente sceso dal cielo e apparso davanti ai miei occhi. (...) Va e annuncia
ai Romani che il volere degli Dei è che la mia Roma diventi la capitale del mondo.
Che essi diventino pratici nell’arte militare e tramandino ai loro figli che nessuna
potenza sulla Terra può resistere alle armi romane» (Tito Livio, Ab Urbe condita).
Infine, chiedeva di essere onorato come un dio con il nome di Quirino e
reclamava un tempio in suo onore. Senatus Populusque Romanus lo
accontentarono, istituirono in suo onore le feste delle None Caprotine e lo
relegarono fra i miti anziché dargli un posticino fra le pagine della storia: se
avessero scelto di farne un personaggio storico avrebbero dovuto riportare che
in realtà tutta la faccenda era stata solo uno squallido regicidio. Infatti, come
racconterà Plutarco (che era greco e dunque poco propenso a nascondere i
“fattacci” dei Romani), «...essendo Romolo mancato in un attimo, non fu più vista
alcuna parte del suo corpo, né reliquia delle sue vesti. Per cui alcuni s’immaginano
che i senatori, avendolo assalito e trucidato nel tempio di Vulcano, ne avessero
smembrato il corpo, e ripostane ognuno una parte in seno, l’avessero portato via»
(Questioni Romane).
Dopo la morte di Romolo la Città cadde in preda a disordini di ogni tipo. Secondo
i patti, al romano Romolo sarebbe dovuto succedere un re sabino, ma i Romani
erano poco inclini a mettere sul trono un re “straniero” e la lotta per la
successione al trono aprì aspri conflitti fra le famiglie romane.
Tra il 753, anno della Fondazione, e il 509, primo anno della Repubblica,
trascorrono 244 anni durante i quali si avvicendano Sette Re, con una media di
35 anni di governo a testa: troppi anni per un regno e troppo pochi il numero dei
Re. Basandosi sulla tradizione più consolidata, a Romolo successero il sabino
Numa Pompilio (715-672 a.C.), il romano Tullo Ostilio(672-640 a.C.), il sabino
Anco Marcio(640-616 a.C.) e gli etruschi Tarquinio Prisco (616-579 a.C.), Servio
Tullio (578-535 a.C.) e Tarquinio il Superbo (534-510 a.C.).
Conso
Antichissima divinità romana, dai caratteri misteriosi e discussi. Livio lo definiva
“Nettuno Equestre”, Plutarco “Dio del Consiglio” e Dionigi “un genio ineffabile,
guida e custode dei segreti disegni”. Tutti gli antichi autori ne parlano a
proposito del “Ratto delle Sabine” e gli attribuiscono il consiglio dato a Romolo
di rapire le donne.
In origine Conso rappresentava probabilmente il seme generatore (conserere,
“seminare”, “piantare”) e questa ipotesi è avvalorata dal fatto che le feste in suo
onore, Consualia, si svolgevano due volte l’anno: dopo la semina (15 dicembre) e
dopo il raccolto (21 agosto). Era spesso affiancato alla dea Ops8 che assicurava
l’abbondanza dei raccolti. In epoca arcaica Conso era venerato con un altare
sotterraneo in una valle sempreverde di mirti sacri a Venere, detta Valle Murcia.
In questo luogo, dove poi Tarquinio Prisco costruirà il Circo Massimo, Conso
viveva nascosto ed invisibile, per tutto il tempo che intercorreva fra una festa e
l’altra: simbolo del seme affidato alla terra e che in esso rimane nascosto sino al
suo germoglio. Ed infatti, un’altra etimologia fa derivare il nome Conso da
condere, “nascondere”. Livio, parlando del Ratto delle Sabine, fa risalire a
Romolo l’istituzione dei Consualia: «Romolo organizza apposta dei giochi solenni
in onore di Nettuno equestre e li chiama Consualia. Quindi ordina di invitare i
popoli vicini». Plutarco narra invece che Romolo «in primo luogo fece diffondere
la notizia che era stato ritrovato, nascosto sottoterra, un altare di un dio: dio che
era chiamato Conso, che secondo alcuni vuol dire consigliere (...) secondo altri il
dio era Poseidone equestre». Proprio per l’accostamento a Nettuno (il gr.
Poseidone), cui era sacro il cavallo, nei giorni dei Consualia l’ara del dio veniva
dissotterrata e Conso era celebrato con corse di cavalli e di asini inghirlandati
con fiori di campo. Nel 272 a.C., dopo la resa di Taranto, il console Papirio
Cursore fece costruire un tempio dedicato a Conso sull’Aventino, probabilmente
nei pressi delle terme Surane (adiacenze chiesa di S. Prisca).
Ersilia
Hersilia, “Rugiada”, secondo la tradizione riportata da Plutarco era l’unica donna
sposata fra quelle rapite dai Romani, ma a tale proposito precisa che «i rapitori
non lo sapevano; ciò dimostra che i Romani giunsero al ratto non per violenza o
per compiere un’ingiustizia, ma (...) spinti da gravissime necessit{». Un’altra
versione, citata da Macrobio9, sostiene che Ersilia fosse andata in sposa al
romano Ostilio al quale diede un figlio, Osto Ostilio, nonno di Tullo Ostilio, terzo
Re di Roma. La leggenda più diffusa, quella riferita da Plutarco, narra invece che
Ersilia divenne la moglie di Romolo al quale diede due figli, una femmina ed un
maschio: Prima e Aollio, poi chiamato Avilio. Quando Romolo fu elevato fra gli
Dei, seguì il marito nell’apoteosi e onorata con il nome di Hora Quirini. Le fonti
classiche non si dilungano oltre né ci dicono che fine fecero i figli di Romolo.
Spolia opima
Letteralmente “spoglie”, “bottino ricco”. Questo tipo di consacrazione consisteva
nella dedica dell’armatura, delle armi e degli effetti personali che il comandante
romano toglieva al comandante nemico ucciso in singola tenzone.
«Romolo tagliò all’interno dell’accampamento romano una quercia molto grande,
dandole la forma di un trofeo e vi appese le armi di Acrone. (...) Egli
personalmente, indossata una veste, mise sulla testa dai lunghi capelli una corona
di alloro. Sollevando il trofeo, che teneva appoggiato sulla spalla destra, camminò
intonando i canti della vittoria, seguito dall’esercito e accolto dai cittadini con
gioia e stupore. Questa processione costituì un modello a cui ispirarsi per quelle
future da celebrare. Il trofeo fu dedicato a Giove Feretrio» (Plutarco, Vita di
Romolo), al quale Romolo innalzò un tempio sul Campidoglio.
«Portando le spoglie del comandante nemico ucciso (...) Romolo salì sul
Campidoglio. Lì, dopo averle poste sotto una quercia sacra ai pastori, insieme con
un dono, tracciò i confini del tempio di Giove e aggiunse al dio un cognome: “Io
Romolo, re vittorioso, offro a te, Giove Feretrio, queste armi regie, e dedico il
tempio tra questi confini (...) in modo che sia dedicato alle spoglie ricche che coloro
che verranno dopo di me porteranno qui dopo averle sottratte a re e comandanti
uccisi in battaglia”. Questa è l’origine del primo tempio consacrato a Roma» (Tito
Livio, Ab Urbe condita).
Il tempio di Giove Feretrio - secondo la tradizione il primo edificio sacro
costruito a Roma - fu dedicato a Giove in quanto Feretrius, un epiteto che alcuni
studiosi fanno derivare da fero, “portato”, perché a lui venivano “portate”, offerte
le spolia opima, o da ferculum, una sorta di barella sulla quale venivano
trasportate le spolia. Più verosimilmente, Feretrius vuol dire “che colpisce” (da
ferire, “colpire”, “uccidere”) e non a caso il signum di Giove Feretrio era una
pietra dura, custodita nel tempio, che Carandini identifica con un’ascia
preistorica che rappresentava il fulmine e con la quale veniva immolata una
scrofa al termine della ovatio che concludeva la processione che dalla Velia si
snodava lungo la via Sacra fino al Campidoglio. Sempre secondo Carandini, il
tempio si trovava nell’area del Palazzo dei Conservatori e in origine era una
capanna con un’ara antistante. Ricostruito più volte, il tempio - il cui aspetto è
conosciuto solo da una moneta del 44 a.C. - sorgeva su un alto podio gradinato,
era di dimensioni piuttosto ridotte, aveva quattro colonne sulla fronte e una
ricca trabeazione.
La dedica delle spolia opima fu ripetuta soltanto altre due volte nella lunga storia
di Roma: nel 437 a.C. da Aulo Cornelio Cosso che dedicò le spolia di Lars
Tolumnius, re di Veio; nel 222 a.C. da Marco Claudio Marcello che dedicò le
spolia di Viridomaro, re dei Galli Insubri.
Tarpea
È una delle figure più ambigue della mitologia romana, tanto che nel ciclo
leggendario che la riguarda passa dal ruolo di traditrice a quello di eroina.
La tradizione più diffusa narrava che la giovane, figlia di Spurio Tarpeio,
comandante delle guardie del Campidoglio, si era perdutamente innamorata di
Tito Tazio. Aiutata da una serva (o dalla nutrice), Tarpea fece sapere al re sabino
di essere pronta a tradire Roma, a patto che egli la sposasse. Tito Tazio accettò e
la giovane riuscì a farlo entrare con il suo esercito nell’Arx Capitolina. Tito Tazio,
però, non mantenne la promessa e la fece uccidere dai suoi soldati che le
lanciarono addosso i loro pesanti scudi.
Un’altra versione del mito offre un’immagine meno romantica di Tarpea che
avrebbe tradito in cambio di “ciò che Tito Tazio e i suoi soldati portavano al
braccio sinistro”, intendendo i preziosi bracciali d’oro con i quali si ornavano i
Sabini. Questi ripagarono la traditrice schiacciandola sotto il peso dei loro scudi,
“che portavano al braccio sinistro”.
I Romani, poi, “giustiziarono” a loro volta il cadavere della giovane lanciandolo
dalla rupe che da lei prese nome - Mons Tarpeius, Rupe Tarpea - e dalla quale, da
allora, furono gettati i criminali in genere e i traditori in particolare.
Comunque siano andati i fatti, i mitografi romani cercarono di scagionare Tarpea
dall’infamia del tradimento e versioni più recenti della leggenda originaria
raccontavano che la giovane aveva solo fatto finta di tradire Roma. La sua
richiesta di darle “ciò che portavano al braccio sinistro” avrebbe avuto l’unico
scopo di farsi consegnare gli scudi dai soldati sabini che sarebbero così entrati
indifesi nella Cittadella. I Sabini, accortisi dell’inganno, l’avrebbero trucidata nel
modo descritto. Quest’ultima versione ebbe tale consenso popolare che i Romani
le tributarono un culto locale sul Campidoglio, onorandola come un’eroina.
Al di là delle versioni più o meno favorevoli a Tarpea, è certamente più realistico
che si tratti di una mistificazione storica: come poteva Spurio Tarpeio avere una
figlia giovinetta visto che Roma era stata fino a pochissimo tempo prima una
città senza donne? La verità storica è un’altra: l’Arce Capitolina cadde in mano ai
Sabini perché i Romani non seppero difenderla e il mito della traditrice Tarpea
fu solo una menzogna degli storici di parte per coprire una disfatta militare.
Matronalia
Si svolgevano alle Calende di marzo in onore di Giunone Lucina. Il tempio
dedicato a Giunone Lucina sull’Esquilino era stato consacrato il primo marzo del
375 a.C. e Ovidio afferma che Romolo era nato il primo marzo e che proprio in
questo giorno le donne sabine rapite dai Romani si recarono sul campo di
battaglia e riuscirono a far cessare la guerra fra Sabini e Romani. Secondo
Plutarco, le Sabine si gettarono «tra le armi e i cadaveri, piangendo e urlando,
come invasate da un dio, e andarono incontro ai mariti e ai padri; alcune tenevano
tra le braccia i figlioletti» (Vita di Romolo). Le Matronalia, cui partecipavano solo
le donne sposate, presentavano alcune analogie con i Saturnalia: in quel giorno
le serve e le schiave godevano di ampia libertà e le loro padrone preparavano e
servivano una cena in loro onore. In quel giorno i mariti colmavano le mogli di
attenzioni e facevano loro molti regali fra i quali non potevano mancare un
umbella (ombrellino parasole), in segno di onore e tutela, e una clavis (chiave),
simbolo propiziatorio di facili parti.
None Caprotine
Erano feste talmente antiche che persino gli autori classici facevano fatica a
ricostruirne il mito originario discordando sia sul giorno del culto che sulla
divinità al centro dei riti.
Plutarco (Vita di Romolo) le chiama indifferentemente Poplifugia o None
Caprotine e afferma che si riferiscono entrambe alla scomparsa di Romolo sia
perché il rito consisteva nel simulare la fuga del popolo e la confusione che si era
scatenata al momento dei fatti, sia perché la commemorazione avveniva alla
Palus Caprae. Però questa ipotesi di un’unica festa è contraddetta dagli altri
mitografi e persino dallo stesso Plutarco in un’altra sua opera (Vita di Camillo). Il
Vaccai (Feste di Roma antica) dimostra che in effetti si trattava di due feste
distinte, ma connesse in quanto entrambe celebravano in due giorni diversi due
fasi di un unico avvenimento: le Poplifugia (5 luglio) in ricordo della fuga del
popolo e della gran confusione, le None Caprotine (7 luglio) la sparizione di
Romolo.
Se sul significato delle Poplifugia sembra che non vi siano dubbi, sull’origine e
significato delle None Caprotine non tutti gli autori sono d’accordo.
Varrone, Plutarco e Macrobio, infatti, fanno risalire l’istituzione della festa ad un
avvenimento accaduto intorno al 390 a.C. Approfittando della debolezza in cui
versava Roma dopo l’invasione dei Galli guidati da Brenno, i Latini assediarono
la Città e chiesero in riscatto ai Romani le loro giovani vergini, come unica
alternativa ad una totale distruzione dell’Urbe. Gli uomini di Roma, ovviamente,
esitavano a piegarsi a tali disonorevoli condizioni, quando una bella schiava di
nome Filotide (o Tutola) propose ai Romani uno stratagemma che avrebbe
salvato donne e onore: lei e alcune graziose schiave, vestite da donne libere, si
sarebbero recate nell’accampamento dei Latini, li avrebbero circuiti e poi fatti
ubriacare. A questo punto i Romani sarebbero entrati indisturbati nel campo
nemico. Il Senato acconsentì e tutto si svolse come programmato da Filotide.
Infatti, quando tutti i Latini, ubriachi, caddero in un sonno profondo, Filotide,
dall’alto dei rami di un fico selvatico, fece con una lampada il segnale convenuto
di via libera ai Romani che giunsero di corsa e massacrarono tutti i Latini.
In ricordo dell’eroico gesto di Filotide e delle sue compagne furono istituite le
None del Fico o None Caprotine (da caprifico, fico selvatico) alle quali potevano
partecipare tutte le donne, sia libere che serve, tanto che la festa era anche
chiamata Ancillorum Festum, Festa delle Serve. La festa si concludeva con
l’offerta alle donne di un grande banchetto allestito sotto una pergola di rami di
fico selvatico.
Altre interpretazioni della festività riferivano che le None Caprotine così si
chiamavano in onore di Giunone Caprotina, venerata in tutto il Lazio con il nome
di Giunone Sospita (Protettrice), alla quale in quel giorno si sacrificava sotto un
fico selvatico offrendo alla dea la linfa dell’albero. A Roma i riti si svolgevano nel
tempio di Giunone Sospita nel Foro Olitorio (San Nicola in Carcere) che ospitava
una statua della dea che sia Cicerone che Festo descrivono ornata con una
doppia veste cinta alla vita, armata di lancia e scudo e il capo coperto con una
pelle di capra le cui zampe erano annodate sul petto, da cui l’appellativo
caprotina.
Ovatio e Triumphus
Ovatio: l’ovazione, o piccolo trionfo, era una cerimonia con cui venivano resi gli
onori a un generale vittorioso. L’origine della parola è controversa fin
dall’antichità. La maggior parte degli autori vi vede la radice latina ovis, pecora,
animale immolato al termine della cerimonia. Dionigi la fa derivare dalla parola
greca euòi, (evoè), grido di gioia delle baccanti, Festo dalla parola ovantes, a sua
volta derivata dal grido gioioso “O! O!” lanciato dai soldati vittoriosi. L’ovatio,
decretata dal Senato romano, veniva concessa in occasione di guerre di minore
importanza, quando il nemico non era degno di Roma (ad esempio pirati e
schiavi), quando il conflitto si era concluso con poco o nessun spargimento di
sangue o non c’era stato pericolo per l’esercito. Poteva essere accordata anche
ad un generale che aveva condotto una campagna vittoriosa nel corso di una
guerra non ancora conclusa. Il generale al quale era dedicata l’ovatio entrava in
città a piedi (nel trionfo su una biga trainata da due cavalli bianchi), indossava la
toga praetexta del magistrato (una toga con una striscia color porpora, a
differenza dei generali trionfanti che indossavano la toga picta, completamente
viola e ornata con ricami d’oro) e si cingeva la fronte con la corona ovalis, una
corona di mirto, in luogo della corona triumphalis di alloro. Il Senato non
precedeva il generale, come avveniva nel trionfo, e di solito i soldati non
partecipavano alla parata.
Triumphus: il trionfo (dall’etrusco triumpe; in origine questo termine designava
una musica e una danza) era la più alta onorificenza militare concessa dal Senato
al comandante vittorioso di una guerra che avesse visto almeno cinquemila
nemici caduti. In età imperiale fu concesso solo agli Imperatori. In origine era
una pratica religiosa di purificazione dell’esercito vittorioso che tornava dalla
guerra ma già in epoca repubblicana si era trasformata in una sfarzosa
dimostrazione del potere romano: nel corteo veniva esibito il bottino di guerra e
fatte sfilare grandi tavole su cui erano incisi i dati e gli avvenimenti salienti della
campagna militare. Su una di queste tavole, nel suo trionfo del Ponto, Cesare fece
scrivere il celebre veni, vidi, vici.
Il trionfo era occasione di grande festa popolare alla quale partecipavano in
massa i cittadini che acclamavano il trionfatore con grida di esultanza e lancio di
fiori. Il corteo, aperto da trombe, si articolava in tre parti. Il primo settore era
riservato al bottino e alle tavole esplicative portati a piedi e su lunghe colonne di
carri; dietro a questi, gli ostaggi e i prigionieri in catene. La parte centrale del
corteo era riservata al trionfatore: funzionari, magistrati e senatori precedevano
il carro del trionfatore seguito dai parenti maschi a cavallo. Il trionfatore stava
ritto su un carro sfarzosamente decorato e trainato da quattro cavalli che da
Cesare in poi saranno bianchi. Portava le antiche insegne regali: indossava vesti
di porpora ricamate d’oro e una corona d’alloro sulla testa; nella mano destra
teneva un ramoscello d’alloro e nella sinistra uno scettro d’avorio. Uno schiavo
gli sorreggeva sul capo una pesante corona d’oro e, affinché non suscitasse
l’invidia degli Dei e per metterlo in guardia dalla presunzione, gli ripeteva
continuamente: «Ricordati che devi morire! Guardati attorno! Ricordati che sei
solo un uomo!». Il corteo era chiuso dall’esercito che marciava al ritmo di inni
militari, di canti agli Dei e di canzonacce di scherno rivolte al trionfatore.
Il momento culminante del trionfo era il sacrificio nel tempio di Giove Capitolino
che veniva celebrato non appena arrivava la notizia che nel vicino Tullianum
era avvenuta l’esecuzione di almeno uno dei prigionieri nemici. Infine, il
trionfatore offriva un banchetto pubblico ai soldati e ai cittadini.
Secondo le ipotesi più accreditate questo era il percorso del corteo: iniziava nel
Circo Flaminio (Portico d’Ottavia), costeggiava l’area del Teatro di Marcello ed
entrava nel Foro Olitorio, attraversava l’area sacra di S. Omobono, imboccava il
vico Iugario ed entrava nella piazza del Foro Romano. A questo punto tornava
indietro per il Vicus Tuscus, entrava nel Foro Boario, percorreva la valle Murcia
(Circo Massimo), costeggiava il Palatino in corrispondenza dell’attuale via di S.
Gregorio, entrava nuovamente nel Foro percorrendo la via Sacra e risalendo il
Clivo Capitolino giungeva al Tempio di Giove Capitolino.
Tullianum
«Per intimorire la crescente audacia criminosa» e perché ormai i cittadini «non
distinguevano più fra le azioni giuste e le ingiuste, e avvenivano dei delitti senza
che se ne scoprisse l’autore» (Tito Livio) Tullo Ostilio (III Re) - prendendo ad
esempio il carcerem dei circhi, vale a dire lo steccato che tratteneva i cavalli
prima della corsa - “inventò” il carcere, ovvero un luogo dove rinchiudere i
delinquenti prima della loro ultima corsa verso la morte... Altri autori
affermavano che il carcere era detto Tullianum perché sorgeva presso un tullus,
una sorgente, o dalla sua forma a tholos (un ambiente circolare che si restringe
verso l’alto). In generale si ritiene che l’edificio originario fosse una cisterna che
raccoglieva le acque del Campidoglio, prosciugata alla meglio e chiusa da una
copertura in legno. Nei secoli successivi la copertura in legno fu sostituita da una
in muratura e su questa venne edificato un secondo ambiente, comunicante con
il sottostante attraverso una botola. Il piano superiore ospitava i detenuti in
attesa di giudizio, mentre nel piano inferiore venivano eseguite le condanne a
morte mediante strangolamento eseguito a mani nude. Un cunicolo collegato con
il Tevere permetteva una rapida eliminazione dei cadaveri. Gli scrittori romani
distinguevano il carcer (piano superiore) dal tullianum sotterraneo in quanto la
carcerazione era sconosciuta alla giustizia romana che prevedeva come
condanna solo l’esilio o la pena capitale. Il Carcer e le vicine Lautumiae (nei
pressi dell’attuale Clivo Argentario), altri ambienti del carcere così chiamati
perché ricavati entro antiche cave di tufo (da latomiae, “pietre tagliate”), erano
prigioni più miti, relativamente confortevoli, nelle quali i carcerati, ad esempio,
potevano ricevere le visite di parenti e amici. Si narra che il poeta Nevio (III sec.
a.C.) abbia scritto due commedie in carcere.
Per quanto riguarda il Tullianum, invece, «il suo aspetto è ripugnante e
spaventoso per lo stato di abbandono, l’oscurit{, il puzzo», scrive Sallustio e con il
quale concordano tutti gli storici dell’antichità che lo descrivono come un luogo
talmente orrendo che alcuni condannati preferivano suicidarsi piuttosto che
esservi rinchiusi. Fu questo il caso di Erennio Siculo, un aruspice amico di Caio
Gracco, che si tolse la vita battendo la testa contro uno stipite dell’ingresso
prima di essere rinchiuso nel carcere. Svetonio, nella Vita di Tiberio, riferisce che
poiché una antica legge vietava l’uccisione nel carcere di una vergine, questa
veniva violentata dal carnefice prima di essere giustiziata.
Una lapide posta all’entrata del piano superiore ricorda che qui furono
giustiziati, fra tanti, i partigiani di Caio Gracco, i partecipanti alla congiura di
Catilina, Vercingetorige, re dei Galli, e Giugurta, re di Numidia, il quale, prima di
morire, non seppe trattenersi dal beffeggiare i suoi carnefici: «Come è freddo
questo vostro bagno, Romani!».
Per esservi stati detenuti S. Pietro e S. Paolo, secondo una tradizione nata nel IV
secolo, l’edificio fu per secoli un luogo di culto cristiano consacrato a S. Pietro in
Carcere fino a quando, nel 1597 l’Arciconfraternita dei Falegnami fece iniziare
sopra al carcere la costruzione della Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami.
La denominazione di “Carcere Mamertino” con la quale è oggi indicato è di epoca
medievale.
Accanto al Tullianum vi erano le cosiddette Scalae Gemoniae (grossomodo
l’attuale scalinata che fiancheggia la chiesa di S. Giovanni dei Falegnami), una
scalinata scavata nel tufo che secondo un’etimologia popolare deriverebbe il suo
nome da gemo, cioè dai “gemiti” dei condannati prima della loro esecuzione nel
Tullianum. Su questa scala venivano anche esposti i corpi dei giustiziati prima di
essere gettati nel Tevere.
Note
1] Lacus Curtius: uno spazio irregolare che indica l’ultimo avanzo dell’antichissima palude
del Foro. All’origine della sua denominazione troviamo due leggende. La prima narra che nel
362 a.C. in quel punto si aprì una profonda voragine che non si riusciva a richiudere. I Romani
interrogarono l’Oracolo che rispose che la voragine si sarebbe richiusa solo se vi fosse stato
gettato quanto Roma aveva di più caro. Il giovane Marco Curzio, ritenendo di essere “quanto
di più caro” aveva Roma, in groppa al suo cavallo si gettò nella voragine che si richiuse seduta
stante sopra di lui. Un piccolo bassorilievo posto in loco nel Foro mostra il sacrificio di Curzio.
La seconda leggenda fa riferimento ad un avvenimento più antico: nel 445 a.C. il console Caio
Curzio avrebbe recintato questa voragine aperta dalla caduta di un tremendo fulmine.
2] Tempio Giove Statore: attualmente la teoria più accreditata lo colloca nel cosiddetto
tempio di Romolo (figlio di Massenzio) nel Foro. Probabilmente il santuario di epoca romulea
consisteva semplicemente in un altare circondato da uno steccato o da un basso muro. Il
tempio vero e proprio fu costruito nel III secolo a.C. all’epoca della terza guerra contro i
Sanniti e custodiva una statua di Giove rappresentato con la folgore nella mano destra e le
gambe affondate in un blocco di pietra ad indicare la fermezza del dio nell’arrestare i nemici.
3] Luceres: secondo Tito Livio erano di origine incerta, secondo altri autori erano gli abitanti
delle zone boscose intorno a Roma (da lucus, “bosco”), secondo altri ancora erano o genti di
origine etrusca condotte a Roma da un lucumon, un re, o discendenti da Lucero, re dei Rutuli
(Ardea).
4] Gli storici moderni affermano che il Collis Quirinalis era abitato da popolazioni sabine ancor
prima della Fondazione ed era così chiamato da un tempio in onore del dio sabino Quirinus
fatto costruire, secondo la leggenda, da Modio Fabidio, figlio del dio.
5] Curia: dall’arcaico co-viria, “riunione di uomini”.
6] Plutarco racconta che Romolo e Tito Tazio non tennero mai consiglio in comune. Ognuno di
loro deliberava separatamente con i 100 Anziani del proprio Consiglio che poi si riunivano in
uno stesso luogo per deliberare unitamente.
7] Palus Caprae: un’area paludosa formata da un piccolo fiume, l’Acqua di Amnia Petronia,
che scendeva dal Quirinale e raggiungeva Campo Marzio. Corrisponde all’incirca all’area poi
occupata dal Pantheon, dalle terme di Agrippa e dal teatro di Pompeo. La palus fu bonificata
da Agrippa e trasformata nello stagnum (la piscina delle terme fatte da lui costruire) dal quale
fuoriusciva l’Euripus, un canale scoperto che convogliava le acque verso il Tevere, all’altezza
dell’attuale Ponte Vittorio Emanuele II.
8] Ops: dea italica dell’abbondanza (ops, “ricchezza”, “risorsa”), soprattutto agricola. In suo
onore si celebravano gli Opeconsiva (25 agosto) e gli Opalia (19 dicembre). Faceva parte di
una serie di divinità minori introdotte da Tito Tazio ed aveva una cappella nel Foro dove
potevano entrare solo le Vestali e il Pontefice Massimo.
9] Ambrosio Teodosio Macrobio: scrittore latino (IV-V sec.) di origine greca o africana. Fu
tra gli ultimi grandi rappresentanti della cultura pagana in un’epoca in cui era ormai
trionfante il cristianesimo. È noto soprattutto per Saturnalia, vasta opera enciclopedica in
sette libri pervenutaci incompleta.