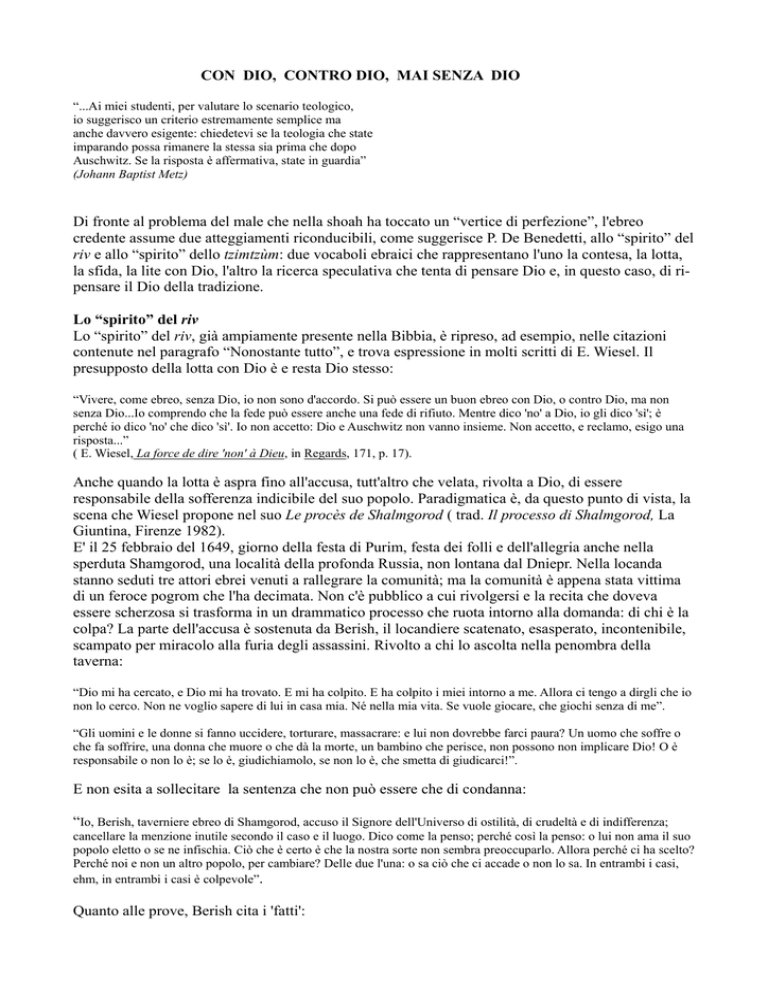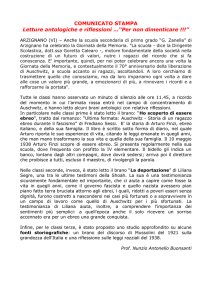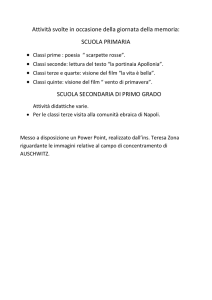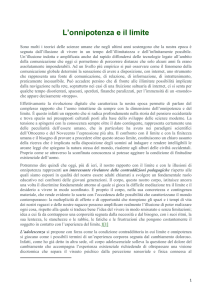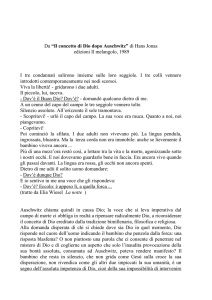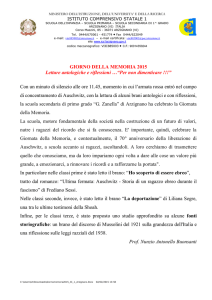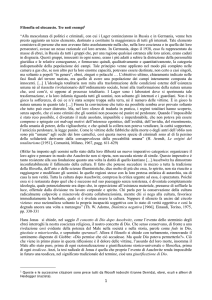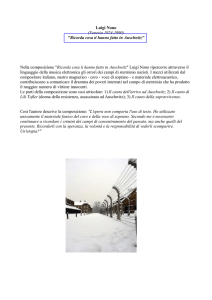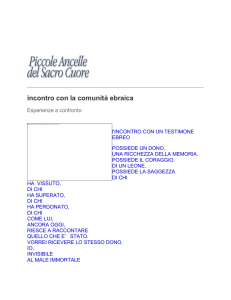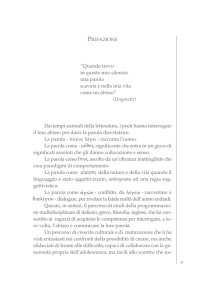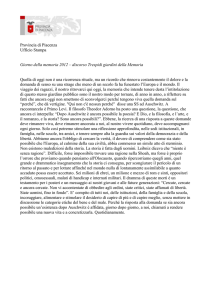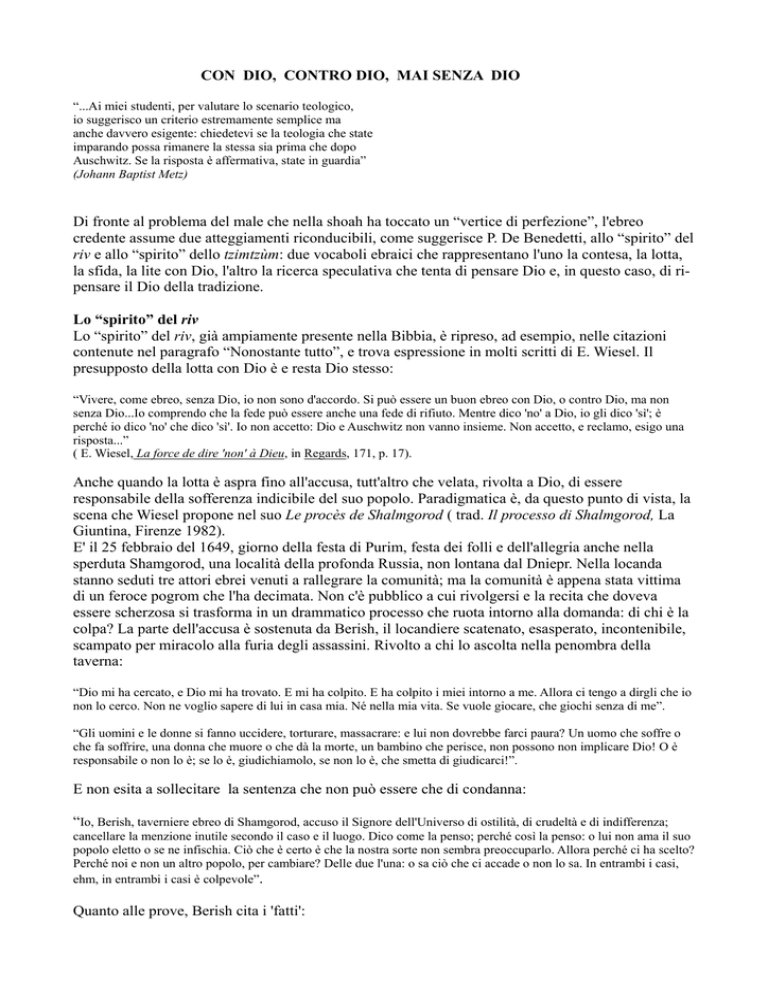
CON DIO, CONTRO DIO, MAI SENZA DIO
“...Ai miei studenti, per valutare lo scenario teologico,
io suggerisco un criterio estremamente semplice ma
anche davvero esigente: chiedetevi se la teologia che state
imparando possa rimanere la stessa sia prima che dopo
Auschwitz. Se la risposta è affermativa, state in guardia”
(Johann Baptist Metz)
Di fronte al problema del male che nella shoah ha toccato un “vertice di perfezione”, l'ebreo
credente assume due atteggiamenti riconducibili, come suggerisce P. De Benedetti, allo “spirito” del
riv e allo “spirito” dello tzimtzùm: due vocaboli ebraici che rappresentano l'uno la contesa, la lotta,
la sfida, la lite con Dio, l'altro la ricerca speculativa che tenta di pensare Dio e, in questo caso, di ripensare il Dio della tradizione.
Lo “spirito” del riv
Lo “spirito” del riv, già ampiamente presente nella Bibbia, è ripreso, ad esempio, nelle citazioni
contenute nel paragrafo “Nonostante tutto”, e trova espressione in molti scritti di E. Wiesel. Il
presupposto della lotta con Dio è e resta Dio stesso:
“Vivere, come ebreo, senza Dio, io non sono d'accordo. Si può essere un buon ebreo con Dio, o contro Dio, ma non
senza Dio...Io comprendo che la fede può essere anche una fede di rifiuto. Mentre dico 'no' a Dio, io gli dico 'sì'; è
perché io dico 'no' che dico 'sì'. Io non accetto: Dio e Auschwitz non vanno insieme. Non accetto, e reclamo, esigo una
risposta...”
( E. Wiesel, La force de dire 'non' à Dieu, in Regards, 171, p. 17).
Anche quando la lotta è aspra fino all'accusa, tutt'altro che velata, rivolta a Dio, di essere
responsabile della sofferenza indicibile del suo popolo. Paradigmatica è, da questo punto di vista, la
scena che Wiesel propone nel suo Le procès de Shalmgorod ( trad. Il processo di Shalmgorod, La
Giuntina, Firenze 1982).
E' il 25 febbraio del 1649, giorno della festa di Purim, festa dei folli e dell'allegria anche nella
sperduta Shamgorod, una località della profonda Russia, non lontana dal Dniepr. Nella locanda
stanno seduti tre attori ebrei venuti a rallegrare la comunità; ma la comunità è appena stata vittima
di un feroce pogrom che l'ha decimata. Non c'è pubblico a cui rivolgersi e la recita che doveva
essere scherzosa si trasforma in un drammatico processo che ruota intorno alla domanda: di chi è la
colpa? La parte dell'accusa è sostenuta da Berish, il locandiere scatenato, esasperato, incontenibile,
scampato per miracolo alla furia degli assassini. Rivolto a chi lo ascolta nella penombra della
taverna:
“Dio mi ha cercato, e Dio mi ha trovato. E mi ha colpito. E ha colpito i miei intorno a me. Allora ci tengo a dirgli che io
non lo cerco. Non ne voglio sapere di lui in casa mia. Né nella mia vita. Se vuole giocare, che giochi senza di me”.
“Gli uomini e le donne si fanno uccidere, torturare, massacrare: e lui non dovrebbe farci paura? Un uomo che soffre o
che fa soffrire, una donna che muore o che dà la morte, un bambino che perisce, non possono non implicare Dio! O è
responsabile o non lo è; se lo è, giudichiamolo, se non lo è, che smetta di giudicarci!”.
E non esita a sollecitare la sentenza che non può essere che di condanna:
“Io, Berish, taverniere ebreo di Shamgorod, accuso il Signore dell'Universo di ostilità, di crudeltà e di indifferenza;
cancellare la menzione inutile secondo il caso e il luogo. Dico come la penso; perché così la penso: o lui non ama il suo
popolo eletto o se ne infischia. Ciò che è certo è che la nostra sorte non sembra preoccuparlo. Allora perché ci ha scelto?
Perché noi e non un altro popolo, per cambiare? Delle due l'una: o sa ciò che ci accade o non lo sa. In entrambi i casi,
ehm, in entrambi i casi è colpevole”.
Quanto alle prove, Berish cita i 'fatti':
“Il primo fatto ce l'avete davanti a voi, intorno a voi: Shamgorod. Shamgorod aveva una comunità ebraica prima...Una
vita ebraica, un calore ebraico. Una melodia ebraica in ogni strada, in ogni catapecchia. Andate a cercare ora.
Shamgorod è muta. Il suo silenzio non è un fatto?”
A chi gli obietta che Dio è vittima della sua creazione:
“Vittima lui? La vittima è impotente; Dio non lo è. Al contrario: è onnipotente, e tutti i poteri derivano dal suo. Se
l'assassino uccide è perché è più forte della sua vittima; e questa forza chi gliel'ha data? Colui che è il solo a poter dare
tutto”.
E a chi gli chiede se si renda conto che sta accusando Dio di stare dalla parte degli assassini, Berish
risponde:
“Esattamente. E non mi domandate da dove lo so. Lo so dagli assassini: Me l'hanno detto loro. Lo hanno detto alle
vittime. Lo ripetono continuamente. Tutti gli assassini della Storia pretendono di agire sempre in nome del Signore”.
Nonostante tutto, Berish conclude:
“Ho vissuto da ebreo, morirò da ebreo; ed è anche in quanto ebreo che con tutte le mie forze gli griderò che ha torto. E
poiché la fine si avvicina, griderò più forte. E poiché la fine si avvicina, la sua colpevolezza è ancora più grande”.
Lo “spirito” dello tzimtzùm
Per meglio afferrare il concetto di tzimtzùm conviene attingere ad una splendida pagina di Gershom
Scholem nella quale l'autore parla di Isaac Luria (1514 – 1572), capo della scuola cabbalistica di
Sàfed. Al centro della riflessione di Luria sta la teoria dello tzimtzùm che concepisce il processo
cosmico in termini drammatici e nuovi rispetto alla tradizione dell'antica Qabbalà, benché lo stesso
Luria si proponga come l'interprete autentico di essa. In realtà, osserva Sholem, la sua lettura è
addirittura antitetica. Ma ecco la pagina di Sholem:
“...Per l'antica Qabbalà il processo cosmico si svolge in un modo molto (…) semplice. Il primo momento è l'atto col
quale Dio procede all'esterno, e proietta dal suo essere la sua forza creativa; ogni atto successivo è un simile ulteriore
processo di esteriorizzazione. Il processo si svolge cioè interamente secondo lo schema delle teorie emanazionistiche
neoplatoniche, dall'alto in basso, secondo una linea unitaria. E', se posso esprimermi così, una via a senso unico, e
corrispondentemente semplice.
La concezione di Luria invece non ha questa innocente semplicità. Al vertice del suo pensiero è la dottrina dello
tzimtzùm,una delle idee mistiche più sorprendenti, e più ricche di implicazioni, che siano mai state concepite nella storia
della Qabbalà. Tzimtzùm vuol dire realmente 'concentrazione' o 'contrazione', ma -se si vuole comprendere esattamente
il significato della concezione di Luria – sarebbe da tradursi assai meglio con 'ritiro' o 'ritorno'. Luria (…) partiva da una
fonte talmudica che, per dirla in breve, egli aveva però rovesciata. In un passo del midrash è detto che Dio avrebbe
concentrato la sua Shekhinà, la sua sacra presenza nel Santo dei Santi, nel luogo dei Cherubini, e così Egli al tempo
stesso avrebbe concentrato tutto il suo potere e lo avrebbe contratto in un solo punto. Da qui deriva il termine tzimtzùm;
ma il suo contenuto è trasformato così da divenire proprio l'opposto che prima esprimeva: infatti il cabbalistico
tzimtzùm non significa la concentrazione di Dio in un luogo, ma il suo ritrarsi fuori da ogni luogo. Che significato ha
tutto questo? Detto brevemente significa che l'esistenza dell'universo fu resa possibile da un processo di contrazione di
Dio. Originariamente Luria parte da un pensiero assolutamente razionalistico, ed anzi, se si vuole, abbastanza
naturalistico. Come può esistere un mondo, quando l'essere di Dio è dappertutto? Come può esistere in questo luogo
concreto qualcosa di diverso da Dio, dal momento che Dio è 'tutto in tutto'? Come può Dio creare dal nulla, se non può
esservi un nulla, dato che il suo essere penetra ogni cosa? E Luria risponde con un pensiero che (…) ha dato prova di
essere uno dei più fruttuosi e profondi per la riflessione dei mistici ebrei posteriori. Luria intende dire che Dio -per
garantire la possibilità del mondo - dovette rendere vacante nel suo essere una zona, dalla quale Egli quindi si ritrasse;
una specie di mistico spazio primordiale, in cui Egli potesse ritornare nell'atto della creazione e della rivelazione. Il
primo di tutti gli atti dell'Essere ionfinito (…) non fu pertanto un movimento verso l'esterno, ma verso l'interno, un
movimento entro se stesso, un restringersi in sé -se posso usare questa ardita espressione – di Dio, 'da sé in se stesso'.
Quindi invece di produrre una prima emanazione dal suo essere o dalla sua forza fuori di sé, [Egli] al contrario si
sprofonda giù nel fondo di se stesso, si concentra in se stesso; e ha fatto sempre così fin dal principio della creazione” (
G. Sholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, Einaudi, Torino 1993, pp. 270-71).
La dottrina dello tzimtzùm, tanto ardita da essere considerata blasfema eppure continuamente
ripresa, intende l'atto divino originario non come 'rivelazione', ma come 'occultamento', solitudine',
'esilio' di Dio dalla sua onnipotenza.
Di questo ritrarsi di Dio nella solitudine, della sua impotenza, vi sono molti esempi nella Bibbia e
su di essi riflettono spesso i rabbini nel Talmud. Susan Shapiro, la studiosa già citata nel testo
preparatorio, si è soffermata nella sua ricerca sull'ermeneutica ebraica su un passo del Talmud
babilonese (Yoma) assai interessante. In esso appare evidente come, all'indomani della distruzione
del primo Tempio, Daniele e Geremia omettano, in riferimento a Dio, due dei tre attributi, quelli che
indicano potenza e terrore, ricordati da Mosè nel Deuteronomio ( “Dio grande, forte e terribile”).
Yoma sostiene che l'omissione degli attributi era doverosa , anzi necessaria, perché “il Santo -sia
egli benedetto- esige che si dica la verità”, e i rabbini “non volevano attribuirgli cose false”. Quanto
poi al fatto che più tardi Esdra ripristini nella sua integrità la 'corona degli attributi divini' (grande,
potente, tremendo), cò è dovuto al fatto che, “vivendo molto tempo dopo la distruzione del primo
Tempio e mentre si costruiva il secondo Tempio, i rabbini successivi videro probabilmente la verità
in modo diverso e, testimoniando in favore della verità del loro momento storico, poterono così
restaurare quegli aggettivi prima cancellati che si riferivano alla maestà di Dio” ( S. Shapiro,
L'ascolto della testimonianza della negazione radicale, in 'Concilium', 5/1984, p. 26)
Affiora qui l'idea non di un Dio 'Signore' della storia, ma di un Dio 'contaminato' e 'limitato' dalla
storia la quale può opporsi a che venga ripristinata integralmente la sua divina essenza. Come dire:
Dio ha bisogno dell'uomo. E questo accresce a dismisura la responsabilità dell'uomo verso Dio.
H. Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz.
“Un frammento di teologia speculativa”
Non si tratta di dimostrare l'esistenza di Dio. Possiamo pensare che Jonas aderisca, sotto questo
aspetto, alla dialettica trascendentale di Kant in cui si dimostra che non è possibile dimostrare
l'esistenza di Dio. Si tratta invece di stabilire come Dio possa essere pensato. Si tratta dunque di una
riflessione filosofica (che tuttavia parte dalla certezza dell'esistenza di Dio): costruire un'idea
coerente di Dio.
A rendere improponibile la concezione tradizionale di Dio ( i cui attributi fondamentali, secondo
Jonas, sono l'infinita bontà, l'onnipotenza e la comprensibilità da parte dell'uomo), ha fatto irruzione
nel XX s. la shoah.
Nella storia passata di Israele si narra che Dio ha stretto un patto di protezione e di salvezza con il
suo popolo, e a questo patto è rimasto fedele, nonostante tutto. Molte sono le traversie vissute e le
persecuzioni subite da questo popolo, ma i suoi profeti e i suoi maestri hanno sempre potuto
'comprendere' e 'giustificare' le sofferenze patite: a volte perché quelle sofferenze erano giuste
punizioni causate dall'infedeltà del popolo; a volte perché quei patimenti erano testimonianza della
fede di fronte al mondo.
Adesso però, di fronte ad Auschwitz, queste 'giustificazioni' non reggono, sono incomprensibili e
inaccettabili. Quale colpa può giustificare il massacro di sei milioni di ebrei? E d'altra parte: il
popolo ebraico non è stato chiamato a testimoniare la propria fede; non gli è stata data alcuna
possibilità di farlo e del resto sono stati uccisi anche ebrei senza fede e un milione di bambini che
non potevano testimoniare alcunché. In nome della razza, la fede è stata messa fuori questione: non
è in causa, non c'entra. Da questo punto di vista la shoah è un evento che appartiene all'Occidente
laico.
Jonas sottolinea che l'ebreo è più in difficoltà, di fronte alla shoah, di quanto non sia il cristiano, dal
momento che egli aspetta qui la salvezza: il suo Dio è il Dio della storia e Auschwitz contesta e
cancella un Dio così clamorosamente perdente. Il cristiano, invece, vede qui il peccato e nell'aldilà
la salvezza. La domanda, per l'ebreo credente, è: quale Dio ha permesso Auschwitz?
La riflessione di Jonas può essere articolata in quattro punti o momenti: la 'narrazione mitica delle
origini', le implicazioni teologiche del mito, l'obiezione logica al concetto di onnipotenza,
l'obiezione teologica al concetto di onnipotenza.
1) Il mito: La creazione come 'rischio' divino
a)- Dio abbandona la sua solitudine e si mette in gioco senza riserva nella creazione. Il mondo si
dispiega nel tempo secondo un processo libero e autonomo che Dio, per una scelta imperscrutabile,
ha voluto. Dio si è così 'ristretto', ha ridotto la propria divina sovranità correndo il rischio di non
riaverla, data l'imprevedibilità del divenire.
b)- Nel divenire del mondo irrompe la vita, evento non previsto e che rappresenta la possibilità che
la materia si volga verso Dio reintegrandone la pienezza. Ma con la vita si affaccia nel mondo la
morte, esito ineludibile della vita. Questa si rifrange nell'infinita gamma delle forme dei viventi. La
vita, ancorché finita, è volta verso Dio: “Le sue creazioni, realizzando se stesse secondo il loro
istinto, legittimano il rischio divino”. Si tratta di un processo libero ma inconscio, 'innocente'.
c)- L'uomo, creatura di Dio, è libero e sa. L'innocenza -che è ignoranza- non appartiene all'uomo
responsabile. Ora, a partire dall'uomo, verso dove si volgerà la creazione? L'esito della scelta divina
di 'ritrarsi' è realmente nella possibilità dell'uomo. Il destino stesso di Dio è in bilico. “La
Trascendenza diviene consapevole di se stessa con la comparsa dell'uomo e da quel momento ne
segue l'agire trattenendo il respiro, sperando e corteggiandolo, con gioia e con tristezza, con
soddisfazione e disinganno”.
2) Implicazioni teologiche del mito
a)- Un Dio sofferente. Nel mito, nell'atto della creazione -in particolare dell'uomo- appare un Dio
sofferente e ciò sembra urtare con la rappresentazione biblica della maestà di Dio. Ma è proprio
così? O non è vero, invece, che il Dio della Bibbia 'sopporta' la contraddizione? “Non incontriamo
forse nella Bibbia ebraica un Dio che si sente ignorato e misconosciuto dall'uomo e che di ciò si
rattrista? Non lo vediamo rammaricarsi per aver creato l'uomo, soffrendo per la delusione che
l'uomo gli ha procurato?”.
b)- Un Dio diveniente. Il mito racconta che con la creazione Dio diviene; rinunciando all'eterna
identità divina egli si 'cala' nel tempo. Ciò contrasta con la tradizione greca (si pensi al 'motore
immobile' aristotelico che “muove senza essere mosso”), ma non con quella ebraica in cui Dio
appare 'toccato' da ciò che accade nel mondo, e perciò viene mutato nella condizione che gli è
propria. Essendo in rapporto con il mondo creato, Dio stesso muta con il mutare del processo
cosmico. (Ciò mette in crisi anche l'alternativa nietzschiana dell'eterno ritorno dell'identico perché
l'eterno stesso non può essere lo stesso una volta che si ammette che l'eternità è toccata da ciò che
accade nel tempo).
c)- Un Dio che si prende cura. Il mito racconta di un Dio che non è lontano, ma coinvolto in ciò di
cui si prende cura. Interrotta la sua solitudine con l'atto creatore, Dio è coinvolto nel mondo e nella
storia che non dipendono più da lui. Per questo egli è in costante pericolo, in quanto 'dipende' da ciò
che ha creato e che è oggetto della sua cura e della sua preoccupazione: “Dio...ha concesso qualcosa
all'Altro da sé, da lui stesso creato: uno spazio per agire e per determinare insieme ciò che è oggetto
della sua preoccupazione”.
E' chiaro che questo Dio non è onnipotente e che pertanto è necessario rinunciare alla tradizione
dell'assoluta, illimitata onnipotenza divina.
3) Obiezione logica al concetto di onnipotenza
Sotto il profilo logico il concetto di onnipotenza appare in tutta evidenza 'critico': la semplice
nozione di potenza rende contraddittorio, anzi privo di senso il concetto di onnipotenza. Come la
libertà è possibile e ha senso solo in rapporto alla limitazione, così è realmente possibile e ha senso
la potenza solo se contrastata, limitata, contenuta. Una potenza assoluta, non limitata da nulla, non
ha 'oggetto' su cui agire, è potenza che non ha potenza dal momento che non può esercitarla
concretamente; è potenza 'astratta', potenza che nega se stessa. Come la libertà, la potenza ha
bisogno di qualcosa che la contrasti, la limiti, le resista, ovvero la faccia essere potenza determinata
e concreta. Libertà e potenza sono concetti di relazione, e la relazione implica 'limite'.
Da ciò deriva che il concetto di creazione implica quello di reale autolimitazione di Dio. Dio è
limitato realmente perché reale è la creatura, ovvero l'alterità.
4) Obiezione teologica al concetto di onnipotenza
L'onnipotenza è conciliabile con la bontà di Dio solo al prezzo di una totale incomprensibilità di
Dio stesso. Onnipotenza, bontà e comprensibilità non possono sussistere insieme: la relazione fra
due di esse esclude la terza. Di fronte all'evidenza del male, l'onnipotenza è astrattamente
compatibile (ma non nella tradizione ebraica!) solo con la comprensione (il male sarebbe spiegato
in quanto Dio stesso lo 'compie'); non è ovviamente compatibile con la bontà. Quest'ultima, d'altra
parte, non è per Jonas rinunciabile: ne andrebbe evidentemente del concetto stesso del Dio biblico.
Altrettanto irrinunciabile è, per Jonas, la 'comprensibilità del Dio di una tradizione che si fonda
sulla rivelazione stessa di Dio: il 'Deus absconditus' è infatti estraneo all'ebraismo. Anche quando
Dio tace o si cela, egli è presente, anzi è presente in maniera più pregnante proprio quando tace e
volta le spalle. Ora Dio sarebbe del tutto incomprensibile se alla bontà (irrinunciabile) venisse
attribuita anche l'onnipotenza: come si potrebbe spiegare Auschwitz? Tenendo ferme come
irrinunciabili la bontà e la comprensibilità di Dio, non resta che riconoscere che Dio non è
onnipotente. Ad Auschwitz Dio non intervenne non perché non volle, ma perché non poté
intervenire.
Poiché per l'ebraismo Dio non può essere origine del male, e poiché nell'ebraismo non vi è traccia
di un dualismo manicheo (Dio è Uno), non si può concludere altrimenti che affermando che il male
viene dal cuore dell'uomo. Creando l'universo e volendo libero l'uomo, Dio si è limitato e
ritraendosi ha reso possibile fuori di sé il male.
Jonas conclude richiamando l'analogia della propria posizione con la dottrina dello Tzimtzùm di cui
abbiamo detto, e rammentando che, comunque, il nostro dire intorno a questi problemi è un
'balbettio', così come lo è ogni tentativo di risposta alla domanda di Giobbe, come lo sono “anche
le incomparabili parole dei grandi vati e uomini di fede, dei profeti e dei salmisti”.