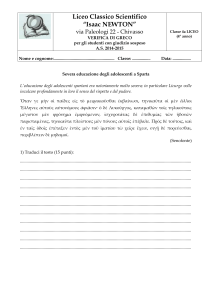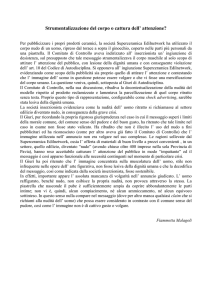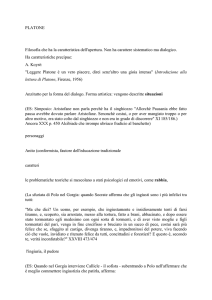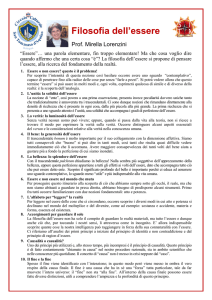RICERCHE
/
FILOSOFIA
I lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:
Carocci editore
via Sardegna ,
Roma,
telefono ⁄ ,
fax ⁄
Visitateci sul nostro sito Internet:
http://www.carocci.it
Il pudore
tra verità e pratica
A cura di Maria Letizia Perri
Carocci editore
Il volume è stato pubblicato con il contributo finanziario R.S. ex %
(Polisemia dell’agire. Determinatezza delle attività
e indeterminatezza dell’orizzonte umano), condotta dalla curatrice
a edizione, luglio
© copyright by
Carocci editore S.p.A., Roma
Realizzazione editoriale: Omnibook, Bari
Finito di stampare nel luglio
dalla Litografia Varo (Pisa)
ISBN
---
Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. della legge aprile , n. )
Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico.
Indice
.
.
.
.
.
Presentazione
di Giovanni Ferretti
Una introduzione tra verità e pratica
di Maria Letizia Perri
Per un significato etico e antropologico del pudore
di Franco Biasutti
Introduzione
Pudore e giustizia
Il pudore come “passione”
Il pudore come “scissione”
Appunti per una conclusione
Le forme della sincerità e il pudore
di Andrea Tagliapietra
Tra residui di pudore e germogli di verità pratiche
di giornalismo nell’era del blog...
di Giorgio Boatti
INDICE
.
.
.
.
.
.
La pratica femminile tra visibile e invisibile
di Diana Sartori
Il pubblico e il privato
L’indicibile della pratica
Tra visibile e invisibile
Il mare senza pudore. A proposito di un epigramma funerario del VII secolo a.C.
di Marcello La Matina
Il pudore tra orgoglio e umiltà. Il contributo di
Agostino
di Donatella Pagliacci
Introduzione
Genesi e caduta
La sede del pudore
Teoria e pratica del gesto come pudore
di Eleonora Bairati
Abitare una distanza prossima: una prospettiva
sul pudore
di Carla Danani
.
.
.
Il pudore come sentimento dell’intero
di Francesco Totaro
Il pudore in sé e la prospettiva dell’intero
Il pudore nella relazione con l’altro
La dialettica del pudore tra negazione e affermazione
INDICE
.
.
Il pudore senza riscatto
Contro l’evanescenza del pudore e l’appiattimento sull’apparire
Indice dei nomi
Presentazione
di Giovanni Ferretti
Il pudore – come ha osservato pertinentemente Max Scheler –
è un sentimento che fa parte del “chiaroscuro” della natura
umana, che è ad un tempo corpo ma non soltanto corpo, visibile ma anche invisibile, intimità privata e purtuttavia ineliminabile esposizione allo sguardo pubblico, individualità irrepetibile ma anche intreccio di relazioni con altri. Di questa complessità il pudore è ad un tempo testimonianza e messa in atto,
manifestazione della verità della persona e provocazione a pratiche che ne custodiscono o ne calpestano la dignità.
La Giornata di studio Il pudore tra verità e pratica, tenutasi
all’Università di Macerata il giorno maggio , di cui qui
presentiamo gli Atti, ha voluto affrontare questo tema da un
particolare angolo di visuale: quello appunto indicato dalla seconda parte del titolo: “tra verità e pratiche”. Come bene spiega nel saggio introduttivo Maria Letizia Perri, che ha organizzato la giornata di studio e cura questi Atti, si tratta non tanto
di un punto di vista filosofico precostituito o dato per scontato,
e tanto meno di quello del soggetto trascendentale moderno,
autocentrato sulla propria volontà di potenza e monologico;
bensì di un punto di vista che si va cercando attraverso indagini come questa, nella direzione di una concezione della filosofia che non solo sappia coniugare la verità con la pratica di essa, ma anche e soprattutto venga messa in atto nella comunicazione dialogica effettiva, ad un tempo libera e liberante. La messa a tema del pudore non vuole quindi essere un ulteriore esempio di “microconcettualità”, tanto cara alla filosofia “debole”
GIOVANNI FERRETTI
postmoderna, rassegnata alla cura di soli frammenti di senso,
quanto il confronto e il ripensamento di una tradizione antropologica e di una pratica di vita certamente da cambiare, ed in
parte anche ampiamente mutata, e tuttavia ancora portatrice di
valori da riscoprire, proprio per resistere all’invadente “impudicizia” del moderno.
Nella direzione di una rivisitazione della tradizione antropologica implicata nel concetto di pudore, si troverà in questi
Atti anzitutto il puntuale saggio di Franco Biasutti, Per un significato etico e antropologico del pudore, che ci offre alcuni pertinenti affondi sul significato del pudore in Platone, Aristotele
ed Hegel, ricavandone suggestive indicazioni di carattere antropologico ancora oggi di attualità. Nel saggio di Donatella Pagliacci, Il pudore tra orgoglio e umiltà. Il contributo di Agostino,
viene invece in primo piano quell’ambivalenza del pudore, tra
conseguenza del peccato e virtù, che tanto influenzerà tutta la
tradizione occidentale cristiana. Alcuni interessanti esempi della rappresentazione della “pudicizia” nella tradizione artistica
medioevale e rinascimentale si trovano inoltre lumeggiati nel
contributo di Eleonora Bairati, Teoria e pratica del gesto come
pudore, mentre alla rivisitazione della storia della “spudoratezza”, mascherata come imperativo della “sincerità” in ordine al
dominio delle coscienze, è dedicato il provocante saggio di Andrea Tagliapietra intitolato Le forme della sincerità e il pudore,
che individua nella pratica religiosa della “confessione” un prodromo di quel costume moderno in cui la “sincerità” è diventata una costrizione sociale. Una vivace testimonianza dell’“impudicizia” del moderno, ovvero della “morte del pudore” nell’attuale cultura dei media, si può leggere infine con gusto nel
contributo del giornalista Giorgio Boatti, Tra residui di pudore
e germogli di verità pratiche di giornalismo nell’era del blog...
Per quanto riguarda la parte più propriamente teoretica degli Atti, il saggio di Diana Sartori La pratica femminile tra visibile e invisibile si pone particolarmente all’attenzione. Esso offre, infatti, un ricco e illuminante quadro del dibattito odierno
sulla valenza teoretica e pratica del pudore, soprattutto nel
PRESENTAZIONE
l’ambito del movimento femminista. Al di là degli estemporanei
elogi del pudore propri di un certo “pensiero debole”, il saggio
per un verso dà per acquisita conquista il rifiuto del pudore come virtù imposta alle donne, in funzione di una loro ghettizzazione nel privato; ma per altro verso rivaluta il pudore quale positiva resistenza alla completa visibilità mercantile dell’intimità
femminile. Non tutto, nella donna, è bene che sia portato sempre alla luce, poiché è proprio sul confine tra il visibile e l’invisibile, un confine storicamente e culturalmente variabile e purtuttavia essenziale, che si gioca ancor oggi la libertà femminile;
e forse – aggiungiamo noi – si gioca la libertà stessa della persona e la salvaguardia dei sentimenti più profondi che la costituiscono. Osservava Scheler: «il pudore è uno degli ausiliari
(Gehilfin) più profondi e naturali dell’amore, quasi fosse l’involucro della crisalide, dove questa può lentamente maturare».
Il bel saggio di Carla Danani, Abitare una distanza prossima:
una prospettiva sul pudore propone un’impegnata rilettura teoretica del pudore sullo sfondo della concezione gadameriana
dell’ermeneutica; più precisamente, in riferimento alla dialettica di familiarità e di estraneità che caratterizza la pratica ermeneutica; ove il pudore viene ripensato quale custode di quella
“distanza ermeneutica” che sempre va mantenuta, anche nella
più riuscita relazione, per salvaguardare sia l’alterità altrui sia la
propria; alterità entrambe essenziali perché vi sia effettiva relazione tra i diversi. Chiude il volume il denso saggio di Franco
Totaro, Il pudore come sentimento dell’intero, dove il pudore,
portato a chiarezza concettuale, rivela la propria consistenza
ontologica di apertura all’intero e la dignità antropologica di
sentimento dell’intero.
Ci auguriamo che questa sia pur breve presentazione possa
invogliare alla lettura dei diversi contributi qui pubblicati, suscitando un dibattito teoretico e innescando delle pratiche in
grado di farci avanzare nella costruzione di una comunicazione
rispettosa della diversità di genere e al tempo stesso capace di
sviluppare relazioni interpersonali profonde, arricchenti e pienamente liberanti.
Una introduzione tra verità e pratica
di Maria Letizia Perri
Non è sempre necessario che il vero prenda corpo;
è già sufficiente che aleggi nei dintorni come spirito e provochi una sorta di accordo come quando il
suono delle campane si distende amico nell’atmosfera apportatore di pace.
J. W. Goethe
Tra verità e pratica: nesso concettuale, percorso oppure luogo,
una sorta di terra di mezzo della filosofia, dove andare a cercare, tra altre presenze, il posto del pudore?
Non si può stabilire così su due piedi; perché ognuna di
queste parole della filosofia, poste nell’intreccio linguistico
che dà il titolo a questa raccolta di saggi – Il pudore tra verità
e pratica – rimanda ad una questione corrispondente, che sottintende e cui allude: sono questioni che riguardano la filosofia ma che toccano, al tempo stesso, il nostro quotidiano e le
sue pratiche.
Perciò, meglio assumere per il momento la formula tra verità e pratica come una generica segnalazione, un cartello stradale messo in gioco come cifra spaziale; un’indicazione ancora
generalissima, dunque, per accompagnare lo sguardo verso uno
spazio indeterminato e non ancora identificabile.
Eppure, determinata e concreta è la fiducia che si prova nel
consegnare a questo ritaglio di spazio tra verità e pratica, la parola pudore; proviamo fiducia che accada di fare un’esperienza
filosofica nuova e vivificante di concetti, significati e parole che,
con ogni evidenza, costituiscono il lessico di base del filosofare;
sorto nell’“officina” della filosofia, luogo di una pratica e di uno
stile di vita comuni e messo a punto, più tardi, nel “laboratorio”
epistemologico, dall’età moderna in avanti.
Come ci si fa osservare, se la filosofia, dopo la grande tradizione dei sistemi, non ha più parole ma sembra alimentarsi di
citazioni e di commenti, di tante tessere di un mosaico autorevole da ricostruire, se, in una parola, «siamo diventati tutti ales
MARIA LETIZIA PERRI
sandrini», come dice Salvatore Natoli, quel che occorre è probabilmente tornare alle grandi parole della filosofia, quelle che
sopravvivono in quanto sono “sapienti” di per sé .
Accettiamo pure di offrire asilo politico ai superstiti; però,
cerchiamo di cogliere il problema anche da un’altra angolatura altrettanto essenziale; di questa stessa sapienzialità, intimamente custodita e difesa nel tempo dalle parole della filosofia,
per altro verso, siamo noi, a nostra volta, i superstiti: come uomini e donne, impegnati in storie di vita difficili e imbrigliati
nei quesiti di un tempo radicalmente nuovo; e come amici della sofia, ovvero gente cui sta a cuore la filo-sofia, della cui pratica vorremmo ancora poter fare esperienza: con e nonostante
le parole della filosofia.
In altri termini, il problema è più complesso di quanto possa apparire se alle parole della filosofia si guarda come ai serbatoi di memoria storica, ai segni di una veneranda tradizione da
non dimenticare; la questione è più complessa, poiché, a quanto pare, si tratta di gestire una difficile convivenza tra sopravvissuti – le parole antiche della filosofia, da una parte, e le nostre parole – tra esiliati, bisognosi di abitare di nuovo la filosofia se non anche di provvedere a costruire le condizioni per nuove forme di abitabilità della casa comune.
È un fatto inoltre che, in un modo o nell’altro si cerchi di
districare il problema, le parole della filosofia pesano: perché
pesa la loro storia ultramillenaria, quale originario imprinting
della grandezza umana da cui provengono, che dona loro consistenza sapienziale; poi, perché le parole pesano in quanto tali: le parole hanno e fanno peso, sono segni che articolano voci, sono corpo, fatto e cosa, come mostrano alcune lingue antiche, ad esempio, l’ebraico davàr, che significa appunto sia
parola che cosa, così denotando le radici costruttive del parlare umano e, al contempo, il nominare come attività creatrice;
sono incisioni le parole, iscrizioni di mondi, di tempi e spazi,
di territori e contesti vitali, e di storie personali; se è così, le
parole con-portano – portano con sé – immagini, modelli e criteri che raffigurano molteplici e differenti pratiche esperien
UNA INTRODUZIONE TRA VERITÀ E PRATICA
ziali della realtà; per questo esse, le parole, non possono essere soltanto serbatoi di sapienza ma, anche e di più, sono tracce e solchi profondi di quel qualcosa che Aristotele indicò come tíw praktik|, e cui conferì idea e spazio filosofici – non
senza ulteriori sovraccarichi problematici – tramite il concetto di frónhsiw: virtù emblematica e tra le più complesse fra
quelle che, secondo lo Stagirita, abitano l’anima razionale
umana.
Pesano inoltre le parole della filosofia, sul piano specificamente disciplinare, perché ci vengono incontro – nonostante
esteriormente possano apparire superstiti e reduci – come dei
pieni concettuali; sovrabbondanti di significati divenuti incontestabilmente evidenti o, per dir così, corde di cui non è più dato recuperare la cima , le parole in quanto forme concettuali ci
legano a doppio filo a linguaggi che non fanno più presa su scenari storici radicalmente mutati e, come corde, ci ancorano a
terre non più abitabili.
In altri termini, le parole della filosofia sono risorse e condizioni di possibilità sì ma anche condizionamenti; perciò,
piuttosto che contribuirvi, esse pesano sul nostro poter fare filosofia: specialmente se, come accade oggi, intende presentarsi come una pratica esperienziale, la filosofia non può prescindere dalla connessione con il tempo presente e dalla lettura dei
suoi fenomeni storici.
“Come fare”, allora, perché la forza vincolante di queste parole, che ci pesano e ci legano, si converta in un’offerta di nuove possibilità? per far sì, cioè, che il laccio possa trasformarsi in
link, in collegamento e connessione, come accade nella pratica
virtuale, che perfino la filosofia accademica oggi scopre e interpreta come efficace e costruttiva forma di incremento per l’esperienza della realtà?
Da dove cominciare, in altre parole, perché ciò che pesa sulla nostra capacità di fare esperienza filosofica sia anche ciò che
le dà peso per raggiungere spessori esperienziali di qualità?
Come si può notare dal contenuto di questi interrogativi,
al tema del pudore che si è messo in gioco non s’intende affi
MARIA LETIZIA PERRI
dare alcun compito di servizio, né contenutistico né metodologico; il pudore non fa qui la sua comparsa come figura
esemplare o immagine riflessa di una filosofia indebolita ; la
nostra direzione di marcia è senz’altro differente, nella misura in cui il pudore non rappresenta né surroga, né attenua la
tinteggiatura filosofica della presente riflessione: in una parola, nessuna maieutica del pudore per far accadere il filosofare nuovo, forte o debole che sia.
Il pudore, piuttosto, e con esso le parole verità e pratica, con
cui spartisce qui un’esperienza filosofica in comune, giunge e
compare, come si diceva, come un pieno di concetto; un contenitore di significati di tradizione, dunque, che accede come una
di quelle parole filosofiche che pesano ma che, entrando nel gioco interattivo con le altre due – verità e pratica – e con i loro significati, potrà forse cambiare pelle; senza denudarsi (impudicamente) e lasciarsi svuotare o decostruire, bensì accettando di
comunicare e di farsi attraversare da significati altri, prestandosi cioè al taglio della differenza; al fine, lo si è già detto, che il
peso di antiche e sedimentate fatiche del concetto si convertano in nuove possibili risorse di senso.
È una tecnica sperimentale quel che si prospetta? l’ennesimo escamotage di una microfilosofia post-postmoderna? oppure è un alibi per non prendere il toro per le corna, giocando con le parole ovvero e-ludendo problemi – ben più seri –
del nostro tempo?
Direi di no; soprattutto direi che non si tratta di applicare
una tecnica ma di far accadere un’esperienza pratica; non a caso ho scelto di delineare il tema in termini di effettiva esperienza filosofica; sono più che convinta, infatti, che la sensazione
palpabile circa il fatto che la filosofia oggi tenda a richiudersi
dentro nuove e inedite forme di dogmatismo, sia molto di più
che un’impressione; e ancor più sono convinta che, se il discorso filosofico intende riprendersi il ruolo riflessivo e critico
di cui come mai oggi le società hanno bisogno, uscendo dalle
varie mode “alessandrine”, gli sia conveniente sfilare dalla fitta trama del suo passato, remoto e prossimo, quella cima che
UNA INTRODUZIONE TRA VERITÀ E PRATICA
lo conduce alla tradizione antica dell’esperienza filosofica, alla
filosofia intesa e vissuta come pratica di vita ; senza sentimenti di nostalgia di grembo materno e di passati gloriosi ma solo
come un’immersione benefica in acqua sorgiva.
Dunque, se pure occorre ripensare le parole della filosofia,
lo si deve fare con coerenza e guardando oltre: non citandole
come icone e simulacri di arcaica sacralità né come vetrine metropolitane, d’accordo, ma neppure come segnali di rassegnato
tramonto e di assenza di nuova germinazione.
Per questo ritengo che occorra proseguire anche oltre il pur
conveniente ripensamento: in sintesi, è opportuno progettare
come fare esperienza con, delle e sulle parole della filosofia.
In che cosa consiste, allora, questo tipo di esperienza?
Come è facile dedurre da quanto osservato, sostanzialmente si tratta di inserire nell’intercapedine tra verità e pratica un
contenuto – il pudore – il cui significato viene da lontano e che,
sia come parola in quanto tale sia come parola della filosofia, fa
la sua comparizione come padrona della propria evidenza semantica e concettuale: nello spazio situazionale tra verità e pratica, in un primo momento, si ha l’impressione di avere di fronte un significato collaudato, solido e consistente, che rende il
termine pudore una parola, per dir così, “esatta”.
Si tratta quindi di es-porre tale contenuto al movimento spaziale circoscritto dal “tra”, vale a dire osservare gli effetti dinamici dell’attraversamento, marcato dalle parole verità, da un lato, e pratica, dall’altro.
La solidità semantica e concettuale che la parola pudore
“padroneggiava” tende a fluidificarsi; la rigidità del pieno diventa flessibile assumendo sfumature, tonalità e modulazioni
inedite – come accade alle note musicali se le si accosta l’una
all’altra nella concertazione del pentagramma – le quali conferiscono alla parola, senza farle subire perdite, un assetto semantico differente.
Si dirà che è in gioco qui un’esperienza che assomiglia assai
di più ad un esperimento di chimica piuttosto che alle pratiche
linguistiche e filologiche che, di consueto, accompagnano la
MARIA LETIZIA PERRI
metodologia della conoscenza filosofica; ma tant’è, non è poi
detto che la filosofia e le sue esperienze perdano in identità e in
dignità se la pratica filosofica scambia e spartisce i suoi sentieri
con operazioni che, “professionalmente”, non appartengono al
proprio metodo di indagine e di ricerca.
Perché proprio il pudore all’avvio di questa singolare esperienza?
Escludendo motivazioni di carattere storico-epocale, come si diceva, primo ospite è il pudore per almeno due motivi:
l’uno riguarda la connotazione antropologica ed esistenziale
che, tradizionalmente, la parola pudore evoca, contiene e trasmette; questa evidenza antropologica che immediatamente
connota il senso del pudore dice, ancor prima che lo si indaghi come segno linguistico e come concetto logico, che “ne va”
delle esistenze, dei viventi tutti, che il pudore, insomma, ci riguarda; come è chiaro, è già un motivo importante per interessarci del pudore e per farne il battistrada del percorso di
problematizzazione – fulcro dell’esperienza proposta – che interesserà, in momenti successivi, altre parole e contenuti di carattere antropologico.
L’altro motivo è contestuale all’istanza di fondo da cui nasce l’esperienza filosofica cui si sta accennando. Infatti il senso del pudore sembra essersi cristallizzato in un significato di
tutta evidenza: chi dubiterebbe, anche extra moenia philosophiae, del fatto che il pudore è sentimento soggettivo e che
l’emotività e le altre manifestazioni fisiche e corporee che
l’accompagnano ne rivelano la presenza in interiore homine?
Chi non chiamerebbe in causa, perciò, i saperi dell’umano,
come la psicologia, la biologia, la medicina (sintomatologia di
rossore, accelerazione del battito cardiaco, sudore) appellandosi, infine, alla morale del pudore quale suprema virtù personale?
Insomma, che il pudore sia un sentimento o una virtù – o
l’uno e l’altro – interni alla coscienza singola e che lo si debba
pensare come requisito individuale di una più ampia gestione
autonoma del proprio sé, è senso comune ovvero immagine
UNA INTRODUZIONE TRA VERITÀ E PRATICA
consolidata e tradotta in significati di assoluta evidenza, a prescindere dal suo manifestarsi in atti e fenomeni concreti.
E probabilmente, mi si passi la supponenza, un’analoga raccolta di dati esperienziali e culturali di questo tipo sarebbe
quanto basta, come incipit, per l’approccio alla questione da
parte di una filosofia teorica.
Ma è poi questo il significato del pudore, che il pudore abiti l’intimo foro interiore del soggetto individuale? che non sia,
invece, da concepire come una pratica sociale, indipendente
dalla coscienza – in senso psicologico e in senso morale – o che
non sia, ad esempio, un connotato estetico, un dispositivo politico e una norma giuridica e altro ancora, fuori dalla coscienza
soggettiva e dalle sue voci?
Sono di questo tipo le domande che interessano l’approccio
pratico della filosofia o, meglio, sono queste le questioni che toccano la filosofia e la contattano, favorendo l’apertura di quelle
potenzialità che originariamente possiede quale esperienza pratica di cura della vita.
In tal senso, ci aspettiamo con fiducia che sia la tensione comunicativa, iscritta nel percorso tra verità e pratica, a fornirci
orientamenti soddisfacenti.
C’è un motivo ulteriore, infatti, che è opportuno esplicitare
nonostante in buona misura si colleghi al precedente, che consiste nella seguente annotazione: se, da un lato, è tangibile la
permanenza, nel lessico filosofico e non, del pudore come immagine ideale, come concetto e come parola, tant’è che se ne sono appena indicate evidenza ed ovvietà concettuali, dall’altro, è
altrettanto tangibile l’assenza del pudore come fenomeno empirico dallo scenario storico.
Allo scenario di senso del pudore, in altre parole, non sembra più corrispondere uno scenario storico, nel quale il pudore
accada come evento.
È questo un contrasto che, specie nella prospettiva che mi
preme mettere a punto, si mostra piuttosto rilevante; tale scarto fa sì che lo spazio tra verità e pratica, dove il pudore si apre al
movimento della problematizzazione, venga a dischiudersi non
MARIA LETIZIA PERRI
solo a partire e grazie alla domanda che chiede “che cosa è pudore?” ma da un’interrogazione più complessa, che intreccia alla prima richiesta, la quale punta a determinarne il significato,
l’altra domanda, quella che chiede: “che ne è del pudore?”.
Si chiede ragione, dunque, da un lato, di una corrispondenza logica finalizzata ad acquisire il significato del pudore, dall’altro e nello stesso tempo, di un’incompatibilità sul piano storico temporale; si chiede ragione, allora, di una sottrazione di
significato antropologico, che ci tocca e ci riguarda nella misura in cui, come si diceva, ciò che caratterizza immediatamente
la parola in questione e ne fa un significato evidente è, per l’appunto, la sua determinazione antropologica; in questa prospettiva, ciò che si chiede, in ultima analisi, è poter assumere consapevolezza del pudore come presenza e, insieme, responsabilità per il pudore come e in quanto assenza.
L’interrogativo si rivela complesso poiché porta allo scoperto anche altro: che l’assenza storica e oggettiva del pudore, fatto empiricamente accertabile, non va necessariamente intesa
come perdita e sottrazione – cioè in negativo. Il gioco di presenza e assenza mostra, in modo pregnante ritengo, che l’assenza è evento positivo se la si coglie come evento, come l’accadere di un’esperienza: ovvero dell’esperienza dell’assenza di pudore e di atti e pratiche di pudore. Che il pudore manchi di presenza, se è così, può diventare un segnale o una cifra che immette nel percorso un ulteriore fattore di problematicità, la cui
forza non fa che incrementare lo spazio tra verità e pratica: si
tratta di quella forza problematizzante che le esperienze critiche
traggono direttamente dal rapporto con ciò che incontrano de
visu nel mondo; questa pressione buca, per dir così, l’assetto linguistico e semantico della parola pudore, provocando la frattura nel rapporto tra il permanere del senso del pudore e la crisi
di validità, sul piano oggettivo, delle pratiche e delle attitudinali del pudore.
Non è qui il caso di dilungarsi, ma non è difficile capire che,
in tale prospettiva, l’evidenza concettuale del pudore si frantuma in una pluralità di tratti problematici, che ne trasformano i
UNA INTRODUZIONE TRA VERITÀ E PRATICA
connotati conservativi; questi tratti critici segnano in profondità, ben oltre gli interessi della filosofia, i criteri delle pratiche
interpretative, tramite le quali, come uomini e donne, impariamo ad inserirci in una tradizione culturale, la manteniamo in vita, la sviluppiamo, la trasformiamo.
Sul fronte disciplinare della filosofia, se gli ultimi cenni sono sufficientemente chiarificanti, va da sé che il tema del pudore, ospite del modello di esperienza qui proposto, può diventare un dispositivo di apertura per accedere o per riprendere questioni di fondo – come appunto la complessità del nesso tra senso e validità, tra linguaggio e mondo, tra le pretese delle immagini linguistiche del mondo e le aspirazioni delle pratiche sociali
ad autointerpretarsi come processi di costruzione e di riformulazione di mondi vissuti.
Del resto, sono nodi e problemi che la filosofia non può ritenere risolti.
Riassumendo, quel che sembra emergere è il fatto che l’interna “sapienzialità” che abita la parola filosofica pudore, si
presta ad essere attraversata da numerose e differenti tensioni
critico-riflessive e, così, ad accogliere in misura più cospicua il
movimento della sua problematizzazione.
Anziché come esempio di microconcettualità, pertanto, il
concetto di pudore si rivela un avvio esemplare per inaugurare questa nuova esperienza, la quale si attua nello spazio tra verità e pratica.
A tal proposito può essere opportuno richiamare l’attenzione del lettore con un brevissimo corollario.
Paradossalmente, questa esperienza può apparire tutt’altro
che pudica; poiché è ormai inteso che l’attuarla esige qualcosa
di più concreto ed efficace che ripensare il pudore, tra le altre
parole della filosofia; essa persegue, inoltre, finalità per le quali non basta confidare in un utopico rilancio al futuro delle parole della filosofia.
Nelle Leggi Platone afferma: «C’è che le cose umane non sono degne di per sé di grande preoccupazione (spoud|w), d’altra parte, è necessario occuparsene seriamente (spoudázein)» .
MARIA LETIZIA PERRI
Per occuparsi seriamente delle pratiche umane, allora, non
solo preoccupati in teoria, occorre porsi nell’al di qua sia dell’ideologia che dell’utopia – sempre inseparabili del resto –
delle parole filosofiche – e cercare forme più forti e s-pregiudicate di coinvolgimento; a mio parere, dopo le estenuanti avventure della tradizione del vedere-rappresentare come volontà di potenza e come dominio sull’intera realtà, prima, e
poi, di contro, dopo i rimedi postmoderni dell’ascolto come
potere della passività, occorrerebbe ripristinare una sensibilità diversa, che si avvalga dei sensori del corpo: un corpo in
salute, di cui imparare dagli antichi le forme di cura, capace di
avvicinare con tatto, vista, udito – risorse non accantonabili
dell’originario meditare – ciò che si cerca e intorno a cui si indaga, al fine di vivere un’esperienza filosofica effettiva.
In questa prospettiva, per ritornare alle questioni di metodo, andrebbero incontrate le parole verità e pratica, che insieme
alla parola pudore sono state messe in gioco; cioè innanzitutto
visivamente, come il titolo del percorso raffigura; verità e pratica compaiono a vista come punti di demarcazione di uno spazio, come i confini estremi di un percorso di attraversamento o,
ancora, come poli tensionali di un passaggio.
Poiché la visibilità, tuttavia, non è sufficiente a giustificare
la chiamata in causa di parole tra le più pesanti della filosofia e
della sua tradizione, occorre trovare quei motivi che ne legittimino l’assunzione, almeno in apparenza, spregiudicata – di
nuovo, impudica – che se ne sta facendo.
In che senso, dunque, verità e pratica?
Di ciascuno dei due concetti non si finirebbe mai di tracciare la storia, la genealogia arcaica, i punti di trasformazione,
la semantica, la sintassi e l’uso pragmatico.
Ma non è questo, come si è già inteso, che interessa l’esperienza filosofica che si sta avviando; infatti, se pure verità e pratica si rendono visibili come confini perimetrali che delimitano
e tracciano lo spazio della problematizzazione del pudore, non
vuol dire che li si debba intendere come una sorta di vigilantes,
come custodi autorevoli di un patrimonio concettuale, storico
UNA INTRODUZIONE TRA VERITÀ E PRATICA
ed ermeneutico, da cui ci si attendano garanzie teoretiche e metodologiche a sostegno dell’esplorazione del pudore.
Il progetto che mi sta a cuore evita, per quel che può, incoerenza e corto circuito; ambiziosamente ricerca, invece, e
persegue congruenza di metodo e di contenuto.
Si può affermare allora che verità e pratica stanno semplicemente; come segni che marcano i bordi della parola pudore, che
è il problema e che fa problema; non evocati come requisiti fondativi e criteri di marcia collaudati nel tempo ma assunti nella
presa d’atto che essi costituiscono per noi altrettante evidenze
linguistiche, verità e pratica partecipano de facto e de iure, simmetricamente prendendovi parte, al percorso problematizzante che l’esperienza propone e che intende realizzare a partire,
per l’appunto, dal tema del pudore.
Viene a configurarsi, in tal modo, un modello di pratica filosofica che si svolge come un movimento ad andamento oscillante, alla cui dinamica e solo ad essa è affidato il compito di
disegnare il tracciato; non esiste, perciò, alcun percorso precostituito, metodologicamente anticipato o ermeneuticamente presupposto.
In questo imprevedibile “in cui”, che è lo spazio tra verità
e pratica, i punti, le linee e le curvature del percorso vengono
disegnate dallo scambio interconcettuale che accade tra le parole e ad opera delle stesse, nella dinamica del gioco combinato tra i significati.
Ma il modello proposto – occorre esplicitarlo – si presenta,
intenzionalmente, anche quale esperimento applicativo di quell’orizzonte teorico – che merita di non rimanere tale – che conosciamo come paradigma linguistico-comunicativo .
Ora, quel modello pratico di interscambio comunicativo,
che detto paradigma propone e che collega a nuclei di senso
normativo, si vorrebbe qui estendere oltre i limiti delle situazioni di scambio linguistico intersoggettivo, le quali costituiscono la sua più diretta e ovvia applicazione: oltre le relazioni
tra individui e gruppi di individui, che quotidianamente s’impegnano in forme sociali di cooperazione e reciprocità, è pos
MARIA LETIZIA PERRI
sibile intravedere, a mio parere, la comparsa di altri possibili
partecipanti allo scambio interattivo.
Del resto, è lecito confidare nei potenziali e nei contributi
chiarificatori del suddetto paradigma in misura estesa, progettandone lo sfruttamento, teorico e pratico, anche in relazione
ad altre forme di scambio comunicativo; il fatto di verificarne
l’attitudine e l’efficacia, in altri termini, non solo nei casi di
scambio di atti linguistici – come nella comunicazione tra persone – ma anche nel caso di scambio tra i linguaggi, le componenti concettuali e le forme linguistiche, non credo che costituisca un’ipotesi irrazionale o che suoni come eresia filosofica;
anche perché, entrando nel merito del paradigma in questione, forse è necessario verificarne la solidità teoretica e le potenzialità pratiche, proprio estendendone l’applicazione a contesti comunicativi allargati; tanto più se la posta in gioco è la
costruzione di principi, criteri e regole per la gestione di processi rilevanti sul piano etico e politico in quanto finalizzati a
regolare le forme di condivisione sociale: infatti, il paradigma
comunicativo mette in gioco questioni di fondo come la cooperazione, le forme del riconoscimento reciproco, l’etica delle
relazioni economiche e di mercato, le quali interessano il difficile problema dell’interculturalismo, dell’accordo tra sfere
culturali diverse, tra valori morali e religiosi e tra stili e forme
di vita.
Non è da escludere, perciò, che anche i saperi, i linguaggi,
i concetti e le parole si prestino ad entrare come soggetti attivi
in situazioni comunicative e cooperative virtuali e che, per loro tramite, si possano incrementare gli obiettivi della chiarificazione critica della realtà: anzi, si può perfino ritenere che lungo un itinerario come quello che si sta ipotizzando, i punti di
approdo dei processi di chiarificazione che interessano non solo la filosofia ma le scienze umane e gli stessi modelli di sapere
scientifico, si rivelerebbero più concreti e, soprattutto, più
spendibili storicamente; più aderenti, inoltre, allo spirito originariamente filosofico che, per dirla con Husserl, abita l’identità europea; comunque più proficui, a mio parere, di quanto
UNA INTRODUZIONE TRA VERITÀ E PRATICA
non si siano rivelati alcuni esiti, a volte discutibili, del pensiero
contemporaneo; penso ad alcune strade battute dai filosofi
“analitici” così come alle avventure del decostruzionismo dei
“continentali”.
Mi rendo conto che si potrebbe contestare come arbitraria
l’attribuzione di soggettività a forme linguistiche, che il modello proposto implica; di norma, infatti, noi pensiamo le parole, i
concetti e i linguaggi piuttosto come dispositivi e strumenti metodologici, sebbene ne serbiamo un’idea, ermeneuticamente
pregnante, che li raffigura come forme viventi nello sfondo del
linguaggio, inteso come comunità linguistica di appartenenza;
inoltre forme e atti linguistici li pensiamo come prodotti storici, quali manufatti del lavoro della mente umana.
Difficilmente perciò concetti e parole si danno a pensare come soggetti: e, allora, in che senso li chiamiamo soggetti?
Credo che motivazioni vi siano e di diverso genere; cercherò
in questa sede di illustrare i motivi che ritengo principali e adeguati alla riflessione di metodo che si sta svolgendo.
Sorvolo, perché un discorso specifico in merito ci porterebbe davvero troppo lontano, sul tema che ha impegnato a lungo
gli indirizzi della critica della modernità e che verte sul tentativo di de-soggettivizzazione (o de-trascendentalizzazione) del fondamento moderno.
Basta osservare che lo sforzo di decentramento del soggetto
moderno, pensato dalle filosofie coscienzialiste postcartesiane
per lo più in forma antropomorfica e come dotato di autonomia
e di potere pressoché infinito nel conoscere e nell’agire, non
conduce, e in effetti non sempre ha condotto, necessariamente
alla soppressione della figura e/o della parola soggetto: un approdo, peraltro, non così fruttuoso come potrebbe apparire, se
non altro perché ogni congedo epocale costituisce – e non solo
in filosofia – una decurtazione di potenzialità.
L’opera di decentramento può condurre, invece, positivamente, ad una prosecuzione più assennata dell’uso filosofico
della parola soggetto, cioè ad assumerne un significato emancipato dalle ipoteche soggettivistiche moderne.
MARIA LETIZIA PERRI
Senza subire svuotamenti concettuali, in altre parole, ma
passando al vaglio di una riflessione critica capace di disarticolare dal nucleo concettuale del soggetto l’automatismo del
riferimento alla figura del fondamento antropocentrico, la
parola soggetto rimane filosoficamente disponibile; per così
dire, essa resta esposta, cioè aperta ad accogliere una più ampia significazione.
Di qui, un’ulteriore motivazione connessa alla precedente
sul filo di un collegamento che però occorre esplicitare.
Da siffatta critica, infatti, non si ottiene soltanto un guadagno linguistico e concettuale, che consiste, come si è detto, nel
poter svincolare la parola soggetto dalla necessità di riferirsi ad
un nome proprio; se si riflette a livello più radicale, si può comprendere come se ne possa trarre un sensibile cambiamento del
modo di concepire e di riferirsi al senso della realtà.
Va da sé, infatti, senza scomodare voci autorevoli dell’antica tradizione del pensiero filosofico, che la centralità del soggetto moderno ha oscurato quello che la filosofia intese – e dovrebbe intendersi ancor oggi – come realtà.
Si sa che per gli antichi l’equivalente di ciò che noi oggi pensiamo e definiamo con la parola senso per dire di tutta la realtà,
non era in vista oggettivamente; comunque sia, non poteva
coincidere con un predicato della realtà fornito dal soggetto; vale a dire che intendere e concepire il mondo circostante e la natura complessivamente ovvero come intero e per intero, per gli
antichi, non dipendeva né conseguiva dall’iniziativa – del soggetto – di conferire ad esso attributi e determinazioni: non era
insomma una questione di potere, foss’anche soltanto del potere di esprimere un giudizio, nella misura in cui il giudizio in
quanto tale, mette in crisi l’interezza della realtà; tale potere,
seppure pensato come infinitamente potente dai moderni, di
fatto, manca l’intero e coglie, di necessità, solo le parti.
Pensare il senso della realtà non è lo stesso, infatti, che affermare o negare che qualcosa della realtà è o non è sensato.
Il senso della realtà per gli antichi doveva essere un incombere che desta meraviglia, che stupisce e risveglia: una
UNA INTRODUZIONE TRA VERITÀ E PRATICA
“chiamata” o un appello a ricercare e a confrontarsi, nel dialogo, sui percorsi da intraprendere e sulle mete man mano
raggiunte, non senza il lume di una saggezza ancora più antica, tramandata in gesta eroiche.
Dunque, per gli antichi sapienti e per i filosofi doveva essere unità o, meglio, “interalità” ciò che dalla modernità in avanti si preferì intendere e nominare come senso della realtà: per
questo l’intero si dava come orizzonte di opacità e, ancora per
questo, era un che di incombente e di stupefacente.
Ora, ormai fuori dal soggetto – nel significato poc’anzi inteso – si danno a noi le condizioni per un reimpianto, nel nostro
filosofare, di potenziali di riferimento alla realtà come interalità;
a ciò che Jaspers, ad esempio, definisce Um-greif-ende, collegandosi appunto al principio-intero, pensato da Anassimandro
come ƒpeiron periéxon.
È anche vero però che non basta essere usciti dalla tela di
ragno del soggetto-fondamento: le condizioni si danno, infatti, se, finalmente, accettiamo che non tutto sia conoscibile e
che, del conoscibile, non tutto sia avvicinabile e concepibile
lungo un identico percorso di esplorazione; del resto, già prima dello scarto verità/metodo, suggestivamente individuato
da Gadamer, la lezione metodologica di Kant a cos’altro aspira se non a dimostrare che, per gli umani, ciò che non si può
conoscere non va perduto, sebbene alla domanda che chiede:
“che cosa è?” non tutto risponda o, se risponde, lo fa per enigmi che sviano i nostri processi mentali?
Ed è vero che non c’è perdita antropologica, anzi, forse ci
prepariamo a più ampie acquisizioni; per via della nostra natura razionale, ancora secondo Kant, per via del desiderio e della
tensione esistenziale verso un contatto profondo con il senso
originario, secondo Jaspers , siamo convinti, nonostante tutto,
del fatto che ciò che non si può conoscere, “è, tuttavia”.
Che l’intero o il senso della realtà “è, tuttavia” costituisce,
dunque, per gli umani un’apertura di orizzonti e di potenzialità ancora sconosciuti e impraticati, a mio parere, dalla filosofia; questa incisione – “che essa è, tuttavia” – nel tessuto di
MARIA LETIZIA PERRI
una realtà che nell’insieme resta sconosciuta, o, meglio, la scoperta che la parola senso altro non è che la cifra di ciò che come interalità resta ignoto, è un “quasi nulla”, per dire con
Jankélévitch ma, certamente, non è poco per la saggezza filosofica e per i suoi obiettivi: infatti, è offerta di un metodo genuinamente filosofico, poiché questa consapevolezza dirige
all’acquisizione di nuove forme relazionali, di nuove opportunità di esperienza teorica e pratica, di nuovi modi di essere
e di agire con quel “circostante” che non si lascia frammentare in determinazioni singolari né si incontra lungo i percorsi
della metodologia cognitivista e scientista.
Ecco il punto: nella realtà, colta come un orizzonte inclusivo
e circostante (Umgreifende) è possibile pensare insistano molte
componenti: i fenomeni naturali, certo, quelli storico-esistenziali e i significati culturali; e poiché, inoltre, pensare l’intero come
spazio comune e inclusivo non contravviene ad alcun divieto cognitivo, lo si può concepire abitato da molti e differenti generi di
soggetti; non solo da individui, persone, popoli di diversa provenienza e razza, ma anche da soggetti altri: come i beni, i valori, le norme morali e giuridiche, le istituzioni politiche, gli organismi sociali; e, ancora, i saperi, i linguaggi, i metodi e le metodologie tramite cui conosciamo, le regole e gli stili di vita in base ai quali condividiamo parole, pensieri ed esperienze.
In una battuta, nihil obstat all’abitare in molte guise la realtà.
Forse ha ragione Nancy: se la realtà nella sua interezza non
si dà a conoscere, tuttavia, sappiamo di poterla spartire (partager) come uno spazio comune o con-essere .
La partitura dei molti soggetti, tuttavia, non può mancare di
distinzione; la con-presenza e la comunanza, del resto, come
ogni forma di condivisione, includono la differenza e ne evocano il problema.
È una questione quest’ultima che necessita di maggiore approfondimento di quanto qui sia possibile rendere, ma è intuitivo che i soggetti, intesi come corpi individuali e come persone,
non prendono parte nello spazio comune come semplicemente
presenti, bensì come esistenti o, meglio, co-esistenti: e se esistere
UNA INTRODUZIONE TRA VERITÀ E PRATICA
è il modo di star-ci con capacità, talento e abilità di essere esposti, stare nella comune realtà come soggetti esistenti significa avere accesso ad una pluralità di forme di relazione e significa poter
agire altrimenti, cioè secondo una pluralità di pratiche differenziate, tramite le quali ci si espone al contatto con soggetti altri,
con le componenti non autonomamente attive della realtà, le
quali ci stanno ma, propriamente, non esistono.
Con le dovute differenze, si può allora affermare che, se la
realtà, complessivamente intesa, si lascia concepire come spaziatura interattiva e plurirelazionale, uno spazio cioè frequentato e spartito tra soggetti di diversa natura, genere e specie, è anche possibile ipotizzare che, oltre ai soggetti in carne e ossa, si
presentino altri partecipanti i quali, come soggetti differenti, sono chiamati a cooperare ad un ampio e articolato progetto di
praticabilità della realtà medesima.
La realtà, d’altra parte, non si incontra come un fatto (prodotto) o un insieme di fatti ma, essenzialmente, come dato: e come dato fenomenologicamente valido, questo volto della realtà
non ha bisogno di maquillage, di sedute di prova e controprova; nel senso che è per “chiamata”, per dire con Heidegger o per
apertura o, aggiungerei, per contatto, che l’esperienza della
realtà accade: senza bisogno che alcuna determinazione verbale ne certifichi l’oggettività.
Anche le parole, se è così, possono far parte come soggetti
altri della pratica cooperativa di mondo, la quale non si preoccupa ma, piuttosto, intende occuparsi in concreto di entrare in
relazione con una realtà, di per sé inconoscibile, contribuendo
a farne accadere l’esperienza in forme e modi plurali.
Dunque, anche “quasi niente”, come è l’ampliamento semantico provocato dall’esperienza di scambio interconcettuale, che
qui si propone, può dare origine, a mio avviso, a trasformazioni
sensibili che sono di sicuro incremento all’opera comune.
In conclusione: il gioco delle parole – che non è un gioco di
parole – verità, pudore, pratica non nasce a tavolino; non c’è progettazione metodologica né pesano ipoteche e preventivi sulle
indagini critiche e sulle pratiche che si dovranno svolgere.
MARIA LETIZIA PERRI
Sono semplicemente parole – e cose – dalle quali ciò che ci si
attende – questo l’unico presupposto – è che con ogni probabilità esse provocheranno effetti nello spazio dinamico che tracciano e in cui si incrociano reciprocamente insieme ai rispettivi
significati.
Per il momento, queste parole stanno qui in mezzo a noi come soggetti anch’esse, portando con sé, quale unica determinatezza, l’essere segni e incisioni effettivi di esperienze storiche, filosofiche e culturali in senso esteso; ed è questa la loro intima
sapienzialità certamente; negli involucri che la contengono però
ci sono cellule semantiche che si possono rinnovare, rendendosi nuovamente disponibili; perché ciò sia possibile, questa sapienza sedimentata, piuttosto che ripensata, dovrà lasciarsi attraversare e mischiarsi e, senza perdersi, aprirsi alla comunicazione con parole e significati altri, di ieri e di oggi.
Perché è vero che «dove ci sono le parole, lì si tocca terra...» .
Se dicessi, infine, che in questa raccolta di saggi e contributi
ciò di cui si tratta è definire che cosa è pudore, chiamando la logica del pudore alla presenza per diagnosticare le ragioni e i
sintomi di un’assenza, certamente mentirei; qui si tratta di pudore, di verità, di pratica intrecciati insieme, di condivisione,
perciò, di relazioni di coinvolgimento e di reciprocità, di nuove forme possibili di comunanza: tra parole, pensieri, cose e
persone, gente qualunque e filosofi: soggetti tutti, seppur distintamente, della grande intrapresa (opera) che è orientarsi
nel mondo e praticarne le infinite strade.
Si tratta, in definitiva, di occuparsi, come indica Platone – e
di prendersene cura – di quanto viene all’esperienza nello spazio comune, a partire da voci e sguardi differenti.
Note
. S. Natoli, Parole della filosofia, Feltrinelli, Milano , pp. -.
. La parola ebraica tikvà significa corda e anche speranza. La parola cima, che in latino (cyma) significa germoglio, deriva dal greco kyma, cioè feto
UNA INTRODUZIONE TRA VERITÀ E PRATICA
e dal verbo kyo, concepisco, sono incinta; il tutto discende dall’accadico kimu
che significa famiglia, stirpe.
. A. Dal Lago, P. A. Rovatti, Elogio del pudore. Per un pensiero debole,
Feltrinelli, Milano .
. Sull’argomento cfr. R. Madera, L. V. Tarca, La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche, Mondadori, Milano .
. Platone, Le leggi, VII, b.
. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, voll. I-II, trad. di P. Rinaudo, Il Mulino, Bologna .
. Per un approfondimento della prospettiva centrata sull’essere inteso
come interalità cfr. F. Totaro, Per una metafisica dell’inattuale, in F. Botturi, F.
Totaro, C. Vigna (a cura di), La persona e i nomi dell’essere. Scritti in onore di
Virgilio Melchiorre, vol. I, Vita e Pensiero, Milano , pp. -, ss.
. Cfr. K. Jaspers, Cifre della trascendenza, trad. di G. Penzo, Marietti,
Genova .
. V. Jankélévitch, Il non-so-che e il quasi niente, trad. di C. A. Bonadies,
Marietti, Genova .
. J. L. Nancy, Essere singolare plurale, trad. di D. Tarizzo, Einaudi, Torino .
. Natoli, Parole della filosofia, cit., p. .
Per un significato etico
e antropologico del pudore
di Franco Biasutti
Introduzione
È necessario premettere che la presente ricerca si muoverà all’interno di un preciso arco semantico, quello segnato dai termini a†dQw e pudor per quanto riguarda le lingue classiche e dai
termini che rispettivamente li traducono nelle lingue moderne:
pudore, pudeur, Scham, shame ; non si terrà viceversa conto di
tutti i termini derivati e dei sinonimi. Questa prima limitazione di carattere linguistico è destinata a circoscrivere di conseguenza anche lo spettro concettuale che verrà preso in considerazione.
Preso atto dei limiti appena fissati, è possibile rilevare un dato che può in qualche modo risultare degno di nota, ossia che i
lessici filosofici non sempre registrano la voce pudore: ciò accade sia nel caso di opere più antiche, quali ad esempio i lavori di
Goclenius e di Chauvin , come pure nel caso di testi più recenti, come ad esempio le opere di Mauthner o di Lalande oppure ancora di Abbagnano . Sembra quindi che molti dizionari filosofici, anche importanti, non si rivelino interessati al concetto di pudore: questo significa forse che tale concetto non è
particolarmente degno di nota, non suscita una sufficiente curiosità in campo filosofico? Un comportamento tutto diverso
sembra viceversa rilevabile sul versante teologico, dove all’opposto i lessici registrano in generale la voce: è questo il caso ad
esempio del Kittel così come di altre monumentali opere collettive come il Dictionnaire de spiritualité oppure Die Religion
FRANCO BIASUTTI
in Geschichte und Gegenwart , per giungere infine a pubblicazioni più recenti quali il Dizionario enciclopedico di filosofia, teologia e morale o il Nuovo dizionario di Teologia morale . Sulla
base di queste osservazioni ci si potrebbe considerare autorizzati a ritenere che il termine pudore copre un concetto certamente rilevante sul piano teologico, per giungere forse a concludere che si tratta di un concetto che appartiene prevalentemente alla teologia. Tutto ciò non può comportare comunque
la rinuncia a cercare un significato che emerga anche a partire
da una prospettiva filosofica.
Rimanendo nell’ambito sin qui esplorato forse l’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert potrebbe fornire un primo significativo esempio, se l’autore dell’articolo, che pur cita ampiamente Rousseau e si richiama alla tradizione del giusnaturalismo, non trattasse l’argomento da un’angolatura abbastanza limitata. Il pudore è definito come «vergogna naturale, saggia ed
onesta», come «timore segreto», «sentimento per le cose che
possono arrecare infamia»: in quanto tale non può essere considerato né una chimera né un pregiudizio popolare, ma qualcosa che la natura stessa ha diffuso presso tutti i popoli e tutte
le nazioni; da questo punto di vista ad ogni modo il pudore viene preso in considerazione soprattutto in quanto è la virtù peculiare del sesso femminile, proprio perché costituisce una delle più dolci armi che le donne possiedono per difendersi dagli
oltraggi e proteggere il proprio onore . Se quindi l’Encyclopédie sembra affrontare il tema da un punto di vista abbastanza limitato, diversamente si comporta l’Historisches Wörterbuch der
Philosophie, che si colloca su di una prospettiva molto ampia
storiograficamente, da cui risulta di conseguenza deducibile
anche una grande ricchezza di suggerimenti sul piano speculativo . In questa sede, ovviamente, non è possibile inseguire
l’Historisches Wörterbuch lungo tutta l’ampiezza dei punti di vista prospettati, ma è necessario limitare l’indagine, restringendola ad alcuni autori, segnatamente a Platone, ad Aristotele e a
Hegel, nella convinzione di offrire comunque per questa via un
quadro sufficientemente ricco e differenziato sul piano storico
PER UN SIGNIFICATO ETICO E ANTROPOLOGICO DEL PUDORE
e sufficientemente solido dal punto di vista teoretico. Va tenuto presente, da ultimo, che qui di seguito non verrà effettuata
un’analisi esaustiva del pensiero degli autori citati in merito al
tema proposto, ma che essi saranno utilizzati come punti di appoggio ermeneutici, al fine appunto di individuare una prospettiva autenticamente filosofica sul pudore.
Pudore e giustizia
Per quanto riguarda la filosofia platonica, essa offre almeno due
luoghi eminenti per analizzare il concetto di a†dQw, l’uno nel
Protagora, nell’ambito del mito di Prometeo, il mito della creazione dell’uomo, l’altro nelle Leggi, nell’ambito del mito di Crono, un altro dei miti delle origini.
Per quanto riguarda il Protagora, come è noto, si tratta del
racconto relativo alla creazione delle stirpi mortali (ynhtà génh)
da parte degli dei, che formarono tutte le diverse specie dei viventi mescolando terra e fuoco: il genere umano e tutti gli animali furono quindi creati insieme. A questo punto Prometeo e
suo fratello Epimeteo ricevono da Zeus l’incarico di distribuire
a ciascun genere degli esseri viventi mortali le facoltà naturali
(dunámeiw), affinché se ne potesse garantire la sopravvivenza;
Epimeteo allora insiste presso il fratello e da lui ottiene di essere il solo ad operare la distribuzione: Prometeo a questo punto
si allontana ed Epimeteo comincia la sua opera, assegnando le
facoltà in modo che si equilibrassero, così che ciascuna specie
animale avesse i mezzi sia per sfuggire alla distruzione reciproca, sia per poter sopravvivere nei confronti della natura .
A questo punto il mito si presenta come sviluppato secondo
due fasi. Innanzitutto accade che Epimeteo, il quale non era
molto sapiente (o[ pánu sofów), sbagli nel ripartire le dunámeiw,
così che il genere umano alla fine della distribuzione rimane
senza facoltà naturali: l’uomo quindi si trova nudo, scalzo, privo di riparo e di armi, in una situazione di svantaggio e alla
mercé degli altri esseri viventi, tale quindi che la sua sopravvi
FRANCO BIASUTTI
venza è messa in pericolo. La situazione, come è noto, viene in
un primo momento salvata da Prometeo, il quale con il furto del
fuoco e del sapere tecnico (¡ntexnow sofía) ristabilisce l’equilibrio naturale: le téxnai, in quanto perì tòn bíon sofía, riescono quindi a garantire la sopravvivenza del genere umano; esse stanno perciò all’uomo così come artigli, pelliccia, zoccoli,
velocità ecc. stanno agli esseri viventi privi di linguaggio (tà
ƒloga): grazie alle téxnai l’uomo articola innanzitutto la voce
formando così le parole, diventa capace di costruire case, di fabbricare vesti e calzature ed impara a coltivare la terra . Il fine di
tutto questo è l’equilibrio naturale delle diverse specie dei viventi: fino a questo punto, quindi, si rimane ancora sul piano
della pura natura.
L’intervento di Prometeo, in realtà, si rivela insufficiente:
non esisteva, infatti, lo Stato, la póliw, la comunità politica, in
quanto gli uomini erano ancora privi della politik| sofía ovvero della politik| téxnh. Anche dopo il dono del fuoco e del
sapere tecnico si registra una persistente debolezza del genere umano rispetto al resto dei viventi, in quanto gli uomini risultano ancora incapaci di vivere insieme e di formare una comunità. Dato che è impossibile per l’uomo vivere da solo nella natura, per la seconda volta il genere umano corre il pericolo di essere distrutto. La seconda fase del mito si compie
pertanto quando Zeus invia Ermes sulla terra per portare agli
uomini pudore (a†dQw) e giustizia (Díkh), in modo che servissero da ordinamento delle città .
Il discorso sviluppato da Platone intorno ad a†dQw nel
Protagora trova un complemento pressoché necessario nel mito di Crono, così come viene presentato nelle Leggi. Al tempo
di Crono un potere felice reggeva tutte le cose umane senza
violenze e ingiustizia, per cui allora gli uomini avevano goduto di una forma di governo, al cui confronto anche il migliore
tra quelli del tempo presente non era che una pallida imitazione. Per accudire alle cose umane in qualità di re e di magistrati infatti Crono aveva designato non dei semplici uomini,
ma aveva inviato esseri di origine divina e superiore, i demo
PER UN SIGNIFICATO ETICO E ANTROPOLOGICO DEL PUDORE
ni: costoro avevano portato agli uomini il pudore (a†dQw), il
buon governo (e[nomía) e la giustizia (Díkh) . In un altro
luogo delle Leggi Díkh viene presentata come figlia di a†dQw :
il nesso tra a†dQw e Díkh è con tutta probabilità ripreso da
Esiodo e deve essere considerato come un punto fondamentale, in quanto mette in luce l’originario significato eticopolitico del pudore. A†dQw genera Díkh ed apre in questo modo la strada alla filía, alla convivenza: la comunità politica
provvede alla salvezza dell’uomo soprattutto nei confronti degli altri uomini. Prima di a†dQw e Díkh gli esseri umani si danneggiavano reciprocamente: Platone sembra in questo modo
voler porre l’accento sul fatto che c’è una sorta di capacità autodistruttiva del genere umano, tale per cui bisogna pensare
di salvare l’uomo non solo e non tanto dalla natura, quanto
piuttosto anche da se stesso; la póliw preserva l’uomo non più
soltanto contro le minacce esterne, ma lo protegge soprattutto dai suoi simili.
Se a questo punto si ponesse la domanda “che cosa è il pudore?”, non vi è dubbio che la risposta dovrebbe essere ricercata a partire dallo stretto legame che è stato instaurato tra pudore e giustizia. Va innanzitutto rilevato che a†dQw e Díkh hanno origine divina: Zeus ed Ermes da un lato, Crono e i demoni
dall’altro. In questo senso, quindi, il pudore diventa un segno
di distinzione del genere umano rispetto agli altri viventi: esso è
proprio degli esseri viventi dotati del lógow, non di quelli che
sono ƒloga. Sotto questo profilo il pudore presuppone un certo livello di cultura, di paideia, ovvero di Bildung, vale a dire il
sollevamento dell’uomo da una vita propriamente ferina e l’impiego delle diverse arti: l’uso della parola, le prime forme di vita organizzata (il lavoro) e di vita associata; è necessario in sostanza che le téxnai abbiano già addomesticato la natura, sia intesa come ambiente di vita sia come quella naturalità che è interna all’essere umano.
Vi è inoltre un altro elemento da tenere presente. Accingendosi ad eseguire il comando di Zeus, Ermes chiede in quale modo vada fatta la distribuzione . Per quanto riguarda le
FRANCO BIASUTTI
arti, infatti, si era fatto in modo che solamente alcuni, e non tutti indistintamente, fossero competenti nelle diverse téxnai, in
quanto uno solo poteva bastare per molti: un solo medico, ad
esempio, può essere sufficiente a provvedere per molti degli
appartenenti alla comunità, per cui non è necessario che tutti
siano istruiti nell’arte medica. Lo stesso accade per le altre arti. Ma il caso di a†dQw è del tutto particolare: Zeus comanda a
Ermes che pudore e giustizia siano distribuiti a tutti indistintamente, in quanto tutti ne devono avere una parte. La comunità
politica non potrebbe sussistere se soltanto pochi possedessero a†dQw e Díkh . Il pudore quindi non ha un uso privato, implica all’opposto la relazione con gli altri. Il significato eticopolitico di a†dQw non va tuttavia ricercato in ciò che oggi si direbbe “il comune senso del pudore”. Per Platone infatti a†dQw
si contrappone a ceu^dow, ovvero a menzogna, inganno . Se a
sua volta ceu^dow trova il suo contrario, il suo opposto naturale in ˙l}yeia, allora Díkh, in quanto figlia di a†dQw, fonda una
póliw, una comunità politica, il che è dire una forma di intersoggettività, che ha nella verità uno dei suoi fondamenti o presupposti.
Il pudore come “passione”
Possiamo ritornare alla domanda originaria “che cosa è il pudore?”, per rivolgerla a questo punto ad Aristotele: nell’ambito
di tale domanda lo Stagirita si chiede innanzitutto se il pudore
sia propriamente una virtù. Da quanto è stato osservato finora
su a†dQw e Díkh può sembrare, almeno a prima vista, sorprendente che nell’Etica Nicomachea si affermi che il pudore non
rientra nel genere della virtù . Tuttavia, ad un’indagine più ravvicinata non tarda ad emergere che le eventuali differenze tra
Platone ed Aristotele, almeno in questo caso, sono in realtà minori di quanto in un primo momento potrebbe sembrare .
Si può osservare, infatti, che già secondo Platone a†dQw
rientra come differenza specifica nell’ambito del genere della
PER UN SIGNIFICATO ETICO E ANTROPOLOGICO DEL PUDORE
paura, allo stesso modo in cui, ad esempio, il numero dispari
è ricompreso nel più ampio genere del numero : sotto questo profilo il pudore è a sua volta ulteriormente riconducibile al genere della passione (páyow) . Non è difficile scoprire
che Aristotele, a sua volta, si pone sostanzialmente dal medesimo punto di vista. Il pudore presenta notevoli analogie con
la paura proprio perché produce effetti analoghi: infatti, così
come è caratteristico di chi prova paura l’impallidire, altrettanto è proprio di chi si vergogna l’arrossire; si tratta in entrambi i casi di fenomeni fisici (svmatiká), che coinvolgono
la conformazione del corpo .
Ancora secondo Platone il pudore è a volte una cosa opportuna, a volte una cosa non opportuna, può essere cioè sia
buono che cattivo: ad esempio, non si deve avere il pudore di
dire la verità . Anche in Aristotele si può riscontrare un analogo punto di vista: il pudore può essere sia buono che cattivo, nel
senso che non si confà ad ogni età, in quanto esso conviene al
giovane, ma non al vecchio . In conclusione il pudore, aristotelicamente, assomiglia più ad una passione (páyow), mentre
non può essere considerato una disposizione etica (£jiw), poiché non possiede quel grado di stabilità, che viceversa distingue
la disposizione; per lo stesso motivo non rientra nel novero delle virtù, proprio in quanto la virtù è innanzitutto una £jiw .
Il pudore come “scissione”
Nell’ambito della domanda “che cosa è il pudore?”, la trattazione aristotelica spinge ad approfondire l’analisi secondo una
prospettiva antropologica: lungo questa direzione alcuni spunti interessanti possono essere rintracciati nel pensiero di Hegel.
Il filosofo di Stoccarda tratta del pudore (Scham) in uno degli Zusätze al § della Enciclopedia delle scienze filosofiche: dato che il § fa parte del Concetto preliminare della Scienza della Logica, a prima vista si è lontanissimi dal contesto del pensiero platonico: in realtà si può osservare che anche Hegel trat
FRANCO BIASUTTI
ta del pudore nell’ambito del mito, quello cristiano del peccato
originale, che è anch’esso un mito delle origini.
Il fatto che il contesto sia costituito dal racconto biblico del
Genesi potrebbe suggerire che ci si intende muovere nell’ambito di una prospettiva di carattere teologico: Hegel tuttavia chiarisce subito ed in maniera inequivocabile che il suo punto di vista è radicalmente diverso. Nella medesima Aggiunta in cui si
affronta il tema del pudore si afferma infatti che «la filosofia non
deve avere soggezione della religione», in quanto se «il vero può
essere conosciuto in modi diversi», si deve comunque ammettere che «il modo più perfetto di conoscere è quello che si ha
nella forma pura del pensiero», in quanto qui solamente l’uomo
può comportarsi «in modo assolutamente libero» e l’attività
umana in cui è dato di conoscere la verità nella forma del puro
pensiero è appunto la filosofia . Nessuna prospettiva di tipo
teologico quindi: piuttosto, secondo l’assunto hegeliano, è opportuno trattare del mito del peccato originale all’interno della
logica perché tale scienza si occupa del conoscere ed anche il
racconto biblico tratta a sua volta della conoscenza, della sua
origine e del suo significato .
Agli occhi di Hegel Adamo ed Eva sono soprattutto un simbolo: essendo i primi uomini, essi rappresentano l’uomo in generale. La situazione e condizione di vita dei primi esseri umani rappresentano la vita spirituale nella sua immediatezza e naturalità, che si manifesta perciò come uno stato di innocenza e
di fiducia ingenua. È però tendenzialmente sbagliato pensare
che questa unità immediata, l’innocenza come stato naturale,
sia «il giusto (das Rechte)» . Per l’essere umano la natura è essenzialmente un punto di partenza che egli deve saper trasformare: in quanto l’uomo si comporta come puro essere naturale, si trova in una situazione in cui non deve essere. La vita spirituale si distingue dalla vita naturale e segnatamente da quella animale proprio perché non rimane ferma allo stadio della
propria immediatezza: appartiene infatti alla più profonda essenza dello spirito umano che la situazione immediata costituita dallo stato dell’innocenza e della fiducia ingenua sia supera
PER UN SIGNIFICATO ETICO E ANTROPOLOGICO DEL PUDORE
ta . Con l’abbandono dell’unità naturale si verifica quella che
Hegel definisce la «miracolosa scissione (wundervolle
Entzweiung) dell’elemento spirituale in se stesso»: il risveglio
della coscienza coincide con l’entrare nell’«opposizione (Gegensatz)», in quanto il concetto dello spirito implica necessariamente il punto di vista della «separazione (Trennung)». La natura non conosce una scissione interna di questo tipo, perciò le
cose naturali sono innocenti e non fanno nulla di male: per questo stesso motivo il concetto del «male morale (Böse)» è totalmente sconosciuto alla natura .
Quella appena descritta costituisce pertanto la cornice antropologica, al cui interno si innesta il discorso hegeliano intorno al significato del mito del peccato originale per quanto riguarda il pudore.
Hegel richiama a questo proposito l’attenzione sul fatto che
«la prima riflessione della coscienza nel suo destarsi comporta
che gli uomini si accorsero di essere nudi»: il pudore, dato che
il risveglio della coscienza, come si è visto, significa entrare nell’opposizione, implica la scissione dell’uomo dal suo essere naturale, sensibile; gli animali, che non giungono fino a questa
scissione, non hanno proprio per questo il senso del pudore .
Il pudore perciò vale sostanzialmente come un segno: esso
è il segno di una avvenuta Trennung, di una Entzweiung, ovvero la rottura di una immediatezza. In quanto uscita dallo stato
di natura con conseguente perdita dell’innocenza, il pudore è
il principio, il punto in cui trova il suo inizio l’umanità dell’uomo. In questo senso, in quanto esso è un punto di svolta,
un vero e proprio Wendepunkt, esso rappresenta un momento
positivo di crisi.
Appunti per una conclusione
Fin qui possiamo arrivare con Hegel. Ci si può avviare verso la
conclusione cercando di raccogliere e comporre insieme i significati principali emersi nel corso della presente analisi.
FRANCO BIASUTTI
Il pudore platonicamente è un dono divino e ciò vuol dire
che rappresenta certamente qualcosa di importante per l’uomo,
ma non va comunque enfatizzato oltre misura: in quanto può
essere tanto buono quanto cattivo, il passaggio dal pudore alla
virtù richiede un lungo cammino, per cui quindi molto ancora
deve essere fatto.
Il pudore, in quanto originaria scissione, rappresenta il primo destarsi della coscienza ma, proprio in quanto inizio, non è
ancora la coscienza compiuta, realizzata. Hegel infatti ricorda
che il punto di vista della scissione è esso stesso un cominciamento, un luogo di partenza che deve a sua volta essere superato: lo spirito deve anche saper ritornare all’unità mediante se
stesso .
A†dQw genera Díkh in favore degli esseri umani e la giustizia
tra gli uomini, secondo il dettato platonico, significa appunto tò
tà aøtou^ práttein: si ha cioè giustizia quando ciascuno svolge
il compito che gli è proprio nello stato rispetto agli altri . Díkh
colloca perciò ogni essere vivente al posto che gli è proprio ed
in questo modo definisce rapporti di equilibrio di ciascun essere umano verso i suoi simili . In questo senso non ci si vergogna mai da soli, in generale ci si vergogna sempre di fronte agli
altri: considerato sotto un simile profilo il pudore rappresenta
il primo istinto verso l’intersoggettività.
Hegel ribadisce che la naturalità per l’uomo, ovvero la natura in quanto viene tradotta in termini antropologici, si presenta nella forma della singolarità esclusiva: in questo senso la
malvagità naturale è appunto l’uomo naturale, cioè l’uomo che
è come non deve essere, ovvero che non è capace di andare oltre se stesso in quanto singolo . Il pudore, visto da questo lato, è allora il primo, più originario superamento di questa cattiva soggettività, del soggetto in quanto rimane confinato in
un’individualità escludente, che si limita a volere soltanto se
stesso nella propria particolarità, con il conseguente rifiuto dell’universale.
Il pudore considerato come páyow rappresenta un forte richiamo alla somaticità: in questo senso esso rivela che l’essere
PER UN SIGNIFICATO ETICO E ANTROPOLOGICO DEL PUDORE
umano è costitutivamente legato, compromesso con la propria
corporeità. Il pudore, tuttavia, pur apparendo come natura, si
mostra al tempo stesso come una fisicità che è orientata oltre la
pura natura: in questo senso esso rivela quindi che la stessa corporeità umana è già, per così dire, compromessa con lo spirito.
Il pudore, in ogni caso, produce effetti fisici (svmatiká), i
quali, avendo a che fare con le passioni, rinviano alla sensibilità:
non per questo, tuttavia, esso perde la sua intrinseca valenza etica. Forse, a questo punto, si apre lo spazio per un’ultima domanda. Quali indicazioni si possono ricavare per l’etica, ovvero come diventa possibile pensare l’etica a partire dall’essenza
del pudore? Ovviamente si possono qui ricavare soltanto alcuni spunti a carattere generale, individuando quindi non molto
di più che una direzione verso cui eventualmente procedere. Secondo la prospettiva fin qui delineata, l’etica non può più essere intesa come la moralità della coscienza singola, come il dialogo tra la coscienza individuale e la pura legge della ragion pratica: essa deve qui poter fare riferimento all’agire considerato
nella sua intersoggettività. Pensata secondo questa sua essenza,
l’etica va allora considerata come un qualcosa che costitutivamente implica una originaria pluralità di soggetti, che va compresa come relazione reciproca tra molti. Se etica significa quindi agire nell’intersoggettività, questo stesso agire, pensato nella
sua effettività concreta, si rivela come strutturalmente compromesso con la sensibilità: questa compromissione è quindi la sua
natura, non un suo difetto. All’etica allora spetta il compito, certamente difficile, di creare le condizioni per un’armonizzazione
di tutto l’uomo, non di organizzare il predominio di una parte
sull’altra.
Note
. Per la corrispondenza delle rispettive traduzioni ci si basa su Ae. Forcellini, Lexicon totius latinitatis, a I. Furlanetto, F. Corradini et I. Perin emendatum et auctum, Typis Seminarii, Patavii , tom. III, p. .
. R. Goclenius, Lexicon philosophicum, Typis M. Beeckeri, Francofurti
.
. S. Chauvin, Lexicon philosophicum, excudit F. Alma, Leovardiae .
FRANCO BIASUTTI
. Wörterbuch der Philosophie, von F. Mauthner, Muller, München-Leipzig .
. A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, revue
par MM. les Membres et Correspondants de la Société Française de Philosophie, Alcan, Paris .
. N. Abbagnano, Dizionario di Filosofia, UTET, Torino . Altri dizionari filosofici che non registrano la voce pudore sono ad esempio i seguenti:
A. Halder, M. Müller, Philosophisches Wörterbuch, Herder, Freiburg-BaselWien ; Enzyklopädie, Philosophie und Wissenschaftstheorie, hrsg. J. Mittelstraß, J. B. Metzler, Stuttgart-Weimar .
. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, hrsg. G. Kittel, W.
Kohlhammer, Stuttgart ss.; la voce pudore è stata scritta da R. Bultmann.
. Dictionnaire de spiritualité, publié sous la direction de M. Viller, Beauchesne, Paris ss.
. Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, hrsg. K. Galling, Mohr, Tübingen ss.
. B. Mondin, Dizionario enciclopedico di filosofia, teologia e morale,
Massimo, Milano .
. Nuovo dizionario di Teologia morale, a cura di F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo .
. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, par une Société de Gens de Lettres, mise en ordre et publié par M. Diderot et par M. d’Alembert, Compact Edition, Pergamon Press, New YorkParis , vol. III, tome XIII, p. .
. Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. J. Ritter und K. Gründer, Schwabe & Co., Basel ss., vol. VIII, R-Sc, coll. -; a quest’opera
si rinvia comunque per i necessari riferimenti bibliografici.
. Platone, Protagora, c-d.
. Ivi, d- a.
. Ivi, b-c.
. Platone, Le leggi, d-e.
. Ivi, d-e.
. Esiodo, Le opere e i giorni, -. Per quanto riguarda il concetto
di a†dQw in Esiodo cfr. D. L. Cairns, AIDŌS. The Psychology and Ethics of
Honor and Shame in Ancient Greek Literature, Clarendon Press, Oxford ,
pp. -, cui si rinvia anche per più ampi riferimenti bibliografici sul tema.
. Platone, Protagora, c.
. Ibid.
. Platone, Le leggi, d-e.
. Aristotele, Etica Nicomachea, b .
. Per un’analisi più dettagliata delle prospettive di Platone ed Aristotele su a†dQw si rinvia ancora a Cairns, AIDŌS, cit., rispettivamente pp.
-, -.
. Platone, Eutifrone, c.
. Platone, Protagora, b.
PER UN SIGNIFICATO ETICO E ANTROPOLOGICO DEL PUDORE
. Aristotele, Etica Nicomachea, b -.
. Platone, Carmide, a.
. Aristotele, Etica Nicomachea, b -: «La passione non si confà
ad ogni età, ma alla giovinezza. Noi infatti pensiamo che i giovani devono essere pudichi in quanto, vivendo sotto l’influenza delle passioni, commettono
errori, mentre ne sono impediti dal pudore; e lodiamo quelli che sono pudichi tra i giovani ma nessuno loderebbe un vecchio perché è incline al pudore: infatti riteniamo che egli non deve compiere nessuna delle azioni per le
quali ci si deve vergognare».
. Ivi, b .
. Cfr. G. W. F. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, con le Aggiunte a cura di L. von Henning, K. L. Michelet e L. Boumann,
Parte prima: La scienza della logica, trad. a cura di V. Verra, UTET, Torino ,
pp. - (ed. or. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse . Erster Teil: Die Wissenschaft der Logik. Mit den mündlichen Zusätzen, hrsg. E. Moldenhauer und K. M. Michel, Suhrkamp, Frankfurt am
Main , § , Zusatz n. , pp. -).
. Ivi, p. ().
. Ivi, pp. - (-).
. Ivi, pp. - (-).
. Ibid.
. Ivi, p. ().
. Ivi, pp. - ().
. Platone, La Repubblica, b.
. Platone, Alcibiade I, b-d.
. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, cit., pp. - (-).
Le forme della sincerità e il pudore
di Andrea Tagliapietra
Se i comandamenti di Dio fossero undici, e non dieci, ovvero
quanti Mosè ricevette sul Monte Sinai, l’undicesimo comandamento, il comandamento più disatteso, ma anche più perversamente perseguito dai contemporanei, potrebbe essere una sorta di adattamento, rovesciato in forma di diritto ed esteso alla
totalità di ciò che si è e di ciò che si pensa – accortamente, infatti, Kant precisava: «Posso concedere, benché sia molto doloroso, che non si trovi, nella natura umana, la franchezza (Offenherzigkeit) (di dire tutta la verità che si conosce). Ma la sincerità (Wahrhaftigkeit) (che sia detto con veridicità tutto ciò che
si dice) è necessario poterla pretendere da ogni uomo» –, del
kantiano dovere incondizionato della veridicità: quando chiedi
ad un tuo simile qualcosa, hai sempre il diritto di pretendere da
lui una risposta sincera.
Nel romanzo L’immortalità Milan Kundera sviluppa un ironico capitoletto su questo undicesimo comandamento che, nel
villaggio globale, ossia nella società della comunicazione, del
giornalismo d’assalto, dei reality show, dell’informazione indiscreta, spudorata, pettegola e del mito strumentale della trasparenza assoluta, è, a suo personale giudizio, il volto attuale del
totalitarismo.
«Notate bene», scrive Kundera, «che Mosè non ha incluso
fra i dieci comandamenti di Dio “Non mentire”». Infatti, aggiungiamo noi, l’originario precetto biblico, l’ottavo comandamento del decalogo, è «non pronunciare falsa testimonianza
contro il tuo prossimo» (Esodo , ). Ciò, prosegue lo scrit
ANDREA TAGLIAPIETRA
tore ceco, non è una semplice variante giuridica della più generale interdizione della menzogna, ma comporta una differenza
essenziale. «Perché chi dice: “Non mentire”, prima ha detto per
forza: “Rispondi”, e Dio non ha dato a nessuno il diritto di pretendere dal prossimo una risposta. “Non mentire”, “rispondi la
verità” sono parole che un uomo non dovrebbe mai dire a un
altro uomo, finché lo considera un suo pari». «Forse», ironizza
Kundera, «soltanto Dio avrebbe il diritto di dirle, ma Dio non
ha alcun motivo di farlo, visto che sa tutto e non ha bisogno della nostra risposta» .
Per l’autore dell’Insostenibile leggerezza dell’essere, fra chi
ordina e chi deve obbedire, fra il comandante e il soldato o fra
il servo e il padrone, non c’è una disparità di dignità, una disuguaglianza di potere tanto radicale quanto quella fra chi ha
il diritto di pretendere una risposta e chi si trova nella condizione di essere obbligato a rispondere alla domanda. È una situazione che la cronaca spesso ci presenta: si pensi, per esempio, alla cruda evidenza delle terribili foto delle sevizie perpetrate dai soldati americani ai danni dei detenuti iracheni nel
carcere di Abu Ghraib. Qui appare, con tutta l’efficacia sintetica che è propria dell’immagine, quel nesso brutale che accosta la domanda di verità – i prigionieri, si dice, in questo modo
venivano “preparati” all’interrogatorio – alla perdita di dignità, alla nudità dei corpi e, oltre questa, alla violenza delle
torture, il cui sfondo sessuale rivela l’obiettivo di produrre
un’umiliazione sistematica atta a colpire il pudore stesso dei
detenuti e, con questo, la loro capacità di resistenza in quanto
individui.
«Porre una domanda», scriveva Elias Canetti in Massa e potere, «significa agire per penetrare» . La domanda, nell’inchiesta inquisitoria, diventa implacabilmente, forse inevitabilmente, un mezzo per l’esercizio del potere che affonda, affilato come un coltello, nel corpo dell’interrogato. Interrogare è, allora, questione di chirurgia, è lavoro di bisturi e di precisione. È
scavo in profondità, è messa allo scoperto di quanto vi è di più
intimo. Secondo Ernst Bloch la tensione dell’interrogatorio e
LE FORME DELLA SINCERITÀ E IL PUDORE
il lavoro anatomico della ricerca delle prove indiziarie, malgrado l’evolversi dei dispositivi civili d’inchiesta giudiziaria,
ereditano sempre qualcosa dalla regina probationis, da
quell’«inconcepibile crudeltà» che è l’«indagine dolorosa»
della tortura .
Ma, si dirà, questa scena crudele, la scena della tortura, la
scena della macchina della verità e l’occhio dell’inquisitore
che mette a nudo, che viviseziona l’interrogato, riguardano
quella verità che si cerca di estorcere all’altro e che, certo, non
ci sogneremmo neppure lontanamente di chiamare con il nome di sincerità. Non solo perché sotto tortura, sotto la minaccia della violenza – come ben sanno i carnefici di ogni epoca e latitudine –, si ammette qualsiasi cosa, ma perché la nostra sensibilità, che altro non è che il risultato immediato della nostra tradizione culturale, ci dice che un requisito primario della sincerità dev’essere la libertà. Io sono sincero se mi
viene concessa la possibilità di esprimermi liberamente. La
condizione della libertà è necessaria perché nell’atto di sincerità ciò che è in gioco, per i moderni, non è tanto la verità sul
mondo quanto la verità su se stessi e, per esprimerla, a differenza dell’inquisito che è in ostaggio del potere altrui, bisogna possedersi.
Nel suo significato più comune la sincerità è, per il Dizionario della lingua italiana curato da Giacomo Devoto e Gian
Carlo Oli, la «corrispondenza di un’espressione o di un comportamento all’effettivo modo di sentire o di pensare» . Sincero, gli fa eco il Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, è colui «che nell’agire, nel parlare e in azioni similari
esprime con assoluta verità ciò che sente, ciò che pensa» .
Analoghe definizioni si riscontrano a proposito dei termini
che, nelle principali lingue moderne, esprimono la nozione di
sincerità.
Come si può quindi vedere, nell’idea di sincerità che storicamente ci appartiene , più che la relazione con una verità data che si dovrebbe testimoniare con i detti e con i fatti, ciò che
viene sottolineato e su cui viene posto l’indice di rilevanza pe
ANDREA TAGLIAPIETRA
culiare è l’autorispecchiamento del soggetto nelle azioni e nelle
parole, ossia la piena coincidenza dell’individuo con se stesso.
Così, la massima della sincerità moderna, la massima di quella
sincerità, cioè, che è già strettamente integrata alla nozione di
autenticità fino al limite della sinonimia – come attestano, del
resto, i sensi e le accezioni secondarie degli stessi dizionari –, appare splendidamente enunciata, alla stregua del motto di un’impresa rinascimentale, nei versi dell’Amleto shakespeariano, in
quel famoso passo in cui Polonio dà al figlio Laerte, in partenza per Parigi, il seguente consiglio: «Questo soprattutto: sii fedele a te stesso (to thine own self be true) / E ne deve seguire,
come la notte al giorno, / Che non sarai mai falso (false) con nessuno» (Amleto, atto I, sc. , -) .
Al cuore della nozione moderna e contemporanea di sincerità si installa la specificità di una relazione esclusiva con se stessi che il filosofo francese Vladimir Jankélévitch, nel piccolo trattato sulla sincerità inscritto nel disegno complessivo del monumentale Traité des Vertus, chiamava «sincerità terza», ovvero
«divenire ciò che si è» . Ecco allora che se dire «ciò che si pensa» e «fare come si dice», ossia le massime che riassumono i due
primi gradi della sincerità per Jankélévitch, appaiono esprimere l’aspetto convesso della sincerità come virtù sociale e di relazione – e, tramite questa caratteristica, la mettono in rapporto
con il plesso classico della veridizione-franchezza –, il terzo,
quello del «divenire ciò che si è», sembra manifestare «una sincerità immanente, una sincerità senza socialità», una sincerità
«concava, auto-riflessiva», ossia «immediatamente rivolta verso
se stessi».
Queste due forme della sincerità, la veridizione-franchezza
e l’autoriflessione come autotrasparenza e autoappropriamento,
poste in continuità e contiguità fra loro, rispecchiano due momenti della vicenda dell’idea di sincerità nella nostra cultura
che, insieme, corrispondono anche a due diverse figure della
soggettività, che, pure, continuano a vivere e a esercitare il loro influsso nel presente della nozione. Quella, cioè, di un soggetto che si fa modellandosi sul valore normativo di una verità
LE FORME DELLA SINCERITÀ E IL PUDORE
esterna che egli proferisce o che gli viene detta, e quella di un
soggetto che cartesianamente cerca la verità dentro di sé, esaminandosi, perché ne è legittimato ontologicamente e gnoseologicamente.
Le ultime ricerche di Michel Foucault incentrate sull’ermeneutica del soggetto e sulla parresia come cura di sé mediante la verità – e successive alla torsione programmatica che accompagna il vasto progetto della storia della sessualità –, ritornando ai luoghi classici, antichi e tardo-antichi, del processo di soggettivazione implicato nelle pratiche di veridizione-franchezza, miravano a marcare, mediante la costruzione
di una sorta di contro-modello storico-teoretico, una soluzione di continuità rispetto all’illusorio filo rosso che sembra
collegare, all’interno degli schemi tradizionali della storiografia filosofica, la problematica metafisica della psyché platonico-aristotelica con l’anima mea della meditazione agostiniana e, di qui, attraverso l’esercizio della confessione e le successive pratiche penitenziali del Medioevo cristiano, fino all’innesto con la soggettività moderna del cogito dove, secondo l’autore della Storia della follia, Cartesio elabora una figura del soggetto che riconosce in se stesso «un’intrinseca capacità di verità».
Con Cartesio «il soggetto è ritenuto a priori capace di verità» e solo accessoriamente – par provision, si potrebbe dire, alludendo alle regole della morale provvisoria del Discorso sul metodo –, capace, in quanto soggetto etico, di dire la verità e, dunque, di essere sincero.
Invece, nella parresia degli antichi studiata da Foucault, il
soggetto che parla, nel momento stesso in cui afferma io dico
la verità, si impegna a fare quello che dice: «io –afferma il soggetto parresiastico – sono assolutamente, integralmente e totalmente identico al soggetto che io stesso costituisco, allorché ti dico quello che ti dico». La parresia è, infatti, quel: a)
parlar chiaro, b) che dice la verità, c) con coraggio, d) rischiando liberamente, e) in modo disinteressato, f) nel momento opportuno (kairòs). In essa tutte le specificazioni pratiche del
ANDREA TAGLIAPIETRA
l’atto di dire la verità vanno intese come prove di verità finalizzate a surrogare la funzione di quell’attività mentale che,
per il pensiero postcartesiano, funge da sutura tra la dimensione della certezza e quella della verità (nel nostro dire può
sempre darsi uno scarto tra ciò di cui siamo convinti e quel
che è effettivamente vero, ovvero ciò che ritrae lo stato delle
cose così come sono).
Ma, soprattutto, nel processo parresiastico, a differenza di
quanto accade nella nozione moderna di sincerità, è colui che dirige, è la guida a sopportare il peso della verità. È il maestro a
trasmettere il discorso vero, con tutto il sistema di obblighi, doveri e impegni necessari a dire il vero. Nella parresia, cioè, la
funzione pedagogica determina la funzione psicagogica: la verità
che a te io dico, tu puoi vederla in me. Inoltre, nella parresia l’atto pedagogico della verità si inserisce in una struttura dinamica
asimmetrica in cui il potere sta dalla parte non di chi compie
l’atto parresiastico, ma da quella di chi ne è il beneficiario (di
qui, per esempio, il ruolo basanico esercitato dal coraggio nella
parresia politica).
Per comprendere il mutamento di paradigma della sincerità moderna e contemporanea – e, insieme, l’origine più remota dei suoi problemi e delle sue aporie – è necessario, invece, introdurre un modello, che farà la sua comparsa storica, su
larga scala, con il cristianesimo e con la pratica della confessione, in cui il prezzo essenziale della verità e del dire il vero non
grava più su colui che guida, ma su colui la cui anima dovrà essere guidata. «Almeno a partire dal Medio Evo», scrive Foucault, «le società occidentali hanno posto la confessione fra i riti più importanti da cui si attende la produzione della verità» .
La confessione non è la reminiscenza in cui si cerca in se stessi
la traccia originaria di un qualche sapere dimenticato, ma la cui
sede effettiva rimane comunque altrove, nell’iperuranio. La
confessione cerca il rapporto fondamentale con la verità nell’esame di se stessi, un esame che consegna, qui e ora, attraverso tante impressioni fuggitive, le certezze fondamentali della coscienza.
LE FORME DELLA SINCERITÀ E IL PUDORE
Come suggerisce Foucault nel corso del sull’Ermeneutica del soggetto, nella confessione «sarà solo a condizione di
enunciare lei stessa, su se stessa, un discorso vero, solo cioè a
condizione di enunciare lei stessa un discorso vero su se stessa,
che l’anima potrà essere guidata» .
Se nella parresia la verità pesa sulla guida e nella confessione la verità pesa sul guidato, il soggetto della pratica di soggettivazione parresiastica appare decentrato rispetto al soggetto
della confessione che, al contrario, risulta centrato in se stesso.
Per Foucault, dissociando pedagogia e psicagogia e centrando
la verità su chi si confessa, la pratica della confessione induce
a ritenere che «l’anima dica la verità perché questa verità è una
verità che solo essa può dire, poiché è la sola a detenerla». Inoltre, il rapporto duale della confessione presuppone che l’interlocutore, vuoi reale, vuoi virtuale, eserciti un potere inquisitorio sul confessante, imponendo, chiedendo, giudicando, punendo, consolando, perdonando.
«Nella spiritualità cristiana», scrive Foucault, «è il soggetto
che viene guidato a dover essere presente all’interno del discorso vero come oggetto del suo proprio discorso vero. Nel discorso di chi viene guidato il soggetto dell’enunciazione dovrà
essere il riferimento dell’enunciato» . Nella confessione si richiede non solo di dire il vero, ma di dire il vero a proposito di
se stessi.
Riassumendo l’argomentazione foucaultiana approda, dunque, a questa distinzione schematica: nella parresia «il soggetto
dell’enunciazione è il soggetto dell’enunciato», nella confessione
«il soggetto dell’enunciazione è l’oggetto dell’enunciato» ovvero,
nella parresia si tratta di divenire soggetto di verità, nella confessione si tratta di dire la verità su se stesso. Il che, altrimenti detto,
significa che la parresia è una pratica di soggettivazione (in cui si
diventa soggetti di verità), la confessione è una pratica di assoggettamento (in cui io sono soggetto della verità solo all’origine e
al termine di un assoggettamento all’altro che ribalta la dinamica
del potere propria della parresia: «non è colui che dice la verità,
ma colui che chiede la verità ad esercitare il potere»).
ANDREA TAGLIAPIETRA
«Divenire soggetto di verità significa», per Foucault, che chi
è guidato «possa dire a sua volta il vero e che possa dirlo a se
stesso, ma non è in alcun modo necessario e indispensabile che
dica la verità di se stesso» . Insomma, la parresia non è la sincerità perché essa descrive, nota Foucault nel Résumé del corso
del ,
l’assorbimento di una verità offerta da un insegnamento, da una lettura o da un consiglio, che va assimilata sino a farla diventare parte di
se stessi, un principio interiore permanente e sempre attivo. In una
pratica come questa, non viene ritrovata una verità nascosta in fondo
a se stessi mediante il movimento della reminiscenza; si interiorizzano verità che sono state accolte mediante un’appropriazione sempre
più spinta.
Nell’ascetica della verità divengono più importanti, rispetto all’esteriorità del dire e del gesto coraggioso che costituivano l’antica pratica parresiastica – e che si conservano nel rapporto, intimo e duale, con la franchezza del Maestro, dell’amico e soprattutto di se stesso –, l’ascolto, la scrittura, la memoria: tutte
tecniche che, conclude il filosofo francese, «hanno lo scopo di
legare fra loro la verità e il soggetto» .
La parresia è una epiméleia heautoû, una cura di sé, che
non coincide mai con quel presunto rispecchiamento, senza
resti, che la tradizione storico-filosofica proietta nella figura
del conosci te stesso, del gnothi seauton rielaborato dalla tradizione metafisico-spiritualista che, nella prospettiva foucaultiana, è destinato a incanalarsi e poi a procedere verso la
teoria generale e universale del soggetto propria della filosofia moderna (teoria che racconta e vede, con sguardo retrogrado, un’illusoria continuità della conoscenza di sé nella linea tracciata fra Platone, Agostino, Cartesio, Kant, Husserl e
Freud).
L’interpretazione della parresia e i testi parresiastici studiati da Foucault invitano a una pratica di sé e a una pratica della
verità in cui è in gioco la liberazione del soggetto (la traduzione latina di parresia è libertas), piuttosto che la sua reclusione
LE FORME DELLA SINCERITÀ E IL PUDORE
in una camicia di forza di verità che, dalle pratiche confessionali antiche e dalle Confessioni agostiniane fino alle Confessions di Rousseau, ma anche oltre (in Kierkegaard e in Dostoevskij, per esempio), costringe il soggetto della sincerità ad
affidarsi al meccanismo negativo – e sacrificale, come aveva intuito il genio di Maria Zambrano nelle pagine della Confessione
come genere letterario – dell’autocolpevolizzazione, dell’autoaccusa e poi, nella prospettiva contemporanea, del progressivo autodissolvimento. Di questo autodissolvimento, per esempio, è stato buon profeta Nietzsche che, nei Ditirambi di Dioniso, così cantava l’interminabile agonia del soggetto sincero:
«Adesso – da solo con te, / in due con il tuo proprio sapere, /
in mezzo a cento specchi / falso di fronte a te, / in mezzo a cento ricordi / incerto, / di ogni ferita stanco, / per ogni gelo freddo, / strozzato dai tuoi propri lacci, / conoscitore di te stesso
(Selbstkenner)! / carnefice di te stesso (Selbsthenker)!» (Tra uccelli di rapina, vv. -) .
Ma l’interrogazione della genealogia foucaultiana ci suggerisce, a questo punto, anche l’articolazione nodale che consente di congiungere la forma moderna della sincerità al pudore, vale a dire quella volontà di sapere che, nel momento in cui pone
il soggetto che confessa come oggetto della sua stessa confessione, designa principalmente una posta in gioco di verità, ovvero il sesso come spazio segreto da mettere a nudo. Per noi moderni abitatori dell’Occidente, che, come diceva Benedetto
Croce, «non possiamo non dirci cristiani», la verità e il sesso si
connettono nella confessione, ossia attraverso l’espressione
esaustiva di un segreto individuale che comporta l’enunciazione veridica della propria singolarità sessuale, del proprio corpo
e del proprio piacere.
L’obbligo della confessione – scrive Foucault – ci è ora rinviato a
partire da tanti punti diversi, è ormai così profondamente incorporato in noi che non lo percepiamo più come l’effetto di un potere
che ci costringe; ci sembra al contrario che la verità, nel più segreto di noi stessi, non “chieda” che di farsi luce; che se non vi accede
è perché una costrizione la trattiene, perché la violenza di un pote-
ANDREA TAGLIAPIETRA
re pesa su di essa e non potrà articolarsi alla fine che al prezzo di
qualcosa come una liberazione. La confessione rende liberi, il potere riduce al silenzio; la verità non appartiene all’ordine del potere,
ma è in una parentela originaria con la libertà: altrettanti temi tradizionali della filosofia che una “storia politica della verità” dovrebbe capovolgere, mostrando che la verità non è libera per natura, né l’errore servo, ma che la sua produzione è interamente attraversata dai rapporti di potere. La confessione ne è un esempio. Bisogna essere ben presi in trappola da quest’astuzia interna della
confessione, per assegnare alla censura, al divieto di dire e di pensare, un ruolo fondamentale; bisogna farsi un’immagine capovolta
del potere per credere che ci parlino di libertà tutte quelle voci che,
da tanto tempo, nella nostra civiltà, ripetono senza fine la formidabile ingiunzione di dire ciò che siamo, quel che facciamo, quel che
ricordiamo e quel che abbiamo dimenticato, quel che nascondiamo
e quel che si nasconde, quello a cui non pensiamo e quel che pensiamo di non pensare .
Per Foucault mediante la confessione della verità il potere si
iscrive nel cuore delle procedure d’individualizzazione assoggettandole. Il soggetto occidentale moderno diviene, allora,
«una bestia da confessione», in cui «la verità mostra la sua autenticità grazie all’ostacolo ed alle resistenze che deve eliminare per formularsi» . Queste resistenze sono, se pensiamo
al modello della confessione, in Agostino e nel penitente cristiano come, poi, in Rousseau e nella grande stagione autobiografica del romanzo europeo – ma questo tragitto continua, certo, fino a Freud e al lettino dello psicoanalista –, proprio la vergogna e il pudore. La nozione di sincerità, che dipende dalla figura storica della confessione implica, cioè, l’acquisizione della figura del pudore come una resistenza che
deve essere superata, perché questo superamento funge, in
qualche modo, da prova. «La discrezione», scrive Freud in
una lettera del giugno all’amico pastore Pfister, «è incompatibile con il successo dell’analisi: bisogna essere senza
scrupoli».
L’essere senza scrupoli dell’analista si rovescia, così, nella
provocazione, propria dell’analisi, ad essere spudorati, ossia ad
LE FORME DELLA SINCERITÀ E IL PUDORE
intendere il pudore come sintomo di inibizione e di repressione. «Quando dico: “Non ho nulla di cui vergognarmi”», scrive
Umberto Galimberti nella sua analisi del “vizio” contemporaneo della spudoratezza, «non sto dicendo solo “Non mi vergogno, quindi non sono colpevole”, ma anche: “Non mi vergogno,
quindi non temo l’esposizione agli altri. Ho oltrepassato quello
che per chiunque sarebbe il pudore e ho fatto della spudoratezza non solo la mia virtù, ma la prova della mia sincerità e della mia innocenza”» .
L’apparentamento, sempre più frequente nei costumi contemporanei, fra spudoratezza e sincerità suggerisce, sulla base
delle famose analisi sartriane dell’Essere e il nulla, di azzardare
un accostamento fra lo sguardo oggettivante e identificante della vergogna e il modo d’essere della cosa che è il presupposto
ontologico della sincerità.
Infatti, dire che, nella confessione sincera, il soggetto dell’enunciazione diventa l’oggetto dell’enunciato, significa attribuire alla sincerità quello sguardo oggettivante e identificante
che Sartre riferiva al sentimento originale della vergogna (vereor gognam): «La vergogna pura non è il sentimento di essere
questo o quell’oggetto criticabile; ma, in generale, di essere un
oggetto, cioè di riconoscermi in quell’essere degradato, dipendente e cristallizzato che io sono per altri» . Ma, nella prima
parte dell’Essere e il nulla, nel corso della celebre analisi della
figura della malafede, Sartre aveva scorto questa cristallizzazione oggettivante e identificante, propria del modo d’essere
della cosa, come il tratto ontologico peculiare evocato dalla nozione di sincerità là dove in essa si pretende di essere identici a
se stessi.
La sincerità – egli scrive – si presenta come un’esigenza, e di conseguenza non è uno stato. Ora qual è l’ideale da raggiungere in questo
caso? Che l’uomo sia per se stesso soltanto ciò che è, insomma sia pienamente ed unicamente ciò che è. Ma questa è proprio la definizione dell’in-sé o, se si preferisce, il principio d’identità. Porre come
ideale l’essere delle cose, non significa insieme confessare che questo
essere non appartiene alla realtà umana e che il principio d’identità,
ANDREA TAGLIAPIETRA
lungi dall’essere un assioma universalmente universale, è solo un
principio sintetico che gode un’universalità semplicemente parziale?
Così, perché i concetti di malafede possano illuderci almeno per un
istante, perché la franchezza dei “cuori puri” (Gide, Kessel) possa valere per la realtà umana come ideale, occorre che il principio d’identità non rappresenti un principio strutturale della realtà umana, che
la realtà umana non sia necessariamente ciò che è, ma possa essere
ciò che non è .
Detta in altre parole, la nozione di sincerità moderna, derivata
dalla figura culturale della confessione, entra in crisi, diventando impossibile, perché lo sguardo che rivolgiamo a noi stessi rimane, malgrado l’introiezione, lo stesso sguardo reificante dell’inquisitore, l’occhio di Dio che rivela la nudità di Adamo ed
Eva (formula della vergogna: “io ho vergogna di me di fronte ad
altri”; formula della sincerità: “io sono sincero con me di fronte
a quell’altro che io stesso sono”). Nei confronti di questo sguardo possiamo cercare di sottrarci attraverso le figure umbratili
della malafede, mirabilmente esplorate nei quadri fenomenologici sartriani del cameriere del caffè, dell’omosessuale o della
donna al primo appuntamento, o di adeguarci, mediante il rilancio provocatore-probatorio, ma altrettanto ambiguo, della
spudoratezza.
In entrambe le vie, però, non incontriamo la libertà di essere noi stessi, bensì la sottomissione al potere altrui e alle istanze
della società. Quella libertà che sembrava la condizione necessaria della sincerità viene meno. È a questo punto, là dove la nozione moderna di sincerità, entrata in crisi, cede il passo a quella di autenticità, che si apre, forse, lo spazio più opportuno per
il recupero pensoso della figura del pudore, ossia di quel ritorno dell’individuo su se stesso (Rückwendung auf das Selbst) che
suggeriva la famosa tesi scheleriana .
L’autenticità, anche quando sembra prodursi nello slancio
esibizionistico, è intimamente pudica. Il suo dispositivo viene
espresso da un altro portentoso brano che l’Amleto di Shakespeare ci consegna, all’ingresso in scena del principe di Danimarca, nel primo atto del dramma: «“Sembra” signora? No, è.
LE FORME DELLA SINCERITÀ E IL PUDORE
Io non conosco “sembra” / Buona madre (“Seems”, madam?
Nay, it is. I know not “seems”) / Non è solo il mio mantello color dell’inchiostro, / Né gli abiti di circostanza di solenne nero,
/ Né le raffiche di sospiri e il fiato mozzo, / No, e nemmeno il
fiume copioso nell’occhio / Né l’atteggiarsi sconsolato del viso, / Insieme a tutte le forme, le espressioni, / I modi del dolore, a poter dire la mia verità (That can denote me truly. These
indeed “seems”;) / Questi invero “sembrano” perché sono /
Azioni che un uomo può recitare. / Ma io ho dentro ciò che
non si mostra – / Fuori ci sono i fronzoli e le maschere del dolore» (Amleto, atto I, sc. , vv. -) .
L’autenticità incontra il pudore nella frase di Amleto: io ho
dentro ciò che non si mostra. Essa è resistenza al meccanismo
panottico della sincerità, rivendicazione di un fondo irriducibile alle identità e ai ruoli che il potere e la società impongono all’individuo. Ma questo fondo, che consente all’individuo di essere fedele a se stesso, non è stabile.
È, piuttosto, una mise en abîme, o, come suggeriva Lionel
Trilling in Sincerità e autenticità, una sorta di autotrascendenza negativa:
non è certo un caso che l’idea di sincerità, del proprio io e della difficoltà di conoscerlo e mostrarlo, sia venuta a tormentare l’animo
umano nell’epoca che vide l’improvvisa fioritura del teatro. Una nota opera di sociologia contemporanea porta il titolo La vita quotidiana come rappresentazione [Trilling qui fa riferimento al capolavoro di Erving Goffman, pubblicato nel ]: possiamo supporre
che l’Amleto dei nostri giorni dica: “Dentro di me ho qualcosa che
va al di là della rappresentazione”. In questa impresa di rappresentazione dell’io, in cui ci si porta sul palcoscenico sociale, la stessa sincerità gioca un ruolo curiosamente compromesso. La società ci richiede di rappresentarci come persone sincere e il modo più efficace di soddisfare tale richiesta è cercare di esserlo veramente, di essere effettivamente ciò che vogliamo che la nostra comunità sappia
che siamo. In poche parole, recitiamo il ruolo di noi stessi, sinceramente facciamo la parte della persona sincera, col risultato di rendere possibile un giudizio non autentico sulla nostra sincerità. Di
questi tempi la parola “autenticità” sale alle labbra così facilmente
ANDREA TAGLIAPIETRA
e in così tanti contesti da poter resistere benissimo agli sforzi di definizione che farò in seguito, mentre per il momento credo di potermi accontentare del suo riferimento a un’esperienza morale più
vigorosa della “sincerità”, a un concetto più esigente dell’io e di ciò
in cui consiste essere sinceri con esso, a un riferimento più ampio all’universo e al posto occupatovi dall’uomo, e a una visione meno accomodante e benevola delle circostanze sociali della vita. Agli ordini del criterio di autenticità, molto di ciò che un tempo si pensava
costituisse il tessuto stesso della cultura oggi sembra di scarsa importanza, pura fantasia o rituale, o contraffazione bell’e buona. Per
contro, molto di ciò che tradizionalmente la cultura condannava e
tentava di escludere, come il disordine, la violenza, l’irrazionalità, si
vede riconoscere una notevole autorità morale grazie a una rivendicata autenticità .
Per Trilling l’individuo contemporaneo ha una percezione risentita della cultura, ossia è caratterizzato da un senso che è, insieme, molto intenso, ma anche molto ostile della civiltà. L’intensificazione del condizionamento sociale che caratterizza l’ascesa storica dell’individuo moderno approda alla ribellione,
ossia all’illusione di potersi estraniare dalla propria cultura, anzi di giungere in un punto in cui sia possibile porsi al di là della cultura (questa posizione, per inciso, ha molte affinità con
quella del rinunciante, dell’anacoreta del deserto, che Louis Dumont, alla ricerca delle origini storiche dell’individualismo occidentale, poneva in opposizione esistenziale al cosmo e alla società tardo-antichi ).
Questo punto, suggerisce Trilling, è forse stato intuito da
Freud quando associa alla resistenza dell’io individuale la formulazione dell’istinto di morte: l’io può distruggere l’io con le
stesse energie che definiscono il suo essere così come l’io può
essere salvato negando quelle energie che pure profondamente contribuiscono a costituirlo. Per Freud, in significativa sintonia epocale con l’analisi del Sein zum Tode di Heidegger , la
morte è produttrice eminente di autenticità. Oltre ogni condizionamento culturale rimane sempre, secondo la lettura trillinghiana di Freud, il senso di se stesso che dipende dal «signifi
LE FORME DELLA SINCERITÀ E IL PUDORE
cato biologico» dell’individuo mortale; dalla caducità del dato
umano primigenio di ogni persona:
Freud – scrive lo studioso americano – può avere ragione o torto, ma
credo occorra fermarsi a riflettere un attimo se quest’importanza data alla biologia sia proprio un concetto reazionario o non sia invece
un’idea liberatoria. Essa ci dice che la cultura non è onnipotente; che
c’è un residuo umano che la società non riesce a controllare o condizionare, e che questo residuo, per quanto elementare possa essere, vale a sottoporre la cultura dominante a una forma di critica e a contestarne l’assolutismo .
L’irriducibilità del fondo biologico di ciascuno significa, allora, che
almeno una piccola parte del nostro destino individuale si situa al
di fuori della cultura e ci consente quel punto archimedico da cui
poter negare il condizionamento olistico della società, quella meravigliosa facoltà di opporsi che accomuna la grande filosofia e la
grande letteratura occidentale nel tipico gesto che rovescia lo schema della violenza, il tutti contro uno della repressione sacrificale che
tiene assieme le società, nell’uno contro tutti dell’individuo che si libera e sa dir di no.
Questo movimento di rivendicazione dell’autenticità è il
volto esterno, offensivo, ma altrettanto sfumato, ineffabile e
impalpabile – spesso, infatti, condensato in un gesto, in un
tratto di stile, in una sfumatura estetica, come quando, per riconoscere l’autenticità di un’opera d’arte, si dice che vi si vede la mano dell’artista –, del movimento retrattile e difensivo
del pudore.
Un pudore da intendersi, alla scuola di Jankélévitch, in
prossimità con quell’ironia che, pur imparentata, per certi versi, con la menzogna, è il modo più onesto che la verità ha di essere detta, abbandonando l’accordo maggiore della sincerità
che è stata propria dei martiri della confessione, ma anche degli eroi della parresia, per la modestia della tonalità minore della vita di ciascuno. Dietro il pudore, infatti, che è un velo che
mostra almeno tanto quanto nasconde, sta il quasi nulla del corpo, della biologia, del difetto e del gesto, dell’irriducibile diffe
ANDREA TAGLIAPIETRA
renza che è il ciascuno al fondo di ognuno. Non, quindi, un’individualità titanica e frontale, da esibire circonfusa di luce, ma
qualcosa di labile e insieme prezioso, che ha a che fare con la caducità dell’esperienza del corpo e della relazione e che fa venire in mente quello splendido passo del Trattato delle virtù, dove «il pudore si dissolve e si perde nell’intimità oscura dell’io indiviso, si ripiega al fondo della notte buia, in una fuga travolgente e assurda, e nella sua solitudine s’inabissa, deliziosamente, come un passante anonimo che scompare, la sera, nelle
profondità della grande città» .
Note
. I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, trad. di A. Poggi,
a cura di M. M. Olivetti, Laterza, Roma-Bari , p. , nota † (ed. or. Die
Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Königsberg , ora in
Kant’s Gesammelte Schriften, voll. I-IX: Werke; voll. X-XIII: Briefwechsel; voll.
XIV-XXIII: Handschriftlicher Nachlass; voll. XXIII ss.: Vorlesungen, a cura della
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Königlich Preußischen [poi
Deutschen] Akademie der Wissenschaften, de Gruyter, Berlin-Leipzig
ss., vol. VI, pp. -, p. , nota). Tale distinzione si rispecchia, in qualche
modo, nella stessa biografia di Kant, se è vero ciò che il filosofo già confessava a Moses Mendelssohn, in una lettera dell’ aprile : «in verità, io penso, con la più chiara convinzione e per mia grande soddisfazione, molte cose
che non avrò mai il coraggio di dire; ma non dirò mai qualcosa che non pensi» (Lettera a Moses Mendelssohn dell’ aprile ; trad. it. in I. Kant, Epistolario filosofico (-), a cura di O. Meo, il Melangolo, Genova ,
lettera , pp. -, p. [in Kant’s Gesammelte Schriften, cit., vol. X, Brief ,
pp. -]). Il dire la verità non significa mai dire tutta la verità che si può dire, ma semplicemente saper custodire in sé l’aurea misura dell’equilibrista,
che cammina sul filo teso fra l’eccesso della riservatezza (Zuruckhaltung), ovvero il silenzio che spinge verso la misantropia, e quello della dissimulazione
sociale (Verstellung), ossia la finzione che precipita inesorabilmente verso
l’insincerità.
. M. Kundera, L’immortalità, trad. a cura di A. Mura, Adelphi, Milano
, p. (ed. or. Nesmrtelnost, , Atlantis, Brno ).
. E. Canetti, Massa e potere, a cura di F. Jesi, Adelphi, Milano , p.
(ed. or. Masse und Macht, Classen Verlag, Hamburg ).
. Il saggio Considerazione filosofica del romanzo giallo fu presentato da
Bloch in forma di conferenza a un corso estivo di germanistica presso l’Università di Tubinga nell’estate del , poi in E. Bloch, Volti di Giano, a cura di T. Cavallo, Marietti, Genova , p. (ed. or. Verfremdungen (Janus-
LE FORME DELLA SINCERITÀ E IL PUDORE
bilder), , in Id., Literarische Aufsätze, Gesamtausgabe, voll., Suhrkamp,
Frankfurt am Main , vol. IX).
. G. Devoto, G. C. Oli, Dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze , p. .
. N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna
, p. .
. Non posso che rinviare, per il profilo d’insieme di questa storia, ad A.
Tagliapietra, La virtù crudele. Filosofia e storia della sincerità, Einaudi, Torino .
. W. Shakespeare, Amleto (-), testo inglese a fronte, a cura di A.
Lombardo, Feltrinelli, Milano , pp. -.
. V. Jankélévitch, Traité des Vertus (), vol. II, Les vertus et l’amour,
Flammarion, Paris , t. I, pp. -. In particolare, per la “sincerità terza” cfr. il § , Devenir ce qu’on est, ivi, pp. -. Del Trattato esiste una traduzione antologica, molto parziale: V. Jankélévitch, Trattato delle virtù, a cura di F. Alberoni, Garzanti, Milano .
. M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto (Corso al Collège de France
-), Feltrinelli, Milano (ed. or. L’herméneutique du sujet (Cours au
Collège de France -), Seuil-Gallimard, Paris ); Id., Discorso e verità nella Grecia antica, Donzelli, Roma (ed. or. Discourse and Truth. The
Problematization of Parresia, Northwestern University Press, Evanston, ILL,
).
. M. Foucault, La volontà di sapere, Feltrinelli, Milano (ed. or. La
volonté de savoir, Gallimard, Paris ); Id., Storia della sessualità, vol. II, L’uso dei piaceri, Feltrinelli, Milano (ed. or. L’usage des plaisirs, Gallimard,
Paris ); Id., Storia della sessualità, vol. III, La cura di sé, Feltrinelli, Milano (ed. or. Le Souci de Soi, Gallimard, Paris ). La prosecuzione della Storia della sessualità foucaultiana prevedeva un quarto volume, La Chair
et le Corps, poi trasformatosi in Les Aveux de la Chair, dedicato alla fase cristiana di questa storia, la cui stesura risultava a buon punto nel e di cui
la morte di Foucault impedì il completamento.
. Foucault, La volontà di sapere, cit., p. .
. Id., L’ermeneutica del soggetto (Corso al Collège de France -),
cit., p. .
. Ibid.
. Ivi, p. .
. Id., I corsi al Collége de France. I Résumés, Feltrinelli, Milano ,
pp. - (ed. or. Résumé des cours -, Gallimard, Paris ).
. M. Zambrano, La confessione come genere letterario, Bruno Mondadori, Milano (ed. or. La confesión: género literario, , Ediciones Siruela, Madrid ).
. F. Nietzsche, Ditirambi di Dioniso, a cura di G. Colli, in Opere di Friedrich Nietzsche, Adelphi, Milano ss., vol. VI, t. , pp. - (ed. or. DionysosDithiramben, , in Id., Werke, Kritische Gesamtausgabe, herausgegeben
von G. Colli und M. Montinari, de Gruyter, Berlin ss., Abt. VI, Bd. ).
ANDREA TAGLIAPIETRA
. Foucault, La volontà di sapere, cit., pp. -.
. Ivi, pp. e .
. U. Galimberti, I vizi capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, Milano , p. .
. J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, trad. di G. Del Bo, revisione di F. Fergnani, M. Lazzari, Il Saggiatore, Milano , p. (ed. or. L’être et le néant,
Gallimard, Paris ).
. Ivi, pp. -.
. M. Scheler, Pudore e sentimento del pudore, trad. di A. Lambertino,
Guida, Napoli , p. (ed. or. Über Scham und Schamgefühl, in Id., Schriften aus dem Nachlass, I, Gesammelte Werke, vol. X, Francke, Bern ).
. Shakespeare, Amleto, cit., pp. -.
. L. Trilling, Sincerità e autenticità, introduzione e cura di A. Tagliapietra, Sansoni, Milano , p. (ed. or. Sincerity and Authenticity, Harvard
University Press, Cambridge, MA, ).
. L. Dumont, Saggi sull’individualismo. Una prospettiva antropologica
sull’ideologia moderna, Adelphi, Milano , pp. - (ed. or. Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Seuil,
Paris ).
. M. Heidegger, Essere e tempo, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino ,
§ , p. (ed. or. Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen , rist. ).
. L. Trilling, Al di là della cultura, a cura di G. Fink, La Nuova Italia,
Firenze , pp. - (ed. or. Beyond Culture. Essays on Literature and Learning, Penguin, Harmondsworth ).
. Mi permetto di rinviare in proposito a A. Tagliapietra, Filosofia della bugia. Figure della menzogna nella storia del pensiero occidentale, Bruno
Mondadori, Milano , pp. XIII-XVI (Quella meravigliosa facoltà di opporsi) e Id., Esser contro, in “XAOS. Giornale di confine”, I, (http://www.
giornalediconfine.net/n_precedente/art_.htm).
. V. Jankélévitch, L’ironia, il nuovo melangolo, Genova , p. (ed.
or. L’ironie, Flammarion, Paris ).
. Id., Traité des Vertus (), vol. III, L’innocence et la méchanceté,
Flammarion, Paris , p. .
Tra residui di pudore
e germogli di verità pratiche
di giornalismo nell’era del blog...
di Giorgio Boatti
Poiché nella professione giornalistica non si è tenuti a sottostare alle regole di prudenza lessicale, agli obblighi di rigore semantico, ai doveri di profondità teorica che incombono sulle
accademiche specializzazioni felicemente confluite nell’incontro organizzato dall’Università di Macerata, credo mi sia consentito un privilegio: quello di giungere subito alla notizia.
La notizia – una notizia che come tutte le nuove che ci vengono scagliate addosso, è risaputa, o almeno largamente intuita –
è che il pudore, almeno nella professione giornalistica, è morto.
E se non è proprio del tutto trapassato, risulta – almeno
temporaneamente – essersi dileguato, e dunque lo possiamo ritenere piuttosto irreperibile.
Assieme al pudore sembra sottrarsi, ad ogni recente tentativo di individuazione, anche la modestia, che al pudore aveva
fatto compagnia, in una lunga stagione di crescita e di consolidamento del ruolo della stampa dentro la società moderna.
Mi conforta – nell’affidare alla pagina scritta, queste iniziali e assai soggettive premesse espresse nel corso dell’incontro
maceratese – intercettare segnali che sembrano confermare, da
una visuale ben più ampia e autorevole della mia, questa faccenda della scomparsa del pudore, o almeno della modestia,
nella professione giornalistica. E anzi, proprio da questa eclisse di una virtù tanto difficile da definire quanto netta nel far avvertire il suo esserci o il suo mancare, viene tratta una datazione precisa e, dalla datazione, deriva poi anche una modalità, un
sistema di valori, che finisce col definire un’epoca, un preciso
modo di operare della stampa.
GIORGIO BOATTI
Infatti, a dar retta a un’intelligente e ampia riflessione che
Russell Baker ha sviluppato recentemente, recensendo i volumi che hanno raccolto gli scritti di Abbott Joseph Liebling , una
colonna del “New Yorker” scomparso nel dopo una lunga
e brillante carriera giornalistica, c’è stata un’epoca – alla quale
sicuramente appartiene la parabola professionale di Liebling –
in cui «tutti i bravi giornalisti sapendo che dovevano sforzarsi
di essere modesti, riuscivano ad esserlo per davvero».
A quest’epoca della modestia giornalistica vengono attribuite da Russell Baker anche precise scansioni cronologiche:
«dagli anni Venti sino a quelli di Eisenhower la modestia era
una connotazione fondante dello stile della stampa americana
ma stava già dileguandosi quando Liebling morì. Da allora – aggiunge Russell Baker – quella che una volta era stata “la stampa” si è andata trasformando nei “media” e ha diffuso la pratica di quel modo di pensare imperiale che non induce a praticare la modestia, né negli zar di tutte le Russie né nei corrispondenti di Washington».
A questo punto Russell fissa una notazione, concernente
quella perduta era della modestia, che risulta preziosa – anche
se apparentemente scontata – nello svilupparsi di queste considerazioni:
Lo stile modesto metteva in luce davanti al lettore come il reporter
non fosse affatto infallibile, come era andata asserendo la vecchia religione del reportage “obiettivo”, ma fosse semplicemente un fragile
essere umano come lo siamo tutti, anzi così esplicitamente umano da
potergli accordare fiducia. Questo comportava che nel concretizzarsi del lavoro, vale a dire nel testo stesso del reportage, ci fosse spazio
per la presenza dell’autore, del reporter. Contravvenendo, in questo
modo, a quella che era stata fino ad allora una regola imprescindibile che imponeva che il reporter dovesse essere letto, ma mai e poi mai
avvertito nel suo esserci... .
Il patto tra giornalista e lettore, nell’epoca in cui la stampa non
si era ancora trasformata nei “media”, implicava dunque un
senso della modestia che aveva molto a che spartire con il pu
TRA RESIDUI DI PUDORE E GERMOGLI DI VERITÀ
dore. E se per quanto riguarda il giornalismo d’oltre Atlantico
si può confidare nelle valutazioni di Russell Baker qualche
spunto, sul senso del pudore, sull’adottare la modestia come
una sorta di abito professionale, lo si ritrova anche in alcuni
grandi, anche se dimenticati, professionisti del giornalismo italiano rinato dopo il crollo della dittatura fascista. Uno di questi, ad esempio, è sicuramente Tommaso Besozzi, il più grande
cronista del dopoguerra italiano, paziente dipanatore di misteri italiani di quegli anni, a cominciare dal caso del bandito
Giuliano.
In una bella biografia che ricostruisce la sua parabola professionale ed esistenziale finita tragicamente (Besozzi, dopo un
ricovero in clinica psichiatrica, si suicida) emergono tratti di
quel suo particolare procedere, assai diverso da quello dei divi
e delle divine della carta stampata che cominciano a imporsi
quando il suo astro inizia a declinare: «Tommaso Besozzi parlava poco e non credeva quasi a niente. Fu così che scoprì alcune
bugie della sua epoca: come era veramente morto il bandito
Giuliano, per esempio. Tommaso Besozzi fu il più grande giornalista del dopoguerra [...] più tardi qualcuno disse che ricordava un clochard» .
Oreste Del Buono, che aveva avuto modo di conoscere Besozzi e che ha voluto la biografia, scritta da Enrico Mannucci,
di lui ha scritto che «scriveva come un farmacista dosa gli ingredienti di un medicinale che può rivelarsi pericoloso. Non
amava la folla, i grandi fatti, i posti in prima fila. Disse una volta: “se sai guardare, anche nel deserto succedono cose meravigliose...”» .
Credo sia stato Oreste Del Buono a suggerire all’autore la citazione di Sherwood Anderson che apre la biografia di Besozzi:
Erano le verità che trasformavano la gente in caricature grottesche. Il
vecchio aveva una sua complessa teoria a questo proposito. Era sua
opinione che quando qualcuno si impadroniva di una verità, e diceva
che quella era la sua verità, e si sforzava di vivere secondo essa, allora
costui si trasformava in una caricatura, e la verità che egli abbracciava, in una menzogna .
GIORGIO BOATTI
Sicuramente la citazione suggerita va bene per afferrare il profilo complessivo, sempre volutamente sotto tono, di un grande
“vecchio” del giornalismo come Tommaso Besozzi.
Ma penso che Oreste Del Buono, col quel suo modo sempre piuttosto allusivo e criptico, di mettere lì cose importanti e
paletti di avvertimento senza voler mai avere l’aria di farlo, nel
suggerire quella citazione ad apertura di una biografia che sarebbe finita in mano a giornalisti della trascorsa generazione
ma, soprattutto, a giovani che si stavano avviando verso la professione, volesse lasciar lì un segnale d’allerta, un invito a non
prendersi troppo sul serio e, soprattutto, a non prendere troppo sul serio le proprie “verità”.
E quasi in un gioco di rimandi – che ovviamente esiste solo
nei miei pensieri – trovo che questa citazione da Sherwood Anderson trovi eco nell’articolo di Russell Baker proprio dove, parlando della generazione dei giornalisti della “stampa”, dunque
prima dell’avvento dei media, e delineando la caratteristica principale che aveva lo “stile modesto”, o pudoroso che dir si voglia,
afferma che questo consisteva nell’affrontare vicende complicate, talvolta molto complicate e tragiche, come se non lo fossero.
Non per attenuarne la portata, l’impatto e l’insegnamento
ma, piuttosto, nella tranquilla e indistruttibile convinzione che
tutte le grandi faccende, a cominciare dalla vita stessa, fossero temi che i limitati attrezzi del giornalista non potevano pretendere di afferrare, e magari sciogliere, e che questo lavoro era meglio lasciarlo fare ai profeti e ai preti, ai filosofi e ai poeti. Nonché ai grandi tycoons mediatici che anche ai tempi di Liebling
non mancavano (Russell Baker parla di Henry Luce, giornalista
ed editore co-fondatore di “Time”, potentissima figura dell’industria mediatica USA ai tempi di Eisenhower, noi potremmo forse far emergere altri nomi).
Lo stile modesto e pudoroso dunque è cauto nel portare in
giro le proprie verità, e – come consiglia di fare Sebastian Matta con il Caos – “le abbraccia con leggerezza”.
Come si è visto, dal pudore si è transitati, con passi a ritroso, allo stile pudoroso e modesto.
TRA RESIDUI DI PUDORE E GERMOGLI DI VERITÀ
Un ritrarsi, ovviamente, davanti all’impossibilità di stringere in una definizione, in un’asserzione, quel pudore che forse è
più facile scorgere nel suo mancare piuttosto che nelle tracce
che lascia il suo esserci.
Infatti non riesco a trovare definizione adeguata del pudore.
Se alcune parole giungono a recintarne in qualche modo i
confini (è l’altra faccia della medaglia della vergogna, dice l’etimologia) più essenziale è l’immagine metaforica alla quale, sempre alla ricerca delle connessioni che lo uniscono al mestiere che
pratico, finisco per ricorrere.
Ecco, nella rappresentazione che può essere correlata alla
professione giornalistica, o meglio a quella stagione della professione giornalistica di cui possono fare da icone le figure pur
così diverse di un Liebling o di un Besozzi, il pudore credo possa essere rappresentato, in un certo senso, come una particolare gradazione di luce.
Sì, mi piace pensare al pudore come una gradazione di luce
che determina le sfumature, le tonalità che il reporter si impegna (o si impegnava) a rispettare nel suo far racconto al lettore
circa a un fatto, un contesto.
Se il pudore era la luce sull’orizzonte caduto sotto lo sguardo, e catturato dalla tastiera del giornalista, la modestia, sorella
inseparabile del pudore professionale, ne era allora – in un certo
senso – l’ombra. L’ombra di sé, del proprio esserci, dentro quel
duplice orizzonte che stava al tempo stesso al di fuori (gli eventi,
gli accadimenti) e dentro (nei pensieri, nelle emozioni) del reporter stesso.
Il buon professionista ovviamente scorgeva il delinearsi di
quest’ombra, di questo inafferrabile doppio di sé che si faceva
pressoché nullo, nascondendosi sotto la suola delle sue scarpe,
quando la luce di eventi eclatanti diffondeva bagliori immensi
sul palcoscenico degli eventi.
E invece quest’ombra, questo doppio del proprio professionale e personale esserci, si allungava nei momenti in cui la luce si faceva radente. Rendeva, certamente, preziosa e inusuale
la prospettiva ma, altresì, chiedeva forme nuove e fragili di at
GIORGIO BOATTI
tenzione perché indistinti si facevano i contorni delle cose. Difficile l’individuazione delle tonalità dei colori. Ingannevole la
misura della distanza, della vicinanza.
Penso che quest’immagine del pudore come angolo di luce
che si spande sugli eventi che cadono sotto gli occhi del professionista della stampa abbia un legame con il tema che si vuole riprendere in questo studio. E questo legame ho l’impressione prenda posto dentro una concatenazione di riflessioni
che hanno avuto, qualche tempo fa, un certo rilievo e che ora
sembrano appartenere, almeno nel nostro paese, a territori meno frequentati.
Mi riferisco a quell’Elogio del pudore di Dal Lago e Rovatti
che costituiva un po’ la ripresa di quella proposta di “pensiero
debole” che accese polemiche e fraintendimenti.
Il pudore a cui facevano riferimento gli autori era quello,
suggerito alla teoria, da adottare quale terapia all’ossessiva «tentazione di dire la verità che affligge da sempre la filosofia e che
continua a produrre effetti autoritari ed esiti contraddittori».
La pretesa di viridizione, di possedere una verità più alta e
più forte, veniva fatta entrare in corto circuito con un pensiero
che si voleva fare consapevole dei limiti – in questo senso, era
definito “debole” – che lo abitano: aprendo così lo sguardo,
scriveva allora Rovatti, «ad un orizzonte contraddittorio e conflittuale in cui scopriamo con pena che la nostra identità è un
polo illusorio e che il cammino da fare è necessariamente quello che procede, per così dire, contro noi stessi».
Un cammino che “procede contro noi stessi” e che ricorda
molto la citazione di Sherwood Anderson ad apertura della biografia di Besozzi, o le notazioni di Russell Baker sullo stile modesto e pudoroso di una generazione di giornalisti che – non solo per questione di età – è pressoché estinta e che amava la verità ma non la voleva abbracciare troppo vigorosamente, per
non soffocarla.
Dopo la generazione dei giornalisti dallo “stile pudoroso” è
giunta la generazione dei coetanei di Bob Woodward e Carl
Bernstein, protagonisti del caso Watergate, che impose le di
TRA RESIDUI DI PUDORE E GERMOGLI DI VERITÀ
missioni a Nixon e rappresentò la vittoria della stampa – forse
a quel punto già diventata i “media” – sulla Casa Bianca, vale a
dire su uno dei maggiori centri di potere planetari.
Certo, non tutti i giornalisti sono, sono stati, o saranno protagonisti di imprese analoghe a quella vicenda che dalla redazione del “Washington Post” è approdata con Robert Redford
e Dustin Hoffman sul grande schermo.
Ma pochi giornalisti, appartenenti alla generazione di
Woodward, si sono sottratti – a partire dai primi anni Settanta –
alla magnetizzazione e all’immagine della professione che promanava da quella che, dopo essere stata una vicenda vera, si era
trasformata in un simbolo.
Non solo: si era imposta come orizzonte etico, nuovo ordine cavalleresco dove a colpi di giornalismo investigativo si potevano spazzare via dal mondo i corrotti, i criminali che tramavano nell’ombra contro la democrazia e la pace, i profittatori
che razziavano pubbliche risorse, gli arroganti che calpestavano gli umili, i deboli, gli orfani. E non avevano neppure rispetto per le donne, più o meno vedove.
Ecco, è difficile essere modesti e pudorosi, e non esporsi calpestando ogni senso della personale riservatezza, e – nel furore
delle battaglie che si conducono o si crede di condurre contro
il potere e la corruzione, per il bene di tutti – non stringere troppo dappresso quelle verità che dovrebbero essere invece “abbracciate con leggerezza”.
Quello che è venuto dopo, in stretta successione con la trasformazione della stampa nei “media” è stata, ovviamente, l’inevitabile esposizione “mediatica” del giornalista. E lì, con i
drammi di ogni scacchiere del mondo raccontati in diretta TV,
si abbina un esserci professionale che è esattamente agli antipodi dello “stile pudoroso”.
Perché, qualsiasi sia l’atteggiamento personale e il ruolo
che si decide di interpretare o di non interpretare, si porta comunque in scena una maschera che – svolga il copione del divo o dell’antidivo, della retorica o dell’antiretorica, stia dalla
parte dei potenti o da quella dei reietti del mondo – è vincola
GIORGIO BOATTI
ta ad essere assertiva. E dunque contribuisce a far dissolvere,
sotto la luce di qualsiasi riflettore mediatico odierno, quelle tonalità di luce, e quell’ombra, che compongono la delicata, preziosa, dialettica che pudore e modestia intrecciano col mestiere del giornalista.
Negli ultimi anni un nuovo strumento sorto in rete, il blog,
getta originali implicazioni nel rapporto tra pudore, informazione e comunicazione. Implicazioni che coinvolgono non solo
i professionisti dell’informazione stessa ma, potenzialmente,
tutti gli utenti della rete.
Innanzitutto val la pena di chiarire che il blog è parola, in lingua inglese, che nasce dalla somma e contrazione di due termini.
L’uno è il web, vale a dire la rete, lo spazio di Internet in cui
prendono posto i siti. L’altro, log, ha il significato – per l’equipaggio di una nave, ad esempio – di diario di bordo, in cui debbono essere registrati gli eventi in ordine cronologico.
Il blog è dunque una modalità della comunicazione in rete,
realizzato solitamente con una grafica assai semplice, che senza
avere praticamente costi di realizzazione né sbarramenti consente a chiunque di immettersi nel sempre più vasto oceano della comunicazione mediatica di cui il giornalismo è un settore
sempre più ridotto e intrecciato.
Il fenomeno dei blog nasce nel , dalla creatività di due
ragazzi americani, Evan Williams e Meg Hourihan, ideatori di
un software che, grazie al sito Internet www.blogger.com, permette di pubblicare una pagina web in pochissimi minuti.
Il primo blog accreditato è quello di Dave Winer, fondatore di Userland software nella Silicon Valley, creato nel .
In Italia i primi blog nascono nel e nel giro di pochissimo tempo investono il mondo universitario, le più composite
realtà giornalistiche, i più diversi ambiti sociali.
Infatti,
Ci sono weblogs “intimistici” o “diaristici”, centrati cioè sulle riflessioni, sui pensieri e sugli appunti esistenziali dei singoli. Altri si occupano di micro-realtà individuali: reti di idee, nate spontaneamente,
animate da privati cittadini, capaci di offrire terreno fertile di infor-
TRA RESIDUI DI PUDORE E GERMOGLI DI VERITÀ
mazione e crescita per una vasta comunità di utenti. Ci sono weblogs
legati ad associazioni, a movimenti o gruppi associati, che danno conto di realtà quotidiane diffuse, ma spesso senza possibilità di espressione sui canali ufficiali di comunicazione.
Tanto che qualcuno ha sostenuto che il fenomeno dei weblogs
«merita di crescere ed incontrare il favore dei naviganti di Internet alla ricerca di un tipo di informazione che, utilizzando canali convenzionali, rischierebbe probabilmente di non giungere
mai al destinatario; il blog quindi come editoria del popolo per
il popolo» .
Queste erano le migliori aspirazioni al sorgere del blog.
A distanza di qualche tempo basta fare un giro in rete per
comprendere come la vena intimistica e di esibizione personale
abbia trovato in questo strumento un veicolo che, in piccolo,
non fa che ribadire i meccanismi già sperimentati con l’avvento, in tutte le sue modalità, di quella società dello spettacolo di
cui Guy Debord era stato lucidissimo anticipatore.
Tutti siamo diventati attori pubblici che esprimono emozioni privatissime davanti a sconosciuti o comunque davanti a una
platea quotidiana e sovrapponendo quindi, secondo nuove regole, dimensioni private e maschere di ruoli sociali che a lungo
erano stati ben distinti e che seguivano comunque, nel loro
emergere, copioni ben collaudati.
Quello che ne deriva è quella “società di passioni tristi”, o
meglio ancora, quella società pericolosamente intimista che Richard Sennett aveva delineato trent’anni fa in un saggio fondamentale, The Fall of Public Man , che viene ben prima della rete e dei blog ma che, guarda caso, è pressoché contemporaneo
alla morte della stampa e alla sua rinascita nel più grande grembo dei “media”.
Sulle implicazioni generali di questa trasformazione – anche
sul fronte del pudore – c’è poco da aggiungere a quello che Sennett ha scritto.
Ma, per concludere, alcune cose andrebbero puntualizzate
circa l’impatto dei blog sullo stile – pudoroso o meno – della
professione giornalistica.
GIORGIO BOATTI
È avvenuto, infatti, soprattutto negli USA e in misura assai più
ridotta nel nostro paese, che da alcuni professionisti dell’informazione il blog sia stato considerato e utilizzato come uno strumento in grado di aggirare i controlli gerarchici, le censure più
o meno palesi, le uniformità editoriali più o meno esplicitamente praticate.
Alcuni casi clamorosi hanno poi dimostrato come un blog, tenuto da un grintoso e documentato professionista dell’informazione, possa riuscire a smascherare clamorose bufale diffuse da
poderose reti d’informazione. Da lì è emerso come prima o poi
tutti i media, ma soprattutto i giornali tradizionali, non potranno
più permettersi di ignorare a lungo la nuova maturità – nel reperire, arricchire, confrontare e correggere informazioni – che sta
crescendo grazie anche ai blog tra il pubblico dei lettori, e non
solo da parte dei professionisti dell’informazione.
Anche tra questi ultimi però, e soprattutto tra quanti utilizzano il blog non come esibizione delle proprie private faccende
ma come “recinto personale” in cui praticare, seppur nel modo
diverso imposto dalle circostanze, l’antico mestiere al servizio
dei lettori, non sono pochi coloro che ritengono che un ritorno
allo stile pudoroso sia un orizzonte inevitabile. Indispensabile
per difendersi dall’esposizione mediatica che ha fatto dell’icona del giornalista – dell’icona del giornalista di successo, e del
suo esserci e del suo apparire, della sua voce e del suo volto –
un prodotto al quale viene subordinato il senso vero, l’utilità civile e il piacere personale di un mestiere che altri, sicuramente
una minoranza, praticano in altro modo. Ritenendo, forse ottimisticamente, che possa conoscere in futuro, almeno in alcuni
nuovi ambiti, possibili positive evoluzioni.
A incoraggiarli questi pochi e testardi ottimisti sono vari
indizi.
Tra questi voglio fare riferimento ad un blog di Jay Rosen,
professore di giornalismo della New York University e che per
certi versi riprende spesso i temi di Russell Baker che erano stati accennati all’inizio di questo saggio. «Al giorno d’oggi – spiega Rosen nella presentazione del suo blog PressThink – dicia
TRA RESIDUI DI PUDORE E GERMOGLI DI VERITÀ
mo “media” invece di “stampa” (the Press). Ma è un errore. La
stampa è diventata il fantasma della democrazia della macchina
dei media e noi dobbiamo riportarla in vita. [...] Dobbiamo evitare – ripete più in là – che la stampa sia assorbita dai “Media”».
Forse è tardi. Forse, dice qualcuno, tutto questo è già avvenuto e ampiamente.
Ma, anche nelle situazioni più perigliose, c’è sempre una via
di fuga, un’uscita di sicurezza e solitamente sono presenze silenziose e appartate ma ben significativamente influenti sulla
nostra felicità, sull’accettazione di noi stessi – quali il pudore, e
la modestia – che ci dicono le strade da intraprendere e quelle
da evitare.
Come diceva Hölderlin, che di queste cose se ne intendeva,
«laddove c’è il pericolo, là c’è la salvezza».
E se un blog può essere il passaggio stretto per ritrovare lo
stile pudoroso o per giungervi, ben vengano i blog e i loro germogli di fragili verità sparsi nella rete.
Note
. R. Baker, A Great Report at Large, in “The New York Review of
Books”, , , November , .
. Per un’introduzione al lavoro giornalistico di A. J. Liebling, cfr. Just
Enough Liebling: Classic Work by the Legendary New Yorker Writer, by A.
J. Liebling, with an introduction by D. Remnick, North Point, New York
.
. Baker, A Great Report at Large, cit.
. E. Mannucci, I giornali non sono scarpe. Tommaso Besozzi una vita da
prima pagina, Baldini & Castoldi, Milano .
. Ivi, p. .
. Ibid.
. S. Anderson, Racconti dell’Ohio, Newton Compton, Roma .
. A. Dal Lago, P. A. Rovatti, Elogio del pudore. Per un pensiero debole,
Feltrinelli, Milano .
. La citazione proviene da http://www.noemalab.org/sections/specials/
weblog_didattico.
. R. Sennett, The Fall of Public Man, W. W. Norton & Company, New
York-London ; trad. it. Il declino dell’uomo pubblico. La società intimista, Bompiani, Milano .
La pratica femminile
tra visibile e invisibile
di Diana Sartori
In nome di quale ragione occulta, sconosciuta,
l’Aurora appare e scompare?
María Zambrano
Il pudore è tradizionalmente una virtù femminile, virtù associata alle donne e richiesta alle donne . La virtù del capo chino, del
rossore, della modestia, del riserbo, della riservatezza che è tanto ben incarnata nella nostra letteratura da Lucia Mondella, col
suo mento sempre incollato al petto e lo sguardo basso.
Davvero difficile è associare la virtù del pudore ad un soggetto maschile. Non è casuale la percezione di dissonanza che
l’elogio del pudore da parte di Dal Lago e Rovatti genera nel
senso comune filosofico, e che come l’idea di un pensiero “debole” ha ingenerato analogie di femminilizzazione del pensiero
nei casi migliori, e di minaccia di svirilizzazione del soggetto filosofico nei peggiori.
Non c’è di che stupirsi di questo legame tra il pudore e la
differenza sessuale, per almeno due ordini di motivi, i quali peraltro si intrecciano pressoché indissolubilmente nella nostra
tradizione.
Il primo è l’appartenenza del pudore, per eccellenza, alla
sfera semantica della sessualità. Laddove la sessualità viene associata al peccato e nel contempo alla conoscenza del bene e
del male, peccato di volontà di conoscenza che fu di Eva e la
cui prima conseguenza fu il pudore per la nudità. Circostanza
sulla quale si è imperniata una tradizione religiosa, e non solo,
di misoginia associata ad una paura insieme della sessualità e
della femminilità e sulla quale si è concentrata molta critica
femminile e molta teologia femminista impegnata ad «esorcizzare Eva dal male» . Non intendo riprenderla, mi piace però
qui suggerire da un lato come nascita del pudore e desiderio di
DIANA SARTORI
conoscere il bene e il male sorgano con la percezione di una differenza sessuale che è propriamente una caduta nell’umanità
terrena. Dall’altro lato che questa tradizione di pudore della
differenza sessuale che si volge in misoginia e in sentimento
della peccaminosità femminile (vicenda spesso imputata esageratamente a san Paolo per quanto riguarda l’obbligo di velarsi per le donne) è a tutt’oggi un terreno quanto mai caldo e
combattuto per le sorti di un mondo in cui la globalizzazione
minaccia l’equilibrio delle differenze e in tempo di morte del
patriarcato. Non c’è che da far mente locale-globale a come
tanto spesso il conflitto che questa innesca finisca per esplodere sul punto dolente della posizione delle donne. La questione
del velo è qui sintomatica di come il passaggio della contemporaneità si giochi anche sulla visibilità/non visibilità femminile. Al punto che essa diventa la cartina di tornasole della possibilità della vita comune nel mondo globalizzato dalla logica
del mercato, producendo una sorta di metro di misura dell’integrabilità che richiede parallelamente un percorso obbligato
dell’emancipazione femminile. Tornerò poi sulla questione,
per il momento torno al secondo ordine di motivi per cui non
c’è da stupirsi di quanto il pudore sia virtù difficilmente associabile al soggetto maschile. In questo caso si tratta di motivi di
tradizione più strettamente filosofica, connessi con la congenita appartenenza della filosofia alla costitutiva metafora della luce, della visibilità, all’immagine dell’eliotropo, ha detto Derrida, a un sole che stenta a tramontare sebbene, come suggerisce
ancora Rovatti, si sia nel tempo del declino della luce .
Poco adatta è la piena luce della tradizione filosofica alla
virtù del pudore, com’è d’altra parte poco adatta anche alle
donne. Non è qui il caso di ripercorrere le già tanto transitate
vicende della costellazione metaforica che ha messo in congiunzione la verità intesa come alétheia, il bene, la luce solare,
la visibilità e il sapere. E nemmeno intendo insistere più di tanto sulla congiunzione anch’essa già illuminata del cosiddetto
fallo-logo-centrismo, per quanto si stenti a trarne in filosofia le
dovute conseguenze assumendo pienamente quanto quella co
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
stellazione sia il segno natale di un preciso soggetto di sesso maschile, con il che il destino della filosofia è fatalmente segnato .
È indispensabile, però, sottolineare alcune coordinate che
nell’orizzonte di quest’orbita filosofica non possono che fare da
punti di riferimento per orientarsi in un percorso di ricerca sul
pudore. E che mi sono tanto più necessari in quanto l’obiettivo
che mi sono data è di riflettere su quella pratica femminile che
sta tra visibile e invisibile, in uno spazio che per certi versi, non
tutti, si sovrappone a quello del pudore.
Molti elementi si costellano nella nostra tradizione a mettere il destino femminile sotto il segno dell’invisibilità, prima, e a
segnarne, poi, l’orizzonte emancipativo nella traiettoria di un’uscita dall’invisibilità alla visibilità.
Di questi, quelli su cui voglio attirare l’attenzione sono il
rapporto visibile-invisibile, quello tra pubblico-privato, e tra dicibile-indicibile, tutte coppie dualistiche che tratteggiano un
percorso obbligato per il raggiungimento del fine verità-politica-sapere secondo il quale un soggetto si fa tale portandosi dal
privato al pubblico-politico, dal non sapere al sapere, dal non
detto alla dicibilità, dall’invisibile al visibile. Portandosi, insomma, attraverso una sorta di seconda nascita alla pienezza
dell’essere soggettivo, per una via di esplicitazione, venuta alla
luce, rivelazione, dissoluzione delle brume di ciò che è oscuro,
nascosto, non detto, non saputo, impolitico, non libero.
Percorrerò velocemente alcune delle coordinate di questa
costellazione, affrontando dapprima il nodo del dualismo pubblico-privato, poi quello della dicibilità-indicibilità relativamente al nodo della pratica e del sapere che deriva dalle pratiche, per concludere sul tema della visibilità-invisibilità.
Il pubblico e il privato
La separazione tra sfera privata e sfera pubblica è stata, fin dai
tempi più lontani, una questione cruciale nella storia del pensiero femminile. Carole Pateman a questo proposito si è ad
DIANA SARTORI
dirittura spinta ad affermare che «la dicotomia tra il privato e
il pubblico è centrale in quasi due secoli di scritti femministi
e di lotta politica; è in definitiva, ciò su cui verte il movimento femminista» .
È una crucialità obbligata, che si connette all’identificazione compiuta nella tradizione del pensiero politico, fin dai
tempi più remoti, della divisione tra sfera pubblica-politica e
sfera privata-domestica con la differenziazione sessuale. Con
la conseguenza di produrre una polarità di «sfere separate»
che, in analogia con il dualismo natura-cultura o physis-nomos,
riserva al maschile la dimensione della vita pubblica e politica, l’ambito di esercizio della libertà, e invece assegna il femminile, prossimo alla naturalità e vincolato alla necessità, alla
domesticità e al privato . L’attenzione femminile non poteva
non appuntarsi sullo scardinamento di questo dualismo oppositivo il quale, definendo nel contempo i confini della politica e il confinamento impolitico della differenza, ha costituito la prima barriera che si è levata contro l’accesso delle donne alla sfera pubblica. Già la storia del primo femminismo racconta la valenza dirompente dell’irrompere femminile sulla
scena politica e le contraddizioni che induce nella tradizionale visione della politica come nelle strategie politiche delle
donne: l’ormai celebre “dilemma di Wollstonecraft” tra eguaglianza e differenza rappresentò il primo portato dell’incontro
tra la richiesta di riconoscimento politico delle donne e la separazione vigente nella teoria politica tra pubblico e privato.
E volta a spezzare la tenaglia di quella separazione sarà anche
la parola d’ordine del femminismo della “seconda ondata”
radicato nella pratica di consciousness-raising: «il personale è
politico». Sulla scorta di questa intuizione le femministe radicali denunciarono l’agire di meccanismi di potere nel cuore
della sfera privata e la valenza politica di ciò che avviene in
quella personale, mentre le femministe di ascendenza socialista o marxista posero la questione della funzione del lavoro
domestico nell’organizzazione socio-economica. E ciò quando
per tutte, almeno in Occidente, si apriva la stagione di quel
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
l’ingiunzione all’emancipazione che ancor peggio che porre
una donna nell’arduo doppio ruolo lavorativo-domestico la
pone nell’insostenibile posizione di un double-bind non tanto
diverso dal vecchio dilemma della lungimirante Wollstonecraft. In tutti i casi ciò che emergeva era il perverso dispositivo di esclusione, misconoscimento e funzionalizzazione femminile legato alla separazione tra sfera privata/domestica e sfera pubblica-politica . Un dispositivo che fu in seguito al centro dell’analisi filosofico-politica femminile degli anni Ottanta, attenta al riesame delle concezioni tradizionali del rapporto pubblico-privato nel quadro di un ripensamento dei concetti della filosofia politica capace di raccogliere l’invito della
teoria femminista a superare la dicotomia delle due sfere . Fu
in tale quadro che si affermò la convinzione che la separazione delle due sfere – privata-pubblica – fosse una costante della filosofia politica in quanto fattore costitutivo di una politica costruita su una semplificazione e riduzione del politico attraverso l’esclusione delle donne e di un intero ambito della
vita e della natura umana dalla sfera della politica. Le donne
vengono messe direttamente al servizio di quest’ambito impolitico e indirettamente a supporto esterno di una sfera pubblica-politica che si può reggere nella sua separazione solo sostenendosi su questo supporto esterno e negato. Il confine della
politica si traccia così attorno ad uno specifico soggetto politico atto ad abitare quell’artificiale spazio pubblico: il ben noto “soggetto politico”, adulto, libero, autonomo, indipendente da vincoli di necessità e di relazione, spassionato, svincolato da legami familiari e intimi, sovrano e titolare di interessi e
diritti, uguale ad altri soggetti simili a sé e sostanzialmente
egoisti, dotato di ragione e di capacità di giudizio imparziale.
Un individuo capace di dominare le pulsioni degli istinti, del
corpo e delle emozioni, e di confinare “pudicamente” le proprie preferenze e opzioni di vita, convinzioni religiose e morali nella sfera personale, privata e domestica. Lo sguardo della dimensione politica e pubblica non può penetrare in questa
sfera protetta dall’interferenza altrui e salvaguardata dalla cu
DIANA SARTORI
stodia femminile, vero rifugio in cui ritirarsi al riparo dalla durezza delle regole dell’agone pubblico . Di contro alla luce
spietata di quel luogo aperto tanto simile ad un campo di battaglia, infatti, la luminosità dello spazio chiuso del privato è
più riposante e soffusa: lì si suppone possano fiorire relazioni
d’amore, rapporti emotivi e passionali, di solidarietà, di cura,
d’affetto, di sostegno ed educazione, di altruismo e persino sacrificio di sé, amicizia e reciprocità. La separazione tra pubblico e privato è la soglia che separa i due regimi di rapporti e
i due mondi, soglia che tradizionalmente solo gli uomini valicavano, a lungo invalicabile per le donne, o valicabile, appunto, con il dovuto pudore .
L’impudicizia del femminismo fu esattamente in ciò: di valicare quella soglia e addirittura di pretendere di contestarla,
revocando in dubbio la legittimità di una separazione che sta
al cuore di una complessiva immagine del soggetto e dei rapporti soggettivi, in primis dei rapporti tra i sessi, come della definizione di ciò che nella vita è pubblico, politico, personale,
intimo e privato.
Nonostante la grande unità di intenti circa la crucialità di
quella soglia il progetto di ripensare la dicotomia tra privato e
pubblico è stato inteso dalla critica femminista in accezioni diversificate. Come era avvenuto ai tempi della discussione sul
suffragio, quando le posizioni femminili si divisero lungo la linea di demarcazione eguaglianza-differenza che riproduceva
l’enfasi su opposte vocazioni, pubblica o privata, delle donne,
così la discussione si è spesso polarizzata secondo prospettive
che privilegiano l’una o l’altra dimensione. A parte le posizioni prettamente emancipazioniste, tese al mero allargamento alle donne della vita pubblica così com’è, si sono sviluppati, in
linea di massima, due grandi filoni di ricerca e due progetti teorici e politici: da un lato quello della “redenzione del privato”
e dell’accento sulle relazioni di cura o “materne” come modello cui ispirare il ripensamento del pubblico e del politico, e dall’altro quello che è ruotato attorno al ripensamento del concetto di cittadinanza .
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
Entrambe le aree di riflessione ormai datano anni di acceso
dibattito e i loro risultati riempiono scaffali, a testimonianza di
quanto ripensare il pubblico, il privato e il loro rapporto non sia
impresa che si possa compiere in modo semplicistico o riduttivo, né nelle teorie né nelle pratiche. Quella soglia è quella della
nostra stessa casa, e segna il passaggio fra dimensioni tra le quali noi stesse in carne e ossa passiamo quotidianamente, ma non
è detto possano trapassare l’una nell’altra. Come ha osservato
Carole Pateman, sebbene il femminismo stia tentando «per la
prima volta nel mondo occidentale» di costruire una teoria che
includa davvero uomini e donne, individuale e collettivo, vita
privata e vita politica invece di opporli e separarli:
Il femminismo guarda a un ordine sociale differenziato in cui le varie
dimensioni siano distinte ma non separate o opposte, e che si basi su
una concezione dell’individualità che includa sia gli uomini che le
donne come creature biologicamente differenziate, ma non ineguali.
Nondimeno, le donne e gli uomini, e il privato e il pubblico, non sono necessariamente in armonia. Date le implicazioni sociali delle capacità riproduttive femminili, è certamente utopico supporre che le
tensioni tra il personale e il politico, tra l’amore e la giustizia, tra l’individualità e la comunità spariscano con il liberalismo patriarcale .
La complessità rilevata da Pateman è un elemento cruciale anche
nella visione politica e teorica del pensiero del femminismo italiano e del pensiero della differenza. Certamente anche in Italia si
condivise l’idea del personale che è politico a partire dagli anni
Settanta. Con una variante significativa che segnalava una direzione peculiare rispetto al femminismo di matrice anglofona.
Penso alla frase che fu di Carla Lonzi «è già politica» che faceva intuire come nelle pratiche del femminismo italiano si delineasse fin da allora l’attenzione, addirittura evitando di nominare il tradizionale dualismo pubblico-privato, a tematizzare un’accezione di politica più grande e complessa di quella del cosiddetto politico (o della sfera della politica intesa come luogo della rappresentanza ecc.) mettendo in primo piano la politicità di dimensioni della vita, sia privata che pubblica, che quella politica
DIANA SARTORI
non era in grado di riconoscere né di riportare a sé. E sfuggendo
così alla tentazione di vedere il superamento del dualismo come
la vicenda di una progressiva inclusione delle dimensioni private
nel pubblico. Una tendenza che, tutto sommato, continuo a riconoscere anche in molte posizioni che, sottolineando lo sforzo per
il compimento della cittadinanza femminile in qualche modo, mi
sembrano suscettibili di riproporre la storia delle donne nella
chiave delle magnifiche sorti e progressive di un’entrata, di una
conquista, di un’inclusione nello spazio uniforme e ordinato della politica pubblica. È forse un giudizio ingeneroso, ma mi sento
di avanzarlo perché comunque avverto quanto sia ancora molto
forte la tendenza a immaginare il femminismo come la storia dell’inclusione, quando credo che l’anima della differenza politica
femminile sia stata piuttosto il contrario, ovvero l’interruzione
del processo inclusivo.
E vengo ora ad un secondo elemento della costellazione indicata in apertura, che contribuisce a complicare il quadro ma
anche a renderne più preciso il senso.
L’indicibile della pratica
Da questa breve ricognizione della dicotomia privato-pubblico
si ricava come sussista una sorta di percorso obbligato della libertà femminile che è disegnato da una concezione la quale pone come termine di misura la visibilità pubblica-politica, il mostrarsi, il rivelarsi, l’uscire dall’invisibilità del privato per dirsi,
significarsi apertamente ed esplicitamente. Un percorso tutto
costruito sul calco di una vicenda di liberazione maschile come
uscita dai vincoli di dipendenza, oscurità, seconda nascita, uscita dallo stato di minorità, venuta alla luce e così via nelle diverse varianti della grande metaforizzazione della nascita e della ripetizione della liberazione dal vincolo materno.
La riflessione femminile ha prodotto una radicale rottura di
questo modello, e si può dire che il femminismo sia sorto precisamente dalla resistenza ad essere cooptate in questo percorso di negazione della prima nascita, quale condizione per en
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
trare nell’orbita simbolica del paterno sole e per esserne illuminate di riconoscimento soggettivo.
Questa resistenza alla visibilità, all’uscita all’aperto e alla luce, per certi versi ha preso la forma di una specie di pudore femminile. È un fenomeno che, stante la moderna ingiunzione all’emancipazione secondo il modello suddetto, non è affatto facile leggere in chiave di libertà femminile e che tende a essere
ricondotto piuttosto ad un’interpretazione che vi vede il permanere di subalternità ai tradizionali divieti patriarcali e misogini, come dimostrano ancora una volta i dibattiti sul velo islamico e i paradossi che vi si manifestano.
Ma non occorre uscire dai confini della nostra tradizione
occidentale per incontrare difficoltà di questa natura relativamente al senso in cui inscrivere comportamenti femminili che
scartando per qualche aspetto dal modello della libertà moderna (intesa appunto come venuta alla luce dell’individualità
autonoma che rigetta da sé le brume di ogni autorità) appaiono come retaggi oscurantisti che gettano ombra sull’affermazione globale di quello che ad alcuni e alcune pare ancora il
compimento del progetto universale dell’Illuminismo . Basti
pensare alla lettura corrente che ricevono fenomeni quali la
scarsa presenza femminile nei meccanismi istituzionali della
rappresentanza politica o nei livelli dirigenziali delle carriere
lavorative, prevalentemente considerati esclusivamente indicatori di “ritardo” o di permanenza di pregiudizi e discriminazione sessista e di rado forse indici di una differente traiettoria di esercizio di libertà femminile che diserta quei luoghi
di manifestazione privilegiandone altri. Oppure, in un ambito
ancor più prossimo al tema del pudore, basta ricordare quanto le posizioni sulla pornografia di giuriste femministe come
Dworkin e MacKinnon abbiano scatenato accese polemiche
che rivelarono quanto la difesa della liberazione sessuale potesse risultare ambigua e contraddittoria per la libertà delle
donne, virando in una spinta alla mera disponibilità del corpo
femminile ad immettersi nel circuito del desiderio maschile .
Un fenomeno che peraltro non può non richiamare alla men
DIANA SARTORI
te quella sorta di profonda pulsione scopica per il corpo della
donna e il chiuso del suo segreto di vita che percorre le vicende della nostra tradizione conoscitiva e scientifica , e che già
da sé solo potrebbe offrire ottime ragioni ad un prudente pudore femminile.
La modalità di renitenza femminile al regime dell’esplicitazione e della visibilità su cui intendo soffermarmi ora è però di
altro tenore, e interseca un altro degli aspetti suggeriti alla riflessione da questo incontro: quello della pratica e della verità
pratica. C’è infatti un aspetto per cui tale resistenza si intreccia
strettamente ad un peculiare legame femminile con la dimensione pratica e di qui con la difficoltà di darle espressione nella
forma dell’esplicitazione .
Hannah Arendt, nel suo presentare quello che resta uno dei
più appassionati sforzi di fare spazio nella filosofia alla Vita activa, diceva che quel che si proponeva era molto semplice:
«niente di più che pensare a ciò che facciamo» . Come dimostra anche l’eccezionalità di quell’opera, si tratta però di un’impresa tutt’altro che facile. Infatti è non solo difficile, ma pressoché impossibile in linea di principio, dire quello che facciamo. Sconfortante, vien da pensare, ma lo si pensa per l’eredità
di una tradizione che ha messo al primo posto il sapere razionalizzabile, esplicitato e formalizzabile, secondarizzando la primarietà dell’esperienza pratica così che il sapere pratico pare
oscuro e incontrollabile. O lo si porta alla luce, così da poterlo
dominare, o può apparire persino minaccioso, al punto che la
tentazione è stata perlopiù quella di negargli lo stesso nome di
sapere.
Anche a prescindere da ogni genetico vizio riduzionistico di
tale eredità, tuttavia, dire, pensare la dimensione pratica è carico di difficoltà: il silenzio, l’invisibilità, la muta funzionalità sono infatti tratti connaturati a questo fondo pratico. Non a caso
Michael Polanyi lo denomina dimensione tacita . È proprio la
sua qualità di primarietà non solo a sottrarla alla piena visibilità, ma a collocarla in posizione seconda. Tutti gli elementi che
vi si associano, il senso comune, la valenza grammaticale, l’es
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
sere sottratta al dubbio ed indiscussa, l’accettazione fiduciaria
e d’autorità, l’andare da sé, l’imprescindibilità dell’esperienza
personale, tutti questi sono altrettanti caratteri che la rendono
tanto potente ed efficace quanto invisibile, anzi tanto potente
ed efficace in quanto invisibile. Il punto è che lo sfondo pratico funziona in quanto è funzionale. Alla conoscenza tacita è
quindi intrinseca una certa ineffabilità; essa non è completamente articolabile, né è possibile tradurla in un insieme esplicito definito di regole. In ciò stanno la sua forza ed efficacia, ma
anche la sua intrinseca fragilità, restando legata la sua sorte alla continuità dell’esercizio, vincolata alla trasmissione esemplare in presenza, e l’autorità del suo sapere rimanendo personale
e incarnata. Comprensibili, dunque, gli sforzi per ridurre e tradurre la dimensione tacita alla parola e alla norma, all’autorità
impersonale di un sapere neutro, aperto, oggettivo e oggettivato, che hanno costruito la nostra tradizione scientifica. Forse
meno comprensibili le tonalità epiche, emancipative e del genere «magnifiche sorti e progressive», che la storia del pensiero ha narrato come perenne battaglia con la dimensione tacita;
proprio su quello sfondo essa si è stagliata facendone insieme il
suo sostegno e il suo nemico.
Le voci che sono confluite in questo grandioso coro epico
sono state le più varie, ma davvero difficile è riconoscervi delle voci femminili. E ciò nonostante la storiografia femminista
abbia prodotto ormai una poderosa opera di auscultazione delle voci femminili che si siano levate a prendere soggettivamente la parola in questo raccontare: escluse rare eccezioni, le donne non hanno partecipato alla storia dei tentativi di dare
espressione esplicita, simbolica e codificata ai saperi maturati
e praticati nella storia della vita del genere umano. La domanda sul perché mai ciò sia avvenuto ha ricevuto in genere (anzi
in gender!) risposte che fanno leva sul concetto di esclusione,
il cosiddetto “paradigma dell’oppressione” . Pur non contestando l’influenza dei fattori oppressivi che hanno storicamente tolto alle donne gli strumenti materiali e simbolici necessari
all’espressione, ritengo che il “paradigma dell’oppressione”
DIANA SARTORI
come categoria interpretativa sia riduttivo, soffrendo di vari difetti, il primo dei quali è di sottovalutare la libertà femminile.
Non è possibile qui argomentare in merito; mi limito, rispetto
allo specifico punto che qui mi interessa, a dire che forse si può
migliorare quella risposta dicendo che le donne non sono state soggetto di quella storia perché ne sono state l’oggetto. Più
precisamente: non sono state dalla parte del soggetto di questo
sforzo di esplicitazione dell’oggetto costituito dal sapere pratico implicito, perché dal punto di vista di quella storia esse sono collocate dalla parte dell’oggetto laddove erano soggetti .
La tacita dimensione pratica è abitata da tutti, ma essa ha
delle abitatrici per eccellenza, le donne. Per antonomasia tutrici e coltivatrici di questa dimensione ne hanno fatto la loro
dimensione prima e privilegiata e raramente ne sono uscite.
Esse ne sono divenute come le custodi e le funzionarie. Ricordando il carattere funzionale della dimensione tacita, e la posizione simbolica tradizionale della donna come funzione, il
cerchio si chiude: le donne sono funzionarie della funzionalità. Numi tutelari del sapere sussidiario e funzionale, proprio
in quanto sussidiarie e funzionali. Basta sviluppare questa
equazione per ricavarne tutta una serie di trasformazioni delle quali la prima è che la dimensione tacita trova il suo perfetto corrispettivo nel silenzio femminile.
Come quella del paradigma dell’oppressione, questa spiegazione ha però un difetto: in questo incastro resta tagliata
fuori la libertà femminile. Si dimentica che in tale incastro le
donne hanno pur vissuto e agito la loro libertà, e si dimentica
che la dimensione pratica tacita sarà sì funzionale, ma funziona. Essa è efficace nello strutturare la realtà e il nostro agire
nel mondo, al punto da poter essere pensata e vissuta come autosufficiente, al contrario della dimensione dell’esplicitazione
codificata che non può vivere di vita propria; nel suo morto e
luminoso mondo è impossibile vivere esclusivamente senza il
sostegno oscuro della dimensione vivente tacita e pratica. È
infatti possibile in linea di principio vivere senza transitare la
soglia del detto e della regola, persino nel bel mezzo dei di
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
scorsi, dei codici e delle norme. In tante vite femminili si avverte questa possibilità di non uscire alla luce, come una propensione a un vivere senza nome né legge.
Una risposta a quella domanda deve quindi non trascurare
che in quell’assenza femminile dalla storia dell’espressione della dimensione pratica agiscono insieme elementi di necessità ed
elementi di libertà.
Guardando al primo ancor più che di oppressione si tratta
di un vero e proprio interdetto alla libertà femminile: per una
donna cercare di esprimere simbolicamente il proprio sapere
pratico significa togliersi insieme ad esso dalla sussidiarietà, affermare cioè la propria libertà trasgredendo il suo ruolo e quello della dimensione che custodisce. Se infatti c’è un limite intrinseco a esplicitarla, ciò è stato storicamente fatto dall’uomo
cui non è parso così facendo di violare alcunché della propria
libera soggettività, al contrario trovandovi la sua affermazione.
Guardando al secondo ordine di fattori, quelli legati alla libertà, il senso di quell’assenza rivela diffidenza, la reticenza e
addirittura la resistenza femminile all’esplicitazione, espressione, fissazione simbolica e normazione del sapere posseduto in
forma implicita e pratica. Perché mai?
Difficile comprenderne il senso, massimamente intenderlo
nel senso di una libertà e non di una costrizione, o di una forza e non di una debolezza. Tutto depone a sfavore. Qui avviene, con modalità forse ancor più evidenti, qualcosa di analogo
a quel che si è rilevato per il dualismo privato-pubblico e per
la coppia invisibile-visibile. L’ordine di priorità e la gerarchia
di valore che struttura il loro legame è tale da prescrivere una
traiettoria emancipativa di passaggio dall’uno all’altro la quale
si offre come via pressoché esclusiva di liberazione, con il paradossale risultato di incanalarla nel destino di una sorta di libertà coatta. Così diventa arduo persino concepire che libertà
si possa dare diversamente che da quella “naturale” e ovvia forma di sviluppo, difficile pensare che la via non sia il rendere visibile, il manifestarsi, il pubblicizzarsi-politicizzarsi, l’esprimersi apertamente ed esplicitamente, il dirsi, il significarsi.
DIANA SARTORI
Se sarebbe raccomandabile di per se stessa l’attenzione circa l’agire di questa sorta di vizio dello sguardo fissato sulla metaforica concettuale della luce , essa lo è massimamente quando la libertà di cui tratta è quella di un soggetto femminile. Le
traiettorie che questa ha percorso e percorre sovente sono tortuose e imprevedibili, persino difficili da riconoscere come tali
per uno sguardo educato a quel grado di sensibilità alla luce. Ricordo che quando presi a interrogarmi su quella resistenza femminile a immettersi sulla via della visibilità e dell’esplicitazione
mi parve come di violare un lontano insegnamento femminile:
mi immaginai una nonna che mi guardava con disappunto dicendo “ma allora non hai imparato proprio niente!”.
Avendo sempre tenuto in gran conto la saggezza delle nonne l’apparizione di quel fantasma mi suonò come un avvertimento: forse quella domanda celava un’insidia, forse stavo dimenticando o persino tradendo qualcosa. Un’eredità, un insegnamento? Quella domanda stessa rivelava un dubbio circa la
bontà della sua scelta di rifiuto ad uscire dalla dimensione tacita e di portarsi apertamente su quella del sapere esplicitato,
e tradiva la rottura di una sottesa consegna del silenzio. Così
quel temuto oscuro destino nonnesco prese ad apparirmi sotto tutt’altra, per quanto obliqua, luce, quella che prendeva i
contorni di una “strategia della nonna”. La nostra “nonna” lascia andare sulla scena della pubblica piazza il marito, pur essendo convinta che di fatto comanda lei. Lei si tiene stretta al
terreno primario della dimensione tacita, pratica, implicita, dove quotidianamente esercita la sua azione e la sua forza, e non
ritiene le convenga esplicitarla, fare altrimenti le pare forse futile, forse secondario, probabilmente rischioso. La nonna, matura e più esperta erede della più celebre servetta tracia , confida nella potenza della propria posizione, non ha sensi d’inferiorità e riderebbe di chi la descrivesse oppressa, fiduciosa in
entrambi i fattori che il paradigma dell’oppressione dimentica:
la libertà femminile e il fatto che la dimensione tacita funziona.
Lei diffida di tutto ciò che vuole dire, fissare, codificare, regolare, normare sia il mondo in cui vive che il suo sapere di que
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
sta vita. Forse per coscienza dei limiti e della parzialità della parola, della regola, della legge, di ogni formulazione univoca e
morta della concreta realtà vivente. Forse per la volontà di salvaguardare la propria libertà di agire di volta in volta giudicando puntualmente le situazioni nelle possibilità che offrono.
Lei non vuole legare le mani alla propria libertà, non vuole negarsi alcuna possibilità, e pare convinta che l’esplicitazione, la
parola, la significazione simbolica sempre taglino via qualcosa,
presumibilmente innanzitutto un taglio di questa libertà.
Insomma, un rigetto della parzialità, della limitatezza e della rigidità che comporta l’uscita dalla dimensione tacita verso la
determinatezza della parola esplicita. Un timore, anche, di venir limitata nella propria libertà e forza sotterranea. Timore legittimo se si fanno i conti con il potere, per quanto irriso, innegabilmente detenuto e rappresentato dagli uomini sulla scena
pubblica delle parole, delle norme e delle forme.
Come dar torto a questo timore, forse che non si è dimostrato storicamente ben fondato? Forse non si ricordano le
grandi energie maschili dedicate ad un’impresa di esplicitazione del sapere implicito che si è tradotta anche in un’impresa di
appropriazione e colonizzazione di saperi tradizionalmente
femminili?
Vista alla luce di questa valutazione della rischiosità di uno
scontro diretto sul terreno aperto che si è dimostrato più consono alle forze maschili, la nonna sembra condurre la sua silenziosa e discreta guerra secondo una condotta informata da una
saggezza lontana dalla logica eroica, visibile, volontaristica, centrata sul passaggio teoria-pratica e sul nesso mezzi-fini tipica
dell’impostazione con cui la nostra tradizione ha pensato l’agire. Quasi sembra seguire la più accorta tradizione strategica cinese, che raccomanda al saggio stratega di praticare una via di
forza efficace che “diventa manifesta senza doversi mostrare”,
che si mantiene invisibile palesandosi nei suoi effetti di trasformazione, trasformazioni silenziose estranee all’epica dove non
c’è nulla da raccontare, perché l’essenziale avviene non sulla
scena aperta dove le forze si individuano e si scontrano nel com
DIANA SARTORI
battimento, ma prima, a monte, nella dimensione invisibile delle condizioni che producono gli effetti . Mostrarsi, esporsi,
portarsi nello scontro diretto sono in questa logica altrettante
fonti di indebolimento e dimostrazioni di inefficacia, sono debolezza, non forza.
La contrarietà del fantasma della nonna è quindi ora comprensibile, tanto più che il dubbio sul suo tacito insegnamento investe anche il suo punto più critico, e cioè la trasmissione.
La sua forza e la sua debolezza sono le stesse della dimensione tacita: la potenza di strutturare grammaticalmente e implicitamente il mondo , ma la rischiosità connessa al fatto che
dipende dalla trasmissione d’autorità contigua, genealogica,
in presenza, dall’ininterrotta continuità dei passaggi . Una
donna che sollevi quel dubbio si sottrae a quell’autorità e la
mette a repentaglio. L’ostilità femminile alla significazione
esplicita ha anche questo segno di fedeltà, il rifiuto di desautorare la tradizione femminile, di minare imprudentemente il
canale di una trasmissione di forza tacita.
E il nome più adatto per la sapienza della nonna è appunto prudenza, un sapere prudenziale pratico che sarebbe ingenuo e pericoloso pretendere di ridurre ad un problema d’applicazione di un sistema esplicitato di regole generali, di norme
e di fattispecie. Non troppo ferrata in filosofia, più che invocare l’antica metis, la nonna, forte del suo tesoro di massime
prudenziali proverbiali, sentenzierebbe in merito con aria
sprezzante: “val più la pratica della grammatica!”. Incorrendo
nel pari disprezzo filosofico della sentenza kantiana che stigmatizza «la presunzione di veder più lontano e più sicuramente con occhi di talpa fissi nell’esperienza» .
A sentir Kant, dunque, il sapere della nonna, di cui ho cercato fin qui di comprendere la mutezza, sarebbe anche cieco!
La sua prospettiva sarebbe ristretta, il suo orizzonte limitato,
la sua vista miope, incapace di vedere lontano. Quella che ho
chiamato la sua strategia non meriterebbe questo nome, ma al
massimo quello di tattica, di opportunistica arte di arrangiarsi, di espediente. E la nonna altro non sarebbe se non una
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
“praticona” che si muove a tentoni e non riesce a sollevare gli
occhi all’altezza di una visione teorica più vasta e comprensiva, generale o universale, non riuscendo peraltro a sollevare
se stessa da una condizione di sudditanza alle più immediate
e prossime necessità. La pratica, insomma, lungi dall’essere,
come presume, autonoma, è seconda, bassa e servile. Alla teoria e alla grammatica è necessario in definitiva rivolgersi, e a
loro va tributato l’onore della priorità.
Come prendere le difese del sapere pratico e della strategia
della nonna dalla doppia accusa di essere seconde e subalterne
sia dal punto di vista dell’efficacia che da quello della libertà?
Una prima risposta è ricordare che la pratica è una grammatica. La rete di nervature delle pratiche struttura e orienta il mondo, e lo fa tanto più efficacemente in quanto agisce a monte, in
profondità, a livello grammaticale. Certo il carattere di funzionalità e sussidiarietà proprio della dimensione tacita pratica la
pone in quel regime di efficacia invisibile che non solo si presta
all’inversione tra primarietà e secondarietà, ma che anche sembra incapace di significarsi e determinarsi da sé dipendendo per
questo dall’operazione di focalizzazione che avviene nella significazione esplicita. La dimensione del sapere pratico sembra insomma vuota in quanto si tiene disponibile ad ogni significazione, e in quanto tale prende un aspetto subalterno e servile.
Ma ciò non corrisponde al vero, la pratica non è affatto aliena dalla significazione, né dalla capacità di dare regolazione di
senso al reale. Per il suo carattere grammaticale essa preordina
ogni significazione, opera il primo taglio di misura della realtà,
costituisce il primo riferimento su cui s’incardina ogni determinazione di significato. In essa poi si sedimenta la significazione
riuscita, che diventa senso comune, lo sfondo d’autorità dal quale si stagliano i successivi giudizi, e si formano le individuazioni.
Su questo sfondo si innesca la seconda questione, quella
della libertà. Se si pensa al rapporto che sia la dimensione tacita sia la strategia della nonna intrattengono con la tradizione e
la trasmissione del senso comune ricevuto, e non del senso libero, viene il sospetto che esse siano vincolate alla continua
DIANA SARTORI
conferma dell’ordine esistente. Sospetto grave per la primarietà della dimensione tacita, ma ancor più per la libertà della
nonna. Eppure la sua azione e la sua consegna, per come le ho
immaginate, sono nell’intenzione e sotto il segno della libertà:
quello della fedeltà ad un sapere che non si fissi in un sistema
codificato, che non si tramuti in norme e regole che predeterminino e vincolino l’agire, che non possa prescindere dall’esercizio del giudizio, che non diventi un morto meccanismo
che irrigidisce la fluidità del movimento della vita, che non dimentichi la particolarità delle situazioni e dei contesti in nome
dell’universalità, che non possa fare a meno delle persone in
carne ed ossa e delle loro relazioni .
Una strategia che ha di mira in primo luogo la salvaguardia
della libertà soggettiva, attenta a conservarla e a trasmetterla in
quanto tale. Con la cura di non condizionare la libertà, ma di
curare le condizioni perché libertà ci sia. Forse così facendo si
sacrifica l’epica arditezza dello sguardo che azzarda la significazione, e alza lo sguardo al cielo luminoso dell’universalità, della norma e della parola piena. Gli occhi di talpa fissi nell’esperienza non hanno questa fascinazione, ma forse in compenso
anche meno la subiscono ed evitano, oltre che di cadere ridicolmente nelle buche, di prendere molti degli abbagli che produce la pretesa di fissare lo sguardo nella luce piena.
La strategia della nonna, la sua resistenza a immettersi sulla
via maestra della visibilità, dell’esplicitazione, della rivendicazione del proprio ruolo pubblico appaiono come una forma di
consapevole pudore, ma non un pudore mosso dalla debolezza,
quanto dalla forza. Anche se da una forza difficile da riconoscere, così differente dalla forza che si impone esplicita e pretende il suo luogo in piena vista prendendo la sua misura dalla
visibilità. Una forza pudica forse perché accompagnata dall’amore per le relazioni, l’attenzione all’altro, forse per questo così esposta all’impudicizia e all’arroganza dell’altra.
È un’opzione carica di rischi, quasi fatale sul metro di valori tradizionale, dove il virilismo affermativo ha dettato legge.
Difficile trovare chi ne prenda le difese, anche se l’esistenza di
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
questa strana forma di pudore della forza non è passata inosservata. Adorno ad esempio rileva qualcosa di simile quando osserva come esista una sorta di legge del “tatto” o “riguardo” che
condanna chi la rispetta e trascina in basso sempre più in basso i
rapporti umani privati:
chi nel corso della conversazione, parla sulla testa anche di uno solo degli altri, appare senza tatto. Per amore dell’umanità, il colloquio
si restringe ai temi più prossimi, più stupidi e più banali: basta che
sia presente un solo inumano. [...] Il giuramento di attenersi al positivo opera come la forza di gravità che trascina tutti in basso. Essa
si mostra superiore all’impulso che resiste, in quanto si rifiuta di entrare in trattative con quest’ultimo. Il più differenziato, che non vuole soccombere, resta strettamente obbligato al riguardo verso tutti i
privi di riguardo .
Il pudore nell’esibire, manifestare, far valere la propria forza ha
insomma il paradossale effetto di rischiare di volgersi in debolezza nel confronto con la forza esercitata senza pudore. Un fenomeno ben noto alle filosofe del linguaggio e alle linguiste che
hanno posto attenzione ai differenziati registri comunicativi che
tendono ad assumere i due sessi in una conversazione , rilevando come alla propensione assertiva maschile (che si esprime
in forza enunciativa autoaffermativa tesa a far valere prioritariamente le proprie ragioni circa l’oggetto in discussione) corrisponda un’attitudine femminile a salvaguardare in primo luogo
la relazione di comunicazione rispetto al suo oggetto con l’effetto di indebolirne la forza di enunciazione.
Con ciò non intendo certo avanzare la tesi che esista una sorta di “legge della forza inversa del pudore” che vada a spiegare
la posizione di debolezza femminile sul piano della visibilità o
della forza sociale! Solo segnalare come tale posizione possa apparire in tutt’altra luce assumendo una prospettiva diversa da
quella del cosiddetto “paradigma dell’oppressione” che assegna
in toto all’agire del patriarcato, o del “fallologocentrismo”, la responsabilità di tale posizione. Quella responsabilità esiste, indubbiamente, ma quella prospettiva ha l’effetto niente affatto se
DIANA SARTORI
condario di collocare completamente fuori dal campo visivo la
libertà femminile. La visione che ne risulta è, questa sì, miope e
menomata, e ciò proprio nel momento, il nostro presente, in cui
sta avvenendo un mutamento, la fine del patriarcato, che registra il dissolversi dei contorni stessi dell’orizzonte entro cui si era
disegnata quella che ho chiamato “strategia della nonna” .
In questa trasformazione l’equilibrio di rapporti tra visibile
e invisibile, tacito ed esplicito, pratica e “grammatica”, tra ciò
che sta sullo sfondo e ciò che sta in primo piano, proprio ciò su
cui verteva la strategia della nonna, si sta ridefinendo, esattamente come si stanno ridefinendo i rapporti tra gli uomini e le
donne. Non sono certo in grado di dire quale nuovo equilibrio
ne possa sortire, so che vorrei quello che sicuramente stava a
cuore anche a lei: forza efficace e libertà. E quel che mi pare di
aver imparato da lei è che per mantenerle e trasmetterle occorre avere cura delle condizioni che ne consentono la vita e l’esercizio. Avendo ereditato, nonostante i dubbi, l’avvertimento
circa i rischi che la brama della parola pienamente esplicitata e
della normazione comportano, sono propensa a pensare che la
prima di queste condizioni sia che il cambiamento del rapporto tra visibile e tacito non venga inteso come semplice passaggio della dimensione tacita pratica alla forma esplicita del sapere. Questo non è possibile fortunatamente, ma non è nemmeno
auspicabile. Si può, anzi si deve, dare valore alla dimensione del
sapere dell’esperienza, pensarla, farne discorso, riconoscerla e
dargli forza e autorità, ma non ci si può illudere di tradurla completamente nelle formule delle forme oggettivate di conoscenza. Possiamo (per riprendere il “semplice” proposito di Arendt)
pensare ciò che facciamo, non ridurlo al pensiero. Possiamo fare di un sapere misconosciuto un sapere riconosciuto, questo
non vuol dire che esso diventi completamente “conosciuto” e
dominato, il venire alla luce di qualcosa tenuto in ombra. Piuttosto far sì che quella zona d’ombra, quella dimensione tacita
pratica entri con tutto ciò che in essa non sarà mai piena visibilità, pensiero e significazione simbolica codificata in un circolo
con il pensiero e il simbolico.
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
Tra visibile e invisibile
Al termine di questo itinerario che si proponeva di mettere il tema del pudore sotto il segno della costellazione disegnata dai
rapporti polari visibile-invisibile, pubblico-privato, dicibile-indicibile, concludo tornando alla questione iniziale del pudore
come virtù femminile.
È stata una virtù femminile per eccellenza, sì, una virtù imposta e coatta che è stata segno di non libertà, certamente. Per
questo motivo è esistita una certa spudoratezza del femminismo: le brave ragazze vanno in paradiso e le cattive ragazze vanno dappertutto, diceva un vecchio slogan. Le donne hanno infranto i confini del pudore, ed è stato un bene. Tuttavia ciò non
significa che la via della libertà femminile sia tutta segnata entro la traiettoria del percorso che porta al venire all’aperto, alla visibilità, alla dicibilità piena. C’è una coazione altrettanto
forte nella prescrizione di questo percorso, una brama di visibilità e di esplicitazione che ordina l’inclusione, e che sento in
grande misura come una richiesta più maschile che femminile.
Una richiesta di visibilità che è anche richiesta di disponibilità
e omologazione, e nella quale non posso fare a meno di avvertire una minaccia. Qualcosa che minaccia di togliere una differenza, come una luce che voglia penetrare a togliere e violare
ogni ombra, ogni riparo. Senza rispetto, senza pudore. In
omaggio ad una logica della visione piena, della piena luce
diurna, di un aperto che è sfacciato, impudico e arrogante. Di
una priorità di ciò che è visibile e disponibile e che in quanto
tale è a nostra disposizione, sotto l’egida di una modernità davvero “illuminista” viziata di brama di controllo e di narcisismo.
Nell’ultimo libro di Diotima, intitolato Approfittare dell’assenza , abbiamo affrontato il tema dell’assenza femminile dalla storia e dalla tradizione, interrogandoci sul suo senso, e sulla
richiesta di presenza e inclusione che sembra tanto scontata, e
che rende spesso tanto imperscrutabili certi comportamenti
femminili che vi resistono.
DIANA SARTORI
Darci una risposta alla domanda circa quell’assenza ha comportato un mutamento profondo, quanto difficile, nel guardare
alla storia delle donne, a seguito del quale abbiamo portato l’attenzione sul fenomeno, che è diventato una sorta di chiave per
aprirne la comprensione, la postura dell’intermittenza.
Abbiamo osservato come la presenza femminile sia stata simile ad un fiume carsico, che appare e si inabissa, per poi riapparire. E invece di guardare a questa intermittente visibilità e invisibilità come segno di una carenza da colmare, per rendere
stabile e visibile la presenza delle donne nella storia inscrivendola in una tradizione esplicitata, abbiamo cominciato a pensarla sotto il segno di una storicità originale: quella di una presenza che non ha bisogno di rendersi visibile per essere, che non
ha brama di durare, di mostrarsi. Qualcosa che ha il suo cuore
in quella forza di cui sono testimoni, come riporta Luisa Muraro nell’introduzione, le Madres di Plaza de Mayo. Interrogata
sul futuro della loro attività Ebe De Bonafini, una delle iniziatrici di quell’esperienza, dice che il gruppo delle Madres non è
affatto preoccupato del futuro, di darsi una durata, una forma
di permanenza, una continuità perché per loro, che da quasi
trent’anni ogni giovedì sono a Plaza de Mayo, «ogni giorno è
l’unico e il migliore».
Si percepisce qui una fiducia che è quella forse necessaria
nel guardare al passato della libertà femminile, come al suo presente e al suo futuro, che non si basa sulla necessaria iscrizione
in una tradizione o in un’eredità pacificamente e continuamente trasmissibile. Un esserci che scommette e fida sul desiderio
di libertà e sulla forza della libertà stessa di trovare i suoi passaggi e le sue imprevedibili e sempre eccedenti manifestazioni.
È una fiducia nella libertà che può accompagnarsi al pudore, che non deve per forza prendere la via della disponibilità alla visibilità. Quella fiducia e apertura a riconoscere le vie impreviste della libertà che forse sarebbe raccomandabile nel guardare a quel che ci mostrano le donne velate, al di là di quello che
noi dalla nostra posizione e dalla nostra storia vediamo in loro,
lo sguardo di una libertà che non necessariamente imbocca la via
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
dell’emancipazione, che pratica altri sentieri non sempre per noi
così visibili e che forse può aprire varchi imprevedibili, anche
per noi, tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile.
Guardando a questo presente lontano come al nostro lontano passato si può intravedere una diversa dimensione, quella
dove pratiche, vite, relazioni femminili si sono collocate sulla
soglia tra chiuso e aperto, privato e pubblico, visibile e invisibile, attraversandola, rompendola e spostandola.
È proprio su quella frontiera mobile che Chiara Zamboni riconosce scaturire quella strana luce che irradia dalla scintilla
dell’immaginazione creativa femminile in quelli che chiama i
momenti radianti nella storia delle donne, come l’esperienza
delle beghine, o quello delle preziose, ma molti altri:
Come agisce l’immaginazione creativa femminile in questi momenti radianti? Li si riconosce rispetto ad altri perché in essi le donne
hanno la capacità di inventare pratiche che aggirano, mettono in
scacco, spiazzano la distinzione tra sfera privata e sfera pubblica.
Trovano uno stile, un modo di fare che non è solo privato né solo
pubblico, ma si colloca ad un altro registro, tanto da cambiare i termini della questione. E questo non facendo teoria politica, ma
agendo. L’immaginazione creativa permette loro di rimanere fedeli alla propria esperienza, sottraendola alle forme storiche di alienazione. Ciò in genere provoca a lungo andare le istituzioni del
tempo ad intervenire per ristabilire i confini precisi di ciò che è
pubblico. [...] Ha ragione dunque Hannah Arendt a definire in Vita activa l’importanza della distinzione tra pubblico e privato, perché questa separazione caratterizza gran parte della storia maschile, che ha segnato simbolicamente anche la vita delle donne. È anche vero però che i momenti radianti della storia delle donne sono
proprio quelli nei quali questa distinzione è aggirata .
La peculiare qualità radiante di questi momenti epifanici di libertà femminile non sta quindi in un semplice manifestarsi, nella venuta alla luce di ciò che era nascosto: essi aprono passaggi
che lasciano passare la luce, e anzi fanno luce, ma continuano a
trattenere la relazione con ciò che sta nel riserbo dell’ombra,
non sgominandola nel trionfo duraturo e imperante della luce.
DIANA SARTORI
La loro dimensione è più simile a quella della sottile linea di
un chiaroscuro mutevole dove si dà passaggio tra visibile e invisibile, e il loro tempo può scintillare nell’impermanenza, intermittente. Con il pudore di non consegnarsi all’impero della
luce meridiana, e men che mai alla presunzione del suo pieno
trionfo. Il tempo dell’Aurora, lo chiamerebbe María Zambrano:
A differenza del regno dell’Aurora, quando il sole appare, – l’astro
unico, il poderoso, potente e decisivo –, appare con lui il suo regno,
il regno del potere. Il potere che quando cessa di essere aurorale si
converte in imperativo, in imperante, nell’unico, senza curarsi di stabilire i prolegomeni, i fondamenti di questo suo regno unico; senza
mai voltarsi indietro a contemplare la propria apparizione o la propria
nascita. Si direbbe che il sole è, senza essere nato. [...] Solo nella penombra si annida, anche per il sole stesso, la liberazione da questo suo
regno, in cui rimane, esso stesso, prigioniero del proprio potere .
Note
. Dalla circostanza che il pudore sia “virtù muliebre” parte la riflessione di Monique Selz nel suo Il pudore. Un luogo di libertà, Einaudi, Torino
, che ho letto solo dopo aver completato questo scritto, trovandovi peraltro non pochi punti di convergenza.
. A. Dal Lago, P. A. Rovatti, Elogio del pudore. Per un pensiero debole,
Feltrinelli, Milano .
. Con l’espressione di Mary Daly, in Al di là di Dio Padre, Editori Riuniti, Roma .
. Il dibattito sull’uso del velo islamico è acceso e vasto, spesso ha costituito il punto critico delle varie posizioni avanzate nell’ambito della discussione sui temi della tolleranza e del multiculturalismo. Senza inoltrarmi nella bibliografia in merito mi limito a segnalare due testi che negli ultimi anni
hanno sollevato molte polemiche: Fadwa El Guindi, Veil: Modesty, Privacy
and Resistance, Berg, New York , e Parvin Darabi, Romin P. Thomson,
Rage Against the Veil, Prometheus Books, Amherst .
. P. A. Rovatti, Il declino della luce, Marietti, Genova ; J. Derrida, La
mitologia bianca. La metafora nel testo filosofico, in G. Conte (a cura di), Metafora, Feltrinelli, Milano . Derrida riflette estesamente sull’immagine del
velo in relazione alla differenza sessuale a partire dal racconto Sapere di Hélène Cixous (Hélène Cixous, Jacques Derrida, Veli, Alinea, Firenze ).
. Nonostante la fortunata espressione sia ancora di Derrida, rispetto a
ciò il riferimento primario è il pensiero di Luce Irigaray, specie per l’analisi
del tema della visibilità, in Speculum, Feltrinelli, Milano .
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
. Carole Pateman, Feminist Critiques of the Public-Private Dichotomy,
in S. I. Benn, G. F. Gauss (eds.), Public and Private in Social Life, Croom
Helm, Kent , p. (ora ristampato anche nella raccolta di saggi di Carole Pateman, The Disorder of Women, Democracy, Feminism and Political
Theory, Polity Press, Cambridge ). Per una ricognizione più dettagliata
dell’argomento mi permetto di rimandare al mio Donne e uomini tra pubblico e privato, in “Annali di studi religiosi”, , , pp. -.
. L’espressione «sfere separate» è tipica della discussione sul suffragio
femminile, su cui cfr. Rosalind Rosenberg, Beyond Separate Spheres: Intellectual Roots of Modern Feminism, Yale University Press, New Haven .
. Hannah Arendt esprime al massimo grado la deprivazione di vita
pubblica connessa al “privato” in Vita activa. È questo il principale motivo
della difficoltà per le filosofe politiche femministe di rapportarsi proficuamente al pensiero di Arendt, accusata di mutuare una visione mascolina
della vita politica. È questo il giudizio di Hanna Pitkin, Justice. On Relating
Private and Public, in “Political Theory”, , , pp. -. Sulla questione cfr. Bonnie Honig (ed.), Feminist Interpretations of Hannah Arendt,
Pennsylvania State Press, University Park .
. Posizioni significative del femminismo della seconda fase su questi temi sono ad esempio quelle di Betty Friedan, La mistica della femminilità, Comunità, Milano ; Shulamith Firestone, La dialettica dei sessi, Guaraldi, Firenze ; Ketty Millet, La politica del sesso, Bompiani, Milano ; Michelle Z. Rosaldo, Woman, Culture and Society: A Theoretical Overview, in Michelle Z. Rosaldo, Louise Lamphere (eds.), Woman, Culture and Society,
Stanford University Press, Stanford .
. Susan Okin nel suo Justice, Gender, and the Family (Basic Books, New
York ), riprendendo il significato dell’affermazione «il personale è politico», si chiede «in quali modi il personale è politico e il politico è personale?». Okin individua quattro principali modi: . quel che avviene nella vita
privata e domestica non è immune da dinamiche di potere; . le decisioni politiche influenzano la sfera privata e familiare; . è nella vita domestica che avviene la socializzazione; . la divisione del lavoro nella sfera domestica produce conseguenze in altre sfere.
. Sul rapporto pubblico-privato cfr. Carol C. Gould, Private Rights and
Public Virtues: Women, the Family, and Democracy; Linda J. Nicholson, Feminist Theory: The Private and the Public, entrambi in Carol C. Gould (ed.),
Beyond Domination: New Perspectives on Women and Philosophy, Rowman
& Allanheld, Totowa ; Susan M. Okin, Gender, the Public and the Private, in D. Held (ed.), Political Theory Today, Polity Press, Cambridge ;
Jean Bethke Elshtain, Public Man, Private Woman. Women in Western Political Thought, Princeton University Press, Princeton ; Anne Showstack
Sassoon (ed.), Women and the State: The Shifting Boundaries of Public and
Private, Routledge, London ; J. Siltanen, M. Stanworth (eds.), Women
and the Public Sphere. A Critique of Sociology and Politics, Hutchinson, London-Sydney .
DIANA SARTORI
. Christopher Lasch ha parlato di un «rifugio in un mondo senza cuore» (Haven in a Heartless World. The Family Besieged, Basic, New York ).
. Pudore contro cui peccavano, comunque, anche quegli uomini che in
pubblico si lasciassero andare a manifestare qualsivoglia tratto che potesse ricordare il legame a quella sfera intima e femminile.
. Per un quadro della lunga discussione sulla cittadinanza femminile
cfr. Citizenship in Feminism: Identity, Action and Locale, in “Hypatia”, special issue, Fall ; R. Lister, Citizenship. Feminist Perspectives, New York
University Press, New York ; Ursula Vogel, Michael Moran (eds.), The
Frontiers of Citizenship, Macmillan, London . In Italia cfr. Gabriella Bonacchi, Angela Groppi (a cura di), Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne, Laterza, Roma-Bari .
. Pateman, Feminist Critiques of the Public-Private Dichotomy, cit., p. .
. Carla Lonzi, Maria Grazia Chinese, È già politica, Rivolta Femminile, Milano .
. Naturalmente quando da quei confini si esce i problemi si fanno ancor più acuti, come non hanno mancato di rilevare le esponenti del cosiddetto
pensiero postcoloniale, in particolare Gayatry Chakravorty Spivak nel suo
Critica della ragione postcoloniale, Meltemi, Roma .
. Per le posizioni delle due giuriste sulla pornografia: Andrea Dworkin,
Pornography: Men Possessing Women, Putnam, New York ; Andrea
Dworkin, Catharine MacKinnon, Pornography & Civil Rights: A New Day for
Women’s Equality, Organizing Against Pornography, Minneapolis .
. Nel senso di sottolineare come comportamenti femminili a prima vista indotti da ingiunzione patriarcale possano avere una lettura in chiave di
salvaguardia del desiderio femminile non subalterno a quello maschile, anche la difesa della verginità fatta da Irigaray.
. Gran parte della riflessione epistemologica femminista, specie quella che si è concentrata di recente sul tema delle tecnologie riproduttive, concorda su questa ricerca di portare nella visibilità e sotto controllo il corpo
femminile, a fare, per riprendere il titolo di Barbara Duden, del corpo femminile un “luogo pubblico”. Tuttavia una delle letture più incisive in questo
senso è stata data da un uomo. Cfr. D. Noble, Un mondo senza donne. La
cultura maschile della chiesa e la scienza occidentale, Bollati Boringhieri, Torino .
. La parte che segue riprende in forma sintetica il mio «colla presunzione di veder più lontano e più sicuramente con occhi di talpa fissi nell’esperienza», in Diotima, Il profumo della maestra, Liguori, Napoli .
. Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano , p. .
. M. Polanyi, La conoscenza personale. Verso una filosofia post-critica,
Rusconi, Milano , e Id., La dimensione tacita, Armando, Roma .
. Sebbene molte l’abbiano ripresa, la definizione è stata avanzata criticamente da Gerda Lerner, The Majority Finds its Past. Placing Women in History, Oxford University Press, New York . La questione riguarda in ge-
LA PRATICA FEMMINILE TRA VISIBILE E INVISIBILE
nerale le categorie con le quali va approcciata la storia delle donne, ed è stata in questo ambito poi ampiamente dibattuta.
. Si potrebbero ricordare le tante letture che sono state date della tradizionale posizione simbolica della donna che la mettono dal lato della natura-materia e nel luogo dell’oggetto e non del soggetto, ma qui il significato di
ciò che intendo è più circoscritto e in parte dissonante. Non nego il senso dell’individuazione della proporzione simbolica “uomo : soggetto = donna : oggetto”, ma dire che nel caso dell’assenza della voce femminile nel dare espressione alla dimensione tacita ciò va compreso tenendo presente che qui le donne si collocano dalla parte dell’oggetto in quanto attivamente soggetti di tale
dimensione.
. Sull’idea di metafora concettuale fondamentale il progetto intrapreso da G. Lakoff e M. Johnson a partire da: Metafora e vita quotidiana, L’Espresso, Roma e Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and Its
Challenge to Western Thought, Basic Books, New York .
. Sulla famosa servetta: Adriana Cavarero, Nonostante Platone, Editori Riuniti, Roma , e H. Blumenberg, Il riso della donna di Tracia. Una preistoria della teoria, Il Mulino, Bologna .
. Su questo ho trovato illuminante il saggio di F. Jullien, Trattato dell’efficacia, Einaudi, Torino , che mette a confronto le tradizioni di pensiero strategico europeo e orientale, in particolare cinese.
. Si potrebbe dire che in ciò la dimensione tacita è la rivale del “simbolico”, e questo perché è già simbolica.
. Da questo punto di vista si tratta di una predilezione che ha strettamente a che fare con quella individuata da Luisa Muraro per il metonimico
rispetto al metaforico in Maglia o uncinetto, Feltrinelli, Milano .
. Il celebre saggio di Kant da cui è tratta la citazione si intitola infatti
Sopra il detto comune: «Questo può esser giusto in teoria, ma non vale per
la pratica» (in Scritti di filosofia politica, La Nuova Italia, Firenze ).
. Un buon esempio di fedeltà a questa strategia si può trovare nel dibattito che ha coinvolto molte teoriche che (pure con diverse posizioni) si rifanno all’etica della cura nella difesa di una posizione contestualistica di contro ad una razionalistica e universalistica nell’ambito della riflessione etica.
. T. Adorno, Minima moralia, Einaudi, Torino , § .
. Fra i tanti studi: Patrizia Violi, L’infinito singolare. Considerazioni sulle differenze sessuali nel linguaggio, Essedue, Verona , e Luce Irigaray,
Parlare non è mai neutro, Editori Riuniti, Roma .
. La riflessione sulla fine del patriarcato fu avanzata in È accaduto non
per caso, in “Sottosopra Rosso”, gennaio , ma da allora molti sono stati i
contributi che hanno rilevato questo profondo cambiamento.
. Diotima, Approfittare dell’assenza. Punti di avvistamento sulla tradizione, Liguori, Napoli .
. Chiara Zamboni, Momenti radianti, in Diotima, Approfittare dell’assenza, cit., p. .
. María Zambrano, Dell’aurora, Marietti, Genova , pp. -.
Il mare senza pudore.
A proposito di un epigramma funerario
del VII secolo a.C.
di Marcello La Matina
A Salvatore Nicosia,
autentico «letztes, sehendes Gesicht»
Ho ascoltato con molto interesse le relazioni presentate in questa Giornata di studio . Esse hanno posto l’accento su ciò che
solitamente le culture e le persone tendono a nascondere: ossia
le forme e i sensi del pudore. Due costanti mi sembra siano
emerse da questo scavo; da una parte il pudore è onninamente
presente come un comportamento legato alla pressione sociale: è dunque un fenomeno storico o se non altro antropologico. Dall’altra, almeno in casi paradigmatici, esso pare custodire un contenuto di verità che travalica gli obiettivi di coesione
e di sopravvivenza del gruppo o della comunità entro i quali è
codificato.
Attribuisco un significato particolare al testo letto da
Franco Biasutti (cfr. supra, pp. -), che ha tracciato un’introduzione storica e filosofica al tema. Egli si è giustamente
concentrato sulla voce greca aidòs (aijdwv", lat. pudor), cioè
“pudore, vergogna”, notando come essa si trovi ad essere assente nei lessici filosofici, mentre viene comunemente ospitata nei dizionari teologici e scritturistici. Biasutti ha messo in
connessione la nozione di aidòs con il tema della giustizia, come appare nelle Leggi di Platone; ma ha anche evidenziato il
legame che quest’ultima nozione intrattiene con la nozione di
techne, rileggendo in modo stimolante il mito di Prometeo ed
Epimeteo narrato da Platone nel Protagora. Anche l’approccio ad Aristotele mi è parso interessante poiché rendeva evidente il legame fra aidòs e phobos. Entrambi sono pathē capaci di manifestarsi in una declinazione cromatica del volto. La
paura che “sbianca”, e il pudore che “fa arrossire” (erythrià)
MARCELLO LA MATINA
il volto entrano di diritto nel campo delle figure retoriche e
delle immagini letterarie d’ogni tempo. Assai rilevante, infine,
anche il riferimento all’analisi hegeliana del racconto sul peccato originale (Genesi, ), in cui il concetto di pudore viene
esaminato di conserva con quello di hamartìa o colpa.
Tuttavia, se l’ambito dell’aidòs risulta ora ben illuminato,
che ne è – mi chiedevo mentre Biasutti parlava – del suo antonimo, per esempio della spudoratezza? In greco antico esiste il
concetto di anàideia, o «mancanza di pudore», ed esiste un aggettivo, anaidès, “spudorato”, che è ben diffuso già a partire
dall’epica arcaica. Anche rimanendo nell’ambito della poesia,
numerosi sono i testi in cui è menzionato qualcosa o qualcuno
“senza pudore”. Troviamo sia aidòs sia anaidès già in Omero,
dove, ad esempio, il verbo aidèomai, “mi vergogno”, funziona
addirittura come «connotatore di civiltà» (cfr. Dodds, , pp.
e ss.). Gli antropologi suddividono infatti le civiltà ad oralità primaria in due gruppi. Essi chiamano “civiltà della vergogna” quelle nelle quali il comportamento “impuro” è sanzionabile ai soli occhi dei membri conspecifici: quindi, diremmo,
orizzontalmente. “Civiltà della colpa” sono dette al contrario
quelle nelle quali una condotta “impudica” è tale perché viola
una norma “verticale” o offende una divinità.
Come la nozione di aidòs, così pure quella di anaidès è pervasiva nella cultura arcaico-classica, potendosi ritrovare sia
nella sfera sessuale sia in ambito militare, sia nella comunicazione intima sia nel discorso politico. Non è questa la sede per
tracciare una fenomenologia della “spudoratezza” nella civiltà
ellenica. E forse non è nemmeno utile. Ciò che invece mi pare
intrigante è il contenuto di un epigramma greco arcaico costituito da un esametro, dove questo aggettivo compare riferito
a pòntos, “mare”. Vorrei quindi, come prima cosa, presentare
e discutere l’espressione pòntos anaidès, “mare senza ritegno”.
Vorrei poi richiamare alla vostra attenzione una famosa storia
dove si narra ciò che accadde ad un sovrano lidio che violò il
pudore coniugale. Il primo testo è una epigrafe funeraria di un
solo esametro risalente al VII secolo a.C. Essa documenta la
IL MARE SENZA PUDORE
più antica attestazione di anaidès fuori dall’epica; ed è interessante anche perché non è un epigramma letterario, ossia un
Buchepigramm, ma uno Steinepigramm, un autentico epitaffio
scritto su pietra per un autentico defunto. Il secondo testo è la
cosiddetta storia della “moglie di Candaule”, un mythos reperibile in Erodoto (I -). Questi due testi abitano da lungo
tempo la mia mente, e spesso si sono presentati insieme al ricordo, come fossero convocati da qualche parentela confusa e
inafferrabile. Rileggendoli davanti a voi, spero di approdare a
qualche idea meno offuscata, se non proprio chiara del tutto
e distinta.
Un frammento di stele calcarea proveniente da Corinto e datato approssimativamente all’anno a.C. conserva il seguente
esametro :
D ‡einiva tovde sa`ma, to;n w[lese povnto" ajnaidhv".
Di Dveinias è questa tomba, ucciso da un mare senza ritegno.
L’epigramma menziona la causa della morte di Dveinias. È il mare ad averlo ucciso. Ma perché il mare sarebbe anaidès, cioè spudorato? L’epigrafe non lo dice. Sicché occorre cercare una spiegazione altrove. Prima che in questo passo, anaidès compare sia
nell’Iliade sia nell’Odissea: potrebbe l’espressione “ucciso da un
mare spudorato” essere stata mutuata da qualche passo dei poemi di Omero? In Iliade I è Achille ad usare l’espressione per
riferirsi ad Agamennone, suo avversario nella spartizione del bottino e del prestigio militare (vv. -). In Iliade V “spudorato” è detto Kydoimòs, personificazione della mischia tumultuosa
di una battaglia. In questi due casi, come in altri passi dell’Odissea, l’aggettivo è riferito alla sfera antropomorfa .
Più interessanti ai nostri fini appaiono un paio di luoghi
dell’Iliade e uno dell’Odissea, dove, piuttosto sorprendentemente, l’attributo “spudorato”, “senza ritegno” è predicato di
MARCELLO LA MATINA
una pietra o roccia, cioè di un’entità sprovvista di intenzionalità e fors’anche di caratteri antropomorfi. In Iliade IV, nel pieno di un combattimento la morte coglie l’eroe Diore figlio di
Amarinceo: «Da una pietra scheggiata fu raggiunto al tallone,
/ Alla coscia destra; a lanciarla era stato il capo dei Traci, / Pìroo, il figlio d’Imbrase, che da Eno era giunto; / Entrambi i tendini gli recise, e le ossa la pietra svergognata (la`a" ajnaidh;") /
Fracassò d’un colpo; e quello supino nella polvere / Cadde,
con ambo le mani cercando i suoi compagni» (vv. -). La
stessa formula (la`a" ajnaidh;"), in identica sede metrica, si ritrova in Odissea XI , dove la pietra spudorata è quella del mitico Sisifo, condannato nell’Ade a spingere su per un colle un
masso gigante che sempre verso la cima gli sfugge rotolando
verso il pendio e vanificando il suo sforzo. Odisseo lo incontra
nell’episodio della Nevkuia, il regno delle ombre, mentre al colmo della tensione «la rupe in alto spingeva, sul colle; ma quando era sul punto / Di sovrastare la vetta, lì lo travolgeva forza
gagliarda: / Quindi, di nuovo giù al piano rotolava la pietra
spudorata. / Ma quello ancora cercava di spingere; e colava sudore / Dalle membra, e polvere dal capo si levava» (vv. ). Anche in Iliade XIII , è detta anaidès una pietra. Questa volta, però, l’immagine è usata nel co-testo di una similitudine, dove il piombare improvviso di Ettore sui nemici è assimilato al rovinoso rotolare di una roccia che cade per salti dall’alto «frantumando con pioggia infinita il sostegno della pietra impudica (ajnaidevo" e[cmata pevtrh")».
Ora, se escludiamo i casi in cui la spudoratezza venga attribuita al comportamento di un agente umano o antropomorfo , rimane un piccolo gruppo di testimonianze nelle quali l’assenza-di-pudore viene attribuita ad oggetti privi di intenzionalità e non antropomorfi: in Omero la pietra ridotta in
frammenti (che riduce in frammenti) è sfrontata; nel nostro
esametro è sfrontato il mare, che ha inghiottito il corpo di
Dveinias. Il lessicografo greco Esichio, che scrive però molto
più tardi, conosce un uso metaforico dell’aggettivo, che non
spiega però il senso letterale. In un lemma del suo lessico (s.v.
IL MARE SENZA PUDORE
bavbax) lo stesso Esichio accosta l’aggettivo anaidès a forme
come màtaios (vano), làlos e fl™aros (chiacchierone, fanfarone). E sebbene in altri luoghi della sua opera egli documenti
l’applicazione dell’attributo anaidès anche al mondo animale
– in particolare al cane e alla mosca insolente –, nulla finora ci
aiuta a capire cosa renda anaidès un oggetto solido come la
pietra o un oggetto sparpagliato come il mare. Anche altri testi, che qui non alleghiamo, non si discostano dagli usi fin qui
presentati.
Ancorché frammentarie e certo insufficienti, queste testimonianze ricalcano il campo semantico presente nelle attestazioni omeriche: per un verso si dà spudoratezza in agenti
antropomorfi o in prerogative di essi; per un altro verso sono
spudorati alcuni oggetti o entità solo indirettamente collegabili all’ambito antropomorfo. Naturalmente i greci pensavano anche in termini di prosopopea: Thanatos, la morte, è a
volte personificato. Ed anche Pòntos, il mare, assume, in alcuni testi, un carattere affine, per mutevolezza, a quello di un
individuo. Ma la pietra, perché è anaidès? D’altra parte, sappiamo che esistette in Atene una livqo" ajnaideiva", una “pietra della sfrontatezza”, che era il luogo dell’Areopago dove si
collocava la tribuna della pubblica accusa. Ma c’entra questa
pietra con le altre? E con il mare che si portò Dveinias? A me
pare che le attestazioni più antiche riferite alla “pietra senza
vergogna” siano estranee al tribunale ateniese. Ancor più lontano mi pare, e per collocazione geografica e per valenza simbolica, il “mare spudorato” dell’epigramma di Dveinias. In
questi casi, come in Omero, l’assenza-di-pudore pare inspiegabile letteralmente, perché nessun agente antropomorfo
sembra coinvolto nell’azione espressa dal co-testo immediato
dell’attributo. Epperò cosa ci dice che il senso antropomorfo
di anaidès sia prioritario, nell’uso, rispetto a quello non antropomorfo? E, se anche fosse, come tracciare una netta demarcazione fra tratti antropomorfi (o teriomorfi) e non antropomorfi entro una cultura nella quale tutto il pensiero è
narrativo, e quindi, necessariamente formulato in termini di
MARCELLO LA MATINA
agenti “ominizzati”? Penso sia prudente, per il momento, lasciare da canto la questione semantica, in attesa di aver ricevuto lumi dalla lettura del nostro secondo testo, che è un racconto in prosa, anch’esso assai più antico della sua prima redazione per iscritto.
In una riflessione sulla letteratura del pudore e della spudoratezza non si può fare a meno di menzionare la favola di Candaule. Essa narra – in margine alla genealogia dei discendenti di
Creso – le vicende di un sovrano – noto anche come Mirsilo –,
il quale era a tal punto convinto della superiore bellezza della
moglie da decidere di mostrarla nuda al suo attendente Gige al
solo fine di condividere con lui questa credenza. Erodoto narra
la vicenda come un caso di violazione del pudore. Infatti, egli
inserisce – nel discorso con cui Gige tenta di schermirsi dalla
pressione di Candaule – un noto proverbio che recita a un di
presso: «la donna che si spoglia del chitone si spoglia anche del
pudore» (Erodoto I , ). Il racconto contiene però altri due
proverbi: nel primo Candaule motiva il suo perverso desiderio
sostenendo che «le orecchie si trovano ad essere per gli uomini
più infide degli occhi» (I , ). Nell’altro Gige, per giustificare
la propria ritrosia a compiere l’intrusione richiestagli, ricorda il
motto che prescrive «che ognuno guardi le proprie cose» (I ,
). Tutti e tre i motti sono connessi col pudore. Ma il più interessante dei tre è quello che presenta un conflitto sensoriale fra
orecchie ed occhi, fra credibilità di una notizia solo udita e persuasività di una notizia testimoniata dalla conferma visiva. Candaule si rende conto della debolezza insita in una descrizione
solo verbale della bellezza della propria moglie; per questa ragione vorrebbe mostrare visivamente tale bellezza coinvolgendo un estraneo entro una forma di conoscenza autoptica. Cosa
che ai lidi, non meno che ai greci, doveva apparire come un atto di tracotanza sacrilega. Pur di condividere con altri l’informazione circa la bellezza della moglie, Candaule è pronto a
IL MARE SENZA PUDORE
commettere hybris, rompendo il contratto scopico sul quale si
basa il pudore coniugale.
Dunque, egli è spudorato. Ad un differente livello di lettura, però, il peccato insano di Candaule configura un conflitto
estesico tra l’occhio e l’orecchio, tra l’informazione visiva e
quella orale. Un conflitto certo non riconducibile al personaggio di Candaule, soggetto della storia narrata, quanto piuttosto
ad Erodoto stesso, che è soggetto di un’enunciazione storiografica diversa, volta a modificare la precedente acquisita gerarchia nell’uso e nelle forme della sensorialità. È stato Marshall McLuhan ad attirare l’attenzione degli studiosi sul ruolo
che i sensi – della vista anzitutto e dell’udito, ma anche del tatto – rivestono nel configurare l’immagine che una cultura si fa
del proprio ambiente e del mondo in generale. In chiave assai
simile, l’antropologo François Hartog ha riletto l’episodio di
Candaule come conflitto fra due modi della conoscenza entrambi problematizzati nel lavoro dello storico. L’occhio, scrive Hartog, richiama il concetto di autopsia, per esempio l’esperienza diretta del testimone che conosce per aver visto. Vedere con i propri occhi significa accedere ad una fondatezza
della testimonianza irraggiungibile e forse incomprensibile per
l’uomo orale, il quale crede a ciò che vede solo quando la realtà
raffigurata nella visione è quella stessa che l’ascolto ritmico e
formulaico gli rappresenta in termini concettuali. Ora, come
sappiamo dagli studi sull’oralità greca, tutta la “letteratura” fino ad Erodoto è orale, e tutta quanta l’enciclopedia tribale nella quale si muove l’uomo arcaico dipende dalle relazioni acustiche tra l’aedo e il suo pubblico. Ponendo un conflitto fra occhi e orecchie, fra il testimone che sa per avere ricevuto un’investitura dalle Muse e il testimone che sa perché ha visto, Erodoto intende sottolineare il passaggio da una storiografia mitica intessuta di mirabilia ad un mestiere nel quale il narratore è
anche histor, colui che sa per avere visto.
Accogliendo questo duplice livello del racconto, è facile
ipotizzare che la hybris di Candaule possa non concernere solo
l’oggetto mostrato, cioè la nudità fisica della regina. La traco
MARCELLO LA MATINA
tanza potrebbe riguardare un travalicamento di ben altra soglia:
per esempio, quella che separa il pudore dalla spudoratezza in
quanto forme opposte di conoscenza . C’è un conoscere che
equivale ad un mettere a nudo, svelare, contemplare un oggetto nelle sue forme essenziali. E c’è un conoscere che è invece fatto di frequentazione, di un coltivare nel tempo, di un incontrare a parte. I greci antichi usavano la parola synousìa per indicare tanto le lezioni di Socrate quanto la relazione sessuale, intima, tra persone. Il rapporto che Candaule pare avere con la regina è inizialmente di questo tipo: un synousiàzein che si nutre
di uno spazio ben delimitato e di una durata. Poi, però, il re decide di abbandonare la relazione esclusiva: possiamo chiamare
“impudica” questa forma di conoscenza che è costretta a denudare l’altro per renderlo trasmissibile ad altri? E non è questo
svelamento dell’oggetto che generalmente viene considerato
comunicazione? Se è così, allora dobbiamo concluderne che la
conoscenza impudica di Candaule ha un suo pendant nella conoscenza autoptica che lo storico Erodoto intende promuovere
come forma scientifica di un sapere storico controllabile, condiviso perché riconducibile all’esperienza autoptica dello svelamento di un oggetto.
Non solo; se mettiamo le cose in questo modo, allora occorre rileggere il testo di Erodoto, cercando di verificare l’idea
che l’errore, la hamartìa di Candaule, consista in qualcosa di diverso dalla semplice superficialità di un marito vanesio. La colpa coinvolge la gerarchia sensoriale in un conflitto che oppone
una forma “pudica”, ma non verificabile, di conoscenza ad una
forma “spudorata” del conoscere per autopsia; solo quest’ultima è condivisibile e verificabile sul campo, anche se a prezzo –
come scoprirà Candaule – molto alto. Il re Candaule viene presentato come innamorato della moglie e al contempo persuaso
della superiorità della bellezza di questa su ogni altra donna.
L’oggetto che il re desidera comunicare è dunque questa bellezza di per sé incomunicabile, perché può essere nota solo mediante un medium sensoriale privato. Di che natura è questo accesso? Indubbiamente Candaule accede alla bellezza della mo
IL MARE SENZA PUDORE
glie in regime visivo e acustico: la vede in privato e la sente parlare, fors’anche sorridere in una relazione faccia a faccia.
Non si deve sottovalutare l’importanza di questa comunione fàtica stabilita dagli occhi e dalla voce. Essa ad esempio è
centrale nel famoso frammento di Saffo (fr. Voigt) dove simile a un dio sembra colui che sedendo innanzi alla persona
amata ha modo di stabilire con essa una tal corrispondenza. La
conoscenza erotica iscritta nei versi è mediata dalla contemplazione faccia a faccia (v. : ejnavntiov" toi ijsdavnei); è un fatto
acustico-visivo (vv. -: kai; plavsion a\du fwneivsa" ujpakouvei
kai; gelaivsa" ijmevroen). Sempre Saffo, però, quando decanta la
bellezza di una fanciulla da lei amata e poi perduta (fr.
Voigt), rievoca l’incedere flessuoso di lei (vv. -: ta`" ke bolloivman e[ratovn ba`ma ... i[dhn); in un altro frammento, poi (fr.
Voigt) allude al desiderio che scaturiva dalle conturbanti movenze del corpo dell’amata (vv. -: kai; strwvmnªan eºjpi; molqavkan ajpavlan pa.ª º ...wn ejxivh" povqoªn º.nidwn). Una fanciulla era la persona amata da Saffo; e ciò che vi è di interessante
nei frammenti citati è il riferimento ad una, diciamo così, corporeità che si manifesta nel suo potere e nel suo richiamo erotico come movimento, come tensione muscolare. Nell’evocare
la sua relazione con il corpo amato, Saffo iscrive nei versi una
forma di conoscenza che non è più acustico-visiva. La relazione erotica è ora diretta alla persona, non ad un oggetto percepito; ecco perché questa conoscenza è codificata in termini muscolari, empatici al corpo dell’amata. I due frammenti documentano per noi due differenti modi di conoscere in senso erotico, che nella relazione amorosa di Saffo sono ancora perfettamente equilibrati.
Possiamo pensare che sempre il corpo amato sia sempre conosciuto in questi due modi or ora evocati. È bello agli occhi che
lo contemplano e che ne codificano icasticamente le proporzioni in un canone; ed è bello muscolarmente per un altro corpo,
MARCELLO LA MATINA
al cui interno esso stimola risposte muscolari e tensive di carattere empatico. Ora, se la codifica visiva della bellezza può esser
detta exosomatica, cioè relativa a qualcosa che rimane esterno al
soggetto spettatore, la codifica empatica presuppone un accesso
all’io dell’altro che si muove per noi lasciando tracce della sua muscolarità nel nostro corpo e nel nostro io. Ciò che viene conosciuto in questo modo non ha tanto lo statuto di oggetto percepito, quanto quello di un essere altro, la cui presenza è immediatamente data al corpo vivente che la codifica. Ho chiamato
altrove endosomatica questa forma di conoscenza personale che
risulta dal rilevamento della presenza di altri attraverso una
Einfühlung .
Candaule desidera comunicare la bellezza della moglie ma
si scopre incapace di tradurre tale bellezza in modo adeguato
perché «gli orecchi sono più infidi degli occhi». Pertanto, decide di consentire una transcodificazione del corpo della donna dal regime del parlato al regime visivo, della perlustrazione
scopica. Candaule opta così per una forma di comunicazione
autoptica: non i segni verbali della bellezza verranno mostrati
al perplesso Gige, ma la bellezza stessa; non i signa data dalla
parola linguistica, ma la res ipsa, la cosa in sé. Nell’effettuare
questa traduzione Candaule compie quel che qualcuno ha
chiamato uno “stupro scopico”. Egli mostra la sede stessa del
pudore, cioè le pudenda, che i greci chiamavano ta aidòia.
Questo stupro, consumato dagli occhi, dovrebbe transcodificare, secondo le intenzioni di Candaule, il corpo della moglie
(cui egli ha accesso empaticamente) in un doppio o in un simulacro capace di conservare ed esibire identiche marche di
bellezza. L’obiettivo di Candaule è perciò la costruzione di un
teatro scopico che consenta questa trascodificazione. Erodoto
presenta l’agguato ordito da Candaule con dovizia di particolari, dando anche alla scena l’aspetto di una sceneggiatura che,
agli occhi del lettore moderno, ricorda l’avido rituale dello
strip-tease:
Fatti animo, Gige, e non aver paura di me, che io ti parli per metterti
alla prova; né di mia moglie che da lei ti venga qualche danno. Pen-
IL MARE SENZA PUDORE
serò io a trovare l’occasione, cosicché lei non sappia neppure che tu
l’hai guardata. Ti metterò nella stanza (oi[khma) dove dormiamo, dietro la porta aperta; dopo che sarò entrato, anche mia moglie verrà a
letto. Vicino all’ingresso c’è un seggio; su questo seggio ella deporrà,
uno ad uno, gli abiti che si toglie, e tu potrai guardarla molto tranquillamente. Ma quando dal seggio andrà al letto e ti volterà le spalle, abbi cura allora, che non ti veda, mentre esci dalla porta (trad. D. Musti; corsivo mio).
Lo “stupro”, come sa bene il lettore di Erodoto, non porterà le
conseguenze sperate da Candaule, ed egli perderà sia la moglie
sia il regno. La regina, infatti, scoperto l’apparato, deciderà di
vendicarsi di Candaule, facendosi aiutare nell’ucciderlo proprio
da Gige. Con queste parole ella lo obbligherà a una non facile
scelta:
O uccidi Candaule e hai me e il regno di Lidia, oppure devi morire
subito, perché tu, per il futuro obbedendo in tutto a Candaule, non
veda ciò che non devi. In vero, deve morire l’autore di questa trama
o tu, che mi hai contemplato nuda e hai fatto cose non lecite (trad. D.
Musti).
L’agguato ordito da Candaule ai danni della moglie si ripete così all’inverso, mantenendo la stessa sceneggiatura. Dice, infatti,
la regina a Gige:
“L’attacco avverrà da quello stesso luogo da cui lui mi mostrò nuda; sarà
aggredito nel sonno.” Dopo che ebbero preparato l’attentato, quando fu notte, Gige seguì la donna nella stanza nuziale [...]. Lei gli diede un pugnale e lo nascose dietro la stessa porta (trad. D. Musti; corsivo mio).
L’omicidio è rituale; è un atto di working-through che ha lo scopo
di ricondurre nel chiuso di una camera nuziale quella bellezza che
la superficialità del re e gli sguardi indiscreti di un estraneo avevano bensì tradotto, ma anche tradito. Qual è allora la hybris commessa da Candaule? Quale il pudore che emerge violato da questo
apologo? Rinunciando a mostrare i signa verbalia della bellezza
MARCELLO LA MATINA
della regina, Candaule si era illuso di poter mostrare la res ipsa. Ma
non si era accorto che nel tradurre da un accesso endosomatico,
tensivo, ad un accesso exosomatico, visivo, egli avrebbe snaturato
quel contenuto stesso che intendeva tradurre e diffondere.
Volendo usare una terminologia più vicina ai concetti della
filosofia dei linguaggi, si potrebbe così schematizzare la situazione comunicativa messa in atto da Candaule ai danni della
moglie. All’inizio del racconto Candaule dispone di una definizione della bellezza che è frutto di un accesso personale al corpo di lei. Abbiamo chiamato endosomatico questo accesso che
si sostanzia di frequentazione e di percezione dell’altro come
Leib, cioè come corpo vivente, sorgente di atti . Nella seconda
scena Candaule decide di tradurre il Leib della moglie in un èidolon costituito da un pacchetto di marche visive. A tal fine, nella terza scena, egli costruisce un teatro scopico che consenta di
diffondere la bellezza della moglie ormai ridotta ad un oggetto
capace di “trasmigrare” dall’ambito coniugale ad un ambito allargato. Nel far questo Candaule spera che l’informazione in
partenza, cioè la bellezza come egli la conosce, possa essere condivisa dal destinatario della comunicazione, cioè dallo spettatore Gige.
Il sovrano non si rende conto di commettere due atti di hybris: il primo ha natura interpersonale e consiste nell’avere ridotto la persona della regina da interlocutore di una relazione
visiva ed empatica a mero oggetto di una visione oggettivante:
Candaule mette in posa la regina, ne fa un tema per una spettacolarizzazione. Il secondo atto di hybris è quello che ci interessa di più e che costituisce a nostro avviso la violazione più grave nell’ambito della comunicazione interpersonale. Traducendo il corpo amato (e muscolarmente conosciuto) in un corpo da
altri visibile, Candaule ha tradotto colpevolmente l’accesso endosomatico all’altro in un accesso exosomatico. La bellezza della regina non è più in relazione personale con lui, ma viene trasformata in pura informazione visiva, capace di viaggiare attraverso una modalità sensoriale che viene disaffiliata dall’etica
della relazione personale.
IL MARE SENZA PUDORE
Ciò fa della comunicazione tra Candaule e Gige una comunicazione spudorata. Non tanto perché l’oggetto di esso sia un
nudo di donna, quanto piuttosto perché la relazione conoscitiva viene disaffiliata dalla relazione amorosa e quindi personale.
La vicenda – e il tradimento di Candaule che scopre la nudità
della moglie – ricordano molto da vicino il peccato di Adamo
ed Eva che scoprono la loro nudità solo dopo aver colpevolmente disaffiliato il loro desiderio di conoscere il bene e il male dalla relazione personale ed etica con Dio creatore. In entrambi i casi la nudità disvelata è solo espressione di una scissione: il soggetto conoscente non è più capace di custodire la relazione personale con altri. Il pudore segnerebbe, quindi, il confine tra due modi del conoscere, designandone uno come termine marcato dell’opposizione.
In che senso allora il mare può essere senza pudore? L’epigrafe, dicevamo, non ci dà indicazioni, né rimanda ad un modello
univoco presente nella dizione formulaica. I precedenti omerici (o il riferimento pindarico), come abbiamo visto, parlano di
pietra spudorata (e morte spudorata), ma nulla pare accomunare questi usi in base ad una precisa marca semantica. Provo,
allora, a fare un’ipotesi e la offro senza alcuna pretesa. Muoviamo dalle prime attestazioni di anaidès. I passi omerici menzionano una pietra scheggiata nell’atto di frammentarsi o nell’atto di frammentare un corpo che da essa viene offeso, colpito. D’altro canto, il passo pindarico delle Olimpiche – che però
è successivo al nostro epigramma – fa riferimento alla morte
chiamandola senza pudore. Forse la morte è spudorata perché
non guarda in faccia a nessuno. Così pensa anche Salvatore Nicosia, il quale, commentando l’esametro di Dveinias, scrive:
«Anaidès (senza ritegno, spietato, inesauribile) è qui il mare,
come in Pindaro la morte (Olimpiche X ): quasi una forza
animata, ostile e cieca, che non ha esitato a travolgere Dveinias,
senza riguardo alcuno» (Nicosia, , p. ).
MARCELLO LA MATINA
A cosa pensava (se pure a qualcosa) l’epigrammista o colui
che ha composto il verso? Aveva egli – consapevolmente o meno – un modello formulaico preciso? Se aveva in mente qualcosa di simile a quello che Pindaro stesso aveva in mente, allora il mare potrebbe essere spudorato come lo è la morte, perché entrambi non guardano in faccia. Ma il binomio “morte”“pudore” non è attestato prima del V secolo. Se il modello è,
come pensiamo, quello omerico, allora il mare sarebbe spudorato come la pietra di cui si parla nei poemi epici: nell’Iliade (IV ) essa colpisce un uomo al tallone recidendogli entrambi i tendini e le ossa senza pietà. Nell’Odissea (XI ) la
pietra impudica è quella di Sisifo: un sasso gigante che l’infelice spinge con ambo le braccia su per una rupe finché una
forza violenta non lo travolge facendolo rotolare inesorabilmente fino al piano. In ambo i casi Omero presenta la formula làas anaidès in fine di verso. Nulla fa pensare ad una violazione di tipo sessuale e nulla fa pensare ad un’attività o ad un
processo comune a questi agenti non antropomorfi. Solo gli
effetti possono essere accomunati. La pietra di Sisifo vanifica
i suoi sforzi tensivi. La pietra che scardina i tendini disperde
la tensione muscolare del corpo vivente. Il mare che uccide
Dveinias disperde il suo corpo, così come farà la morte impudica in Pindaro.
Ma un argomento secondo me decisivo per la corretta formulazione del problema è la metrica, e non la semantica. Il
pensiero formulaico tende ad aggregare i chuncks di informazione in relazione alle possibilità che essi offrono di completare l’esametro. Pertanto, è “anaidès in fine di verso” che va
spiegato, non il solo aggettivo come parola singola. E, se questo è il nostro compito, allora è ragionevole indicare nella formula omerica làas anaidès il più diretto antenato dell’espressione pòntos anaidès del nostro epigramma. E ciò – ritengo di
poter dire – prima ancora di far riferimento alla semantica dell’espressione. In sostanza, si tratta di partire dall’equivalenza
metrica come criterio preferibile rispetto a quello della comparazione semantica. E, sulla base della “omeostasi metrico
IL MARE SENZA PUDORE
ritmica” , le occorrenze di anaidès che contano sono quelle in
cui l’aggettivo è combinato con làas (o un suo isometron), per
dar vita ad un’espressione formulaica costante. Lo ripetiamo:
è questo sintagma formulare che va spiegato e non, banalmente, la singola parola. A questo punto, individuato il sintagma,
si può effettuare la comparazione dei passi. Ne risulta una costante: il poeta epico impiega la formula quando ha bisogno di
individuare ritmicamente qualcosa che disperde allentando
una tensione vitale. Ora si può immaginare l’eroe che combatte fino all’ultimo, ma che un sasso all’improvviso disarticola nei suoi legamenti. Questa immagine del morire è ben rappresentata in Omero. Si può pensare alla tensione dello sforzo di Sisifo tenuto in piedi dai muscoli rappresi nel sostenere
la pietra. La pietra impudica spezza questa tensione dissipando l’unità delle membra tenute insieme dallo sforzo. Ma l’immagine della pietra impudica non è convocata per ragioni solo semantiche, bensì perché quella formula evoca un potenziale ritmico adatto alla tensione dell’episodio. Sviluppando
un’indicazione di Gennaro D’Ippolito (), possiamo affermare che, nell’epica arcaica – e nella poesia che ne adotta i modi di composizione – una formula non viene necessariamente
scelta per quel che permette di denotare (che bisogno ci sarebbe di dire ogni volta che Achille è “piè veloce”, che Atena ha
“occhi di civetta”?), ma perché esprime un potenziale ritmico
che è già semanticamente orientato. Ecco un primo possibile
indizio metrico-semantico.
A questo punto possiamo articolare meglio la nostra ipotesi. Allentare una tensione vitale significa disperdere il soma.
È questo che di solito fa la morte, è questo che fa il mare al
corpo del povero Dveinias. L’immagine dell’epigramma è
però più complessa. In esso c’è un elemento spudorato e c’è
una pietra. Tutto accade come se l’ignoto epigrammista avesse trasferito al mare l’attributo che in Omero era della pietra,
cioè “spudorato”, mantenendo, però, l’equilibrio omeostatico dell’immagine presa a modello. Sicché nel verso c’è sempre
qualcosa di “impudico” che disperde e c’è sempre una pietra:
MARCELLO LA MATINA
ma ora le due cose non coincidono. Ora è il mare che è impudico. La pietra è diventata sāma, ossia pietra tombale, cippo.
Nel nuovo equilibrio del verso la pietra riveste di pudore ciò
che il mare “impudico” aveva denudato.
Se quest’ipotesi fosse plausibile, il nostro esametro potrebbe essere considerato come una testimonianza assai interessante dei cambiamenti che la memoria formulaica può impercettibilmente introdurre nei testi. Si tratterebbe insomma di un caso di amnesia strutturale, quel fenomeno – già notato da antropologi ed etnologi – in virtù del quale un precipitato mnestico
riesce a sopravvivere dinamicamente adattandosi alle mutate
esigenze del contesto. In alcuni lavori precedenti ho avuto modo di occuparmene . Qui vorrei menzionare due casi macroscopici di amnesia strutturale. Il primo riguarda la notissima favola del lupo e dell’agnello. Nella versione latina di Fedro il lupo a un certo punto tira in ballo il padre dell’agnello («pater,
hercle, tuus – inquit»); nella versione detta “augustana” – che è
tipologicamente e genealogicamente vicina a quella di Fedro –
il padre menzionato è stranamente quello del lupo (come si vede nella raccolta di Hervieux). Altro caso, ben noto agli studiosi dei Vangeli, è nella pericope del giovane ricco, dove lo scambio di parole è tra l’espressione
maestro buono, cosa devo fare per ottenere etc.
che compare in Marco , e Luca , , e l’espressione
maestro, cosa di buono devo fare per ottenere etc.
riportata da Matteo , . Anche in questo caso sembra che l’amnesia abbia salvato il concetto di /buono/, connettendolo però
una volta con /maestro/ ed un’altra con /che cosa/. In entrambi
i casi la memoria dinamica ha mantenuto l’equilibrio dell’immagine, ridistribuendo però “il carico” semantico in modo diverso
fra i costituenti dell’enunciato. Questo dinamismo è in verità
molto più frequente di quanto non ci capiti di notare quotidianamente.
IL MARE SENZA PUDORE
Qualcosa di simile potrebbe essere accaduto all’immagine
della pietra. Essa appare in origine legata al concetto di pudore attraverso la formula omerica (la`a" ajnaidhv"), impiegata in
fine di verso. Nel nostro epigramma, l’attributo continua a
comparire come in Omero in fine di verso, ma la pietra, per
compensazione amnestica, viene, per così dire, mutata di segno. La pietra, che era impudica in Omero, è ora la pietra tombale che riconduce al pudore il corpo disperso e ucciso da un mare impudico. Forse l’autore dell’epigramma ha pensato al testo
di Omero adattandolo a un contesto diverso; o forse ha creato
inconsapevolmente. L’immagine del mare impudico e della
pietra tombale è comunque nuova ed assai efficace. Anche da
un punto di vista ritmico l’esametro appare ben costruito. Esso è nettamente diviso in due membri: il primo (D‡einiva tovde
sa`ma) indica la pietra che custodisce l’identità del defunto; il
secondo (to;n w[lese povnto" ajnaidhv") menziona il mare sfrontato. I due membri sono connessi da un ritmo semantico – nel
senso che a questa espressione ha dato Eric A. Havelock. Se il
mare disperde la vita e il ricordo, esso è impudico perché impedisce di conferire all’essere una nuova modalità di esistenza.
Il sāma è questa nuova dimora che si candida a custodire, dopo averlo costituito, il corpo disperso nella morte e nell’acqua
del mare.
L’impudicizia del mare non è dissimile, secondo questa seconda interpretazione, da quella di Candaule. Entrambi disperdono ciò che l’amore dovrebbe custodire e ricomporre.
Anche nella storia di Candaule troviamo un ritmo semantico
dove qualcosa riunisce ciò che qualcos’altro aveva disperso.
Candaule pretendeva di mostrare il corpo della moglie ottenendo, al contrario, di disperderlo. La regina ha compiuto allora la necessaria riparazione, ricostituendo in un nuovo spazio coniugale e di potere la sua esistenza. Lo stesso accade a
Dveinias, il cui corpo disperso dal mare viene ricostituito dal
sāma in un solo luogo. Ogni volta il ritmo è quello della dispersione/frammentazione e della ricomposizione/ri-semantizzazione.
MARCELLO LA MATINA
Nella sua relazione (cfr. supra, pp. -), Giorgio Boatti ha
parlato del pudore in relazione al mestiere del giornalista. Egli
citava quei casi nei quali un cronista per conoscere l’identità
di una vittima può esser costretto a cercare frugando tra i documenti del morto. È, certo, un comportamento ai limiti, questo che invade lo spazio corporeo al fine di ottenere un’informazione; Boatti lo ha stigmatizzato. Ma sarebbe vano voler
ignorare che ciò che può fare un cronista spudorato è stato fatto per secoli dai violatori di tombe e viene fatto da alcuni secoli anche dagli archeologi. Come i giornalisti essi frugano i
cadaveri alla ricerca di documenti. C’è qualcosa di spudorato
in questi comportamenti. Possiamo accostare il violatore di
tombe al mare impudico? E il cronista affamato all’impudico
Candaule? Entrambi sembrano condividere l’idea che il diritto all’informazione non abbia un senso del pudore.
Come il mare, come il violatore di tombe, così anche Candaule agisce disperdendo quel soma che un sāma funerario vorrebbe ricomporre conferendogli una nuova forma di esistenza
simbolica. Che dire a questo punto dell’archeologo? Il suo comportamento è certamente quello del violatore di tombe. Egli deve propalare, cioè disperdere nello spazio dell’informazione
quel che la pietà e l’amore hanno custodito o ricomposto. Diversamente dal violatore, l’archeologo è mosso, però, da un’etica che affonda le sue radici nel metodo del filologo. In questo
l’archeologo si differenzia dal tombarolo, in quanto egli assegna
al soma custodito o incustodito uno statuto testuale: egli riconduce il corpo da un pudore religioso ad un pudore simbolico,
evitando così di commettere hybris. Egli ricompone nella forma
di un testo ciò che la morte aveva una prima volta disperso. Egli
attua una forma di culto laico che rappresenta al contempo il
pudore della conoscenza amnestica. Che questo sia plausibile,
lo dice anche l’uso greco di erigere un tumulo per quei defunti
il cui corpo – sovente disperso in mare – non era stato rinvenuto e non poteva materialmente essere sepolto. L’istituto del ce
IL MARE SENZA PUDORE
notafio (lett. “sepolcro vuoto”) esplicita la necessità simbolica
del passaggio dalla dispersione della morte alla ricomposizione
nel pudore della pietra che fa da teca al corpo .
Non è difficile realizzare come il sāma, pieno o vuoto, sia
l’ancestrale di quel prodotto scientifico che sarà inventato dalla filologia ottocentesca: esso è un’edizione critica, ma con
un’importante differenza. Mentre l’edizione critica di un testo
verbale è un manufatto segnico che sta per il suo designatum, la
tomba, il sāma, non è un mero sostituto notazionale della vita di
un defunto. Come la maschera funebre egizia e come l’icona bizantino-slava esso si sovrappone al defunto, lo indica e lo possiede . Non è un segno ma un testimone. I testi che la memoria strappa all’oblio sono come i corpi di lontani naufragi, sopravvissuti al mare impudico grazie alla pietà del filologo, che
riscatta l’empia impudicizia di Candaule e dei violatori di corpi, vivi o morti, di tutti i secoli. A questi, a noi, conviene ricordare quel che scriveva il poeta Platone in un epigramma che assolve per una volta il mare dall’accusa di impudicizia, per puntare il dito sulla ben più esecranda spudoratezza degli uomini,
cui pietà non convien sempre:
Naufrago sono, lo vedi. Se il mare m’uccise, ritegno
Di spogliarmi provò della mia veste:
Nudo mi rese un uomo, con mano intrepida – tanto
Il sacrilegio, tanto poco il lucro.
Ma se la metta, la veste, la porti nell’Ade, e Minosse
Gli veda indosso quegli stracci miei!
(trad. F. M. Pontani)
Note
. Il presente testo trascrive, con qualche libertà e alcune precisazioni, il
contenuto di un intervento orale, svolto a margine del dibattito vero e proprio. Salvo l’aggiunta delle note e dei riferimenti testuali, ho ritenuto di non
dover modificare la struttura del parlato, più adatta, a mio avviso, a rendere il carattere indiziario e il tono sommesso del ragionamento. Le traduzioni dal greco, salvo diversa indicazione, sono di chi scrive. Desidero ringraziare Maria Letizia Perri per avermi invitato a partecipare ai lavori e Andrea
Antonelli che mi ha rivolto alcuni quesiti (ai quali spero di aver dato rispo-
MARCELLO LA MATINA
sta nello stendere queste pagine). Sono grato anche a Roswita Bertelsons che
ha discusso con me tutto il testo scritto.
. Riporto il testo e la traduzione così come sono stabiliti da Nicosia
(), pp. -. L’epigrafe, rinvenuta nei pressi della città di Corinto, si trova
ora custodita presso il Museo Epigrafico di Atene (n. inv. ). È scritta boustrofhdovn ossia a righe alterne quanto alla direzione: prima da destra a sinistra e poi da sinistra a destra, a somiglianza del moto di una coppia di
buoi nell’arare un campo.
. Numerose le attestazioni nell’Odissea, dove in più punti l’aggettivo
anaidès è riferito ai pretendenti che infestano la casa di Odisseo e ne insidiano la moglie Penelope (I , XIII , XX . . , XXIII ). In XXII
infine sono dette “spudorate” le ancelle di Penelope passate dalla parte dei
pretendenti.
. Ricordo un verso in cui Pindaro (Olimpiche X ) evoca il destino di
Ganimede, definendo impudica la sua morte. Sempre Pindaro (Nemee XI )
dice sfrontata la speranza e (fr. a ) anaidē le azioni di qualcuno.
. Il detto è ripreso da Plutarco in De audiendo d con riferimento ad
Erodoto; un’eco si trova pure in un altro passo dei Moralia, dove Plutarco
racconta della pitagorica Teanò, la quale è portata a modello di pudicizia morale e, soprattutto, linguistica (Praecepta Coniugalia ).
. Per il metodo di Erodoto, cfr. Hartog (), soprattutto, al cap. , le
pp. - e -. Sulla storia di Candaule scrive lo studioso: «Comme le rappelle l’histoire de Gygès, l’oreille, du point de vue du faire-croire, vaut moins
que l’oeil; il doit donc s’ensuivre qu’un récit raccroché à un j’ai entendu sera
moins croyable ou moins persuasif qu’un autre, voisin, organisé autour d’un
j’ai vu» (Hartog, , p. ).
. Questa ipotesi sui modi diversi di conoscenza, aurale/orale e visivo, è
ovviamente largamente accettata dagli studiosi. Diverse, e in buona parte
nuove, sono le implicazioni che ne trae Hartog, e che vorremmo per conto
nostro sviluppare nelle pagine seguenti. La differenza – si vedrà – non va posta tanto in termini di sensorialità, di conflitto tra occhio ed orecchio, quanto in termini di modalità di codifica dell’informazione. Come ho argomentato in La Matina (), la codifica visiva è exosomatica, per esempio processa l’informazione lasciando estraneo al coding il soggetto, che non si rappresenta in ciò che conosce. La codifica empatica è invece endosomatica e contiene sempre come sua parte il soggetto conoscente; inoltre, quest’ultima si
sviluppa come reazione alla presenza di un altro soggetto piuttosto che ad un
oggetto ricostruito percettivamente. In poche parole, l’accesso endosomatico codifica la reazione del Sé ad Altri.
. La nozione di synousìa è stata studiata in un bel saggio da Rossetti
(), che ne ha messo in luce le implicazioni semantiche. A questo scritto
rimando il lettore che fosse interessato anche a dei rimandi bibliografici.
. Per uno sviluppo del concetto di Einfühlung – teorizzato da Theodor
Lipps e sviluppato in senso filosofico da Edith Stein – nel quadro della filosofia dei linguaggi, mi permetto di rimandare a La Matina ().
IL MARE SENZA PUDORE
. Faccio mia la distinzione tra Körper e Leib, formulata da Edith Stein
nel quadro di un approccio fenomenologico al problema dell’empatia. Cfr.
ancora La Matina ().
. Questa nozione – seppur con altre parole – è spiegata in La Matina
(), note al cap. .
. Mi permetto di rimandare il lettore soprattutto a La Matina (),
dove ho proposto di differenziare i criteri che ci permettono di riconoscere
due manifestazioni testuali come “lo stesso testo”. Nel caso di un testo scritto, infatti, l’identità viene di preferenza imputata su basi compitazionali,
mentre nel caso di testi orali, tramandati a memoria, l’identità tra due o più
performances del testo dipende dall’equilibrio di più fattori, il più importante dei quali è l’amnesia strutturale. Ho chiamato identità amnestica quella
equivalenza che è posta tra due performances orali e non si basa su uno “spartito” comune ad esse, ma sul mantenimento dell’equilibrio omeostatico tra
aedo/rapsodo e partecipanti ratificati ad una data performance.
. Assai lunga la lista dei morti in mare, ai quali i greci tributarono sempre gli onori funebri e, dove prescritto dalle norme civiche, eressero un monumento. La raccolta di Nicosia (, pp. -) riporta il testo di un probabile cenotafio (Corcira, ca.) in cui sei esametri sono inscritti lungo
un’unica linea che costituisce il perimetro di un grande tumulo di forma circolare (una tomba a thòlos?). Rispetto alla sorvegliata austerità di questo
Steinepigramm appare spesso lezioso il testo di molti epigrammi spesso “fittizi”, e spesso redatti per “finti” dispersi in mare. Alcuni possono leggersi
nel Libro VII dell’Anthologia Palatina. In uno, molto bello, il motivo della
morte per acqua si lega a quello della morte prematura: «T’affidasti a bufere di scirocco: / l’ora del tempo infida t’avvinse, sommerse la tua / età soave un estuare d’acqua» (; trad. F. M. Pontani).
. Sul tema del sepolcro che “possiede” il defunto si veda l’epigramma
in memoria di M. Sempronio Nicòcrate, del III secolo d.C. in Nicosia (),
pp. -. In vita questo ignoto Nicòcrate era un «uomo delle Muse, poeta e
citarista», ma anche «mercante di belle donne». L’epigrafe sul sarcofago che
contiene le sue ossa è incisa su un pannello inserito in mezzo a due rilievi che
raffigurano un poeta di fronte alla sua Musa e reca, tra l’altro, i versi: «Compiuto il mio tempo / resi la vita avuta in prestito dal cielo, / e anche dopo morto / le Muse hanno il mio corpo» (trad. S. Nicosia).
Riferimenti bibliografici
’ . (), Lettura di Omero. Il Canto V dell’Odissea. Introduzione, testo critico, traduzione e Appendice su testo e linguaggio,
Manfredi, Palermo.
. . (), I Greci e l’Irrazionale (), La Nuova Italia, Firenze.
. (), Le miroir d’Hérodote, Gallimard, Paris.
MARCELLO LA MATINA
. (), Il problema del significante. Testi greci fra semiotica e filosofia del linguaggio, Carocci, Roma.
. (), Cronosensitività. Una teoria per lo studio filosofico dei linguaggi, Carocci, Roma.
. (), What is a Philosophy of Languages About? Symbols Time
Otherness, in “Rivista italiana di Linguistica”, II.
. (), Il segno e la memoria. Iscrizioni funebri della Grecia
Antica, Sellerio, Palermo.
. . (a cura di) (-), Anthologia Palatina, I-IV, Einaudi,
Torino (vol. II, libri VII e VIII).
. (), Il momento conviviale dell’eteria socratica e il suo
significato pedagogico, in “Ancient Society”, VII, pp. -.
. (), Zum Problem der Einfühlung, Buchdruckerei des Waisenhauses, Halle (rist. Kaffke, München ).
Il pudore tra orgoglio e umiltà.
Il contributo di Agostino
di Donatella Pagliacci
Introduzione
«Nessun sentimento, come il sentimento del pudore, esprime
in modo così chiaro incisivo e immediato la singolare posizione che l’uomo occupa nella grande serie degli esseri, cioè la sua
collocazione tra il divino e la sfera animale» . Con queste parole, tratte dall’opera Pudore e sentimento del pudore, Max
Scheler ci conduce al cuore del nostro intervento. L’esperienza umana del pudore nasce, infatti, da un’impressione angosciante e conturbante, perché si leva «sull’esperienza di una
condizione già decaduta», di timore, sottolinea Melchiorre,
per la «ripetizione di una storia che già vive nella nostra esperienza e nella nostra memoria» . Il pudore, dunque, attraverso la percezione del nostro essere corporeo, investe il volume
totale della nostra esistenza. Questo complesso dinamismo, tra
interiore ed esteriore, trova nel pensiero e nell’opera di Agostino di Ippona una feconda tematizzazione.
L’analisi di Agostino si dispiega secondo un percorso lineare che, muovendo dall’esperienza dello scacco originario, coglie
nel pudore una possibilità e una via per ricomporre e rigenerare la vicenda umana, trasformando dall’interno l’orientamento
della vita intenzionale. Il pudore accompagna tanto l’orgoglio
quanto l’umiltà, come se abitasse una terra di mezzo, a partire
dalla quale è in grado di attivare un circolo per certi versi vizioso, che determina un ripiegamento negativo verso se stessi, ma
anche virtuoso che produce un fecondo scambio tra l’inquietu
DONATELLA PAGLIACCI
dine interiore e le scelte pratiche dell’esistenza, diventando modello propositivo per l’intera vita morale.
L’intento di fondo della nostra indagine è dunque quello di
cogliere, attraverso la puntuale lettura di alcuni testi paradigmatici, quale idea Agostino maturi nel corso della sua esistenza
intorno al pudore. Il discorso si articola in due momenti: in primo luogo si cercherà di ricostruire la genesi del sentimento del
pudore e come questo, accompagnandosi all’orgoglio, possa distrarre l’uomo dall’orientamento al bene; in secondo luogo si
proverà a ricostruire il sostegno che il pudore è in grado di offrire all’anima umana che, affranta dai propri vizi, si incammina, con umiltà, verso il compimento della propria vocazione all’alterità.
Genesi e caduta
Agostino tratta la questione della genesi del pudore, tra l’altro,
nel libro XIV del De civitate Dei, a cui dedica due paragrafi nei
quali definisce come e quando nasca nell’uomo il pudore e in
che modo questo accompagni il dispiegarsi della vita umana.
Il pudore nasce dalla disobbedienza del primo uomo nel momento in cui infrange la sua relazione con il Creatore. Esso non
è tuttavia una conseguenza diretta del peccato, ma deriva dalla
pena dovuta per la colpa commessa. Agostino è molto attento
nel rileggere gli istanti immediatamente successivi al peccato per
mostrare come, dopo l’errore, non c’è nell’uomo nessuna iniziativa per invocare la misericordia per ciò che aveva commesso,
dunque non c’è prima facie né vergogna, né pudore, anzi ciascuno tenta di scaricare su altri la responsabilità di quanto ha compiuto: «Anche se essi non negano la loro azione. Come Caino, la
loro superbia tuttavia cerca pur sempre di scaricare sull’altro lo
sbaglio dell’uno: la superbia della donna sul serpente, quella dell’uomo sulla donna» .
L’esperienza del pudore segna una svolta nell’essere umano.
L’uomo, a cui erano stati concessi privilegi eccezionali (vivere
IL PUDORE TRA ORGOGLIO E UMILTÀ
eternamente, generare senza l’impulso disordinato, sperimentare la delizia di un’amicizia speciale), decide di infrangere il divieto, l’unico, che gli era stato posto. Dalla consapevolezza della disobbedienza nasce la vergogna; più precisamente, per dirla con Bonhoeffer, l’uomo «si vergogna perché ha perduto qualche cosa che formava parte del suo essere originale, della sua integrità; si vergogna di essere stato messo a nudo» . Agostino
ammette che solo qualcosa di perverso può aver indotto l’essere umano a disobbedire, qualcosa che sottraendosi all’ordo amoris ne tenta il sovvertimento, qualcosa che determina un’inversione repentina nell’esperienza umana e da cui dipendono contraddizioni e ambivalenze di molte scelte che ineriscono la sfera morale, tale è appunto l’agire della volontà.
A causa della perversione della voluntas l’uomo, dalle vette dell’elezione sprofonda nell’abisso della caduta e rimane solo a dover sostenere la pesantezza della propria fragilità, il fardello della propria esistenza . La consapevolezza di aver abbandonato la via della fedeltà, per quella del desiderio, lo rende ancora più vulnerabile, fragile dinanzi allo sguardo dell’Altro da cui era stato scelto come creatura privilegiata. Lo
sguardo divino interpella l’uomo, gli ricorda l’offesa, si fa condanna e, nella colpa, siamo privati di tutto ciò che eravamo e
che avevamo originariamente. Da adesso in poi ogni uomo è
nudo , di una nudità che diventa problema e che esprime, in
chiave moderna, «la nostra oggettività senza difesa» , quella
passiva solitudine, di cui parla Agostino, quando riconosce la
condizione nella quale ci troviamo immersi, consapevoli di dover combattere contro l’insorgere delle passioni che affliggono l’anima .
La disobbedienza, responsabile dell’allontanamento e della
dispersione della creatura, si fa compagna dell’inquietudine che
tormenta la vita interiore; lontana dalla quies e dalla patria, dal
dominio sui desideri, la creatura cerca di mascherare la propria
vergogna, come dice Scheler, con «il velo, per così dire l’“alone” dell’impressione del pudore» . Solo dopo la caduta l’uomo
percepisce di aver perduto la solidità del proprio volume totale
DONATELLA PAGLIACCI
e, sapendo di aver indebolito il proprio rapporto con ciò che sta
in alto, si ripiega verso il basso, verso quel mondo che prima dominava e dal quale, ora rischia di essere dominato:
Non era così però prima del peccato – dice Agostino –; infatti sta scritto: Tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, ma non ne provavano
vergogna [Gn. , ], e non perché non conoscevano la propria nudità,
ma perché essa non era ancora sconveniente, poiché la passione non
turbava ancora quelle membra contro la volontà, e la carne, in certo
senso non costituiva ancora un’accusa, nella sua disobbedienza, nei
confronti della disobbedienza dell’uomo .
Dunque l’uomo compie liberamente quella che Sartre chiama caduta originale, egli non è gettato da altri o dal proprio destino nella dispersione, per questo il suo essere solo con la propria corporeità, ridotto alla pura animalità, non dipende, per Agostino, dal
suo status originario, ma dalla propria colpa:
Si accorsero dunque di essere nudi, cioè di essere stati spogliati di quella grazia per la quale la nudità del corpo non li turbava, in quanto nessuna legge del peccato si opponeva al loro spirito. Pertanto conobbero ciò che sarebbe stato meglio ignorare se, credendo e obbedendo a
Dio, non avessero commesso un’azione che li avrebbe costretti a sperimentare le conseguenze funeste dell’infedeltà e della disobbedienza. [...] Quindi ciò che la passione, disobbedendo, provocava contro
la volontà a causa della disobbedienza condannata, il ritegno lo nascondeva con pudore .
Sembra qui posta una discontinuità tra vergogna e pudore che
forse un chiarimento terminologico potrebbe contribuire a precisare. Infatti, non sempre pudore e vergogna possono essere
intesi come sinonimi; come sottolinea anche Melchiorre, «la
vergogna nasce da un evento già compiuto, mentre il pudore è
un’oscillazione angosciosa che vive nella possibilità e precede
ogni compimento; la vergogna vive nella colpa, il pudore sostiene ed invoca una positività e vive solo nella possibilità della
colpa» . Dunque il pudore contiene in sé la positività che manca alla vergogna, è attivo, dove la vergogna è passiva .
IL PUDORE TRA ORGOGLIO E UMILTÀ
Ma è la radicalità del male commesso, cioè la perversione
della volontà ad interessare in maniera preminente Agostino,
che sottolinea come questa res, pur essendo costitutivamente
bona, riesce a spingere l’uomo verso le tenebre e l’abisso del
peccato. In questa situazione di smarrimento e caduta nella
quale ogni creatura vive, Agostino ritiene che solo l’amore sia in
grado di riattivare un processo di avvicinamento e di ricerca di
sé con sé e con l’altro che da sempre ci costituisce .
È qui che s’innesta una rilettura marcatamente positiva del
pudore, che diviene sinonimo di virtù morale, retta abitudine,
rispetto di sé e degli altri, come si evince da alcuni passi come:
De vera religione , ; Confessioni II, , ; II, , ; VIII, ; Commento al Vangelo di San Giovanni, , .
Nel primo testo Agostino, dopo aver definito quali sono i
tratti distintivi dell’uomo che vive secondo la carne, cioè dell’uomo vecchio e dell’uomo nuovo, cioè di chi, rinnovando la
propria esistenza, si conforma alle leggi spirituali, illustra quali
sono le età e i progressi della vita. La prima età è quella in cui
l’uomo segue gli esempi, la seconda segna l’abbandono delle cose umane per dedicarsi alle divine, la terza, quella che qui ci interessa, è contrassegnata non solo dal sostanziale equilibrio tra
ragione e passioni, ma soprattutto da un gradevole godimento
interiore accentuato dal pudore mediante il quale vive correttamente, tanto da smorzare il piacere che si può provare nel peccare. Nella terza, infine, ammette Agostino, «ormai più sicuro,
congiunge l’appetito carnale con la forza della ragione e, quando l’anima si unisce alla mente, gode interiormente di una sorta
di dolcezza coniugale, coprendosi con il velo del pudore, in modo che vive rettamente non più per costrizione, ma perché non
ha piacere a peccare, anche se tutti lo permettessero» . Le altre
età vengono poi in qualche modo influenzate dalla svolta operata dal pudore, che finisce per acquistare un valore positivo, poiché è in grado di riabilitare dall’interno la condizione umana.
Alla consapevolezza della ferita interiore e alla possibilità di
una possibile guarigione da questa infermità Agostino dedica l’affresco delle Confessioni. In questa sede emerge una certa ambi
DONATELLA PAGLIACCI
valenza propria del pudore che riesce, talvolta, ad incoraggiare
l’uomo che così si abbandona alla sola via che possa ricondurlo
al bene e, quindi, si qualifica come elemento positivo, mentre in
altre occasioni, assecondando il desiderio perverso, trascina l’uomo verso attitudini del tutto immorali. I due passi a cui facciamo
riferimento sono tratti dal secondo libro nel quale, come noto,
Agostino riferisce il ben noto furto delle pere e dall’ottavo.
Il primo brano appartiene al racconto degli anni dell’adolescenza irrequieta di Agostino, precisamente nel momento in cui
la madre, temendo che il figlio potesse avventurarsi in legami
poco adatti alla sua condizione e a ciò che ella desiderava per
lui, lo esorta al pudore; Monica sembra qui essere pervasa da un
sentimento di angoscia che, con le parole di Scheler, «si verifica, in modo particolare, quando il pudore funge da mezzo protettivo nei riguardi del compimento del primo atto sessuale [...]
ed è qui che l’emozione del pudore si collega profondamente
con l’angoscia» . Agostino così descrive questo episodio:
La donna che era già fuggita dal centro di Babilonia [Ger. , ], ma
ancora si attardava negli altri quartieri, la madre della mia carne, mi
raccomandò, sì, il pudore, ma non si curò di rinserrare nei limiti dell’affetto coniugale, se non si poteva reciderla fino al vivo, la mia virilità, di cui suo marito le aveva parlato, e che, lo sentiva, già allora funesta, sarebbe divenuta pericolosa in avvenire .
Nel brano tratto dall’ottavo libro delle Confessioni, viene confermata una certa fiducia che possiamo riporre nel pudore, poiché asseconda il nostro desiderio di abbandono. Come noto questo libro
rappresenta un momento cruciale dell’intero itinerario agostiniano, perché è qui che viene affrontato più da vicino il tema del dissidio interiore della volontà e della lacerazione che la voluntas determina nella coscienza personale . Così Agostino, nel descrivere
il tormento e l’angoscia che lo assalivano a causa della volontà perversa, riferisce di sentire, nonostante il peso dei propri peccati, una
forza che lo attrae e lo rafforza dall’interno. Questa energia, che
consolida e sostiene l’ascesa interiore, riesce anche a potenziare il
pudore e la vergogna; così, da un lato cresce il dolore e la soffe
IL PUDORE TRA ORGOGLIO E UMILTÀ
renza, ma dall’altro determina un’accelerazione verso quell’«istante biograficamente databile – come dice Jaspers – che fa irruzione
nella vita e le dà una fondazione nuova» :
Tale era la mia malattia e io mi torturavo con accuse ben più aspre del
solito contro me stesso, avvolgendomi contro me stesso, avvolgendomi e torcendomi nella mia catena, fino a spezzarla del tutto: era ormai
sottile quella che mi tratteneva, ma pur sempre mi tratteneva. E tu incalzavi nelle mie profondità, Signore raddoppiando con intransigente misericordia le frustate del timore e della vergogna, perché non mi
indugiassi ancora una volta e così non si spezzasse più quel legame tenue e sottile che era rimasto, rinvigorendosi di nuovo fino ad avvicinarmi più saldamente di prima .
L’esperienza umana della conversione è dunque preceduta da
una profonda inquietudine interiore che invade e condiziona
ogni percezione, formando quasi una catena per la coscienza; in
questo ritorcersi dell’anima, che stenta ad abbandonare i lacci
che la tengono avvinta al desiderio perverso, il pudore esercita
una spinta contraria e orienta verso l’avventura dell’incontro, in
cui si rende presente la verità che da sempre abita nel cuore dell’uomo.
Un altro testo tratto dal secondo libro delle Confessioni mostra un diverso volto del pudore, questa volta eminentemente
negativo. Descrivendo il proprio stato d’animo nel compiere insieme ad altri un atto malvagio, Agostino riconosce il ruolo negativo svolto dal pudore nel male facere. La vicinanza di amici
persuasi a compiere azioni sconvenienti, amplificava, anche nel
giovane Agostino, il desiderio e la soddisfazione nel compiere
gesti disdicevoli. Anzi, egli arriva persino ad ammettere di avere provato, trovandosi insieme a persone tanto insolenti, una
certa vergogna e pudore per non essere, in confronto a loro, abbastanza temerario:
Da solo non avrei compiuto quel furto in cui non già la refurtiva ma
il compiere un furto mi attraeva; compierlo da solo non mi attraeva
davvero e non l’avrei compiuto. Oh amicizia inimicissima, seduzione
inesplicabile dello spirito, avidità di nuocere nata dai giochi e dallo
DONATELLA PAGLIACCI
scherzo, sete di perdita altrui senza brama di guadagno proprio o avidità di vendetta! Uno dice: “Andiamo, facciamo”, e si ha pudore a
non essere spudorati .
Il pudore, dunque, può costituire una specie di esperienza di
«ritorno su se stessi» che, da un lato, mette a nudo gli eccessi
dovuti al perverso amore di sé , quella «insidia che, nell’amore, sembra strapparci al nostro essere per la totalità» e, dall’altro, permette di discernere ciò di cui dobbiamo gloriarci da
ciò di cui dobbiamo vergognarci. Si apre, in tal senso, la strada
per ritornare al nostro essere originario e dunque anche, come
noto alla verità trascendente che ci abita e ci supera: «Noli foras ire in teipsum redi in interiore homine abitat veritas et si
tuam naturam mutabiles inveneris trascende et teipsum» .
Il peccato originale, secondo Agostino, mette in primo piano, in maniera emblematica, il tema della fragilità umana . Solo un evento altrettanto radicale può neutralizzare questo male
della colpa e trasformarlo in bene. Solo un uomo nuovo, diverso capace di compiere il bene per il bene, potrà riscattare tutto
il dolore e la sofferenza che fanno gemere l’umanità. Agostino
sembra via via propendere per un’interpretazione più propositiva della vicenda umana, in cui l’umiltà si oppone all’orgoglio,
dove questa apre una voragine che risucchia dall’interno le migliori intenzioni, quella ci dona la forza di lottare, dove questa
genera il vuoto, quella riempie la nostra esistenza e ci avvicina
all’esperienza di quell’umile che sulla croce ha perdonato; stringendo una nuova alleanza con l’umiltà il pudore ricostituisce le
fondamenta del nostro essere.
La sede del pudore
Un ulteriore passo avanti nel nostro percorso può essere operato attraverso l’analisi del nesso istituito da Agostino tra pudore
e umiltà. Questo accostamento ci viene suggerito dalle parole
con le quali il vescovo di Ippona, in un discorso sulla passione
di Gesù, scritto intorno al circa, sottolinea quanto orgoglio
IL PUDORE TRA ORGOGLIO E UMILTÀ
si deve provare ad essere cristiani, tanto che persino il segno,
che più di ogni altro rappresenta la nostra fede, ossia la croce,
viene impresso nella fronte che è la sede del pudore:
Perché di questa croce non avessimo a vergognarci, noi ce la siamo collocata nel bel mezzo della fronte, ossia nella sede del pudore. Se poi
volessimo spiegare quanta dottrina di pazienza, e quanto salutare, sia
in questa croce, quali parole saranno adatte per l’argomento, o quale
tempo per le parole? Se uno infatti crede veramente e intensamente in
Cristo, come oserà alzarsi in superbia, quando Dio stesso si fa maestro
di umiltà non tanto con la parola, ma più ancora con l’esempio?
La croce, vanto e scandalo per i cristiani, chiede di essere interpretata perché mostra una via radicalmente nuova capace di
riscattare l’uomo dalla vergogna ed aprirlo ad un orizzonte di
vita nuovo, trasfigurato. Nella sua deformità, la croce è in grado di svelare il difficile equilibrio del rapporto, costitutivamente asimmetrico, che si istituisce tra l’umiltà di chi sta in alto e
l’orgoglio di chi sta in basso, tra la luce che è venuta a rischiarare le tenebre e l’oscurità del peccato che ci impedisce di vedere. In questo senso la croce di Cristo è l’immagine più forte
con cui Dio ha rivelato al mondo ciò che è possibile compiere
nel suo nome, perché in essa e per essa l’umiltà sconfigge l’orgoglio, la pace vince la guerra, l’amore trasforma l’odio, il perdono riscatta il peccato .
Agostino ricorda inoltre che i catecumeni, anticamente, venivano segnati con la croce sulla fronte , quel gesto testimonia
l’adesione a Cristo, perché ciò che viene realmente segnato non
è il volto esteriore, ma quello dell’uomo interiore. Essere cristiani significa aderire interiormente all’umiltà e alla regalità del
Figlio, far vincere non l’orgoglio, ma la docilità del pudore, mediante il quale riconosciamo e accogliamo la nostra condizione:
C’è infatti la fronte nel volto, ma c’è anche quella nella coscienza. Allorché dunque alle volte riceve un’impressione la fronte interna, arrossisce quella esterna; arrossisce sotto l’emozione del pudore o impallidisce a causa del timore. C’è dunque la fronte dell’uomo interiore. Lì
DONATELLA PAGLIACCI
furono contrassegnati coloro che non dovevano essere sterminati, poiché, sebbene non correggessero i misfatti che venivano compiuti in
mezzo a loro, tuttavia se ne addoloravano e se ne separavano grazie allo stesso dolore; ma pur separati davanti a Dio, erano mescolati agli occhi degli uomini. Vengono contrassegnati occultamente, ma non vengono offesi apertamente .
I cristiani, “segnati” dalla croce, vivono un’esistenza che scoprono essere profondamente annodata alla croce ; nel volgere lo
sguardo verso l’umile legno, sono esortati da Cristo sofferente a seguire il suo esempio. Lui, che ha portato sulle proprie spalle la croce ove sarebbe stato crocifisso, ci chiede di prendere la nostra croce, ma cosa significa per l’uomo portare la croce, se non, avverte
Agostino, saper «dominare la propria parte mortale»?
Ricondotto a riflettere sulla propria vita e sulle proprie scelte, l’uomo è chiamato a vivere responsabilmente nel mondo e
con gli altri, affinché sia l’amore lecito , accompagnato dal retto pudore, a prevalere sulla libidine. La perversione della libido,
che non dipende dalla natura malvagia dell’oggetto che desidera, crea una dipendenza da qualcosa che è fuori e cerca nel pudore un alleato per nascondere la scelleratezza del proprio desiderio. In queste condizioni all’uomo è data comunque una possibilità, quella di riconoscere che il centro del proprio equilibrio
riposa nel suo essere interiore. È qui che ognuno può sperimentare la fecondità dell’incontro con colui che, essendo «interior
intimo meo et superior summo meo» , è il solo che può insegnarci ad accogliere correttamente la nostra realtà e ad amarla .
Note
. M. Scheler, Pudore e sentimento del pudore, trad. di A. Lambertino,
Guida, Napoli , p. (ed. or. Über Scham und Schamgefühl, in Id., Schriften aus dem Nachlass, I, Gesammelte Werke, vol. X, Francke, Bern ). Anche E. Mounier cerca di definire questo sentimento in relazione all’essere personale: «Il pudore è il sentimento che la persona ha di non essere pienamente
esaudita dalle proprie espressioni, e di essere insidiata nel suo essere da chi
scambierebbe la sua esistenza manifesta per la sua esistenza totale. E come il
pudore fisico non significa che il mio corpo sia impuro, ma che io sono infinitamente più del mio corpo guardato o colto da altri, alla stessa maniera il pu-
IL PUDORE TRA ORGOGLIO E UMILTÀ
dore dei sentimenti significa che ciascuno dei miei sentimenti mi limita e mi
falsa; e uno e l’altro significano ugualmente che io non posso essere in balìa
della natura o degli altri. Non mi confonde il fatto di essere questa nudità o di
rappresentare questo personaggio, ma di far sì che io sembri essere nient’altro
che questo» (E. Mounier, Le personnalisme, , in Œuvres, III, Seuil, Paris
, p. ; trad. di A. Cardin, Il personalismo, AVE, Roma , p. ).
. V. Melchiorre, Corpo e persona, Marietti, Genova , p. .
. «Nusquam hic sonat petitio veniae, nusquam imploratio medicinae.
Nam licet isti non sicut Cain [cfr. Gen. , ] quod commiserunt negent,
adhuc tamen superbia in aliud quaerit referre quod perperam fecit: superbia
mulieris in serpentem, superbia viri in mulierem» (De civitate Dei, XIV, ).
. D. Bonhoeffer, Etica, trad. di A. Comba, Bompiani, Milano , p.
(ed. or. Ethik, Chr. Kaiser, München ).
. Risuonano su questo punto le parole di Jankélévitch che dichiara: «L’ipseità immanente e trascendente tutta insieme nello stesso soggetto, non è
dunque solamente ciò che io sono, ma ciò che ho; la mia essenza morale la più
intima rassomiglia a una specie di tesoro prezioso che mi sarebbe rivelato:
questo avere che io sono, questo essere che io ho riassume tutto il mistero inesplicabile della mia responsabilità. L’ipseità è un fardello, il fardello del destino umano nella mia persona» (V. Jankélévitch, Traité des Vertus, , vol.
II, Les vertus et l’amour, Flammarion, Paris , p. ).
. In un paragrafo del suo Corpo e persona, Virgilio Melchiorre, trattando il nesso che corre tra corpo e verità, introduce il tema del pudore come ricordo del corpo. Così dopo aver brevemente intercettato alcune tra le
prospettive più significative sul tema del pudore, tra cui quella hegeliana
centrata proprio sul pudore come ricordo del corpo, precisa che «il pudore
non si erge dunque contro la differenza, ma contro la differenza che non sa
trascendersi e che non sa mantenersi in questo trascendimento, così come
l’amore non esige il naufragio delle diversità, ma solo la loro reciprocità»
(Melchiorre, Corpo e persona, cit., p. ).
. Ivi, p. .
. «Dolores porro, qui dicuntur carnis, animae sunt in carne et ex carne.
Quid enim caro per se ipsam sine anima vel dolet vel concupiscit? Sed quod
concupiscere caro dicitur vel dolere, aut ipse homo est, sicut disseruimus, aut
aliquid animae, quod carnis afficit passio, vel aspera, ut faciat dolorem, vel
lenis, ut voluptatem. Sed dolor carnis tantum modo offensio est animae ex
carne et quaedam ab eius passione dissensio, sicut animi dolor, quae tristitia
nuncupatur, dissensio est ab his rebus, quae nobis nolentibus acciderunt. Sed
tristitiam plerumque praecedit metus, qui et ipse in anima est, non in carne.
Dolorem autem carnis non praecedit ullus quasi metus carnis, qui ante dolorem in carne sentiatur» (De civitate Dei, XIV, , ).
. Scheler, Pudore e sentimento del pudore, cit., p. .
. «Quod ante peccatum hominis non fuerunt. Nam sicut scriptum est:
Nudi erant, et non confundebantur [...]; non quod eis sua nuditas esset incognita, sed turpis nuditas nondum erat, quia nondum libido membra illa prae-
DONATELLA PAGLIACCI
ter arbitrium commovebat, nondum ad hominis inoboedientiam redarguendam sua inoboedientia caro quodammodo testimonium perhibebat» (De civitate Dei, XIV, ).
. «Cognoverunt ergo quia nudi erant, nudati scilicet ea gratia, qua fiebat ut nuditas corporis nulla eos lege peccati menti eorum repugnante confunderet. Hoc itaque cognoverunt, quod felicius ignorarent, si Deo credentes et oboedientes non committerent, quod eos cogeret experiri infidelitas et
inoboedientia quid noceret [...]. Quod itaque adversus damnatam culpa inoboedientiae voluntatem libido inoboedienter movebat, verecundia pudenter
tegebat» (De civitate Dei, XIV, ). Sul nesso tra pudore e colpa riflette anche
Scheler, che sottolinea il peso della colpa soprattutto a partire dalle esperienze interpersonali. In particolare afferma: «Il pudore dunque è un sentimento di colpa per l’io individuale in generale: non necessariamente per il mio
io individuale, ma per l’io individuale come tale, ovunque esso sia dato, in me
o in un altro. Ed è proprio questo che indica anche come il pudore non sia
una qualità affettiva inerente all’io come lo sono l’afflizione e la malinconia»
(Scheler, Pudore e sentimento del pudore, cit., p. ).
. Melchiorre, Corpo e persona, cit., p. .
. «Il fenomeno fondamentale del pudore consiste piuttosto nel “vergognarsi”, che è sempre un vergognarsi di qualcosa ed è sempre relazionato
a un dato di fatto, che “esige” per sé tale relazione, del tutto indipendentemente dallo stato del nostro io individuale. Il “vergognarsi” è un moto emozionale del tutto particolare che non chiama in causa alcun “sé”, cioè un rapportarsi vissuto del sentimento all’io, meno che meno il fatto che io mi vergogno “di” me. Per questo l’insorgere del pudore può assumere anche la forma di un “muoversi”, di un “essere presi”, di un “essere pieni”» (Scheler, Pudore e sentimento del pudore, cit., p. ).
. Sotteso a tutto il discorso agostiniano vi è un fondamentale ottimismo
antropologico, che emerge dalla rilettura della vasta produzione agostiniana.
Qui riportiamo come testo paradigmatico un passo del De civitate Dei, in cui
appunto, Agostino dichiara: «Neque enim caeci creati erant, ut imperitum
vulgus opinatur: quando quidem et ille vidit animalia, quibus nomina imposuit [...]. Patebant ergo oculi eorum, sed ad hoc non erant aperti, hoc est non
attenti, ut cognoscerent quid eis indumento gratiae praestaretur, quando
membra eorum voluntati repugnare nesciebant» (De civitate Dei, XIV, ).
. Cfr. anche alcuni testi di De civitate Dei, I, -; II, ---, , ; IV, ; V, ; VI, -, , ; VII, , ; VIII, ; XIII, -.
. «Tertiam iam fidentiorem, et carnalem appetitum rationis robore maritantem, gaudentemque intrinsecus in quadam dulcedine coniugali, cum
anima menti copulatur, et velamento pudoris obnubitur, ut iam recte vivere
non cogatur, sed etiamsi omnes concedant, peccare non libeat» (De vera religione, , ).
. Scheler, Pudore e sentimento del pudore, cit., p. .
. «Non enim et illa, quae iam de medio Babylonis fugerat [...], sed ibat
in ceteris eius tardior, mater carnis meae, sicut monuit me pudicitiam, ita cu-
IL PUDORE TRA ORGOGLIO E UMILTÀ
ravit quod de me a viro suo audierat, iamque pestilentiosum et in posterum
periculosum sentiebat cohercere termino coniugalis affectus, si resecari ad vivum non poterat» (Confessiones II, , ).
. Per un approfondimento della considerazione agostiniana della voluntas rimandiamo al nostro articolo su Male e peccato: “De civitate Dei XIV”.
Riflessi antropologici, in AA.VV., Il mistero del male e la libertà possibile (III):
Lettura del “De civitate Dei” di Agostino. Atti del VII Seminario del Centro Studi Agostiniani di Perugia, a cura di L. Alici, R. Piccolomini, A. Pieretti, Institutum patristicum Augustinianum, Roma , pp. - e al nostro volume Volere e amare. Agostino e la conversione del desiderio, Città Nuova, Roma .
. K. Jaspers, I grandi filosofi, trad. di F. Costa, Longanesi, Milano
, p. .
. «Sic aegrotabam et excruciabar accusans memetipsum solito acerbius
nimis ac volvens et versans me in vinculo meo, donec abrumperetur totum,
quo iam exiguo tenebar. Sed tenebar tamen. Et instabas tu in occultis meis,
Domine, severa misericordia flagella ingeminans timoris et pudoris, ne rursus
cessarem et non abrumperetur id ipsum exiguum et tenue, quod remanserat,
et revalesceret iterum et me robustius alligaret» (Confessiones VIII, , ).
. «Solus non facerem furtum illud, in quo me non libebat id quod furabar, sed quia furabar; quod me solum facere prorsus non liberet, nec facerem. O nimis inimica amicitia, seductio mentis investigabilis, ex ludo et ioco
nocendi aviditas, et alieni damni appetitus, nulla lucri mei, nulla ulciscendi
libidine, sed cum dicitur: “Eamus, faciamus” et pudet non esse impudentem»
(Confessiones II, , ).
. Scheler, Pudore e sentimento del pudore, cit., p. . Avverte in tal senso il filosofo tedesco: «Ciò significa che il “ritorno su se stessi”, nella cui dinamica sorge il pudore, non ha luogo né quando si sa di essere “dati” nella propria individualità, ma soltanto quando l’intenzionalità affettivamente percepibile dell’altro oscilla tra un modo di in-tendere individualizzante e un modo di
in-tendere generalizzante, e quando l’intenzionalità proprio e quella vissuta, di
chi la guarda lungi da coincidere, hanno una direzione opposta» (ibid.).
. «Cum vero ille diligitur de quo vivitur, non se diligendo magis diligit,
qui propterea non se diligit, ut eum diligat de quo vivit. Non sint ergo seipsos
amantes qui pascunt oves Christi, ne tamquam suas, sed tamquam ipsius eas
pascant; et velint ex illis sua lucra conquirere, sicut amatores pecuniae; vel eis
dominari, sicut elati; vel gloriari de honoribus quos ab eis sumunt, sicut superbi; vel in tantum progredi ut etiam haereses faciant, sicut blasphemi: nec
cedant sanctis patribus, sicut parentibus non obedientes; et eis qui illos corrigere volunt quia perire nolunt, mala pro bonis reddant, sicut ingrati: interficiant animas et suas et alienas, sicut scelesti; materna Ecclesiae viscera dissipent, sicut irreligiosi; non compatiantur infirmis, sicut sine affectione; famam
sanctorum maculare conentur, sicut detractores; cupiditates pessimas non refrenent, sicut incontinentes; exerceant lites, sicut immites; nesciant subvenire, sicut sine benignitate; indicent inimicis piorum quae occultanda cognove-
DONATELLA PAGLIACCI
rint, sicut proditores; humanam verecundiam inverecunda exagitatione perturbent, sicut procaces; non intellegant neque quae loquuntur, neque de quibus affirmant [cfr. Timoteo , ] sicut caecati; laetitias carnales spiritalibus
gaudiis anteponant, sic ut voluptatum amatores magis quam Dei. Haec enim
atque huiusmodi vitia, sive uni homini accidant omnia, sive his alia, illis alia
dominentur, ex illa radice quodammodo pullulant, cum sunt homines seipsos
amantes. Quod vitium maxime cavendum est eis qui pascunt oves Christi, ne
sua quaerant, non quae Iesu Christi; et in usus cupiditatum suarum conferant, pro quibus sanguis fusus est Christi. Cuius amor in eo qui pascit oves
eius, in tam magnum debet spiritalem crescere ardorem, ut vincat etiam mortis naturalem timorem, quo mori nolumus, et quando cum Christo vivere volumus» (In Iohannis evangelium tractatus , ).
. Melchiorre, Corpo e persona, cit., p. .
. De vera religione, , .
. Cfr. su questo punto l’opera dedicata alla controversia pelagiana
Contra Iulianum opus imperfectus in cui il tema del pudore è ampiamente
dibattuto perché connesso alla questione della concupiscenza della carne
prima e dopo il peccato.
. «De qua cruce ut non erubesceremus, eam in ipsa fronte, hoc est, in
pudoris domicilio collocavimus. Iam vero quae in ista cruce, vel quam salubris sit doctrina patientiae, si explicare conemur, quae verba rebus, quae verbis tempora suppetunt? Quis enim homo, qui veracissime atque intentissime
credit in Christum, superbire audeat, docente humilitatem Deo non tantum
verbo, sed etiam exemplo suo?» (Sermo /C, ; cfr. Sermo , ).
. «Confiteamur itaque, fratres, intrepidi, vel etiam profiteamur, Christum pro nobis esse crucifixum; non paventes, sed gaudentes: non verecundantes, sed gloriantes dicamus. Vidit hunc apostolus Paulus, et commendavit titulum gloriae. Qui cum haberet multa magna atque divina, quae de Christo commemoraret, non dixit gloriari se in mirabilibus Christi, quia, cum
esset apud Patrem Deus, mundum creavit, cum esset etiam quod nos homo,
mundo imperavit; sed mihi autem, inquit, absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi [Gal. , ]. Videbat pro quibus, quis, ubi pependerat;
et de tanta humilitate Dei et divina celsitudine Apostolus praesumebat»
(Sermo /C, ).
. «Hunc ergo volens videre Zacchaeus, in quo figurabatur persona humilium, non attendit turbam impedientem; sed ascendit sycomorum, quasi
fatui pomi lignum. Nos enim, inquit Apostolus, praedicamus Christum crucifixum, Iudaeis quidem scandalum: attende sycomorum: Gentibus autem stultitiam [ Cor. , ]. Denique de cruce Christi nobis insultant sapientes huius
mundi, et dicunt: Quale cor habetis, qui Deum colitis crucifixum? Quale cor
habemus? Non utique vestrum. Sapientia huius mundi stultitia est apud
Deum [cfr. Cor. , ]. Non enim vestrum cor habemus. Sed dicitis cor nostrum stultum. Dicite quod vultis: nos ascendamus sycomorum, et videamus
Iesum. Ideo enim vos Iesum videre non potestis, quia sycomorum ascendere erubescitis. Apprehendat Zacchaeus sycomorum, ascendat humilis cru-
IL PUDORE TRA ORGOGLIO E UMILTÀ
cem. Parum est si, ascendat; ne de cruce Christi erubescat, in fronte illam figat, ubi sedes pudoris est: ibi omnino, ibi in quo membro erubescitur, ibi figatur unde non erubescatur. Puto quia tu irrides sycomorum: et ipsa me fecit videre Iesum. Sed tu irrides sycomorum, quia homo es: stultum autem
Dei sapientius est quam hominum [cfr. Cor. , ]» (Sermo , , ).
. Cfr. su questo punto Cavadini, che ritiene che «per Agostino il segno
della croce è un segno non solo nel senso di un segno distintivo impresso nella fronte, ma nel vero senso della parola, come sintomatico del significato della vita cristiana e del suo conformarsi all’umiltà di Cristo» (J. Cavadini, “The
Tree of Silly Fruit”: Images of the Cross in St. Augustine, in AA.VV., The Cross
in Christian Tradition. From Paul to Bonaventure, ed. by E. A. Dreyer, New
York-Mahwah, NJ, , pp. -).
. Cfr. In Iohannis evangelium tractatus , ; , -; , ; , ; , ; ,
; , . Sullo stesso argomento si veda anche Confessiones I, , ; De catechizandis rudibus , ; , ; Sermo , , ; Sermo , -; Sermo , , ;
Sermo /B, ; Sermo /C, ; Sermo /A, .
. «Gemunt tamen et moerent: et ideo signati sunt in fronte; in fronte
interioris hominis, non exterioris. Est enim frons in facie, est frons in conscientia. Denique aliquando quando interior frons pulsatur, exterior obrubescit: aut pudore obrubescit, aut timore pallescit. Est ergo frons hominis interioris. Ibi signati sunt illi, ne vastarentur: quia etsi peccata quae fiebant in
medio eorum, non corrigebant; tamen dolebant, et ipso se dolore separabant;
et separati Deo, oculis hominum mixti erant» (Sermo , , ).
. Ci siamo soffermati su questo tema in un lavoro, di prossima pubblicazione, sulla croce in Agostino: Opere di Sant’Agostino, La croce, Roma. La
croce sintetizza e riassume l’intero volume dell’esistenza perché si dispiega in
senso orizzontale che simboleggia la consapevolezza del nostro essere limitato e la ricerca della gioia presente; in senso verticale in cui è simboleggiato,
da un lato il fine verso cui è protesa la nostra vita e dall’altro lo spessore della vita morale che si dispiega non solo nella ricerca dell’onore, della gloria e
dell’immortalità, ma anche della tolleranza e della pazienza. Queste virtù, storicamente accreditate, sono buone se rivolte verso il bene. È, infatti, il fine
buono verso il quale siamo protesi a salvaguardare l’identità di ciò che viviamo e scegliamo nel presente temporale.
. Sermo , .
. «Non facit, si est ibi tertia divina dilectio. Etenim tres dilectiones
commemoravi: de tribus me, quod Dominus daret, dicturum esse promisi; de
licita humana, de illicita humana, de illa excellenti atque divina. Interrogemus divinam caritatem, et ponamus ante illam duas humanas caritates, et dicamus ei: Ecce licita caritas humana, qua uxor diligitur, et filiae aliaeque necessitudines saeculares: ecce alia illicita, qua diligitur meretrix, qua diligitur
ancilla aliena, qua diligitur aliena filia non petita, non promissa, qua diligitur
uxor aliena. Duae ante te sunt caritates; cum qua istarum vis manere? Qui eligit manere cum illa humana licita, cum illa humana illicita non manet» (Sermo , ).
DONATELLA PAGLIACCI
. «Et haec est concupiscentia carnis, qua caro concupiscit adversus spiritum; adversus quam propterea concupiscit et spiritus, ne quo impellit excurrat. Malum est ergo, et quod impellit in malum; sed si non excurrit, repugnante sibi spiritu, non vincitur homo a malo. Tunc autem omni malo carebit, quando cui repugnet non erit. Neque hoc cum fiet, natura, sicut Manichaeus insanit, a nobis separabitur aliena, sed sanabitur nostra. Quae nunc,
si quemadmodum regeneratione et remissione peccatorum sanatur a reatu,
sic ab omni esset infirmitate iam sana; non contra carnem spiritus concupisceret, ut non operaremur nisi licitum; sed ita caro spiritui consentiret, ut
nihil contra illum concupisceretur illicitum» (Contra Iulianum opus imperfectum , ).
. Confessiones III, , .
. «Amate quod eritis. Eritis enim filii Dei, et filii adoptionis. Hoc vobis gratis dabitur, gratisque conferetur» (Sermo , ).
Teoria e pratica
del gesto come pudore
di Eleonora Bairati
Per uno storico dell’arte, ovviamente, la parola pudore immediatamente suscita il pensiero della censura, in quanto l’invocazione del comune senso del pudore, dalla Controriforma in
avanti, è stata una delle molle fondamentali degli atti censori,
ma di questo non voglio parlare.
Mi ha invece stimolato moltissimo l’invito – e ringrazio Letizia Perri per averlo fatto – per pensare nel concreto delle immagini, per cui ho fatto tre passaggi che qui rapidamente vi sintetizzo: la ricerca del simbolo, la ricerca dell’immagine come allegoria o personificazione e la verifica nel concreto della pratica artistica.
Nello sterminato immaginario simbolico della tradizione visiva occidentale non c’è un simbolo per il pudore, esiste invece
la personificazione allegorica della pudicizia. In quel repertorio
incredibile di personificazioni e immagini, esteso a tutti i livelli
– gli oggetti, le cose concrete, le idee e via dicendo – che è l’Iconologia di Cesare Ripa, un testo che ha avuto un’immensa fortuna, ma che poi ha agito molto limitatamente sulla pratica degli artisti, e che raccoglieva – essendo agli inizi del Seicento –
tutto il grande dibattito sulle immagini che si era svolto nella
Controriforma, la pudicizia è descritta in questo modo: «una
giovanetta vestita di bianco, in testa abbia un velo dell’istesso
colore che le cuopra la faccia fino alla cinta, con la destra mano
tenghi un giglio parimenti bianco e sotto il piede destro una testuggine»; la banalità del testo è quasi estrema, l’unica cosa che
devo spiegare è la testuggine, anche per far capire un po’ il succo della cosa: «la testuggine dimostra che le donne pudiche de
ELEONORA BAIRATI
vono stare assidue nelle case loro come fa la tartaruca [sic] nella sua casa datale dalla natura»; qui è in cauda veneni: «pensiero di Fidia in una sua statua», perché il riferimento al modello
classico è una specie di alibi per questo tipo di discorsi ed è frequentemente e anche a sproposito usato. Ci sarebbe però da cogliere l’elemento del velo, perché il velo copre ma non impedisce che si veda, infatti, anche nell’immaginetta che accompagna
la descrizione, il viso si vede sotto il velo, quindi il tema del “velare e svelare” sarebbe stato un filone che ho pensato anche di
imboccare, ma sarebbe stato complicato per me visualizzarlo,
mentre mi piaceva avere in questa sede un discorso di visualizzazione (cfr. FIG. ).
Quindi niente simbolo, personificazione in questa fase, secondo passaggio, e mi ci è voluto molto poco, presenza di un
concetto di pudicizia nella teorica rinascimentale, terzo passaggio.
Ebbene di pudicizia parla niente meno che Leon Battista Alberti nel De pictura (). Alberti sottolinea la complessità e la
ricchezza della grande arte che per lui è la composizione delle
historiae e, quindi, per accentuare le possibilità che la composizione può comportare e stimolare l’artista a usarle dice: «in
un dipinto sievi alcuno ignudo e alcuni parte nudi, parte vestiti, ma sempre si serva alla vergogna e alla pudicizia. Le parti
brutte del corpo ed altre simili, le quali porgono poca grazia, si
cuoprano col panno o con qualche fronde o con la mano». Attenzione, non si tragga l’indebita conclusione che Alberti è l’inventore della foglia di fico, orripilante soluzione censoria che
non è neanche controriformistica, ma compare in età di Restaurazione, per le statue antiche. Questi sono concetti estetici, non morali, poi si capisce ancora meglio: «dipignevano gli
antiqui l’immagine di Antigono solo da quella parte del viso
ove non era mancamento dell’occhio»; questo è un aneddoto
riferito ad Apelle che per trarsi d’impaccio nel fare il ritratto
del re Antigono che aveva perso un occhio, lo ritrae di profilo
– vediamo subito un’immagine – «e dice Plutarco: gli antiqui
pittori dipignendo i re, se in loro era qualche vizio, non voler
TEORIA E PRATICA DEL GESTO COME PUDORE
lo però essere notato, ma quanto potevano, servando la similitudine» – quindi non commettendo, diciamo, errore – «lo
emendavano». Allora sulla base della teorizzazione dell’Alberti possiamo guardare con occhi, diciamo così, corretti questo
celeberrimo ritratto di Piero della Francesca che ritrae Federico da Montefeltro, il quale in un torneo aveva ricevuto un colpo di lancia che, oltre a tagliargli parte del setto nasale, lo aveva privato di un occhio.
Piero della Francesca conosceva perfettamente il trattato
dell’Alberti, anzi si può dire che ci si era formato sopra; quindi, in questo caso, segue la stessa regola di Apelle, anzi forse
conosceva anche l’aneddoto e, quindi, si investiva di questa
grandezza; usava un criterio, perciò, teorizzato pure nella teorica rinascimentale, che è quello della convenienza e della discrezione. La discrezione, in particolare, vuol dire proprio questo: non mostrare il difetto.
Quindi, togliendo assolutamente a Piero l’accusa che in altri tempi gli era stata fatta di avere agito come artista cortigiano, per andare incontro alla necessità di non ledere la dignità
del principe, il ritratto è, invece, perfettamente coerente con
questo tipo di indicazioni. Ma Piero ci sarebbe arrivato anche
senza conoscere l’Alberti, seguendo soltanto la sua perfetta conoscenza delle pratiche pittoriche dell’epoca. In Italia il ritratto di tre quarti arriva, per suggestione fiamminga, molto tardi;
Piero conosceva la pittura fiamminga, ma ne aveva un’altra
proiezione: l’immensa fortuna del ritratto di profilo nel Quattrocento italiano e specialmente nel ritratto di corte, come riferimento al grande modello classico e cioè alle monete antiche
con le immagini degli imperatori.
Questo è un caso interessante, in cui si coglie la dinamica tra
la precettistica e la pratica, perché sia Alberti che Leonardo non
stanno certamente facendo teorizzazioni in astratto, bensì stanno lavorando per i pittori.
Il De pictura è il primo trattato in Italia indirizzato alla pratica dei pittori e quel che afferma Alberti ha poco a che fare con
precetti moralistici; ha molto a che fare però con altri concetti
ELEONORA BAIRATI
di tipo normativo-precettistico, come la discrezione, di cui ho
appena detto, e la convenienza.
La convenienza, donde nel traslato il termine s-convenienza,
per l’appunto, era il rapporto armonico di tutte le parti della
composizione: convenienza che poteva anche essere detta decoro, applicato, nel significato di rapporto armonico tra le parti,
soprattutto nella precettistica architettonica.
Dice Leonardo: «osserva il decoro, cioè la convenienza dell’atto, vesti, sito e circospetti» cioè gli elementi accessori «della
dignità o viltà delle cose che tu vuoi figurare»; questo è un dato molto importante, perché la convenienza o il decoro non significano esclusivamente bellezza armonica. Il Rinascimento
raffigura anche la bruttezza fisica, il difetto fisico, purché rispetti la convenienza, la convenienza della storia, del soggetto,
del luogo.
Dice ancora Leonardo: «si deve osservare il decoro, cioè che
i movimenti siano annunziatori dell’animo del motore» e Leonardo è uno straordinario artista dell’animo, cioè dell’affiorare
dei sentimenti dell’animo, sempre con la convenienza al luogo
e al momento, manifesto strepitoso di Leonardo in questo senso è l’Ultima cena.
Quindi da un lato abbiamo un’iconografia di un certo tipo,
dall’altro, la presenza di questo concetto della pudicizia come
convenienza nella teorica; ma poiché l’arte vive dell’arte, non vive solo, anzi vive poco di precettistica, ma moltissimo di conoscenza della tradizione, del tramando, non si fa fatica a trovare
nella pratica dell’arte, quindi nelle immagini e nelle opere, il
concetto di pudicizia tradotto in forma attraverso il gesto.
Il gesto è portatore di significato ma è anche, contemporaneamente, uno schema visivo e l’arte cresce sullo schema; questo gesto è quello della Venere pudica. La meravigliosa statua
che si trova collocata agli Uffizi, meglio conosciuta come Venere dei Medici, è la più nota di questa tipologia, talmente nota da attraversare il tempo e da ritrovarla sul pulpito del Duomo di Pisa di Giovanni Pisano (-); nella sua straordinaria complessità, appare come un’enciclopedia figurata: al
TEORIA E PRATICA DEL GESTO COME PUDORE
centro della struttura monumentale, c’è un pilastro vivente di
figure che lo sostiene, che reca nel registro superiore le virtù
teologali – fede, speranza, carità; in questo pilastro che stiamo
vedendo, invece, compaiono le virtù cardinali.
Giovanni Pisano ha così tradotto la Venere pudica – notiamo il gesto che è schema formale, tra l’altro di straordinaria eleganza, vediamo un braccio allungato, quello che cela il sesso,
l’altro piegato a coprire i seni, identico persino nella posizione
di equilibrio, di contrapposto classico della posizione delle
gambe, alla Venere pudica degli Uffizi – come “temperanza”.
Questo gesto di pudore, quindi, è per lui espressivo di ciò che
la temperanza vuol dire, cioè moderazione e controllo su se stessi e sul proprio vivere.
Che in pieno Quattrocento la Nascita di Venere di Botticelli
riprenda esattamente lo schema, con in più la bellissima invenzione del manto dei capelli – diceva Alberti «coprire col drappo» – che, in questo caso, sono meravigliosi capelli biondi, non
sorprende certamente; qui lo schema formale e la sua eleganza
prevalgono sul fatto che il gesto sia portatore di significati. Così
lo aveva usato Giovanni Pisano, mentre per Botticelli è proprio
il ritmo assolutamente impeccabile di un artista che è anche uno
straordinario grafico e un amante della linea, ad essere espresso
in questo modo.
Vorrei concludere con questa cosa straordinaria: la Cacciata
di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre di Masaccio, che si trova
nella Cappella Brancacci al Carmine (); ho scelto intenzionalmente di illustrare l’immagine prima del restauro, perché
compare un’aggiunta, veramente goffa e orripilante, benché antica, di fronde che velano il sesso di Adamo. Nell’ultimo restauro le fronde sono state tolte, giustamente, anche perché le
analisi a luce radente hanno dimostrato che la pittura sottostante di Masaccio era perfetta.
Ora, che i progenitori siano raffigurati nudi non solo è “conveniente” ma è obbligatorio, perché la Genesi dice: «prima del
peccato erano nudi e non se ne vergognavano»; e, infatti, anche
in pieno Gotico i progenitori sono comunque raffigurati ignu
ELEONORA BAIRATI
di: qui la cacciata raffigura un tempo che è posteriore al peccato. Ugualmente, sempre nella Genesi si legge: «si accorsero di
essere nudi e se ne vergognarono e presero delle fronde per farsene cintura»: alibi e giustificazione per l’azione censoria di aver
messo poi le fronde sulle due figure.
È straordinario il fatto che qui non è solo vergogna ma è dolore, cioè la consapevolezza di quello a cui andranno incontro,
a provocare questa disperazione; per cui, il gesto umanissimo di
Adamo che si copre il volto e non il sesso è del tutto naturale,
così come il gesto di questa Eva che grida il suo dolore, il volto
ridotto a una maschera espressiva; bisogna davvero fermarsi a
riflettere per accorgersi che Eva ha lo stesso gesto della Venere
pudica, senza abbellimenti, in questo caso; il gesto, però, è altamente significante, è il gesto del pudore – «si accorsero che erano nudi e ne ebbero vergogna» ed è, insieme, dolore della carne, anche perché la figura di Eva in questo caso non ha né l’eleganza, né le motivazioni che abbiamo visto prima.
Questo per dire che nella pratica artistica, il lavoro sull’immagine e su ciò che l’immagine veicola, è sempre fuso con la necessità di chi sta lavorando. Per questo l’immagine è sempre polissemica, perché è un intreccio fra la tradizione, la precettistica, il rinnovamento, la committenza e con una lunga serie di altre problematiche.
TEORIA E PRATICA DEL GESTO COME PUDORE
La Pudicitia, dall’Iconologia di Cesare Ripa,
FIGURA
Abitare una distanza prossima:
una prospettiva sul pudore
di Carla Danani
Che cosa è mai il pudore? Non si può prescindere dalla dimensione storica per rispondere a questa domanda: di volta in
volta si segnalano come pudichi una reazione oppure un’altra,
un atteggiamento oppure un altro, a seconda di ciò che viene
“per lo più” percepito come “conveniente”, di contro a ciò che
viene sentito come sfacciatamente inopportuno. Diverse sono
le interpretazioni di tale convenire: e se la convenienza può essere declinata come conformismo o addirittura opportunismo,
è anche vero, però, che può esprimere un agire misurato, che
si tiene nei giusti limiti. Tuttavia, anche avvenuta la ricognizione storica e l’accertamento di questo multiverso di significati,
rimane da porre una domanda ulteriore e da indagare ancora
che cosa sia mai che, nel cambiamento, fa da regola a che, nonostante le diverse forme, parliamo di pudore e insieme, nonostante una loro comune contrapposizione alla “troppa esposizione”, ad alcune forme dell’“esser misurato” non diamo
questo nome.
Si può forse individuare una ricorrenza che è come la filigrana della plurisignificazione del pudore, che ne è, appunto in questo senso, regola. Ciò forse non vorrà dire riportare un ordine
univoco nel multiverso, e neppure ridurre l’ambiguità più sotterranea, dell’umano, che sembra annunciarsi in esso: ma non è
questo il punto. Si tratta piuttosto, più in generale, di comprendere quali disposizioni e quali pratiche preservare, promuovere,
oppure riabilitare, per una piena fioritura dell’umano: e forse il
pudore, nella sua inattualità, richiama a qualcosa che ne deve far
parte a pieno titolo.
CARLA DANANI
Nel multiverso di significati che disorienta l’interrogazione diretta e nel disagio di un’ambiguità che può essere ridotta solo accettando il prezzo di un pregiudizio di impoverimento, l’indagine è bene che si muova nel segno di un “taglio”
laterale: cercando, senza voler disporre anticipatamente di
una definizione e seguendo, piuttosto, ciò che si è depositato
nel nostro “senso comune”, di rintracciare il pudore là dove si
dà in esercizio in quelle che sono le pratiche consuete, i temi
della vita quotidiana e le questioni secolari della filosofia. Si
potrà coglierne di qui qualche suo tratto non accidentale, il ricorrere di una movenza che lo fa riconoscere, e interrogare allora questo tratto, questa movenza, circa la posta in gioco, “di
che ne va”.
Il nostro “taglio laterale” prende la strada dell’esperienza
ermeneutica e, in particolare, dell’interrogazione filosofica su
quella dialettica di familiarità ed estraneità che la costituisce .
La riflessione ermeneutica non intende la distanza come un
abisso da colmare, perché separa e allontana, ma come ciò in cui
si radica il comprendere : mette a tema una distanza che se non
diventa mai un abisso, tuttavia non si riduce mai fino ad esaurirsi, che testimonia una prospettiva sempre situata e avvertita
della propria finitezza e però sempre alla ricerca dell’intero, nel
movimento della parte e del tutto.
La distanza di cui vive l’ermeneutica ha quindi il senso di
quella non coincidenza e non appropriazione che aprono la
possibilità per lo spazio della relazione. È una distanza abitata
secondo una tonalità particolare: dice ritegno piuttosto che reticenza, dice partecipazione piuttosto che indifferenza, apertura e attraversamento piuttosto che rigida chiusura.
In qualche modo il movimento di questa distanza sembra
dire qualcosa della dimensione del pudore, sembra fare un po’
di luce su ciò che, di volta in volta e diversamente, nelle sue forme singolari, ma per lo più, viene chiamato pudore o dichiarato come sua assenza. Va anche detto che, di contro, se si può
tentare di intendere la distanza come chiave interpretativa per
comprendere ciò che chiamiamo pudore, in questo modo si ar
ABITARE UNA DISTANZA PROSSIMA : UNA PROSPETTIVA SUL PUDORE
riverà forse a dire del pudore come tono dell’autentica pratica
ermeneutica, la quale non è una teoria della conoscenza, ma il
modo di stare al mondo che si articola come dialogo, esercitandosi come esperienza teoretica e pratica.
Per una rilettura del pudore in questa direzione ci si può
avvalere, a sorpresa rispetto alla vulgata che lo vuole esaurire
nelle parole della continuità, della familiarità e dell’intesa, delle sollecitazioni dell’ermeneutica di Gadamer. Gadamer filosofo della distanza? Piuttosto: là dove sembra fuori gioco, si rileva una certa tonalità della distanza, che riverbera nelle movenze della prassi ermeneutica come condizione della sua possibilità.
Gadamer parla esplicitamente di una «funzione ermeneutica della distanza» , nella quale diventano accessibili all’osservazione le differenze.
La capacità dislocativa dell’esperienza della distanza agisce
in modo duplice. Da un lato Gadamer parla di «distanza da se
stessi». Essa si rivela nel linguaggio . Infatti l’essere umano, a
differenza degli animali, parla: cioè non realizza solo momenti
espressivi, versi di allarme o di richiamo quali si scambiano gli
animali, ma è in grado di “comunicare”. Egli sa trascendersi e
questo gli rende possibile la relazione con l’altro.
È chi ha preso distanza da sé che sa andare oltre la realizzazione di movimenti espressivi, siano di allarme o di richiamo. Chi non sa prendere distanza da sé, e cioè sa solo esprimer-si, propriamente non parla, perché il linguaggio è invece
accoglimento di altro.
Ora, chi non sa condividere, parlando, e “si parla addosso”, per parafrasare Woody Allen, non lo diremmo uno “spudorato”?
A prendere «distanza da se stessi» in qualche modo però anche si impara; è importante la formazione, dice Gadamer: il formarsi alla distanza dal proprio saper fare, dalle proprie prevenzioni e dall’autoconsapevolezza delle proprie capacità .
Ci si mette, così, in grado di vedere le cose anche dal punto
di vista dell’altro. E, tuttavia, mai nel senso di poter presumere
CARLA DANANI
l’oblio di sé, qual era l’ingenuità dell’obiettivismo storicistico .
Non si tratta tanto di accantonare ciò che si è per accreditare un
altro, ma di mettersi in gioco tenendosi in gioco. Solo così si può
lasciar entrare in gioco anche l’altro. Questo tenersi in gioco che
custodisce la distanza dell’altro è visto esprimersi, in ermeneutica, nella struttura della domanda.
Ma domandare non è facile, anzi è tra le cose più difficili.
Domandare bene significa aprire delle possibilità e mantenerle aperte. Non è questo un “far spazio”? È il riconoscimento e
la pratica di una distanza non lasciata a sé e tuttavia non piegata al “per me”, esercizio di continuo attraversamento piuttosto che statica attestazione di un dato o tensione a elidere una
separazione.
D’altra parte questo attraversamento è anche accoglimento, risposta a un’altra domanda che interpella: apertura, esposizione, non assimilazione rendono possibile la relazione ermeneutica.
Per esprimere la distanza ermeneutica si può forse far riferimento a quella distanza che caratterizza il theorein. Per Gadamer
il termine “teoria” non intende, come il rapporto teoretico pensato
nell’orizzonte dell’autocoscienza, quella distanza dall’ente che permette di “conoscere ciò che è” in maniera imparziale e lo assoggetta
ad un dominio anonimo. Non è la distanza del rapporto soggetto-oggetto. La distanza della theoria è piuttosto quella della prossimità e
dell’appartenenza. Il senso più antico di theoria è la partecipazione
alla delegazione inviata alla festa in onore di un dio. Contemplare l’epifania del dio non vuol dire considerare in maniera distaccata uno
stato di cose, oppure osservare uno spettacolo meraviglioso: contemplare significa prendere parte autentica a ciò che accade, significa un vero e proprio essere-presso .
Non si tratta, insomma, di una distanza di contrapposizione, ma
della condizione di possibilità della relazione e della differenza
nell’apertura della verità. Per l’ermeneutica, infatti, la verità
non è prima di tutto un tratto distintivo dell’autocoscienza del
ABITARE UNA DISTANZA PROSSIMA : UNA PROSPETTIVA SUL PUDORE
l’uomo, e, di converso, non è la soggettività, istitutrice della verità: nella verità si è, senza potersi mettere mai alle sue spalle. La
ragione dell’uomo deve pensarsi in questa verità, piuttosto che
come un’autocoscienza che si sa opposta al tutto.
L’attraversamento della distanza ermeneutica, allora, si
esprime piuttosto nella forma del ritegno, che della reticenza,
della consapevolezza e della ricerca di una relazione all’intero
che si sa parte.
Ritegno, si diceva, e non reticenza: assunzione comunque
della responsabilità di stare al gioco, di rispondere all’appello.
Se si abbandona qualcosa alla sua distanza assoluta si paga il
prezzo di non sentirlo parlare. Solo nella comprensione «si verifica la riconversione di una morta traccia di significato in senso vivo e concreto», così come «l’essere dell’opera d’arte è gioco che si compie solo con la fruizione da parte dello spettatore» . Certo, ritegno però: se si vuol parlare al posto di ciò che
si cerca di comprendere non si sente più alcun’altra voce che la
propria, e la comprensione fallisce.
Si prende la parola, quindi, la si spende, interpretando, talvolta “si alza la voce”, però nessuno può davvero prendere la
parola per un altro. Tanto è vero che “si comprende diversamente, se pur si comprende”. La comprensione viene da un
mettersi in ascolto di un “per sé” e “per altro” che non si esaurirà in un “per me”. C’è bisogno che si “faccia spazio”, per far
venire alla parola. Lasciando che la distanza continui ad alimentare la relazione: che custodisca il segreto di una verità
non esauribile, continuamente appellante e quindi creativa,
indomabile.
Nel “tra” della distanza ermeneutica si dice che l’uno non è
l’altro. L’ermeneutica sa che non ci si scambiano i posti e protegge, così, la mutualità di ciò che si relaziona dalla trappola dell’unione fusionale. Una distanza che ha il tono della delicatezza, del ri-tegno, va preservata fin nel cuore della mutualità, è distanza che integra con il rispetto l’intimità.
Possiamo allora dire che questa distanza ha la tonalità del
pudore? Non invoca, il pudore, proprio la distanza dell’altro e
CARLA DANANI
la difesa dal mero consumo o dalla mera oggettualizzazione, la
non-chiusura e la protezione?
L’ascolto è fatto di attesa, attenzione, pro-tensione che però
si trattiene. Non vi ritroviamo la stessa movenza di quel che
chiamiamo pudore? Il pudore non è vergogna, che si prova di
fronte ad una negatività già accaduta, ma esercizio e richiesta di
sospensione, una pausa in nome dell’attenzione, allorché si coglie che diversi sono gli esiti possibili della relazione.
Si potrebbe parlare, allora, di patologie della distanza, che
di converso illuminano in controluce la tonalità del pudore. Patologie dell’eccesso e del difetto.
La pretesa di eludere la distanza, quindi, da un lato: l’imporre la propria parola anziché il lasciar parlare e il rispondere, il pretendere anziché il chiedere, la tensione ad un attraversamento esaustivo, le richieste di perfetta trasparenza, veridicità, fondatezza, identificazione. Si tratta di un esigere che,
nella pretesa di guadagnare la totalità dell’altro, o non trova
altro che sé, o perde il contatto con la condizione di esseri
umani iniziati a una vita comune; porta infine ad una sorta di
cecità per troppa luce, ad uno stato di isolamento e alienazione per richiesta eccessiva. È forse, questa, una versione della
spudoratezza?
D’altro canto la celebrazione assolutizzante della distanza,
e quindi la reticenza o l’indifferenza: il rinunciare al mettersi in
gioco convinti dall’impulso scettico che profetizza l’impossibilità di un rapporto autentico all’alterità. È forse anche questa
una versione della mancanza di pudore, ora nella sua declinazione che può divenire noncuranza e non-sensibilità verso l’alterità dell’altro?
Entrambe le patologie della distanza minano la possibilità
della relazione, mettendone in crisi una sua condizione essenziale.
Forse di esitare, piuttosto, chiede il riconoscimento della
distanza, di esitare a chiudere in un concetto, in una definizione, in una formula discorsiva, in un possesso, di esitare perché “c’è dell’altro”. Di esitare continuando il gioco, conti
ABITARE UNA DISTANZA PROSSIMA : UNA PROSPETTIVA SUL PUDORE
nuando a rimanere in cammino, sapendo che si sarà sempre
“qui” o “là”, senza poter saltare al di là della propria ombra
ma che, tuttavia, il dialogo fa sì che la prospettiva e l’orizzonte si muovano. La polarità di familiarità ed estraneità che fonda il compito dell’ermeneutica fa appello a questo “abitare
camminando”.
Questo modo di stare nella relazione sembra costituire anche la filigrana del pudore. Un modo che, pur prendendo forme concrete diverse, ha appunto i toni del riconoscimento e della richiesta di una distanza come sua condizione di possibilità.
Il pudore viene a configurarsi, allora, come quel modo di abitare la distanza che è “far spazio”, “apertura”, “raccoglimento”,
“rimando”, “attenzione” che custodisce la capacità della parola di dischiudere un’infinità di possibili ulteriori parole: perché
c’è sempre ancora un’altra parola da dire o da lasciarsi dire, se
non si riduce l’altro a cosa. Il pudore custodisce la possibilità
del dialogo che è infinito , del dialogo che «ha un’interna infinità o non ha fine» .
Si tratta allora di una pratica non meramente resistenziale
ma creativa, fucina di futuro.
L’ermeneutica sembra dirci, anche, che forse qui non si tratta, semplicemente, di un’istanza etica, che faccia appello alla
buona volontà del soggetto. Certo «bisogna cercare di comprendere l’altro, e questo significa che bisogna essere preparati ad
avere torto» , ma anche «gli esseri immorali si sforzano di comprendersi» . La riflessione che nasce dalla prassi quotidiana del
parlare e del comprendere rende chiaro che se la tonalità dell’esperienza ermeneutica non è un certo modo di abitare la distanza, non c’è comprensione affatto, e non, soltanto, che allora c’è
una cattiva comprensione. Si tratta di una preliminare condizione di possibilità che, poi, la scelta morale può declinare o forzare in una direzione o in un’altra.
Troviamo qui un accenno di risposta anche alla famosa accusa di Derrida, esposta nel suo intervento Buone volontà di potenza, secondo la quale dietro lo sforzo dell’ermeneutica – di
comprendere l’altro –, dietro il suo “appello alla buona vo
CARLA DANANI
lontà”, dietro la sua aspirazione al “consenso”, si nasconderebbe in effetti una “volontà di potenza”, che va smascherata. Derrida propone di considerare se la condizione del comprendere,
lungi dall’essere la disponibilità illimitata al dialogo, che l’ermeneutica sollecita, non sia piuttosto «l’interruzione, la rottura
[rupture] del rapporto, un certo rapporto di interruzione, la sospensione di ogni mediazione» . Piuttosto che condurre ad
un’intesa e ad un accordo, non dovrebbe, il dialogo, preservare
la differenza delle opinioni e rispettare l’altro nella sua alterità
inappropriabile? Non dovrebbe salvaguardare il disaccordo?
Per l’ermeneutica il Bruch, l’interruzione, segna l’inizio del
confronto e del dialogo, non lo conclude; certo questa frattura
non verrà mai definitivamente sanata e il non-comprendere non
sarà mai eliminato, ma pur sapendo ciò ed esperendolo ogni
volta nei limiti del dialogo, anzi proprio per questo, l’ermeneutica si dispone ad un dialogo infinito – a partire dall’interruzione. L’interruzione è qualcosa di originario nella misura in cui
originaria è la relazione, che si partecipa come linguaggio, in
quella lingua che prima di essere nostra è già sempre altrui, e
che nelle parole da noi proferite dice sempre altro da quelle
stesse parole.
Così «il dialogo che noi siamo è un dialogo senza fine. Nessuna parola è l’ultima, come non c’è una prima parola» : l’importante, per Gadamer, è serbare questa infinità, ed essa si serba custodendo l’interruzione nella relazione, tenendosi nel segreto di una distanza prossima. Una prossimità pudica?
Note
. H.-G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano , p. (d’ora in poi VM).
. Id., Del circolo dell’intendere, in Id., Verità e metodo , Bompiani, Milano (d’ora in poi VM ).
. Id., Autocritica, in VM , p. ; non è rilevante, qui, affrontare la questione della primarietà o meno della distanza temporale.
. Id., Elogio della teoria. Discorsi e saggi, Guerini e Associati, Milano
, p. .
. Ivi, pp. -.
ABITARE UNA DISTANZA PROSSIMA : UNA PROSPETTIVA SUL PUDORE
. Id., Del circolo dell’intendere, cit., p. .
. Id., La ragione nell’età della scienza, il Melangolo, Genova , p. ;
cfr. inoltre VM, p. .
. Id., La ragione nell’età della scienza, cit., p. .
. Id., Fino a che punto il linguaggio preforma il pensiero?, in VM , pp.
-.
. Id., Uomo e linguaggio, in VM , p. .
. VM, pp. -.
. Id., E tuttavia: potenza della volontà buona, in “aut aut”, -,
, p. .
. J. Derrida, Buone volontà di potenza (risposta a Hans-Georg Gadamer), intervento nell’ambito di un incontro tra Gadamer e Derrida organizzato dal Goethe Institut di Parigi, aprile , trad. it. in “aut-aut”, -,
, p. .
. H.-G. Gadamer, Dekonstruktion und Hermeneutik, in Id., Gesammelte Werke : Hermeneutik im Rückblick, Mohr, Tübingen , pp. , .
Il pudore come sentimento dell’intero
di Francesco Totaro
Il pudore in sé e la prospettiva dell’intero
Portare il pudore a chiarezza concettuale può sembrare una
pretesa insostenibile, dal momento che, più di altri sentimenti,
il pudore è per sua natura quasi inafferrabile. Ad una prima ricognizione emerge la doppiezza del suo spessore semantico.
Anzitutto per la sua contiguità con il sentimento di vergogna,
tanto che in alcuni lessici indo-europei uno stesso termine li indica entrambi (shame, Scham). Tale contiguità non è casuale. Infatti, sia il pudore sia la vergogna (lat. verecundia, da vereor) si
definiscono a partire da una zona di rispetto alla quale allude un
confine non oltrepassabile. A chi compete tracciare la linea di
confine e dove essa si situa? La difficoltà di attribuire a qualcuno il codice del pudore si riflette nell’uso impersonale del latino pudet. Il pudēre rinvia a una forza anonima, che può discriminare, in base all’autorità di un costume condiviso, ciò che è
permesso da ciò che non è permesso, il lecito dal non lecito (del
resto una coniugazione impersonale hanno pure licet e decet).
Inoltre, forse proprio in ragione della natura fluida della sua codificazione, il pudore si manifesta in forme storiche sempre
molteplici o addirittura in forme che non si riuscirà mai a portare a manifestazione.
C’è però da chiedersi se sia possibile, pur scontando l’insuperabile insondabilità e la variabilità storica del pudore, mettere a tema il suo livello trascendentale o la condizione che ac
FRANCESCO TOTARO
compagna in modo persistente l’esperienza che di esso facciamo. Del resto, nei suoi mutamenti non si dà pur sempre a vedere la costanza del pudore e, per quanto il pudore sia qualcosa di variabile, esso non rinvia a una permanenza o a una sorta
di essere in sé?
Il pudore in sé sembra delinearsi come una zona di confine
che allude a una dimensione sconfinata; è la soglia cui è sotteso un orizzonte abissale che perciò può essere detto difficilmente, tanto meno si lascia cogliere in modo sistematico. In
una pregevole analisi del pudore corporeo – si tenga conto
però che il corpo non è l’unico depositario del pudore – Virgilio Melchiorre notava che il pudore riguardo al corpo, nel rifiuto opposto a chi lo voglia possedere anche con la semplice
violenza dello sguardo, significa affermare «io sono più del
mio corpo» . Il pudore in questo caso scatta allorché si è invasi dalla spiacevole o fastidiosa intuizione che, attraverso la
fruizione separata del corpo, si venga ridotti esclusivamente a
cosa. Il mio corpo viene separato da me e viene messo a disposizione di un altro che si atteggia a padrone di ciò che mi
costituisce.
Ma il corpo, si diceva, non è l’unico depositario del pudore.
Max Scheler ha distinto il sentimento del pudore corporeo da
quello più propriamente psichico-spirituale. Prima però di accedere alla loro trattazione rispettiva, egli ha cercato di dare
conto della «legge ultima» dell’origine dei «molteplici fatti
concreti» nei quali si manifestano il pudore e il sentimento del
pudore e l’ha rintracciata in «una certa disarmonia dell’uomo
tra il significato e le esigenze della sua persona spirituale, da
una parte, e i suoi bisogni corporei, dall’altra» . La valenza essenziale degli atti propri della persona, per cui essi si svolgono in modo indipendente dai dati di fatto obiettivi o contingenti entro cui la persona stessa si trova a vivere, a causa di tale disarmonia è inevitabilmente costretta a ripiegarsi in un ambito esistenziale contrassegnato dal limite e dalla dipendenza.
Per esempio, l’artista immerso liberamente nella creazione di
colori e sfumature secondo le esigenze di un mondo essenzia
IL PUDORE COME SENTIMENTO DELL’ INTERO
le, improvvisamente si ritrova riportato alla consapevolezza
circoscritta del suo esistere come «un certo uomo, con un dato nome, sottomesso a tutte le leggi della natura, in mille modi dipendente dall’insieme delle relazioni causali di cui fa parte» . Nel brusco passaggio, che coinvolge la medesima persona, da un’apertura intenzionale illimitata ai vincoli imposti
dallo spazio e dal tempo, si viene a fare l’esperienza di una restrizione o, per dirla di nuovo con Scheler, di una caduta in cui
emerge il sentimento del pudore. La costrizione repentina al
limite ci scopre in una nudità radicale che è la condizione di
possibilità di ogni ulteriore esperienza di nudità come riduzione passiva, o persino violenta, della nostra intenzionalità.
La nudità è qui da intendersi come privazione di ciò che non
può non costituirci e il pudore che ne consegue, o le si accompagna, come il sintomo immediato dell’offesa che la privazione comporta. Il pudore recepisce e insieme rifiuta il misconoscimento che ci investe nel nostro essere più proprio,
che non sopporta l’amputazione del lato della intenzionalità
ideale da quello dell’effettualità. Il pudore è anzitutto pudore
di sé, a motivo di una non compiutezza che ci sorprende, di un
meno che ci assale improvvisamente e ci rende deficitari in
modo intrinseco, prima ancora che altri ce ne diano un riscontro esterno.
Queste osservazioni permettono di inquadrare il pudore nel
suo spessore di esperienza complessiva dell’umano e ci spingono all’analisi della struttura ontologica che la sottende.
Perché il pudore denuncia un’aspirazione tradita all’intero
della persona? E prima ancora: quale nesso tra la persona e l’intero nel cui orizzonte essa sempre si comprende? Cerchiamo di
portare alla luce alcune evidenze. La struttura dell’esserci, che
si lascia cogliere in ogni essente, consiste nell’apertura a un orizzonte interale che si schiude sempre a partire da un punto di vista. Quindi la coscienza di ciascuno – e intendo per coscienza il
centro dinamico dei molteplici atti dell’apertura all’essere – è sì
coscienza interale, ma sempre situata e collocata in una prospettiva che è parziale. La dimensione interale dell’esserci con
FRANCESCO TOTARO
serva perciò un carattere pur sempre invisibile (le potremmo
anche dare il nome di mistero, se non fosse parola abusata), dal
momento che ogni esserci espone o esibisce soltanto uno dei lati o delle facce che lo costituiscono.
Probabilmente proprio questa invisibilità, mai riscattabile,
ha a che fare con la fragilità che rende l’esserci inquieto nella
rappresentazione di sé, segnata da oscillazione e irresolutezza.
Si dà un rapporto squilibrato dell’esserci all’essere nel quale le
manifestazioni possibili sopravanzano ogni manifestazione attuale. Il rapporto dell’esserci con l’essere è strutturalmente inconcluso, cioè “non finito”.
Il pudore nella relazione con l’altro
Ma in che modo al pudore di sé, costitutivo di ciascuno, si può
affiancare l’esperienza del pudore nella relazione con un altro? La mia fragilità e la mia inconclusività sono per ciò stesso aperte all’altro e in lui potrebbero ricevere un completamento positivo all’essere che ancora mi manca. La mia prospettiva potrebbe ricevere integrazione dalla prospettiva altrui nella convergenza a una comune pienezza d’essere. Perché accade che il gioco delle prospettive dia invece luogo a una
logica di intrusione, che di nuovo suscita in me l’esperienza
del taglio tra la mia dimensione intenzionale e la mia dimensione effettuale? Ciò non accade forse perché l’altro mi impedisce di coltivare la mia peculiare prospettiva all’essere e mi
piega al suo punto di vista innalzandolo a una soffocante pretesa di interalità?
Facciamo un passo indietro. Beninteso, l’altro può essere latore, nei miei confronti, di un’offerta di senso che si configura
come dono senza imposizione e prevaricazione. In tal caso il pudore caratterizza lo stesso esercizio del dono da parte di colui
che dona, in quanto egli non mi fa pesare il suo atto mantenendolo nel nascondimento e nella discrezione. In questa direzione Nietzsche, in un aforisma () di Aurora che porta il titolo
IL PUDORE COME SENTIMENTO DELL’ INTERO
Pudore di colui che dona, dice dell’importanza di donare senza
mostrare il proprio viso e, di contro, del carattere opprimente
del dono che invade:
È così ingeneroso far sempre la parte di colui che dà e che dona, e
mostrare in tutto questo il proprio viso! Bisogna dare, invece, e donare, senza rivelare il proprio nome e il proprio beneficio. Oppure
non averlo, un nome, come fa la natura, in cui appunto quel che massimamente ci rallegra è non incontrarvi finalmente più nessuno che
dona e che dà, più nessun “volto misericorde”! – Senza dubbio anche questo conforto ve lo fate sfuggire introducendo un Dio in questa natura – ed ecco che allora tutto ritorna non libero e opprimente. Come? Non poter mai essere soli con se stessi? Mai più incustoditi, indifesi, senza dande, senza doni? Se sempre un altro è intorno
a noi, è reso impossibile il meglio del coraggio e della bontà nel mondo. Contro questa invadenza del cielo, contro quest’inevitabile vicino soprannaturale, non si desidererebbe darci interamente in balia
del diavolo?
Verrebbe da replicare a questa denuncia nietzschiana del “cielo invadente” che il Dio del pudore è forse quello che fa sentire la sua voce nel soffio leggero della brezza quando parla a
Elia oppure quello che si manifesta nella debolezza del Cristo crocifisso. In entrambi i casi si tratta di un Dio che dona la
sua parola o la sua vita senza mostrare il proprio viso e lasciando all’uomo il libero gioco del riconoscimento. Ma la duplice tipologia del dono descritta da Nietzsche discrimina con
efficacia l’atteggiamento di colui che dona autenticamente,
sottraendosi all’effetto di ipoteca – sempre in agguato – su chi
riceve il dono, dall’atteggiamento di colui che dona appunto
per sottrarre al destinatario del dono lo spazio della sua identità o dell’essere “solo con se stesso”, dell’invisibilità in cui ciascuno è costituito e in cui ciascuno “nasconde” la propria prospettiva all’intero. Chi dona con pudore nega se stesso, mentre chi dona senza pudore nega colui a cui dona. Il pudore è
l’atto di ritrarsi dal dono per non rovesciarlo in beneficio per
se stesso.
FRANCESCO TOTARO
Potremmo aggiungere che il dono senza pudore introduce
una sottomissione che schiaccia il ricevente e induce in lui la
vergogna, quindi una forma di pudore passivo, per la riduzione
a nudità ontologica di fronte all’arroganza che accompagna il
dono impudico. L’antidoto al dono che non rispetta il donatario sarebbe la declinazione anonima del dono stesso, grazie alla
quale il soggetto donante, più che diluirsi nell’impersonalità del
“si dona”, dovrebbe aprirsi all’orizzonte del “noi doniamo”. Se
siamo “noi” a donare, il dono non appartiene a me più di quanto non appartenga ad altri e, perciò, il dono che mi viene dall’altro incentiva al tempo stesso la mia capacità di donare, secondo una reciprocità che non si riduce né all’equivalenza dello scambio né all’uniformità di una distribuzione geometricamente egualitaria. Il donare si darebbe, in definitiva, secondo la
logica di una proporzione analogica che garantirebbe l’identità
e le differenze, mettendo però ciascuno nella condizione reciproca di essere donante e donato. Il «vivere senza doni», da
Nietzsche rivendicato, si traduce allora, piuttosto, nella denuncia del dono unilaterale, in quanto produce l’effetto della dipendenza e della negazione del «meglio del coraggio e della
bontà del mondo», di cui ciascuno è responsabile pena la propria insignificanza o l’accettazione di una condizione patologica di minorità.
Pertanto, rispetto alla dimensione di non finitezza o di non
conclusività che custodisce al tempo stesso una interalità possibile, viene vissuto negativamente ogni atto di espropriazione
della singolare prospettiva all’essere attraverso l’imposizione di
una prospettiva altrui. L’altro mi impone la sua prospettiva e
quindi esercita un potere di sostituzione della mia capacità di
rapporto all’intero. L’altro non si propone come mediazione per
l’intero e quindi come prospettiva che amplia lo spazio della
mia prospettiva arricchendola e completandola. La mia prospettiva viene semplicemente eliminata a vantaggio di una prospettiva che non mi appartiene e mi esclude, paradossalmente,
attraverso una inclusione impropria.
IL PUDORE COME SENTIMENTO DELL’ INTERO
La dialettica del pudore
tra negazione e affermazione
A questo punto siamo in grado di considerare le strategie di
elaborazione del pudore da parte di colui che viene offeso
nella propria consistenza ontologica o viene spogliato, letteralmente, del proprio essere. Il pudore registra la forzata spoliazione di sé ma insieme esprime la resistenza basilare alla
pretesa di espropriazione e di spossessamento, fino alla protesta e alla riaffermazione di sé. Axel Honneth, in un contesto teorico decisamente allergico all’approfondimento trascendentale, ha però scandagliato efficacemente «i sentimenti di reazione negativa che accompagnano l’esperienza del misconoscimento» e, rovesciandosi in funzione positiva, «possono rappresentare proprio la base pulsionale-affettiva alla
quale la lotta per il riconoscimento è ancorata dal punto di vista motivazionale» . Sentimenti quali la vergogna o l’ira, l’offesa o il disprezzo sprigionano un potenziale cognitivo e pratico in grado di operare il passaggio – si potrebbe dire – dai
sintomi della frustrazione, collegata o alla violenza fisica o alla privazione dei diritti o all’umiliazione del proprio modello
di vita, alla terapia rigeneratrice dell’autostima e del rispetto
altrui. Il recupero di un riconoscimento interrotto e il corrispettivo risanamento del misconoscimento subito viaggiano
sull’onda di una dignità antropologica indisponibile alla propria soppressione:
La ragione di ciò dev’essere nuovamente ravvisata nella costitutiva dipendenza dell’uomo dall’esperienza del riconoscimento: per giungere a una relazione riuscita con se stesso, egli deve ottenere il riconoscimento intersoggettivo delle sue capacità e prestazioni. Se questa
forma di approvazione sociale viene a mancare a qualche livello del
suo sviluppo, nella sua personalità si apre, per così dire, un vuoto psichico che si esprime nei sentimenti di reazione negativa come la vergogna o l’ira. Per questo l’esperienza del misconoscimento è sempre
accompagnata dalle sensazioni affettive che per principio possono ri-
FRANCESCO TOTARO
velare al singolo che gli vengono negate socialmente determinate forme di riconoscimento .
Il sentimento di vergogna si rivela allora in tutta la sua pregnanza morale e si estende alla globalità della persona, a qualsiasi livello essa sia violata od offesa nelle proprie aspirazioni
normative e di valore:
Tra i sentimenti morali quello che possiede il carattere più manifesto è la vergogna, in quanto con essa non s’intende soltanto l’ovvia
ritrosia, antropologicamente ben radicata, nel mettere a nudo il
proprio corpo; nel caso di questo sentimento non è possibile stabilire in anticipo da quale lato dell’interazione venga violata la norma
morale che per così dire “manca” al soggetto per proseguire secondo routine il suo agire. Il contenuto emotivo della sensazione di
vergogna consiste anzitutto, come hanno concordemente stabilito
gli approcci psicoanalitici e fenomenologici, in una sorta di depressione del senso del proprio valore: il soggetto che sperimentando l’insuccesso del proprio agire si vergogna di sé, si sente dotato di un valore sociale inferiore a quello che si era precedentemente attribuito .
Quando il pudore viene elaborato nel senso della esteriorizzazione, cioè nella forma della vergogna di sé attribuita all’altro e dell’insofferenza per la depressione di sé che dall’altro
deriva, esso può assumere l’espressione della protesta, della
ribellione e quindi della “ricostruzione” di una positiva autoaffermazione. Tutto ciò avviene, vorremmo aggiungere,
non senza lasciare cicatrici nel profondo dell’esperienza. Il
pudore che si risolve in ri-affermazione lascia alle sue spalle
l’angoscia retrospettiva di essere stati nella condizione di poter cedere all’imposizione altrui e di avere vissuto l’esposizione al rischio di indulgere, per così dire, alla caduta nell’acquiescenza all’atto espropriatore. L’essere stati considerati,
anche per un attimo, come cedevoli alla sottrazione della prospettiva propria, cioè del proprio valore, e il dubbio di aver
dato esca a tale pretesa sono ciò che suscita un pudore resi
IL PUDORE COME SENTIMENTO DELL’ INTERO
duale come vergogna per l’immagine di sé abusata dall’altro.
D’altra parte, quest’ultimo viene investito, nel moto reattivo
che parte dalla vergogna, di un disprezzo aggiuntivo pari al
deprezzamento per il quale egli ci ha fatto una richiesta implicita di adesione.
Cerchiamo di precisare ancora. L’esito finale di quella che
potremmo anche chiamare la “dialettica del pudore” è di certo la conferma dell’identità propria e della sua inviolabilità. Ci
sentiamo restituiti a noi stessi. Consideriamo però la causa
scatenante della nostra reazione di pudore in qualche modo
lesiva di quella tenace autorappresentazione di sufficienza che
coincide con il nostro orgoglio, forse perché, anche per un attimo, la nostra prospettiva all’intero ha vacillato e l’invisibilità
della sua dimensione nascosta è stata sul punto di dissolversi
sotto i riflettori indiscreti dell’usurpatore. Resta allora l’inquietudine della domanda: come colui che ha tentato di privarmi della mia relazione all’intero inchiodandomi su una prospettiva d’esserci a me ostile, e ha cercato quindi di amputarmi del mio diritto a una comprensione globale, ha potuto arrogarsi una simile pretesa? Da dove può essere derivata questa intenzione abnorme? Ora che il pericolo è scampato, mi
chiedo come abbia potuto originarsi e come io abbia potuto
essere coinvolto nella sua origine. La promiscuità, anche involontaria, con il pericolo mi turba.
Il pudore senza riscatto
Sempre Honneth fa un breve riferimento a una forma di vergogna provocata da se stessi per essere rimasti al di sotto dell’immagine del proprio Io ideale e della norma morale che le
fa da sostegno. È un concetto che merita di essere approfondito. Si tratta, insomma, in questo caso, di un vissuto di vergogna per l’esperienza di essere inferiori al livello normativo e
assiologico sull’osservanza del quale fondiamo le nostre legit
FRANCESCO TOTARO
time attese di realizzazione. Qui il pudore, come vergogna di
sé di fronte agli altri la cui causa è però attribuita a se stessi,
non prende la via della sua esteriorizzazione, si incanala invece in una forma più subdola e dolorosa senza ritornare, nella
protesta o nella ribellione, all’altro cui è imputata la causa scatenante. Il pudore si inabissa in chi ne è portatore e resta così
ingabbiato in un meccanismo di privazione che si consegna a
un movimento distruttivo. Alla negazione del rapporto all’intero determinata da un’alterità usurpatrice, il sentimento del
pudore risponde torcendo la propria intenzionalità su se stessa. L’immagine di umiliazione che proviene dall’altro entra in
un circolo perverso con la propria autocomprensione. La persona si paralizza nella vergogna per se stessa a causa del sentirsi inchiodata a una rappresentazione di inferiorità irreversibile e senza riscatto. Se il pudore estroverso è capace di aprire una zona di gioco tra ciò che di fatto si è e ciò che si può essere ed è perciò il rifiuto di rimanere imprigionati nella unilaterale brutalità del dato, la sua forma di introversione conduce a disperare della possibilità che la chiusura nell’immagine
imposta dall’altro venga riscattata e si riesca a essere più di ciò
che si è stati costretti a diventare a seguito della riduzione del
nostro essere all’apparire prodotto dallo sguardo di svalutazione dell’altro. Fiducia, stima e rispetto nella relazione con
l’altro vengono ingoiati in una depressione irreversibile del valore di sé.
La privazione dell’apertura interale qui sembra perdere
ogni provvisorietà e lo stigma con cui si è stati segnati appare
come permanente. La prospettiva che sempre siamo, e quindi
l’apertura all’orizzonte non concluso e non finito, si restringe
nella chiusa puntualità di una presenza senza rinvio. Il pudore
si avvita in un processo di implosione che culmina nel disprezzo di sé. Da gioco di sé con sé nell’apertura a un intero invisibile, diventa irrigidimento nella maschera immobile alla quale
ci si sente condannati. La maschera della vergogna, come identità negata, può infine affidare disperatamente alla pulsione di
IL PUDORE COME SENTIMENTO DELL’ INTERO
morte la rottura dell’identità a cui è negato il gioco con l’intero. Quando ho vergogna verso me stesso posso consegnarmi al
corto circuito di morte e liberazione.
Contro l’evanescenza del pudore
e l’appiattimento sull’apparire
Si è visto che l’esperienza del pudore si situa sul confine tra la
dimensione visibile e quella invisibile dell’esserci connettendole entrambe. Essa ha quindi bisogno strutturalmente della
non coincidenza tra essere e apparire o della eccedenza del
primo sul secondo. Senza eccedenza dell’essere sull’apparire
il pudore non sarebbe possibile. Tale eccedenza non è da
confondere con una visione dualistica, poiché l’apparire non
è certamente da intendere come separato dall’essere. Esso
però non copre tutto l’essere, dal momento che l’essere che
appare è una parte dell’essere che potrebbe manifestarsi. Appiattire l’essere sul suo apparire significherebbe allora rinunciare allo stesso apparire in quanto ulteriorità rispetto all’apparire attuale. La contrazione dell’essere nell’apparire comporta la povertà dell’apparire medesimo. Il pudore, rifiutandosi all’apparire separato dall’essere, esige la dignità, insieme,
dell’essere e dell’apparire. Perciò può esprimere la protesta
per il taglio dell’apparire dall’essere che lo anima e per la sua
cattura a vantaggio di un essere non proprio.
Come dar conto allora, al polo opposto della pesantezza
del sentimento di pudore che toglie senso al vivere, delle situazioni connotate dall’assenza di pudore? Come interpretare
alcuni modelli vistosamente invasivi della cultura giovanile attuale, per i quali l’affrancamento dal pudore sembra diventare l’imperativo dominante del costume, al punto che ci si vergogna semmai soltanto del pudore stesso e cioè della non disponibilità alla spudoratezza?
L’evanescenza dell’esperienza del pudore è forse comprensibile in una più generale temperie culturale incline al
FRANCESCO TOTARO
l’appiattimento dell’essere sull’apparire. Non si tratta di coltivare nostalgie repressive. Le forme tradizionali di accanimento riguardo al senso del pudore, riferito soprattutto alla
sfera “materiale”, hanno comportato l’emarginazione dolorosa del corpo dalla positività della persona e alimentato al contempo fantasie morbose di “cattiva” invisibilità. L’alleggerimento del sentimento del pudore comporta però nuove patologie della personalità come l’ossessione per una visibilità
sempre più autoaggressiva ed eteroaggressiva. L’esibizione
corporea può inoltre diventare il tramite comunicativo esclusivo a svantaggio di una conoscenza interpersonale completa
o costituire forma di difesa dal coinvolgimento interale. Insomma, la mancanza di pudore e l’incondizionata propensione ad apparire possono dar luogo a una contrazione della coscienza dell’intero personale e rovesciarsi quindi in una nuova mutilazione. A soffrirne è la capacità di cura responsabile
della relazione con l’altro nell’insieme delle sue componenti.
Se cessa l’attenzione all’invisibile che ci costituisce e cresce, in
alternativa, la paura della responsabilità di un incontro interale, allora si può anche essere disponibili alla riduzione di sé
al semplice apparire istantaneo e alla rappresentabilità fine a
se stessa. La sfera della manifestazione come esibizione diventa assoluta.
Nei confronti di un simile appiattimento, il pudore potrebbe rivendicare legittimamente la propria funzione di sentimento dell’intero, che ciascuno nella sua peculiare prospettiva – nel proprio giardino interiore sempre aperto agli altri –
è chiamato a coltivare.
Note
. V. Melchiorre, Metacritica dell’eros, Vita e Pensiero, Milano , pp.
ss. Ma prima E. Mounier, Il personalismo, trad. di A. Cardin, AVE, Roma
, pp. ss.
. M. Scheler, Pudore e sentimento del pudore, trad. di A. Lambertino,
Guida, Napoli , p. .
. Ivi, p. .
IL PUDORE COME SENTIMENTO DELL’ INTERO
. Ivi, p. .
. F. Nietzsche, Aurora, trad. di F. Masini, M. Montinari, Adelphi, Milano , pp. s.
. Re , .
. A. Honneth, Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto, trad. di C. Sandrelli, Il Saggiatore, Milano , p. .
. Ibid.
. Ivi, p. .
Indice dei nomi
Abbagnano N., ,
Adorno T., ,
Agostino Aurelio, , , -,
,
Alberoni F.,
Alberti L. B., -,
Alembert J.-B. Le Rond d’, ,
Alici L.,
Allen W.,
Anassimandro,
Anderson S., -, ,
Antigono Monoftalmo,
Antonelli A.,
Apelle, -
Arendt H., , , , -
Aristotele, , , , -, -,
Bairati E.,
Baker R., -, , -
Benn S. I.,
Bernstein C.,
Bertelsons R.,
Besozzi T., -
Bethke Elshtain J.,
Biasutti F., , -
Bloch E., ,
Blumenberg H.,
Boatti G., ,
Bonacchi G.,
Bonhoeffer D., ,
Botticelli S.,
Botturi F.,
Cairns D. L.,
Canetti E., ,
Cavadini J.,
Cavallo T.,
Cavarero A.,
Chakravorty Spivak G.,
Chauvin S., ,
Chinese M. G.,
Chiodi P.,
Cixous H.,
Compagnoni F.,
Conte G.,
Corradini F.,
Croce B.,
Dal Lago A., , , , ,
Daly M.,
Danani C.,
Darabi P.,
De Bonafini E.,
Debord G.,
Del Buono O., -
Derrida J., , , -
Descartes R., ,
Devoto G., ,
Diderot M., ,
D’Ippolito G.,
INDICE DEI NOMI
Dodds E. R.,
Dostoevskij F. M.,
Dreyer E. A.,
Duden B.,
Dumont L., ,
Dworkin A., ,
Eisenhower D. D., ,
Erodoto, , -, -,
Esichio, -
Esiodo, ,
El Guindi F.,
Federico da Montefeltro,
Fedro,
Ferretti G., -
Fidia,
Fink G.,
Firestone S.,
Forcellini Ae.,
Foucault M., -, -
Freud S., , , -
Friedan B.,
Furlanetto I.,
Gadamer H.-G., , -, -
Galimberti U., ,
Galling K.,
Gauss G. F.,
Gide A.,
Giuliano S.,
Goclenius R., ,
Goethe J. W.,
Goffman E.,
Gould C. C.,
Groppi A.,
Gründer K.,
Habermas J.,
Halder A.,
Hartog F., ,
Hegel G. W. F., , , -,
Heidegger M., , ,
Held D.,
Hervieux L.,
Hoffman D.,
Hölderlin J. C. F.,
Honig B.,
Honneth A., , ,
Hourihan M.,
Husserl E., ,
Irigaray L., , -
Jankélévitch V., , , , , -,
Jaspers K., , , ,
Jesi F.,
Johnson M.,
Jullien F.,
Kant I., , , , , ,
Kessel J.,
Kierkegaard S.,
Kittel G., ,
Kundera M., -,
Lakoff G.,
Lalande A., ,
La Matina M., -
Lamphere L.,
Lasch C.,
Leonardo da Vinci, -
Lerner G.,
Liebling A. J., , -,
Lipps T.,
Lister R.,
Lombardo A.,
Lonzi C., ,
Luca, evangelista,
Luce H.,
MacKinnon C., ,
Madera R.,
INDICE DEI NOMI
Mannucci E., ,
Marco, evangelista,
Masaccio, Tommaso di Ser Giovanni Cassai detto,
Matta S.,
Matteo, evangelista,
Mauthner F., ,
McLuhan M.,
Melchiorre V., , , -, ,
,
Mendelssohn M.,
Meo O.,
Michel K. M.,
Millet K.,
Mittelstraß J.,
Moldenhauer E.,
Mondin B.,
Moran M.,
Mounier E., -,
Müller M.,
Muraro L., ,
Nancy J. L., ,
Natoli S., , -
Nicholson L. J.,
Nicosia S., , -
Nietzsche F., , , -,
Nixon R. M.,
Noble D.,
Okin S. M.,
Oli G. C., ,
Olivetti M. M.,
Omero, -, -,
Pagliacci D.,
Paolo di Tarso, santo, ,
Pateman C., , , -
Perin I.,
Perri M. L., , ,
Pfister O.,
Piana G.,
Piccolomini R.,
Pieretti A.,
Piero della Francesca,
Pindaro, -,
Pisano G., -
Pitkin H.,
Platone, , , -, , -, -,
, ,
Plutarco, ,
Polanyi M., ,
Privitera S.,
Redford R.,
Ripa C., ,
Ritter J.,
Rosaldo M. Z.,
Rosen J.,
Rosenberg R.,
Rossetti L.,
Rousseau J.-J., , -,
Rovatti P. A., , , , -,
Saffo,
Sartori D.,
Sartre J.-P., , ,
Scheler M., , , , , , ,
-, -,
Selz M.,
Sennett R., ,
Shakespeare W., , -
Showstack Sassoon A.,
Siltanen J.,
Socrate,
Stanworth M.,
Stein E., -
Tagliapietra A., , -
Tarca L. V.,
INDICE DEI NOMI
Thomson R. P.,
Totaro F., ,
Trilling L., -,
Vigna C.,
Viller M.,
Violi P.,
Vogel U.,
Williams E.,
Winer D.,
Wollstonecraft M. S., -
Woodward B., -
Zamboni C., ,
Zambrano M., , , , ,
Zingarelli N., ,