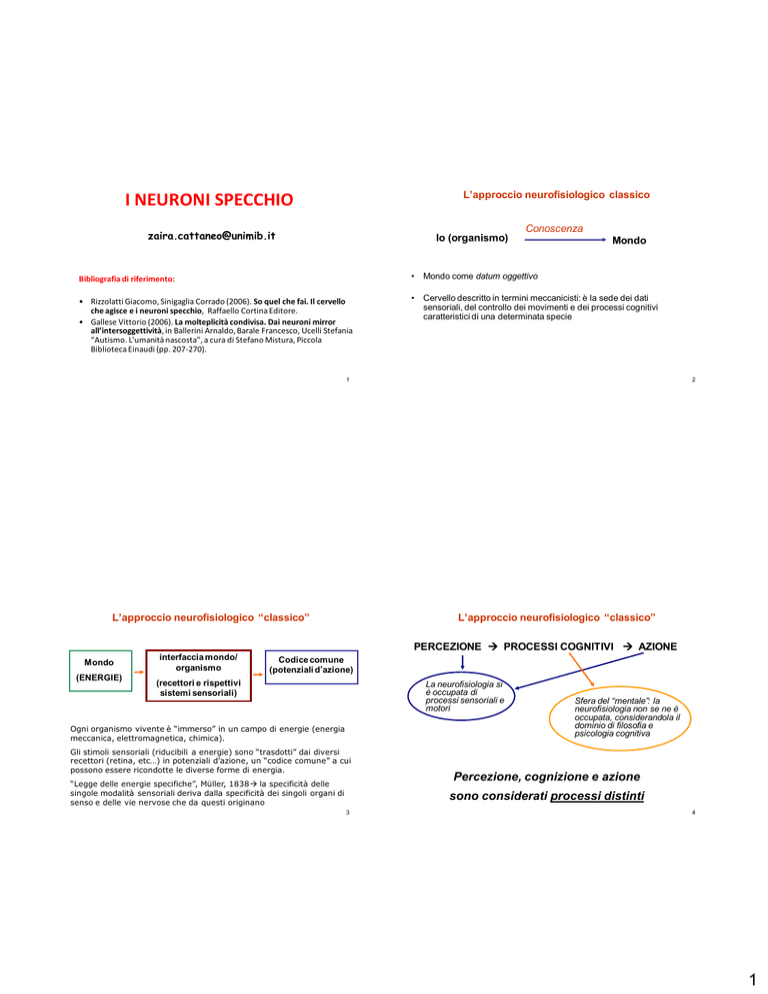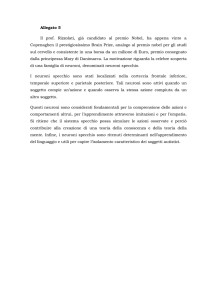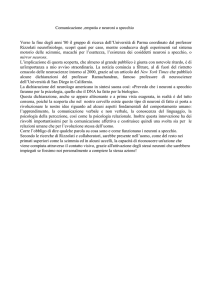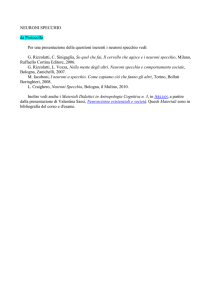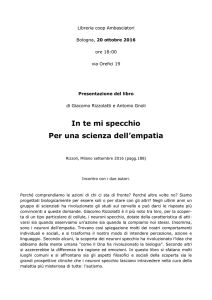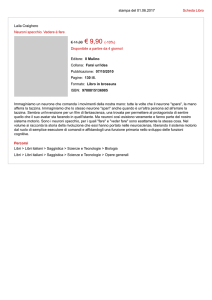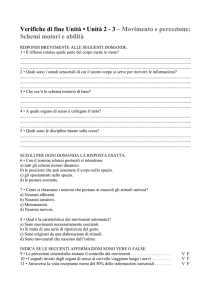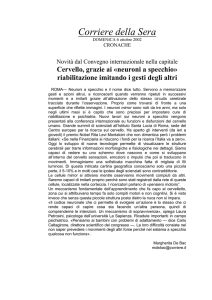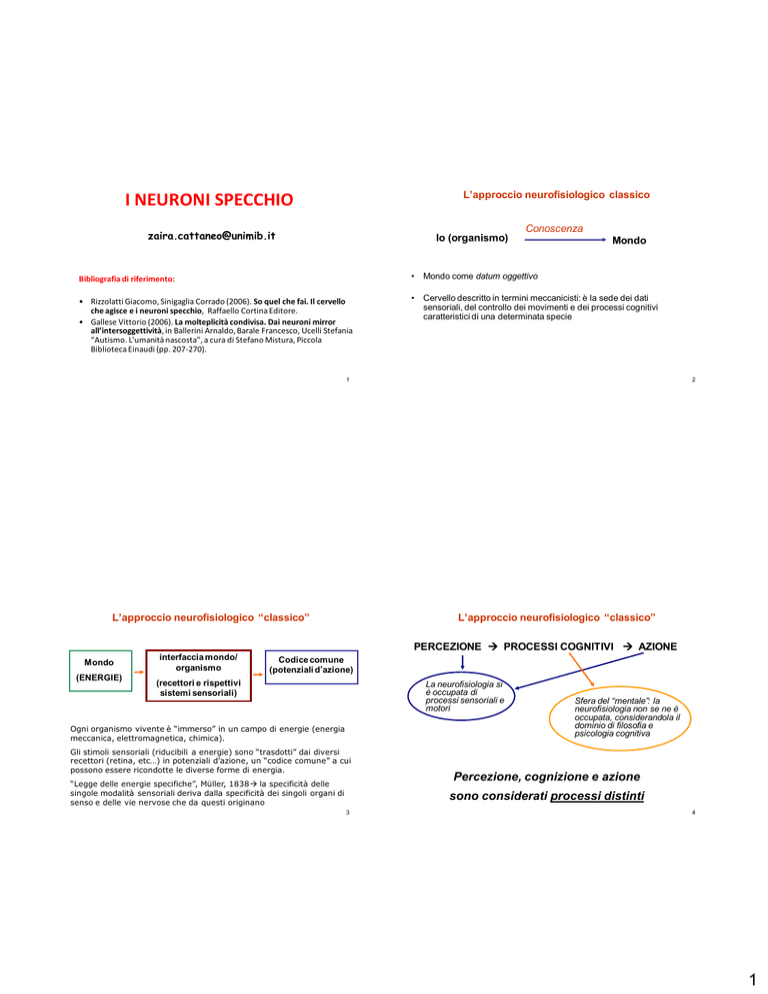
L’approccio neurofisiologico classico
I NEURONI SPECCHIO
Conoscenza
[email protected]
Io (organismo)
Mondo
Bibliografia di riferimento:
• Mondo come datum oggettivo
• Rizzolatti Giacomo, Sinigaglia Corrado (2006). So quel che fai. Il cervello
che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore.
• Gallese Vittorio (2006). La molteplicità condivisa. Dai neuroni mirror
all’intersoggettività, in Ballerini Arnaldo, Barale Francesco, Ucelli Stefania
“Autismo. L'umanità nascosta”, a cura di Stefano Mistura, Piccola
Biblioteca Einaudi (pp. 207-270).
• Cervello descritto in termini meccanicisti: è la sede dei dati
sensoriali, del controllo dei movimenti e dei processi cognitivi
caratteristici di una determinata specie
1
L’approccio neurofisiologico “classico”
2
L’approccio neurofisiologico “classico”
PERCEZIONE PROCESSI COGNITIVI AZIONE
Mondo
(ENERGIE)
interfaccia mondo/
organismo
Codice comune
(potenziali d’azione)
(recettori e rispettivi
sistemi sensoriali)
La neurofisiologia si
è occupata di
processi sensoriali e
motori
Ogni organismo vivente è “immerso” in un campo di energie (energia
meccanica, elettromagnetica, chimica).
Gli stimoli sensoriali (riducibili a energie) sono “trasdotti” dai diversi
recettori (retina, etc…) in potenziali d’azione, un “codice comune” a cui
possono essere ricondotte le diverse forme di energia.
“Legge delle energie specifiche”, Müller, 1838 la specificità delle
singole modalità sensoriali deriva dalla specificità dei singoli organi di
senso e delle vie nervose che da questi originano
Sfera del “mentale”: la
neurofisiologia non se ne è
occupata, considerandola il
dominio di filosofia e
psicologia cognitiva
Percezione, cognizione e azione
sono considerati processi distinti
3
4
1
L’approccio neurofisiologico “classico”
Secondo il modello neurofisiologico classico
Prevede una dicotomia
sistema sensoriale/ sistema motorio
Per prendere qualcosa con la mano il cervello effettua processi
organizzati in maniera seriale:
Input esterno
aree corticali posteriori (sensoriali)
aree associative (cognizione) : compito di “mettere insieme” le
informazioni provenienti dalle diverse aree sensoriali e di formare i
“percetti” oggettuali e spaziali da inviare alle aree motorie per
l’organizzazione dei movimenti.
5
Aree nascoste
all’interno del
solco
intraparietale
corteccia motoria: Il sistema motorio è punto d’arrivo
dell’informazione sensoriale elaborata dalle aree sensoriali ed è in sé privo
di ogni valenza percettiva e cognitiva; ha un ruolo periferico e meramente
esecutivo
6
Perchè ci sono così tante aree motorie?
Tale parcellizzazione sarebbe alquanto sorprendente se le aree
motorie avessero come sola funzione il controllo dei movimenti
recenti dati neurofisiologici dimostrano che le aree motorie giocano
un ruolo più vasto nel comportamento e sono coinvolte in funzioni
tradizionalmente considerate proprie di aree corticali associative di
ordine superiore.
Parcellizzazione anatomo-funzionale della corteccia motoria e della corteccia
parietale posteriore organizzazione molto più complessa di quella postulata
da Penfield, Woolsey e dallo stesso Brodmann
7
8
2
Carattere esecutivo/rappresentazionale del sistema motorio
Circuiti corticali fronto-parieto-temporali: integrano informazioni
sensoriali e motorie relative a una certa parte corporea e ne
assicurano il controllo.
Le informazioni non fluiscono unidirezionalmente dalla corteccia
posteriore alle aree motorie frontali: esistono anche connessioni
rientranti, che connettono le aree motorie con le regioni “sensoriali”
posteriori Vs. dicotomia tra aree sensoriali e aree motorie
Questi circuiti supportano le “rappresentazioni corticali” di distinti
effettori che assolvono a funzioni diverse Le aree frontali e parietali
hanno un’organizzazione effettore-specifica (i.e., braccio, mano, testa,
etc…) e non rigidamente modalità-specifica (i.e., visiva, tattile, etc…)
9
10
Neuroni motori di F5
Una nuova concezione del sistema motorio
Rizzolatti et al. registrata l’attività neuronale di F5 durante
un’ampia gamma di atti motori eseguiti in contesti naturali - per es.
si chiede alla scimmia di raggiungere o di prendere oggetti di vario
tipo (pezzi di cibo o oggetti tridimensionali di forma e taglia differenti)
vicini e lontani.
Le funzioni sensoriali, percettive e motorie non sono prerogativa
esclusiva di aree tra loro separate
i neuroni della corteccia motoria (tradizionalmente solo “motori”)
scaricano anche in risposta a stimolazione sensoriale
le aree parietali posteriori (tradizionalmente “associative”) oltre a
ricevere forti afferenze dalle regioni sensoriali, possiedono proprietà
motorie analoghe a quelle delle aree della corteccia frontale
agranulare (con cui formano circuiti intracorticali altamente
specializzati)
molti neuroni di F5 si attivano quando la scimmia compie un atto
motorio (per es. afferrare cibo) indipendentemente da se usi il
braccio dx, sx o la bocca (quindi anche quando muscoli usati sono
diversi).
Lo stesso tipo di movimento (per es. flessione dito indice) che attiva
un neurone durante un atto motorio (per es. afferrare) non lo fa
durante un altro (grattare), anche se i muscoli coinvolti sono gli
stessi!
Sistema motorio non periferico e isolato dal resto delle attività
cerebrali, ma implicato nelle trasformazioni sensori-motorie da cui
dipendono l’individuazione, la localizzazione degli oggetti e
l’attuazione dei nostri movimenti
11
12
3
E’ possibile suddividere i neuroni di F5 in classi
specifiche, a seconda degli atti motori codificati
F5 codifica gli atti motori, non i singoli movimenti
l’attivazione dei neuroni di F5 è determinata dallo scopo
dell’azione, indipendentemente dagli specifici movimenti
compiuti e dagli specifici effettori usati
Neuroni-afferrarecon-la- mano-econ-la-bocca
Neuroni motori di F5 correlati con il livello più alto di
descrizione di un’azione: il suo finalismo.
Neuroni-strappare
Neuroni-afferrarecon-la-mano
il sistema motorio non è un semplice esecutore di
movimenti
Neuroni-tenere
Neuroni-manipolare
13
Proprietà dei neuroni motori di F5
14
Proprietà visuo-motorie di F5
Una porzione dei neuroni di F5 risponde selettivamente anche a
stimoli visivi neuroni visuo-motori
F5 contiene una sorta di vocabolario di atti motori, le cui parole sono
rappresentate da popolazioni di neuroni, di cui alcune indicano
Esperimento di Murata et al. (1997):
a) afferrare con visione l’oggetto
• lo scopo generale dell’atto (afferrare, tenere, etc…);
I neuroni motori di F5
scaricano
b) afferrare l’oggetto al buio
• il modo di esecuzione (presa di precisione, con le dita, etc…)
c) fissare l’oggetto
• la segmentazione temporale dell’atto nei movimenti elementari che lo
compongono (apertura della mano, chiusura, etc…)
15
I neuroni visuo-motori di
F5 scaricano
Congruenza tra la selettività motoria per un determinano tipo di
prensione e quella visiva per oggetti che, pur possedendo taglie e
forme diverse, sono accomunati dalla medesima presa codificata a
livello motorio
16
4
Neuroni sensori (visuo)-motori
Neuroni visuo-motori di F5 e atti motori potenziali
Neuroni visuo-motori di F5 scaricano nello stesso modo sia quando
la scimmia interagisce con un determinato oggetto sia quando si
limita a osservarlo
• Effettiva esecuzione la scarica rappresenta l’attivazione di un
comando motorio
Risposte “visive” in neuroni motori (“canonici”): rispondono alla
semplice osservazione (indipendentemente che vi sia o meno
l’intenzione di agire, per es. di afferrare l’oggetto) ogni volta che un
oggetto è presentato, le sue caratteristiche visive sono
automaticamente “tradotte” in un potenziale atto motorio.
vedere l’oggetto significa evocare automaticamente cosa faremmo
con esso, significa immaginare un’azione potenziale l’oggetto
acquista una piena valenza significativa solo in virtù della propria
relazione dinamica con il soggetto attivo fruitore di questa relazione.
• Semplice osservazione la scarica riflette l’evocazione di un
pattern motorio identico a quello codificato quando l’animale si
muove, ma che rimane allo stadio di un atto potenziale.
17
Rappresentazione come “controllo”
Il soggetto “agente”
18
Evocazione di un pattern motorio potenziale
L’oggetto (per es. la tazza) funge da POLO D’ATTO VIRTUALE,
che per la sua natura relazione definisce ed è insieme definito dal
pattern motorio che viene ad attivare.
Il soggetto è un soggetto AGENTE Ruolo attivo
dell’azione nel determinare il processo di significazione del
mondo.
Ci creiamo delle rappresentazioni al fine di esercitare
un controllo sulle azioni (connotati relazionali e quindi
intenzionali della rappresentazione).
19
Vedere la tazza già forma preliminare
d’azione, sorta di “appello” ad agire, che,
indipendentemente da che l’atto si compia
o no, la caratterizza come qualcosa DA
prendere per il manico, con due dita, etc,
identificandola cioè in funzione delle
possibilità motorie che essa racchiude
20
5
Concezione intenzionale della nozione di
rappresentazione
NEURONI CANONICI E NEURONI SPECCHIO
Processi sensoriali: da un alto costituiscono il presupposto
dell’azione, ma contemporaneamente sono anche parte dell’azione.
Azione e percezione non possono essere considerate unità distinte
Le rappresentazioni mentali non nascono con una specifica valenza
linguistico-simbolica
Valenza linguistico-simbolica successiva acquisizione attraverso
un processo di ridefinizione funzionale di processi già presenti per
altri scopi, ovvero il controllo motorio.
Accezione “incarnata”, situata nel corpo, dei processi cognitivi:
EMBODIED COGNITION
21
Neuroni visuo-motori di F5
neuroni canonici
(congruenza tra proprietà
motorie e selettività visiva)
Non sono il solo tipo di neuroni ad avere proprietà
visuo-motorie. Soprattutto nella convessità corticale di
F5 vi sono altri neuroni (neuroni mirror) che
rispondono sia quando la scimmia effettua una
determinata azione, sia quando osserva un altro
individuo compiere la stessa azione
22
Neuroni mirror: somiglianze e differenze coi neuroni
canonici
Neuroni mirror: somiglianze e differenze coi neuroni
canonici
• Proprietà motorie:
I due tipi di neuroni sono indistinguibili; anche i neuroni mirror si attivano
selettivamente durante specifici atti motori
• Proprietà visive:
A differenza dei neuroni canonici, i neuroni mirror non rispondono alla
semplice presentazione del cibo o di altri oggetti tridimensionali
Neuroni specchio: stesso funzionamento dei neuroni canonici ma con
la differenza che qui lo stimolo visivo non è costituito da un oggetto o
dai suoi movimenti, ma dai movimenti compiuti da un altro individuo e
oggettualmente correlati nel modo dell’afferrare, del tenere o del
manipolare.
Come gli oggetti, così tali movimenti assumono significato per chi li
osserva in virtù del vocabolario d’atti di cui egli dispone e che ne
regola la possibilità di agire
la loro attivazione è legata all’osservazione da parte della scimmia di
specifici atti compiuti da altri che comportano un’interazione effettore
(mano o bocca)-oggetto.
23
24
6
I NEURONI MIRROR si suddividono in classi distinte
Proprietà dei neuroni mirror (collegati alla mano)
nella scimmia
Neuronispecchio-tenere
Attivazione legata all’osservazione da parte della scimmia di
specifici atti compiuti da altri che comportano un’interazione
mano-oggetto.
Neuroni-specchio
-afferrare
NON si attivano quando gli atti si limitano a mimare la presa in
assenza dell’oggetto
Neuroni-specchiointeragire con le
mani
Neuronispecchio manipolare
NON si attivano quando i gesti sono intransitivi (privi di correlato
oggettuale)
Scaricano per lo più indipendentemente dalla distanza e dalla
localizzazione spaziale dell’atto osservato
25
I neuroni specchio della bocca
Gran parte dei neuroni specchio di F5 risponde all’osservazione di un solo
tipo d’atto. Altri neuroni sono meno selettivi, scaricando durante
26
l’osservazione di due, o raramente tre, atti motori
La maggior parte (circa 85%) dei neuroni specchio della bocca
risponde alla vista di atti come afferrare il cibo con la bocca, il
masticarlo o il succhiarlo neuroni ingestivi
F5, regione dorsale: qui per
lo più rappresentati i
movimenti della mano
F5, regione ventrale:
controllo dei movimenti della
bocca.
Circa 1/3 dei neuroni di
quest’area ha proprietà
tipiche dei neuroni specchio
(cf. Ferrari et al. 2003)
Come i neuroni specchio collegati alla mano, i neuroni ingestivi
scaricano solo quando vi è un’interazione tra un effettore e un oggetto (e
non quando vi è la semplice presentazione di un oggetto o l’esecuzione
di movimenti intransitivi).
La maggior parte di questi neuroni è selettiva per un determinato tipo
d’atto.
27
Circa 1/3 mostra una stretta congruenza tra azione osservata ed
eseguita.
28
7
Neuroni comunicativi ed evoluzione (cf. studi di
Van Hooff, 1962, 1967)
Neuroni specchio comunicativi
Esiste un’altra categoria di neuroni specchio collegati alla bocca che:
•
Rispondono all’osservazione di atti compiuti con la bocca ma dotati
di funzione comunicativa
• A differenza degli altri neuroni specchio, rispondono alla vista di atti
intransitivi
• L’osservazione di atti di tipo ingestivo provoca un’attivazione scarsa
o nulla
Grooming (pulizia e spulciamento reciproco della
pelliccia) modalità principale di affiliazione e
coesione sociale. Durante il grooming spesso
schiocco delle labbra che accompagna i
movimenti (ingestione parassiti prelevati dal
partner, suono più marcato rispetto agli atti
ingestivi).
Atti comunicativi quali lo schioccare o la
protrusione delle labbra in assenza di
grooming sorta di ritualizzazione di un atto
motorio che trasforma le funzioni
comportamentali connesse all’ingerire in
funzioni comunicative
29
30
Ipotesi sperimentale
I neuroni specchio scaricano anche quando l’azione è
parzialmente oscurata
31
32
8
Il neurone evoca lo stesso atto motorio
potenziale sia quando la scimmia
osserva l’intera azione (A) sia quando
ne vede solo una parte (B).
Grazie a questa rappresentazione
motoria interna, la scimmia può
integrare la parte mancante,
riconoscendo nella sequenza parziale
dei movimenti vista il significato
complessivo di un’azione.
L’atto motorio potenziale evocato può
essere lo stesso anche se
l’informazione sensoriale disponibile è di
volta in volta differente
Umiltà et al. 2001
33
34
I neuroni specchio non rispondono solo ad atti
singoli ma anche ad atti motori concatenati
Le azioni “rompere” e “strappare” con la mano sono quelle che
– nella scimmia – avvengono più di frequente.
Il comportamento dei neuroni mirror riflette questo fatto il
suono collegato alla rottura di un oggetto (per es. noccioline) o
allo strappare della carta otteneva più degli altri suoni (connessi
ad azioni diverse) un’attivazione dei neuroni mirror.
Fogassi et al. (2005) hanno mostrato che la maggior parte dei neuroni nel
lobo parietale inferiore della scimmia si attivavano in maniera diversa a
seconda che l’atto motorio compiuto dalla scimmia successivo
all’afferramento di un oggetto consistesse nel portarlo alla bocca o nel
metterlo in un contenitore (era la scimmia a fare l’azione).
35
36
9
Concatenazione di atti motori per eseguire un’azione:
l’osservatore capisce qual è lo scopo dell’agente che
compie l’azione
Concatenazione di atti motori per eseguire un’azione:
l’agente sa qual è lo scopo dell’azione che sta
compiendo
I neuroni specchio codificano il significato intenzionale dell’azione
durante la sua esecuzione (afferrare per portare alla bocca o afferrare
per spostare) fin dal primo movimento compiuto questo perché
l’intenzione del proprio atto è da subito chiara all’agente.
Anche l’organizzazione dei campi recettivi dei neuroni parietali
favorisce l’organizzazione degli atti motori in specifiche catene
motorie.
Per es. molti neuroni parietali che rispondono alla flessione passiva
dell’avambraccio hanno campi recettivi tattili localizzati sulla bocca, e
alcuni di essi si attivano anche durante atti come l’afferrare con la
bocca: tali neuroni sembrano pertanto facilitare l’apertura della bocca
quando un oggetto è raggiunto e afferrato dalla mano dell’animale.
La scimmia è in grado di anticipare l’esito dei movimenti iniziali dello
sperimentatore grazie al contesto (per es., presenza o meno del
contenitore; se l’oggetto è cibo o qualcosa d’altro).
Se le azioni osservate sono ambigue: l’attivazione di uno o più atti
motori potenziali, intenzionalmente concatenati tra di loro, permette
alla scimmia di decifrare le intenzioni dell’attore dell’azione e di
scegliere quella di volta in volta compatibile con lo scenario osservato.
37
38
Il sistema dei neuroni specchio nell’uomo
E’ più esteso rispetto alla scimmia (ma va considerato che le
tecniche di registrazione sono diverse)
I neuroni specchio
nell’uomo
Codifica gli atti motori sia transitivi che intransitivi
Seleziona sia il tipo d’atto sia la sequenza di movimenti che lo
compongono
Non necessita di un’effettiva interazione con gli oggetti,
attivandosi anche quando l’azione è semplicemente mimata
gamma di funzioni più ampia rispetto che nella scimmia, ma il
suo ruolo primario resta quello legato alla comprensione del
significato delle azioni altrui.
39
40
10
La localizzazione dei neuroni specchio nell’uomo
Area 6 dorsale
(ma
“preparazione
all’azione” più
che attivazione
specchio”)
Brain imaging e neuroni specchio nell’uomo
Settore del lobo frontale
che si attiva durante
l’osservazione di azioni
altrui, ma solo in certe
condizioni sperimentali
non fa parte del sistema
specchio perché i suoi
neuroni non hanno
proprietà motorie
• porzione rostrale (anteriore) del lobo
parietale inferiore
corrisponde all’area 40 di
Brodmann, l’omologo umano di PF.
Settore del lobo parietale che
si attiva durante l’esecuzione
delle azioni o l’osservazione
quando fatte da altri
Settore del lobo frontale che si attiva
durante l’esecuzione delle azioni o
l’osservazione quando fatte da altri
• settore inferiore del giro precentrale e
settore posteriore del giro frontale
inferiore
settore posteriore del giro frontale
inferiore corrisponde all’area 44 di
Brodmann (parte posteriore dell’area
di Broca): sembra essere l’omologo
umano dell’area F5 della scimmia e
possiede una rappresentazione ,
oltre che dei movimenti della bocca,
anche di quelli della mano.
41
I neuroni specchio dell’uomo rispondono anche ad atti
intransitivi
42
I neuroni specchio codificano sia lo scopo dell’atto
motorio, sia il decorso temporale dei vari movimenti
osservati
Fadiga et al. (1995): registrazione dei MEP (potenziali evocati
motori) indotti tramite TMS (stimolazione magnetica transcranica)
nella corteccia motoria sinistra, in vari muscoli della mano e del
braccio destri di individui cui era stato chiesto di osservare uno
sperimentatore mentre afferrava degli oggetti con la mano o
compiva gesti apparentemente privi di significato (senza un
correlato oggettuale)
in entrambi i casi aumento selettivo dei MEP nei muscoli attivati
dall’esecuzione dei movimenti osservati.
Differenza rispetto alla scimmia in cui neuroni specchio non
rispondono alla vista di movimenti non finalizzati del braccio
43
44
11
FDI= Right first dorsal interosseous
Gangitano et al. (2001): la registrazione dei MEP (indotti da TMS)
nei muscoli della mano dei soggetti che osservavano lo
sperimentatore afferrare un oggetto ha evidenziato come
l’attivazione della corteccia motoria riproduca fedelmente il decorso
temporale dei vari movimenti osservati
I MEP possono essere modulati dall’osservazione passiva di
un’azione. Durante l’osservazione dell’azione vengono registrati
potenziali motori più ampi rispetto alla condizione di controllo (black
screen). Inoltre, l’effetto facilitatorio dipende anche dalla fase del
movimento osservato.
L’ampiezza dei MEP cresce al crescere dell’apertura della mano
osservata e diminuisce quando la mano osservata nel videoclip si
chiude per afferrare l’oggetto.
45
46
Neuroni specchio e intenzioni
47
Iacoboni et al., 2005
48
12
Capire le intenzioni altrui
Capire per predire
Iacoboni et al., 2005: il sistema mirror premotorio è in
grado non solo di determinare il cosa di un’azione, ma
anche il suo perché, cioè l’intenzione che l’ha promossa.
Determinare l’intenzione alla base dell’azione A
equivale a predire il suo scopo distale, cioè lo scopo
della successiva azione B.
Nell’uomo ci sono processi di natura intellettiva che non si basano sui
meccanismi di risonanza motoria via sistema dei neuroni specchio per
comprendere le intenzioni altrui
Tuttavia, i neuroni specchio consentono di catturare la dimensione
pragmatica “originaria” dell’esperienza, consentono una comprensione
delle intenzioni altrui che non ha nulla di teorico, ma poggia
sull’automatica selezione di quelle strategie d’azione che in base al
nostro patrimonio motorio risultano di volta in volta più compatibili con
lo scenario osservato.
Il sistema dei neuroni specchio e la selettività delle loro risposte
determinano uno spazio d’azione condiviso, all’interno del quale ogni
atto e ogni catena d’atti, nostri o altrui, appaiono immediatamente
iscritti e compresi, senza che sia necessaria una esplicita “operazione
conoscitiva”.
49
50
Capire “simulando” e capire “pensando”:
Differenze di vocabolario inter-specie
Ci sono azioni che esulano dalla nostra conoscenza motoria,
perché non appartengono al patrimonio della nostra specie o
perché non siamo realmente in grado di compierle.
Capiamo queste azioni tramite meccanismi “riflessivi”
Tuttavia, capiamo le azioni che appartengono al nostro patrimonio
motorio grazie a meccanismi di simulazione (anche se le azioni
sono svolte per es. da animali e non da esseri umani).
Buccino et al. (2004):
ai partecipanti presentati video (senza sonoro) in cui individui di
specie diverse (uomo, scimmia, cane) compivano atti motori di tipo
ingestivo (mordere) o comunicativo (rispettivamente: parlare,
schioccare le labbra, abbaiare).
Atti ingestivi: anche se visivamente l’atto compiuto dalle tre specie è
diverso, si attivavano aree molto simili (zona rostrale e caudale nel lobo
parietale inferiore, parte posteriore del giro frontale inferiore e adiacente
giro precentrale).
51
52
13
Calvo-Merino et al. (2005): la vista
di atti eseguiti da altri comporta una
diversa attività cerebrale a seconda
delle competenze motorie
specifiche dei soggetti in questione
Partecipanti: danzatori classici,
maestri di capoeira, e principianti
Differenze di vocabolario
intra-specie
Video con passi di capoeira
attivazione del sistema dei neuroni
specchio (corteccia premotoria,
parietale e STS) maggiore nei
maestri di quest’arte rispetto ad altri
due gruppi.
Atti comunicativi: forte attivazione dell’area di Broca (parte posteriore del
giro frontale inferiore) se l’agente era umano, attivazione debole se scimmia,
assente se cane.
Atto comunicativo differisce VISIVAMENTE nelle tre specie tanto quanto
quello ingestivo
Siamo in grado di comprendere che il cane abbaia, ma in questo caso la
comprensione si basa solo sull’informazione visiva
La comprensione dell’azione del cane che mangia è invece di natura visuo53
motoria
Neuroni specchio e l’origine del linguaggio umano
Video con passi di danza classica
attivano il sistema dei neuroni
specchio dei danzatori classici più
di quello dei ballerini di capoeira e
dei principianti
E’ la pratica motoria a modulare l’attivazione del
sistema dei neuroni specchio
54
Neuroni specchio e l’origine del linguaggio umano
La vista di un atto – tramite meccanismi di risonanza – può evocare
inconsapevolmente un movimento analogo nell’osservatore.
Tale movimento è colto da chi è osservato e può indurre questo a
modificare il suo movimento.
Sempre grazie alla risonanza chi osserva si accorge di questo
mutamento tra la propria e l’altrui mano si instaura una relazione
di reciproca interazione.
Atti animali: “mutui riaggiustamenti” grazie a cui tali atti
acquistano una valenza sociale forme di comunicazione che
anticipano quelle più propriamente intenzionali.
55
Scimmie dal grooming a gesti comunicativi (protrusione o schioccare
delle labbra); alcuni neuroni specchio della bocca si attivano sia
durante l’esecuzione di azioni ingestive, sia durante l’osservazione di
atti comunicativi orofacciali.
Uomo gran parte degli atti intransitivi dei bambini deriva da atti
transitivi (per es. origine del gesto indicare). Nell’uomo il sistema dei
neuroni specchio attivato anche dall’osservazione di pantomime di atti
manuali, di gesti intransitivi o di effettivi atti comunicativi orofacciali.
Ipotesi:
È stata la progressiva evoluzione dei neuroni specchio,
originariamente deputato al riconoscimento di atti transitivi
manuali (afferrare, tenere, raggiungere, ecc…) e orofacciali
(mordere, ingerire,…) a fornire il substrato necessario per la
comparsa delle prime forme di comunicazione interindividuale.
56
14
Neuroni specchio e l’origine del linguaggio umano:
stretta connessione fra atti manuali e gesti orolaringei
Le tappe dell’evoluzione verso il linguaggio
Integrazione di un sistema
orofacciale con un sistema
manuale
Formazione di un
armamentario di protosegni
gestuali di matrice per lo più
pantomimica
•
Meno dispendioso (più
fatica a gesticolare che
a parlare)
•
Comunicare di notte
•
Avere le mani libere per
usare strumenti
1. Afferrare con la bocca due oggetti di taglia differente
e, contemporaneamente, aprire la mano dx
apertura massima delle dita è maggiore quando la
bocca si apre per afferrare un oggetto di grandi
dimensioni
2. Presentati due oggetti 3D, uno grande e uno piccolo,
sulla cui superficie riportati due simboli o due serie di
macchie: afferrare gli oggetti e, solo in presenza dei
simboli, aprire anche la bocca la velocità di
apertura della bocca è maggiore quando mano è
diretta verso l’oggetto più grande
Emergenza di un protolinguaggio bimodale (gesti e
suoni)
Evoluzione del
meccanismo dei
neuroni specchio
Esperimenti di Gentilucci et al_2001
Comparsa di un sistema
prevalentemente vocale
3. Come 2 ma pronunciare una sillaba invece che aprire
la bocca: la massima potenza vocale registrata è
maggiore quando si afferra l’oggetto più grande
57
58
Emozioni: riconoscimento “riflessivo” e/o “empatico”
NEURONI SPECCHIO, EMOZIONI ED EMPATIA
Altri individui: non si caratterizzano solo per le azioni ma anche per
sensazioni ed emozioni.
Le emozioni possono essere comprese
•
tramite un’elaborazione riflessiva degli aspetti sensoriali connessi alla
loro manifestazione sul volto o nei gesti degli altri interpretazione cognitiva
di uno stato di cose esterno al soggetto.
Tale comprensione è però solo “razionale”, priva di “colore emotivo”
(autismo?).
•
entrando in “risonanza emotiva” tramite il meccanismo dei neuroni
specchio prerequisito necessario per il comportamento empatico. E’
probabilmente il meccanismo più antico dal punto di vista evolutivo, è
tipicamente esperienziale.
Le emozioni consentono all’individuo di:
• acquisire informazioni circa il proprio stato, permettendo di
riorganizzare queste informazioni e conseguentemente le proprie
azioni (sociali e non)
• Interagire con gli altri individui: comprendere le emozioni altrui,
entrare in “risonanza emotiva” con gli altri consente di affrontare
in maniera efficace minacce o opportunità; possibile l’instaurarsi e il
consolidarsi dei primi legami interindividuali.
59
Questi due meccanismi non sono mutualmente esclusivi. La simulazione
incarnata è uno stadio necessario per il corretto sviluppo di strategie
cognitive sociali più sofisticate.
60
15
Empatia e imitazione
2 vie per le espressioni facciali delle emozioni
T. Lipps (1903): concetto di empatia (Einfühlung)
• Attraverso il nucleo facciale nel ponte del tronco encefalico che
regola i movimenti facciali spontanei/emozionali
ipotizza un ruolo critico per il meccanismo di imitazione interna (inner
imitation) delle azioni degli altri nel generare empatia (imitiamo
automaticamente l’espressione facciale di un altro, rievochiamo l’emozione
associata, e attribuiamo quell’emozione all’altro individuo).
• Corteccia motoria per i movimenti volontari
Nei primati più evoluti e negli umani rispetto ad altri primati: maggior
flessibilità nella comunicazione emotiva che si accompagna a un
maggior sviluppo delle 2 vie deputate all’espressione facciale delle
emozioni (> volume nucleo facciale; > densità neurale nell’area della
corteccia motoria per controllo movimenti viso)
A favore:
Attività elettromiografica (EMG): le persone imitano rapidamente e
inconsapevolmente l’espressione facciale degli altri, perfino quando la
percezione di queste facce non è consapevole (Dimberg et al., 1998, 2000).
Gli individui imitano inconsapevolmente la postura, i gesti e le espressioni
facciali degli altri; questo “effetto camaleonte” è più evidente negli individui
maggiormente empatici (Chartrand & Bargh, 1999)
[Parr et al., 2005]
61
62
Analisi di un’emozione: il disgusto
Provare disgusto e percepire disgusto substrato neurale comune INSULA
Funzionalmente suddivisibile in:
•
regione anteriore “viscerale”: fortemente connessa con i centri gustativi e
olfattivi; associa stimoli olfattivi, gustativi e visivi alle correlate sensazioni e
risposte viscero-motorie; coinvolta nell’enterocezione, ovvero la ricezione degli
stati interni del corpo. Se stimolata, può produrre varie risposte viscerali, quali
aumento del battito cardiaco, conati di vomito, etc…Si attiva anche alla vista di
espressioni facciali di disgusto degli altri.
Lesioni all’insula anteriore determinano l’incapacità di provare disgusto e di
cogliere reazioni di disgusto negli altri (Adolphs et al., 2003; Calder et al.,
2000).
•
regione “posteriore”: connessioni con le aree corticali uditive,
somatosensoriali e premotorie; non è legata a modalità olfattive e gustative.
Circuito implicato nell’imitazione: come si connette al sistema limbico?
Il settore anteriore dell’insula è connesso sia col sistema limbico che con la
corteccia parietale posteriore, frontale inferiore e temporale superiore (mirror
system) (Augustine, 1996)
63
64
16
Un substrato neurale comune per provare e riconoscere le emozioni
OSSERVAZIONE DI ESPRESSIONI DI DISGUSTO
Wicker et al. (2003)
Studio fMRI, 2
condizioni:
1) Stimolazione olfattiva
diretta:
ai soggetti presentati
odori disgustosi o
piacevoli;
1) Osservazione:
presentati dei video in
cui alcune persone
annusavano un liquido
maleodorante, bene
odorante o neutro, e
manifestavano
un’espressione facciale
conseguente.
L’osservazione della smorfia di disgusto determina un’attivazione dell’insula.
Tale attivazione coincide con quella riscontrata quando i soggetti annusavano
gli odori disgustosi
65
66
Autismo
Risultati di Wicker et al. (2003) suggeriscono che:
La comprensione degli stati emotivi altrui dipende da un meccanismo
specchio in grado di codificare l’esperienza sensoriale direttamente in
termini emozionali.
Ciò vale non solo per il disgusto, ma anche per altre emozioni primarie
(paura, rabbia, felicità, sorpresa, tristezza).
L’emozione dell’altro è compresa dall’osservatore grazie a un meccanismo
di simulazione che produce nell’osservatore uno stato corporeo condiviso
con l’attore di quella espressione.
Non è necessario riprodurre integralmente il comportamento degli altri per
coglierne la valenza emotiva il fatto che le reazioni viscero-motorie
dovute all’azione dell’insula non abbiano necessariamente effetto a livello
dei centri periferici non significa che siano irrilevanti. In modo simile, la
comprensione del significato delle azioni osservate non richiede la loro
effettiva replica.
67
L’autismo è un disturbo dello sviluppo
neuropsicologico che si manifesta in
marcate e persistenti difficoltà
nell’interazione sociale, nella
comunicazione e nel repertorio di interessi
e di attività.
68
17
Autismo: Modelli psicologici esplicativi più accreditati
Autismo come deficit nell’acquisizione della teoria della mente
• Deficit nell’acquisizione della teoria della mente (Baron-Cohen et
al., 1995) difficoltà nell’attribuire stati mentali agli altri e a se
stessi
• Teoria della disfunzione esecutiva (Fuster, 2002) deficit nella
capacità di controllare volontariamente i propri processi di azione,
attenzione e pensiero
Termine “teoria della mente” introdotto alla fine degli anni
Settanta da Woodruff e Premack (1979) per indicare la continua
attività di attribuzione agli altri di stati mentali come credenze,
desideri, inganni, scopi, etc…, nonché la capacità di intendere,
spiegare e predire il comportamento altrui come governato da
tali stati intenzionali.
• Teoria della coerenza centrale debole (Frith, 1989) scarsa
capacità di integrare informazioni diverse, tenendo conto di aspetti
contestuali, per formare unità coerenti e dotate di significato
69
70
“E’ probabile che deficit precoci nello sviluppo di sistemi di “neuroni
specchio” determinino una successiva “cascata” di compromissioni del
comportamento, caratteristica della sindrome clinica dell’autismo”
Sistema mirror imitazione ToMM
Sistema mirror imitazione funzioni esecutive
71
72
18
1.
Neuroni mirror imitazione ToMM
Primi sintomi autismo: si manifestano come deficit nell’imitazione
(e.g., Smith & Bryson, 1994; Rogers, 1999), seguiti poi da altre
compromissioni nella condivisione emotiva, attenzione condivisa e
gioco di finzione e, solo in un secondo momento, del ToMM.
Rogers & Pennington (1991) deficit nell’imitazione connessi a
prime fasi dell’autismo
L’ imitazione precede lo sviluppo del ToMM
in entrambi i casi si tratta di tradurre la prospettiva dell’altro – cosa
sta facendo o pensando – nella propria
genero un piano d’azione che corrisponde a quello dell’altro
[imitazione];
“copio” le credenze dell’ altro nella mia mente, creando così una
rappresentazione di “secondo ordine” della rappresentazione
“primaria” del mondo dell’altro (senza confondere questa con le mie
credenze) [ToMM]
73
Williams et al (2001): l’evoluzione della capacità d’imitazione negli
umani ha probabilmente utilizzato un sistema mirror già esistente (e
il cui scopo era capire il comportamento degli altri)
Malfunzionamento del sistema mirror
compromessa la capacità di imitazione
deficit nel ToMM
74
Obiezioni alla spiegazione dell’autismo come deficit di
TOMM
Gli autistici costruiscono continuamente “teorie” per farsi un’idea del mondo.
La teorizzazione sul mondo intenzionale dell’altro è l’unica strategia
disponibile per entrare in comunicazione con l’altro.
Una paziente con lesione bilaterale della corteccia cingolata anteriore
proposta come la regione sottesa al modulo del ToMM non mostrava
compromissioni nelle capacità di lettura della mente (Bird et al., 2004).
75
19