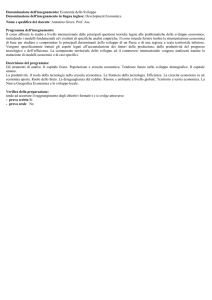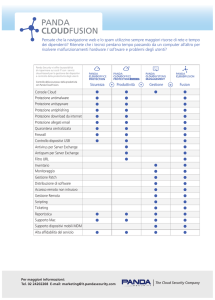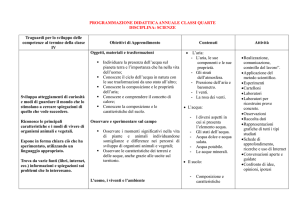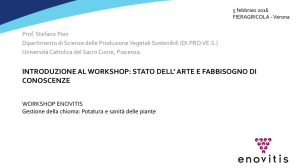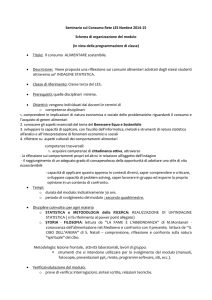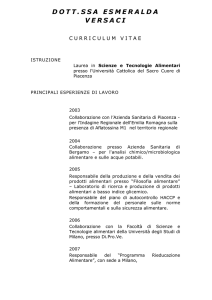Dal flusso di energia solare alla produzione di cibo per l’umanità
a cura di
Gianfranco D’Onghia
Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Questo articolo è presente sul sito www.vglobale.it (D’Onghia G., 2008. Dal flusso di energia
solare alla produzione di cibo per l’umanità. Stiamo minando la “fabbrica” del cibo. Villaggio
Globale, L’energia che verrà, Anno XI, Numero 43, Settembre 2008, (on-line www.vglobale.it ).
Energia solare e produttività degli ecosistemi
Ogni giorno il sole fornisce al nostro pianeta un’enorme quantità di energia: in media
3000-4000 Kcal/m2/giorno corrispondenti a circa 1,1-1,5 milioni di Kcal/ m2/anno (Odum e
Barrett, 2007). Circa il 30% di questa energia è assorbita e riflessa dallo strato atmosferico,
mentre poco meno del 70% di tale energia, grazie a processi termoregolatori realizzati
dall’atmosfera e dagli oceani, determina il clima del nostro pianeta consentendo la vita nelle
sue varie forme, dagli organismi agli ecosistemi, adattate a differenti condizioni, da quelle più
calde (equatoriali) a quelle più fredde (polari). Una frazione esigua dell’energia radiante (in
media circa l’1%) costituisce il vero e proprio propellente della vita che struttura e alimenta
gran parte dei sistemi viventi sulla terra e negli oceani, dalla più piccola pianticella di geranio
presente sul nostro balcone all’intera foresta tropicale con tutti gli organismi ivi presenti, dalle
piccole patelle distribuite lungo le nostre coste rocciose fino alle barriere coralline che
ospitano una notevole varietà di forme di vita.
Sulla terra, come nel mare, soltanto gli organismi vegetali (e numerose specie di
microrganismi) possono captare l’energia radiante e inglobarla, attraverso il processo di
fotosintesi, nei legami chimici di molecole organiche utilizzate per le proprie necessità vitali
compreso la crescita e la riproduzione. E’ attraverso questo processo di conversione
dell’energia del sole che i vegetali hanno strutturato le foreste del pianeta, i boschi, le praterie
e tutti i sistemi viventi della biosfera anche quelli dove i vegetali sono microscopici e
dominano le biomasse animali, come nel mare. Un’eccezione a questo propellente della vita si
rinviene nelle profondità degli oceani dove esistono anche organismi e comunità che
dipendono dalla chemiosintesi batterica. A parte questa eccezione, è soprattutto attraverso la
fotosintesi che viene prodotto il cibo dei viventi, in modo diretto per gli erbivori ed indiretto
per i carnivori e i decompositori.
La frazione di energia del sole che diventa biomassa vivente è così bassa (in media l’1% ed
è nota come efficienza ecologica di fotosintesi) perché non tutte le lunghezze d’onda dello
spettro solare sono utilizzate nella fotosintesi. Infatti, i vegetali terrestri usano la parte visibile
della radiazione (non l’ultravioletto né l’infrarosso) nella banda del rosso e del blu. Inoltre,
una grossa frazione della radiazione, anche di quella utile, non viene captata dai sistemi
fotosintetici delle piante ma finisce sul suolo nudo, sulle rocce, sulla sabbia dei deserti, sui
ghiacci polari e su tante altre superfici dove non ci sono vegetali e/o sistemi fotosintetici
(come la corteccia degli alberi).
Poiché i vegetali sono in grado di “produrre il cibo” autonomamente, a partire da energia
radiante e semplici molecole inorganiche, come acqua, anidride carbonica e sali minerali,
sono noti come organismi autotrofi, in particolare foto-autotrofi. La velocità di trasformazione
dell’energia radiante in energia chimica è nota come produttività primaria per cui gli
organismi che la realizzano sono anche noti come produttori. I vegetali, comunque, come tutti
gli esseri viventi, utilizzano parte di questa energia chimica per i vari processi vitali tra cui
anche l’assorbimento dell’acqua e dei nutrienti. Quindi, dell’energia radiante trasformata in
energia chimica (produttività primaria lorda), una parte più o meno cospicua viene spesa nel
mantenimento (respirazione). Quello che rimane al netto di questi costi di mantenimento
costituisce l’accumulo di sostanza organica da parte dei vegetali ed è nota come produttività
primaria netta. Questa è, dunque, la fonte di sostentamento di tutti gli organismi eterotrofi
ossia di quelli che prendono energia alimentare mangiando altri organismi (erbivori e
carnivori) o utilizzando sostanza organica morta (detritivori e decompositori). Pertanto, la
produttività primaria netta è la risorsa di cibo del pianeta. Attraverso il processo di fotosintesi
gli organismi vegetali producono ogni anno circa 170 miliardi di tonnellate di sostanza
organica. I due terzi sono prodotti sulle terre emerse (circa 115 miliardi di tonnellate) e un
terzo negli oceani (circa 55 miliardi di tonnellate) (Whittaker, 1975). La maggior produttività
delle terre emerse è principalmente dovuta alla rilevante (sebbene notevolmente ridotta
dall’uomo) copertura vegetale rappresentata dalle foreste e, in misura minore, dalle praterie e
dalle terre coltivate. Foreste e boschi, savane e praterie, brughiere e macchie, costituiscono
ecosistemi di vastissime estensioni in cui l’habitat è strutturato da organismi vegetali che
producono cibo in forma di fibre, foglie, frutti, semi, fiori, linfa ed essenze vegetali. Tutta
energia alimentare utilizzata in prima battuta dagli erbivori ma che sosterrà, indirettamente,
anche la vita dei carnivori e dei decompositori.
La produttività degli oceani, invece, è principalmente dovuta al fitoplancton, ossia un
complesso di organismi microscopici unicellulari, con breve ciclo vitale, che galleggiano in
prossimità della superficie delle acque dove vi è disponibilità di radiazione solare. Le
dimensioni microscopiche del fitoplancton precludono l’accumulo di biomassa vegetale in
mare aperto. Oltre i 200 m di profondità (la profondità media degli oceani è di circa 3800 m)
la penetrazione della radiazione solare è trascurabile e, pertanto, non è possibile la vita
vegetale nelle profondità marine. Nelle zone costiere, invece, la presenza di organismi
vegetali di maggiori dimensioni (alghe e piante superiori) ancorati sul fondo dove arriva la
radiazione solare, determina un notevole incremento di biomassa e parallelamente di
produttività. Possono strutturarsi così, anche nel mare, ecosistemi in cui la componente
vegetale costituisce l’habitat di numerosi organismi erbivori, carnivori e decompositori.
Energia ausiliaria e uso della produttività in ambiente terrestre
Alcuni ecosistemi si presentano particolarmente produttivi poiché, oltre alla disponibilità
di energia radiante, di acqua e nutrienti (azoto, fosforo), usufruiscono di apporti ausiliari di
energia. L’energia fondamentale che i vegetali trasformano in energia chimica, attraverso la
fotosintesi, è quella del sole. Gli apporti ausiliari di energia si configurano in meccanismi
ambientali che consentono di ridurre i costi di mantenimento a favore della crescita dei
vegetali. Per esempio, una corrente marina che renda disponibili maggiori quantità di azoto e
fosforo per le alghe che potranno assorbirli con minore spesa energetica, determinerà un
incremento di produttività primaria netta.
L’intervento dell’uomo nei sistemi agricoli, dall’irrigazione alla concimazione, dal
controllo dei parassiti alla selezione genetica, si configura come energia ausiliaria che riduce i
costi di mantenimento delle colture a favore di una maggiore produttività. Così il frumento o
il mais spendono molto meno per assorbire acqua e nutrienti o per difendersi dai parassiti e
quello che non viene speso per queste “faccende”, risolte dall’uomo con investimenti
energetici (ed economici), può essere accumulato nei tessuti eduli. Attraverso la selezione
genetica è stato favorito in molte colture il “rapporto di resa” ossia il rapporto tra la parte
commestibile e quella non commestibile. Però piante con un elevato rapporto di resa
dispongono di minore strutture e fibre per la propria autoprotezione, per cui deve intervenire
l’uomo con energie ausiliarie che forniscano protezione da parassiti e insetti nocivi.
2
Stando alle stime riportate da Whittaker (1975), le terre coltivate, che coprono una
superficie di circa 14 milioni di kilometri quadrati, producono annualmente circa 9 miliardi di
tonnellate annue di sostanza organica. Questa cifra corrisponde a circa l’8% della produttività
primaria netta delle terre emerse. Ovviamente, non tutta questa produttività corrisponde a
prodotti alimentari per il consumo umano. Il raccolto destinato al consumo animale (mucche,
cavalli, maiali, pecore, polli) supera di 5 volte quello destinato al consumo umano (Odum,
2001). Inoltre, molti terreni coltivati sono destinati alla produzione di fibre, di legno e, negli
ultimi tempi, di biomasse vegetali per ottenere combustibili. Infine, esiste una notevole
quantità di scarti dai raccolti (radici, foglie, cortecce, rami etc.) rispetto alle parti
commestibili. Anche questi scarti, comunque, potrebbero essere utilizzati in differenti modi,
dalla concimazione dei terreni alla produzione di energia.
Vitousek e collaboratori in un famoso articolo del 1986 (Human appropriation of the
products of photosynthesis) indicavano che l’uomo utilizza ogni anno per se e per gli animali
domestici soltanto il 3% della produttività terrestre come fonte di cibo ma se ne appropria di
circa il 40% per altri scopi, tra cui la produzione di beni non commestibili, risorse di vario
tipo estratte dalle foreste, tagli e incendi boschivi, pastorizia, rimozione di territorio naturale
per attività umane (strade e infrastrutture), erosione dei suoli e conseguente desertificazione.
La produzione di cibo dall’agricoltura è aumentata enormemente nel secolo scorso grazie
alla meccanizzazione, irrigazione, impiego di fertilizzanti e pesticidi. Ma questo è avvenuto
soprattutto nei paesi industrializzati che dispongono di risorse economiche (energia ausiliaria)
per muovere macchine, trattori e pompe nonché per produrre fertilizzanti e pesticidi.
L’agricoltura intensiva dei paesi industrializzati è sostenuta da una fonte energetica gratuita e
pressoché inesauribile, quella radiante, e da una a costi sempre più elevati perché in
esaurimento, quella del petrolio. L’agricoltura intensiva dei paesi industrializzati ha
aumentato la produzione di cibo destinato al consumo umano, ma anche determinato profonde
alterazione dell’habitat. Basti pensare al disboscamento o all’inquinamento delle acque
prodotto dall’uso di fertilizzanti e pesticidi. Pertanto, per una corretta valutazione del reale
beneficio sociale derivante da questo tipo di agricoltura bisognerebbe aggiungere ai costi
energetici ausiliari quelli del degrado ambientale.
Considerando che per raddoppiare il rendimento dei raccolti bisognerebbe decuplicare gli
input di energia ausiliaria (Odum, 2001), si capisce perché la produzione di cibo nei paesi in
via di sviluppo è ancora molto bassa rispetto alle esigenze della popolazione. Nella parte
povera del pianeta, l’incremento nella produzione di cibo è determinato soprattutto
dall’aumento di terra coltivata piuttosto che dall’aumento dei rendimenti delle colture.
Purtroppo, l’aumento di terra da coltivare viene realizzato con il taglio della foresta tropicale
ottenendo risultati tragici su differenti fronti. Infatti, i suoli dei tropici sono poveri di nutrienti
poiché il loro ciclo si realizza soprattutto all’interno della biomassa vivente degli alberi con il
supporto di organismi simbionti, come funghi delle micorrize, alghe e licheni. Una volta
tagliata la foresta l’humus esposto all’intensa radiazione solare e alle elevate temperature dei
tropici si esaurisce in breve tempo e così i pochi nutrienti presenti in questi suoli vengono in
breve tempo dilavati dalle piogge torrenziali. A causa del regime climatico il suolo subisce
una profonda erosione per cui l’agricoltura, così come realizzata nei paesi industrializzati,
risulterebbe fallimentare per gli ingenti investimenti economici necessari per rigenerare
idonee condizioni per le colture. A tutto questo si deve aggiungere la perdita della biodiversità
della foresta tropicale nonché del ruolo che questa ha nel riciclo dell’anidride carbonica a
livello planetario.
Come prima detto, una grossa frazione della produttività primaria è utilizzata anche per
altri scopi. Tra questi vi è la produzione di combustibili. Anche se questo uso della
produttività terrestre costituisce un tema di grande attualità a causa dell’esaurimento del
petrolio, di fatto si tratta di un uso vecchio quanto l’umanità. Senza considerare il petrolio,
3
che in realtà si tratta di produttività primaria trasformata, sotto la superficie terrestre, nel corso
di ere geologiche, il legno costituisce per oltre la metà della popolazione mondiale il
combustibile principale. In alcuni paesi più poveri è usato dal 99% della popolazione come
unico combustibile. Viene usato per cucinare, riscaldamento e illuminazione nonché per
l’industria leggera spesso ad una velocità superiore a quella necessaria per ricrescere (Odum e
Barrett, 2007). Da un pò di tempo anche nei paesi industrializzati si sta pensando di utilizzare
le biomasse provenienti sia dalle foreste che dall’agricoltura per far fronte alla crisi energetica
dovuta alle ridotte disponibilità di petrolio. Alcune delle opzioni possibili richiederanno
ulteriore terra per la coltivazione di piante da cui estrarre combustibili (come biodiesel
dall’olio di colza) o su cui far crescere alberi a rapida crescita e da tagliare in breve tempo
(“foreste combustibili”), determinando competizione tra produzione di cibo e di combustibili
in terreni arabili ed aggravando la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo. Rispetto
alle azioni da intraprendere, è di fondamentale importanza tener presente che foreste, boschi,
praterie, zone umide e altri ecosistemi naturali sostengono la vita sul pianeta attraverso la
produzione di beni e servizi per tutti i viventi e, quindi, per il funzionamento della biosfera.
Bisognerà acquisire la saggezza di non erodere ulteriormente questo capitale naturale.
I processi dissipativi nella catena alimentare limitano il cibo per i consumatori
La produttività primaria netta accumulata nei vegetali si rende disponibile per gli animali
(organismi eterotrofi) presenti nei differenti livelli delle reti alimentari di ecosistemi terrestri e
acquatici. Questi ultimi organismi sono noti come “consumatori”. Produttori e consumatori
durante il loro ciclo vitale rinnovano cellule e tessuti eliminando rifiuti organici che sono
riciclati dagli organismi decompositori. Alla morte di tutti gli esseri viventi, siano essi
produttori, consumatori o decompositori, la sostanza organica dei loro “corpi” si rende
disponibile ancora per questi ultimi (gli spazzini della natura), soprattutto microrganismi, in
grado di decomporla e renderla nuovamente inorganica (per esempio come sali di azoto e
fosforo) disponibile per i produttori.
Questi processi di funzionamento della vita negli ecosistemi terrestri e acquatici sono
possibili grazie al continuo flusso di energia solare. Però mentre la materia subisce numerose
trasformazioni e quindi può essere riciclata e riutilizzata, l’energia nel suo fluire si degrada in
quanto soggetta a processi dissipativi. Dalla termodinamica sappiamo che 1) l’energia si
conserva, non si può creare né distruggere; 2) ad ogni trasformazione l’energia si degrada. In
altri termini, quando facciamo il pieno di gasolio nella nostra auto il motore consente di
trasformare l’energia contenuta nel gasolio in energia di movimento ma soltanto una frazione
diventa energia dinamica di movimento mentre frazioni rilevanti si “perdono” nel
raffreddamento, attrito, gas di scarico, radiazione del motore etc. Così, non tutta l’energia
contenuta nella radiazione solare captata dai sistemi fotosintetici viene trasformata in energia
chimica, una parte consistente è perduta in forma di “calore” non utilizzabile. Non esistono
macchine perfette con rendimenti del 100% nell’uso dell’energia; frazioni rilevanti si perdono
in forma di energia degradata (entropia o disordine termodinamico).
Processi dissipativi che producono entropia si verificano anche nelle reti alimentari nelle
quali oltre ai principi della termodinamica intervengono processi di tipo biologico. Pertanto,
l’energia chimica contenuta nelle piante ovvero nel primo livello della catena alimentare non
può essere completamente trasferita in quella degli animali erbivori ovvero del secondo
livello della catena alimentare. Per esempio, un erbivoro nel suo pascolare non consuma
totalmente i vegetali di cui si ciba, infatti, le radici o le parti più dure e meno appetibili non
vengono mangiate. Eppure anche nelle radici e in tutte gli altri tessuti, siano essi duri o teneri,
vi è energia chimica derivante dalla trasformazione di energia solare. Quindi, questa frazione
di energia non viene utilizzata. Inoltre, delle parti consumate non tutto viene assimilato e,
quindi, alcuni tessuti vegetali non digeribili vengono eliminati con le deiezioni. Infine, di
4
quanto è stato assimilato non tutto viene convertito in biomassa; una frazione consistente sarà
utilizzata nei differenti processi metabolici che consentono le funzioni vitali dell’erbivoro, a
partire dall’energia spesa per mangiare e per il movimento a quella spesa per processi di
secrezione, digestione, riproduzione etc. degradandosi nel cosiddetto “calore respiratorio”.
Quindi, a fronte di una certa quantità di energia contenuta negli organismi vegetali
(produttori) soltanto una parte (circa il 10%) diventerà sostanza organica degli erbivori
(consumatori primari). Così di tale sostanza organica soltanto una frazione (variabile da 1 a
20%) diventerà sostanza organica dei carnivori (consumatori secondari). Infatti, anche per il
trasferimento dell’energia dal secondo livello alimentare, quello degli erbivori, al terzo
livello, quello dei carnivori valgono le medesime considerazioni energetiche. Un leone che
cattura e uccide una zebra non è in grado di consumarla in tutte le sue parti, tra cui le strutture
scheletriche, i denti o gli zoccoli che pure contengono energia chimica. Quindi, questa
frazione di energia non viene utilizzata. Così di quello consumato una parte non sarà
assimilata e della parte assimilata una frazione rilevante sarà utilizzata per il fabbisogno
metabolico del leone (anche per la cattura della zebra) che implica anche in questo caso un
degrado come “calore respiratorio”. Questo flusso di energia che parte dai vegetali e continua
con erbivori pascolanti e carnivori che mangiano erbivori costituisce le catene alimentari del
“pascolo”. L’energia non utilizzata e non assimilata può essere ancora recuperata nelle catene
alimentari del “detrito” che partono dalla sostanza organica (resti di organismi, rifiuti
organici, feci etc.) e vedono l’intervento degli spazzini della natura (detritivori,
decompositori) fino ai loro predatori. Tutto il calore respiratorio prodotto in entrambi i tipi di
catene alimentari non può essere più recuperato e va ad aggiungersi all’entropia o “disordine”
dell’universo. Di fatto, le catene alimentari sono sequenze tra loro interconnesse che
costituiscono reti alimentari attraverso le quali fluisce l’energia radiante convertita in sostanza
organica.
A fronte di quanto appena riportato, è evidente che passando da un livello alimentare al
successivo c’è sempre meno energia (e meno cibo) disponibile per gli organismi negli
ecosistemi. Questo fatto incontrovertibile viene rappresentato attraverso piramidi alimentari in
cui la quantità (numerica, in biomassa ed energetica) dei vegetali è maggiore di quella degli
erbivori, quella di questi ultimi è maggiore di quella dei carnivori e così via fino ai carnivori
terminali che sono gli organismi più rari del pianeta. Sempre meno bocche possono essere
sfamate passando dal livello dei produttori a quello dei consumatori all’apice di tali piramidi.
Le proteine della carne sono presenti nella dieta dei popoli più ricchi, che possono permettersi
il lusso di coltivare terra per produrre alimenti per gli animali domestici e vivere anche come
consumatori secondari e terziari, mentre i poveri del mondo mangiano (quando possibile)
riso, cereali e patate vivendo soltanto come consumatori primari.
La notevole perdita di energia ad ogni passaggio da un livello alimentare al successivo
impone un limite al numero di tali livelli nelle reti trofiche. L’evoluzione probabilmente non
ha prodotto un predatore del leone non tanto perché il leone è così impossibile da uccidere e
mangiare (il pianeta ha conosciuto predatori più grossi e terribili del leone) quanto perché ci
sarebbe poca energia per sostenere un livello trofico al di sopra di quello del leone. Il fatto che
i piccoli del leone possano essere predati dalle iene dipende dalla complessità delle interazioni
tra organismi nelle reti trofiche e non significa che la iena occupa stabilmente un livello
trofico al di sopra di quello del leone. Nel mare le catene alimentari si presentano più lunghe
perché sia il consumo che l’assimilazione soprattutto da parte degli erbivori e, in misura
minore, dei carnivori è in genere più efficiente nel trasferire energia da un livello trofico al
successivo. In pratica ad ogni passaggio si perde un pò meno energia nelle catene alimentari
marine. Infatti, i vegetali marini sono più piccoli e teneri e, quindi, più facili da consumare e
digerire anche da parte di erbivori a loro volta molto piccoli (zooplancton) mentre quelli
terrestri, invece, sono più grandi e con solide strutture di sostegno, spesso molto dure,
5
coriacee e spinose. Comunque, nel mare le reti alimentari sono persino più complesse in
quanto la gran parte degli organismi si riproduce attraverso la produzione di uova e larve e,
pertanto, molte specie prede mangiano uova e larve dei loro predatori. Inoltre, le cose sono
ulteriormente complicate dal fatto che molti organismi marini passano da un livello trofico al
successivo durante la loro crescita.
Energia solare, alghe microscopiche e produzione di cibo nel mare
Il cibo che l’umanità ricava dal mare è soprattutto di origine animale (pesci, molluschi,
crostacei) e deriva principalmente dalle catene alimentari il cui primo anello è rappresentato
da alghe microscopiche (fitoplancton) la cui distribuzione è limitata alla disponibilità di luce,
più o meno nei primi 200 m di profondità. La produttività primaria dovuta al fitoplancton è
correlata non soltanto alla disponibilità di luce ma anche a quella di nutrienti (azoto, fosforo,
ferro etc.) nonché a particolari fonti di energia sussidiaria (correnti ascendenti, flussi di marea
etc.) (Nybakken, 1997). Pertanto, essa si differenzia moltissimo tra acque costiere, estuari,
mare aperto, zone con correnti ascendenti delle acque e così via. L’energia fissata dai
produttori primari viene trasferita nei successivi anelli delle catene alimentari marine. Come
prima riportato, nei processi di trasferimento si verifica una consistente perdita di energia e
pertanto la sua quantità, insieme alla biomassa, si riduce passando dai primi agli ultimi livelli
trofici, generalmente occupati dai carnivori terminali (o predatori di vertice delle piramidi
alimentari).
Assumendo un’efficienza di trasferimento del 10% tra il primo e il secondo livello trofico,
occorrerebbero 100 kg di fitoplancton per formarne 10 kg di zooplancton. Considerando
ancora un’efficienza del 10% nei successivi passaggi, dai 10 kg di zooplancton si potrà
formare 1 kg di alici e soltanto 100 g di tonno. A fronte di tale esempio, si comprende che la
quantità di risorse presenti in una determinata area marina dipenderà non soltanto dalla
produttività primaria ma anche dall’efficienza di trasferimento nella piramide alimentare.
Poiché l’efficienza di trasferimento nel mare è generalmente maggiore che negli ecosistemi
terrestri (produttori e consumatori primari sono soprattutto organismi microscopici o molto
piccoli di più facile consumo e assimilazione) le catene alimentari possono presentarsi più
lunghe (anche con 6-7 livelli trofici). Comunque, l’energia disponibile per i predatori di
vertice è sempre piuttosto esigua e questo spiega non soltanto la rarità di questi organismi
negli ecosistemi ma anche il fatto che maggiori quantità di risorse (e di cibo) si ricavano nei
primi livelli trofici piuttosto che negli ultimi.
Le stime effettuate da Pauly e Christensen (1995) indicano che in media l’8% della
produttività primaria globale del mare sostiene la pesca a livello mondiale o, in altri termini,
questa è la percentuale di produttività primaria che diventa cibo per l’uomo. Questa
percentuale si abbassa per l’oceano aperto (circa 2%) e aumenta nelle zone costiere e con
correnti ascendenti (tra 24 e 35%) confermando la maggiore produttività di questi ultimi
sistemi ambientali anche in termini di risorse sfruttate dall’uomo. Le statistiche della FAO
(2002) riportano che le catture degli organismi marini a livello mondiale si attestano intorno a
90 milioni di tonnellate per anno. Considerando le catture non controllate dalle statistiche
ufficiali nonché quelle non regolate o illegali è probabile che le catture mondiali di specie
marine oscillino tra 100 e 140 milioni di tonnellate/anno (King, 1995). I pesci costituirebbero
oltre l’85% di queste catture, i molluschi circa il 9% e i crostacei soltanto il 5-6%. In base a
quanto prima detto sulla produttività dei sistemi acquatici, le rese medie per l’oceano aperto
sarebbero di appena 0,02 tonnellate/km2/anno per le acque tropicali e 0,5 per quelle
temperate, 2 e 6 tonnellate/km2/anno per le acque della piattaforma continentale
rispettivamente temperata e tropicale fino a circa 18 tonnellate/km2/anno per le zone con
correnti ascendenti delle acque (Marten e Polovina, 1982).
6
Pesci, cefalopodi, crostacei e altri organismi, costituiscono risorse del mare utilizzati
dall’uomo, soprattutto per scopi alimentari ma anche per la produzione di farine di pesce,
prodotti per l’acquacoltura e prodotti artigianali e ornamentali di vario tipo. Queste risorse
sono potenzialmente rinnovabili (gli organismi, nascono, crescono, si riproducono e muoiono)
ma non inesauribili. La loro consistenza ed evoluzione è legata ai numerosi fattori selettivi
che agiscono nell’ecosistema marino (condizioni idrografiche, produttività, predazione etc.)
nonché alle attività umane, prima fra tutte l’attività di pesca.
La sovrapesca e l’accorciamento delle reti alimentari
La pesca è una delle attività più antiche dell’umanità. Infatti, ancor prima dell’agricoltura,
la pesca ha assunto un ruolo fondamentale per l’uomo come fonte di cibo.
Sebbene nel corso della lunga storia dell’umanità siano variate le tecniche del prelievo e le
quantità di organismi raccolti, il rapporto uomo-organismi nell’attività di pesca si configura
unicamente come un rapporto di predazione. L’uomo si pone, quindi, ad un livello trofico
superiore a quello degli organismi pescati. Nel corso dei millenni e fino al XIX secolo,
l’uomo non ha ritenuto, neppure lontanamente, di poter causare il depauperamento o persino
l’estinzione delle popolazioni sfruttate, anzi riteneva che le risorse del mare fossero
inesauribili e quindi per poterne ottenere una maggiore quantità bisognava dedicare più tempo
e potenziare i mezzi impiegati nel loro prelievo, ossia aumentare il cosiddetto “sforzo di
pesca”. In realtà, sebbene le popolazioni delle specie acquatiche siano rinnovabili esse non
sono inesauribili. La sostenibilità dello sfruttamento di queste specie si basa sul presupposto
che l’ammontare della biomassa pescata in mare debba essere proporzionale alla sua capacità
di rinnovo. Infatti, un eccessivo prelievo impedisce l’adeguata ricostituzione delle popolazioni
determinandone il depauperamento e generando una serie di problemi economici e sociali.
L’incremento di catture che a volte, ma sempre più raramente, è possibile registrare in alcune
aree è generalmente dovuto all’aumento della flotta e al miglioramento delle tecnologie di
pesca piuttosto che ad una maggiore disponibilità di risorse nel mare. In tali situazioni lo
sforzo di pesca mantenuto ad alti livelli potrebbe determinare il collasso di una o più risorse
nelle aree di distribuzione. Tristemente famoso è il caso del collasso dello stock canadese del
merluzzo Atlantico (Walters e Maguire, 1996).
Attualmente il 47% degli stock ittici mondiali risultano pienamente sfruttati, il 18%
sovrasfruttati e il 10% in una condizione di depauperamento. Soltanto il 25% degli stock
risulterebbero, invece, moderatamente sfruttati o sottoutilizzati dalla pesca (FAO, 2002). Il
termine sovrapesca (overfishing) può essere considerato rispetto a due principali processi
biologici di incremento della biomassa degli stock ittici ossia reclutamento (le nuove
generazioni di pesci si uniscono allo stock adulto) e accrescimento (gli individui crescono in
lunghezza e peso). Pertanto, si può determinare una condizione di sovrapesca quando uno
stock è depauperato ad un livello tale che i pochi adulti rimasti risultino insufficienti a
produrre abbastanza nuovi individui da rinnovare la popolazione. Questo tipo di sovrapesca si
verifica più frequentemente nelle specie pelagiche dove gli individui sono aggregati in banchi
ad alta densità, facili da individuare con gli strumenti di bordo (ecosonar) e quindi facili da
catturare anche quando l’intero stock risulta sovrasfruttato. Altri organismi che possono
andare incontro a questa sovrapesca sono quelli con basse capacità riproduttive, come le
tartarughe, gli squali e i mammiferi. La vulnerabilità di questi organismi all’azione della
pesca può determinare non soltanto il collasso degli stock ma persino l’estinzione della specie
(Roberts e Hawkins, 1999; Jackson et al., 2001). Spesso la sovrapesca si riferisce al fatto che
gli individui di una popolazione sono catturati quando sono ancora molto piccoli ovvero la
pesca cattura questi individui non dando loro il tempo di raggiungere dimensioni che possano
fornire biomasse pescabili di una certa entità. Oltre tutto, a questi individui catturati
prematuramente non viene consentito di riprodursi almeno una volta nell’ambito del loro ciclo
7
vitale. Questo tipo di overfishing si verifica soprattutto nelle specie demersali (quelle che
vivono in prossimità del fondale marino) le quali vengono catturate principalmente con
attrezzi (reti a strascico) che non selezionano le differenti taglie degli individui nello stock ma
catturano anche le forme giovanili. Molti stock demersali mediterranei sono in una condizione
di sovrapesca di questo tipo.
Passando da una singola popolazione all’insieme di specie sfruttate dalla pesca in una
realtà multispecifica, come quella mediterranea, un altro concetto delineatosi più di recente è
quello di “ecosystem overfishing” (Pauly, 1983). Questo tipo di sovrapesca si riferisce al fatto
che la riduzione in biomasse e taglie di popolazioni ittiche originariamente abbondanti non è
compensata dal contemporaneo o successivo incremento di biomassa di altre popolazioni
ittiche. Pertanto, un ecosistema relativamente maturo, stabile ed efficiente dominato da specie
longeve e di grosse dimensioni si trasformerebbe in uno relativamente instabile, immaturo ed
inefficiente dominato da specie più piccole e opportuniste. In altri termini, gli organismi dei
livelli trofici superiori e i predatori di vertice, più vulnerabili al prelievo non soltanto per le
loro maggiori dimensioni ma anche in relazione alle loro strategie vitali (crescita lenta,
maturità sessuale raggiunta dopo alcuni anni, bassa fecondità) diventano sempre più rari
mentre aumentano i consumatori dei primi livelli trofici non più soggetti al controllo da parte
dei loro predatori rimossi dalla pesca. Questa condizione spiega la riduzione dei vertebrati,
squali e pesci ossei più longevi, e l’incremento degli invertebrati a breve ciclo vitale nelle aree
sovrasfruttate dall’attività di pesca, riflettendosi in un accorciamento della rete alimentare
(“fishing down marine food web”) (Pauly et al., 1998).
La tragedia dei beni comuni e il necessario cambio di rotta
Gli effetti negativi, sia dal punto di vista ecologico che economico, generati dallo
sfruttamento incontrollato di risorse comuni, sia se si tratti di terra per il pascolo o pesci in
mare, sono stati presentati in un famoso lavoro intitolato “The tragedy of the commons”
(Hardin, 1968), in cui viene spiegato che chi partecipa al prelievo di una risorsa pur essendo
consapevole della necessità di conservarla ne causa l’esaurimento. A fronte di quanto
riportato, è evidente che sia l’uso della terra (per qualsiasi destinazione) che l’attività di pesca
pur fornendo beni e generando profitti, possono causare, non soltanto sovrasfruttamento delle
risorse (suolo, stock ittici) ma negatività a livello di ecosistema (inquinamento del suolo e
delle acque; alterazione della biodiversità e della struttura delle reti alimentari). Dalla
preistoria ai tempi attuali, l’uso delle risorse naturali da parte dell’uomo ha attraversato
differenti fasi legate principalmente all’incremento demografico e allo sviluppo della
tecnologia. Questa se da un lato ha consentito di estrarre e prelevare risorse anche in ambienti
remoti e inaccessibili (per esempio il sottosuolo o le profondità degli oceani), dall’altro ha
determinato effetti di vario tipo ed entità nell’ambiente (Commoner, 1972).
Nel caso dell’agricoltura nei paesi industrializzati, al vantaggio di rendimenti elevati delle
colture, che deriva dall’investimento in energia ausiliaria attraverso l’uso estensivo di
macchine, fertilizzanti e pesticidi, si contrappongono le conseguenti ripercussioni ambientali.
Inoltre, la cattiva gestione del territorio, tra cui il disboscamento e l’urbanizzazione
(complessi abitativi e strade) in zone rurali, ha provocato rilevanti perdite dei suoli. Nei paesi
in via di sviluppo, la crescente pressione demografica e le condizioni di povertà hanno spinto
alla deforestazione per ricavare legna, coltivare prodotti agricoli e far pascolare gli animali
domestici, aggravando i processi di desertificazione già favoriti dal regime climatico. Poiché
il suolo costituisce il supporto base per realizzare la produttività primaria in ambiente
terrestre, la diminuzione delle superfici coltivabili implicherà una riduzione di prodotti
alimentari per l’uomo e gli animali.
Nel caso della pesca, all’investimento economico per la gestione dell’impresa da pesca,
dalla costruzione dell’imbarcazione ai costi del gasolio, corrispondono profitti derivanti dalla
8
vendita del pescato. Oltre che dal punto di vista ecologico, anche in termini economici, la
sovrapesca determina effetti negativi sul capitale naturale rappresentato dalle popolazioni
acquatiche. Infatti, questo capitale produce di anno in anno “interessi” in forma di nuovi
organismi da pescare. Se si intacca questo capitale le nuove entrate si ridurranno e, quindi, si
tenderà ad intaccare ulteriormente il capitale per poter ricavare almeno le medesime entrate.
Tale processo protratto nel tempo condurrà alla riduzione del capitale fino al suo esaurimento
condizionando negativamente le successive attività economiche. Se le modalità con cui viene
effettuato il prelievo sono appropriate, ossia bilanciano le capacità rigenerative delle
popolazioni di pesci, crostacei e molluschi, gli effetti saranno positivi e così il profitto
economico; se, invece, il prelievo eccede la ricostituzione di tali popolazioni gli effetti
saranno negativi generando situazioni di inefficienza economica. Gli effetti a livello ecologico
ed economico si rifletteranno su quelli sociali, soprattutto in termini di occupazione, reddito e
qualità della vita degli operatori del settore (Spagnolo, 2006).
La incessante crescita della popolazione umana richiede una maggiore quantità di risorse,
innescando un processo irreversibile di maggiore consumo al di sopra delle capacità portanti
del pianeta. Poiché questo non è poi tanto grande, da un pò di tempo, è stata ravvisata la
necessità di un cambio di rotta nella gestione del patrimonio naturale. La crescita della
popolazione (ma anche quella economica) non può essere illimitata rispetto a risorse limitate
(Ehrlich ed Ehrlich, 1991). L’efficienza ecologica di fotosintesi nella biosfera è in media
dell’1%, ma mentre per la foresta tropicale è intorno al 3,5% per i deserti è di circa lo 0,05%.
Per avere più cibo e risorse conviene mantenere la foresta o aumentare il deserto? La risposta
è scontata e implica una gestione del capitale naturale che miri alla conservazione degli
ecosistemi e dei processi che consentono il mantenimento della vita.
A livello mondiale sia l’erosione dei suoli (e la relativa desertificazione) che il prelievo
delle risorse marine rappresentano problematiche ambientali ormai affrontate in termini
globali e su principi di sostenibilità. Il concetto di sviluppo sostenibile, ossia di uno sviluppo
che risponda ai bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future, è
stato introdotto dalla Commissione Mondiale per lo Sviluppo e l’Ambiente (Commissione
Brundtland, 1987). Tale concetto evidenzia la necessità di un’equità intergenerazionale
nell’uso delle risorse. Con la conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo,
tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, vengono definite le azioni da intraprendere per coniugare
esigenze di sviluppo con principi di sostenibilità. In particolare, è attraverso l’adozione
dell’agenda per il XXI secolo (Agenda 21) che vengono definite le linee programmatiche
dirette ad assicurare la cooperazione internazionale nello sfruttamento sostenibile delle risorse
e la protezione dell’ambiente. Per esempio, per contrastare l’innesco di processi di
desertificazione occorre agire soprattutto sul mantenimento e sul controllo della copertura
vegetale dei suoli nonché sull’utilizzo dei residui e rifiuti vegetali che concorrono alla loro
fertilità e alla loro capacità di trattenere acqua. Qualora il suolo venga sottoposto ad
agricoltura intensiva è necessario che le colture siano compatibili con le caratteristiche
naturali dei terreni e dell’ambiente e che le comunità locali siano coinvolte nel ripristino di
pratiche tradizionali che non soltanto riducano l’erosione ma anzi adottino processi di tipo
conservativo che permettano di formare il suolo anziché consumarlo.
Le più recenti convenzioni internazionali considerano lo sfruttamento delle risorse
biologiche del mare su base ecosistemica ossia che includa una gestione sostenibile non
soltanto degli stock ittici commerciali, ma anche del sistema ecologico che ne supporta la
produzione. Tutti siamo consapevoli che il prezzo che paghiamo comprando il pesce dipende
dai costi sostenuti per catturalo e per venderlo, ma quasi nessuno tiene conto del lavoro fatto
dall’ecosistema marino per produrlo a partire dall’energia del sole. Per questo è fondamentale
conservare intatte strutture e funzioni ecosistemiche che possano continuare a produrre beni e
servizi per la vita sul pianeta.
9
L’approccio ecosistemico è stato specificamente trattato nella Conferenza di Reykjavik del
2001 sulla “Pesca responsabile negli ecosistemi marini”. Tale approccio considera gli impatti
che la pesca ed altre attività umane determinano sull’ecosistema marino con l’obiettivo di
contribuire alla sicurezza alimentare nel lungo periodo, allo sviluppo umano nonché alla
conservazione degli habitat e delle relative risorse (Garcia et al., 2003). Le conclusioni di
Reykjavik sono state ulteriormente ribadite, per esempio nel World Summit sullo Sviluppo
Sostenibile tenutosi nel 2002 a Johannesburg, Sud Africa. Gli oceani, mari, isole e aree
costiere costituiscono componenti essenziali ed integrate dell’ecosfera. Essi rappresentano
aree critiche per la sicurezza alimentare globale e per sostenere la prosperità economica di
differenti nazioni e soprattutto dei paesi in via di sviluppo.
Bibliografia
Commissione Brundtland G.H., 1987. Commissione mondiale indipendente sull’ambiente e lo
sviluppo. Il futuro di noi tutti. Bompiani Editore.
Commoner B., 1972. Il cerchio da chiudere. Garzanti.
Ehrlich P., Ehrlich A., 1991. Un pianeta non basta. Muzzio Editore.
FAO 2002. The state of the world fisheries and aquaculture 2002. FAO, Rome.
Garcia S.M., Zerbi A., Aliaume C., Do Chi T., Lasserre G., 2003. The ecosystem approach to
fisheries. Issue, terminology, principles, institutional foundations, implementation and
outlook. FAO Fisheries Technical Paper, N. 443: 71 pp.
Hardin G., 1968. The tragedy of the commons. Science, 162: 1243-48.
Jackson J.B.C., Kirby M.X., Berger W.H., Bjorndal K.A., Botsford L.W., Bourque B.J.,
Bradbury R.H., Cooke R., Erlandson J., Estes J.A., Hughes T.P., Kidwell S., Lange C.B.,
Lenihan H.S., Pandolfi J.M., Peterson C.H., Stenek R.S., Tegner M.J., Warner R.R., 2001.
Historical Overfishing and the Recent Collapse of Coastal Ecosystems. Science, 293: 629638.
King M., 1995. Fisheries Biology, Assessment and Management. Fishing News Books.
Blackwell Science.
Marten C.G., Polovina J.J., 1982. A comparative study of fish yields from various tropical
ecosystems. In: Theory and management of tropical fisheries (eds Pauly D. & Murphy
G.I.). ICLARM Conference Proceedings, 9.
Nybakken J.W., 1997. Marine Biology. An ecological approach. Addison-Wesley
Educational Publishers Inc.
Odum E.P., 2001. Ecologia: un ponte tra scienza e società. Piccin.
Odum E.P., Barrett G.W., 2007. Fondamenti di ecologia. Piccin.
Pauly D., 1983. Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks. Fish. Tech.
Pap. 234: 52 pp.
Pauly D., Christensen V., 1995. Primary production required to sustain global fisheries.
Nature, 374: 255-257.
Pauly D., Christensen V., Dalsgaard J., Froese R., Torres R.F.Jr., 1998. Fishing down marine
food webs. Science, 279: 860-863.
Roberts C.M., Hawkins J.P., 1999. Extinction risk in the sea. TREE, 14: 241-245.
Spagnolo M., 2006. Elementi di economia e gestione della pesca. FrancoAngeli.
Vitousek P.M., Ehrlich P.R., Ehrlich A.H., Matson P.A., 1986. Human Appropriation of the
Products of Photosynthesis. BioScience, 36 (6): 368-373.
Walters C., Maguire J.-J., 1996. Lessons for stock assessment from the northern cod collapse.
Reviews in Fish Biology and Fisheries, 6: 125-137.
Whittaker R.H., 1975. Communities and Ecosystems, 2nd Ed. Macmillan, London.
10