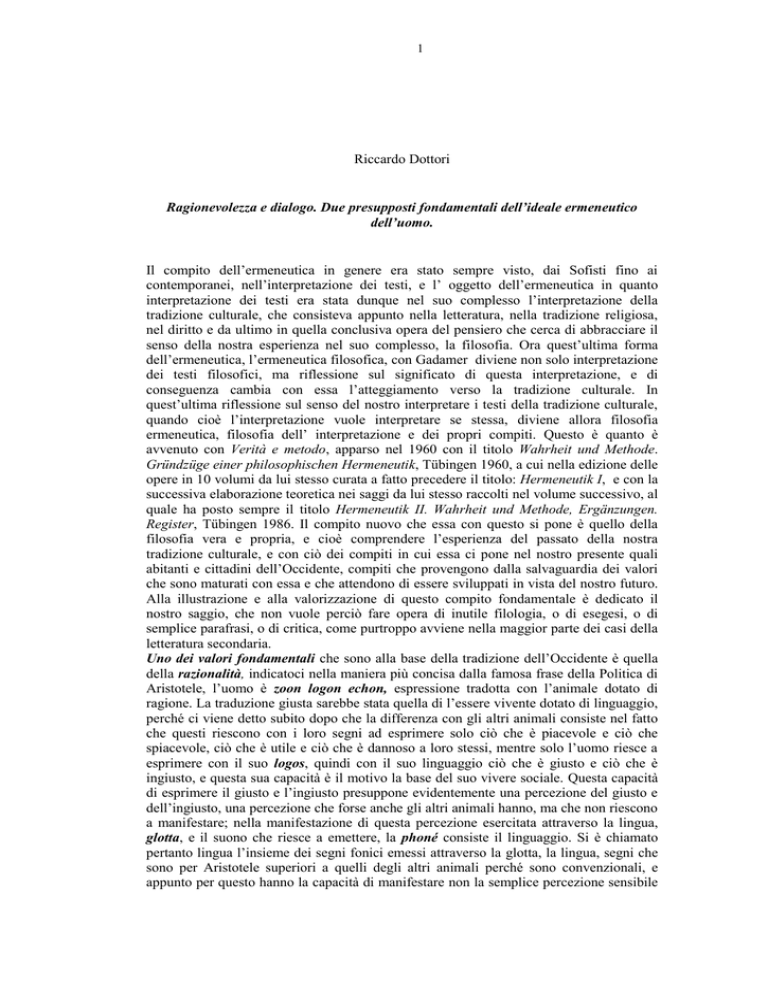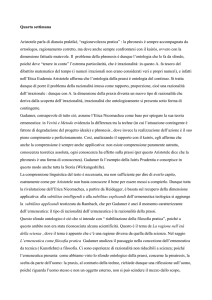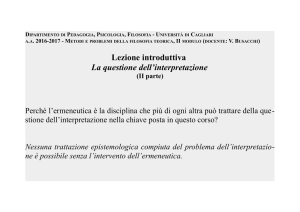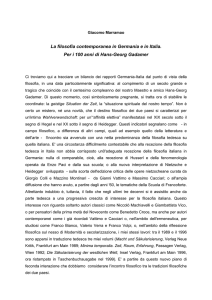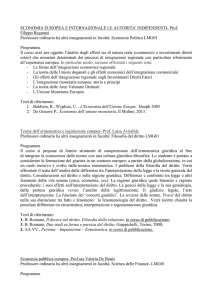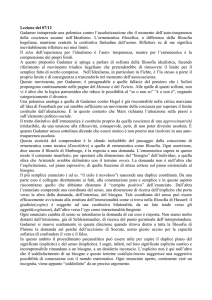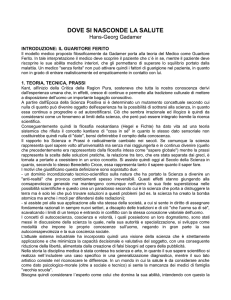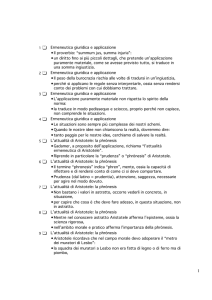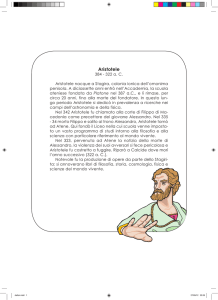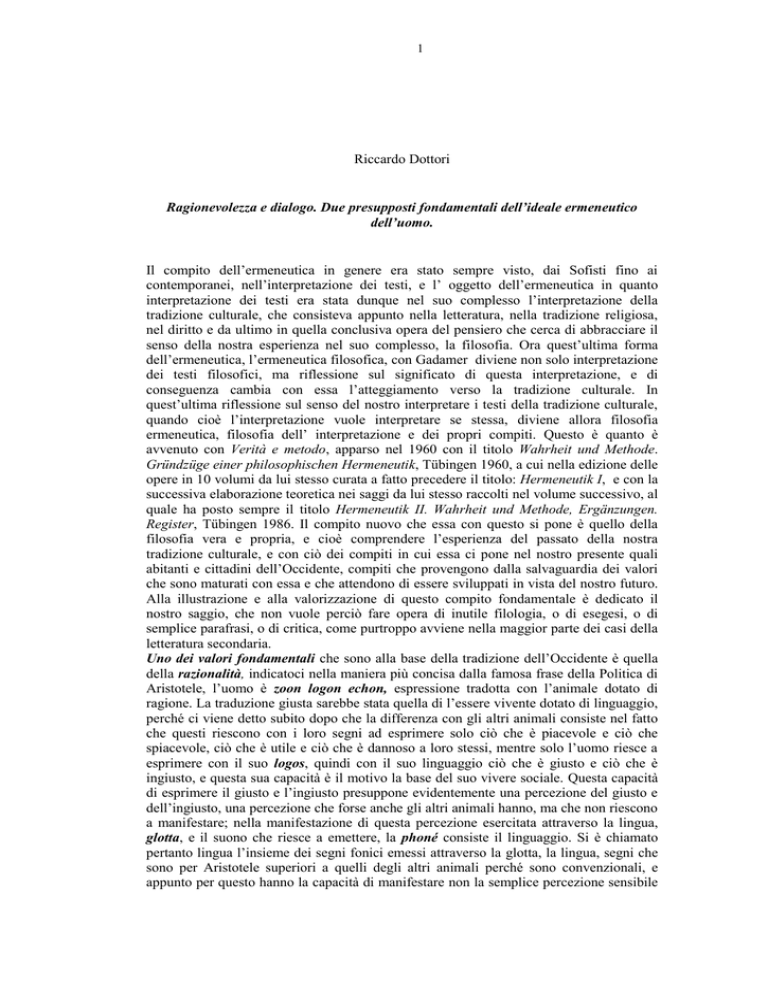
1
Riccardo Dottori
Ragionevolezza e dialogo. Due presupposti fondamentali dell’ideale ermeneutico
dell’uomo.
Il compito dell’ermeneutica in genere era stato sempre visto, dai Sofisti fino ai
contemporanei, nell’interpretazione dei testi, e l’ oggetto dell’ermeneutica in quanto
interpretazione dei testi era stata dunque nel suo complesso l’interpretazione della
tradizione culturale, che consisteva appunto nella letteratura, nella tradizione religiosa,
nel diritto e da ultimo in quella conclusiva opera del pensiero che cerca di abbracciare il
senso della nostra esperienza nel suo complesso, la filosofia. Ora quest’ultima forma
dell’ermeneutica, l’ermeneutica filosofica, con Gadamer diviene non solo interpretazione
dei testi filosofici, ma riflessione sul significato di questa interpretazione, e di
conseguenza cambia con essa l’atteggiamento verso la tradizione culturale. In
quest’ultima riflessione sul senso del nostro interpretare i testi della tradizione culturale,
quando cioè l’interpretazione vuole interpretare se stessa, diviene allora filosofia
ermeneutica, filosofia dell’ interpretazione e dei propri compiti. Questo è quanto è
avvenuto con Verità e metodo, apparso nel 1960 con il titolo Wahrheit und Methode.
Gründzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960, a cui nella edizione delle
opere in 10 volumi da lui stesso curata a fatto precedere il titolo: Hermeneutik I, e con la
successiva elaborazione teoretica nei saggi da lui stesso raccolti nel volume successivo, al
quale ha posto sempre il titolo Hermeneutik II. Wahrheit und Methode, Ergänzungen.
Register, Tübingen 1986. Il compito nuovo che essa con questo si pone è quello della
filosofia vera e propria, e cioè comprendere l’esperienza del passato della nostra
tradizione culturale, e con ciò dei compiti in cui essa ci pone nel nostro presente quali
abitanti e cittadini dell’Occidente, compiti che provengono dalla salvaguardia dei valori
che sono maturati con essa e che attendono di essere sviluppati in vista del nostro futuro.
Alla illustrazione e alla valorizzazione di questo compito fondamentale è dedicato il
nostro saggio, che non vuole perciò fare opera di inutile filologia, o di esegesi, o di
semplice parafrasi, o di critica, come purtroppo avviene nella maggior parte dei casi della
letteratura secondaria.
Uno dei valori fondamentali che sono alla base della tradizione dell’Occidente è quella
della razionalità, indicatoci nella maniera più concisa dalla famosa frase della Politica di
Aristotele, l’uomo è zoon logon echon, espressione tradotta con l’animale dotato di
ragione. La traduzione giusta sarebbe stata quella di l’essere vivente dotato di linguaggio,
perché ci viene detto subito dopo che la differenza con gli altri animali consiste nel fatto
che questi riescono con i loro segni ad esprimere solo ciò che è piacevole e ciò che
spiacevole, ciò che è utile e ciò che è dannoso a loro stessi, mentre solo l’uomo riesce a
esprimere con il suo logos, quindi con il suo linguaggio ciò che è giusto e ciò che è
ingiusto, e questa sua capacità è il motivo la base del suo vivere sociale. Questa capacità
di esprimere il giusto e l’ingiusto presuppone evidentemente una percezione del giusto e
dell’ingiusto, una percezione che forse anche gli altri animali hanno, ma che non riescono
a manifestare; nella manifestazione di questa percezione esercitata attraverso la lingua,
glotta, e il suono che riesce a emettere, la phoné consiste il linguaggio. Si è chiamato
pertanto lingua l’insieme dei segni fonici emessi attraverso la glotta, la lingua, segni che
sono per Aristotele superiori a quelli degli altri animali perché sono convenzionali, e
appunto per questo hanno la capacità di manifestare non la semplice percezione sensibile
2
del piacevole o dello spiacevole, di ciò che è immediatamente utile o dannoso, come
fanno i segni naturali degli animali, ma ciò che non si percepisce immediatamente, ma
soltanto attraverso la mediazione del rapporto con l’altro, e cioè attraverso la costatazione
che ciò che è piacevole e utile per l’altro è spiacevole o dannoso per me, e ciò che utile
per me può essere spiacevole o utile per l’altro. Questa percezione mediata dal rapporto
attraverso l’altro non è più una percezione sensibile di un oggetto o di uno stato interno,
ma la percezione di una relazione, ed è stata perciò chiamata dianoia, pensiero. I segni
fonici emessi e articolati attraverso la lingua sono la manifestazione di questa percezione
relazionale, o del pensiero, che connette la mia alla altrui percezione quando siamo in un
rapporto discorsivo, e da ultimo dialogico con l’altro; ora connettere viene detto in greco
legein, ma il logos sta significare sia questa percezione della relazione basilare Io - Tu,
che è la dianoia, il pensiero, sia anche la manifestazione di questa percezione relazionale
perché appunto ci si rende conto del fatto che la percezione relazionale diviene reale solo
nel momento in cui la si manifesta, solo cioè attraverso la lingua e il sistema di segni
fonici che la possono manifestare in tutte le sue valenze. In che cosa consiste il giusto e
l’ingiusto lo sappiamo solo nel momento in cui lo manifestiamo reciprocamente tramite
segni, e questa capacità assolutamente relazionale della reciproca manifestazione delle
nostre percezioni relazionali è detta appunto logos, linguaggio. Ma questa capacità
linguistica che per Aristotele come per Chomsky appartiene solo alla specie umana, è
inoltre ciò che ci lega reciprocamente, ovvero la base del vivere in comune o della
società.
Nel vivere sociale siamo quindi legati dalla nostra capacità di manifestare non solo tutto
ciò che ci sembra giusto e ingiusto, ma anche i motivi per cui lo riteniamo tale; il
linguaggio in quanto logos è perciò oltre la semplice manifestazione, la capacità di dare le
ragioni delle nostre opinioni: per questo il logos è stato tradotto nella lingua latina con
ragione, una metonimia fondamentale per la quale la parte, la manifestazione attraverso la
lingua o il linguaggio del giusto e dell’ ingiusto diviene il tutto della comunicazione e del
pensiero, il dar ragione delle nostre opinioni sulla base delle cognizioni di causa. Sulla
base del poter dare la ragione, ton logon didonai, il logos diviene la ragione, ciò che lega
in modo indissolubile l’essere e il pensiero. Perciò non è del tutto ingiusta la traduzione
latina della espressione aristotelica zoon logon echon come l’essere vivente dotato di
ragione.
A questa ragione come causa, aitia, fondamento, archè, si aggiunge il concetto di ragione
come fine, telos, che è poi la vera ragione di tutto il processo. Ora questo pensare non
solo secondo il principio di causa effetto, ma anche di azione diretta ad un fine, diviene il
vero principio della civiltà occidentale. Ma nell’era della tecnica la ragione come il
principio dell’essere e del pensare e la conseguente visione della vita comune da
impostare secondo il principio di ragione come principio dell’agire razionale, come agire
diretto ad un fine, che dal punto di vista sociale e politico vuol dire agire secondo la
norma del giusto e dell’ingiusto, e dal punto di vista singolo agire in vista del bene,
diviene nell’era della tecnica il principio della razionalità dell’agire e del pianificare, sia
al livello individuale, che al livello sociale, agire avendo come fine e come misura
semplicemente l’utile. Al livello macroeconomico la razionalità vuol dire in questo caso
la razionalizzazione della produzione e delle risorse del nostro pianeta; e questo sembra
essere l’arma più propria per quanto riguarda la sussistenza e sopravvivenza di una
umanità che tende continuamente a crescere entro quelli che sono i limiti delle risorse del
nostro pianeta. Il problema è che la nutrizione di ormai quasi 7.000.000.000 di abitanti
della terra e la miseria in cui versa la grande maggioranza delle popolazioni africane e in
parte asiatiche, nonché la situazione di endemica arretratezza degli stati dell’America
latina e degli stati europei post-comunisti pongono dei seri interrogativi per la
pianificazione delle risorse per il futuro dell’umanità. È chiaro infatti che nella misura
3
in cui ci sforziamo di rispondere a questi interrogativi e a questi problemi andiamo a
cozzare con i limiti che il nostro pianeta pone alle condizioni della nostra sussistenza.
Questa è la prima sfida.
Ma non è l’unica. Con questa sfida della razionalizzazione e della pianificazione del
futuro viene ad incrociarsi l’altra sfida che proviene da un principio fondamentale della
civiltà occidentale in quanto cristiana, ed è quella legata alla solidarietà. È impossibile
pensare di poter pianificare il nostro futuro, inteso come il futuro del pianeta, senza il
valore fondamentale della solidarietà. La razionalizzazione della produzione e delle
risorse non è da sola sufficiente a far fronte ai problemi di cui si parla; infatti il regime
della libera iniziativa e della concorrenza nell’età industriale nella quale viviamo tende
sempre all’accaparramento delle risorse per l’ assicurazione della propria
sopravvivenza o per la propria egemonia.
Perciò questa è la seconda sfida, direttamente incrociata con la prima e forse
contrapposta alla prima: la sfida della solidarietà tra gli abitanti del pianeta.
Noi lottiamo non solo per la nostra sussistenza o sopravvivenza, ma per la nostra
egemonia, in quanto la vediamo come condizione della sopravvivenza. La Cina, il
Giappone e i paesi Arabi lo stanno facendo da tempo; essi stanno acquistando vaste aree
agricole in Africa, e nei paesi dell’Est europeo per garantirsi la loro autosufficienza
alimentare. L’Occidente, se con tale termine intendiamo l’Europa, non lo sta facendo, ma
è anche vero che in questo Occidente dobbiamo anche includere l’America del Nord e
parte dell’America latina; questi paesi, legati a noi dalla cultura soprattutto, oltre che da
interessi economici, sembrano garantire all’Occidente l’autosufficienza alimentare,
almeno finché l’Europa grazie ai trattati commerciali, alla sue tecnologia ed industria,
potrà pagarsela. Ma non è del tutto chiaro quanto tutto questo possa continuare. La nostra
razionalità, che è in concreto la nostra tecnologia e l’industria ad essa strettamente legata,
ci concede ancora un margine di superiorità sul resto del mondo, ma cominciano già ad
avvertirsi i primi segnali che l’Oriente possa strapparci questa superiorità, perlomeno per
quanto riguarda lo sviluppo industriale. E poiché il progresso tecnologico è strettamente
legato al primato della produzione industriale, in senso qualitativo e qualitativo, se
perdiamo la sfida della solidarietà, abbiamo perso anche la sfida della pianificazione
razionale e pacifica del nostro futuro.
Qui possiamo richiamarci ad un altro dei valori fondamentali della nostra tradizione
occidentale: v’è una condizione basilare perché questa pianificazione razionale
all’insegna della solidarietà possa essere perseguita e sviluppata, e questa è la
democrazia, che fondamentalmente significa potere del popolo, un potere che deve però
essere garantito dal ‘dialogo’ tra perone libere, ma che può anche essere inteso come il
dialogo tra i vari segmenti produttivi della società. E in ultimo al dialogo tra stati; senza
democrazia al livello internazionale e senza dialogo, che è il momento portante della
solidarietà, è difficile che la razionalizzazione della produzione e delle risorse al livello
mondiale possa funzionare.
Ma v’è ancora un’ ultima sfida, quella del dialogo tra le diverse religioni e le diverse
civiltà, e questa è forse la sfida più difficile: infatti le società e civiltà non occidentali
sembrano non tenere in alcun conto la democrazia. E vi sono religioni che sono alla base
di queste società perché ne determinano gli scopi e di conseguenza lo stile di vita, che
sono insensibili se non contrarie alla democrazia e al dialogo, sia per ragioni di semplice
potere a cui non si vuole rinunciare, sia perché democrazia e dialogo pretendono come
condizione di base l’ ammettere che l’altro (in questo caso le altre religioni) possano
essere nel vero, mentre esse stesse credono di essere detentrici dell’unica verità.
4
Questa negazione delle democrazie, che si traduce poi nella negazione dei diritti della
persona e nella negazione della libera critica e del dialogo, è lo spettacolo a cui
quotidianamente assistiamo e che non ci fa ben sperare per il nostro prossimo futuro.
Bisogna anche dire che questo è un problema posto già da chi è stato il primo e più
ardente propugnatore del dialogo, Platone. All’inizio del grande dialogo sullo stato, la
Repubblica, Socrate pretende di poter dialogare con coloro che lo vogliono distogliere dal
suo programma quotidiano per invitarlo ad un banchetto, e minacciano di portarlo via
con la forza se non accetta. Socrate oppone la possibilità che egli dialogando possa
persuaderli a lasciarlo andare; ma i suoi interlocutori obiettano semplicemente: puoi tu
dialogare con chi non ascolta? La risposta è molto chiara: No in nessun modo.1
Questo è il problema, e questa è anche la sfida fondamentale per l’Occidente prossimo
venturo: trovare un modo per rendere possibile ed accettabile il dialogo tra le diverse
religioni. Forse l’unico modo è quello che è stato proposto da Papa Woityla: qualsiasi
cosa possiamo pensare di Dio e quindi qualsiasi cosa possa dividerci su questo, vale
comunque il fatto che se crediamo in un Dio, questo è lo stesso per i cristiani ed ebrei,
musulmani e induisti, confuciani e taoisti; quindi: preghiamolo insieme. Tutto questo si
trova già nella tradizione occidentale anticipato da un dramma di J. E. Lessing, Nathan il
saggio, scritto nella seconda metà del Settecento, allorché uscì l’Editto per la Tolleranza
dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria. Il protagonista di questo dramma, l’ebreo
Nathan da tutti detto il saggio, incontra il Saladino, in cui si può vedere la figura del
despota illuminato, che gli chiede di rispondere alla domanda che lo assilla: quale delle
tre fedi monoteistiche sia la vera fede
Nathan il saggio, che non vuole né deludere, né urtare il Saladino con cui vuole fare
affari racconta allora la novella, di cui si trovava già traccia in Maimonide, di un padre
che possedeva un preziosissimo anello che aveva la virtù di rendere grati a Dio e agli
uomini chiunque lo portava, e che veniva tramandato di generazione in generazione al
figlio che il padre riteneva più degno, e che diveniva con questo il capo e il signore del
casato. Questo padre aveva tre figli e siccome li amava tutti in egual modo, non sapeva a
chi di essi doveva lasciare in eredità l’anello; allora fece fare a un gioielliere due altri due
anelli identici al primo e ne donò uno a ciascuno dei propri figli; sorse allora la questione
tra di essi di quale fosse il vero anello posseduta dal padre: uno solo sarà il vero anello,
gli altri due saranno imitazioni. Queste tre fedi nuziali simbolizzano evidentemente le tre
fedi monoteistiche. E la risposta che Nathan il saggio dà al Saladino, che pone il
problema, quale è il vero anello, è anzitutto: “Impossibile provare quale sia l’anello vero
– (…) quasi come per noi è impossibile provare - quale sia la vera fede.”2 Ma il giudice,
al quale i figli si rivolgono per dirimere la questione, non può emettere nessuna sentenza,
ma dare solo un consiglio: “Ognuno ebbe l’anello da suo padre, ognuno sia sicuro che
esso è autentico”3 La risposta della questione del Saladino è dunque questa: tutte e tre le
fedi sono vere, quando sono una vera fede. La verità di questa fede si dimostra però non
con il conoscere, ma con il consiglio che dà alla fine il giudice: “Vostro padre non era più
disposto a tollerare in casa sua la tirannia di un solo anello. E certo vi amò ugualmente
tutti e tre. Non volle infatti umiliare due di voi per favorirne uno. Orsù, sforzatevi di
imitare il suo amore incorruttibile e senza pregiudizi. Ognuno faccia a gara per dimostrare
alla luce del giorno la virtù della pietra e del suo anello.”4 Il che vuol dire che la verità
dell’anello non riguarda il sapere teoretico, ma il sapere pratico: la verità, o la bontà, della
1
Cfr. Platone, Repubblica, I, 327 a-c.
Cfr. G. E. LESSING, Nathan der Weise, tr. it. a cura di A. Casalegno, Garzanti editore, Milano,
1992, p. 157.
3
Cfr. Ivi, p. 161
4
Cfr. Ibidem, p. 163
2
5
fede si dimostra in base agli effetti che essa produce nei secoli, e solo tra mille e mille
anni verrà il giudice che potrà giudicare quale sia stato il vero anello, la vera fede. Il Bene
è l’idea che va oltre l’idea dell’essere e l’idea del vero.
Ma vediamo che proprio su questo non c’é accordo. Possiamo certo dire che i motivi non
sono veri motivi religiosi, ma piuttosto motivi politici ed economici. E che l’Oriente
mussulmano rimprovera all’occidente di volerlo colonizzare materialmente e
spiritualmente, e perciò di volerlo assoggettare dopo averlo colonizzato, o per averlo
colonizzato. Su questo ci deve essere dialogo, anche se sembra che sia, come dice il
vecchio proverbio, un dialogo tra sordi. E allora dobbiamo rispondere al proverbio
dicendo che è dunque necessario un nuovo linguaggio, e precisamente il linguaggio dei
sordi, e cioè il linguaggio per gesti; se uno dei tre valori fondamentale dell’Occidente,
dopo la razionalità e la democrazia, è la solidarietà, il che vuol dire la carità, dobbiamo
fare questi gesti, cioè questi segni concreti che portano alla mutua comprensione e alla
conseguente mutua accettazione. Il gesto in tal senso dice molto di più della parola,
perché impegna il dialogante in un’azione. Non basta infatti parlare della volontà di
dialogo o delle possibilità del dialogo, o dei modi possibili di instaurare un dialogo, o
anche dei limiti del dialogo; soltanto quando ci si impegna effettivamente nel dialogo, nel
riconoscimento dell’altro, senza che sappiamo nulla di lui, in quel primo gesto di saluto,
di cortesia non falsa, prima che cominci la lotta per il riconoscimento dei diritti reciproci,
solo allora il dialogo inizia veramente prima che si proferisca ancora parola. Una volta ci
si toglieva il cappello in segno di riconoscimento e di saluto; si può poi porgere la mano
per offrire amicizia e rispetto, e si può porgere la mano per chiedere aiuto: che cosa l’altro
chiede lo si capisce dal suo gesto, e il nostro gesto, a meno che non sia semplice
simulazione, dovrà essere la risposta più eloquente per dimostrare la vera volontà di
dialogo, la solidarietà di mettere la mano in tasca per offrire una moneta, prima di pensare
che questo sia inutile, che questo non è il modo per risolvere i problemi dell’altro, che
sono magari la disoccupazione, la fuga dal proprio paese per sottrarsi alla schiavitù, alla
fame, alla morte; prima che inizi la lotta per il riconoscimento reciproco dei propri diritti
e il discorso su come affrontare e risolvere i problemi della possibilità e dei limiti del
nostro aiuto. Tutto il resto sarà poi possibile sulla base di questo primo gesto
fondamentale di risposta.
Anche se sappiamo, infatti, che non potremmo risolvere il problema di tutte le
popolazioni che sono afflitte da povertà, da sottosviluppo, da guerre sanguinose per il
potere, e che vi sono limiti innegabili alla solidarietà, della cui soluzione si può parlare
solo a livello politico internazionale, è tuttavia questo gesto la base fondamentale per
iniziare a pensare alla soluzione di questi problemi, e la soluzione non arriverà certamente
domani, ma forse tra un secolo, o sarà lunga quanto la storia dell’integrazione tra le
culture.
Qui tocchiamo comunque un altro problema, che è un problema basilare
dell’ermeneutica, quello della comprensione tra le diverse culture, che Gadamer alla fine
della sua vita ha visto come il problema del dialogo tra le grandi religioni mondiali, che
sono collegate naturalmente alle loro culture.5 L’ermeneutica o l’arte dell’interpretazione,
è da sempre stata rivolta all’interpretazione di quei testi che formano il fondamento di una
cultura, dai testi biblici a quelli letterari, ovvero l’oggetto dell’ermeneutica è stato sempre
e anzitutto la traduzione culturale, com’essa ci parla attraverso il medio del linguaggio, e
cioè i testi che ci sono pervenuti. Diversamente però dall’ermeneutica tradizionale
Gadamer intende il rapporto con la tradizione che passa attraverso il linguaggio come un
rapporto con il Tu, e cioè come un dialogo; in questo dialogo con la tradizione colui che
5
Cfr. H.G. GADAMER, Die Lektion des Jahrhunderts. Ein philosophischer Dialog mit Riccardo
Dottori, Lit Verlag, Münster-Hamburg-London, 2001; tr. It. Lßultimo Dio, Meltemi, Roma, 2002.
6
dialoga con il testo, e con la tradizione, non si pone come un Io di fronte a un Tu che è la
tradizione come un soggetto al di fuori di essa che dialogherebbe con un Tu come se
questo fosse un oggetto, e cioè l’oggetto del proprio comprendere, così come secondo lui
è il caso di Dilthey e dello storicismo, perché piuttosto egli si trova all’interno della stessa
tradizione, ed è condizionato da questa.6 Il rapporto alla tradizione come ad un TU va
perciò inteso come il rapporto Io – Tu che ritroviamo nella tradizione ponendoci
all’interno della tradizione stessa, ovvero inserendoci in quel dialogo continuo tra Io e Tu
che pervade e sostiene la nostra tradizione culturale. In tal senso la tradizione non è un
oggetto alla quale ci rapportiamo, ma è l’elemento portante di questo dialogo in cui
siamo. Questo comporta che situandoci in questo rapporto alla tradizione come nel
dialogo vivente che è la tradizione stessa, il rapporto Io - Tu in cui in essa ci situiamo, ci
si rivela fondamentalmente come un rapporto di carattere morale. Questo è stato detto
esplicitamente da Gadamer già nella prima edizione di Verità e metodo che festeggiamo,
ed è stato poi ignorato.
Il carattere morale a cui Gadamer pensa, e che forma l’altro momento fondamentale della
filosofia ermeneutica oltre il comprendere e l’interpretare, è quello che gli è stato
suggerito dall’Etica Nicomachea di Aristotele.7 E’ stato il libro del compianto Franco
Volpi su Heidegger del 1984 a mettere in evidenza l’importanza dell’Etica nichomachea
per lo stesso Essere e tempo di Heidegger, che gli era stata segnalata dallo stesso
Gadamer, il quale gli aveva suggerito, come egli stesso raccontava in uno dei suoi primi
articoli, che il concetto heideggeriano del Gewissen, della coscienza morale, che troviamo
in Essere e tempo non rimandava né a Kant, né a Hegel, né a Schopenhauer, ma piuttosto
a concetto aristotelico di phronesis; questo ci è stato poi mostrato dalla edizione delle
Lezioni di Heidegger sul Teeteto e sul Sofista di Platone,8 in cui Heidegger sostiene
addirittura che per capire Platone dobbiamo prima capire Aristotele, che è colui che ce lo
ha spiegato nella maniera migliore, dato che era stato 20 anni alla scuola di Platone. E’
stato poi il V° volume dell’edizione delle opere di Gadamer a farci vedere come la stessa
cosa valga per lui, che in quegli anni era stato allievo di Heidegger a Marburgo. In questo
V° volume edito nel 1985, è apparso un suo lavoro, scritto nel 1930 e mai pubblicato, dal
titolo Praktisches Wissen, sapere pratico, titolo che è appunto la traduzione del termine
aristotelico phronesis.9
E’ in questo saggio che Gadamer sviluppa la sua interpretazione del concetto di phronesis
nell’accezione propriamente aristotelica, che lo distingue da quella platonica. Ora il
Socrate platonico aveva criticato la sofistica che faceva consistere la virtù nel sapere, che
per questo era insegnabile, in quanto verteva fondamentalmente sul concetto di utile, e
aveva dimostrato sia nel Protagora, che nel Carmide e nell’Eutidemo (noi
aggiungeremmo anche nel Teeteto), che il concetto di utile non può essere visto come la
misura di cui l’uomo dispone o può disporre nel proprio agire, perché l’utile è
semplicemente il concetto di misurabile, di ciò che può essere misurato sempre in vista di
6
H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, J.
Mohr (Paul Siebek), 1960, tr. it. a cura di Gianni Vattimo, Milano 1972, 2° ed. Con testo tedesco a
fronte e Intr. Di G.Reale, Bompiani, Milano, 2000. Cfr. In particolare Parte II, 2, Dilthey nelle
aporie dello storicismo, pp. 455-503.
7
Cfr. in proposito R. DOTTORI, La phronesis in Aristotele e l’inizio della filosofia ermeneutica, in
„Paradigmi“, Rivista di critica filosofica, XXVI, III Quadrimestre, 2009, pp. 53-66; tr. ampliata in
lingua ted. in: A. PRZYLEBSKY, Hrsg., Ethik im Lichte der Hermeneutik, pp. 35-53 F. VOLPI, La
rinascita della filosofia pratica in Germania, in: C. PACCHIANI, (a cura di), Filosofia pratica e
scienza politica, Abano Terme, Francisci, 1980.
8
Cfr. M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platos Hölengleichnis und Theätet, Gesamtausgabe
Bd. 34, Klostermann, Frankfurt a/M, 1988.
9
Cfr. H.G. Gadamer, Gesammelte Werke, Bd. 5 : Griechische Philosophie I, J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen 1985, pp. 230-48.
7
un certo scopo, che è sempre altro per colui che cerca il suo proprio utile. L’utile in
quanto tale invece è sempre qualcosa che resta al di fuori di lui, perciò di esso vi è Logos,
cioè è esprimibile e calcolabile; ma questo tipo di sapere è appunto la techne, che è
insegnabile, ma che non è una virtù etica, bensì dianoetica, in quanto non riguarda
l’esercizio del sapere che l’individuo porta avanti per se stesso ed in vista del fine suo
proprio, ovvero del suo proprio utile, bensì quel tipo di utile che dipende sempre da uno
scopo ad essa esterno. Perciò Platone può identificare l’utile in quanto l’utile dell’uomo
che ricerca il proprio fine, con il bene (Rep. I, 336 d), e questo basta a difendere Platone,
che qui si identifica con Socrate, dall’accusa di intellettualismo; anzi, obietta Gadamer,
Socrate poté addirittura essere accusato nel 19° Secolo di utilitarismo.
Il sapere o senso pratico che deve prendere la decisione riguardo alle varie possibilità del
proprio modo di comportarsi determina il suo modo di porsi rispetto alla norma
universale: quindi è esso, e non la norma, che determina l’azione. È sempre la propria
riflessione che determina la sua presa di pozione e la direzione del suo agire; questa
riflessione è la phronesis, il sapere pratico, da cui scaturisce la virtù della sophrosyne,
della saggezza. Il sapere pratico è questo fenomeno unitario di ragione e di
comportamento: la scelta dell’azione o la decisione seguono il proposito dello sguardo
rivolto al bene. Questo vuol dire, di nuovo, che per Gadamer l’ermeneutica è possibile
soltanto sulla base della phronesis, è la realtà della phronesis, ovvero che
l’interpretazione è un compito teoretico e pratico insieme; e cioè, il vero conoscere è
interpretare, e l’interpretare, poiché è rivolto alla realtà dell’altro ed ha come scopo il
rimuovere, per quanto è possibile questa alterità, e ricercare un terreno comune; ma
questo comprendere è allora un compito etico, ed in questo consiste il significato
dell’etica di Aristotele per l’ermeneutica.
Lo stesso principio che vale per il rapporto interpretativo vale infatti anche per il rapporto
sociale: vanno accettate anzitutto le regole basilari del rapporto etico perché ci possa
essere comprensione. Ma quali sono queste regole basilari? Semplicemente quelle del
dialogo, basate sul principio della società comunicativa, cioè del non assumere come
valida nessuna norma finché non sia passata attraverso la discussione delle ragioni altrui
da parte di ogni membro di questa società comunicativa, oppure nel cercare di
determinare dei criteri di condotta che potremmo cercare di applicare in un caso
concreto? Per quanto pensiamo che il primo principio sia valido, pensiamo però anche
che difficilmente arriveremmo ad agire seguendo questo principio assolutamente
universale, perché è puramente formale. Per questo per Aristotele la phronesis comporta
fondamentalmente la synesis, la comune comprensione, ed anche la syggnome, la
benevolenza e la non invidia, cioè il mettersi dal punto di vista dell’altro ed essere pronti
a scusare l’altro; questo è quel che chiamiamo la vera comprensione, che porta alla
eubolia, la buona decisione, che ha in vista il bene comune. 10
Solo nel passare continuamente in rassegna tutte le possibili opinioni ed alternative, nella
comune discussione tra uomini mossi dalla volontà di intendersi, come ci è già detto da
Platone nella VII Lettera, siamo d’improvviso illuminati da una verità, che riluce nel
luogo più bello della nostra anima, e dove va pertanto custodito. Non v’è pertanto un
possesso pubblico di questa verità in una dottrina, ad essa si perviene solo con il dialogo;
ovvero questa verità non può essere scritta, ogni scritto è infatti soggetto all’
Questa problematica del ruolo di Aristotele nella filosofia pratica e nell’ermeneutica
contemporanea è stata delucidata nel suo complesso dall’ottimo lavoro di GIOVANNI PELLEGRINI,
Il bene e l’apparenza. Aristotele e i limiti della morale, Roma 2008 (Tesi dottorale, XIII Ciclo
dell‘ Università di Roma Tor Vergata, 2001-2, poi pubblicata in volume); cfr. anche M. NOBILE,
La parola e l’enigma. Un’interpretazione dell’etica di Aristotele, Carocci, Roma, 2002, in
particolare 5.3 : Un esito ermeneutico, pp. 207-17.
10
8
interpretazione o, come ci viene detto nel Fedro, è simile a un figlio senza padre. Qui,
come ha visto Gadamer, sono gettate le basi per l’ermeneutica contemporanea.
Questo vale tanto più per la conoscenza del mondo storico, e per tutto ciò che proviene
dalla nostra tradizione culturale: è la coscienza stessa della nostra storicità che ci deve far
comprendere come ogni giudizio su ciò che è storico non può essere la pura e semplice
comprensione ‘oggettiva’ di ciò che è stato, poiché ciò che è stato ed è ancora presente
attraverso le opere della nostra tradizione culturale, che comprende la religione, la
legislazione, le opere dell’arte e della filosofia, hanno per una autentica coscienza storica
una insuperabile alterità. E non esiste d’altronde un mondo ‘oggettivo’ che non sia un
mondo storico. Questo vuol dire che la conoscenza del mondo storico si dà in questa
forma di partecipazione che è al tempo stesso tanto identità, o meglio comunanza, quanto
ineliminabile diversità; l’autentica coscienza storica è la coscienza di questo dover
ricercare una possibile comunanza o compartecipazione nella diversità.
Questo vuol dire che ogni conoscenza è fondamentalmente interpretazione: interpretare è
tradurre da un lingua ad un’altra, dalla lingua dell’altro alla lingua propria. Ciò comporta
però che non vi sia una pura identità con l’altro, e quindi una teoresi pura: questo è il
prezzo che dobbiamo pagare per continuare a credere nella possibilità della conoscenza, e
quindi della verità; il conoscere è comprendere l’altro, ed il comprendere è interpretare.
Questo vuol dire, di nuovo, che per Gadamer l’ermeneutica è possibile soltanto sulla base
della phronesis, è la realtà della phronesis, ovvero che l’ interpretazione è un compito
teoretico e pratico insieme; e cioè, il vero conoscere è interpretare, e l’interpretare, poiché
è rivolto alla realtà dell’altro, ha come scopo il rimuovere, per quanto è possibile questa
alterità, e ricercare un terreno comune; ma questo comprendere è allora un compito etico,
ed in questo consiste il significato dell’etica di Aristotele per l’ermeneutica.
Questo rapporto alla nostra tradizione culturale come inserimento in un dialogo con
l’alterità dell’altro che è un compito teoretico e pratico, cioè etico e necessariamente
anche politico insieme, vale naturalmente quale modello o paradigma del rapporto di chi
partendo dalla base della nostra tradizione culturale nella quale si trova inserito, vuole
mettersi in rapporto alle altre tradizioni culturali. Questo è tanto più serio e difficile
quando questo rapporto diventa il rapporto pratico con comunità o individui che oggi si
trovano essi stessi ad essere inseriti nella nostra società, determinata dalla nostra
tradizione culturale, e ancora più problematica quando si presenta come problema non
semplicemente interpretativo al livello individuale, ma quando diviene il problema della
integrazione di gruppi, di origine culturale diversa, nella nostra società e tradizione
culturale, perché l’atteggiamento ermeneutico, e cioè interpretativo e pratico dettato dalla
ragionevolezza, dalla phronesis, che deve essere proprio anzitutto dell’ individuo, deve
informare di se da un lato l’intera società e dall’altro gli stessi gruppi sociali che
all’interno di essa sono accolti. E questo presenta la difficoltà che tutti conosciamo: non
tutti, né dal punto di vista individuale, né del gruppo sono disposti a questa comprensione
e accettazione reciproca. Questo sembra valere oggi per il rapporto tra le religioni. Qui è
chiara l’importanza della comprensione e della interpretazione, perché all’intolleranza
segua il dialogo; ma è anche chiara l’importanza del momento ermeneutico della
ragionevolezza, della phronesis, e della corrispondente virtù etica della sophrosyne.
Possiamo qui ritornare a ciò che chiamavamo il linguaggio del gesto: non tutti sono
disposti a ricambiare il gesto di saluto, che vuol dire accettazione, e non tutti sono
disposti ad accettare il modo di presentarsi dell’altro, il suo modo di vestire, la
determinata cura del suo corpo, se così la si può chiamare, e infine la sua fede religiosa e
i condizionamenti comportamentali che essa comporta. Al gesto di saluto può
corrispondere l’indifferenza o il gesto di ostilità, se non di violenza; se a questo gesto di
ostilità si risponde con altrettanta ostilità, invece che con il gesto del tendere la mano non
per chiedere, ma per porgere aiuto e accettazione, allora l’epilogo non può essere che
9
violenza generalizzata e la fine della pace sociale. Solo una società di individui pronti alla
accettazione dell’altro può con i propri gesti di accettazione e di pace impedire tutto
questo. La nostra civiltà occidentale ha scoperto essa stessa molto tardi il principio della
tolleranza, ma si è ormai incamminata verso la via dell’accettazione dell’alterità
dell’altro, e della integrazione, tanto che nonostante casi singoli più o meno numerosi,
vediamo che non c’è più alcuna possibilità del ritorno indietro. Senza questa accettazione
non è possibile alcuna democrazia,e la democrazia sarà compiuta solo quando i diversi
gruppi sociali all’interno della stessa società si accetteranno sulla base del riconoscimento
del principio comune della reciproca accettazione.
Ma la tolleranza e l’accettazione non sono ancora la solidarietà, che rappresenta il
passaggio della carità dal livello individuale a un principio non più etico, ma politico.
Come la solidarietà possa essere realizzata è un problema la cui soluzione impiegherà,
come dicevamo, per l’Occidente tutto quanto il nostro prossimo futuro; se nell’Ottocento
Hegel poneva il fine della storia futura nella realizzazione del concetto della libertà, ora
vediamo che questa realizzazione per avere un senso possibile, deve essere intesa come il
compimento della comune accettazione e la fine delle lotte per la supremazia e per il
potere economico che serve, ma al tempo stesso asservisce. Questo fine è anche difficile
a essere determinato, perché partendo dal livello individuale e familiare, attraversa ogni
forma possibile di rapporto interpersonale, a tutti i livelli privati e pubblici, sociali e
politici, fino al rapporto universale degli stati. Senza solidarietà, la forma ultima della
accettazione reciproca, non è garantita né pace, né libertà, né società, associazione statale
o associazione degli stati.
Così vediamo che proprio sulla base di questi valori fondamentali dell’ Occidente, e cioè
la razionalità dal punto di vista teoretico, la ragionevolezza dal punto di vista pratico, la
democrazia, che esige libero dialogo, o dialogo tra uomini liberi, e da ultimo la carità,
cioè la vera accettazione dell’altro prima del dialogo, nel senso che è alla base del
dialogo, è possibile affrontare le sfide che il nostro futuro ci pone; questo non vuol dire
che l’Occidente possa rinchiudersi in se stesso, perché proprio dalle altre culture e civiltà
l’Occidente può imparare quel rispetto per altri valori che l’Occidente stesso sta perdendo
nella sua chiara deriva nihilistica alla quale assistiamo: la perdita del senso della famiglia,
che vuol dire perdita del primo dei legami sociali; la perdita della fiducia nella vita, che è
fiducia in se stessi, e che vuol dire perdita della volontà di affrontare con gioia il proprio
futuro, di plasmarlo e modellarlo non solo al livello individuale, ma sociale; la perdita del
senso della salute, che i giovani calpestano con sdegno, così come sempre più spesso
calpestiamo la natura; la perdita infine del senso della carità, al livello individuale, che è
essa stessa la base del senso sociale della solidarietà.
L’Occidente potrà continuare a credere in se stesso se non perderà i suoi valori
fondamentali, e se saprà insegnarli senza guerre e senza volontà di imporre la propria
supremazia, che è già sufficientemente messa a rischio dall’Oriente emergente. Che anche
l’altro capisca e accetti tutto questo, è ancora una nuova e forse ultima sfida per la pace e
la sussistenza dell’umanità nei limiti del nostro pianeta. Ma perché l’altro capisca sono
necessari due presupposti: anzitutto che si impari ad avere torto; l’Occidente parla sempre
di ragioni, o di aver ragione, ma molto di meno di avere torto; in secondo luogo, perché
gli altri capiscano e accettino i nostri valori o le nostre ragioni, è assolutamente necessario
che noi siamo disposti a capire a ad accettare i loro valori, che sono forse anche i nostri,
quelli che abbiamo dimenticato.