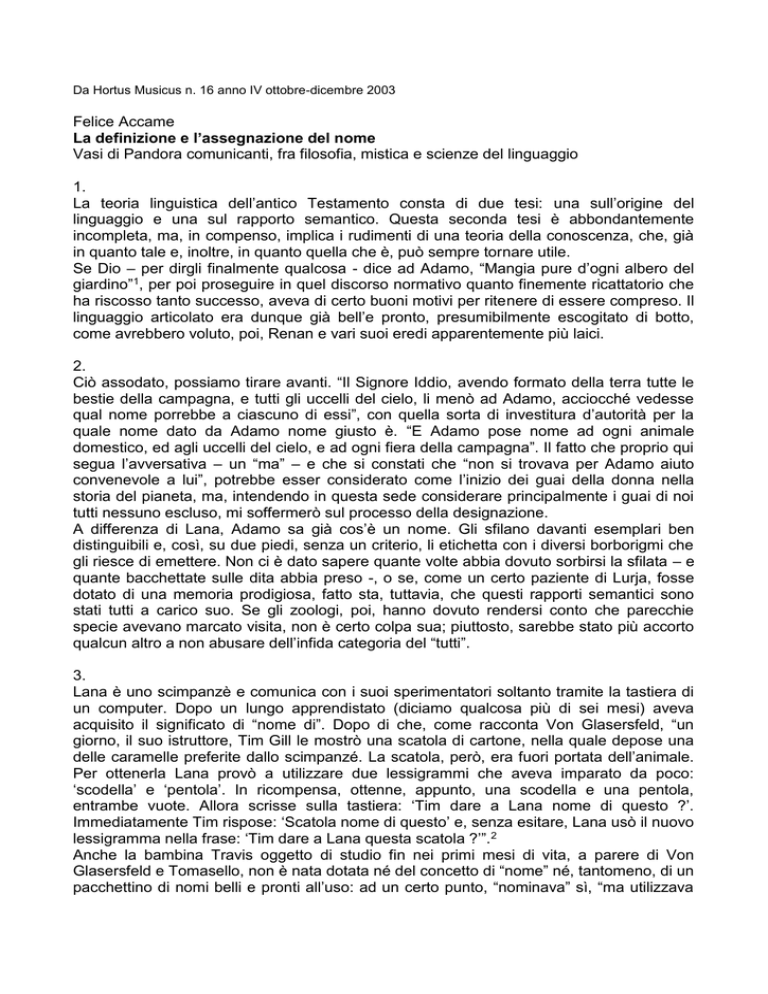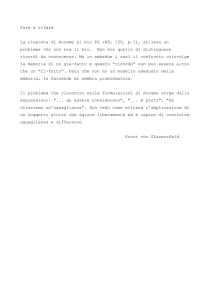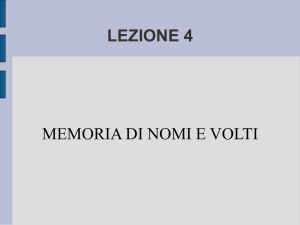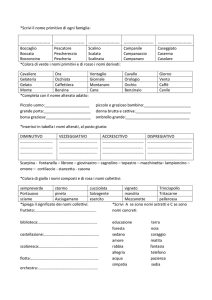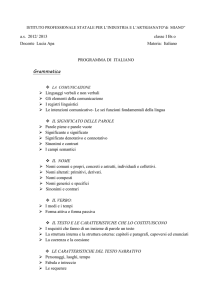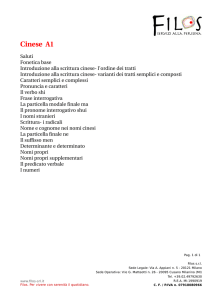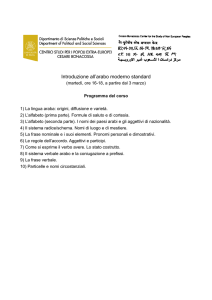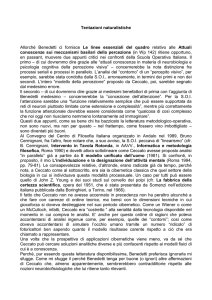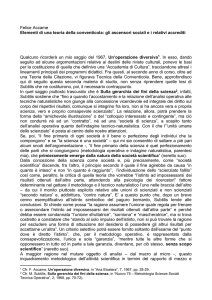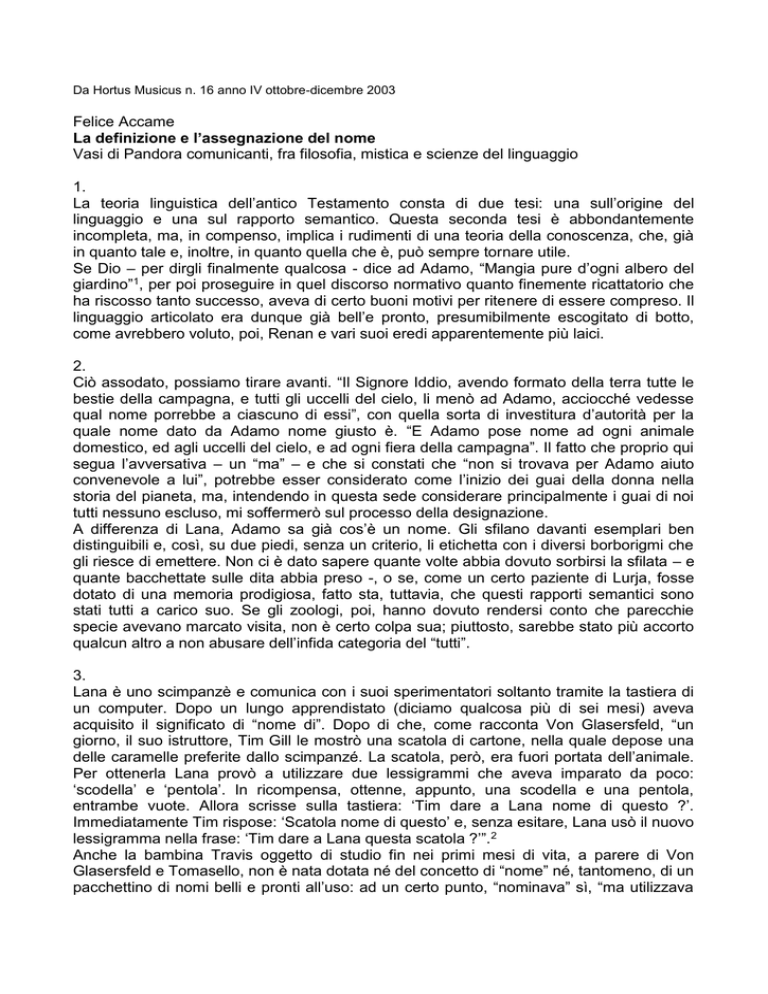
Da Hortus Musicus n. 16 anno IV ottobre-dicembre 2003
Felice Accame
La definizione e l’assegnazione del nome
Vasi di Pandora comunicanti, fra filosofia, mistica e scienze del linguaggio
1.
La teoria linguistica dell’antico Testamento consta di due tesi: una sull’origine del
linguaggio e una sul rapporto semantico. Questa seconda tesi è abbondantemente
incompleta, ma, in compenso, implica i rudimenti di una teoria della conoscenza, che, già
in quanto tale e, inoltre, in quanto quella che è, può sempre tornare utile.
Se Dio – per dirgli finalmente qualcosa - dice ad Adamo, “Mangia pure d’ogni albero del
giardino”1, per poi proseguire in quel discorso normativo quanto finemente ricattatorio che
ha riscosso tanto successo, aveva di certo buoni motivi per ritenere di essere compreso. Il
linguaggio articolato era dunque già bell’e pronto, presumibilmente escogitato di botto,
come avrebbero voluto, poi, Renan e vari suoi eredi apparentemente più laici.
2.
Ciò assodato, possiamo tirare avanti. “Il Signore Iddio, avendo formato della terra tutte le
bestie della campagna, e tutti gli uccelli del cielo, li menò ad Adamo, acciocché vedesse
qual nome porrebbe a ciascuno di essi”, con quella sorta di investitura d’autorità per la
quale nome dato da Adamo nome giusto è. “E Adamo pose nome ad ogni animale
domestico, ed agli uccelli del cielo, e ad ogni fiera della campagna”. Il fatto che proprio qui
segua l’avversativa – un “ma” – e che si constati che “non si trovava per Adamo aiuto
convenevole a lui”, potrebbe esser considerato come l’inizio dei guai della donna nella
storia del pianeta, ma, intendendo in questa sede considerare principalmente i guai di noi
tutti nessuno escluso, mi soffermerò sul processo della designazione.
A differenza di Lana, Adamo sa già cos’è un nome. Gli sfilano davanti esemplari ben
distinguibili e, così, su due piedi, senza un criterio, li etichetta con i diversi borborigmi che
gli riesce di emettere. Non ci è dato sapere quante volte abbia dovuto sorbirsi la sfilata – e
quante bacchettate sulle dita abbia preso -, o se, come un certo paziente di Lurja, fosse
dotato di una memoria prodigiosa, fatto sta, tuttavia, che questi rapporti semantici sono
stati tutti a carico suo. Se gli zoologi, poi, hanno dovuto rendersi conto che parecchie
specie avevano marcato visita, non è certo colpa sua; piuttosto, sarebbe stato più accorto
qualcun altro a non abusare dell’infida categoria del “tutti”.
3.
Lana è uno scimpanzè e comunica con i suoi sperimentatori soltanto tramite la tastiera di
un computer. Dopo un lungo apprendistato (diciamo qualcosa più di sei mesi) aveva
acquisito il significato di “nome di”. Dopo di che, come racconta Von Glasersfeld, “un
giorno, il suo istruttore, Tim Gill le mostrò una scatola di cartone, nella quale depose una
delle caramelle preferite dallo scimpanzé. La scatola, però, era fuori portata dell’animale.
Per ottenerla Lana provò a utilizzare due lessigrammi che aveva imparato da poco:
‘scodella’ e ‘pentola’. In ricompensa, ottenne, appunto, una scodella e una pentola,
entrambe vuote. Allora scrisse sulla tastiera: ‘Tim dare a Lana nome di questo ?’.
Immediatamente Tim rispose: ‘Scatola nome di questo’ e, senza esitare, Lana usò il nuovo
lessigramma nella frase: ‘Tim dare a Lana questa scatola ?’”.2
Anche la bambina Travis oggetto di studio fin nei primi mesi di vita, a parere di Von
Glasersfeld e Tomasello, non è nata dotata né del concetto di “nome” né, tantomeno, di un
pacchettino di nomi belli e pronti all’uso: ad un certo punto, “nominava” sì, “ma utilizzava
mezzi non verbali (piagnucolii, gesti, ecc.) per chiedere questi oggetti prima di accorgersi
che l’atto di nominare avrebbe ampliato i suoi tentativi comunicatorii”3.
4.
Nella teoria linguistica dell’Antico Testamento, allora, i nomi sono etichette per l’ordine di
un creato. Come tali, di riflesso, hic et nunc, sono articolabili in gerarchie. Ci sono nomi più
importanti di altri e ci sono nomi incommensurabilmente più importanti di altri. “Essendosi
fatto ubbidiente fino alla morte, e la morte della croce”, si dice in Filippesi (2, 8-9), “Iddio
lo ha sovranamente innalzato, e gli ha donato un nome, che è sopra ogni nome”. Il che
costituisce la logica premessa di quella drastica soluzione suggerita in Levitico (24, 1116) secondo la quale “chi avrà bestemmiato il Nome del Signore, del tutto sia fatto morire”.
5.
Una volta poste le premesse per la sua sussistenza, l’aura mistica del nome è destinata a
stagnare. Ancora nei primi mesi del 1913, per esempio, sul monte Athos – nei monasteri di
Sant’Andrea e di San Pantelemon – accadono fatti strani per gli illuministicamente
ottimisti, fatti strani ma non privi di una certa gravità. Dietro pressante invito del Santo
Sinodo della Chiesa russa, sbarcano i fucilieri della marina e, dopo averne vinta la
resistenza, arrestano e deportano – qualcuno in Siberia, la maggior parte nel Caucaso –
alcune centinaia di monaci eretici. Li guidava, questi monaci, un tal padre Antonio
Bulatovich che, quando ancora si chiamava Alessandro, era stato ufficiale negli ussari
dello zar, inviato per non meglio precisabili esplorazioni in Etiopia4 e, poi, in Manciuria, nel
1900, al comando di un distaccamento di cavalleria, per quell’occupazione che, quattro
anni dopo, porterà alla guerra russo-giapponese.
Fattosi monaco e ritiratosi al monte Athos, Bulatovich si imbatte nel libro di Ilarione, Le
montagne del Caucaso, uscito nel 1908, e nell’onomatodossia. Tale dottrina sosteneva
la tesi che Gesù Cristo, come il Padre peraltro, è presente nel suo stesso “Santo Nome” –
presente nel senso che, nel “Nome” dimorerebbe “immutabilmente con i suoi infiniti
attributi divini”. L’argomento, uno dei tanti derivabili dall’ontologia linguistica, non era
nuovissimo e già, nella storia della filosofia, aveva dato adito a discussioni (pur con le
varianti del caso, per esempio, allorquando Sant’Anselmo d’Aosta propose, ottocento anni
prima, la sua dimostrazione dell’esistenza di Dio5) e confutazioni, ma per padre Antonio
Bulatovich era proprio quel che ci voleva. Di retroterra culturale ce n’era a iosa. Volendo –
radicandosi nella tradizione dell’esicasmo (dal greco “hesychia”, inteso come “pace” e
“silenzio dell’unione con Dio”) - si poteva scendere fino a San Simeone il Nuovo Teologo e
a Sant’Atanasio, il fondatore della Grande Lavra, nel 963 – l’origine stessa della tradizione
del monte Athos -, a Gregorio Sinaita, l’autore de Il metodo della sacra preghiera e
dell’attenzione, a Gregorio Palamas o a Varlaam il calabrese. Le citazioni non sarebbero
mancate.
Il Bulatovich, tuttavia, non aveva fatto i conti con la critica e, allorquando, sulla rivista “Il
Monaco Russo” apparve una severa stroncatura dell’onomatodossia a firma
dell’arcivescovo Antonio di Volinsk, sulle prime, credette di cavarsela invitando
l’arcivescovo a non dir più fesserie, ma, sulle seconde – velocissime -, dovette anche
rendersi conto di aver suscitato un vespaio. Da lì in avanti la vicenda segue modelli
consolidati: assemblee interne, conquista della maggioranza, espulsione – non senza
spargimenti di sangue – dei “monaci che sbagliano”, convocazioni al Comitato Centrale,
dichiarazioni più e meno furbesche alla stampa da parte di entrambi i contendenti, offerta
di resa onorevole, rifiuti sdegnati, affamamento dei rivoltosi, repressione militare, soluzione
esicastica conclusiva di regime e, in quanto vittime, messe, più tardi, sul conto altrui
(c’erano giusto i bolscevichi).
6.
All’imeslavie (o glorificazione del nome) non sarebbe mancato neppure un futuro. Il
“Leonardo da Vinci” russo, Pavel Aleksandrovic Florenskij (1892-1943) e Sergej Nikolaevic
Bulgakov (1871-1944), filosofi, tentando di conferire lunga vita all’onomatodossia, non
hanno lesinato negli sforzi di teorizzarne i fondamenti. A entrambi sta bene la tesi secondo
la quale “il nome di Dio è Dio” e Bulgakov, nella sua Filosofia del nome - pubblicata a
Parigi nel 1953, ma redatta fra il 1920 e il 1921 -, riesce ad individuare una protolingua
universale prebabelica nonché un Logos anteriore a qualsiasi parola che fungerebbe da
perenne serbatoio di senso e di significato.
7.
Tutto ciò spiega in abbondanza – se non giustifica – le ambasce definitorie delle scienze
linguistiche. Le grammatiche sfuggono al compito utilizzando la tecnica dell’elenco aperto il nome designa “esseri animati”, “cose”, “concetti”, “qualità”, “azioni”, etc. – fino ad
ospitare checchessia. Qualcuno, più coraggioso e più sfrontato, l’ha definito come “quella
parola che designa una nozione dal punto di vista dell’’essere’” 6, virgolettando l’essere e
facendo finta di aver detto qualcosa, ma, perlopiù, si preferisce tacere. Negli scritti teorici
del primo Chomsky, d’altronde, come dice Zonta, “definizioni del nome o di altre parti del
discorso non figurano”. Si rinvia al problema delle “strutture profonde”, costringendo i tanti
chomskiani del pianeta ad appellarsi “ad una certa ‘naturalità’ dei raggruppamenti di
parole” o “all’’intuizione’ necessaria per scoprirli” 7. Il secondo Chomsky è quello che si è
accorto di aver trascurato la semantica a favore della sintassi, quello che rimpiange un
modello che sia uno dell’attività mentale e una teoria che sia una del significato, e,
dunque, quello che può imputare a sé e agli altri ciò che, per l’appunto, imputo io a lui e
agli altri8.
8.
Ben poca cosa, sarebbe accontentarsi di aver fatto emergere un rapporto fra grammatica
e filosofia nonché le disgrazie conseguenti. La mancata definizione del nome – la miseria
scientifica – lascia in vita o, addirittura, genera le speculazioni mistiche9. Detto questo,
arrabbiarsene, deprimersene, e lasciare le cose come stanno (magari dopo aver buttato
alle ortiche la grammatica nell’ovvia consapevolezza che, allorché ci si mette in mano, se
Dio vuole, parlare sappiamo già) non costituirebbe un gran contributo.
Chi si è preoccupato di garantire il mondo e l’ordine suo ha posto un rapporto fra i nomi e
le cose, magari dopo aver affidato a “concetti” ed “idee” inanalizzabili il compito di mediare
fra i due. Chi non aveva nulla da garantire – chi ha evitato la metafora filosofica della
“conoscenza” - ha potuto, invece, cercare un rapporto fra i nomi e le operazioni mentali
che designano, esentando il soggetto dalla passività cui pareva condannato. Fra questi
ricorderò Silvio Ceccato e la Scuola Operativa Italiana cui spesso amo riferirmi 10 – perché
pervengono ad una modellizzazione dell’attività mentale soltanto dopo essersi liberati del
peso costituito dalla tradizione filosofica.
In breve. Viene individuata l’attività mentale nella funzione dell’attenzione e questa viene
ricondotta al funzionamento di un organo a due stati – aperto/chiuso, 0-1, etc. Dalla
combinatoria degli stati e dall’applicazione dei risultati ottenuti al funzionamento degli
organi percettivi si otterrebbe, fra l’altro, il patrimonio dei designati linguistici. Questi, poi,
verrebbero inseriti in strutture temporali triadiche ampliabili in reti di complessità crescente.
“Cani e gatti”, per esempio, può espandersi in “corrono” e fermarsi lì, così come, invece, il
tutto può proseguire con “velocemente” e con “in cortile”. In tali strutture si distinguono due
funzioni: i correlati (“cani”, “gatti”) e i correlatori (“e”, oppure il correlatore che rimane
implicito e che correla “cani e gatti corrono”, un’associazione di soggetto e svolgimento).
Ogni lingua si differenzia sia per il patrimonio degli uni e degli altri, sia per il modo con cui
li designa (per esempio, con suffissi e prefissi). Ceccato nota che “a fungere da correlatore
vanno bene solo certi giochi dell’attenzione, e non mai per esempio il risultato di una
osservazione”, mentre, peraltro, è sempre possibile l’inverso, ovvero che quei “giochi
dell’attenzione figurino fra i correlati”. L’unica via che porterebbe all’individuazione del
nome, allora, sarebbe quella sintattica, perché “nome”, dal punto di vista operativo,
sarebbe solo un costituito usato come “correlato”11.
9.
La rete correlazionale così come è stata individuata dalla Scuola Operativa Italiana viene a
identificarsi con la nozione di “pensiero”. Più volte, Ceccato ha parlato della competenza
musicale, sia come modello che come propedeutica dell’analisi del mentale. In quanto
modello è valsa, soprattutto, per la concezione correlazionale del pensiero. Barosso, in
Corso di linguistica operativa, esplicita così l’analogia:
Disegno n. 1
E
Disegno n. 2
“Nella prima rappresentazione grafica, la linea continua indica il tempo di fattura
dell’elemento, e quella tratteggiata la sua presenza in seguito a mantenimento” – e qui si
tira in ballo una delle varie funzioni assegnate alla memoria. Dalla medesima
rappresentazione, poi, risulterebbero “anche le diverse funzioni svolte dai tre elementi nel
costituire la struttura, funzioni che si è convenuto di chiamare di correlato primo (a), di
correlatore (b), e di correlato secondo (c); per cui l’intera struttura viene chiamata
correlazione”12.
Zonta13, invece, fra le tante plausibili, propende per una notazione come questa
Disegno n. 3
ma, a mio avviso, in definitiva, nell’occasione conta soltanto l’evidenziare il rapporto fra
elaborazione in parallelo e polifonia14.
10.
Il fatto che tutto può fungere da correlato (Ceccato fa l’esempio di frasi come “e e o
designano rapporti” o “cantare rallegra”, dove la parte dei nomi è svolta da elementi
linguistici che di solito svolgono la parte di congiunzioni o di verbi) non deve indurre alla
disperazione. In fin dei conti, anche di una metafora si può dire davvero che è tale solo a
patto di averci un’idea delle operazioni mentali del parlante. E’ soltanto presumibile che se
qualcuno nomina “le gambe del tavolo” abbia utilizzato una metafora. Anzi, la gran
maggioranza di chi sta leggendo ciò che scrivo di certo, nel parlare di “gambe del tavolo”,
non “fa” una metafora: l’ha già fatta tempo fa, se l’è trovata bella e fatta e socialmente
condivisa, ha eseguito l’operazione di confronto da cui nasce ed ha proseguito ad usarla
come risultato ottenuto. L’operare mentale è privato. L’importanza dell’assunzione di un
punto di vista operativo sta nel liberare il nome dall’aura mistica che secoli di filosofia e di
religione gli hanno inflitto, nel riammetterlo fra i risultati dell’operare umano e nel poterlo
considerare all’interno di ipotesi relative ad un modello funzionale della mente.
11.
Sulla base dell’ipotesi attenzionale formulata da Ceccato, Vaccarino ha sviluppato un
sistema di analisi semantica che tende a render conto delle varie soluzioni linguistiche
note. Nella storia di questo sistema, possiamo isolare due fasi che, di fatto, riconducono il
nome ad una definizione pre-correlazionale. Nella prima – rappresentata da Analisi dei
significati -, Vaccarino, allorquando deve distinguere il nome “comune” dal “proprio”,
sembra dubitare che il secondo possa risolversi in un “denominare” riferito ad un
esemplare, mentre il primo in un “denominare” riferito ad una classe. Perché quando si
dice, ad esempio, “i cani abbaiano” possiamo rivolgerci potenzialmente sia alla “classe dei
cani” – e in almeno due sensi: sia che “ne stiamo sentendo abbaiare un certo numero”, sia
nel senso che “alludiamo ad un’accolta qualsiasi di esemplari” -, sia “all’affermazione che
quanto chiamiamo ‘cane’ ponendolo perciò come riferimento per i cani particolari, ha la
caratteristica generale di ‘abbaiare’”, sia, ancora, alla “legge” secondo la quale “i cani per
essere tali devono abbaiare”. Ne conseguirebbe, allora, che il “nome comune” deve
prescindere tanto dalla “classe” che dal “generale” e dalla “legge” – inducendo, dunque, a
definirlo come “pseudo-supino del diale in cui sono compresenti” i costituiti dell’ “aver
raggruppato” e del “denominare”15.
Affinando l’analisi – in Prolegomeni -, Vaccarino definisce il nome come risultato da
operazioni di confronto e, più precisamente, come il risultato di aver riferito un “segno” ad
una “cosa” paradigmata, ovvero considerata come termine di confronto. Il “denominare”,
allora, corrisponderebbe all’uso di un nome per isolare qualcosa da qualcos’altro
considerato come “resto”, il nome proprio corrisponderebbe al riferire l’”uno”, o il
“singolare”, al nome, e il nome comune, infine, corrisponderebbe al riferirvi il “plurale” 16.
Tutti componenti, si badi, di cui si sono analizzati gli stati attenzionali costitutivi.
12.
L’Adamo che capisce al volo ed esegue brillantemente il suo compito può anche risultare
compatibile, data la loro inequivocabile derivazione filosofica, con le teorie linguistiche più
in voga, ma non con una ricostruzione operativa delle categorie linguistiche. La genesi è
un’altra. Al nome in quanto tale ci si arriva dopo un bel po’.
Ma, nel passaggio dal nome in quanto tale ad un nome, dico un nome qualsiasi, le cose si
complicano ulteriormente. A maggior ragione se, per una volta, si abbandona il terreno
apparentemente solido dei nomi comuni per guardare a quello apparentemente
solidissimo dei nomi propri. Vige, infatti, l’opinione che se un nome comune può esser
ricco di “giochi dell’attenzione” o di quello che, per tradizionale omaggio al Kant mentalista,
chiamerei “contenuto categoriale” – nella morfemizzazione, per esempio -, un nome
proprio ne sarebbe integralmente scevro.
Visto che “i cani abbaiano”, invece, racconterò alcune vicende connesse al battesimo di un
cane, il nostro. Anna l’ha chiamato Papere.
La storia è questa: la fermano per la strada e le offrono un cucciolo di collie, cane demodé.
Anna è nata nel 1959, ma il Lassie che tornava a casa nel 1943 (e che mostrava ancora
tutto il suo coraggio nel 1946) era ancora ideologicamente attivo (tanto è vero che vivrà la
sua più bella avventura ancora nel 1978)17. Conclusione, lo prende al volo.
Tre anni prima, nel 1990, tuttavia, Francesca Archibugi aveva diretto Verso sera, un film
ambientato nel 1977, dove si narra di un professore comunista già avanti negli anni
(Marcello Mastroianni) e di una sua nipote “movimentista” (o “rivoluzionaria”, o
“movimentista rivoluzionaria”) (Sandrine Bonnaire) che ha una bambina – bambina che
ogni tanto gli affida. Lei e il suo compagno – che vive in una comune – l’hanno chiamata
Papere Mescalina. Inutile dire che per il professore sarà più facile chiamarla con il primo
che con il secondo nome. Il film si sviluppa non tanto e non solo sulla passione di costui
per sua nipote, ma, piuttosto, sul contrasto teorico fra modelli di comunismo
preconfezionati e pratica rivoluzionaria. Anna l’ha visto ed ha colto nel nome Papere sia
quanto rappresentava di rottura con la tradizione denominatoria 18 per la pluralizzazione di
un nome comune assegnato ad una bambina, che quanto rappresentava di critica politica
per la vicenda in cui la coppia di nome e bambina era incastonata.
Nel ringraziare il cielo di non avere un cane di nome Mescalina, dunque, mi corre l’obbligo
di segnalare la funzione di questo pur vago cenno di cronaca ideologica a sostegno di una
tesi: anche i nomi propri veicolano contenuti categoriali – processi di valorizzazione inclusi.
Non dico, beninteso, che ogni volta che Anna chiama Papere, nel solo nominarla,
ricostruisce la serie di operazioni mentali in grazia delle quali le ha assegnato quel nome –
perché è sempre possibile utilizzare qualcosa come già fatto e compiuto (il “pronome” ne è
una dimostrazione) -, ma dico che ogni nome, nell’essere costituito così e così e non cosà
e cosò, si inserisce in una mappa storicizzata di rapporti, una sorta di “enciclopedia
individuale”, dotata di una sua coerenza e, pertanto, in linea di principio indagabile 19.
13.
Alla storia della filosofia spetta di registrare più volte la controversia fra chi sosteneva, per
dirla con Max Muller, “se il linguaggio originasse per appellativi generali, o per nomi
propri”20. Per la seconda soluzione, ad esempio, era Adam Smith e per la prima Leibniz.
Da una parte, l’argomento (da buon Adamo secondo) cominciava con una titubante
asserzione secondo la quale “l’assegnazione di nomi particolari a denotare oggetti
particolari (…) probabilmente sarebbe uno dei primi passi verso la formulazione del
linguaggio” e proseguiva, più fiduciosamente, proponendo la tradizionale immagine dei
“due selvaggi” che, tramite la collaborativa istituzione di un linguaggio, “studierebbersi di
fare i loro mutui bisogni intelligibili l’uno all’altro”. Così la “particolare spelonca”, il
“particolare albero” e la “particolare fontana” saranno stati nominati, “per la prima volta”,
“spelonca”, “albero” e “fontana”, nomi che – al cospetto di nuove spelonche, nuovi alberi e
nuove fontane -, in grazia di somiglianze che saltano all’occhio, sono destinati alla
replicazione.
Dall’altra parte, l’argomento di Leibniz, dritto come un fuso, al posto dei “selvaggi”, tirava
subito in ballo l’altra categoria specializzata nella certificazione della scienza, quella dei
“bambini”. “I fanciulli”, dice più precisamente, “e quelli che non conoscono se non ben
poco della lingua che si attentano a parlare (…) fanno uso di termini generali, come cosa,
pianta, animali, in vece di usare i nomi propri, dei quali sono privi”. Dal che, per lui, si
doveva evincere che “tutti i nomi propri o individuali sono stati in origine nomi appellativi o
generali”. In principio stava dunque la generalità, “perocché debb’essere accaduto molto di
rado che l’uomo inventasse un nome, espressamente e senza ragione, a denotare questo
o quell’individuo”.
L’accorto Muller, tuttavia, racconta la vicenda con intenti bonarii e, spostando sull’asse del
tempo storico le due argomentazioni antitetiche, riesce a riverniciarle di affinità. Adam
Smith ha ragione: “la prima residenza imperiale sul Palatino, dava il nome a tutti gli altri
palazzi”. Ma non meno ragione avrebbe anche Leibniz, allorché “mirando al di là della
prima nascita di tali nomi (…) dimanda in qual guisa tali nomi potrebbero essere sorti”. Nel
“retrocedere”, insomma, si andrebbe ad incappare, prima o poi, in una “idea generale” –
secondo un modello operativo che prevederebbe di lasciare via via sul terreno l’empirico
per ritrovarsi fra l’indice e il polpastrello il residuo categoriale. Il Julian Jaynes de Il crollo
della mente bicamerale – quello che sosteneva esser stati “i primi elementi reali del
linguaggio verbale (…) i suoni finali delle grida intenzionali, differenziati sulla base della
loro intensità”, un allarme, per esempio, poi specificato in “vicino” e “lontano” – potrebbe
anche essere d’accordo21.
Avvalendosi dell’analisi di Vaccarino, però, credo si possa formulare una tesi più
comprensiva. Ci sono i nomi, propri e comuni, e c’è la categoria di nome, proprio e
comune: c’è una sorta di calco mentale in grazia del quale li si produce, e anche di questo
occorrerebbe render conto. Se l’analisi di Vaccarino risultasse convincente – dico la
riconduzione di nomi propri e comuni rispettivamente ad operazioni con il singolare e con il
plurale -, non si potrebbe parlare di una categoria geneticamente antecedente l’altra,
perché, come “destra/sinistra” o “parte/tutto” o “inizio/fine”, si tratterebbe di una coppia
correlativa o, detto diversamente, di costituiti complementari, dove l’uno significa in quanto
è connesso all’altro. A scorno dei filosofi, sarebbero nati assieme vivendo, poi, l’uno in
assenza dell’altro.
Note
1
Cfr. Genesi, 2, 17-20.
Cfr. E. Von Glasersfeld, Linguaggio e comunicazione nel costruttivismo radicale, Clup, Milano 1989,
pagg. 173-174.
3 Cfr. E. Von Glasersfeld, Linguaggio e comunicazione nel costruttivismo radicale, cit., pag. 151, in
nota.
4 Della missione etiope Bulatovich ha lasciato documentazione in Ethiopia Through Russian Eyes tradotto
in inglese dallo stesso Richard Seltzer che, nel 1981, gli dedica The Name of Hero (J. P. Tarcher, Los
Angeles).
5 Riassunto da Runes: “un’idea che esiste nella realtà (in re) è più grande di quella che esiste soltanto nella
mente (in intellectu); pertanto se la mia idea è la più grande, essa deve esistere anche nella realtà. Di
conseguenza Dio, l’Idea perfetta, l’Essere, esiste”. Cfr. D. D. Runes, Dizionario di filosofia, Martello,
Bologna 1963, pag. 37.
6 Cfr. A. Marchese e A. Sartori, Il Segno Il Senso, Principato, Milano 1970, citato da B. Zonta, Le parti del
discorso: il nome, in “Pensiero e Linguaggio in operazioni”, II, 6, 1971.
7 Cfr. B. Zonta, Le parti del discorso: il nome, cit.
8 Sulla questione delle carenze definitorie delle categorie grammaticali e della loro origine nella teoria della
conoscenza, cfr. F. Accame e M. M. Sigiani, Il diktat delle grammatiche, in “Il Confronto”, 14, 1967, F.
Accame, Un esempio di analisi della definizione: parola, vocale, consonante, in “Delta”, 8, 1969 e F.
Accame, Grammatica e filosofia, in “Nuovo 75 – Metodologia Scienze Sociali Tecnica Operativa”, 8, 1973.
Per constatare le virate chomskyane, cfr. N. Chomsky, Il linguaggio come organo, in “Kos”, 137, 1997, e il
mio commento in Sette tesi di Chomsky sul linguaggio, in “Working Papers della Società di Cultura
Metodologico-Operativa”, 84, 1997. In tema di chomskyerie d’epoca, cfr. inoltre F. Accame, Il linguaggio è
come un argano, in “Working Papers della Società di Cultura Metodologico-operativa”, 82, 1997. Per
un’analisi critica più ampia, cfr. S. Ceccato e C. Oliva, Il linguista inverosimile, Mursia, Milano 1988. Per un
confronto fra “grammatica generativa” (o trasformazionale) e “grammatica correlazionale” (o, detto più
sportivamente, fra Chomsky e Ceccato), cfr. M. V. Giuliani, Grammatica trasformazionale e grammatica
correlazionale, relazione presentata al Convegno Internazionale di Studi su La Sintassi, Roma, 17-18
maggio 1969 (e pubblicata in “Rassegna Italiana di Linguistica Applicata”, I, 2, 1969), dove il giudizio risulta
favorevole alla seconda, ma a Chomsky viene anche riconosciuto, già allora, la pur banale opinione che “per
dare ragione del linguaggio occorre tenere presente il suo aspetto mentale”.
9 Incluse quelle ascrivibili al “letterario” in genere. Non a caso, Pauwels e Bergier, in una loro famosa
“introduzione al realismo fantastico” intitolata Il mattino dei maghi (1960), utilizzano sia un racconto di
Clarke che uno di Borges per accreditare di senso la ricerca sui “veri nomi di Dio” nonché sul suo “nome
ineffabile”. Cfr. L. Pauwels e J. Bergier, Il mattino dei maghi, Mondadori, Milano 1997, pagg. 193-199 e
pag. 463.
2
Cfr. F. Accame, L’individuazione e la designazione dell’attività mentale, Espansione, Roma 1994 e F.
Accame, La funzione ideologica delle teorie della conoscenza, Spirali, Milano 2002.
11 Cfr. S. Ceccato, Cibernetica per tutti, vol. II, Feltrinelli, Milano 1970, pagg. 171-176.
12 Cfr. G. Barosso, Principi generali di linguistica operativa, in S. Ceccato (a cura di), Corso di
linguistica operativa, Longanesi, Milano 1969, pag. 66.
13 Cfr. B. Zonta, Le parti del discorso: il nome, cit.
14 Per un’analisi più approfondita, cfr. F. Accame, Sincronia e diacronia nell’analisi metodologicooperativa del linguaggio, in AAVV., Categorie, tempo e linguaggio, Società Stampa Sportiva, Roma
1998.
15 Cfr. G. Vaccarino, Analisi dei significati, Armando, Roma 1981, pag. 161, in nota.
16 Cfr. G. Vaccarino, Prolegomeni, vol. II, Società Stampa Sportiva, Roma 2000, pag. 165.
17 Infatti, Torna a casa Lassie, il prototipo – tratto da un romanzo di Eric Knight-, è del 1943, e i cloni Il
coraggio di Lassie e La più bella avventura di Lassie sono rispettivamente del 1946 e del 1978.
Televisione e telefilm, poi, ovviamente, hanno dato una mano cospicua.
18 Nel Dizionario per Nomi di Cani da me consultato in Rete, Papere – a differenza di Kant, Fichte e Marx –
non figura.
19 Alludo alla teoria dei rapporti logico-consecutivi così com’è formulata e messa in pratica da Vaccarino. Cfr.
G. Vaccarino, Scienza e semantica costruttivista, Clup, Milano 1988, pagg. 21-27 e G. Vaccarino,
Prolegomeni, vol. I, Società Stampa Sportiva, Roma 1997, pag. 49 e seguenti. Per una disamina della
questione nella letteratura della Scuola Operativa Italiana, cfr. F. Accame, Prolusione, Società di Cultura
Metodologico-operativa, Milano 1989.
20 Cfr. M. Muller, Letture sopra la scienza del linguaggio, Daelli e C. editori, Milano 1864, pagg. 379-384.
21 Cfr. J. Jaynes, Il crollo della mente bicamerale, Adelphi, Milano 1984, pagg. 166-167.
10