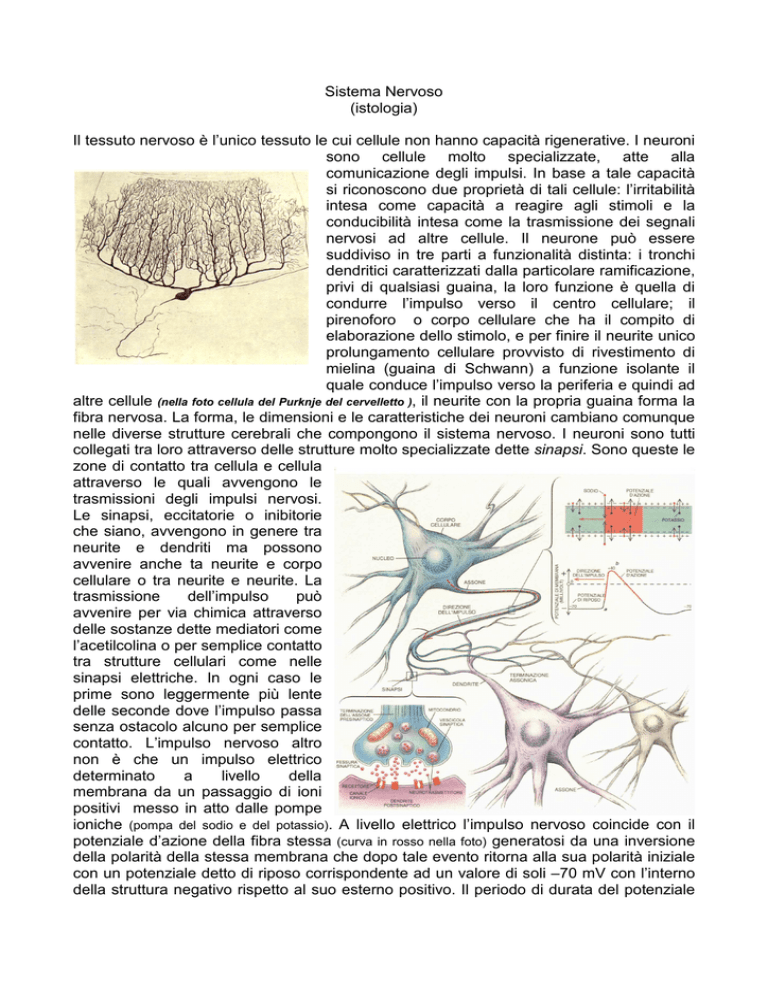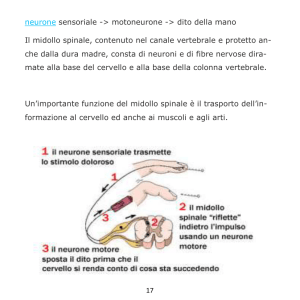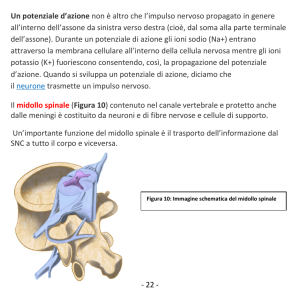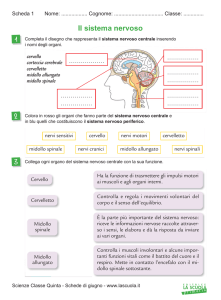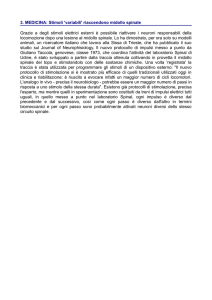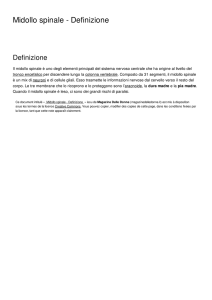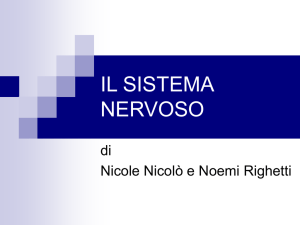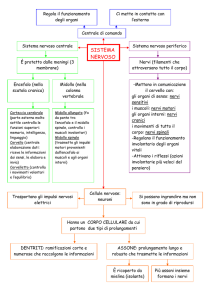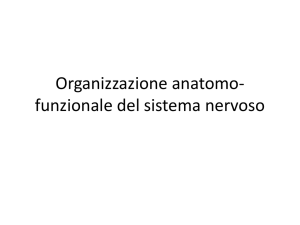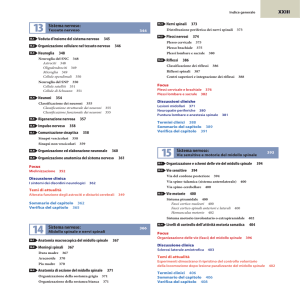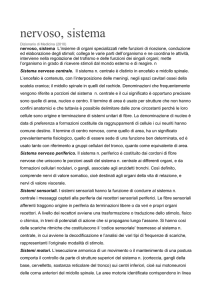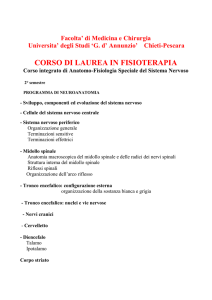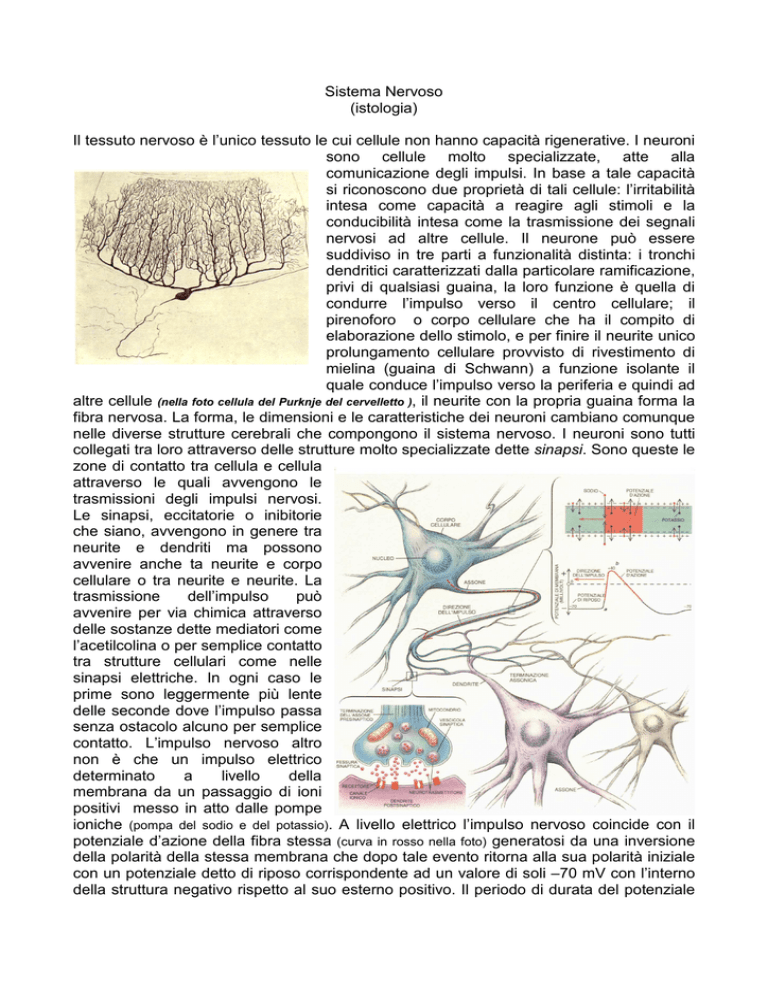
Sistema Nervoso
(istologia)
Il tessuto nervoso è l’unico tessuto le cui cellule non hanno capacità rigenerative. I neuroni
sono cellule molto specializzate, atte alla
comunicazione degli impulsi. In base a tale capacità
si riconoscono due proprietà di tali cellule: l’irritabilità
intesa come capacità a reagire agli stimoli e la
conducibilità intesa come la trasmissione dei segnali
nervosi ad altre cellule. Il neurone può essere
suddiviso in tre parti a funzionalità distinta: i tronchi
dendritici caratterizzati dalla particolare ramificazione,
privi di qualsiasi guaina, la loro funzione è quella di
condurre l’impulso verso il centro cellulare; il
pirenoforo o corpo cellulare che ha il compito di
elaborazione dello stimolo, e per finire il neurite unico
prolungamento cellulare provvisto di rivestimento di
mielina (guaina di Schwann) a funzione isolante il
quale conduce l’impulso verso la periferia e quindi ad
altre cellule (nella foto cellula del Purknje del cervelletto ), il neurite con la propria guaina forma la
fibra nervosa. La forma, le dimensioni e le caratteristiche dei neuroni cambiano comunque
nelle diverse strutture cerebrali che compongono il sistema nervoso. I neuroni sono tutti
collegati tra loro attraverso delle strutture molto specializzate dette sinapsi. Sono queste le
zone di contatto tra cellula e cellula
attraverso le quali avvengono le
trasmissioni degli impulsi nervosi.
Le sinapsi, eccitatorie o inibitorie
che siano, avvengono in genere tra
neurite e dendriti ma possono
avvenire anche ta neurite e corpo
cellulare o tra neurite e neurite. La
trasmissione
dell’impulso
può
avvenire per via chimica attraverso
delle sostanze dette mediatori come
l’acetilcolina o per semplice contatto
tra strutture cellulari come nelle
sinapsi elettriche. In ogni caso le
prime sono leggermente più lente
delle seconde dove l’impulso passa
senza ostacolo alcuno per semplice
contatto. L’impulso nervoso altro
non è che un impulso elettrico
determinato
a
livello
della
membrana da un passaggio di ioni
positivi messo in atto dalle pompe
ioniche (pompa del sodio e del potassio). A livello elettrico l’impulso nervoso coincide con il
potenziale d’azione della fibra stessa (curva in rosso nella foto) generatosi da una inversione
della polarità della stessa membrana che dopo tale evento ritorna alla sua polarità iniziale
con un potenziale detto di riposo corrispondente ad un valore di soli –70 mV con l’interno
della struttura negativo rispetto al suo esterno positivo. Il periodo di durata del potenziale
viene anche detto periodo di refrattarietà della fibra durante il quale la stessa non è
eccitabile da un altro stimolo.
Sistema Nervoso
(anatomia)
Il sitema nervoso viene convenzionalmente suddiviso in due sottosistemi: sistema nervoso
cerebro-spinale e sistema nervoso autonomo. Le strutture
centrali e periferiche come il cervello, il midollo e i nervi
spinali sono preposte alla vita di relazione e costituiscono di
conseguenza la parte volontaria di tutto il sistema; le strutture
autonome clessificate in simpatico e parasimpatico sono
invece preposte alla vita vegetativa ossia al funzionamento di
tutti quei sistemi il cui controllo non dipende dalla volontà.
Nella figura a fianco sono visibili i rapporti tra il cervello, il
midollo spinale e i nervi spinali che da esso si dipartono. Le
strutture autonome che fanno capo ai gangli, si trovano
spesso in prossimità degli organi che innervano regolandone
la funzione.
(Cervello)
Il cervello umano è sicuramente l’organo più complesso che
oggi si conosce. Con i suoi 1000 md.di cellule, di cui 100 md.
sono neuroni, e il suo peso di circa 1200-1800 gr.
rappresenta la struttura in cui risiedono le funzioni più elevate
dell’uomo come l’intelligenza, la creatività, l’emozione, la
consapevolezza e la memoria. Le grandi divisioni anatomiche del cervello danno una
mappa approssimativa delle sue capacità. Il cervello ha
simmetria bilaterale, con gli emisferi destro e sinistro collegati
dal corpo calloso e da altri ponti di sostanza bianca. La
corteccia cerebrale, ossia la superfice degli emisferi, si
presenta ricca di circonvoluzioni che portano la superfice
totale a 1,5 m. quadrati per 2 mm. circa di spessore. La
corteccia forma la cosidetta sostanza grigia perché priva di
fibre nervose mieliniche. La neocorteccia, più grande e più
recente è suddivisa in lobi: frontale, parietale, temporale e
occipitale. La parte della corteccia più antica sotto il profilo
evolutivo appartiene al lobo limbico in cui risiedono il
comportamento emotivo (istinto) e la memoria a lungo
termine. Altri nuclei di materia grigia si trovano poi all’interno
dell’organo a formare strutture quali il talamo ottico.
L’encefalo è percorso internamente da quattro cavità note
come ventricoli cerebrali. Le prime due di queste cavità
occupano longitudinalmente i due emisferi e vengono
detti ventricoli laterali. Hanno forma estremamente
irregolare e comunicano con il sottostante terzo
ventricolo con i fori di Monro. Il terzo ventricolo è
situato medialmente tra i due talami ottici e comunica
con il quarto ventricolo attraverso l’acquedotto di Silvio.
Il quarto ventricolo, sistemato dietro il cervelletto si continua con il canale centrale del
midollo spinale o canale ependimale. Nel sistema costituito dai ventricoli e dal canale
ependimale circola il liquido cefalo-rachidiano. Il sistema encefalico si continua alla base
con la prima parte del midollo spinale detta midollo allungato o bulbo rachidiano.
(midollo allungato)
Il bulbo o midollo allungato è una struttura centrale sistemata tra l’encefalo e il midollo spinale.
Lungo circa 3 cm. esso è limitato superiormente da una struttura posta trasversalmente e detta
ponte. L’interno rappresenta il pavimento del
lV° ventricolo, sulla faccia anteriore presenta
la continuazione della fessura mediana del
midollo spinale. La faccia posteriore presenta
due strutture parallele, i fasci delle vie
piramidali, mentre lateralmente sono visibili
altre due strutture, le olive bulbari. Il bulbo
oltre ad essere un “organo di transito” per le
vie motorie discendenti e sensitive ascendenti
che dall’encefalo vanno al midollo spinale e
viceversa ha una importantissima funzione nei
nelle attività riflesse. Da esso si originano i
nervi cranici da nuclei di sostanza grigia. Nel
bulbo risiedono inoltre particolari centri attivati
da opportuna stimolazione come il centro del vomito, quello della tosse,; altri sono in permanente
attività come i centri vasomotori e respiratori. I centri bulbari per il controllo autonomo della
circolazione, della meccanica cardiaca e polmonare sono chiamati centri vitali in quanto una loro
lesione provoca la morte.
Tosse: la tosse è dovuta ad una irritazione dell’epitelio delle vie respiratorie; a glottide chiusa
violente contrazioni dei muscoli respiratori (intercostali e diaframma) fanno salire la pressione
all’interno dei polmoni, dopo di ché la glottide improvvisamente si apre pr4ovovando una violenta
emissione d’aria.
Vomito: il vomito è spesso preceduto da intensa salivazione e da nausea. La glottide si chiude per
impedire il riflusso delle sostanze in trachea, e il respiro si arresta a metà inspirazione. I muscoli
della parete addominale si contraggono, l’esofago si rilascia e lo stomaco con movomenti
antiperistaltici si svuota riversando il contenuto verso il cavo orale. Tutta l’attività del bulbo è sotto
diretto controllo ipotalamico.
(Nervi cranici)
Dal midollo allungato si originano parte dei 12 paia di nervi cranici classificati in motori, sensitivi e
misti, così suddivisi: l° olfattivo (sens.), ll° ot tico (sens.), lll° oculomotore (mot.), lV° troclear e (mot.),
V° trigemino (sens.), Vl° abducente (sens.), Vll° f acciale (sens.), Vlll° acustico (sens.), lX°
glossofaringeo (sens.), X° vago (sens.), Xl° access orio (sens.), Xll° ipoglosso (sens.). I bervi
cranici presentano tre caratteristiche comuni: nascono per paia, sono simmetrici, hanno origine in
nuclei di sostanza grigia del nevrasse.
(Midollo spinale)
Racchiuso nel canale vertebrale, si estende dalla prima vertebra
cervicale (atlante) alla seconda vertebra lombare. In una
sezione trasversale si mette in evidenza la sostanza bianca
sistemata perifericamente e la sostanza grigia internamente
disposta con una caratteristica forma ad H al centro della quale
decorre il canale ependimale. La struttura centrale è costituita
fondamentalmente da neuroni motori e sensitivi distribuiti
rispettivamente in corna anteriori e posteriori, nonché da speciali neuroni preposti ai riflessi spinali.
La sostanza bianca del midollo spinale è formata esclusivamente da fasci di fibre nervose
ascendenti come quelli della sensibilità tattile, dolorifica e propriocettiva; e discendenti come quelli
dell’equilibrio, dei riflessi audiovisivi e della motilità muscolare.
(Nervi spinali)
Dal midollo spinale nascono 31 paia di nervi spinali che si originano attraverso due radici, una
dorsale sensitiva con intercalato un ganglio e una ventrale motoria. Le due radici , appena
emergenti si riuniscono poi in un’unica radice mista che va ad innervare l’organo effettore. I gangli
del Simpatico sono ad essi connessi attraverso il ramo
comunicante bianco e il ramo comunicante grigio. Nel midollo
spinale hanno sede un gran numero di riflessi che si mettono in
atto attraverso una serie di neuroni che nel loro insieme
formano gli archi riflessi. Un arco riflesso funzionalmente è
formato da un organo di senso, un neurone afferente, uno o più
neuroni in correlazione sinaptica a livello centrale per
l’elaborazione della risposta, un neurone efferente e un organo
effettore. L’arco riflesso più semplice è quello con una sola
sinapsi fra il neurone afferente e quello efferente (arco
monosinaptico) e i riflessi da esso mediati saranno i riflessi
monosinaptici. Un tipico riflesso monosinaptico è il riflesso da
stiramento a carico del muscolo in cui un muscolo in risposta ad
uno stiramento passivo si contrae. Il riflesso patellare è un
esempio di riflesso da stiramento del quadricipite femorale che appunto viene stirato dal colpo sul
relativo tendine. In questo caso la risposta motoria al muscolo proviene direttamente dai
motoneuroni spinali con esclusione dei centri encefalici. Molti dei riflessi si originano, come il caso
descritto, o si completano a livello spinale. In tutti i vertebrati un taglio trasverso del midollo a
livello cervicale produce uno shock spinale durante il quale tutte le risposte riflesse sono depresse,
a questo segue un periodo in cui le risposte ritornano e finiscono per diventare esagerate. I
muscoli sottoposti al controllo della parte di midollo sottostante il taglio possono paralizzare solo gli
arti inferiori (paraplegia) o tutti e quattro (tetraplegia). La durata dello shock spinale è maggiore
negli animali posti più in alto nella scala evolutiva. Dura infatti alcuni minuti nela gatto, qualche
giorno nella scimmia e circa tre settimane nell’uomo.
(ipotalamo)
E’ una struttura nervosa encefalica posta al di sotto del pavimento del lll ventricolo. Per la sua
importanza viene definito il “centro della visceralità” in quanto
regola e armonizza la funzionalità di numerose funzioni
viscerali. Vi sono diverse connessioni nervose tra ipotalamo e
ipofisi. Alla neuroipofisi giungono terminazioni nervose da
parte del nucleo sopraottico e paraventricolare (fascio
ipotalamo-ipofisario; con l’ipofisi anteriore (adenoipofisi) si
sviluppa un intenso sistema vasale portale che si origina da
capillari e termina in capillari senza passare per il cuore. Le
numerose ricerche condotte su animali da laboratorio hanno
individuato nell’ipotalamo numerosi centri nervosi come quello
della regolazione della temperatura corporea e del bilancio
idrico, il centro del sonno e della veglia, della fame e della sete
nonché la regolazione del comportamento istintivo ed
emozionale dell’individuo.
(controllo termico)
Nella regolazione della temperatura corporea l’ipotalamo funziona come un termostato.
Determinando la temperatura esterna tramite recettori cutanei o quella interna attraverso il sangue,
opera opportunamente la regolazione agendo sulla pressione sanguigna e allo stesso tempo
regolando la funzionalità della tiroide e del rene. La contrazione muscolare causata da brividi da
freddo produce calore anche se di breve durata. La tiroxina (ormone tiroideo) produce calore che si
sviluppa lentamente e in modo prolungato. La perdita di calore avviene per radiazione (nell’ambiente
esterno), per conduzione (contatto con altri corpi) e per convezione ( attraverso il movimento di
liquidi o gas). La sudorazione rimane comunque il modo più rapido per perdere calore;
l’evaporazione di 1 gr. di acqua rimuove 0,6 calorie . Una certa quantità di acqua evapora
continuamente (50 ml/ora) e rappresenta la perspiratio insensibilis.
(sonno e veglia)
La stimolazione dei nuclei talamici diffusi ad una frequenza di 8 stimoli al sec. Induce al sonno;
viceversa a frequenze maggiore si ha la veglia. L’ipotalamo non è comunque direttamente
responsabile del ritmo sonno-veglia, vi sono infatti alcune parti dell’encefalo che entrano in questa
regolazione.
( fame)
La regolazione ipotalamica dell’appetito dipende dall’interazione di due centri; uno posto
lateralmente, centro della fame, ed uno medialmente, centro della sazietà. Il centro della fame è
permanentemente attivo ma l’ingestione di cibo lentamente lo inattiva. L’attività del centro della
fame è probabilmente legata alla velocità con cui le cellule (glucostatiche) utilizzano il glucosio. La
distruzione di tale centro determina l’anoressia, mentre la distruzione del centro della sazietà
provoca l’obesità.
(sete)
Anche la sete è controllata dall’ipotalamo. L’area coinvolta nella sete sembrerebbe essere quella
laterale posteriormente al centro della fame. L’iniezione in tale zona di una soluzione salina
produce tale effetto nell’animale da laboratorio, segno della presenza di osmocettori sensibili ad un
aumento della pressione osmotica. Anche una diminuzione della massa liquida extracellulare
come una emorraggia stimolano la sete.
(Cervelletto)
E’ un organo impari presente in tutti i vertebrati ma con differenti gradi di sviluppo. Esso è formato
da due emisferi (cerebellari) separati da una struttura mediana detta verme. Strutturalmente
l’organo è formato da una corteccia e
internamente da sostanza bianca in cui
sono distribuiti 4 di sostanza grigia: nucleo
del tetto, globoso, emboliforme e dentato.
Il cervelletto è collegato con tre paia di
peduncoli al tronco cerebrale. Il compito
più rilevante del cervelletto è quello di
coordinare i movimenti e regolare la
postura (posizione del corpo nello spazio).
Esso infatti riceve fibre afferenti sia dalla
periferia (ne sono un esempio i nervi
vestibolari) che dall’encefalo. Negli
animali con evidenti lesioni cerebellari tutti
i movimenti sono caratterizzati da una
marcata atassia cioè da una scoordinazione dovuta ad errori di velocità d’ampiezza, di forza e di
direzione dei vari movimenti. L’atassia si manifesta non soltanto aumentando la base di sostegno
del corpo (allargamento delle gambe) e con l’andatura da ubriaco, ma anche con difetti di
precisione dei movimenti che producono la parola, cosicchè si ha la parola scandita. Un altro
caratteristico sintomo di lesione cerebellare è l’incapacità di frenare o di arrestare prontamente un
movimento in atto ne è un esempio il fenomeno del rimbalzo in cui il soggetto affetto da lesione del
cervelletto non riesce a frenare l’estensione dell’avanbraccio sul braccio quando cessa la
resistenza che l’ha tenuto fermo. Anche altri movimenti volontari sono anomali come nel tentativo
di toccare un oggetto con un dito in cui l’individuo lo porta troppo in avanti e nel tentativo di
correggersi lo riporta troppo indietro (dismetria). Queste continue oscillazioni in avanti e indietro
costituiscono il tremore intenzionale che manca nel riposo (a differenza del tremore parkinsoniano)
e si rende evidente ogni qualvolta si ha un movimento intenzionale. Come ultima curiosità va detto
che nel cervelletto, causa la ripetuta stimolazione labirintica, si genera quella sensazione nota
come mal di mare. Tale sensazione può essere abolita nell’animale sperimentale dall’ablazione
del lobo flocculonodulare, ma nell’uomo può essere attenuata da farmaci tranquillanti o antiemetici
come quelli comunemente in commercio.