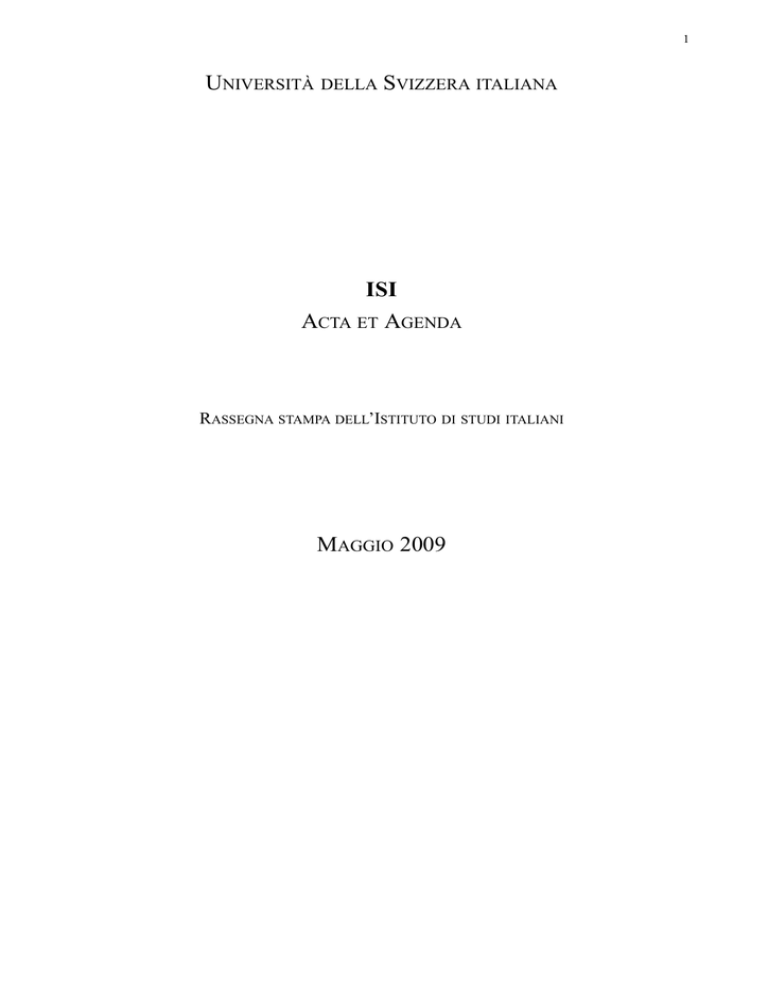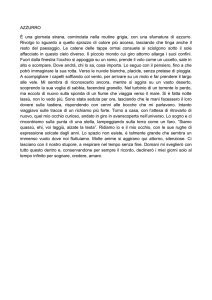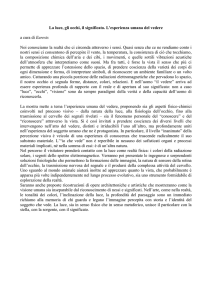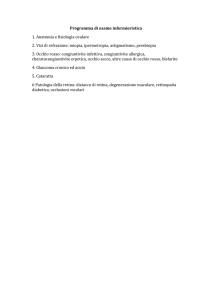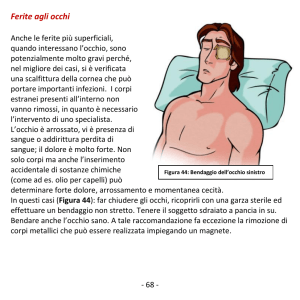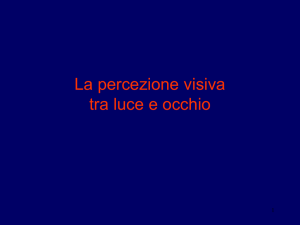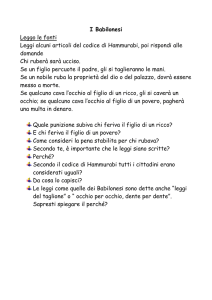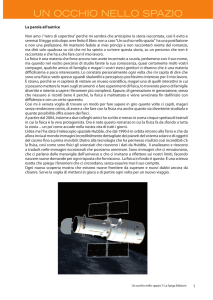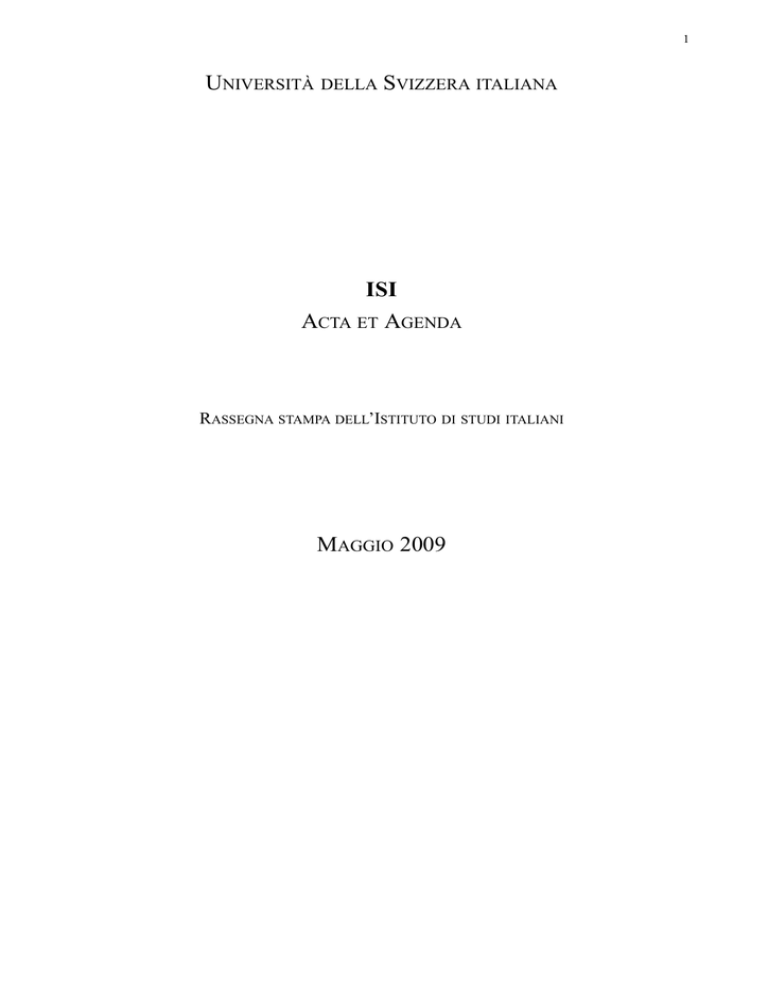
1
UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA
ISI
ACTA ET AGENDA
RASSEGNA STAMPA DELL’ISTITUTO DI STUDI ITALIANI
MAGGIO 2009
2
SEZIONE PRIMA
Libri
3
C. Ossola, Poesia,consolazione della filosofia, «Avvenire», 23 novembre 2008.
«Varcata la terra, / vengono in dono le stelle» [«superata tellus / sidera donat»]: così, come il
Paradiso di Dante, si chiude il De consolatione philosophiae di Severino Boezio (ora riedito, sul
testo critico di Claudio Moreschini, nella bella collana, diretta da Michel Zink, «Lettres gothiques»,
nei Livres de poche). Il testo è preceduto da una meditata introduzione di Jean-Yves Tilliette, che
vede saldarsi, nel trattato di Boezio, l’eredità dell’aristotelismo, del platonismo, dello stoicismo,
consegnati infine al Medioevo cristiano, che farà di Boezio il più amato degli auctores: Dante stesso lo collocherà accanto a Orosio, Isidoro di Siviglia, Beda, Riccardo di San Vittore, nel X canto del
Paradiso (124-129). Due italiani, Fabio Troncarelli e Silvia Albesano (validissima allieva di Cesare
Segre) hanno studiato l’immensa fortuna manoscritta e i volgarizzamenti dell’opera. È, questa, un
canto di prigionia, di meditazione della morte e dei fini ultimi della vita: Boezio, nato tra il 475 e il
480 d.C., negli anni in cui si chiude la millenaria vicenda dell’Impero romano, discendente da illustre famiglia consolare, cristiano, traduttore dell’ Organon di Aristotele (e fondatore quindi del lessico filosofico occidentale), è presto console nell’Italia di Teodorico. Avendo Boezio preso le difese del senatore Albino, accusato di tradimento per aver tenuto una corrispondenza con l’imperatore
di Bisanzio Giustino I, è a sua volta imprigionato a Pavia, torturato, condannato a morte e giustiziato nel 525 / 526 («da martiro / e da essilio venne a questa pace», dirà Dante). La bellezza dell’opera non è solo nella meditazione della vanità della vita, della fama, dei poteri, nella contemplazione dei beni eterni, ma soprattutto nell’alternarsi di verso e prosa. La prosa argomenta e il verso
eleva; la prosa dialoga e il verso stringe a sintesi; la prosa si distende nelle peripezie terrestri e il
verso s’invola nei regni della luce. La prosa scorre nella storia e il verso la riscatta nell’armonia
delle ragioni celesti: «O tu che governi il mondo con perpetua ragione» [«O qui perpetua mundum
ratione gubernas»]. Il fascino dell’opera è soprattutto quello di aver saldato poesia e filosofia, di
aver fatto della poesia lo scrigno del ragionare della mente. Il prosimetro di Boezio si pone accanto a quello di Marziano Capella, De nuptiis Mercurii et Philologiae (V secolo d. C.), come fondatore di un genere che troverà nella Vita Nova di Dante il più alto compimento. Non meno, l’apparire di Filosofia, sin dal I libro del De consolatione, donna severa e maestosa, resterà nella mente di
Dante al disvelarsi di Beatrice nel Paradiso Terrestre (anch’essa dapprima severa con il poeta). Nei
versi di Boezio, il ricordo dei più memorabili incipit di Orazio, di Lucrezio s’intreccia al retaggio
del «fondo oro» della bizantina Ravenna e produce nuove vivide figure di poesia e moralità:
« Anche se il ricco, in fluenti onde d’oro, / avido nuotasse in ricchezze che non tratterrà»[«Quamvis
fluente dives auri gurgite /…»]. Soprattutto prepara, nei suoi versi, la «lucida fonte» dei luminosi
cieli del Paradiso di Dante: «O stelliferi conditor orbis», sino al culmine di un sigillo che nei due
testi pare dettato da uno stesso moto, che unisce e armonizza: «O felix hominum genus, / si vestros
animos amor / quo caelum regitur regat!», «ma già volgeva il mio disio e ’l velle, / sì come rota ch’igualmente è mossa / l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Par., XXXIII, 143-145). Poesia, vero
paradiso della filosofia!
S. Albesano, Consolatio philosophiae volgare: volgarizzamenti e tradizioni discorsive nel Trecento
italiano, Heidelberg, Winter, 2006.
4
«Il Sole 24 Ore », 19 Aprile 2009.
Agostino Paravicini Bagliani. Il potere del papa. Corporeità, autorappresentazione, simbolismi,
Tavarnuzze (Firenze), Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2009.
Natura, scienze e società medioevali: studi in onore di Agostino Paravicini Bagliani, a cura di C.
Leonardi e F. Santi, Tavarnuzze (Firenze), Simel-Edizioni del Galluzzo, 2009.
5
C. Ossola, Le pitture del cuore, «Avvenire», 16 novembre 2008.
Tre libri recenti (Benedetta Papasogli, I moralisti classici, Laterza; e, della stessa, La mémoire du
coeur au XVIIème siècle, Parigi, Champion; Louis Van Delft, Les Moralistes. Une apologie, Paris,
Gallimard), tutti dedicati al XVII secolo, ci riportano a una questione antica: se l’uomo vedesse
davanti a sé dipinti i propri difetti, errori, deformità morali, saprebbe emendarsi?
Pare oggi strano, ma la “pittura dei sentimenti” fu, per qualche secolo, anche più importante della
pittura dei paesaggi. Bernard Lamy, citato da Van Delft, delinea quei tratti: «Il discorso è l’immagine dello spirito. Si dipingono umori e inclinazioni nelle proprie parole senza che ci si pensi» (La
rhétorique ou l’art de parler, 1675). Camillo Baldi, del resto, era andato più in là, nel suo trattato
Come da una lettera missiva si conoscano la natura e qualità dello scrittore (1622), immaginando
che chi legge possa sempre vedere in quei caratteri avanzare un uomo con il “cuore in mano”.
Domanda di aiuto o offerta di verità, quel pulsare è il nostro scrigno, centro, ricettacolo della memoria, sino a suscitare -nel Cardiomorphoseos di Francesco Pona, 1645- una turrita serie di “emblemi sacri” con al centro il cuore. François Lamy, nel suo analitico De la connaissance de soi-mesme,
1694-97, osservava acutamente che «le nostre idee non ci modificano punto […], mentre i nostri
sentimenti e le inclinazioni del cuore sono vere maniere d’essere, vere impressioni calcate nella
sostanza». Questa «scienza del cuore» (Papasogli) richiede percorsi attenti, passi avvertiti, ma verso
dove ? Il cammino verso l’interno non è così agevole come la contemplazione del paesaggio; lo
notava già Fénelon: «È ben vero che le parti interne dell’uomo non sono gradevoli a vedersi quanto le esterne. Ma esse non son fatte per essere viste »: se apparissero, infatti, non potrebbero essere
contemplate che con «ripugnanza»: «È tale orrore che prepara la compassione: […]: fragilità della
creatura, arte del Creatore». Ecco perché crea disagio il «discorso viscerale» : è una verità di noi
troppo esibita, uno squarciare il petto, lasciando apparire “interiore e interiora” di noi. C’è un’arte
di andare “al centro”, al “cuore” del problema che è ardita e perigliosa; altri, come il Castiglione,
preferiscono toccare il soggetto «come per transito», alludendo più che definendo. E del resto, se il
centro fosse sempre davanti a noi, non sarebbe conoscenza ma follia, come in Racine: «Dalla sua
immagine invano ho voluto distrarmi. / Troppo presente ai miei occhi …» (Britannicus, II, 2).
Si apre allora, e sin da Montaigne, un’altra maniera di “pervenire a noi”: quella del “cammin facendo…”, di continuare ascolto e parola, ogni giorno , senza posa, sino alla fine: «Chi non vede che
ho preso una strada per la quale, senza intermissione e senza fatica, avanzerò sin tanto che ci sarà
inchiostro e carta al mondo?» ( Essais, III, 9). Al centro di noi o alla fine è la nostra verità? Il padre
Dominique Bouhours (1628-1702) non aveva dubbi: «I passi che sono alla fine sono come il riassunto e l’estratto dei pensieri della giornata: raccolgono tutto il senso e tutta la forza in due parole
[…]. Sono grani seminali, che contengono una grande virtù in una piccola massa, e fanno molto
effetto in poco tempo» (Pensées chrétiennes pour tous les jours du mois ). Arte di seminare la fine…
I moralisti classici, a cura di B. Papasogli, Roma-Bari, Laterza, 2008.
B. Papasogli, La mémoire du coeur au XVIIème siècle, Paris, Champion, 2008.
L. Van Delft, Les Moralistes. Une apologie, Paris, Gallimard, 2008.
6
«Giornale del Popolo », 22 novembre 2008.
E. Tesauro, Vocabulario italiano, testo inedito a cura di M. Maggi, Firenze, Olschki, 2008.
7
«Il Sole 24 Ore », 30 novembre 2008.
E. Tesauro, Vocabulario italiano, testo inedito a cura di M. Maggi, Firenze, Olschki, 2008.
8
D. Del Giudice, L’occhio. Quel cuore che guarda e ci fa conoscere il mondo, «Repubblica», 27 aprile 2008.
Sguardo penetrante, un tempo, non era un modo di dire, ma corrispondeva, per esempio in Marsilio
Ficino e nei neoplatonici, all’idea che dall’occhio di chi guardava si dipartisse qualcosa che raggiungeva l’occhio del guardato, o della guardata, lo toccava, lo colpiva, lo impressionava, lo penetrava.
Per questo, forse, le figure femminili in Dante e Petrarca tengono gli occhi bassi, non soltanto per
pudore o riserbo della propria “anima”, ma per non essere penetrate da ciò che muove dall’occhio
altrui, preservando così un’ulteriore verginità. Il vedere non è dunque sempre vissuto come un atto
incorporeo, né come una mancata relazione fisica con l’oggetto della visione. Piuttosto l’occhio
governa e fa premio su tutte le percezioni, concentra tutto con un solo organo e un solo senso, escludendo gli altri. Nel nostro tempo il vedere, più che un atto, è diventato una azione, talvolta la nostra
azione principale, spesso merce e lavoro: non si è mai guardato tanto e visto tanto, e mai così forte
è stata l’illusione che non esista più alcun mistero, alcun invisibile. Quando c’è l’immagine, non c’è
la cosa. È un’eventualità che la filosofia stoica conosceva perfettamente, sebbene ritenesse che la
cosa o la persona si fossero momentaneamente allontanate. Oggi, al contrario, le cose sembrano sparite sempre più, ed è l’immagine che è diventata indubbiamente cosa, oggetto di mestiere e di commercio. È difficile dire se tutto questo vedere consumi l’occhio. È possibile però che consumi i sentimenti. Le nostre emozioni davanti alle immagini, così come le opinioni che ci formiamo all’istante e poi lasciamo subito cadere, si accendono e bruciano in un attimo, totalmente intransitive, e
incontrollabili come una salivazione. Non so da quando, ma le immagini hanno preso a scorrere
come una specie di ritmo visivo, un ritmo di sottofondo, o meglio di rumore visivo di fondo, seguendo in questo il destino che fu già della musica e dell’ascolto. Vedere è un’azione, e ci sono le buone
azioni e le cattive azioni. Cos’è un “buon” vedere? E cosa un “cattivo” vedere? Non posso pensare
che dipenda dall’oggetto della visione; l’osceno, credo, non esiste, non c’è nulla di avverso, nulla
che si “ponga contro” il nostro occhio. Dipende da noi, dal nostro modo di vedere che resta segreto, una questione del tutto privata. A differenza delle altre azioni, non c’è nessuno a cui dobbiamo
rendere conto del nostro occhio che vede, nessuno (se non un oculista, il quale tuttavia non cura l’anima e giudica solo in termini di metropia) che possa domandare: il suo occhio com’è? lei come
vede? Per costruire un sentimento del vedere — poiché di questo si tratta — non c’è autorità di insegnamento né ci sono prove da superare, non precetti né consigli. Eppure è solo un sentimento delvedere, un cuore che guarda, che può redimere, se non noi stessi almeno le immagini che il nostro
occhio percepisce. René Guénon nel suo Simboli della scienza sacra dedica un paragrafo all’occhio
che vede tutto, nel capitolo sul simbolismo del cuore. Uno dei simboli comuni al cristianesimo e alla
massoneria, ricorda, è il triangolo nel quale è inscritto il Tetragramma ebraico oppure lo iod che può
esserne considerato un’abbreviazione, sorta di “terzo occhio”, né destro né sinistro, un occhio frontale come quello di Shiva, né solare né lunare, corrispondente al fuoco, il cui sguardo riduce tutto
in cenere perché esprime il presente senza dimensioni, cioè la simultaneità, e così distrugge ogni
manifestazione. L’occhio unico e senza palpebra è il simbolo dell’essenza della conoscenza divina.
L’occhio unico del ciclope indica al contrario una condizione subumana. Come subumana è la condizione di Argo, Argo Panoptes, «che tutto vede», gigante con un solo grande occhio secondo alcuni miti, ma secondo altri con quattro, due davanti e due dietro, e secondo altri ancora con cento occhi
(dormiva chiudendone cinquanta per volta) oppure con un’infinità di occhi disseminati sull’intero
corpo, che non si chiudevano mai tutti insieme, una vigilanza rivolta esclusivamente all’esterno. Di
una persona molto accorta i Greci dicevano che era un Argo oppure che aveva più occhi di Argo.
L’occhio umano è un simbolo universale di conoscenza, l’apertura degli occhi è un rito di apertura
alla conoscenza, un rito di iniziazione. Ma l’occhio ha colpito l’immaginario comune innanzitutto
per la sua forma ovale e per la sua condizione di luogo aperto/chiuso, da cui qualcosa può entrare e
qualcosa può uscire. Nella lingua italiana l’occhio ha infinite declinazioni. Oltre che l’organo della
vista e l’apparato visivo o anche la capacità di leggere bene, vuol dire, ad esempio, il foro aperto in
9
una porta o una parete per spiare di nascosto, oppure la toppa della serratura, oppure i buchi nella
mollica del pane ben lievitato, o ancora, in architettura, ogni apertura circolare o ellittica. Anche
le chiazze naturali sulle piume, il pelo o la pelle di certi animali si chiamano occhi, come le macchie azzurre sulla coda del pavone, e anche le macchie evidenti sulla superficie di marmi o pietre. Occhi sono i dischi del capolino di una margherita o di un girasole, o i cerchi su una superficie liquida agitata. Alcune cose escono dagli occhi, e qualcuno può andare per occhio, cioè
colare a picco con la sua nave. L’occhio pineale è l’ossessione di Georges Bataille. Come lui
stesso ricorda nella Critica dell’occhio, quest’idea risale al 1927 e risponde probabilmente alla
sua concezione anale, cioè notturna, del disco solare. Scrive: «Mi raffiguravo l’occhio in cima
al cranio come un orribile vulcano in eruzione, proprio con il carattere losco e comico che si
attribuisce al di dietro e alle sue escrezioni. Ora l’occhio è senza alcun dubbio il simbolo del sole
abbagliante, e quello che io immaginavo in cima al mio cranio era necessariamente infuocato,
essendo votato alla contemplazione del sole al sommo del suo splendore». Scrive ancora: «Io
non esitavo a pensare seriamente alla possibilità che quest’occhio straordinario finisse per farsi
strada attraverso la parete ossea della testa, perché credevo necessario che dopo un lungo periodo di servilità gli esseri umani avessero un occhio speciale per il sole (mentre i due occhi che
sono nelle orbite se ne allontanano con una specie di ostinazione stupida). Non ero pazzo ma
davo senza dubbio eccessiva importanza alla necessità di uscire in una maniera o nell’altra dai
limiti della nostra esperienza umana […]». Buono o malvagio, qualunque sia il sentimento del
suo vedere, l’occhio è sempre oggetto di acute inquietudini e suscita comunque emozioni contrastanti. Ancora Bataille, scrive che non c’è nulla di più seducente dell’occhio, nulla di più
attraente nel corpo degli uomini e degli animali, e in questo appealè simile al filo della lama.
D’altra parte, la seduzione estrema è al limite dell’orrore, ed è forse quello che ha ispirato
Salvador Dalì e Luis Buñuel nel film Chien andalou, dove un rasoio incideva l’occhio di una
donna giovane e affascinante sotto lo sguardo di un uomo, ammirato fino alla follia, che tiene in
mano un cucchiaino da caffè e improvvisamente ha voglia di prendersi un occhio nel cucchiaino. Voglia piuttosto singolare per un occidentale la cui cultura gli impedisce di mangiare l’occhio dei buoi, degli agnelli o dei maiali. È golosità cannibale, secondo l’espressione di Robert
Louis Stevenson. Nessuno di noi morderebbe mai un occhio. Ci sono quelli che non danno troppa importanza all’occhio e al suo vedere, e preferiscono sentire. Era appunto il caso di Stevenson
nella sua ultima e appassionata discussione letteraria. Quando l’amico Henry James gli lamentò
di non vedere nulla nel romanzo Catriona — «ho l’impressione di trovarmi in presenza di voci
nell’oscurità, voci tanto più distinte e vivaci […] quanto lo sguardo resta occultato» —
Stevenson gli rispose con una frase memorabile: «Ascolto le persone parlare e le sento agire, il
racconto mi sembra questo. I miei due obbiettivi possono essere descritti così: 1. guerra all’aggettivo e 2. morte al nervo ottico». Secondo Stevenson «la letteratura è scritta per e da due sensi:
una specie di orecchio interno, lesto a percepire melodie silenti, e l’occhio che — semplicemente — guida la penna e decifra la frase stampata. Ebbene, proprio come vi sono rime per l’occhio,
così noterete che esistono assonanze e allitterazioni ». E poi ci sono quelli che preferiscono l’assenza dell’occhio, come José Saramago che ha scritto uno dei suoi migliori romanzi, Cecità,
straordinaria metafora di una perdita del vedere nei nostri tempi. Quanto all’“occhio della
coscienza”, poco prima di morire, nel 1847, l’illustratore fantastico e caricaturista francese JeanIgnace-Isidore Gérard, detto Grandville, sognò quest’occhio ossessionante e lugubre, occhio
vivente e totalmente vigile. Lo raccontò in Crime et expiation, e Victor Hugo lo riprese.
L’aspetto assolutamente negativo dello sguardo invidioso, pieno di cattive intenzioni, l’occhio
malevolo, cioè il malocchio, mal d’occhio, è ancora molto vivo nella cultura mediterranea. Ci
sarebbero occhi particolarmente pericolosi, come quelli delle donne anziane, ma anche delle
vipere o dei gechi, perché l’intero mondo animato partecipa di questa presa di potere su altro e
altri. E particolarmente sensibili al malocchio sarebbero i bambini, le puerpere, il latte, il grano
ma anche cavalli, cani e il bestiame in generale, perché il malocchio può uccidere gli animali.
Come difendersi dal malocchio: con veli che nascondono allo sguardo, fumigazioni profumate,
ferro rosso, sale, corni, mezzelune, ferri di cavallo, mani di Fatima. Per la posizione nel corpo,
10
e nella preminenza sulle percezioni del nostro mondo, l’occhio, il suo simbolo, la sua parola
stessa si adeguano all’infinito: occhio del ciclone, occhiolino, occhiello, occhio di bue, occhio
di gatto, locuzioni tutte riguardanti tutt’altro.
W. Deonna, Il simbolismo dell’occhio, a cura di S. Stroppa, Introduzione di C. Ossola, Torino,
Bollati Boringhieri, 2008.
11
M. Belpoliti, Il nostro occhio è un bricoleur, «La Stampa»
– Tuttolibri, 14 giugno 2008.
In Albania, racconta Plinio, vivono uomini nati con occhi
glauchi e capelli bianchi che vedono meglio di notte che
di giorno; lo stesso imperatore Tiberio possedeva una
simile facoltà: se si svegliava di notte, distingueva perfettamente gli oggetti. Kaspar Hauser, il più famoso «bambino selvaggio», percepiva stelle invisibili per mezzo di una
vista straordinaria e anche i colori dentro un’oscura foresta. Gli sciamani, poi, sarebbero dotati di un’acutezza
visiva responsabile delle loro facoltà psichiche, capaci di
vedere a lunga distanza o al buio.
Tutte queste notizie sono fornite da Waldemar Deonna in
un libro straordinario: Il simbolismo dell’occhio, in uscita
da Bollati Boringhieri, summa enciclopedica su come le
differenti religioni e culture hanno considerato l’occhio, il
più importante dei nostri organi di senso, attraverso cui si
è sviluppata la stessa civiltà umana.
Deonna, archeologo e antichista, ha scandagliato l’idea di acutezza visiva ponendo particolare attenzione ai collegamenti tra l’occhio e gli astri, tra l’occhio e il fuoco, badando a distinguere i simbolismi dell’occhio destro e quelli dell’occhio sinistro, la cecità fisica e quella simbolica, il malocchio
e il «buonocchio», l’occhio unico e gli occhi multipli, l’occhio e l’anima, lo sguardo umano e lo
sguardo animale.
Il volume, pubblicato postumo nel 1965, tradotto per la cura di Sabrina Stroppa, è articolato in due
livelli: da un lato, l’esposizione dei vari simboli, riti e credenze; dall’altro un regesto fittissimo di
note, rimandi, commenti e spiegazioni ulteriori, frutto di un’erudizione che Deonna, autore di libri
singolari sul simbolismo dell’acrobata, sulle abitudini a tavola, sui miracoli greci e quelli cristiani,
ha accumulato in decenni e decenni di sterminate letture.
Per un caso fortuito Il simbolismo dell’occhio esce in contemporanea con un libro che si presenta
come il suo esatto opposto, Storia naturale dell’occhio, opera di Simon Ings, scrittore di fantascienza e giornalista scientifico, cosi’ da offrire una doppia e affascinante lettura del nostro prezioso organo di senso.
Mentre Deonna ci accompagna nell’universo dei simboli e dei riti religiosi, Ings ci fa attraversare il
territorio altrettanto frastagliato della scienza. Al centro c’è sempre l’occhio umano, complesso e
misterioso sensore che si è sviluppato a partire da lembi specializzati di pelle. I primi occhi sono
comparsi 550 milioni di anni fa; appartenevano alle trilobiti, creature marine che oggi possiamo
ammirare solo attraverso reperti fossili. Le unità fondamentali di strutture complesse come l’occhio,
scrive Ings, «erano già disponibili molto tempo prima di essere reclutate per compiti sofisticati
come la visione».
Leggendo Storia naturale dell’occhio, libro di rara precisione e completezza, costruito come un racconto, si ha la sensazione che la scienza non sia meno fantastica dei miti. E poichè lo scrittore inglese ha scelto di raccontare la storia dell’occhio evidenziando molte figure di scienziati e ricercatori
del passato e del presente, si ha la sensazione che essi procedano attraverso continui spostamenti e
12
aggiustamenti, mediante discontinuità piuttosto che sviluppi lineari. Come ha scritto George Wald,
premio Nobel, studioso dell’occhio, colui che ha guidato la rivoluzione che ha trasformato la biologia da scienza cellulare in scienza molecolare, «noi siamo il prodotto della rielaborazione piuttosto
che dell’invenzione». L’occhio ha modificato se stesso nel corso di milioni d’anni agendo come un
geniale e previdente bricoleur. Questo sensore è lo strumento privilegiato di un mammifero che ha
smesso di usare il naso per pensare e che si è specializzato nella raccolta. Mentre la maggior parte
degli animali non si preoccupa molto della sostanza delle cose, badando invece a «dove vanno le
cose», noi umani siamo interessati «a quello che le cose sono». I nostri occhi si muovono a scatti,
sembrano letteralmente balbettare, eppure siamo bravissimi nell’individuare i piccoli oggetti: più
preoccupati dalle immagini che non dal movimento.
Molte delle simbologie descritte da Deonna sembrano trovare conferma nel racconto scientifico di
Ings; ad esempio, la visione notturna. Discendiamo da animali notturni, e la nostra capacità di vedere di notte - davvero straordinaria, anche se nei Paesi occidentali e industrializzati oramai nessuno
o quasi l’apprezza più - «è il retaggio del nostro passato notturno». Questa acuità visiva ha tuttavia
un contrappeso: la visione dei colori di cui siamo dotati appare «relativamente notevole ancorchè
difettosa». Nel nostro sistema percettivo il colore «è soltanto un mezzo per distinguere gli oggetti
gli uni dagli altri». Questo perchè la nostra specie si è mossa soprattutto in ambienti ricoperti da
alberi e, come ha dimostrato un neurofisiologo thailandese nel 2000, la luce diurna filtrata dagli
alberi della foresta cambia solo lievemente di colore. Siamo invece più sensibili alla lucentezza, e
questa c’è servita per milioni di anni alla ricerca del cibo nel sottobosco dove il colore non è significativo.
Il capitolo che Ings dedica a questo aspetto, «Vedere i colori», è forse il più bello del libro insieme
al successivo, «Non vedere i colori», dove si parla di Dalton, e di come lo scopritore del daltonismo
in realtà non fosse propriamente un daltonico. La scienza, mi viene fatto di pensare chiudendo i due
libri, è il nostro grande mito attuale, un mito non meno funzionante e seducente dell’altro che abbiamo frequentato per millenni nel passato prossimo.
W. Deonna, Il simbolismo dell’occhio, a cura di S. Stroppa, Introduzione di C. Ossola, Torino,
Bollati Boringhieri, 2008.
13
C. Ossola, L’occhio vuole la sua arte, «Il Sole-24 Ore», 9 novembre 2008.
W. Deonna, Il simbolismo dell’occhio, a cura di S. Stroppa, Introduzione di C. Ossola, Torino,
Bollati Boringhieri, 2008.
14
R.M. Parrinello, L’abito di orecchie di rana, «L’Indice», Aprile 2009.
W. Deonna, Il simbolismo dell’occhio, a cura di S. Stroppa, Introduzione di C. Ossola, Torino,
Bollati Boringhieri, 2008.
15
SEZIONE SECONDA
I Mercoledì dell’ISI, Conferenze e convegni
4 marzo 2009
Marco Maggi: Il lume di una candela.
29 ottobre 2008
Lina Bolzoni: Le passioni delle gocce
d’acqua: la descrizione della vita
delle piccole cose fra Bruno e Campanella.
19 novembre 2008
Andrea Celli: «Perché mi scerpi?».
Il canto di Pier delle Vigne tra Hegel
e De Sanctis.
A misura che i corpi dalla vitruviana centralità delle proporzioni umane nell’universo si
restringono a più minute forme, e il visibile si
riduce agli orli dell’invisibile, la certezza del
nostro percepire si attenua. I corpuscoli non
paiono più miniature di realtà ma divengono
punti di fascino e d’inciampo sul nostro cammino di comprensione, sino a che – come la
fisica che non disgiunge, all’ultimo minimo,
onda da corpuscolo – non venga una sperafilamento di sole ad illuminarci.
Il ciclo di conferenze è organizzato con il patrocinio del Consolato generale d’Italia a Lugano
e in collaborazione con la Società Dante Alighieri della Svizzera italiana di Lugano.
17 dicembre 2008
Antonella Anedda: La vita dei dettagli.
Fessure.
18 febbraio 2009
Daniela Mondini: Reliquie incarnate –
Le “Sacre Teste”
di Pietro e Paolo a S. Giovanni
in Laterano a Roma.
Semestre autunnale
Corpi e corpuscoli
6 maggio 2009
Francisco Jarauta: Frammenti di
un’identità dissociata:
il ritratto nel Novecento.
1° aprile 2009
Jürgen Maehder: Le particelle
della musica – La visualizzazione
dello spazio sonoro nella musica
del secondo Novecento.
Semestre primaverile
Conferenze pubbliche organizzate dall’Istituto di studi italiani nell’a.a. 2008-2009
USI, Via Buffi 13, Auditorio
Ore 18:00-19:30
I mercoledì dell’ISI
16
17
17
M. Camponovo, Sulle avventurose tracce delle reliquie incarnate, «Giornale del Popolo», 21 febbraio 2009.
22 Cultura
MERCOLEDÌ DELL’ISI
+
Le “Sacre Teste” di Pietro e Paolo a Roma
Sulle avventurose tracce
delle Reliquie incarnate
Singolare e poco indagata la tematica affrontata, nel
quarto appuntamento del ciclo, dalla storica dell’arte
Daniela Mondini. Una vicenda di resti sacri e dei loro
preziosi contenitori, di traslazioni e devozioni, tra
visibile e invisibile, occultamento e rituale ostensione.
di MANUELA CAMPONOVO
Più “Corpi e corpuscoli” di così...
Come ha anche sottolineato Carlo
Ossola introducendo il quarto appuntamento, ben si adattava questa
conferenza al tema del ciclo. La storica dell’arte, ricercatrice del FNS e
docente nelle università di Zurigo,
USI di Lugano e Accademia di Mendrisio, mercoledì scorso, anche con
l’aiuto di un repertorio iconografico,
si è avventurata sulle tracce delle Reliquie incarnate – Le “Sacre Teste” di
Pietro e Paolo a S. Giovanni in Laterano a Roma. Un soggetto di studio
singolare, quello delle “reliquie” appunto e dei loro involucri, che solo
dagli anni ’90 conosce «una vera e
propria fioritura», con l’allargarsi
degli interessi all’antropologia dell’immagine e a ricerche interdisciplinari. La relazione ha toccato, attraverso le epoche, la tematica nei suoi
aspetti anche generali: il significato
e la “funzione” delle reliquie (resti diretti o indiretti dei santi, dei loro corpi o di oggetti ad essi appartenuti),
«“pegno” materiale del sacro» che
può essere considerato un «“medium”/un mezzo per attingere alla
sfera del divino». Da qui la virtù miracolosa, la forza salvifica ma anche
la conservazione in contenitori molto spesso preziosi, da venerare all’interno della Chiesa, involucri che venivano sostituiti nella necessità di
«attualizzarne il culto».
La relatrice si è soffermata pure su altre reliquie, come quelle di Cristo
(soprattutto la Veronica) o di altri
santi importanti, ma si è soprattutto concentrata (come da titolo) sulla “fortuna” e “sfortuna” legate ai resti dei “Capita Apostolorum”, una vicenda avvolta nel silenzio da almeno un paio di secoli (l’ultimo trattato, c’informa la prof.ssa Mondini, fu
pubblicato nel 1806 dal prete-antiquario Giovanni Cancellieri).
Non si sa come e in che circostanze
i due crani sarebbero stati separati
dai corpi sepolti fuori le mura per entrare a far parte del tesoro papale
(come attesta per la prima volta un
inventario dell’XI secolo), conservato nella cappella di S. Lorenzo nel Patriarchio Lateranense. La traslazione
potrebbe essere avvenuta nella seconda metà del IX secolo, secondo
diversi studiosi. Ma il fatto che non
ci siano tracce scritte di questo tra-
sferimento e che per duecento anni
i resti rimasero custoditi nel nuovo
deposito, la Cappella papale, senza
che nessuna fonte ne parlasse, apre
interrogativi sulla loro autenticità.
Le teste, rappresentate in effigie in
due medaglioni sugli sportelli bronzei del nuovo altare-reliquiario fatto costruire da Innocenzo III all’inizio del XII, godettero di una sempre
maggiore considerazione nell’ambito della liturgia papale e del “cerimoniale” di stato. I reliquiari che le contenevano dovevano essere inizialmente «semplici cofanetti di metallo nobile». Ma con il ritorno del Papa, al termine dell’Esilio Avignonese, e il loro rinvenimento nell’altare
della cappella Sancta Sanctorum, le
“sacre teste” ebbero una nuova “casa”. Nel 1369 l’orefice senese Giovanni di Bartolo realizzò due busti d’argento: la cerimonia di traslazione e
la collocazione sopra l’altare principale della Basilica Lateranense ebbero luogo il giorno di Pasqua del 1370.
A questo punto, documenti alla mano, la relatrice c’informa che non si
trattava in realtà di due teschi integri ma solo parti di essi. In ogni caso, da qui iniziò la loro “carriera” di
reliquie principali. Inoltre, attraverso la monumentalità antropomorfa,
LIBRO
Incisione tratta dal volume di J.-B. Séroux d’Agincourt, “Histoire de l’art par les monumens
depuis sa décadence jusqu’à son renouvellement du IVe au XVI siècle” (Parigi 1823), basata
su un disegno del 1780 circa.
“parlante” dei loro contenitori e la
“messa in scena” visibile sopra l’altare maggiore di S. Giovanni in Laterano, inaugurarono «un nuovo tipo di “presenza” quasi corporea del
santo venerato». Una “re-incarnazione” che però «non ebbe seguito in altre chiese romane».
I reliquiari, di cui viene fornita una
dettagliata descrizione (grazie a dipinti, stampe e fonti scritte), furono
distrutti (fusi alla Zecca di Roma) nel
1799 dalle truppe francesi e sostituiti con altri commissionati nel 1804
all’architetto Giuseppe Valadier.
I reliquiari neoclassici ottocenteschi a forma di busto si trovano ancora oggi nella Basilica. Ma ormai, in
epoca di scettica secolarizzazione, in
cui per autenticare le reliquie è chia-
mata in causa la certificazione scientifica (in realtà, come in chiusura ha
rilevato Carlo Ossola, «è il culto che
fa la reliquia»), le “teste” hanno perso la loro sacralità. A questo spossessamento corrisponde la maniera di
esporre i contenitori, nel piano superiore del ciborio lateranense, «in
“ostensione continua” senza più
tendaggi. Illuminati perfettamente
da discreti faretti, i busti-reliquiari si
sono trasformati in oggetti di esposizione museale di interesse storico
(-artistico). Che questi busti abbiano contenuto (e che probabilmente
contengano tuttora?) delle reliquie,
un tempo veneratissime, il turista
l’apprenderà forse ancora dall’audioguida noleggiata all’ingresso della basilica Lateranense...».
Raccolte le prose pubblicate nella rivista “Ore in famiglia”
Chiara sconosciuto
A cura di Andrea Paganini, è uscito il volume Quaderno di un tempo
felice, Nino Aragno Editore, Torino. In
esso sono raccolte una serie di prose di Piero Chiara, in gran parte sconosciute, apparse sulla rivista ticinese “Ore in famiglia” tra il 1947 e il
1961, ovvero nel periodo compreso
tra l’esordio dello scrittore con la raccolta di poesie Incantavi (1945) e il
successo del romanzo Il piatto piange (1962). Insieme ad alcuni racconti che ricostruiscono il mondo dell’infanzia di Chiara intorno alla vita
di Via dei Mercanti a Luino, il libro
riunisce scritti di genere diverso: dal
reportage di viaggio al riassunto delle opere di grandi romanzieri, dall’in-
tervento di critica letteraria a quello
di carattere puramente informativo.
In questi testi non c’è ancora la licenziosità del Chiara più noto, «ma si
sente già l’annuncio di una poetica
scanzonata della mediocritas, del
pettegolezzo curioso e sornione, della caricatura grottesca che tende a
enucleare aneddotiche vicende di
piccola umanità, nelle quali le note
malinconiche sono immancabilmente mitigate dall’inconfondibile
ironia». “Quaderno di un tempo felice” compare come titolo di un racconto uscito sul nostro giornale il 16
maggio del 1945 e poi ripubblicato
una prima volta in “Ore in famiglia”
nel ’49 con il titolo Ortensio.
18
Sabato 31 gennaio 2009
Secondo Colloquio ISI: “Carta canta”
Ore 9,00 – Aula 354
Introduzione:
Carlo Ossola, Decantare
Ore 9,30
Stefano Prandi, «Illuminati da un più antico sorriso»
Piero Boitani, «Ridon le carte»: guerra e pace nella tradizione
Annick Paternoster, «‘Ma...!’ disse Renzo», «‘Poh...!’ rispose Tonio»: come ‘suona’ il
common ground nei “Promessi sposi”.
Ore 11,00: Pausa
Ore 11,15
Johanna Miecznikowski, «Il testo recita...»: il rinvio a fonti scritte nella stampa economico-finanziaria
François Dupuigrenet-Desroussilles, «Carta non canta»: marche di autorità false e
fittizie
Ore 12,15: Discussione generale
Ore 13,00: Fine dei lavori
19
C. Marello, Le parole dei sogni, «Corriere del Ticino», 14 settembre 2008.
Decidersi a raccontare un sogno dopo la divulgazione dell’interpretazione dei sogni di Freud e Jung
e la rappresentazione cinematografica delle sedute dallo psicoanalista è atto non privo di coraggio
e rischi. Intendiamoci, non vogliamo parlare qui di sogni descritti all’interno di opere letterarie o
comunque pianificati, ma di racconti orali di sogni.
Claudia Caffi, facendo molta fatica a trovare persone che glieli raccontassero e si lasciassero registrare, ne ha raccolti e trascritti una quantità significativa per il linguista. Ci ha dato un’anteprima
delle sue considerazioni a Bergamo il 10 e 11 settembre 2008 durante il convegno internazionale
“Tra pragmatica e linguistica testuale” organizzato da Federica Venier per ricordare Maria-Elisabeth
Conte, grande linguista scomparsa prematuramente dieci anni fa, di cui Caffi e Venier sono state
allieve (e che talvolta, ci hanno rivelato non senza imbarazzo, sognano).
Caffi ha voluto inquadrare tipologicamente il racconto di sogni nei racconti finzionali: dopotutto è
chiaro fin dall’inizio che il sogno non racconta la realtà. Anche se si scopre che era premonitore,
nel momento in cui lo si fa non è reale.
Già nella locuzione “fare un sogno” si vedono differenze di approccio fra noi e gli antichi: Greci e
Romani, ad esempio, non facevano sogni, li vedevano. Quasi che non fossero prodotti dal soggetto sognante, ma proiettati nella sua mente da qualche essere soprannaturale o da un trapassato con
intenzioni non sempre benevole. Poiché noi apprendiamo dei sogni degli antichi solo da documenti scritti, è ovvio che questi sogni hanno una funzione, altrimenti non verrebbero descritti. Anzi,
molti avanzano dubbi sulla effettiva natura onirica dei sogni storici , come quello di Costantino, e
pensano che siano stati creati dopo, per motivi apologetici, per attribuire soprannaturalità a comportamenti politici molto umani.
Caffi ha poi ritrovato nei racconti trascritti molte delle caratteristiche che aveva messo in luce studiando approfonditamente il dialogo fra pazienti e medici nel libro “La mitigazione” (uscito in italiano nel 2001 e ripubblicato in inglese lo scorso anno, col titolo Mitigation, da Elsevier di
Amsterdam).
Trova un numero altissimo di espressioni linguistiche che testimoniano lo sforzo, e mitigano l’insuccesso, per raccontarlo con una struttura narrativa, per attribuire al luogo e ai personaggi sognati
una qualche sensatezza. Nei suoi studi di pragmatica Caffi distingue in “cespugli” e “siepi” quello
che in Lakoff è il concetto di hedge. I cespugli sono nei racconti di sogni gli oggetti mutevoli: “inizialmente era una farmacia poi no poi è diventata un’altra cosa un altro tipo di negozio... poteva
essere tipo un’agenzia immobiliare”. Le “siepi” sono indicatori di incertezza di ambito maggiore,
come “non lo so, forse, magari, probabilmente”; “ mia figlia c’era e non c’era non lo so , non era
una presenza fissa”.
Mentre l’ascoltavo mi è venuta in mente un’interpretazione dei sogni più casereccia e venale: quella di quanti interpretano i sogni per giocare i numeri al lotto. Non si cerca quasi mai in quella situazione di collegare numeri a una storia, al sogno nella sua globalità; si attribuiscono numeri a oggetti/personaggi singoli, al massimo in relazione a un altro elemento che ne chiarisce meglio il valore.
C. Caffi, Aspetti pragmatici e testuali del racconto di sogni. Relazione tenuta al Convegno internazionale Tra pragmatica e linguistica testuale. Ricordando Maria-Elisabeth Conte. Bergamo,
Università degli Studi, 10-11 settembre 2008.
20
C. Ossola, Meditare, cioè medicare. L’arte di curarsi col pensiero, «Avvenire», 13 settembre 2008.
Meditazioni sacre / Meditazioni profane. Méditations sacrées / Méditations profanes. Convegno
organizzato dal Centro Humanitas della LUMSA. Roma, 12 settembre 2008.
21
F.V. Magrelli, Alla ricerca dell’infinito, «Corriere della Sera» (Roma), 10 settembre 2008.
Meditazioni sacre / Meditazioni profane. Méditations sacrées / Méditations profanes. Convegno
organizzato dal Centro Humanitas della LUMSA. Roma, 12 settembre 2008.
22
23
C. Ossola, Ombre grosse, «Il Sole 24 Ore», 10 Maggio 2009.
L’affascinante mostra che Victor Stoichita ha curato a Madrid prolunga e integra la sua Short
History of the Shadow (Londra 1997, trad. it.: Breve storia dell’ombra, Milano, Il Saggiatore, 2000
e 2007) e compie un percorso di ricerca tra i più rari e coerenti nella storia dell’arte: quello della
rappresentazione di ciò che “racchiude la forma” o la trascende: così nel suo precedente L’ invenzione del quadro (Milano, Il Saggiatore, 1998) studiava il progressivo affermarsi della “cornice”
come modo di individuare la presenza e l’autonomia del dipinto (rispetto alla coessenzialità con l’opera architettonica che, ad esempio, l’affresco aveva nella chiesa medievale). Così ancora in Cieli
in cornice: mistica e pittura nel secolo d’oro dell’arte spagnola (Roma, Meltemi, 2002) egli studia
la raffigurazione dell’irrapresentabile: la “visione” mistica; nel suo saggio, ad apertura di catalogo,
Apparizioni, ombre e limite del visibile, Stoichita, richiamando un passo di Marco (XVI, 12-13),
vede in esso uno dei fondamenti maggiori della quête che la pittura introduce negli atti di conoscenza: «Dopo di ciò, apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna» (duobus ex eis ambulantibus ostensus est in alia effigie). Non c’è dubbio che, nel confronto con gli altri Sinottici, si tratti dell’episodio di Emmaus: ma qui precisamente in quell’ «in alia effigie» l’interprete, con l’Evangelista, fa uscire per sempre la pittura dal dovere dell’imitatio, dal
sogno della perfezione, dal ‘miglioramento estetico’, per introdurla in quel luogo incerto, segnato
dall’ombra, che il Caravaggio porterà, a sua volta, all’estremo, «lasciando il rimanente in ombra, a
fine –scriverà il Bellori- di recar forza con veemenza di chiaro e di oscuro». Il percorso di Stoichita
partendo dal mondo rinascimentale arriva alla contemporaneità quando, nel «trattar l’ombre come
cosa salda» (Purg., XXI, 136), entra in scena la fotografia quale arte del fissar l’ombra, e persino
del rivelare -attraverso il negativo dell’ombra (come accadde a Secondo Pia nel 1898 per la Sindone
del Duomo di Torino)- l’invisibile all’occhio. La sua attenzione è particolarmente acuta quando egli
studia l’ “effetto” della fotografia sulla pittura, in particolare in Magritte e Dalí, ma anche della pittura sulla fotografia, la quale in molti autori tende a sua volta a fare dell’ombra non già un ‘riscontro’ o una ‘proiezione’ di forme, ma un’impregnazione di spazi, come nelle opere (squisitamente
attestate) di Ralph Steiner (1899-1986), di Francesc Català-Roca (1922-1998) o di Sam TaylorWood. Completa il volume una squisita antologia di testi letterari che meditano l’ombra, scelti con
gusto da Anna Maria Coderch; è come se Daniello Bartoli e Poe, Andersen e Borges, commentassero essi stessi, accompagnando il visitatore, l’ “effetto-ombra”. Tanto aveva saggiato, sino a
Philippe Jaccottet, il libro del compianto Max Milner, L’envers du visible. Essai sur l’ombre, Paris,
Seuil, 2005: «Nutrito d’ombra, io parlo / masticando magro pasto di tenebre» (La Semaison, 1959).
Più di tutti, Victor Hugo aveva compreso l’agone che allaccia e disgiunge, e consegna l’una all’altra l’ombra e la luce, la conoscenza alla cecità: «Diamo alla creazione il grande spettacolo / Di un
cieco abbacinato» (Pleurs dans la nuit). «Mascherare l’infinito di tenebra», ecco il compito che
Hugo affidava alle arti, non già per ridurlo, ma per renderlo presente e invisibile (Milner, p. 240): e
Milner coglie, in questo, la sapienza che Hugo ha posto nel rendere irriducibile la rappresentazione
del divino: nella tenebra e nell’ombra essa non sarà mai reificata, mai affievolita; The unending Gift
, come aveva scritto Borges nel suo Elogio dell’ombra, 1969: «Un pittore ci aveva promesso un quadro. Oggi, in New England, apprendo che è morto. […] Ho pensato a quello spazio prestabilito che
la tela non occuperà. Poi ho pensato: se fosse qui, sarebbe negli anni una cosa in più, una cosa, una
delle vanità di casa; ora invece è illimitata, incessante».
Così già era, nella lettura di Michelangelo, riserbo e dono, l’apologo di Nicodemo che di notte visita Gesù, il Nicodemo della Pietà ove l’umano cinge e s’arrende al divino. E non sarà dunque un
caso che Stoichita abbia iniziato la sua carriera di studioso, in Romania, proprio con un libro dedicato al «poeta della notte», Michelangelo, 1974. I due libri, i due uomini, Milner e Stoichita, la loro
storia di discreta civiltà e di esigente lectio, alla fine svelano, nel loro modo di procedere attraver-
24
so la “parte in ombra” dell’umano (entrambi avendo studiato La cena di Emmaus di Rembrandt),
ciò che il paradosso significa: non già un rovesciamento del senso atteso, ma l’attesa di un rovesciamento, di un’epifania che non è possibile invocare se non continuamente lavando, con acqua e con
fango, i nostri occhi.
La sombra [L’ombra], Esposizione e Catalogo [pp. 324, s.i.p.] a cura di Victor Stoichita, Madrid,
Museo Thyssen-Bornemisza, sino al 17 maggio 2009.
Da ricordare: Graham Clarke, La fotografia. Una storia culturale e visuale, Torino, Einaudi, 2009.
25
26
30 marzo-3 aprile 2009
RAI-Radio Tre
Antonella Anedda
Antonella Anedda, nata a Roma, lavora presso l'Università di Siena-Arezzo, dove si occupa di
mediazione linguistica.
Ha pubblicato le raccolte di poesie "Residenze invernali" (1992), "Notti di pace occidentale" (1999)
e "Il catalogo della gioia" (2003); i saggi "Cosa sono gli anni" (1997), "La luce delle cose" (2000)
e il libro di traduzioni "Nomi distanti" (1998). Di Philippe Jaccottet ha curato il volume "La parola Russia" (2004).
Ha collaborato per varie riviste e giornali come "Il Manifesto", "Linea d'ombra", "Nuovi
Argomenti".
Nel 2007 il suo ultimo libro di poesie, "Dal balcone del corpo" (Mondadori).
Ha scelto i libri:
Guerra e pace di Tolstoj
Poesie di Saffo
Operette morali di G. Leopardi
Ulisse di J Joyce
Poesie di E. Bishop
.
27
4 maggio-10 maggio
2009
RAI-Radio Tre
Corrado Bologna
Corrado Bologna insegna Filologia e linguistica romanza nella Facoltà di Lettere dell'Università di
Roma III. Si è occupato di teatrologia medio-latina e romanza, dei primi trovatori provenzali, di
Dante, di storia della tradizione manoscritta fra origini ed età moderna, dell'attività filologica intorno ai testi romanzi nel XVI secolo, del Romanzo di Alessandro, di C. E. Gadda e R. Longhi. Ha collaborato alla Letteratura Italiana Einaudi e pubblicato, fra l'altro, un'edizione commentata del Liber
monstruorum de diversis generibus (Milano, 1977); Tradizione e fortuna dei classici italiani
(Torino, 1994); Flatus vocis. Antropologia e metafisica della voce (Bologna, 1992, II ed. 2000); Il
ritorno di Beatrice. Simmetrie dantesche fra "Vita Nova", petrose e "Commedia" (Roma, 1998), La
macchina del Furioso. Lettura delle "Satire" e dell'"Orlando" (Torino, 1998). Ha scritto inoltre sulle
"figure" della Fortuna e degli Alberi della Vita e della Luce. Ha curato volumi di saggi di K. Kerény,
J. Starobinski, G. R. Cardona.
Ha scelto i libri:
I promessi sposi di A. Manzoni
Pedro Paramo di Juan Rulfo
La terra del rimorso di Ernesto De Martino
Poesie di Mandel'stam
Flamenca di Anonimo
28