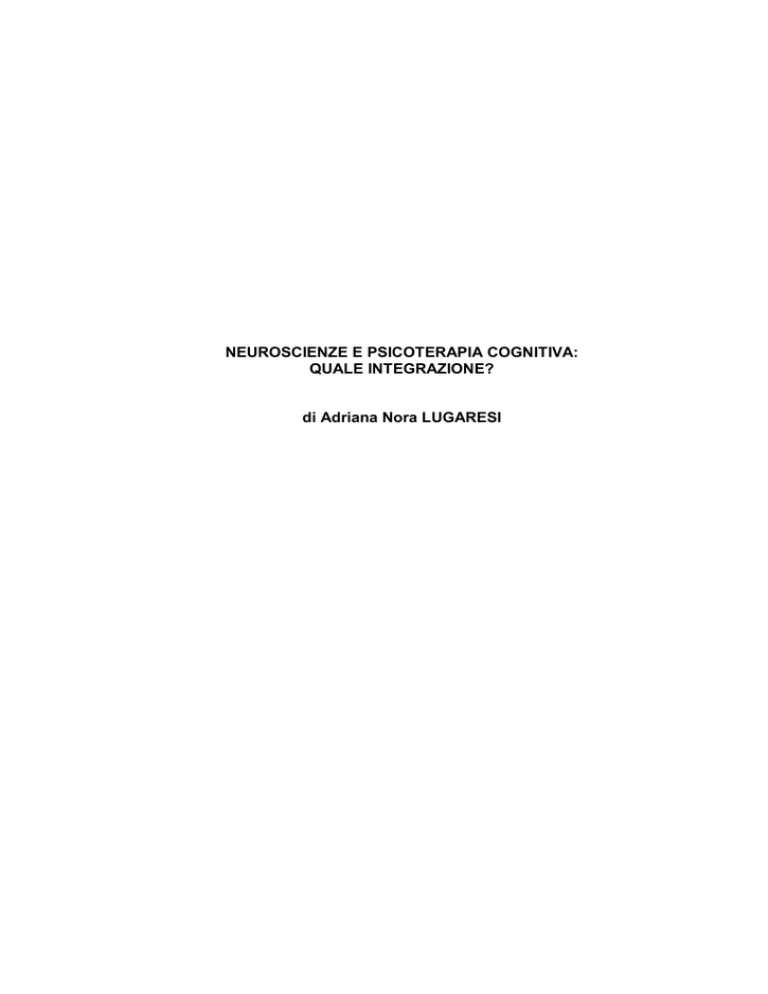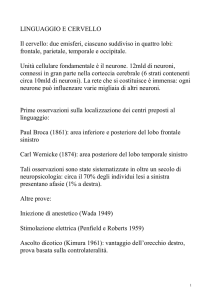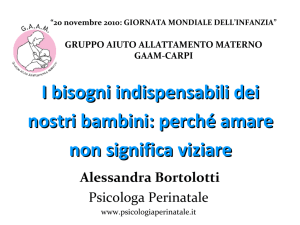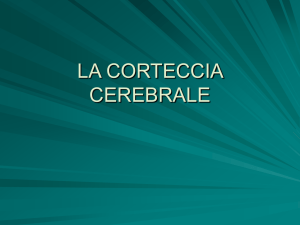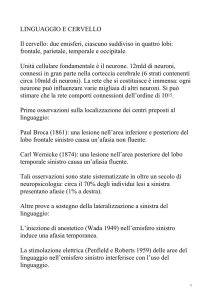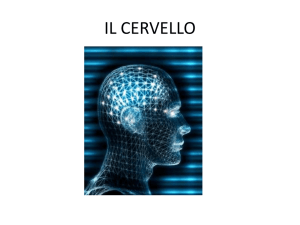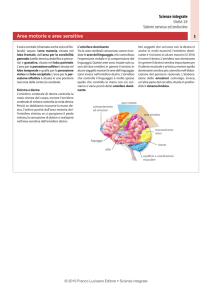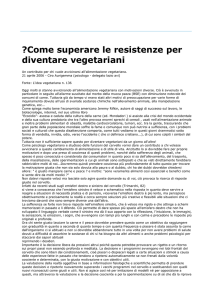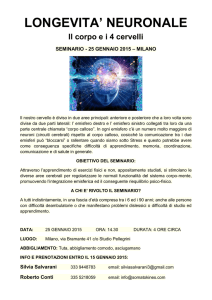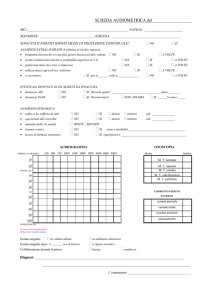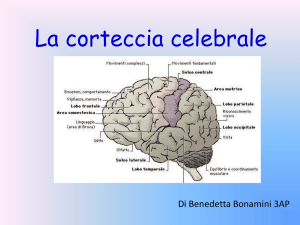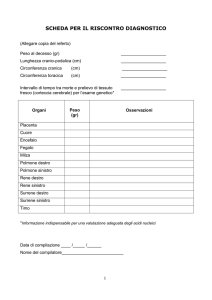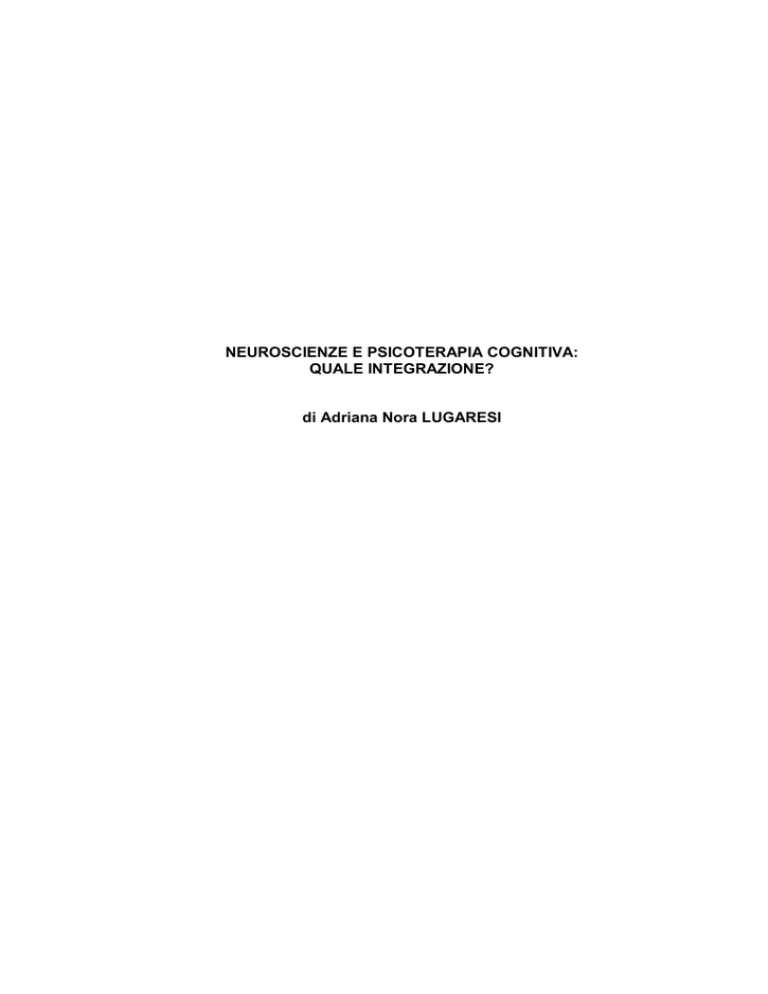
NEUROSCIENZE E PSICOTERAPIA COGNITIVA:
QUALE INTEGRAZIONE?
di Adriana Nora LUGARESI
INDICE
Introduzione
2
Perché prole inetta?
4
Geni e cervello
5
Come la mente si rappresenta il mondo
7
Cervello e lateralizzazione emisferica
8
Esperienza e specializzazione emisferica
11
Processi biochimici legati alla
sintonizzazione affettiva
13
Processi integrativi interemisferici
14
Neuroscienze e psicoterapia:
quali implicazioni?
16
Conclusioni
19
Appendice
22
-
Strutture corticali e sottocorticali
Sistemi specchio e di risonanza
Sistemi di riconoscimento ed espressione facciale
Sistemi di regolazione
Raffronto tra le caratteristiche della funzione S e D
Bibliografia
28
1
INTRODUZIONE
Mi ha sempre incuriosito capire come funziona il cervello umano anche perché,
considerata la professione che ho scelto, ritengo di non poter ignorare l‟organo che ci
rende unici rispetto alle altre specie e dal cui complesso intreccio neurale prende forma la
mente con le sue molteplici attività.
Siamo esseri senzienti e pensanti, capaci di grande ingegno ed umanità. Ma siamo anche
in grado di manipolare gli altri a nostro vantaggio, di ingannare, di fare del male, di
svincolarci moralmente (1).
Spiegare dunque l‟eterogenia del comportamento solo sulla base di disfunzioni cerebrali o
carenza/eccesso di neurotrasmettitori può risultare riduttivo ed irrispettoso. Ma è anche
certo che la mente, con le sue rappresentazioni, non può essere separata dalla base
biologica che dà energia e vita al suo funzionamento.
In tal senso, ritengo utile la seguente definizione: “Mente e cervello non sono due realtà
distinte, una più basilare dell’altra, e neanche due entità che si influenzano reciprocamente
tali per cui, da un lato, le rappresentazioni mentali modificano la biochimica e struttura
cerebrale mentre, dall’altro, la biochimica cerebrale determina le rappresentazioni mentali.
Mente e cervello sono una realtà unica e la differenza sta nel linguaggio, nel codice con
cui tale realtà unitaria viene descritta. Il linguaggio psicologico parla di rappresentazioni
mentali così come il linguaggio biologico di strutture, recettori e neurotrasmettitori: sono i
descrittori ad essere diversi e non la cosa descritta” (Lorenzini, Coratti, 2008) (2).
Nella stesura della presente tesina mi sono avvalsa dei contributi della scienza cognitiva
(3) che attua un progetto di ricerca comune tramite un aggregato multidisciplinare, tra i cui
componenti principali ritroviamo la psicologia cognitiva e le neuroscienze.
Il cognitivismo ha fornito validi modelli per spiegare le leggi di funzionamento del
comportamento ed i modi in cui la mente lo regola, in base agli scopi perseguiti. D‟altra
parte, gli studi sul cervello umano, dal livello molecolare a quello sociale, hanno fornito
interessanti indicazioni sulle modalità con cui gli stimoli ambientali possono influire, nelle
1
Per es., è provato che gli antisociali fanno più operazioni cognitive di svincolo morale rispetto ai soggetti
normali e ciò non per un deficit della teoria della mente o per mancanza di empatia.
2
“La paura può essere descritta come una reazione adrenergica che modifica in modo misurabile una serie
di parametri biologici ed altrettanto correttamente può essere definita come la previsione di una pericolo; la
tristezza è a un tempo la percezione della perdita di qualcosa di importante e l‟abbassamento dei livelli di
serotonina. La paura passerà tanto bloccando gli effetti dell‟adrenalina quanto modificando la percezione di
pericolo: i due fatti avvengono contemporaneamente, sono anzi la stessa cosa. Se modifico la percezione di
pericolo, l‟adrenalina diminuisce e, viceversa, se abbasso l‟adrenalina si attenua la percezione di pericolo.
Se innalzo i livelli di serotonina, la tristezza si attenua e scompare, se attenuo l‟idea di perdita di qualcosa di
importante la serotonina si alza”. (Lorenzini, Coratti, 2008).
3
Con questo termine ci si riferisce a sei discipline specifiche: intelligenza artificiale, psicologia cognitiva,
neuroscienze, linguistica, antropologia e filosofia.
2
varie fasi di vita, non solo sull‟apprendimento e sulla costruzione di significati, ma anche
sulla struttura e sul funzionamento delle diverse aree cerebrali (4).
Il concetto di plasticità cerebrale (5) va quindi inserito in un quadro prospettico più ampio,
legato alla possibilità dell‟individuo di costruire, nell‟arco dell‟esistenza, una sua unicità e
specificità attraverso la complessa interazione tra natura e cultura, ossia tra il suo
patrimonio genetico e le sue esperienze relazionali e di vita (Kandel, 1998, Siegel, 1999;
Ansermert, Magistretti, 2008). L‟effetto che gli eventi ambientali possono produrre a livello
della trascrizione genica porta a considerare il cervello come un organo estremamente
dinamico (Kandel, 1998 e 2005; Gabbard, 2000 e 2005), non più irrimediabilmente
destinato a perdere funzionalità con il trascorrere dell‟età.
Ne deriva la visione di un individuo in continuo divenire, almeno in potenza, e ciò induce a
non trascurare il ruolo svolto dai
meccanismi genetici ed ambientali all‟interno del
funzionamento normale e psicopatologico nonché sulle possibilità di cambiamento. Forse
in futuro sarà inevitabile una maggiore ricaduta sul piano clinico, sul modo in cui si
formulano le diagnosi (Mundo, 2009), si pianificano gli interventi e si valutano gli esiti del
trattamenti.
Lo sviluppo della psicologia clinica come scienza dovrebbe prevedere l‟integrazione di
quei paradigmi neuroscientifici che possono ampliare le conoscenze sulla mente e sul
comportamento, senza ovviamente tralasciare il ruolo delle variabili indipendenti che lo
regolano e nulla togliendo alla comprensione della specificità dell‟individuo, anche in base
al suo bilancio scopistico. Una prospettiva neurocognitiva ben formulata potrebbe
permettere di spiegare un‟architettura generale della mente umana e magari fornire un
modello, scientificamente basato, che contribuisca a chiarire il problema della coscienza,
che il cognitivismo in gran parte ha accantonato, avendo avuto come maggior oggetto di
studio l‟elaborazione mentale. Certamente questo è un limite che ha necessità di essere
superato (Castelfranchi, 2006) (6).
4
Il cervello effettivamente apprende cose diverse utilizzano strutture differenti. Per es., una forma implicita di
apprendimento, è il condizionamento alla paura, mediato dall‟amigdala (V. Appendice). La memoria di lavoro
viene informata di quel che accade e, se è rilevante, la funzione esecutiva disporrà l‟immagazzinamento
dell‟informazione nel sistema della memoria esplicita. In un momento successivo saremo in grado di
richiamare intenzionalmente quegli aspetti dell‟esperienza vissuta, colorandoli dei significati che abbiamo
loro attribuito in base al nostro sistema mentale e scopistico.
5
Molti sistemi cerebrali sono plastici, vale a dire modificabili attraverso l‟esperienza. In mancanza di ciò non
sarebbe possibile imparare.
6
Possiamo dire che la norma dei processi psichici consiste in circa il 99% di elaborazione dell‟informazioni
sottostanti, tacite, silenti ed inaccessibili in linea di principio a qualsiasi coscienza ed introspezione. Questo è
l‟inconscio cognitivista. Il cognitivismo ha vinto perché ha detto che il nostro oggetto di studio non è la
coscienza ma le elaborazioni mentali. Ma non ha dato dei modelli della coscienza (Castelfranchi, 2006).
3
PERCHE’ PROLE INETTA?
L‟essere umano viene al mondo con un cervello immaturo. Necessita di una totale
dipendenza dalle figure di riferimento e di un lungo periodo di sviluppo. I riflessi del tronco
encefalico e l‟attività del sistema limbico organizzano inizialmente la maggior parte delle
esperienze del bambino. In seguito, subentrerà un maggior controllo corticale con la
formazione di circuiti neurali di crescente efficacia e stati di attivazione sincroni.
La qualità del processo di sviluppo è in relazione al tipo di esperienze vissute, le quali
possono favorire o meno un processo di apprendimento ed un incremento di conoscenza,
intesa come la costruzione di mappe sempre migliori di se stessi e dell‟ambiente
(l‟individuo come attivo costruttore del mondo e di sé nonché solutore di problemi) (Kelly,
1995; Lorenzini, Sassaroli, 1995). Necessitiamo di un lungo periodo di neotenia proprio
perché la relazione con il genitore fornisce la base per l’acquisizione e l’incremento delle
possibilità conoscitive processo di automotivazione e attiva costruzione di scopi e mete
(Lorenzini, Sassaroli, 1995) (7). Le esperienze interpersonali precoci possono così influire
non solo sui pattern di attaccamento (Bolwby, 1969, 1973, 1980, 1988) ma anche sugli stili
di conoscenza (attaccamento sicuro ricerca attiva; insicuro-evitante immunizzazione;
insicuro-resistente evitamento; disorientato-disorganizzato ostilità) (Lorenzini,
Sassaroli, 1995).
In linea con tale prospettiva, Siegel (2009) sostiene che il malessere scorre tra la sponda
della rigidità da un lato e quella del caos dall‟altro, ossia tra la tendenza a chiudersi in
modo pregiudiziale a nuove esperienze e tra quella di aprirsi caoticamente ed in modi non
di tipo integrativo. La possibilità di attivare un processo di integrazione, flessibile, adattivo,
coerente e stabile è alla base del benessere, il quale può essere inteso come l‟armoniosa
capacità di integrare l‟ignoto con il noto.
La teoria dell‟attaccamento (Bowlby, 1969, 1973, 1980, 1988) si è poi arricchita con le
ricerche sullo sviluppo del cervello sociale (V. Appendice), realizzate nell‟ambito di quelle
che possiamo definire le neuroscienze delle emozioni (Schore, 1998, 1999, 2000) (Ardino,
Sassaroli, Lorenzini, 2006). Si è visto, inoltre, che il processo di sintonizzazione affettiva
(Trevarthen, 1990, 1993; Ardino, Sassaroli, Lorenzini, 2006) tra madre-bambino
(comunicazione socioemotiva) influisce positivamente sull‟espressione genica, la quale
favorisce l‟organizzazione del cervello, la plasticità neuronale ed i processi di neurogenesi.
7
La crescita cerebrale, che avviene nella vita extrauterina, fortemente influenzata dall‟ambiente, permette
all‟essere umano di svincolarsi dalla rigidità del suo patrimonio istintuale, biologico e genetico, per garantirsi
una migliore sopravvivenza ed esistenza.
4
GENI E CERVELLO
Subito dopo il concepimento il codice genetico guida la crescita e l‟organizzazione delle
cellule nervose. Successivamente, la trascrizione genica (Kandel, 1989, 1998, 2005; Hur e
Bouchard, 1995; Feinberg, 2001, 2006; Higgins, 2008) controllerà gli aspetti della crescita
e della organizzazione cerebrale dipendenti dall‟esperienza e dallo sviluppo.
Natura ed educazione contribuiscono così alla costruzione del cervello tramite le funzioni
di stampo e di trascrizione dei nostri geni. Vari studi indicano come le esperienze possono
influire in modo significativo sull‟espressione del potenziale genetico attraverso la sintesi
proteica (Benedersky, Lewis, 1994; Rakic et al., 1994; Goldsmith et al., 1997; Rutter et al.,
1997; Post e Weiss, 1997; Andreasen, 1997; Marcus, 2004; Kandel, 1989, 1998, 2005;
Higgins, 2008), contribuendo all‟incremento di circuiti neurali ed alla formazione di nuove
sinapsi (8). In questo modo l‟apprendimento modella e rimodella il nostro cervello.
I processi di sviluppo cerebrale e di crescita della conoscenza non vanno però considerati
come il risultato di componenti unicamente genetiche così come sarebbe altrettanto errato
farli risalire esclusivamente alle esperienze (Kagan, 1992; Nelson, 1994; Hur e Bouchard,
1995; Kandel, 1998).
Nello sviluppo del cervello del bambino, il mondo sociale rappresenta ovviamente la fonte
principale delle esperienze che influenzano l‟espressione genica ed i processi che
conducono alla maturazione dei collegamenti neuronali su cui si basano le attività della
mente. A loro volta, le attività della mente possono portare a variazioni fisiologiche
cerebrali che inducono l‟espressione di geni diversi. Un esempio molto chiaro di questo
tipo di meccanismi è fornito dalla risposta a situazioni di stress, associata alla secrezione
di ormoni corticosteroidi che hanno effetti diretti sull‟espressione genica (Post, Weiss,
1997; Schore, 1997, 1998; Kandel, 2005) (9).
Altre ricerche (Higgins, 2008; Tsankova et al., 2007) dimostrano che le esperienze vissute
nel corso della vita possono letteralmente “cambiare la testa” di una persona.
Un‟esperienza traumatica, l‟uso di stupefacenti, la mancanza di affetto possono agire in
modo che certe molecole si leghino al DNA di un individuo, senza toccare la sua sequenza
codificante. Questi annessi molecolari alterano l‟attività genetica, fermando o avviando la
8
Per es., con una ripetuta stimolazione si verifica una risposta maggiore sensibilizzazione. Ciò è
correlato, nel breve termine, con un aumentato rilascio di neurotrasmettitori. Nel lungo termine, l‟esposizione
ripetuta alla stimolazione, attiva geni presenti nel nucleo che trascrivono nuove proteine e stimolano la
crescita di nuove sinapsi. E‟ un esempio non solo di come il cervello cresca in risposta all‟ambiente ma
anche di come quest‟ultimo influenzi l‟espressione del genoma.
9
Attraverso questi meccanismi, processi psiconeuroendocrini che si verificano nel corso di periodi critici
precoci, possono dare origine ad effetti permanenti a livello genomico che influiscono sullo sviluppo dei
circuiti cerebrali (Schore, 1997, 2000).
5
costruzione di proteine che possono avere una ricaduta sul funzionamento mentale di un
individuo (10).
Ma geni ed esperienze interagiscono in modo complesso. Per es., il temperamento del
bambino può provocare determinate risposte nei genitori o nell‟ambiente. Tali reazioni
rappresentano per il bambino esperienze che possono influenzare lo sviluppo del cervello
e la costruzione di significati. In un certo senso, è il bambino stesso che va a determinare
il tipo di stimoli esperienziali cui la sua mente dovrà adattarsi. Allo stesso modo, il
comportamento genitoriale può influire positivamente sullo sviluppo dei bambini con
caratteristiche costituzionali di iperreattività (Kagan, 1994, 1998) (11).
Alcuni studi riferiscono che circa il cinquanta per cento dei tratti di personalità sono
attribuibili a fattori ereditari, mentre l‟altra metà ad aspetti dell‟ambiente “non condiviso”,
sia familiare che extrafamiliare (come le relazioni con i nonni, i fratelli, i coetanei e le
esperienze scolastiche) (Plomin, 1990; Pike, Plomin, 1996). Fratelli (anche gemelli
monozigoti) cresciuti insieme possono sperimentare esperienze relazionali diverse e
quindi un ambiente “non condiviso”, dato che il comportamento dei genitori o di altre figure
significative nei loro confronti non è identico (Plomin et al., 1991; Dunn, McGuire, 1994)
(12). Le intricate interazioni tra geni ed esperienze portano così ad amplificare le differenze
individuali iniziali, anche nei bambini che crescono nello stesso ambiente familiare.
Lo sviluppo, comunque, è un processo che continua nel tempo e l‟individuo può crescere e
cambiare, malgrado eventuali esperienze precoci non ottimali. In tal senso, un
attaccamento insicuro non va visto come un fattore che inevitabilmente porterà allo
sviluppo di psicopatologia, ma che può aumentare il rischio di disfunzioni psicologiche e
sociali (Carlson, Sroufe, 1995; Rosenstein, Horowitz, 1996; Atkinson, Zucker, 1997;
Zeanah, 1997; Solomon, George, 1999; Sroufe, 2000; Fonagy, 1996, 2001; Fonagy et al.,
2002, Attili, 2007) (13). Gli studi su bambini con attaccamento sicuro evidenziano, invece,
lo sviluppo di capacità emotive, sociali e cognitive nei soggetti analizzati (Attili, Vermigli,
Felaco, 1994; van Lange et al., 1997; Thompson, 1999; Attili, 2007).
10
Per es., l‟uso prolungato di droghe attiva la proteina Delta Fos B, che induce lo sviluppo di ramificazioni
dendritiche connesse all‟uso di sostanze (per cui l‟esperienza di droga resta nel cervello tutta la vita).
11
Questi bambini possono presentare risposte fisiologiche eccessive di fronte a stimoli ambientali,
soprattutto se connotati da novità. I genitori che li incoraggiano all‟esplorazione favoriscono la strutturazione
di atteggiamenti meno timorosi nei confronti del mondo, contribuendo inoltre a fornire connotazioni
alternative.
12
Impiegando un modello complesso costituito da fattori “di condivisione” e “di non condivisione”, gli autori
hanno riportato che gran parte delle variazioni osservate tra fratelli è dovuta alla seconda categoria di
esperienze.
13
In bambini con attaccamento evitante spesso si osservano grosse difficoltà nei rapporti con i pari (Attili,
2007). Attaccamenti disorganizzati/disorientati correlano con la tendenza a stati dissociativi, disturbi
dell‟attenzione e nella regolazione delle emozioni (Solomon et al., 1995, Ogawa et al., 1997; Carlson, 1998).
6
Infine, non va dimenticato che il bambino costruisce le sue credenze su se stesso e sul
mondo anche apprendendole direttamente dal genitore (Lorenzini, Sassaroli, 1987, 1995).
Così come ripetute ed intense esperienze, spesso precoci, possono generare una forma di
apprendimento sulla base di situazioni e risposte che si presentano insieme. La riposta, in
tal caso, dipende dal significato individualmente ravvisato nella situazione. Oppure un
insieme di situazioni possono evocare tutte la stessa risposta (classe di stimoli
equivalenti). Oppure si possono derivare delle regole ulteriori da determinate esperienze
sia perché è risultato efficace e sia perché condiviso, anche linguisticamente, dal gruppo
di appartenenza (Mosticoni, 1984, 2006, 2008).
COME LA MENTE SI RAPPRESENTA IL MONDO
I rapporti interpersonali e le modalità di apprendimento hanno dunque un‟influenza
fondamentale sullo sviluppo del cervello e sulla costruzione della mente. Del resto, i circuiti
che mediano le esperienze sociali sono correlati a quelli responsabili dell‟integrazione dei
processi che controllano la regolazione dell‟organismo, la modulazione delle emozioni,
l‟attribuzione di significati, la capacità comunicativa e la rappresentazione mentale (Il
cervello sociale, V. Appendice).
La mente può essere correttamente definita come un sistema che non accidentalmente,
ma funzionalmente, immette energia nel mondo e ne riceve informazioni (Castelfranchi,
1999, 2006; Castelfranchi et al., 2002). Affinché tale sistema abbia una vera condotta ed
esplichi un‟azione occorre, quindi, che non solo guardi ciò che c‟è nel mondo ma anche gli
effetti di ciò che produce nel mondo. Solo un sistema che percepisce i cambiamenti che
sta producendo, ossia gli effetti nel mondo, può guidare l‟azione verso un certo risultato.
Quindi ciò presuppone che ci sia una rappresentazione interna del mondo ed una
rappresentazione che orienta e guida l‟azione, che anticipatoriamente indica in che
direzione procedere (14). In sintesi, la caratteristica principale di una vera attività mentale è
la costruzione di rappresentazioni interne e la probabilità anticipatoria. Ma “anticipare”
significa rappresentarsi quel che sta per accadere ma che ancora non è accaduto e che,
quindi, ancora non si percepisce. L‟individuo costruisce una rappresentazione percettiva
del mondo che i tempi ancora non trasmettono, senza stimolo. Questa è una capacità
prodigiosa: un‟entità che si costruisce una rappresentazione da sé, senza percezione e
senza stimolo in quanto esso deve ancora arrivare. La mente, dunque, è la capacità di
14
La mente, costruisce, mantiene ed usa rappresentazioni interne del mondo per guidare l‟azione verso un
obiettivo predeterminato, ossia per dare un fine al comportamento.
7
costruire endogenamente, e non sulla base di un input percettivo, rappresentazioni del
mondo. In tal senso, consiste nella capacità di costruire rappresentazioni di come il mondo
non è, non di come è (15). Su questa base nasce poi la necessità di rappresentarsi degli
scopi riguardo quello che il mondo si vuole che sia o che diventi e che di solito appunto
non è. Per questo lo si inventa, lo si immagina e si costruiscono rappresentazioni di come
il mondo non è (16). A che serve tutto questo? Solo così è possibile guidare la condotta ed
il mondo verso un certo risultato atteso, quindi immaginato.
Per un sistema rigido, la difficoltà a raggiungere lo scopo può costituire un bel problema,
qualora la risoluzione automatica o la pratica abituale non funzionino più. In tal senso, la
resistenza a cambiare i propri schemi di fronte ad evidenti fallimenti nel perseguimento dei
propri scopi (tendenza all‟assimilazione e non all‟accomodamento) è alla base della
vulnerabilità (17) alla psicopatologia.
Ma al di là dell‟aspetto funzionale (prevedibilità, controllo e comportamento finalizzato),
quali sono gli aspetti strutturali del cervello umano che predispongono (e favoriscono) tale
specifica modalità di elaborazione delle informazioni e costruzione fallace della realtà?
Potremmo inoltre chiederci se la rigidità, o la non flessibilità, possano essere frutto di
modalità non integrate di funzionamento cerebrale, sia a livello intra che interemisferico,
considerando in tal senso le differenze funzionali tra i due emisferi cerebrali.
CERVELLO E LATERALIZZAZIONE EMISFERICA
Siamo una specie altamente evoluta, in grado di attuare una vasta gamma di relazioni
complesse e di varia natura: possiamo cooperare, competere, scambiare informazioni,
costruire teorie sul funzionamento della nostra mente e su quella altrui. Una sofisticata
rete di meccanismi neurocognitivi ci rende unici nelle nostre espressioni più umane ed
evidenzia le peculiarità del nostro “cervello sociale” (Frith, 1999; Adolphs, 2003; Siegel,
1999, 2009; Cozolino, 2006; Kandel, 2005; Gazzaniga, 2008) (V. Appendice).
Se osserviamo il cervello nella sua globalità non possiamo fare a meno di notare le sue
due parti, divise e collegate tra di loro dal corpo calloso. Fin dalla nascita si osservano
delle differenze e delle caratteristiche funzionali.
15
Si tende così a cambiare il mondo reale con l‟azione per renderlo uguale a qualcosa che si è costruito
endogenamente.
16
In tal senso la mente umana non tende alla logica, è uno strumento pratico, serve ad evitare condizioni
avversive e ad ottenere condizioni desiderabili. Serve, cioè, a prevedere e controllare.
17
La vulnerabilità è un intreccio tra fattori biologici (per es., aspetti genetici, virali, traumatici) e fattori
psicologici, primi fra tutte le esperienze precoci nella relazione di attaccamento (Lorenzini, Coratti, 2008).
Anche gli stress sono sia biologici (per es. droghe, intossicazioni) che psicologici (per es., lutto, fallimenti).
8
Nei primi diciotto mesi di vita l‟emisfero destro sembra crescere di più, in concomitanza
con l‟aumento di competenze motorie e sensoriali. Le connessioni al suo interno
costruiscono le strutture di base dell‟attaccamento e della regolazione emozionale
(Schore, 1994) (18).
L‟emisfero sinistro cresce più lentamente fino al secondo anno di vita, quando si
incrementano le capacità linguistiche e locomotorie. Tutto ciò spinge verso l‟esplorazione
del mondo fisico e sociale. In tale periodo, all‟interno dei lobi frontali (V. Appendice), lo
sviluppo si sposta dalle aree orbitomediali verso quelle dorsolaterali, che si collegano alle
regioni corticali del linguaggio (Gould, 1977; Tucker, 1992).
Il corpo calloso, che connette i due emisferi, inizia a svilupparsi verso la fine del primo
anno, permettendo l‟integrazione delle capacità semantiche dell‟emisfero sinistro con le
reti emozionali e somatiche dell‟emisfero destro. La maggiore integrazione tra le due parti
del cervello favorisce una graduale cooperazione nell‟analisi, globale (destro) e specifica
(sinistro) dell‟ambiente circostante (19).
In condizioni adeguate, tutte queste reti si integrano per fornire l‟esperienza di un mondo
interno coerente e sicuro. L‟asimmetria tra i due emisferi cerebrali riguarda anche le
strutture sottocorticali ed il tronco encefalico (20) (V. appendice).
Emisfero destro
L‟emisfero destro è non verbale, olistico, visuospaziale. E‟ caratterizzato da specialità
come la memoria autobiografica, una mappa integrata di tutto il corpo, emozioni
spontanee (21), risposta empatica non verbale, modulazione dello stress e stati di allerta
dell‟attenzione. Media rappresentazioni che si riferiscono a sensazioni, immagini (22),
significati non verbali delle parole (comprensione di metafore, paradossi e contenuti
umoristici del discorso).
La corteccia orbitomediale (V. Appendice) è più ampia nell‟emisfero destro. Dotata di
ricche connessioni con le reti sottocorticali (dell‟apprendimento, della memoria,
dell‟emozione), si collega al corpo regolandone il tono vagale ed il funzionamento dell‟asse
ipotalamo-ipofisi-surrene (Price, 1999; Porges, 2003) (V. Appendice). La parte destra
18
I bambini che vanno incontro a gravi esperienze di deprivazione emotiva in questo periodo sono ad alto
rischio di alterazioni delle componenti strutturali dell‟emisfero destro (Schore, 1997).
19
Il motivo della specializzazione emisferica va rintracciato nella differente modalità di elaborazione delle
informazioni: la corteccia sinistra si presta meglio ad analizzare aspetti temporo-sequenziali delle
informazioni identifica più prontamente dettagli e rileva precise caratteristiche (vantaggio nelle funzioni
specializzate del linguaggio, dei rapporti causa/effetto e nella motilità fine). La corteccia destra risulta
superiore nell‟analisi degli aspetti globali, di relazione generale delle informazioni (individua più facilmente il
contesto e fornisce un quadro generale della situazione più vantaggio nell‟elaborazione delle interazioni
sociali, dell‟esperienza emotiva e dei compiti visuo-spaziali.
20
La corteccia destra è più densamente connessa alle regioni sottocorticali della sinistra.
21
Basate su un pattern match immediato. Come per lo spavento: c‟è prima la risposta affettiva e poi quella
valutativa.
22
Le immagini mentali obbediscono ai principi della percezione (per ruotare mentalmente un‟immagine
tridimensionale, occorre lo stesso tempo se lo si fa manualmente).
9
sembra quindi maggiormente implicata sia nell‟integrazione degli stati del corpo, sia nella
regolazione del sistema nervoso autonomo (Porges et al., 1994; Schore, 2000b, 2000d) e
sembra svolgere un ruolo centrale nei meccanismi che ci consentono di esprimere ed di
essere consapevoli delle nostre esperienze emotive. Questi sistemi, esperienzadipendenti, vengono costruiti nell‟infanzia attraverso la sintonizzazione e la connessione
dell‟emisfero destro del genitore con l‟emisfero destro del figlio (Siegel, 1999; Schore,
2000b). L‟emisfero destro non solo è coinvolto nell‟elaborazione delle emozioni con
funzioni di facilitazione nella formazione dei legami di attaccamento e di regolazione degli
stati affettivi (Schore, 1994, 1996, 1998a), ma controlla anche le funzioni vitali necessarie
per la sopravvivenza, come le strategie di coping deputate a gestire lo stress (Wittling,
Schweiger, 1993; Wittling, 1997).
Varie esperienze di apprendimento vengono organizzate e immagazzinate nelle reti
dell‟emisfero destro, dando origine a ciò che chiamiamo “sensazioni viscerali”. Ciò che è
forse più significativo è che la parte destra risponde a stimoli emozionali negativi prima
della consapevolezza cosciente. L‟elaborazione emozionale sottostante, basata sul
esperienze passate, può così guidare, a nostra insaputa, i nostri pensieri, sensazioni,
comportamenti (Kimura et al., 2004).
Emisfero sinistro
Gazzaniga et al. (1996, 2009) individuano nell‟emisfero sinistro il principale responsabile
del ragionamento “sillogistico” (23), in cui la mente ricerca cause e spiegazione di eventi e
raggiunge conclusioni sulla base di un limitato numero di informazioni (24).
Per tale ragione è stato definito il “grande interprete”, responsabile dei processi cognitivi
che cercano di spiegare e prevedere gli eventi. L‟interprete elabora le informazioni in
ingresso e le mette insieme in una storia che ha senso, anche se completamente
sbagliata. Costruisce così teorie per assimilare le informazioni percepite in un insieme
comprensibile, ma può peccare di poca accuratezza. L‟emisfero destro non ha alcuna
tendenza ad interpretare gli eventi, massimizza le informazioni e ne mantiene una traccia
accurata, lasciando così l‟emisfero sinistro libero di elaborare e costruire inferenze (25).
La parte sinistra del cervello è il centro del processing logico, lineare, linguistico.
L‟elaborazione delle informazioni avviene in forma sequenziale: una rappresentazione
conduce ad altre rappresentazioni tra di esse collegate. Sembra incapace di leggere i
segnali sociali o emozionali non verbali trasmessi dagli altri. Tuttavia essa è in grado di
mediare le norme sociali che regolano l‟espressione emozionale e di valutare complesse
situazioni sociali (Zaidel et al., 1995).
I processi emozionali vanno comunque considerati come una parte fondamentale
dell‟attività di entrambi gli emisferi (26) e non limitati ad un lato o ad un‟area specifica del
cervello.
In tal senso, la mente è creata dall‟insieme delle attività del cervello ed entrambi gli
emisferi contribuiscono a realizzare un processo integrativo.
23
Spesso però non ragioniamo per sillogismi (ossia con la logica) ma costruendo modelli mentali.
L‟emisfero destro non avrebbe questa esigenza di spiegare in quanto “vede” le cose come sono, con
minime alterazioni (Gazzaniga, 1995 e1996).
25
Una inferenza è la capacità di generare conoscenza da conoscenze precostituite nella propria mente. Le
ricerche dimostrano che nel trarre inferenze gli esseri umani compiono errori sistematici e che gli individui
patologici ricorrono alle euristiche più di quanto facciano i soggetti normali in quanto si percepiscono in
condizioni di emergenza e valutano la ricerca di ulteriori informazioni pericolosa, troppo costosa o inutile
(Mancini, Gangemi, 2002).
26
Il cognitivismo si è focalizzato sul fatto che le emozioni si basano o no su una valutazione cognitiva
dell‟evento. Ha lasciato così le emozioni in un capitolo a parte, senza spiegare un‟architettura generale della
mente umana e come le emozioni entrano nella percezione, nella memoria, nel linguaggio, nel pensiero.
24
10
Emisfero sinistro
Emisfero destro
Preferenze emisferiche generali
Cognizione
Emozione
Semantica
Prosodia/Gesticolazione
Capacità astratte
Regolazione somatica
Analisi dettagliata
Analisi globale
Senso dell‟umorismo /mania Tristezza / depressione
Attivazione moderata
Alti livelli di attivazione
Preferenze emisferiche del cervello sociale
Avvicinamento
Legame / affiliazione
Evitamento
Consapevolezza dell‟altro
Autoconsapevolezza
Emozioni sociali
Emozioni personali
Affetto positivo
Affetto negativo
Lettura delle espressioni facciali
Lettura della direzione dello sguardo
Riconoscimento facciale
Intonazione
Stuss, Alexander (1999), Lattner et L. (2005), Cutting (1992), Shapiro et al. (1997), Rossion et al. (2000), Henriques,
Davidson (1991), Schiffer et al. (1995), Sutton, Davidson (1997), Keenan et al. (1999, 2000), Platek et al. (2004),
Dimberg, Petterson (2000), Hugdahi et al. (1989), Johnsen, Hugdahi (1991), Hugdahi (1996), Mandal, Ambady (2004),
Ricciardelli et al. (2002), Watanabe et al. (2002), Platek et al. (2004).
ESPERIENZA E SPECIALIZZAZIONE EMISFERICA
Secondo alcuni ricercatori esistono delle finestre di opportunità, ossia periodi all‟interno dei
quali l‟attivazione di funzioni specifiche è fondamentale per lo sviluppo delle aree
implicate. Bambini che nei primi anni di vita non sono esposti ad un linguaggio parlato
possono perdere la capacità di acquisire normali funzioni linguistiche (Schuman, 1997).
Bambini che non hanno relazioni di attaccamento prima della fine del terzo anno di età
possono trovare difficoltà a formare attaccamenti nel corso della vita (Bowlby, 1988; Colin,
1996). Se nei primi tre anni di vita un bambino non ha avuto frequenti “momenti di
risonanza” (27), in cui il suo emisfero destro poteva sintonizzarsi con quello del genitore, è
possibile che ciò determini un ridotto sviluppo delle funzioni di questo emisfero (28). Così
come l‟emisfero sinistro deve essere esposto a linguaggio verbale per svilupparsi in modo
corretto, è possibile ipotizzare che la maturazione dell‟emisfero destro richieda una
stimolazione emozionale da parte dell‟ambiente.
27
I neuroni specchio giocano un ruolo basilare nella risonanza emotiva (V. Appendice).
Comunicazione non verbale, tono della voce, espressioni del viso, condivisione emotiva sono fattori
essenziali per lo sviluppo dell‟emisfero destro (Siegel, 1999).
28
11
Trevarthen (1993) afferma che lo sviluppo cerebrale dipenda dalle interazioni “cervellocervello” nella cornice di una relazione sicura di attaccamento. Tale ipotesi viene
avvalorata dalle neuroscienze dello sviluppo che sottolineano come la qualità
dell‟attaccamento abbia un impatto positivo sull‟emisfero destro del cervello infantile (Ryan
et al., 1997; Perry, 2001) (29). A sua volta, l‟emisfero destro del caregiver si attiva per
fornire condivisione emotiva, conforto, protezione (Henry, 1993; Schore, 1994, 1999a,
1999b; Shapiro et al., 1997; Siegel, 1999; Wang, 1997) (30).Tale modello psicobiologico
suggerisce che “l‟attaccamento sicuro è connesso allo sviluppo di un sistema regolatorio
efficiente dell‟emisfero destro, così come, specularmente, un attaccamento insicuro, se
non addirittura traumatico, si lega ad un funzionamento non adattivo dell‟emisfero destro”
(Ardino, Sassaroli, Lorenzini, 2006).
Per Fonagy (1991, 2001) la metacognizione è predisposta biologicamente ed emerge
spontaneamente se non viene inibita per mancanza di un attaccamento sicuro e per
esperienze di maltrattamento (Fonagy, 1996, 2001, 2002). La paura della mente dell‟altro
può compromettere lo sviluppo di una teoria della mente matura ed evoluta, nonché i
processi di monitoraggio metacognitivo, provocando effetti drammatici, e difficilmente
reversibili (spontaneamente), sulle relazioni sociali.
Le ricerche della Main (1991) evidenziano che l‟attaccamento è, a sua volta, influenzato
dalla qualità della metacognizione nei genitori, per cui essa potrebbe essere un indice
predittivo dell‟attaccamento e della qualità delle relazioni genitori/figli. Appare infatti
essenziale per lo sviluppo nel bambino di un concetto di sé come essere intenzionale, che
i genitori pensino a lui come essere pensante. Altri autori avevano già messo in risalto
l‟importanza di considerare il bambino come dotato di sentimenti, credenze, desideri
(Winnicot, 1965, 1971; Stern, 1985, Bion, 1962).
Una relazione caratterizzata da sintonizzazione affettiva favorisce l‟attivazione bilaterale
del cervello degli individui interagenti: a) tra i loro emisferi sinistri attraverso comunicazioni
verbali, logiche e lineari; b) fra i loro emisferi destri attraverso la comunicazione non
verbale (espressioni del viso, tono della voce, gestualità). E‟ in questo modo che il cervello
del bambino viene stimolato a sviluppare la sinergia interemisferica, capacità integrative
autonome (Siegel, 1999) ed attività mentali di ordine più elevato.
29
“Uno stile genitoriale supportante facilita l‟attivazione dei sistemi corticali e subcorticali del cervello destro
coinvolti in continue modulazioni emotive” (Ryan et al., 1997).
30
In questo senso avviene una sincronia biologica tra organismi provata anche a livello fisiologico: alla
stimolazione tra madre e bimbo corrisponde un battito cardiaco accelerato, mentre al sorriso di uno dei due
corrisponde una decelerazione.
12
Nelle relazioni caratterizzate da una mancanza di linguaggio emozionale la comunicazione
e la condivisione affettiva sono spesso assenti. Tali interazioni possono risultare mediate
da una logica eccessiva o da rigidi schemi mentali. In questi casi, è in genere presente
una dissociazione fra espressione affettiva (emisfero destro) e comunicazione verbale
(emisfero sinistro), che può essere ricondotta alla tendenza a ricorrere preferenzialmente
alle rappresentazioni non mentalizzanti di un emisfero sinistro dominante. In effetti, la
capacità di integrare gli elementi non verbali e prosodici del discorso con le componenti
semantiche e linguistiche richiede una collaborazione armonica tra i due emisferi cerebrali.
Studi specifici (Beebe, Lachman, 2002) hanno inoltre evidenziato che nel bambino con
problemi affettivi la madre utilizza un linguaggio verbale che non si accorda con la propria
espressione facciale ed è incapace di sintonizzarsi con il livello di sviluppo del bambino nel
risolvere un problema insieme. Tali relazioni sono caratterizzate da una “disconnessione”
tra le rappresentazioni cognitive linguistiche e non linguistiche.
Emozioni, sentimenti,
immagini possono accedere difficilmente alla consapevolezza dell‟individuo per poter
essere comunicate agli altri (o a se stessi) attraverso il linguaggio verbale.
PROCESSI BIOCHIMICI LEGATI ALLA SINTONIZZAZIONE AFFETTIVA
Nell‟uomo, la vista in generale ed il viso emotivamente espressivo in particolare, svolgono
un ruolo importante nel legame di attaccamento (Schore, 1994). Le interazioni faccia a
faccia attivano il sistema nervoso simpatico del bambino, aumentano il consumo di
ossigeno, il metabolismo dell‟energia e favoriscono l‟espressione genica (Kennel, 1986;
Schore, 1994; Gomez-Pinilla, Choi, Ryba, 1999; Kandel, 2005) (31). Alti livelli di attivazione
correlano con maggiore produzione di ossitocina, prolattina, endorfine e dopamina, che
diminuiscono quando madre e bambino si separano. Figure di riferimento sensibili
imparano a regolare gli scambi con il figlio e a rispondere ai suoi bisogni sincronizzando
impegno e disimpegno. Nella misura in cui bambini e adulti si sintonizzano e
desintonizzano, il ciclo di unioni, separazioni e riunioni diventa l‟aspetto centrale dello
sviluppo della regolazione psicologica. Il bambino impara che può stare solo, che può
regolare i propri stati corporei ed emozionali e che il genitore ritorna (32). Mancanza di
attenzione, insufficiente stimolazione, abusi e vergogna prolungata riducono i livelli di
31
La stimolazione del simpatico nel bambino si associa ad un aumento di attività, euforia ed eccitazione. Se
la madre intuisce che c‟è una sovreccitazione, interrompe l‟attività per permettere una ri-regolazione.
32
Il precoce sviluppo del pensiero nel neonato dipende dalla progressiva acquisizione da parte sua di una
relativa indipendenza nella relazione con la madre. Dosando presenze / assenze materne, il bambino
assume un ruolo attivo nel rapporto a due. L‟adulto, gradualmente, potrà diminuire il suo sostegno con
l‟aumento delle capacità di autoregolazione nel bambino.
13
endorfine e dopamina e aumentano gli ormoni dello stress e la noradrenalina. Questo
ambiente biochimico inibisce la plasticità cerebrale e crea vulnerabilità alla psicopatologia.
La ri-regolazione dell‟adulto nei confronti del bambino può avvenire anche con la semplice
stimolazione tattile. La pelle contiene due tipi di recettori sensoriali: quelli che trasmettono
l‟informazione alla corteccia somatosensoriale ed altri che attivano l‟insula, la corteccia
cingolata anteriore e la corteccia orbitale mediana (V. Appendice) (Francis et al., 1999;
Olausson et al., 2002). Questo secondo sistema tattile è alla base del tatto comunicativo
emotivo: modula il contatto pelle a pelle, la produzione ormonale, le emozioni
rasserenanti, le risposte sessuali a vicinanza fisica e carezze. Anche qui, l‟aumento di
ossitocina e di endorfine intensifica il legame attraverso la sensazione di benessere. Un
contatto fisico positivo, oltre ad esercitare una leggera azione calmante, provoca la
diminuzione della pressione sanguigna, favorisce la regolazione autonoma e la salute
cardiovascolare (Knox, Uvnas-Moberg, 1998; Weller, Feldman, 2003) (33).
PROCESSI INTEGRATIVI INTEREMISFERICI
La specializzazione emisferica concerne prevalentemente le funzioni corticali e comunque
esse sono influenzate dagli input provenienti da strutture sottocorticali così come da altre
regioni corticali dello stesso emisfero o di quello opposto. I due emisferi condividono così
le informazioni e operano in collaborazione (Joseph, 1996; Deacon, 1997; Gazzaniga,
1995; Ornstein, 1997).
L‟integrazione tra emisfero destro e sinistro, fisicamente separati e funzionalmente
differenziati, permette di realizzare un funzionamento più adattivo. La dominanza è
comunque relativa, non assoluta: un emisfero non funziona al cento per cento nel suo
campo di specializzazione, ma solo relativamente di più rispetto all‟altro. Quello sinistro
possiede alcune abilità emozionali e quello destro alcune abilità linguistiche, anche se in
misura minore rispetto alla loro “specializzazione”.
L‟emisfero sinistro può avere una funzione di “narratore”, riuscendo ad articolare
linguisticamente (34) la nostra storia di vita e dando un senso alle sensazioni ed emozioni
provate. Questa elaborazione permette di guidare, attraverso forme di consapevolezza più
33
Bambini prematuri tenuti a contatto con il corpo dei genitori e massaggiati regolarmente piangono di
meno, si sviluppano più velocemente ed acquistano più peso (Anderson, 1991; Bergman et al., 2004;
Ottenbacher et al., 1987).
34
Studi sul linguaggio suggeriscono che il non-lineare emisfero destro giochi un ruolo più critico di quel che
si pensi in una varietà di lingue del mondo. Per es., nella lingua tibetana il significato linguistico dipende
molto dal contesto della conversazione e da segnali sociali, funzioni entrambe dell‟emisfero destro. La lingua
giapponese ha un alfabeto fonetico (organizzazione lineare emisfero sinistro) e un alfabeto pittografico
(nessi globali emisfero destro) (Agha, 1993; Deacon, 1997; Ornstein, 1997).
14
ampie, le future azioni. Ma i “dati” della nostra memoria autobiografica sono conservati
principalmente nell‟emisfero destro, per cui creare una storia coerente della propria vita è
un’impresa che implica un’integrazione bilaterale. Inoltre, raccontare storie ci permette di
comunicare verbalmente agli altri il contenuto delle nostre menti e delle nostre emozioni. I
processi narrativi permettono così di dare una sequenza agli eventi della nostra vita e di
razionalizzarli, utilizzando simboli linguistici che possono essere compresi e condivisi da
altri, ma che si rivelano utili e costruttivi solo quando riflettono l‟integrazione delle attività
dei due emisferi cerebrali. Infatti, l‟emisfero sinistro interpretante cerca di elaborare storie
utilizzando le informazioni che ha a disposizione, ma se non integra le rappresentazioni
prodotte dall‟emisfero destro tali storie potrebbero risultare prive di emozionalità e non
veritiere. Il cervello sinistro è quindi in grado di “dare il giusto senso” agli eventi e di
sintonizzarsi con la mente altrui solo quando utilizza il linguaggio emozionale e del corpo
mediati dall‟emisfero destro (35). In un cervello intatto i due sistemi si completano a
vicenda, consentendo di elaborare l‟informazione senza dover sacrificare l‟attendibilità.
Tuttavia in molte situazioni c‟è uno schema di fondo e la tendenza del‟emisfero sinistro a
mettere ordine nei dati che ha a disposizione può costituire la strategia migliore
(Gazzaniga. 2009).
Una mancanza di integrazione dell‟informazione emozionale e somatica dell‟emisfero
destro con il sistema linguistico e cognitivo dell‟emisfero sinistro sembra manifestarsi con
l‟alessitimia (Taylor, 2000). Gli alessitimici possono riconoscere che gli altri provano dei
sentimenti ma sono incapaci di trovarli dentro di sé. Ciò accade malgrado la presenza di
indici di una loro intensa risposta fisiologica a stimoli emozionali negativi (Stone, Nielson,
2001) (36).
La capacità di mentalizzare (mind reading) appare come la sintesi di attività mentali di
natura diversa, legate al funzionamento integrato dei due emisferi cerebrali ( 37).
Mentalizzare vuol dire rappresentarsi la mente propria e altrui spiegazione e previsione
del comportamento. Significa concepire, sia in forma immaginativa che riflessiva gli stati
35
La memoria la costruiamo narrandoci e venendo narrati costruzione collettiva di chi siamo, della nostra
vita, di quanto valiamo. Quando ci raccontiamo tendiamo ad evidenziare i fatti che portano a valutazioni
positive, altri fatti li omettiamo, li ingigantiamo, li inventiamo. Costruiamo un mito distorto della realtà A forza
di raccontare ed immaginarci rischiamo poi di non essere in grado di ricordare esattamente.
36
Alti livelli di alessitimia sono correlati ad una storia di trauma ripetuto (Kosten et al., 1992; Krystal, 1988;
Zeitlin et al., 1993). Gli alessitimici presentano altre difficoltà in relazione al funzionamento emisferico destro,
quali un deterioramento della capacità di lettura delle espressioni facciali e dell‟elaborazione
dell‟informazione emozionale, verbale e non verbale (Jessimer, Markham, 1997; Lane et al., 1996;
McDonald, Prkachin, 1990).
37
Anche se il concetto di mentalizzazione in psicoterapia si è affermato di recente, gli autori che lo hanno
proposto (Fonagy, 1991; Fonagy et al., 2002; Bateman, Fonagy, 2004; Allen, Fonagy, 2006) riconoscono
che, in realtà, esso deriva da precedenti concezioni (Bion, 1962; Marty, 1991).
15
mentali (legati a bisogni, desideri, sentimenti, credenze, obiettivi, ragioni, intenzioni) riferiti
a se stessi e agli altri (auto attribuzione ed etero attribuzione).
E‟ un‟attività che richiede l‟integrità e la maturità del cervello, in particolare della corteccia
prefrontale (38). Occorre eliminare, però, dalla parola mentalizzare il suo connotato
intellettuale e razionale. Infatti, benché nel processo del mentalizzare sia interessata l‟area
cognitiva, in realtà si tratta di un‟attività che si forma intorno alle emozioni ed ai sentimenti.
Si può quindi definire come una vera e propria conoscenza emotiva che nasce
dall‟integrazione di livelli emozionali e cognitivi al tempo stesso (coordinamento delle
attività di processing dei due emisferi) (39).
NEUROSCIENZE E PSICOTERAPIA:
QUALI IMPLICAZIONI?
L‟importanza della qualità della relazione è basilare per il successo terapeutico e ciò
indipendentemente dall‟orientamento teorico del terapeuta e dal fatto che egli pensi che la
relazione sia o meno un ingrediente attivo del processo di cambiamento. La psicoterapia
può facilitare stati di risonanza diadica “bilaterali”, in cui la mente del paziente e quella del
terapeuta possono essere emozionalmente coinvolte e nello stesso tempo concentrate su
esplorazioni narrative riflessive. E‟ attraverso questi stati di attivazione cooperativa, in cui
processi di sintonizzazione affettiva si uniscono a dialoghi riflessivi, che la relazione
terapeutica può permettere lo sviluppo di capacità di regolazione delle emozioni più
efficaci e l‟emergere di narrazioni più coerenti e consentire al sistema della mente di
raggiungere una maggiore complessità e stabilità. In questo senso, il rapporto terapeutapaziente riflette quella che dovrebbe essere l‟essenza delle relazioni umane: comprendere
ed accettare gli altri per ciò che sono, cercando contemporaneamente di alimentare
un‟ulteriore crescita ed integrazione anche a livello cerebrale (40).
38
E‟ chiaro quanto sostenuto da Goldberg (2001): “la corteccia prefrontale è quanto più si avvicina a definire
il substrato neurale della vita sociale”. L‟interazione sociale è fondata sulla capacità di attribuire
reciprocamente stati mentali e tanto più tale capacità è sviluppata tanto più il rapporto sarà fluido. Se ci sono
difficoltà nella capacità di mentalizzare il comportamento dell‟altro si presenta come opaco cortocircuito
all‟interno del rapporto.
39
La Theory of Mind focalizza sulla rappresentazione della mente dell‟altro in termini simbolici mentre la
Simulation Theory afferma che la comprensione del comportamento altrui non è a carattere proposizionalsimbolico in termini di credenze-scopi, ma in termini di immedesimazione. La mente umana fa entrambe le
cose per ragioni diverse, entrambi gli approcci sono veri. Usiamo simulation per capire la mente dell‟altro per
es, per la pena, il senso di colpa. Ma “Io credo che lui creda che io credo..” è un tipo di livello
necessariamente simbolico.
40
Questi elementi nel corso di una terapia o nel contesto di altre relazioni emotivamente coinvolgenti (come
amicizie o relazioni sentimentali), possono facilitare ulteriori processi di sviluppo a livello della corteccia
orbito-frontale ed aumentare le capacità di regolazione delle emozioni.
16
Nell‟ambito degli interventi cognitivo-comportamentali il fatto di tenere un diario, di
utilizzare tecniche di immaginazione guidata o di svolgere un role-playing si sono spesso
dimostrati utili nel catalizzare lo sviluppo non solo di nuove forme di apprendimento ma
anche un‟attività più integrata a livello di funzionalità cerebrale. Il modellamento ad opera
del terapeuta favorisce senza dubbio il meccanismo dei sistemi specchio ed il circuito della
risonanza (che coinvolge anche l‟insula e le aree prefrontali mediali, V. Appendice). L‟uso
di schede di auto osservazione o degli ABC permette al paziente di svincolarsi da schemi
precostituiti, legati ad un‟analisi settoriale dell‟informazione (ipotesi focale bias
confirmatorio) (funzione S), e di attuare un‟analisi più globale, spostando l‟attenzione su
aspetti nuovi (o alternativi) della realtà e riformulando in modo flessibile il proprio
investimento scopistico (funzione D).
E‟ lecito supporre che l‟efficacia delle tecniche immaginative (Edwards, 1990, Layden at
al., 1993; Young, 1994; Smucker et al., 1995; McGinn e Young, 1996; Arntz, Weertman,
1999) risieda in una attivazione delle funzioni emisferiche destre, tramite la memoria
autobiografica e gli aspetti emotivi collegati al vissuto. Attraverso la verbalizzazione, è
plausibile che poi avvenga una rielaborazione di affetti dolorosi dell‟emisfero destro in
termini linguistici dell‟emisfero sinistro. In tal senso, è legittimo ipotizzare, per es., che
esperienze affettive molto precoci potrebbero rimanere confuse ed impossibili da
verbalizzare (41): la psicoterapia attiva un processo che conduce alla capacità di riflettere
sulle relazioni fra passato, presente e futuro sviluppo della coscienza autonoetica (il
senso di sé nel tempo e nello spazio) andare oltre i limiti di quelle che sono le nostre
esperienze del momento (Edelman, 1992). Il fatto di divenire consapevoli delle cause del
nostro malessere o della nostra sofferenza ci permette inoltre di elaborare risposte più
adeguate al raggiungimento di obiettivi specifici.
La strategia di “punire” il comportamento di un paziente (per es. in forma vicaria) va a
modificare un automatismo in quanto, stimolando funzioni corticali superiori, si può ridurre
la ricerca del rinforzo e la generalizzazione. Parimenti si può dire riguardo il coefficiente di
valore e la percezione della gravità del danno. Con l‟intervento terapeutico si va a
sollecitare un‟elaborazione più complessa ed integrata che permetta di attuare valutazioni
più ampie.
41
Levin (1997) teorizza che certe difese siano il risultato di disconnessioni funzionali tra emisfero destro e
sinistro. Una disconnessione da destra a sinistra porta ad una rimozione, in cui le esperienze a forte carica
emotiva non possono essere adeguatamente verbalizzate. Una disconnessione funzionale da sinistra a
destra porta al diniego della realtà. L‟individuo può parlare degli eventi emotiva ma nega il loro valore. In tal
senso, Levin (1997) e Modell (1997) ritengono che l‟uso di metafore (che racchiudono elementi sensoriali,
immaginifici, emotivi e verbali) possa potenziare l‟integrazione tra parte destra e sinistra del cervello.
17
In psicoterapia cognitiva l‟obiettivo è comunque di risvegliare il paziente da una esistenza
in automatico e renderlo capace di ragionamenti, comportamenti e stili di vita alternativi.
Per questo si tenta di renderlo consapevole non solo dei suoi contenuti mentali ma anche
degli stati corporei. In tal modo, riflettendo sulla mente ed entrando in contatto con le
proprie emozioni e sensazioni, si favorisce un‟integrazione tra aspetti razionali
dell‟esperienza e percettivo-emozionali. A tale scopo possono rivelarsi molto utili le
tecniche di desensibilizzazione, le quali agiscono da una parte sull‟amigdala,
sull‟ippocampo e le aree corticali (V. Appendice), mediando il livello di ansia, e dall‟altra
non danno input precisi ai mediatori neurobiologici dell‟ansia, favorendo l‟internalizzazione
progressiva di interpretazioni cognitive più appropriate (Ardino, Sassaroli, Lorenzini, 2006).
E‟ inoltre plausibile che la desensibilizzazione, così come le tecniche di rilassamento,
esercitino una positiva influenza sul vago smart (V. Appendice), favorendo capacità di
autoregolazione ed un
efficace impegno sociale. Inoltre, è parimenti plausibile che
vengano favorite le strategie di coping dell‟emisfero destro, deputate a gestire lo stress
(sistema regolatorio).
Le ricerche rivelano che le pratiche di consapevolezza mindfulness, utilizzate in
psicoterapia cognitiva, rinforzano il funzionamento del corpo, le risposte immunitarie, la
reattività allo stress ed il senso generale di benessere fisico (Davidson, Kabat-Zinn, 2004);
Davidson, Kabat-Zinn, Schumacher et al., 2003). Essa è descritta come: a) osservare,
notare, rendere consapevole; b) descrivere, etichettare, annotare; c) partecipare. Tutto ciò
va fatto in modo non giudicante, con accettazione, nel momento presente ed in modo
efficace (Dimidjian, Linehan, 2003, ). Tale processo permette di vedere le cose in modo
nuovo (Bishop et al., 2004; Shapiro, Carlson, Astin e Freedman, 2006) e sembra favorire i
processi integrativi intra ed interemisferici. Questi ed altri autori riconoscono che la
mindfulness può avere vari esiti, soprattutto a livello emotivo, come la pazienza, la non
reattività, la compassione per se stessi e la saggezza. L‟esperienza della nostra vita sarà
senz‟altro diversa se ci avviciniamo ai contenuti della nostra mente senza evitarli e riuscire
a descriverli con le parole ci permette di condividere con altri e con noi stessi ciò che
abbiamo dentro.
La mindfulness ha influenzato una vasta gamma di approcci alla psicoterapia con nuove
ricerche che rivelano significativi miglioramenti in vari disturbi, con riduzione dei sintomi ed
18
una prevenzione delle ricadute (Hayes, Follette, Linehan, 2004; Hayes, Strosahl, Wilson,
1999; Linehan, 1993; Marlatt, Gordon, 1985; Parks, Anderson, Marlatt, 2001) (42).
Nella terapia dell‟accettazione e dell‟impegno (ACT - Acceptance and Commitment
Therapy) (Hayes, Strosahl et al., 1999; Hayes, Feldman, 2004; Hayes, 2004; Hayes,
Follette, Linehan, 2004; Germer, Siegel, Fulton, 2005). La mindfulness può essere intesa
come “un insieme di processi correlati che minano il dominio delle reti verbali, il quale
implica soprattutto relazioni temporali e di valutazione. Questi processi includono
l‟accettazione, la disidentificazione dai pensieri, il contatto con il momento presente e il
senso trascendente di se stessi” (Fletcher, Hayes, 2006).
Uno dei primi studi che ha dimostrato che la psicoterapia può modificare il funzionamento
del cervello ha utilizzato i principi della mindfulness nel trattamento di soggetti con disturbo
ossessivo-compulsivo (Baxter, Schwartz, Bergman et al., 1992). L‟idea generale è che
l‟accettazione della propria situazione possa alleviare il conflitto interno che si scatena
quando le nostre aspettative non corrispondono a come la vita è nella realtà (Brach, 2003;
Hayes, 2004; Linehan, 1993). Si va così oltre l‟automatismo a cui tende la mente,
rappresentandosi il mondo per come non è (Castelfranchi, 2006).
La mindfulness sembra inoltre generare una maggiore capacità di recepire i segnali non
verbali degli altri. Stare in silenzio per una settimana rende più sensibili alle altre persone
in quanto la percezione dei segnali non verbali attiva l‟insula e la corteccia prefrontale
mediale (V. Appendice), specialmente dell‟emisfero destro, correlate con l‟enterocezione,
l‟interpretazione e l‟attribuzione dei propri stati mentali interni a quelli dell‟altro. Lazar e
coll. (2005) hanno scoperto che i meditatori esperti non solo hanno una corteccia
prefrontale mediale ispessita ma anche un ampliamento dell‟insula destra.
CONCLUSIONI
Si potrebbe obiettare che conoscere come funziona il nostro cervello può risultare
interessante ma irrilevante ai fini di una psicoterapia. In parte è così. Va comunque
considerato che il paziente porta in terapia delle problematiche connesse non solo alla sua
storia di apprendimento ma anche ad uno stile di conoscenza più o meno rigido, più o
meno irrazionale che potrebbe riflettere la tendenza ad attivare in maniera preferenziale le
modalità funzionali di un emisfero rispetto ad un altro. E comunque, vari studi evidenziano
42
Può anche prevenire le ricadute nei casi di depressione cronica trattati con la terapia cognitiva (Segal,
Williams, Teasdale, 2002). Inoltre, essa è utilizzata come componente essenziale nel trattamento del
distrubo borderline di personalità con la terapia dialettico-comportamentale (Linehan, 1993) e nella
prevenzione delle ricadute delle persone con abuso di sostanze.
19
come determinati disturbi possano essere correlati a disfunzioni di un emisfero o dell‟altro.
Per es., la depressione risulta associata ad una riduzione delle attività dell‟emisfero
sinistro e ad un relativo aumento dell‟attivazione del destro (43) mentre la schizofrenia
sembra connessa ad un‟insufficienza funzionale dell‟emisfero destro ed una iperattività
compensatoria dell‟emisfero sinistro (Rotenberg, 1994). Il disturbo di panico, che risulta
legato ad un‟alta sensibilità ai segnali somatici, potrebbe evidenziare disfunzioni a livello
delle corteccia cingolata e somatosensoriale nonché dei sistemi cerebrali di regolazione
(V. Appendice). L‟emisfero sinistro è poi responsabile dell‟interpretazione catastrofica dei
segnali interni che contribuisce ad acuire l‟arousal somatico. Anche una profonda
timidezza ed un‟ansia intensa in situazioni sociali possono risultare associate ad una
disfunzione emisferica destra (sindrome da disabilità d‟apprendimento dell‟ED) (Weintraub
e Mesulam, 1983; Voeller, 1986; Hollander et al., 1996).
E‟ quindi legittimo valutare quali implicazioni possano esserci all‟interno di una
psicoterapia e nella pianificazione della strategia terapeutica. Il dialogo, per es., potrebbe
essere infruttuoso con pazienti che ricorrono prevalentemente ad una logica stretta ed al
distanziamento emotivo. Inizialmente, potrebbe rivelarsi più utile un intervento che
favorisca l‟estrinsecazione delle competenze mediate dall‟emisfero destro. Incoraggiando
l‟immaginazione ed altre modalità non verbali (per es. attraverso la mindfulness o il
rilassamento) si può aiutare il paziente a scoprire nuovi modi di relazionarsi con se stesso
e gli altri. In tal senso, modulare l‟attività di un emisfero o dell‟altro potrebbe, in genere,
rendere necessario l‟utilizzo di tecniche diverse. L‟obiettivo, comunque, sarebbe quello di
favorire un‟integrazione bilaterale.
In tal senso, un‟importante implicazione clinica potrebbe derivare dalla prospettiva
neuroscientifica secondo cui la conoscenza di noi stessi e del mondo può dipendere dal
funzionamento integrato di entrambi gli emisferi. Quello destro “conosce”, afferrandoli,
l‟emozione, l‟intento e lo sfondo contestuale di ciò che viene vissuto o espresso e può farlo
anche al di là della percezione cosciente. L‟emisfero sinistro contribuisce alla
comprensione linguistica e causale, che si verificano entrambe a livello cosciente. In tal
senso, il lavoro di Dawson e Fisher (1994) è d‟aiuto per illustrare due fenomeni clinici di
comune osservazione. La capacità di un paziente di tradurre i sentimenti in parole (una
strategia dell‟emisfero sinistro) spesso contribuisce a diminuire l‟intensità di affetti penosi;
43
Studi mirati su madri depresse hanno evidenziato se il disturbo disturbi depressivo durava da più di un
anno, i bambini avevano una maggiore probabilità di presentare in seguito alterazioni durature
nell‟attivazione dell‟emisfero sinistro (Dawson, 1994; Field et al., 1995)
20
lo stesso accade se il paziente riesce a spostare l‟attenzione su segnali alternativi (una
strategia dell‟emisfero destro) (Tucker et al., 1995). In sintesi, prestare consapevolmente
l‟attenzione a qualcosa ed esprimerla con le parole può aumentare l‟attivazione corticale e
i processi integrativi interemisferici.
Nel trattamento psicoterapeutico, si sa, è necessario osservare anche ai segnali emotivi
non verbali trasmessi tra paziente e terapeuta, oltre che il contesto verbale della seduta.
Non solo sono entrambi ugualmente importanti ma, come suggeriscono i dati scientifici,
parole e sentimenti interagiscono reciprocamente per potenziare l‟elaborazione di
entrambi. L‟accesso all‟emozione accresce la capacità di pervenire ai significati linguistici
dell‟esperienza ed esprimere i sentimenti con le parole rafforza la regolazione affettiva.
Uno dei più interessanti risultati scientifici su cui poter fare delle ipotesi di rilevanza clinica
è la funzione lateralizzata di “interprete” dell‟emisfero sinistro, il quale perviene
continuamente a cause e significati interpretativi delle informazioni che riceve, sia che
esse consistano in dati sensoriali esterni di stimoli ambientali che in dati sensoriali interni
di emozioni e sensazioni corporee. Entrambi, paziente e terapeuta, producono in modo
continuo teorie e spiegazioni per sentimenti, comportamenti e per i contenuti
dell‟interazione verbale. Il fatto è che l‟emisfero sinistro utilizza i dati disponibili e ricava
inferenze e spiegazioni casuali che sembrano esatte ma che potrebbero non esserlo.
Questo dovrebbe indurre ad una maggiore comprensione nei confronti del paziente ed allo
stesso tempo considerare che quando un terapeuta sente di aver ragione circa un
paziente dovrebbe rimanere aperto al fatto che le conclusioni potrebbero essere erronee.
E comunque, paradossalmente, un fattore aspecifico della terapia potrebbe consistere nel
fatto che le co-costruzioni di storie, caratterizzate da un processo di sintonizzazione tra
terapeuta e paziente, possono rivelarsi utili a contenere la sofferenza di quest‟ultimo
anche se esse non possiedono una verità storica.
Certo è che la complessità della mente umana richiede molta flessibilità all‟interno di una
psicoterapia e comunque spinge a riflettere sul delicato ruolo che il terapeuta può svolgere
nel processo di cura e di risoluzione dei sintomi. Del resto Kandel (1998, 2007) fornisce
una visione ottimistica quando presuppone che la relazione ed il dialogo con i pazienti sia
effettivamente
in
grado
di
stimolare
l‟espressione
genica,
mostrando
come
l‟apprendimento che avviene in terapia potrebbe modificare stabilmente il funzionamento
emotivo e comportamentale.
Forse non siamo ancora al punto in cui possono essere attuate dirette traduzioni tra i due
campi ma senza dubbio le spiegazioni neuroscientifiche aprono numerose prospettive.
21
APPENDICE
22
Il cervello sociale
Strutture corticali e sottocorticali
Corteccia prefrontale dorso laterale. Implicata nella memoria di lavoro, si occupa di
importanti funzioni esecutive che consentono l‟autoregolazione ed influenzano il flusso
dell‟attenzione (Bechara, Damasio, Damasio, 2000; Gehring, Willoughby, 2002). Pazienti con
lesione frontale dorso-laterale manifestano facile distraibilità, difficoltà o incapacità nel
programmare il comportamento in funzione di uno scopo. Tendono ad orientare l‟attenzione verso
stimoli non rilevanti rispetto al contesto ed evidenziano scarsa flessibilità cognitiva, difficoltà ad
affrontare situazioni complesse nonché una ridotta capacità di giudizio (44). La porzione anteriore
della corteccia dorsolaterale ha la funzione di mantenere attiva la rappresentazione dell‟obiettivo
finale durante i passaggi intermedi (Koechlin et al., 2000). D‟altro canto, la pianificazione è un
processo complesso che implica più operazioni cognitive e richiede il contributo sia della corteccia
dorsolaterale che di altre aree frontali, incluse la corteccia premotoria, orbitofrontale e frontale
mediale.
Corteccia prefrontale mediale. Le varie regioni interconnesse (corteccia orbitofrontale,
cingolato anteriore, prefrontale ventrolaterale e mediale) svolgono funzioni di ordine elevato, qui di
seguito sintetizzate (Cozolino, 2006; Siegel, 2007, Gazzaniga, 2008):
a) regolazione corporea le funzioni di freno/acceleratore del SNA sono coordinate e ben
equilibrate;
b) comunicazione sintonizzata coordinazione dei segnali provenienti da un‟altra mente con
l‟attività della propria processo di risonanza;
c) equilibrio emotivo monitoraggio ed inibizione delle scariche del sistema limbico quando
raggiunge livelli troppo alti;
d) flessibilità di risposta capacità di riflettere prima di agire (45);
e) empatia, che sembra basarsi su dei cambiamenti interni guidati dai circuiti della risonanza;
f) insight o consapevolezza cosciente di sé connette il passato, il presente e il futuro (46);
g) modulazione della paura, con il rilascio del Gaba (acido gamma aminobutirrico) (47);
h) intuizione, sembra implicare la registrazione dei segnali delle reti neurali che processano
l‟informazione proveniente dagli organi interni;
i) moralità, gli sudi rivelano la partecipazione della corteccia prefrontale mediale nella mediazione
della moralità.
La corteccia orbitomediale (orbito frontale + prefrontale mediale) (48) ha un ruolo centrale nelle
relazioni sociali, nella valutazione dei significati, nella flessibilità di risposta e nella regolazione
delle emozioni. Quest‟area, soprattutto a livello emisferico destro, è in grado di monitorare e
regolare gli stati del corpo (e quindi gli stati emozionali) attraverso collegamenti diretti con il
sistema nervoso simpatico e parasimpatico. E‟ ormai dimostrato il ruolo della orbitomediale nella
regolazione di comportamenti socialmente adattivi: una lesione in questa sede determina serie
alterazioni della regolazione emotiva e dei processi decisionali (49).
44
Il comportamento appare disorganizzato e caotico, anche per l‟intrusione di azioni irrilevanti, non
appropriate, rispetto al fine prefissato. I deficit di pianificazione sono attribuibili ad una ridotta efficienza nei
processi di organizzazione temporale e di memorizzazione a breve termine delle informazioni (working
memory), necessari a pianificare una risposta.
45
Implica valutazione degli stimoli presenti, ritardo della reazione, selezione tra una varietà di alternative
possibili e inizio dell‟azione collaborazione con le aree laterali per eseguire queste funzioni.
46
La corteccia prefrontale mediale ha numerose fibre che la connettono a varie aree cerebrali, sia in output
che in input, e ciò le permette di creare rappresentazioni mentali in una continuità storica.
47
Gaba, un neurotrasmettitore inibitore che agisce nelle aree inferiori del sistema limbico che mediano la
paura, come i nuclei estesi dell‟amigdala “disapprendimento” della paura;
48
Situata tra le strutture limbiche profonde (che sono responsabili delle reazioni emozionali di base) e i centri
corticali più alti, coinvolti nelle attività psichiche superiori.
49
Persone ben adattate diventano incapaci di rispettare norme sociali, di decidere in modo vantaggioso per
se stessi ed esprimere le emozioni in modo appropriato al contesto. I processi decisionali vengono guidati da
23
La corteccia cingolata è un‟area di associazione delle informazioni di tipo viscerale, tattile, motorio,
autonomo ed emozionale (50). Implicata nel monitoraggio simultaneo di informazioni personali,
ambientali ed interpersonali, guida l‟attenzione verso ciò che è più saliente. Tale funzionamento
multiplo si osserva nelle madri di bimbi con attaccamento sicuro (51).
La corteccia anteriore provvede a regolare alcuni aspetti dei processi cognitivi ed emozionali
(identificazione degli errori, adeguamento della risposta di fronte ad uno stimolo nuovo, capacità di
ingannare) (Bush et al, 2000 e 2002; Langleben et al., 2002; Kerns et al. 2004; Kozel et al., 2004).
Diverse porzioni della corteccia cingolata si attivano nella rievocazione di ricordi emozionali e nello
svolgimento di compiti implicanti aspetti emotivi e cognitivi (Maddock et al. 2001, 2003; Phan et al.,
2002).
Corteccia somatosensoriale. Racchiude rappresentazioni multiple del corpo dato che elabora
ed organizza le nostre esperienze di tatto, temperatura, dolore, posizione e stato viscerale. Questi
differenti flussi di informazione ed elaborazione determinano l‟esperienza del sé somatico.
E‟ coinvolta nelle “sensazioni viscerali” poiché attiva ricordi impliciti legati ad esperienze vissute,
aiutandoci a prendere delle decisioni (Damasio, 1994). E‟ esperienza-dipendente e si struttura nel
contesto delle prime relazioni. In tal senso, le esperienze vissute a livello corporeo possono
influenzare il nostro modo di connetterci, comprendere ed empatizzare nelle relazioni
interpersonali (Damasio et al., 2000).
Insula. Considerata “la corteccia limbica di integrazione” per via delle sue connessioni con le aree
limbiche e con i lobi frontali, parietali e temporali (Augustine, 1996), è organizzata
somatotopicamente. Insieme al cingolato anteriore, ci permette di renderci conto di ciò che accade
all‟interno del corpo e di riflettere sulle nostre esperienze emotive (Carr et al., 2003; Bechara,
Naqvi, 2004).
Oltre ad essere implicata nella mediazione dell‟intero campo delle emozioni, dal disgusto all‟amore
(Bartels, Zeki, 2000), connette l‟attivazione dei neuroni specchio - dovuta alla percezione delle
azioni intenzionali di un‟altra persona - alle alterazioni del corpo e degli stati emotivi (risonanza
emotiva) (52). Questi processi influenzano le aree prefrontali mediali, che vengono così incluse nel
circuito della risonanza. Per essere empatici è necessario riflettere sui cambiamenti dei propri stati
interni connessi al circuito della risonanza: la regione prefrontale può svolgere questo ruolo e
creare delle risposte compassionevoli (sentire un‟altra persona) ed empatiche (comprendere
un‟altra persona) (Carr et al., 2003; Gallese, 2003).
Amigdala. E‟ formata da ampi nuclei di neuroni coinvolti nell‟apprendimento, nell‟attenzione e
nell‟emozione. E‟ specializzata nell‟apprendimento del pericolo e delle risposte attacco e fuga
(diretta connessione con il SNA).
L‟amigdala non ha solo effetto sul nostro sistema motorio, può anche modificare il modo di
pensare in quanto le risposte emotive immediate (di paura o disgusto o rabbia) coloreranno
l‟elaborazione delle informazioni future, portando a focalizzare l‟attenzione sugli stimoli negativi,
siano essi reali o semplicemente percepiti come tali. Si ritiene che l‟amigdala compia tipi di
valutazione semplice (E‟ uno stimolo buono o cattivo? Familiare o sconosciuto?) mentre la
corteccia orbitofrontale reagisce a stimoli complessi, che informano su oggetti, persone ed eventi,
e compie valutazioni che si sono sviluppate a partire dalle esperienze di vita.
segnali emozionali che predicono eventi futuri sulla base di esperienze passate. La corteccia orbitomediale
sarebbe il “luogo” in cui tali segnali sono rappresentati in modo non consapevole, ma in grado di orientare il
processo decisionale.
50
Inizia a partecipare all‟attività cerebrale intorno al secondo mese di vita. Le cure genitoriali e i
comportamenti di risonanza resi possibili dal cingolo formano una base neurale per la cooperazione sociale
e l‟empatia (Rilling et al., 2002).
51
Per es., sono in grado di spostare la loro attenzione da ciò che stanno facendo ai bisogni del figlio.
52
In pratica, con i cinque sensi acquisiamo i segnali che provengono da un‟altra persona. Il sistema dei
neuroni specchio percepisce tali “stati intenzionali” e per mezzo dell‟insula modifica gli stati del sistema
limbico e del corpo per sintonizzarli con quelli della persona con cui interagiamo.
24
Ippocampo. Nell‟essere umano i lobi parietali si sono sviluppati dall‟ippocampo e lo aiutano nella
complessa elaborazione visuospaziale (53). Insieme alle strutture ad esso adiacenti, è quindi
specializzato nell‟organizzazione dell‟apprendimento spaziale, sequenziale, emotivo e nella
memoria (Edelman, 1992) (Sherry et al., 1992).
Ipotalamo. I suoi numerosi nuclei organizzano molte funzioni corporee (quali la regolazione di
temperatura, la fame, la sete, il livello di attività). E‟ anche implicato nel comportamento sessuale e
nell‟aggressività. Tramite l‟ipofisi anteriore, converte i processi del cervello in secrezioni ormonali.
Sistemi specchio e di risonanza
Secondo Goleman (2006), l‟intelligenza sociale ha origine da diversi meccanismi cerebrali, in
particolare i neuroni specchio (54) (Rizzolatti, Sinigaglia, 2006; Iacoboni, 2008). Queste particolari
cellule nervose si “accendono” sia quando si esegue un‟azione, sia quando la si osserva (55). Si
ritiene che tale sistema sia implicato nell‟apprendimento e nello sviluppo del linguaggio e che
possa essere coinvolto nella patogenesi di gravi deficit comunicativi (per es., autismo) (Rizzolatti,
Fabbri-Destro, 2008; Iacoboni, 2008).
Certo è che il sistema specchio ha tutto il potenziale necessario per attuare un meccanismo di
comprensione delle azioni e di apprendimento attraverso l’imitazione e la simulazione del
comportamento altrui. Le ricerche dimostrano che questi neuroni si attivano alla percezione delle
emozioni altrui, espresse con movimenti del viso, gesti e suoni (56). Il processo si può esemplificare
in: vedere/sentire imitazione – simulazione interna – esperienza interna comprensione.
Questo meccanismo neurale è alla base anche dell‟empatia (Gallese, 2003; Rizzolatti, Sinigaglia,
2006, Iacoboni, 2008) in quanto non solo sarebbero in grado di rappresentare gli stati interiori altrui
ma mediano i meccanismi basilari della risonanza emotiva (Carr, Iacoboni, Dubeau et al., 2003)
(Miller, 2005) (57)
Sistemi di riconoscimento facciale e di espressione facciale.
L‟area facciale fusiforme, nel lobo occipitale, è una regione associativa deputata all‟identificazione
di facce, conosciute o sconosciute (58). L‟informazione visiva, una volta elaborata, viene connessa
ad altri circuiti neuronali, responsabili del processamento non verbale (sguardo, postura del corpo,
e espressione facciale). Per es., se il volto che guardiamo esprime un‟emozione, si attiva
l‟amigdala dell‟emisfero destro.
Se dobbiamo dare un nome ad una faccia, si attiva l‟ippocampo sinistro. Infine, l‟amigdala sinistra
sembra attivarsi solo di fronte a facce sconosciute, valutate in modo positivo o negativo (Dubois et
al., 1999).
A differenza dell‟amigdala, che matura verso l‟ottavo mese di gravidanza, l‟ippocampo si sviluppa più tardi
e ciò spiega la mancanza di ricordi coscienti nella prima infanzia.
54
I neuroni specchio sono situati nelle aree premotoria e motoria, nell‟area di Broca, nella corteccia parietale
inferiore e nel solco temporale superiore.
55
I neuroni dell‟osservatore “rispecchiano” il comportamento dell‟osservato, come se fosse proprio
l‟osservatore a compiere l‟azione.
56
Tra i neuroni mirrors esistono alcuni che si attivano anche al suono dell‟azione senza che ne abbiamo di
essa un riferimento visivo diretto. Questi mirror, uditivi e audio-visivi, sono quelli che ci consentono di inferire
l‟azione di qualcuno che non vediamo.
57
Le connessioni dei meccanismi di risonanza con i circuiti viscerale ed emotivo permettono la sintonia
emozionale, la condivisione affettiva, la sincronizzazione e l‟empatia (Rizzolatti, Arbib, 1998; Rizzolatti et al.,
1999).
58
Gli aspetti invarianti dei volti vengono processati nell‟area facciale fusiforme, mentre quelli variabili nel
solco temporale superiore.
53
25
Sistemi di regolazione
Sistema di regolazione dello stress (HPA). L‟asse ipotalamo-ipofisi-surrene regola la
secrezione degli ormoni nella risposta somatica a stress e minaccia. La reazione immediata allo
stress è basilare per la sopravvivenza nel breve termine mentre la normalizzazione lo è nel lungo
termine per la salute psicofisica dell‟individuo.
Sistema di regolazione della paura. L‟amigdala comunica a vari centri cerebrali la necessità
di fuga-attacco, innescando una reazione di paura molto prima di poterne avere consapevolezza.
La corteccia prefrontale orbitomediale è un regolatore della paura. Ha relazioni reciproche con
l‟amigdala e può inibirla attraverso la consapevolezza (Beer et al., 2003). Per questo, quando
siamo molto spaventati (alta attivazione dell‟amigdala), la corteccia orbitomediale è inibita, con
conseguente difficoltà ad essere razionali e a controllare il comportamento. Le reti che connettono
orbitomediale ed l‟amigdala vengono modellate dall‟esperienza, per cui la nostra storia di
apprendimento di ciò che è sicuro o pericoloso viene codificata in questo sistema.
Sistema di impegno sociale. Il nervo vago si estende dal tronco encefalico a vari punti del
soma (compresi cuore, gola, sistema digerente, polmoni). Regola l‟omeostasi ed il benessere
emozionale attraverso fibre afferenti (sensorie) ed efferenti (motorie) che consentono un continuo
feedback tra cervello e corpo (Porges, 1994; Porges et al. 1996) (59). Il “vago smart” (branca
mielinizzata del sistema) ha un‟influenza inibitoria e modulatoria sull‟eccitazione simpatica. Esso
permette di mantenere un coinvolgimento positivo con gli altri senza difese o attacco. Diventano
così possibili cure genitoriali, affiliazione e collaborazione (60). Questo sistema è necessario per
inibire l‟aggressività difensiva in risposta a segnali di disagio; tale inibizione permette relazioni
continuative e collaborazione in gruppi ampi, malgrado disaccordi e conflitti transitori (Blair, 1995).
Sembra che lo sviluppo e la buona sintonizzazione del sistema vagale per la regolazione affettiva
dipendano dalla qualità delle relazioni di attaccamento nella prima infanzia; il sistema vagale ci
permette di trasferire ciò che impariamo dall’esperienza con le figure di riferimento in
un’esperienza corporea. Si è anche visto che la regolazione del ritmo cardiaco correla con gli stili
di attaccamento sicuro (Izard, Porge et al., 1991). Questa correlazione riflette la natura esperienzadipendente tanto dell‟asse HPA quanto del vago “smart”.
Correlati del tono vagale
Il tono vagale più alto correla con
Capacità di autoregolazione
Capacità di auto calmarsi dai 3 mesi di età
Gamma di stati emozionali e loro controllo
Risposte autonome più attendibili
Soppressione della variabilità del ritmo
cardiaco
Capacità attentive e di assimilazione
dell‟informazione più elevate
Impegno sociale positivo
Organizzazione comportamentale più elevata
Cure genitoriali coerenti/attaccamento sicuro
Il tono vagale più basso correla con
Irritabilità
Problemi comportamentali a 3 anni di età
Disregolazione emozionale
Distraibilità
Iper-reattività agli stimoli ambientali e viscerali
Ritiro
Impulsività / acting out
Attaccamento insicuro
59
In assenza di sfide esterne, il vago lavora per migliorare digestione, crescita, comunicazione sociale. In
situazioni di sfida, una diminuzione dell‟attivazione vagale facilita l‟intervento del simpatico, la produzione di
energia e la risposta attacco-fuga.
60
Secondo Porges, l‟evoluzione di questo sistema permette di regolare l‟attivazione autonoma in modo
prosociale. Insieme all‟ossitocina ed alla vasopressina il freno vagale facilita la modulazione della risposta
attacco-fuga, rendendo possibile la comparsa del corteggiamento e di legami duraturi di coppia (Porges,
1998).
26
RAFFRONTO TRA LE CARATTERISTICHE
DELLA FUNZIONE S E DELLA FUNZIONE D
DEL CERVELLO
La funzione S
La funzione D
Verbale
Uso di parole per
nominare, descrivere e
definire
Non verbale
Consapevolezza delle
cose senza il minimo
ricorso alle parole
Analitica
Soluzione dei problemi
per gradi, affrontando un
aspetto per volta
Sintetica
Unione degli elementi di
una situazione a formare
un tutto
Simbolica
Concreta, reale
Uso dei simboli per
rappresentare oggetti; per
esempio, il simbolo
a rappresentare “occhio”,
il simbolo + a significare
la operazione della
addizione
Considerazione delle
cose così come sono al
momento presente
Astratta
Estrapolazione di un dato Analogica
parziale utilizzandolo per
rappresentare l‟oggetto
intero
Percezione delle
somiglianze tra oggetti;
comprensione dei
rapporti basati sulla
metafora
Temporale
Scansione del tempo;
applicazione di un ordine
successivo agli oggetti,
alle azioni, ecc. (cose da
fare prima, cose da fare
dopo)
Atemporale
Mancanza del senso del
tempo
Razionale
Formulazione di
conclusioni in base a
premesse e a fatti
Non razionale
Nessuna necessità di
premesse o fatti;
disponibilità a
sospendere il giudizio
Digitale
Uso dei numeri come nel
calcolo
Spaziale
Osservazione della
collocazione degli oggetti
rispetto ad altri oggetti, e
delle parti rispetto
all‟intero
Logica
Formulazione di
conclusioni in base alla
logica; elaborazione di
ordini successivi di tipo
logico (per es. teoremi
matematici, ragionamenti
impostati correttamente)
Intuitiva
Momenti illuminanti, di
improvvisa comprensione
delle cose, spesso in
base a schemi incompleti,
impressioni, sensazioni o
immagini visive
Lineare
Pensiero basato su idee Globale
collegate (un pensiero
segue direttamente un
altro, portando spesso ad
una conclusione
convergente).
Visione contemporanea
di tutti gli aspetti di un
oggetto o di un fatto,
percezione di schemi e di
strutture al completo, che
spesso porta a
conclusioni divergenti
27
Il PROCESSO INFERENZIALE
Una comunicazione efficiente si basa sull‟abilità dell‟ascoltatore o del lettore di completare
l‟informazione lasciata implicita da chi parla o scrive. Questo processo inferenziale avviene
continuamente durante la comprensione del linguaggio e molto spesso senza la
consapevolezza dell‟individuo.
Le ricerche nel campo della neurolinguistica si sono concentrate soprattutto sui deficit dei
processi inferenziali evidenziati da pazienti con danno all‟emisfero destro del cervello
(Beeman, 1993; Brownell, Martino, 1998). Le osservazioni cliniche su alcuni di questi pazienti
hanno evidenziato le loro difficoltà nella comprensione degli aspetti impliciti di un discorso e
ciò viene considerato segnale di un deficit specifico nel capacità di tenere sufficientemente in
conto il contesto. I processi inficiati riguardano vari aspetti, tra cui l‟attivazione di associazioni
semantiche (Beeman, 1993), la revisione delle interpretazioni iniziali, le convenzioni sociali, il
linguaggio non letterale, i discorsi indiretti (Brownell, Gardner, Prather, Martino, 1995). Le
difficoltà presentate dalla maggior parte dei pazienti risultano comunque legate al
mantenimento del contesto o del tema sottostante ad una conversazione (per es., la frase:
“Puoi aprire la porta?”, che ha il significato sottostante: “Vuoi aprire la porta per me?”, viene
intesa come: “Sei capace di aprire la porta?”).
I pazienti con danno all‟emisfero destro presentano inoltre difficoltà nell‟interpretazione di
richieste indirette, contenute all‟interno di una conversazione, (Stemmer et al, 1994; Stemmer,
1999) e nel rilevare i segnali non verbali (come, per es. quando l‟interlocutore richiede il suo
turno o desidera tagliare la conversazione).
Brownell et al. (1995, 1998) segnalano che, oltre alle difficoltà nel processo inferenziale, i
pazienti con danno all‟emisfero destro manifestano anche una rigidità aggiuntiva di pensiero
nella quale l‟interpretazione letterale viene sempre mantenuta. Prendiamo, per esempio, la
frase: “Sally avvicinò la star del cinema con penna e foglio in mano. Stava scrivendo un
articolo su come la pensavano le persone famose in materia di energia nucleare”. Malgrado
l‟evidenza che Sally non è una cacciatrice di autografi, la prima frase spinge molti soggetti con
danno emisferico destro a rimanere vincolati ad essa. Non c‟è solo un fallimento nel realizzare
un processo inferenziale, ma c‟è anche la tendenza a scegliere l‟interpretazione più letterale,
senza modificarla. Gli autori sottolineano, però, che ciò può essere dovuto alla propensione
dell‟emisfero sinistro ad essere più convergente sugli aspetti della semantica. A tale proposito,
gli studi che hanno presentato singole parole al campo visivo di destra (ES), hanno riscontrato
che i soggetti rispondono più velocemente a parole familiari o ad alta frequenza mentre
l‟emisfero destro risponde con la medesima velocità sia alle parole ad alta che a bassa
frequenza. Secondo Beeman (1993), questo suggerisce che l‟emisfero sinistro tende ad
essere più convergente e letterale nelle sue interpretazioni, mentre l‟emisfero destro potrebbe
essere più responsivo nei confronti di interpretazioni alternative. Atchley et al. (1999) hanno
studiato le modalità di recupero del lessico negli emisferi cerebrali attraverso la
somministrazione di coppie di parole non ambigue con diversa caratteristica semantica
variabile (per es.: Agnello-Lana confrontata con Agnello-Fettina). I risultati suggeriscono che
l‟emisfero sinistro seleziona le caratteristiche semantiche, con maggiore o minore possibilità di
associazione, che sono compatibili con la rappresentazione dominante che esso ha della
parola. La compatibilità della dominanza, piuttosto che la forza dell‟associazione, sembra
essere il fattore più importante nel decidere quali significati vanno mantenuti nell‟emisfero
sinistro. Al contrario, l‟emisfero destro mantiene un‟informazione più varia, inclusi significati
che sono meno compatibili con la rappresentazione dominante e l‟informazione contestuale.
Lehman e Tompkins (2000) affermano che le evidenze empiriche sui deficit dei processi
inferenziali evidenziati da pazienti con danno all‟emisfero destro non sono così chiare come
sembra mentre McDonald (1993) puntualizza che i deficit del linguaggio dopo un danno
all‟emisfero destro del cervello somigliano a quelli descritti dopo lesioni prefrontali,
indipendentemente dalla lateralizzazione. In particolare, pazienti con danno prefrontale, a
seguito di una lesione focale o traumatica, spesso falliscono nel tenere in considerazione il
28
contesto comunicativo e nella valutazione delle necessità dell‟ascoltatore, oppure hanno
difficoltà nella strutturazione di un discorso coerente (Kaczmaek, 1984; Novoa, Ardila, 1987;
Prigatano, Roueche, Fordyce, 1986). Una possibile spiegazione riguardo questi deficit, non
afasici, del linguaggio, è che la produzione del discorso e la comprensione del testo richiedono
l‟uso di funzioni esecutive, come la pianificazione, il monitoraggio ed il problem solving.
Inoltre, molti studi che sostengono il deficit emisferico destro nei processi inferenziali si
avvalgono di un‟elaborazione di informazioni di vario tipo: affettivo ed emotivo; sociale e
pragmatico oppure inerenti la prosodia (Brownell et l., 1995; Brownell, Martino, 1998; Lehman
e Tompkins, 2000). Tali processi, molti dei quali si ritiene che vengano realizzati in specifiche
aree dell‟emisfero destro, necessitano di essere attentamente separati dal processo
inferenziale durante la comprensione del testo.
Varie osservazioni cliniche e tecniche di brain imaging suggeriscono che le lesioni prefrontali
sinistre potrebbero provocare i maggiori deficit nel processo inferenziale. In considerazione di
ciò, Ferstl, Guthke, Cramon (2002) hanno dimostrato che pazienti non afasici, con lesioni
temporali sinistre o lesioni frontali destre, riescono a superare compiti che richiedono la
capacità di trarre inferenze, in base alla coerenza del discorso. Al contrario, pazienti con
lesioni frontali sinistre e bifrontali evidenziano i deficit maggiori. Tali risultato confermano che
l‟area frontale dell‟emisfero sinistro contribuisce al processo inferenziale.
Nel complesso, i risultati di tale studio indicano che i deficit non afasici del linguaggio sono
correlati a lesioni prefrontali ma che essi non sono necessariamente connessi a danni
all‟emisfero destro. A sostegno di tale risultato, alcuni studi hanno dimostrato che pazienti con
danno emisferico destro non sempre hanno dei problemi in compiti che richiedono
un‟elaborazione di tipo text-level (Leonard, Baum, 1998; Leonard et al., 1997a, 1997b).
Parimenti, altri studi documentano i deficit mostrati da pazienti con danno frontale sinistro nel
processamento linguistico in base al contesto (Channon, Crawford, 2000; Ferstl, Guthke, von
Cramon, 1999; Kaczmarek, 1984; Novoa, Ardila, 1987). Inoltre, in aggiunta agli studi di brain
imaging che supportano l‟ipotesi di un coinvolgimento dell‟emisfero destro in compiti inerenti la
comprensione di aspetti impliciti del testo (Robertson et al., 2000; St. George et al., 1999), vi è
una crescente evidenza riguardo l‟importanza, in tali compiti, del ruolo svolto dalle regioni
frontomediane e prefrontali dell‟emisfero sinistro (Ferstl, von Cramon, 2001; Fletcher et al.,
1995; Maguire et al., 1999).
Al fine di un‟interpretazione teorica di questi risultati, apparentemente contradditori, vanno
considerati due aspetti (Brownell, Martino, 1998; McDonald, 1993; Stemmer, 1999). In primo
luogo, è fondamentale un‟appropriata selezione dei pazienti e dei gruppi di controllo. Per es.,
Ferstl, Guthke e von Cramon (2002) nel loro studio hanno utilizzato anche un gruppo di
pazienti con lesioni emisferiche sinistre, sia frontali che temporali, ed un gruppo di controllo
costituito da pazienti con danni cerebrali. Così, è stato possibile effettuare un confronto tra i
gruppi in base alle lesioni presentate piuttosto che confrontare un gruppo di pazienti con un
gruppo di controllo sano. In secondo luogo, l‟analisi del compito è fondamentale e spesso
viene sottovalutata. I concetti di inferenza o comprensione del testo sottintendono un numero
di subprocessi che varia in base al loro livello di complessità, ai loro automatismi ed al tipo di
informazioni da processare (Gernsbacher, 1990; Kintsh, 1998). Tutti questi fattori, considerati
nell‟ambito degli studi sui deficit dell‟emisfero destro, non possono essere utilizzati per fare
previsioni su compiti inerenti la valutazione della coerenza di un discorso. Le inferenze
richiedono un uso non automatico della conoscenza generale del mondo, che si attua al di là
dell‟attivazione e della selezione di associazioni (Beeman, 1993, 1998), ma esse non
richiedono di tenere in considerazione le informazioni non letterali, pragmatiche, affettive o
sociali (Alexander, Benson, Stuss, 1989; Brownell et al., 1995).
29
Bibliografia
ADOLPHS, R. (2003a), “Cognitive neuroscience of human social behaviour”. In Nature Reviews
Neuroscience, 4, pp. 165-178.
ADOLPHS, R. (2003b), “Investigating the cognitive neuroscience of social behaviour”. In Neuropsychologia,
41, pp. 119-126.
ADOLPHS, R. (2003c), “Is the human amygdale specialized for processing social information?”. In Annals of
the New York Academy of Sciences, 985, pp. 326-340.
AGHA, A. (1993), “Structural form and utterance context in Lhasa Tibetan. In Monographs in Linguistics and
the Philosophy of Language. New York, Peter Lang.
ALEXANDER, M.P., BENSON, D.F., STUSS, D.T. (1989), “Frontal lobes and language”. In Brain and
Language, 37, 656-691.
ALLEN, J.G., FONAGY, P. (2006), La mentalizzazione (trad.it.), Il Mulino, 2008.
ANDERSON, G.C. (1991), “Current knowledge about skin-to-skin (kangaroo) care for preterm infants”. In
Journal of Perinatology, 11, pp. 216-226.
ANDREASEN, N.C. (1997), “Linking brain and mind in the study of mental illnesses: A project fir a scientific
psychopathology”. In Science, 275, pp. 1586-1593.
ANSERMET, F., MAGISTRETTI, P. (2008), A ciascuno il suo cervello. Plasticità neurale ed inconscio. Bollati
Boringhieri, Torino.
ARDINO V., SASSAROLI S., LORENZINI R. (2006), “La trasmissione transgenerazionale dell‟ansia – Un
modello neurocognitivo dell‟attaccamento tra biologia ed apprendimento. In SASSAROLI S., LORENZINI
R., RUGGIERO G.M. (a cura di), Psicoterapia cognitiva dell’ansia – Rimuginio, controllo ed evitamento”,
Raffaello Cortina Editore, 2006.
ARNTZ, A., WEERTMAN, A. (1999), “Treatment of childhood memories: theory and practice”. In Behaviour
Research and Therapy, 37, pp. 715-740.
ATCHLEY, R.A., KEENEY C.B. and M. (1999), “The effect of time course and context on the facilitation of
semantic features in the cerebral hemispheres”. In Neuropsychology, vol. 13, n. 3, 389-403.
ATKINSON, L., ZUCKER, K.J. (1997), (a cura di) Attachment and psychopathology. Guilford Press, New
York.
ATTILI, G.; VERMIGLI, P.; FELACO, R. (1994), “Modelli mentali dell‟attaccamento negli adulti e la qualità
della relazione madre- bambino”. In ATTILI G. (a cura di), Attaccamento e disadattamento, nucleo
monotematico, Età Evolutiva, 47, pp. 110-117.
ATTILI, G. (2007), Attaccamento e costruzione evoluzionistica della mente – Normalità, patologia, terapia,
Raffaello Cortina Ed.
AUGUSTINE, J.R. (1996), “Circuitry and functional aspects of the insular lobe in primates, includes humans”.
In Brain Research Reviews, 22, pp. 229-244.
BARTELS, A., ZEKI, S. (2000), “The neural basis of romantic love”. In NeuroReport, 11, pp. 3829-3834.
BARTELS, A., ZEKI S. (2004), “The neural correlates of maternal and romantic love”. In Neuroimage, 21, pp.
1155-1166.
BATEMAN, A., FONAGY, P. (2004), Il trattamento basato sulla mentalizzazione (trad. it.), Raffaello Cortina,
Milano, 2006.
BAXTER, L.R., SCHWARTZ, J.M., BERGMAN, K.S., SZUBA, M.P., GUZE, B.H., MAZZIOTTA, J.C. et al.
(1992), “Caudate glucose metabolic rate changes with both drug and behaviour therapy for obsessivecompulsive disorder”. In Archives of General psychiatry, 49, 9, pp. 681-689.
BECHARA, A., DAMASIO, H., DAMASIO, A.R. (2000), “Emotion, decision making and the orbitofrontal
cortex”. In Cerebral Cortex, 10, 3, pp. 295-307.
BECHARA, A., NAQVI, N. (2004), “Listening to your heart: interoceptive awareness as a gateway to feeling”.
In Nature Neuroscience, 7, pp. 102-103.
BEEBE, B., LACHMAN, F.M. (1988), “MOTHER.INFANT MUTUAL INFLUENCE AND PRECURSORS OF
PSYCHIC STRUCTURE. In GOLBERG, A. (a cura di), Progress in self psychology.
BEEBE, B., LACHMAN, F.M. (2002), Infant research e trattamento degli adulti, Raffaello Cortina, Milano,
2003.
BEEMAN, M. (1993), “Semantic processing in the right hemisphere may contribute to drawing inferences
from discourse. In Brain and Language, 44, 80-120.
30
BEEMAN, M (1998), Coarse semantic coding and discourse comprehension. In BEEMAN, M., CHIARELLO,
C. (Eds.), Right hemisphere language comprehension: perspectives from cognitive neuroscience (pp. 255284). Mahwah, NJ: Erlbaum.
BEEMAN, M., BOWDEN, E.M. (2000), “Right and left hemisphere cooperation for drawing predictive and
coherence inferences during normal story comprehension”. In Brain and Language, 71, 310-336.
BEER, J.S., HEEREY, E.A., KELTNER, D., SCABINI, D., KNIGHT, R.T. (2003), “The regulatory function of
self-conscious emotion: insights from patients with orbitofrontal damage”. In Journal of personality and
social psychology, 85, pp. 594-604.
BENEDERSKY, M., LEWIS, M. (1994), “Environmental risk, biological risk, and developmental outcome. In
Developmental Psychology, 30, pp. 484-494.
BERGMAN, N.J., LINLEY, L.L., FAWCUS, S.R. (2004), “Randomized controlled trial of skin-to-skin contact
from birth versus conventional incubator for physiological stabilization in 1200-to 2199-gram newborns”. In
Acta Paediatrica, 93, pp. 779-785.
BION, W.R. (1962), Apprendere dall’esperienza (trad. it.), Armando, Roma, 1988.
BISHOP, S.R., LAU, M., SHAPIRO, S., CARLOSN, L., ANDERSON, N.D., CARMODY, J. et al. (2004),
”Mindfulness: A proposed operational definition”. In Clinical Psychology: Science and Practice, 1, 3, pp.
230-241.
BLAIR, R.J.R. (1995), “A cognitive developmental approach to morality: investigating the psychopath”. In
Cognition, 57, pp. 1-29.
BOWLBY, J. (1969), Attaccamento e perdita, vol. 1. tr. It. Boringhieri, Torino 1972.
BOWLBY, J. (1973), Attaccamento e perdita, vol. 2. tr. It. Boringhieri, Torino 1975.
BOWLBY, J. (1980), Attaccamento e perdita, vol. 3. tr. It. Boringhieri, Torino 1983.
BOWLBY, J. (1988), Una base sicura, Tr. It. Raffaello Cortina, Milano, 1989.
BRACH, T. (2003), Radical Acceptance: Embracinbg your life with the hearth of a Buddha. Bantam Books,
New York.
BROWNELL, H.H., GARDNER, H., PRATHER, P., MARTINO, G. (1995), Language, communication and the
right hemisphere. In KIRSHNER, H.S. (Ed.), Handbook of neurological speech and language disorders
(pp. 325-349). New York: Dekker.
BROWNELL, H.H., MARTINO, G. (1998), Deficits in inference and social cognition: The effects of right
hemisphere brain damage on discourse. In BEEMAN, M., CHIARELLO, C. (Eds.), Right hemisphere
language comprehension: Perspectives from cognitive neuroscience (pp. 309-328). Mahwath, NJ:
Erlbaum.
BUSH, G., LUU, P., POSNER, M.I. (2000), “Cognitive and emotional influences in anterior cingualte cortex”.
In Trends in Cognitive Sciences, 4, pp. 215-222.
BUSH, G., VOGT, B.A., HOLMES, J., DALE, A.M., GREVE, D., JENIKE, M.A. et al. (2002), “Dorsal anterior
cingulated cortex: a role in reward-based decision making”. In Proceedings of the National Academy of
Sciences, USA, 99, pp. 523-528.
CARLSON, E., SROUFE, L.A. (1995), Contribution of attachment theory to developmental psychopathology.
In: CICCHETTI, D., COHEN, D.J. (a cura di) Developmental Psychopathology, Vol. 1, Theory and
Methods, Wiley, New York.
CARLSON, E. (1998), “A prospective longitudinal study of disorganized/disoriented attachment”. In Child
Development, 69, pp. 1107-1128.
CARR, L., IACOBONI, M., DUBEAU, M.C., MAZZIOTTA, J.C., LENZI, G.L. (2003), “Neural mechanisms of
empathy in humans: a relay from neural systems for imitation to limbic areas”. In Proceedings of the
National Academy of Sciences, USA, 100, pp. 5497-5502.
CASTELFRANCHI, C. (1999), “La fallacia dello psicologo. Per una teoria degli atti finalistici non intenzionali”.
In Sistemi Intelligenti, 13, 3, pp. 435-468.
CASTELFRANCHI, C., MANCINI F., MICELI M. (2002) (a cura di), Fondamenti di cognitivismo clinico. Bollati
Boringhieri, Torino.
CASTELFRANCHI, C. (2006), Psicologia cognitiva, Lezione tenuta alla Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Grosseto, 18 - 19 febbraio.
CHANNON, S., CRAWFORD, S. (2000), “The effects of anterior lesions on performance on a story
comprehension test: Left anterior impairment on a theory of mind-type task. Neuropsychologia, 38, 1061017.
COLIN, V.L. (1996), Human Attachment. McGraw-Hill, New York.
31
COZOLINO, L.J. (2004), The making of a therapist: A practical guide for the inner journey. Norton, New
York.
COZOLINO, L.J. (2006), Il cervello sociale, Raffaello Cortina Editore, 2008.
CUTTING, J. (1992), “The role of right hemisphere dysfunction in psychiatric disorders”. In British Journal of
Psychiatry, 160, pp. 583-588.
DAMASIO, A.R. (1994), L’errore di Cartesio. Tr. it. Adelphi, Milano, 1995.
DAMASIO, A.R., GRABOWSKI, T.J., BECHARA, A., DAMASIO, H., PONTO, L.L., PARVIZI, J. ET AL.
(2000), “Subcortical and cortical brain activity during the feelinf of self-generated emotions”. In Nature
Neuroscience, 3, pp. 1049-1056.
DAVIDSON, R.J., KABAT-ZINN, J. (2004), “Alterations in brain and immune function produced by
mindfulness meditation: Three caveats. Comment”. In Psychosomatic Medicine, 66, 1, pp. 149-152.
DAVIDSON, R.J., KABAT-ZINN, J., SCHUMACHER, J., ROSENKRANZ, M., MULLER, D., SANTORELLI,
S.F. et al. (2003), „Alterations in brain and immune functions produced by mindfulness meditation“. In
Psychosomatic Medicine, 65, 4, pp. 564-570.
DAWSON, G., FISHER, K.W. (a cura di) (1994), Human behavior and the developing brain, New York,
Guilford.
DEACON, T.W. (1997), The symbolic species. New York: Norton. Tr. It. La specie simbolica: evoluzione di
linguaggio e cervello, Giovanni Fioriti Editore, Roma 2001.
DIMBERG, U., PETTERSON, M., (2000), “Facial reactions to happy and angry facial expressions: evidence
for right hemisphere dominance”. In Psychophysiology, 37, pp. 693 -696.
DIMBERG, U., THUNBERG, M., ELMEHED, K. (2000),“Unconscious facial reactions to emotional facial
expressions“. In Psychological Science, 11, pp. 86-89.
DIMIDJIAN, S., LINEHAN, M.M. (2003), “Defining an agenda for future research on the clinical application of
mindfulness practice”. In Clinical Psychology: Science and practice”, 10, 2, pp. 166-171.
DUBOIS, S., ROSSION, B., SCHILTZ, C., BODART, J.M. MICHEL, C., BRUYER, R. et al. (1999), “Effect of
familiarity on the processing of human faces”. In NeuroImage, 9, pp. 278-289.
DUNN, J., McGUIRE, S. (1994), “Young children‟s nonshared experiences. A summary of studies in
Colorado and Cambridge. In: HETHERINGTON, E.M., PLOMIN, R. (a cura di) Separate Social Worlds of
Siblings: The Impact of Nonshared Environment on Development, Erlbaum, Hillsdale.
EDELMAN, G.M. (1992), Il presente ricordato. Rizzoli, Milano.
EDELMAN, G.M, TONONI , G. (2000), Un universo di coscienza: come la materia diventa immaginazione.
Tr. t. Einaudi, Torino, 2000.
EDWARDS, D. J. A. (1990), Cognitive therapy and the restructuring of early memories through guided
imagery. In Journal of Cognitive Psychotherapy, 4, 33-50.
FEINBERG, T.E. (2001), Altered Egos: How the brain creates the self, Oxford University Press, Inc.
FEINBERG, T.E. (2006), From axons to identity, W.W. Norton & Co.
FERSTL, E.C., GUTHKE, T., von CRAMON, D.Y. (1999). “Change of perspective in discourse
comprehension: Encoding and retrieval processes after brain injury. In Brain and Language, 70, 385-420.
FERSTL, E.C., von CRAMON, D.Y. (2001), “The role of coherence and cohesion in text comprehension: An
event-related fMRI study”. In Cognitive Brain Research, 11, 325-340.
FERSTL, E.C., GUTHKE, T., von CRAMON, D.Y. (2002), “Text comprehension after brain injury: Left
prefrontal lesions affect inference processes”. In Neuropsychology, vol. 16, n. 3, 292-308.
FLETCHER, P., HAPPE, F., FRITH, U., BAKER, S.C., DOLAN, R.J., FRACKOWIAK, R.S.J., FRITH, C.D.
(1995). “Other minds in the brain: A functional imaging study of “theory of mind” in story comprehension. In
Cognition, 57, 109-128.
FLETCHER, L., HAYES, S.C. (2006), “Relational frame theory, acceptance and commitment therapy, and a
functional analytic definition of mindfulness”. In Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavioral
Therapy, 23, 4, pp. 315-336.
FONAGY, P. (1991), “Pensare sul pensiero”. In P. Fonagy, M. Target, Attaccamento e funzione riflessiva
(trad. it.), Raffaello Cortina, Milano, 2001.
FONAGY, P., STEELE M, STEELE H, et al. (1991), “The capacity for understanding mental states: the
reflective self in parent and child and its significance for security of attachment”. In Special Issue: The
effects of relationships on relationships. Infant Mental Health Journal.
FONAGY, P. (1996), “Attaccamento sicuro ed insicuro”. In Kos, 129, pp. 26-32.
32
FONAGY , P. (2001), Psicoanalisi e teoria dell’attaccamento. Tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2002.
FONAGY, P., GERGELY, G., JURIST, E.L., TARGET, M. (2002), Regolazione affettiva, mentalizzazione e
sviluppo del sé (trad. It.), Raffaello Cortina, Milano, 2005.
FRANCIS, S., ROLLS, E.T., BOWTELL, R., McGLONE, F., O‟DOHERTY, J., BROWNING, A. et al. (1999),
“The representation of pleasant touch in brain and its relationship with taste and olfactory areas”. In
NeuroReport, 10, pp. 453-459.
FRITH, C.D., FRITH, U. (1999), “Interacting minds: A biological basis. In Science, 286, 1692-1695.
GABBARD, G.O. (2000), “A neurobiologically informed prospective on psychotherapy”. In British Journal of
Psychiatry, 177, pp. 117-122.
GABBARD, G.O. (2005), “Mind, brain and personality disorders”. In American journal of Psychiatry, 162, pp
648-655.
GALLESE, V. (2003), “The roots of empathy: The shared manifold hypothesis and the neural basisi of
intersubjectivity”. In Psychopathology, 36, 4, pp. 171-180.
GAZZANIGA, M.S. (1995), “Consciousness and the cerebral hemispheres”. In The cognitive neurosciences.
Cambridge, Ma: Mit Press.
GAZZANIGA, M.S. (1995), The cognitive neurosciences. MIT Press, Cambridge.
GAZZANIGA, M.S. (1996), “Cognitive neuroscience and the future of Psychiatry”. Plenary Address to the
American Association of Director of Psychiatric Residency Training, San Francisco.
GAZZANIGA, M.S., ELIASSEN, J.C., NISENSON, L., WESSINGER, C.M., BAYNES, K.B. (1996),
“Collaboration between the hemispheres of a callosotomy patient: Emerging right hemisphere speech and
the left brain interpreter. Brain, 119, pp. 1255-1262.
GAZZANIGA, M.S. (2008), Human – Quel che ci rende unici, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
GEHRING, W.J., WILLOUGHBY, A.R. (2002), “The medial frontal cortex and the rapid processing of
monetary gains and losses”. In Science, 295, pp. 2279-2282.
GERMER, C., SIEGEL, R., FULTON, P. (2005) (a cura di), Mindfulness and Psychotherapy, The Guilford
Press, New York.
GERNSBACHER, M.A. (1990), Language comprehension as structure building. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
GOLDBERG, E. (2001), L’anima del cervello (trad. it.), Utet, Torino, 2004.
GOLDSMITH, H.H., GOTTESMAN, I.I., LEMERY, K.S. (1997), “Epigenetic approaches to developmental
psychopathology. In Development and Psychopathology, 9, pp. 365-388.
GOLEMAN, D. (2006), Intelligenza sociale, Rizzoli.
GOMEZ-PINILLA, F.; CHOI, J., RYBA, E.A. (1999), “Visual input regulates the expression of basic fibroblast
growth factor and its receptor”. In Neuroscience, 88, pp. 1051-1058.
GOULD, S.J. (1977), Ontogeny and Phylogeny. Belknap Press of Harvard University, Cambridge, MA.
HAYES, A.M., FELDMAN, G. (2004), “Clarifying the construct of mindfulness in the contex of emotion
regulation and the process change in therapy”. In Clinical Psychology: Science and Practice, 11, pp. 255262.
HAYES, S.C. (2004), “Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of
behavioural and cognitive therapies”. In Behavior Therapy, 35(4), pp. 639-665.
HAYES, S.C., FOLLETTE, V.M., LINEHAN, M.M. (2004) (a cura di), Mindfulness and Acceptance:
Expanding the Cognitive-Behavioral Tradition, The Guilford Press, New York.
HAYES, S.C., STROSAHL, K.D., WILSON, K.G. (1999), Acceptance and Commitment Therapy: An
Experiential Approach to Behavior Change. Guilford Press, New York.
HENRIQUES , J.B., DAVIDSON, R.J. (1991), “Left frontal hypoactivation in depression”. In Journal of
Abnormal Psychology, 100, pp. 535-545.
HENRY, J.P. (1993), “Psychological and physiological responses to stress: The right hemisphere and the
hypothalamo-pituitary-adrenal axis, an inquiry into problems of human bonding”. In Integrative
Physiological and Behavioral Science, 28, pp. 369-387.
HIGGINS, E.D. (2008), “The new genetics of mental illness”. In Scientific American Mind, june 2008.
HOLLANDER, E., WEILLER, F., COHEN, L. et al. (1996), “Neurological soft signs in social phobia”. In
Neuropsychiatry, Neuropsychology, and BehavioralNeurology, 9, 182-185.
HUGDAHI, K (1996), “Cognitive influences on human autonomic nervous system function”. In Current
Opinion in Neurobiology, 6, pp. 252-258.
33
HUGDAHI, K., IVERSEN, P.M., NESS, H.M., FLATEN, M.A. (1989), “Hemispheric differences in recognition
of facial expressions. A VHF-study of negative, positive and neutral emotions”. In International Journal of
Neuroscience, 45, pp. 205-213.
HUR, Y.M., BOUCHARD, T.J. (1995), “Genetic influences on pertceptions of childhood family environment:
A reared apart twin study. In Child Development, 66, pp. 330-345.
IACOBONI, M. (2008), I neuroni specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri. Bollati Boringhieri, Torino.
INSEL, T.R. (1992), “Oxytocin – a neuropeptide for affiliation: evidence from behavioural, receptor,
autoradiographic, and comparative studies”. In Psychoneuroendocrinology, 17, pp. 3-35.
IZARD, C.E., PORGES, S.W., SIMONS, R.E., HAYNES, O.M., HYDE, C., PARISI, M. et al. (1991), “Infant
cardiac activity: developmental changes and relations with attachment”. In Developmental Psychology, 27,
pp. 432-439.
JESSIMER, M., MARKHAM, R. (1997), “Alexithymia: a right hemisphere dysfunction specific to recognition
of certain facial expressions?”. In Brain and Cognition, 34, pp. 246-258.
JOHNSEN, B.H., HUGDAHI, K., (1991), “Hemispheric asymmetry in conditioning to facial emotional
expressions”. In Psychophysiology, 28, pp. 154-162.
JOSEPH, R. (1996), Neuropsychiatry, neuropsychology and clinical neuroscience, Baltimore: Williams and
Wilkins.
KACZMAREK, B.L.J. (1984), “Neurolinguistic analysis of verbal utterances in patients with focal lesions of
frontal lobes”. In Brain and Language, 21, 52-58.
KAGAN, J. (1992), “Behavior, biology, and meaning of temperamental construct”. In Pediatrics, 90, pp. 510513.
KAGAN, J. (1994), Galen’s Prophecy: temperament in human nature, Basic Books, New York.
KAGAN, J. (1998), “Biology and the child”. In Einsenberg, N. (a cura di), Handbook of Child Development,
5ed., vol. 3, Emotional and Personality Development, Wiley, New York, pp. 177-236.
KANDEL, E.R. (1989), “Genes, nerve cells, and remembrance of things past”. In Journal of Neuropsychiatry
and Clinical Neuroscience, 1, pp. 103-125.
KANDEL, E.R. (1998), “A new intellectual framework for psychiatry”. In American Journal of Psychiatry, 155
pp. 457-469.
KANDEL, E.R. (2005), Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente, Raffaello Cortina Editore, tr. It.
Milano, 2007.
KEENAN, J.P., McCUTCHEON, B., FREUND, S., GALLUP, G.G. jr., SANDERS, G., PASCUAL-LEONE, A.
(1999), “Left hand advantage in a self-face recognition task”. In Neuropsychologia, 37, pp. 1421-1425.
KEENAN, J.P., WHEELER, M.A., GALLUP, G.G. jr., PASCUAL-LEONE, A. (2000), “Self recognition and the
right prefrontal cortex”. In Trends in Cognitive Sciences, 4, pp. 338-344.
KELLY, G.A. (1995), The psychology of personal construct. Norton, New York.
KENNELL, J. (1986), John Lind Memorial Lecture. Relazione presentata al World Congress of Infant
Psychiatry, Stockholm.
KERNS, J.G., COHEN, J.D., MACDONALD, A.W., CHO. R.Y., STENGER, V.A., CARTER, C.S. (2004),
“Anterior cingulated conflict monitoring and adjustments in control”. In Science, 303, pp. 1023-1026.
KIMURA, I., KUBOTA, M., HIROSE, H., YUMOTO, M., SAKAKIHARA, Y. (2004), “Children are sensitive to
averted eyes at the earliest stage of gaze processing”. In NeuroReport, 15, pp. 1345-1348.
KINTSCH, W. (1988), “The role of knowledge in discourse comprehension: A construction-integration model.
In Psychological Review, 95, 163-182.
KINTSCH, W. (1998), Comprehension: A paradigm for cognition. Cambridege, England: Cambridge
University Press.
KNOX, S.S., UVNAS-MOBERG, K. (1998), “Social isolation and cardiovascular disease: an atherosclerotic
pathway”. In Psychoneuroendocrinology, 23, pp. 877-890.
KOECHLIN, E., CORRADO, G., PIETRINI, P., GRFMAN, J. (2000), “Dissociatine the role of the medial and
lateral anterior prefrontal cortex in human planning. In Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America, 97, pp. 7651-7656.
KOSTEN, T.R., KRYSTAL, J.H., GILLER, E.L., FRANK, J., DAN, E. (1992), “Alexithymia as a predictor of
treatment response in post-traumatic stress disorder”. In Journal of Traumatic Stress, 5, pp. 563-573.
34
KOZEL, F.A., REBELL, L.J., LORBERBAUM, J.P., SHASTRI, A., ELHAL, J.D., HORNER, M.D. et al. (2004),
”A pilot study of functional magnetic resonance imaging brain correlates of deception in healthy young
man”. In Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 16, pp. 295-305.
KRYSTAL, H. (1988), Integration and self healing: affect, trauma and alexithymia. Analytic Press, Hillsdale,
N.J.
LANE, R.D., SECHREST, L., REIDEL, R., WELDON, V., KASZNIAK, A., SCHWARTZ, G.E. (1996),
“Impaired verbal and nonverbal emotion recognition in alexithymia“. In Psychosomatic Medicine, 58, pp.
203-210.
LANGLEBEN, D.D., SCHROEDER, L., MALDIJAN, J., GUR, R.C., MCDONALD, S., RAGLAND, J.D., et al.
(2002), “Brain activity during stimulated deception: An event-related functional magnetic resources study”.
In NeuroImage, 15, pp. 727-732.
LATTNER, S., MEYER, M.E., FRIEDERICH, A.D. (2005), “Voice perception: sex, pitch and the right
hemisphere”. In Human Brain Mapping, 24, pp. 11-20.
LAZAR, S.W., KERR, C.E., WASSERMAN, R.H., GRAY, J.R., GREVE, D.N., TREADWAY, M.T., et al.
(2005), “Meditation experience is associated with increased cortical thickness. In Neuroreport, 16,17, pp.
1893-1897.
LAYDEN, M. A., NEWMAN, C. F., FREEMAN, A., BYERS MORSE, S. (1993). Cognitive therapy of
Borderline Personality Disorder. Boston: Allyn and Bacon.
LEHMAN, M.T., TOMPKINS, C.A. (2000), “Inferencing in adults with right hemisphere brain damage: An
analysis of conflicting results. Aphasiology, 14, 485-499.
LEONARD, C.L., BAUM, S.R. (1998), “On-line evidence for context use by right-brain damaged patients.
Journal of Cognitive Neuroscience, 10, 499-508.
LEONARD, C.L., WATERS, G.S., CAPLAN, D. (1997a), “The use of contextual information by right braindamaged individuals in the resolution of ambiguous pronouns. Brain and Language, 57, 309-342.
LEONARD, C.L., WATERS, G.S., CAPLAN, D. (1997b), “The use of contextual information related to
general world knowledge by right brain-damaged individuals in pronoun resolution. Brain and Language, 57,
343-359.
LEVIN, F. (1997), “Integrating some mind and brain views of transference: the phenomena. In Journal Amer.
Psychoanalysis Assn., 45, pp. 1121-1152.
LINEHAN, M.M. (1993), Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline. Tr. it. Raffaello
Cortina, Milano, 2003.
LORENZINI, R., SASSAROLI, S. (1995), Attaccamento, conoscenza e disturbi di personalità, Raffaello
Cortina Editore.
LORENZINI, R., SASSAOLI, S. (2000), La mente prigioniera, Raffaello Cortina, Milano.
LORENZINI S., CORATTI B. (2008), La Dimensione delirante. Psicoterapia cognitiva della follia, Raffaello
Cortina Editore.
MADDOCK, R.J., GARRETT, A.S., BUONOCORE, M.H. (2001), “Remembering familiar people: The
posterior cingulate cortex and autobiographical memory retrieval”. In Neuroscience, 104, pp. 667-676.
MADDOCK, R.J., GARRETT, A.S., BUONOCORE, M.H. (2003), “Posterior cingulated cortex activation by
emotional words: fMri evidence from a alence decision task”. In Human Brain Mapping, 18, pp. 30-41
MAGUIRE, E.A., FRITH, C.D., MORRIS, R.G.M. (1999), “The functional neuroanatomy of comprehension
and memory: The importance of prior knowledge”. Brain, 122, 1839-1850.
MARLATT, G.A., GORDON, J.R. (1985), Relapse Prevention: Maintenance Strategy in the Treatment of
Addictive Behaviors. Guilford Press, New York.
MANCINI, F., GANGEMI, A. (2002), Ragionamento e irrazionalità. In CASTELFRANCHI, C., MANCINI, F.,
MICELI, M. (a cura di) Fondamenti di cognitivismo clinico, Bollati Boringhieri.
MANDAL, M.K., AMBADY, N. (2004), “Laterality and universality of facial expressions of emotion: the
interface”. In Behavioural Neurology, 15, pp. 23-24.
MARCUS, G. (2004), La nascita della mente. Come un piccolo numero di geni crea la complessità del
pensiero umano, Codice Edizioni, Torino.
MARTY, P. (1991), Mentalisation et Psychosomatique, Laboratoire Delagrange, Paris.
McDONALD, P.W., PRKACHIN, K.M. (1990), “The expression and perception of facial emotion in
alexithymia: a pilot study”. In Psychosomatic Medicine, 52, pp. 199-210.
McDONALD, S. (1993), “Viewing the brain sideways? Frontal versus right hemisphere explanations of nonaphasic language disorders. In Aphasiology, 7, 535-549.
35
MCGINN, L. K.; YOUNG, J. E. (1996), Schema-focused therapy. In: SALKOVSKIS, P. M. (Ed.), Frontiers of
cognitive therapy (pp. 182-207). New York: Guilford.
MILLER, G. (2005), “Reflecting on another‟s mind”. In Science, vol. 308, n. 5724, pp. 945-947.
MODELL, A. (1997), “Reflection on metaphors and affects”. In Ann. Psychoanalysis, 25, pp. 219-233.
MOSTICONI, R. (1984), La ricerca nevrotica dell’equilibrio, Bulzoni Editore.
MOSTICONI, R. (2006), Analisi funzionale in psicologia, Giovanni Fioriti Ed.
MOSTICONI, R. (2008), “Attenzione selettiva e connotazione: la radice (e la stereotipia) dei comportamenti
individuali”. Paper presentato al simposio “Verso un modello unificato degli effetti/funzioni delle emozioni.
MUNDO, E. (2009), Il contributo delle neuroscienze ad una diagnostica più consapevole. In: DAZZI, N.,
LINGIARDI, V., GAZZILLO, F. (a cura di) La diagnosi in psicologia clinica – Personalità e psicopatologia,
Raffaello Cortina.
NELSON, C.A. (1994), “Neural bases of infant temperament”. In: BATES, J.E., WACHS, T.D. (a cura di)
Temperament: Individual Differences at the Interface of Biology and Behavior. American Psychological
Association, Washington.
NELSON, E.E., PANKSEPP, J (1998), “Brain substrates of infant-mother attachment: contributions of
opioids, oxytocin and norepinephrine”. In Neuroscience and biobehavioral Reviews, 22, pp. 437-452.
NOVOA, O.P., ARDILA, A. (1987), “Linguistic abilities in patients with pre-frontal damage. In Brain and
Language, 30, 206-225.
OGAWA, J.R., SROUFE, L.A., WEINFELD, N.S., CARLSON, E.A., EGELAND, B. (1997), “Development and
the fragmented self: Longitudinal study of dissociative symptomatology in a nonclinical sample.
Development and Psychopathology, 9, pp. 855-880.
OLAUSSON, H., LAMARRE, Y., BACKLUND, H., MORIN, C., WALLIN, B.G., STARCK, G. et al. (2002),
“Unmyelinated tactile afferents signal touch and project to insular cortex”. In Nature Neuroscience, 5, pp.
900-904.
ORNSTEIN, R. (1997), The right mind, New York: Harcourt Brace.
OTTENBACHER, K.J., MULLER, L., BRANDT, D., HEINTZELMAN, A., HOJEM, P., SHARPE, P. (1987),
“The effectiveness of tactile stimulation as a form of early intervention: a quantitative evaluation”. In Journal
of Developmental and Behavioral Pediatrics, 8, pp. 68-76.
PARKS, G.A., ANDERSON, B.K., MARLATT, G.A. (2001), “Relapse prevention therapy”. In HEATHER, N.,
PETERS, T.J., STACKWELL, T. (a cura di), Interpersonal Handbook of Alcohol Dependence and
Problems. John Wiley, New York, pp. 575-592.
PERRY, B. (2001), “The neurodevelopmental impact of violence in childhood”. In SCHETKY, D., BENEDEK,
E. (a cura di), Textbook of Child and adolescent Forensic Psychiatry. American Psychiatric-Press,
Washington, DC.
PHAN, K.L., WAGER, T., TAYLOR, S,F., LIBERZON, I. (2002), “Functional neuroanatomy of emotion: A
meta-analysis of emotion activation studies in Pet and fMri”. In NeuroImage, 16, pp. 331-348.
PIKE, A., PLOMIN, R. (1996), “Importance of nonshared environmental factors for children and adolescent
psychopathology. In Journal of the American Academy of Child and adolescent Psychiatry, 35, pp. 560570.
PLATEK, S.M., KEENAN, J.P., GALLUPP, G.G. jr., MOHAMED, F.B. (2004), “Where am I? The neurological
correlates of self and other”. In Brain Research and Cognitive Brain Research, 19, pp. 114-122.
PLOMIN R. (1990), Natura ed esperienza”. Tr. it. Raffaello Cortina, Milano, 1998.
PLOMIN, R., RENDE, R., RUTTER, M. (1991), ”Quantitative genetics and developmental psychopathology”.
In: CICCHETTI, D., TOTH, L.S. (a cura di) Rochester Symposium on Developmental Psychopathology.
Vol. 2. Internalizing ed Externalizing expressions of dysfunction. Erlbaum, Hillsdale.
PORGES, S.W. (1994), “Orienting in a defensive world: mammalian modifications of our evolutionary
heritage. A polyvagal theory”. In Psychophysiology, 32, pp. 301-318.
PORGES, S.W., DOUSSARD-ROOSEVELT, J.A., MAITI, A.K. (1994), “Vagal tone and the physiological
regulation of emotion”. In Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, pp. 167-186.
PORGES, S.W., DOUSSARD-ROOSEVELT, J.A., PORTALES, A.L., GREENSPAN, S.I. (1996), “Infant
regulation of the vagal „brake‟ predicts child behaviour problems: a psychobiological logical model of social
behaviour”. In Developmental Psychobiology, 29, pp. 697-712.
PORGES, S.W. (1998), “Love: an emergent property of the mammalian autonomic nervous system”. In
Psychoneuroendocrinology, 23, pp. 837-861.
36
PORGES, S.W. (2003), “The polyvagal theory: phylogenetic contributions to social behaviour”. In Physiology
and Behavior, 79, pp 503-513.
POST, R.M., WEISS, S.R.B. (1997) “Emergent properties of neural systems. How focal molecular
neurobiological alterations can affect behaviour”. In Development and Psychopathology, 9, pp. 907-930.
PRICE, J.L. (1999), “Prefrontal cortical networks related to visceral function and mood”. In Annals of the New
York Academy of Sciences”, 877, pp. 383-396.
PRIGATANO, G.P., ROUECHE, J.R., FORDYCE, D.J. (1986), Nonaphasic language disturbances after
brain injury. In PRIGATANO, G.P., FORDYCE, D.J., ZEINER, H.K., ROUECHE, J.R., PEPPING, M.,
WOOD, B.C. (Eds.), Neuropsychological rehabilitation after brain injury. Baltimore: John Hopkins
University Press.
RAKIC, P., BOURGEOIS, J.P., GOLDMAN-RAKIC, P.S. (1994), “Synaptic development of the cerebral
cortex: Implications for learning memory and mental illness. In Progress in Brain Research, 102, pp. 227243.
RICCIARDELLI, P., RO, T., DRIVER, J. (2002), “A left visual field advantage in perception of gaze direction”.
In Neuropsychologia, 40, pp. 769-777.
RILLING, J.K., GUTMAN, D.A., ZEH, T.R., PAGNONI, G., BERNS, G.S., KILTS, C.D. (2002), “A neural basis
for social cooperation”. In Neuron, 35, pp. 395-405.
RIZZOLATTI, G., FADIGA, L., GALLESE, V., FOGASSI, L. (1996), “Premotor cortex and the recognition of
motor actions”. In Cognitive Brain Research, 3, pp. 131-141.
RIZZOLATTI, G., ARBIB, M.A. (1998), “Language within our grasp”. In Trends in Neurosciences, 21, pp.
188-194.
RIZZOLATTI, G., FADIGA, L., FOGASSI, L., GALLESE, V. (1999), “Resonance behaviors and mirror
neurons”. In Archives Italiennes de Biologie, 137, pp. 85-100.
RIZZOLATTI, G., SINIGAGLIA, C. (2006), So quel che fai. Il cervello che agisce ed i neuroni specchio.
Raffaello Cortina, Milano.
RIZZOLATTI, G.; FABBRI-DESTRO, M. (2008), “The mirror system and its role in social cognition”. In
Current Opinion Neurobiology, 18(2), pp. 179-184.
ROBERTSON, D.A., GERNSBACHER, M.A., GUIDOTTI, S.J., ROBERTSON, R.R.W., IRWIN, W., MOCK,
B.J., CAMPANA, M.E. (2000), “Functional neuroanatomy of the cognitive process of mapping during
discourse comprehension. In Psychological Science, 11, 255-260.
ROSENSTEIN, D., HOROWITZ, H.A. (1996), “Adolescent attachment and psychopathology”. In Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 64, pp. 244-253.
ROSSION, B., DRICOT, L., DEVOLDER, A., BODART, J.M., CROMMELINCK, M., DE GELDER, B. et al.
(2000), “Hemispheric asymmetries for whole-based and part-based face processing in the human fusiform
gyrus”. Journal of Cognitive Neuroscience, 12, pp. 793-802.
ROTENBERG, V.S. (1994), “An integrative psychophysiological approach to brain hemisphere functions in
schizophrenia. In Neuroscientific Behaviour Review, 18, pp. 487-495.
RUTTER, M., DUNN, J., PLOMIN, R., SIMONOFF, E., PICKLES, A., MAUGHAN, B., ORMEL, J., MEYER,
J., EAVES, L. (1997), “Integrating nature and nurture: Implications of person-environment correlations and
interactions in developmental psychopathology. In Development and Psychopathology, 9, pp. 335-364.
RYAN, R.M., KUHL, J., DECI, E.L. (1997), “Nature and autonomy: An organizational view of social and
neurobiological aspects of self-regulation in behaviour and development”. In Development and
Psychopathology, 9, pp. 701-728.
SASSAROLI, S., LORENZINI, R., RUGGIERO, G.M. (2006), Psicoterapia cognitiva dell’ansia, Raffaello
Cortina, Milano.
SCHIFFER, F., TEICHER, M.H., PAPANICOLAOU, A.C. (1995), “Evoked potential evidence for right brain
activity during the recall of traumatic memories”. In Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences,
7, pp. 169-175.
SCHORE, A.N. (1994), Affect regulation and the origin of the Self: The neurobiology of emotional
development. Erlbaum, Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates, 1993.
SCHORE, A.N. (1996), “The experience-dependent maturation of a regulatory system in the orbital prefrontal
cortex and the origin of developmental psychopathology”. In Development and Psychopathology, 8, pp. 5987.
SCHORE, A.N. (1997), “Early organization of the non linear right brain and development of a predisposition
to psychiatric disorders. In Development and Psychopathology, 9, pp. 595-631.
37
SCHORE, A.N. (1998a), “Early shame experiences and infant brain development”. In GILBERT, P., SHAME,
B.A. (1998), Interpersonal Behavior, Psychopathology and Culture. Oxford University Press, New York.
SCHORE, A.N. (1998b), “The experience-dependent maturation of an evaluative system in the cortex”. In
PRIBRAM, K.H., KING, J. (a cura di) Brain and Values: Is a biological science of values possible?
Erlbaum, Mahwah.
SCHORE, A.N. (1999a), “Parent-infant communication and the neurobiology of emotionaql development”.
Articolo presentato al 14° Convegno annuale “Zero to Three”, losa Angeles, CA, December.
SCHORE, A.N. (1999b), “Practical implications of brain research as it relates to infant/holder development”.
Articolo presentato al Rand/UCLA Child and Adolescent Health Policy Seminar, Rand Corporation, Santa
Monica, CA, May.
SCHORE, A.N. (2000a), “Attachment and the regulation of the right brain”. In Attachment and Human
Development, 2, pp. 23-47.
SCHORE, A.N. (2000b), “The self-organization of the right brain and the neurobiology of emotional
development”. In LEWIS, M.D., GRANIC. I. (a cura di), Emotion, Development and Self-Organization.
Cambridge University Press, New York.
SCHORE, A.N. (2000c), “Attachment, the developing brain and psychotherapy”. Articolo presentato al
Seventh John Bowlby Memorial Lecture, London, March.
SCHORE, A.N. (2000d), “Parent-infant communication and the neurobiology of emotional development”.
Articolo presentato alla Head Start.s Fifth National Research Conference. “Developmental and contextual
transitions of children and families: Implications for research, policy and practice”. Department of Health
and Human Services, Washingotn, DC, June.
SCHUMAN, J. (1997), The neurobiology of affect in language, Blackwell, Malden.
SEGAL, Z.V., WILLIAMS, J.M.G., TEASDALE, J.D. (2002) Mindfulness-based cognitive therapy for
depression: A new approach to preventing relapse. Guilford Press, New York.
SHAPIRO, D., JAMNER, L.D., SPENCE, S. (1997), “Cerebral laterality, repressive coping, autonomic
arousal and human bonding”. In Acta Physiologica Scandinavica, 640, suppl. pp. 60-64.
SHAPIRO, S..C., CARLSON, C.E., ASTIN, J.A., FREEDMAN, B. (2006), “Mechanism of mindfulness”. In
Journal of Clinical Psychology, 62, 3, pp. 373-386.
SHERRY, D.P., JACOBS, L.P., GAULIN, S.J. (1992), “Spatial memory and adaptive specialization of the
hippocampus”. In Trends in Neurosciences, 15, pp. 298-303.
SIEGEL, D.J.(1999), La mente relazionale. Neurobiologia dell’esperienza interpersonale. Tr. it. Raffaello
Cortina Ed., Milano, 2001.
SIEGEL, D.J, (2009), Mindfulness e cervello, Raffaello Cortina Editore.
SMUCKER, M. R., DANCU, C., FOA, E. B., NIEDEREE, J. L. (1995), “Imagery rescripting: a new treatment
for survivors of childhood sexual abuse suffering from post-traumatic stress”. In Journal of Cognitive
Psychotherapy, 9, 3-17.
SOLOMON, J., GEORGE, C., DE JONG, A. (1995), “Children classified as controlling at age six: Evidence
for disorganized representational strategies and aggression at home and at school”. In Development and
Psychopathology, 7, pp. 447-463
SOLOMON, J., GEORGE, C. (1999), L’attaccamento disorganizzato. Tr. it. Il Mulino, Bologna 2007.
SPENCE, S., SHAPIRO, D., ZAIDEL, E. (1996), “The role of the right hemisphere in the physiological and
cognitive components of emotional processing”. In Psychophysiology, 33, pp. 112-122.
SROUFE, L.A. (2000), Lo sviluppo delle emozioni. Tr. it. Raffaello Cortina.
STEMMER, B. (1999), “Discourse studies in neurologically impaired populations: A quest for action. In Brain
and Language, 70, 402-418.
STERN, D. (1985), Il mondo interpersonale del bambino. Tr. it. Boringhieri, Torino, 1987.
St. GEORGE, M., KUTAS, M., MARTINEZ, A., SERENO, M.I. (1999), “Semantica integration in reading:
Engagement of the right hemisphere during discourse processing. In Brain, 122, 1317-1325.
STONE, L.A., NIELSON, K.A. (2001), “Intact physiological response to arousal with impaired emotional
recognition in alexithymia”. In Psychotherapy and Psychosomatics, 70, pp. 92-102.
STUSS, D.T., ALEXANDER, M.P. (1999), “Affectively burnt in: a proposed role of the rightfrontal lobe”. In
TULVING, E. (a cura di), Memory, Consciousness and the brain: The Tallin Conference. Psychology
Press, Philadelphia, pp. 215-227.
SUTTON, S.K., DAVIDSON, R.J. (1997), “Prefrontal brain asymmetry: a biological substrate of the
behavioural approach and inhibition systems”. In Psychological Science, 8, pp. 204-210.
38
TAYLOR, G.J. (2000), “Recent developments in alexithymia theory and research”. In Canadian Journal of
Psychiatry, 45, pp. 134-142.
THOMPSON, R.A. (1999), Attaccamento infantile e sviluppo successivo”. Tr. it. In CASSIDY, J., SHAVER,
P.R. (1999) (a cura di), Manuale dell’attaccamento: teoria, ricerca e applicazioni cliniche. Fioriti, Roma,
2002.
TREVARTHEN, C. (1990), Growth and education of the hemispheres. In C. Trevarthen, C ( cura di), Brain
circuits and functions of the mind (pp. 334-363), Cambridge, England, Cambridge University Press.
TREVARTHEN, C. (1993), “The self born in intersubjectivity: The psychology of an infant communicating”. In
NEISSER, U. (a cura di), The Perceived Self: Ecological and Interpersonal Sources of Self-Knowledge.
Cambridge University Press, New York.
TSANKOVA, N., RENTHAL, W., KUMAR, A., NESTLER, E.J. (2007), “Epigenetic regulation in psychiatric
Disorders”. In Nature Reviews Neuroscience, vol. 8, n. 5, pp. 355-367.
TUCKER, D.M. (1992), “Developing emotions and cortical networks. In Gunnar, M.R., Nelson, C.A. (a cura
di), Minnesota Symposium on Child Psychology, vol. 24: Developmental Behavioral Neuroscience.
Erlbaum, Hillsdale, N.J., pp. 75-128.
TUCKER, D.M., LUU, P., PRIBRAM, K.H. (1995) “Social and emotional self-regulation”. In Annals of the
New York Academy Sciences, 769, pp. 213-239.
VAN LANGE, P.A., OTTEN, W., DE BRUIN, E.M., JOIREMAN, J.A. (1997), ”Development of prosocial,
individualistic and competitive orientations: theory and preliminary evidence”. In Journal of Personality and
Social psychology, 73, pp. 733-746.
VOELLER, K.K.S. (1986), “Right hemisphere deficit syndrome in children. In American Journal of
Psychology, 143, 1004-1009.
VOELLER, K.K.S., HANSON, J.A., WENDT, R.N. (1988), “Facial affect recognition in children: a comparison
of the performance of children with rights and left hemisphere lesions”. In Neurology, 38, pp. 1744-1748.
WANG, S. (1997), “Traumatic stress and attachment”. In Acta Physiologica Scandinavica, 640, pp. 164-169.
WEINTRAUB, S., MESULAM, M. (1983), “Developmental learning disabilities of the right hemisphere:
emotional, interpersonal and cognitive components”. In Archive of Neurology, 40, 463-468.
WELLER, A., FELDMAN, R. (2003), “Emotion regulation and touch in infants: the role of cholecystokinin and
opioids”. In Peptides, 24, pp. 779-788.
WINNICOTT, D.W. (1965), Sviluppo affettivo e ambiente. Tr. it. Armando, Roma, 1970.
WINNICOTT, D.W. (1971), Gioco e realtà. Tr. it. Armando, Roma, 1974.
WITTLING, W., SCHWEIGER, E. (1993), “Neuroendocrine brain asymmetry and physical complaints”. In
Neuropsychologia, 31, pp. 591-608.
WITTLING, W. (1997), “The right hemisphere and the human stress response”. In Acta Pshysiologica
Scandinavica, suppl., 640, pp 55-59.
YOUNG, J. E. (1994), Cognitive therapy for personality disorders: a schema-focused approach (Revised
ed.). Sarasota: Professional Resource Press.
YOUNG, J. E., KLOSKO, J. B. (1994), Reinventing your Life. New York: Plume/Penguin Books USA.
ZAIDEL, D.W., HUGDAHI, K., JOHNSEN, B.H. (1995), “Physiological responses to verbally inaccessible
pictorial information in the left and right hemisphere”. Neuropsychology, 9, pp. 52-57.
ZEITLIN, S.B., McNALLY, R.J., CASSIDAY, K.L. (1993), “Alexithymia in victims of sexual assault: an effect
of repeated traumatisation?”. In American Journal of Psychiatry, 150, pp. 661-663.
ZEANAH, C.H., BORIS, N.W., LARRIEU, J.A. (1997a), “Infant development and developmental risk: A
review of the past 10 years. In Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36,
pp. 165-178.
ZEANAH, C.H., FINELY-BELGRAD, E., BENOIT, D. (1997b), Intergenerational transmission of relationship
psychopathology: A mother-infant case study. In: ATKINSON, L., ZUCKER, K.J. (a cura di) Attachment
and Psychopathology, Guilford Press, New York.
39