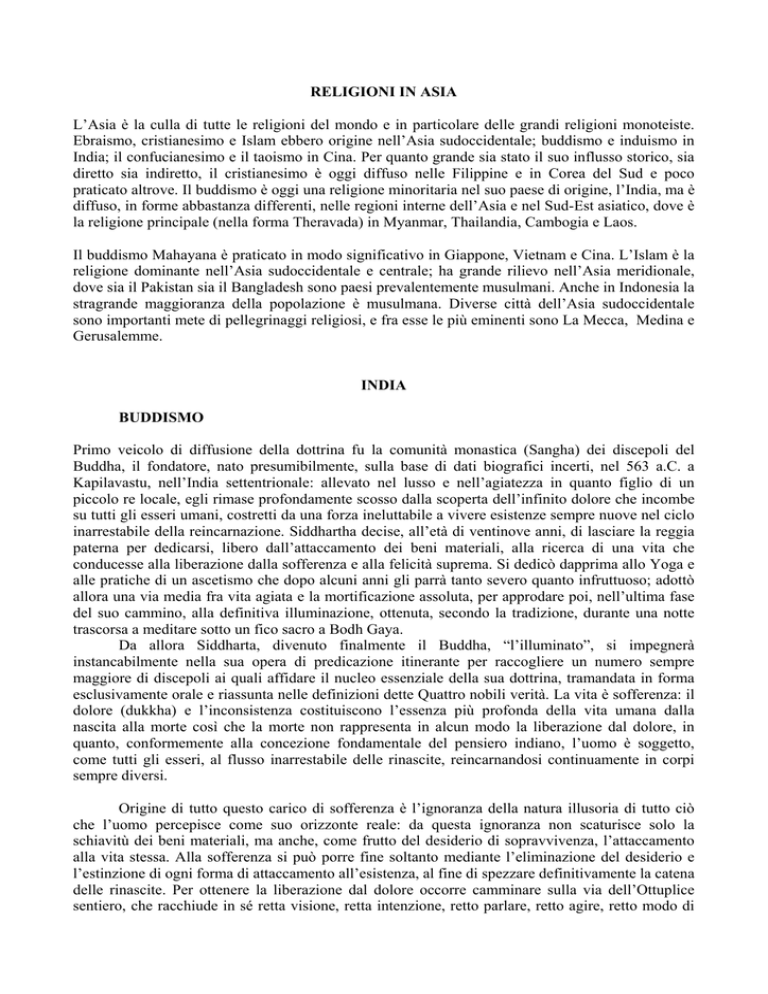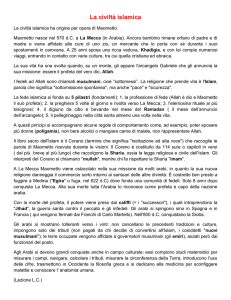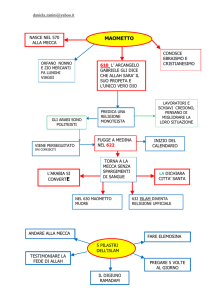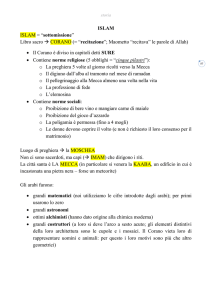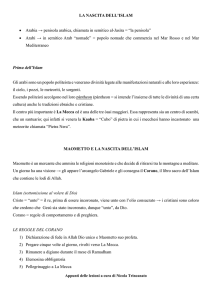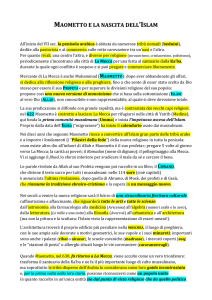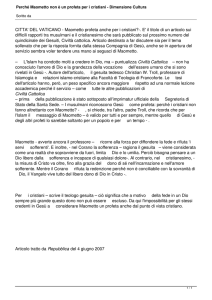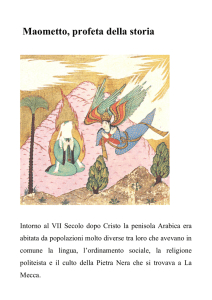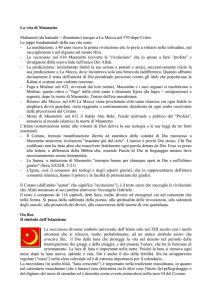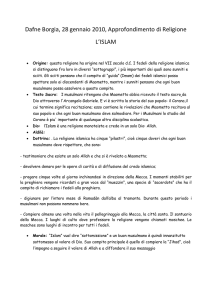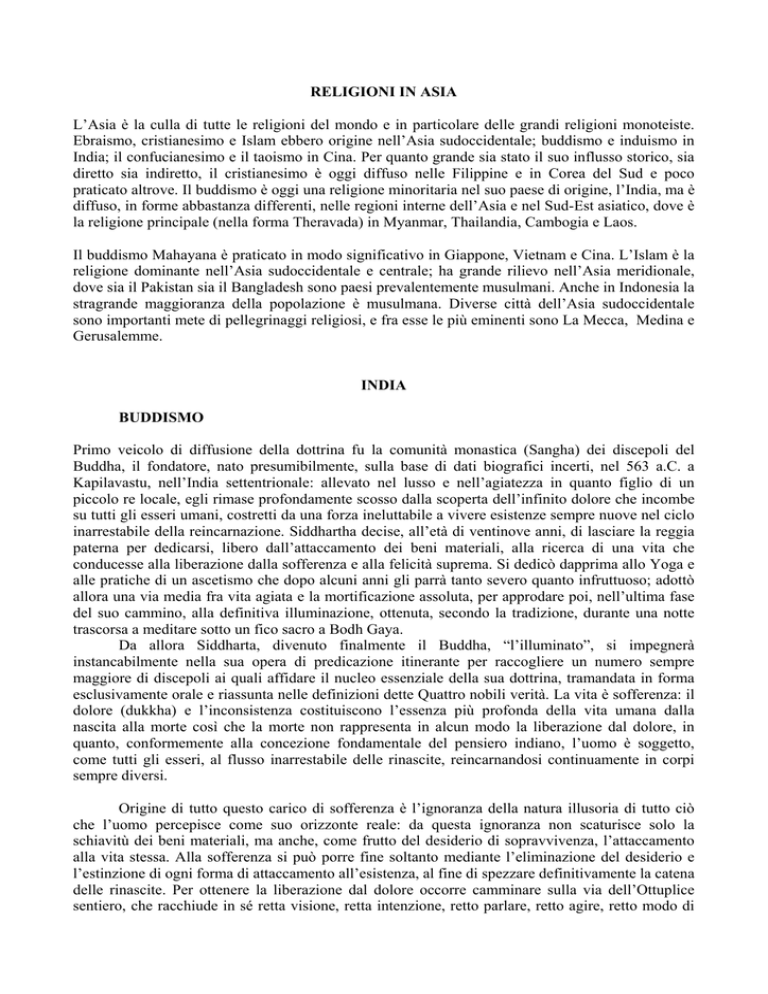
RELIGIONI IN ASIA
L’Asia è la culla di tutte le religioni del mondo e in particolare delle grandi religioni monoteiste.
Ebraismo, cristianesimo e Islam ebbero origine nell’Asia sudoccidentale; buddismo e induismo in
India; il confucianesimo e il taoismo in Cina. Per quanto grande sia stato il suo influsso storico, sia
diretto sia indiretto, il cristianesimo è oggi diffuso nelle Filippine e in Corea del Sud e poco
praticato altrove. Il buddismo è oggi una religione minoritaria nel suo paese di origine, l’India, ma è
diffuso, in forme abbastanza differenti, nelle regioni interne dell’Asia e nel Sud-Est asiatico, dove è
la religione principale (nella forma Theravada) in Myanmar, Thailandia, Cambogia e Laos.
Il buddismo Mahayana è praticato in modo significativo in Giappone, Vietnam e Cina. L’Islam è la
religione dominante nell’Asia sudoccidentale e centrale; ha grande rilievo nell’Asia meridionale,
dove sia il Pakistan sia il Bangladesh sono paesi prevalentemente musulmani. Anche in Indonesia la
stragrande maggioranza della popolazione è musulmana. Diverse città dell’Asia sudoccidentale
sono importanti mete di pellegrinaggi religiosi, e fra esse le più eminenti sono La Mecca, Medina e
Gerusalemme.
INDIA
BUDDISMO
Primo veicolo di diffusione della dottrina fu la comunità monastica (Sangha) dei discepoli del
Buddha, il fondatore, nato presumibilmente, sulla base di dati biografici incerti, nel 563 a.C. a
Kapilavastu, nell’India settentrionale: allevato nel lusso e nell’agiatezza in quanto figlio di un
piccolo re locale, egli rimase profondamente scosso dalla scoperta dell’infinito dolore che incombe
su tutti gli esseri umani, costretti da una forza ineluttabile a vivere esistenze sempre nuove nel ciclo
inarrestabile della reincarnazione. Siddhartha decise, all’età di ventinove anni, di lasciare la reggia
paterna per dedicarsi, libero dall’attaccamento dei beni materiali, alla ricerca di una vita che
conducesse alla liberazione dalla sofferenza e alla felicità suprema. Si dedicò dapprima allo Yoga e
alle pratiche di un ascetismo che dopo alcuni anni gli parrà tanto severo quanto infruttuoso; adottò
allora una via media fra vita agiata e la mortificazione assoluta, per approdare poi, nell’ultima fase
del suo cammino, alla definitiva illuminazione, ottenuta, secondo la tradizione, durante una notte
trascorsa a meditare sotto un fico sacro a Bodh Gaya.
Da allora Siddharta, divenuto finalmente il Buddha, “l’illuminato”, si impegnerà
instancabilmente nella sua opera di predicazione itinerante per raccogliere un numero sempre
maggiore di discepoli ai quali affidare il nucleo essenziale della sua dottrina, tramandata in forma
esclusivamente orale e riassunta nelle definizioni dette Quattro nobili verità. La vita è sofferenza: il
dolore (dukkha) e l’inconsistenza costituiscono l’essenza più profonda della vita umana dalla
nascita alla morte così che la morte non rappresenta in alcun modo la liberazione dal dolore, in
quanto, conformemente alla concezione fondamentale del pensiero indiano, l’uomo è soggetto,
come tutti gli esseri, al flusso inarrestabile delle rinascite, reincarnandosi continuamente in corpi
sempre diversi.
Origine di tutto questo carico di sofferenza è l’ignoranza della natura illusoria di tutto ciò
che l’uomo percepisce come suo orizzonte reale: da questa ignoranza non scaturisce solo la
schiavitù dei beni materiali, ma anche, come frutto del desiderio di sopravvivenza, l’attaccamento
alla vita stessa. Alla sofferenza si può porre fine soltanto mediante l’eliminazione del desiderio e
l’estinzione di ogni forma di attaccamento all’esistenza, al fine di spezzare definitivamente la catena
delle rinascite. Per ottenere la liberazione dal dolore occorre camminare sulla via dell’Ottuplice
sentiero, che racchiude in sé retta visione, retta intenzione, retto parlare, retto agire, retto modo di
sostentarsi, retto impegno, retta consapevolezza, retta meditazione: si tratta, in pratica, del
compendio fondamentale della fede buddista, che vede nella moralità la premessa e insieme la
conseguenza della saggezza e della capacità di possederla attraverso la meditazione.
La riflessione del Buddha muove dalla definizione dell’esistenza umana come complesso di
azioni indotte dalla presenza condizionante di cinque elementi: il corpo materiale, i sentimenti, le
percezioni, la tendenza all’agire e la coscienza. Essi, denominati in sanscrito skandha, “legami”,
con il loro temporaneo e mutevole aggregarsi costituiscono la natura stessa della persona, e di
conseguenza ne determinano, con l’attaccamento alla vita e la propensione all’azione, la
sottomissione alla sofferenza; essa ha luogo nell’ambito di un’esistenza materiale destinata ad
essere per sua natura non permanente (anitya) e, in definitiva, segnata da una condizione negativa in
quanto anatman, esistenza non dotata di una propria essenza.
Da questa concezione dipende anche la formulazione alla quale il Buddha ricorre per
spiegare il concetto di samara, il flusso ininterrotto di rinascite posto come caposaldo
imprescindibile da tutte le correnti del pensiero indiano: secondo la dottrina del pratityasamutpada,
ovvero dell”origine incondizionata”, una catena di dodici cause agisce in ciascuna esistenza
dell’individuo portandolo a ignorare la natura illusoria di tutta quanta la realtà e rendendo possibile
l’azione degli elementi aggregati, che lo spingono all’attaccamento alla vita stessa. Di conseguenza,
l’individuo è indotto alla ricerca spasmodica di una sorta d’immortalità attraverso la rinascita
continua in corpi materiali sempre nuovi: ogni esistenza è così legata indissolubilmente alle infinite
esistenze precedenti e a quelle future, in una catena inestricabile di sofferenza che il saggio deve
necessariamente spezzare.
In questo indirizzo di pensiero trova posto anche l’altro concetto portante della tradizione
indiana, quello di karma, la conseguenza etica indotta dal complesso delle azioni che l’individuo
compie in ciascuna esistenza, determinando inesorabilmente la sua condizione nell’esistenza
successiva, secondo una logica di premio e di punizione: la condotta in vita porta con sé la
possibilità di rinascere sotto forma di animale, oppure di uomo, di demone, di divinità. Prendendo
atto della presenza ineluttabile del karma nell’infinita vicenda umana, il Buddha ravvisa
nell’aspirazione a una vita di ordine superiore il legame che determina – pur nella forma di un
impegno etico e religioso volto al nobile fine dell’accumulo dei meriti – l’attaccamento all’azione
con il conseguente carico di sofferenza. Anche gli dei, che pure apparentemente vivono in uno stato
di somma beatitudine, non sfuggono alla suprema legge dell’universo, all’incombere della morte e
alla possibilità di reincarnarsi in un essere inferiore: essi sono privi di ogni capacità di influire
fattivamente sul destino degli uomini, le cui preghiere e sacrifici si rivelano assolutamente
inefficaci, meramente utili a perpetuare, con la speranza illusoria nel valore delle azioni, la
sottomissione a un karma di dolore. L’illusione domina ancor più beffardamente le stesse divinità
che, inconsapevoli della realtà incombente anche su di loro, non avvertono neppure la possibilità di
raggiungere la salvezza autentica per mezzo dell’illuminazione: solo gli uomini, vicini come sono
alle manifestazioni più concrete del dolore, possono sperare di prendere coscienza delle sue cause e
di ottenere l’illuminazione unica e definitiva che ponga fine al ciclo infinito delle rinascite.
Il fine ultimo dell’uomo che segue il cammino di salvezza suggeritogli dal Buddha è il
raggiungimento della condizione suprema del nirvana, l’estinzione di ogni desiderio e la libertà da
ogni forma di condizionamento materiale e psicologico: ottenuta questa illuminazione interiore, il
saggio prosegue il cammino della sua esistenza terrena liberandosi gradualmente del carico del
karma che lo lega al corpo materiale e preparando la strada alla liberazione definitiva, la condizione
del parinirvana, il nirvana definitivo, l’annientamento totale che coincide con il momento della
morte. Raggiungibile teoricamente da tutti i fedeli, questa condizione di beatitudine eterna è posta
più realisticamente, già nella prima fase dello sviluppo del buddismo (soprattutto dai maestri della
scuola Theravada), come meta principale soltanto per i membri della comunità monastica. Questi
ultimi devono mirare a ottenere l’illuminazione e a essere venereati come arhat, saggi giunti allo
stato di perfezione al termine del lungo cammino sulla via dell’Ottuplice sentiero. Agli altri fedeli
non resta che rassegnarsi all’accumulo di meriti che consente, attraverso l’osservanza, nel corso
della lunga vicenda delle rinascite successive, della legge morale – non uccidere, non rubare, non
pronunciare menzogna, non fare uso di sostanze inebrianti e non abbandonarsi al disordine sessuale
– di reincarnarsi finalmente nella condizione di monaco per compiere il passo decisivo verso la
liberazione.
Buddismo Mahayana Una delle due correnti principali del buddismo, diffusasi dall’India in
Cina, Corea, Giappone, Tibet, Asia Centrale e Vietnam. E’ considerata dagli aderenti come
depositaria dell’autentica tradizione dottrinale risalente al Buddha, in opposizione alla più antica
scuola del buddismo Theravada. Il Mahayana (in sanscrito, “Grande veicolo”), che già nel periodo
indiano appare diviso in due scuole, la Madhyamika e la Vijnanavada, diede origine, diffondendosi
al di fuori dell’India, a ulteriori sviluppi dottrinali, come quelli della scuola della Terra Pura e del
buddismo Zen.
INDUISMO
La cosmologia è il motivo ispiratore fondamentale della teoria dell’induismo ed è fondata su
una concezione che intende l’universo come un grande uovo cosmico con cieli, mondi infernali,
oceani e continenti disposti concentricamente intorno all’India; questo universo sconfinato è
destinato a una esistenza eterna ma ciclica, segnata da una degenerazione costante e inesorabile, da
una sorta di Età dell’Oro della durata di 1.728.000 anni, detta Krta Yuga, fino all’epoca più triste e
precaria, il Kali Yuga, di 432.000 anni, al culmine della quale il cosmo viene interamente divorato
dalle fiamme e dai flutti come in un rito di purificazione generale capace di rigenerare l’Età
dell’Oro e dare avvio a un nuovo ciclo. Allo stesso modo l’esistenza umana è coinvolta nel ciclo
inarrestabile delle rinascite, reso possibile dalla trasmigrazione delle anime, che alla morte
dell’individuo si reincarnano nel corpo di un altro essere vivente, in un processo eterno conosciuto
come samsara.
Ogni uomo è destinato a reincarnarsi in un essere di qualità superiore o inferiore secondo i
meriti accumulati nell’esistenza attraverso l’insieme delle sue azioni, il karma, realtà
tendenzialmente negativa, ma indirizzabile verso un fine positivo per mezzo di pratiche di
devozione e di espiazione che trovano il loro vertice nelle forme di ascetismo volte ad ottenere la
“liberazione”, moksha, dall’attaccamento alla realtà materiale e alle errate concezioni dell’esistenza.
Nei concetti essenziali di samsara, karma e moksha, la tradizione indiana sintetizza i contenuti
essenziali di una visione sostanzialmente pessimistica circa il valore della realtà cosmica e
materiale, il cui incombere inesorabile deve essere assolutamente esorcizzato attraverso un
cammino di liberazione e di rinuncia al mondo, secondo l’ideale delle numerose correnti ascetiche
presenti in India fin dall’antichità.
La considerazione del carattere inesorabile della dimensione materiale dell’esistenza
giustifica l’altro fondamentale aspetto prescrittivi dell’induismo. Questa prescrizione, solo
apparentemente contraddittoria rispetto alle tendenze ascetiche, impone a ogni fedele di assumere
un ruolo preciso nella società, per portare a compimento il dovere assegnatogli dal karma al
momento della nascita, contribuendo a perpetuare il ciclo della storia attraverso la procreazione e a
procurare il benessere materiale a sé e ai suoi simili, nella speranza di ottenere il premio delle
proprie azioni nell’esistenza futura con la trasmigrazione della propria anima nel corpo di un essere
di livello sociale superiore o in quello di un asceta.
Questo atteggiamento fornisce la giustificazione filosofica per la dottrina più nota e
controversa dell’induismo, ovvero la rigida divisione della società in classi, vama, note in Occidente
con il termine, di origine portoghese, caste, alle quali si appartiene per nascita senza alcuna
possibilità di sfuggire alle severe norme di una concezione gerarchica. Un ruolo di assoluta
preminenza è attribuito infatti ai membri delle tre classi superiori, quelle dei sacerdoti (brahmani),
dei guerrieri (ksatriya) e dei lavoratori qualificati (vaisya), che riservano una condizione di totale
sottomissione a chi appartiene alle caste inferiori, da quelle considerate servili (sudra) fino a quelle,
disprezzate come impure, degli “intoccabili”, i “paria” della tradizione occidentale. Questi ultimi, in
India, sono definiti candala, termine riferito impropriamente a chi si trovi nella condizione di “fuori
casta”, perché nato dall’unione illecita fra una donna di casta brahmanica e un uomo di casta
servile.
Il matrimonio fra coniugi appartenenti alla stessa classe costituisce per l’appunto una delle
regole fondamentali dell’organizzazione castale, le cui origini storiche risalirebbero all’epoca
dell’insediamento in India delle tribù indoeuropee, portatrici, secondo la tesi suggestiva ma
controversa dello studioso francese Georges Dumézil, di una “ideologia tripartita”, con le figure del
sacerdote, del guerriero e dell’agricoltore poste a garanzia della buona organizzazione della società:
riservandosi queste tre funzioni e tramandandole ereditariamente nelle caste superiori, gli invasori
indoeuropei avrebbero inquadrato nelle caste inferiori gli abitanti indigeni dell’India. Formalmente
abolito dalla costituzione dell’India moderna, il sistema delle caste continua comunque a
rappresentare per la tradizione indù l’ambito privilegiato per la realizzazione dell’ordine sociale,
riflesso nell’ordine cosmico, il dharma, che ogni fedele contribuisce a determinare conformandosi
ai doveri previsti dallo svadharma, il dharma del singolo individuo, e impegnandosi a realizzare
con successo, anche in termini meramente materiali, il fine (artha) assegnato alla sua esistenza.
Contemplando tra i fini essenziali dell’essere umano anche il soddisfacimento del desiderio
amoroso, kama, il pensiero indù non scorge, in questa tendenza a codificare ogni aspetto della vita
sociale e materiale, alcuna contraddizione con l’aspirazione alla moksha, la liberazione che gli
asceti cercano in modo radicale mirando a cogliere l’identità fra l’atman, l’anima individuale, e il
brahman, il fondamento dell’universo.
La volontà di armonizzare in modo sempre più efficace questi due aspetti portò alla
definizione di concetti come quello di “dharma eterno”, sanatana dharma, una sorta di codice etico
ideale che, sovrapponendo ai doveri sociali alcuni atteggiamenti più specificatamente ascetici,
aspira a superare, considerandole come necessità relativa, le prescrizioni del dharma tradizionale,
come avviene nel caso della definizione della “non violenza”, ahisma, concepita come assenza del
desiderio della violenza da parte del fedele, che tuttavia è disposto a utilizzarla qualora il proprio
ruolo nella società e le condizioni contingenti lo richiedano.
Si delinea così la dottrina centrale dell’induismo che invita il fedele a rispettare le regole del
vivere sociale assumendo tuttavia una atteggiamento di totale distacco da questa dimensione e
soprattutto dai frutti prodotti dalle azioni; secondo l’insegnamento della Bhagavad-Gita, uno dei
principali testi di riferimento della devozione indù, il saggio accetta tutte le incombenze
assegnategli dal karma, imponendosi tuttavia di non godere in alcun modo del frutto delle proprie
azioni e di non considerarle come l’orizzonte principale della propria esistenza. Gli obblighi sociali
costituiscono soltanto, assieme ai riti, il contributo del singolo fedele alla necessità del karma,
superabile comunque attraverso la conoscenza (jnana) della dimensione trascendente, quella del
brahman universale, che è accessibile per mezzo della meditazione.
Sintesi efficace, anche a livello di pratica popolare, di queste due tappe fondamentali
dell’espressione religiosa, è il concetto di bhakti, la devozione entusiastica alle divinità:
interpretando infatti i singoli esseri divini come emanazioni dello spirito universale, il brahman, la
tradizione indù consente al devoto di soddisfare, con la pratica della bhakti, le esigenze del karma,
imponendogli di riservare agli dei tutti gli atti di culto previsti dal rituale, che costituisce però
soltanto la prima tappa del percorso devozionale e il preludio al momento della comprensione,
attraverso la conoscenza, della divinità come parte della realtà ultima, infinitamente superiore alla
sua manifestazione materiale, fonte di illusione (maya) per quanti si limitino a essa spinti
dall’ignoranza.
In questa prospettiva i fedeli rivolgono la loro devozione preferibilmente a una delle divinità
principali del pantheon indiano, a Shiva, a Vishnu o alla dea madre, la Devi, considerando ciascuno
di essi come manifestazione dell’assoluto universale, personificato anche nella divinità creatrice,
Brahma, il regolatore della legge del karma. Contemplando l’estasi erotica della sua seconda sposa,
Sarasvati, talvolta indicata anche come sua figlia, Brahma si sarebbe ritrovato con cinque teste,
prima che Shiva gliene mozzasse una per punirlo del rapporto incestuoso con la figlia: i devoti di
una delle tante correnti shivaite usano ancora come ornamento un teschio, come Shiva fu costretto a
fare dopo il suo gesto cruento, fino al giorno in cui si sarebbe purificato dal sangue del padre
immergendosi nelle acque del Gange nel luogo dove oggi sorge la città sacra di Benares.
Shiva assume così a livello cosmologico il ruolo di distruttore e, nello stesso tempo,
rigeneratore del mondo, colui che dispensa la morte, ma anche la vita. Secondo la leggenda, Shiva
fu condannato ad assumere un aspetto fallico per non avere interrotto, pur trovandosi al cospetto del
saggio Bhrgu, la sua unione sessuale con Parvati, uno degli aspetti con i quali si manifesta la dea
madre; questa natura così esplicitamente sensuale del dio non impedisce comunque che egli eserciti
la funzione di divinità principale degli asceti, che lo raffigurano come un saggio dedito all’esercizio
dello yoga. Una delle pratiche più tipiche proposte dalla tradizione indiana come via per
armonizzare le esigenze della vita attiva con l’ideale della rinuncia è la prescrizione della quattro
fasi della vita (asrama), alle quali dovrebbe conformarsi il bramano devoto, osservando un regime
di castità assoluta durante il periodo di formazione giovanile, prima di compiere i suoi doveri di
padre di famiglia fino alle soglie della vecchiaia, quando si ritirerà nella foresta alla ricerca della
liberazione, per raggiungere, nell’ultima tappa del cammino, una condizione simile a quella dei
sannyasin, gli asceti della rinuncia assoluta.
Al dio Vishnu viene invece attribuito il ruolo di conservatore del mondo, che egli esercita
manifestandosi in determinati momenti della storia del cosmo attraverso un’incarnazione, avatara,
per riportare l’ordine fra gli uomini, minacciati da una condizione di instabilità. Settimo avatara di
Vishnu è così l’eroe di Rama, la figura dell’uomo perfetto mentre nel 3102 a.C., all’inizio del ciclo
cosmico attuale, il Kali Yuga segnato dalla decadenza, si sarebbe conclusa l’esistenza dell’ultimo
degli avatara, l’eroe supremo Krishna, cha appare sotto le sembianze di un divino cocchiere per
rivelare la dottrina dell’assenza del desiderio e del distacco dal frutto dell’azione come via efficace
per ottenere la salvezza, garantendo contemporaneamente la sopravvivenza dell’universo. Al
termine di questa era cosmica Vishnu tornerà a manifestarsi agli uomini come figura escatologica
che riporterà nel cosmo l’epoca della felicità e del trionfo del dharma.
Lakshmi è il nome che la dea madre Devi assume come consorte di Vishnu e dea della
buona sorte, Shri, della ricchezza e della bellezza, oltre che madre di Kama, il dio dell’amore; a lei è
consacrata la vacca, animale considerato sacro e meritevole di venerazione. Alla divinità femminile
si indirizzano principalmente le pratiche delle correnti devozionali che riconoscono in lei il
principio assoluto in considerazione del suo ruolo di detentrice della shakti, l’energia creativa
scatenata dagli esseri divini come condizione indispensabile per rendere manifesta la loro natura
trascendente: in questa prospettiva la presenza della dea come sposa delle divinità maschili appare
lo strumento fondamentale per conciliare il carattere di trascendenza dell’essere divino con le sue
funzioni immanenti e terrene. Anche come sposa di Shiva la Devi tende ad assumere il carattere di
divinità principale nei suoi aspetti benevoli di garante della fertilità e simbolo della fedeltà
coniugale (la sati), ovvero “moglie virtuosa”, che, gettandosi fra le fiamme per difendere di fronte
al padre l’onore calpestato del marito, diverrà il personaggio ispiratore del costume, oggi
ufficialmente abbandonato, di immolare le vedove sul rogo funebre del marito. Nelle sue
manifestazioni più inquietanti, la dea è temuta e venerata con l’epiteto di Kali, essere mostruoso
dalle otto braccia, energia distruttiva e signora del tempo, custode della legge inesorabile del karma,
che divora tutto ciò che è vivo per gettare il seme della nuova esistenza, danzando freneticamente
sui corpi dei nemici uccisi, fiera della sua collana di teschi.
A Kali è consacrata, fin nel nome, la città di Calcutta, dove sorge il più grande dei
numerosissimi templi a lei dedicati, il Kalighat, sede del rito del sacrificio animale, che prevede di
norma l’immolazione di capre. Il culto della dea rappresenta in effetti l’unico ambito in cui
l’induismo tradizionale mantenga la pratica antica del sacrificio cruento come forma di offerta
votiva (puja) alla divinità, il più importante fra i rituali della devozione indù, celebrato ormai da
tempo sotto forma di offerta simbolica di cibo (orzo, riso, latte, burro fuso) all’immagine degli dei
nelle migliaia di templi grandi e piccoli dedicati in tutta l’India a Vishnu, a Shiva e agli altri esseri
divini. Particolarmente venerati, fra i luoghi sacri, sono i grandi edifici di culto, come quelli di
Mahabalipuram, mentre a Rishikesh, sull’Himalaya, e nella città sacra di Benares, sul Gange,
convergono pellegrini da tutta l’India. Oltre che nei pellegrinaggi, la devozione dei fedeli si esprime
nei numerosi rituali previsti nelle festività solenni, da quella in onore di Durga (un altro aspetto
della dea madre Devi), che si celebra ogni anno nel Bengala con la venerazione, per dieci giorni,
delle immagini della dea, poi gettate nel Gange durante una suggestiva cerimonia notturna, ai Mela,
momento di incontro fra i devoti e gli asceti, venerati come santi. La festività più solenne è
certamente il Maha Kumbha Mela, la “festa della brocca” (la brocca simboleggia la funzione
generativa della dea madre) celebrata ogni dodici anni ad Allahabad nel punto di confluenza fra il
Gange e lo Yamuna. La ricorrenza primaverile, Holi, costituisce invece una sorta di carnevale
indiano, caratterizzato significativamente dalla rottura temporanea dei legami sociali con l’incontro
di membri delle diverse caste che, liberi da ogni condizionamento, manifestano la loro felicità
inondandosi reciprocamente con cascate di liquidi multicolori.
CINA
CONFUCIANESIMO
Principale scuola di pensiero della filosofia cinese, nata dall’insegnamento di Confucio e dei
suoi discepoli. Le dottrine del confucianesimo si imperniano su principi etici, sull’arte del buon
governo e su una saggezza pratica che concerne la qualità delle relazioni sociali. Affermatosi nel V
secolo a.C. in Cina, dove divenne ideologia ufficiale dello stato sotto la dinastia Han, il
confucianesimo si è poi diffuso in Corea, Giappone e Vietnam, costituendo uno dei fondamenti
ideologici della cultura dell’Asia orientale.
Il confucianesimo non fu mai una religione istituzionalizzata. Gli eruditi cinesi onorarono
Confucio, considerandolo un grande maestro e un saggio, ma non lo venerarono mai come una
divinità personale, sebbene gli occidentali abbiano per lungo tempo ricondotto la fortuna del
confucianesimo al culto degli antenati, che è parte integrante della religione cinese. Confucio non si
proclamò divinità in nessuna occasione: a differenza delle chiese cristiane, i templi eretti in onore di
Confucio non erano luoghi in cui la comunità religiosa si riuniva per pregare, bensì edifici pubblici
destinati a cerimonie annuali, la più importante delle quali si svolgeva nel giorno del compleanno
del filosofo. I numerosi tentativi di divinizzare Confucio e di interpretare il confucianesimo in
chiave religiosa fallirono grazie alla natura essenzialmente laica di questa filosofia.
Gli insegnamenti di Confucio, che vennero dapprima tramandati oralmente e
successivamente redatti in forma scritta nel Lunyu, sono caratterizzati da un chiaro atteggiamento
conservatore in campo morale, giacché l’intento del filosofo era quello di offrire principi immutabili
in un’epoca turbolenta, contrassegnata dal caos politico e dai traumatici mutamenti sociali che
seguirono la disintegrazione del regno di Chou in piccoli stati feudali in guerra fra loro. Questa
instabilità aveva in certo modo costretto Confucio a inaugurare la riflessione sulla perduta “Via
degli antichi re” della dinastia Chou, e sul modo di farla risorgere. Credendo che le virtù morali dei
sovrani e dei cittadini più abbienti potessero garantire la salvezza dello stato, Confucio sottolineò la
funzione educativa dei riti (li), della musica e dei poemi dell’antica letteratura cinese (in gran parte
musicati), nell’ambito di un progetto politico volto all’eliminazione di qualunque turbativa
dell’ordine costituito. Uno stato provvisto dei riti e della musica più appropriata avrebbe reso
automaticamente felici e virtuosi i suoi cittadini: non sarebbero occorse leggi poiché non sarebbero
mai nate dispute.
Il motivo fondamentale dell’etica confuciana è ren, concetto variamente tradotto con i
termini “amore”, “bontà”, “umanità” e “sensibilità”. Ren è la virtù suprema, che rappresenta lo
stadio di piena fioritura umana. Nelle relazioni tra due individui ren si manifesta in zhong (lealtà
reciproca) e in shu (altruismo), espresso nel modo migliore dalla regola aurea confuciana: ”Non fare
agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”. Altre importanti virtù confuciane sono rettitudine,
decoro, integrità e amore filiale: chi possiede tutte queste virtù diviene uno junzi (uomo perfetto). In
ambito politico Confucio appoggiò un governo di tipo paternalistico in cui il sovrano è benevolo e
stimato e i sudditi sono rispettosi e obbedienti. Il re dovrebbe aspirare alla perfezione morale al fine
di rappresentare un buon esempio per il popolo e far sì che i sudditi rendano prospero il suo regno.
SCUOLE DI PENSIERO CONFUCIANO
Dopo la morte di Confucio nacquero due scuole di pensiero, una rappresentata da Mencio,
l’altra da Xunzi (Hsün-tzu). Mencio proseguì nella trasmissione degli insegnamenti etici di
Confucio, ponendo in rilievo l’innata bontà della natura umana. Egli riteneva, tuttavia, che
l’originaria bontà umana potesse corrompersi in seguito alla volontà distruttiva dell’individuo o al
contatto con un ambiente malvagio. Il problema dell’educazione morale è perciò preservare o,
almeno, riportare in vita la bontà innata di ciascuno. In campo politico, Mencio può essere
considerato uno dei primi sostenitori del diritto di resistenza ai poteri iniqui e del principio di
sovranità popolare. Egli elaborò un meccanismo di revoca del potere politico in base al quale
l’Essere supremo (Tien), che conferiva autorità e potere a un sovrano virtuoso (il cosiddetto
“Mandato dal Cielo”), poteva sottrarli entrambi a un tiranno, manifestando la propria volontà
tramite la volontà del popolo, che è felice di essere governato da un buon sovrano, ma si ribella
legittimamente contro un oppressore.
In contrapposizione a Mencio, Xunzi riteneva che ognuno nascesse con una natura malvagia
(o, quantomeno, caotica e ingovernabile), ma che tale natura potesse essere rigenerata mediante
l’educazione morale. Egli credeva che i desideri dovessero essere incanalati ed eventualmente
repressi dai canoni del decoro e che il carattere dovesse essere plasmato da una regolare osservanza
dei riti e dalla pratica della musica. Tali precetti, indirizzando correttamente le emozioni, avrebbero
favorito l’armonia interiore. Xunzi fu il principale esponente del ritualismo di epoca
tardoconfuciana.
TAOISMO
Il taoismo filosofico ebbe origine nel fermento intellettuale del periodo della dinastia Zhou,
quando numerose scuole filosofiche si interrogarono sul corretto modo di vivere in una mondo
lacerato dai mutamenti politici e sociali. Verosimilmente, le sue origini sono da ricercare nella
cosiddetta “scuola yang”, tanto disprezzata dal filosofo confuciano Mencio, il quale affermava che
gli yangisti non si sarebbero neppure strappati un capello dal capo a beneficio del mondo intero. In
effetti, la scuola yangista predicava la crescita e la valorizzazione dell’interiorità dell’individuo,
ispirandosi a una tradizione cinese di mistica e contemplazione simile allo yoga, che era stata
diffusa nel tardo IV secolo dal filosofo Zhuang Zi.
Le dottrine taoiste fondamentali, sia filosofiche sia mistiche, sono contenute nel Tao-te
ching (Libro della via e della virtù), che risale al III secolo e viene attribuito al Lao Zi, e nel
Zhuangzi, un testo composto di parabole e allegorie, anch’esso risalente al III secolo, ma ricondotto
a Zhuan Zi. Mentre il confucianesimo esortava l’individuo a conformarsi al disegno della natura, il
Tao (la “via”, il “cammino”, il “principio”), che non è definibile a parole né concepibile con il
pensiero. Per essere in armonia con il Tao è necessario “non agire” (wu-wei), non fare cioè nulla di
artificioso o innaturale: abbandonandosi liberamente agli impulsi della propria natura e
affrancandosi da qualsiasi dottrina si giunge all’unità con il Tao e si acquista un potere mistico
(De), che consente di trascendere qualunque contraddizione fra gli aspetti del mondo, persino quella
tra la vita e la morte. In seguito, i taoisti interpretarono il Tao come una sorta di potere magico,
sebbene sia Lao Zi sia Zhuang Zi si siano serviti del termine solo per designare, in generale, la
capacità dell’individuo perfettamente libero. Zhuang Zi, in particolare, si oppose ai confuciani e alla
scuola di Mo Zi, i quali sostenevano che la ragione umana avrebbe potuto rivelare il Tao; Zhuang Zi
riteneva invece che le distinzioni del pensiero concettuale rappresentassero la distanza dell’uomo
dal Tao.
Quanto alle dottrine sociali e politiche, i taoisti invocarono un ritorno alla vita agreste delle
origini. Nel Tao-te ching, il “non agire” fa riferimento tanto al sovrano quanto al privato cittadino.
Diffidando degli artifici concettuali, al pari di Zhuang Zi, Lao Zi raccomandò al sovrano di riempire
il ventre dei sudditi, ma di vuotare le loro menti, in modo tale che essi non potessero desiderare
alcunché; per Lao Zi lo stato ideale doveva incarnarsi nella dittatura di un filosofo-sovrano alla
guida di un popolo obbediente e passivo. Tale visione è ravvisabile, benché sussistano alcune
differenze, nella teoria dello stato totalitario sviluppata dalla scuola filosofico-politica dei legisti
fiorita al tempo degli stati combattenti, il cui massimo esponente fu Han Fei.
LE TRE GRANDI RELIGIONI MONOTEISTE
EBRAISMO
Caratteristica fondamentale dell’ebraismo è un monoteismo radicale, la fede in un unico
Dio, assolutamente trascendente e creatore di un universo che governa provvidenzialmente
dall’inizio dei tempi. Israele esprime la consapevolezza che Dio abbia “parlato” al suo popolo e, nel
corso della storia, la Scrittura sacra, la Bibbia, documenta le tappe di questa rivelazione progressiva,
interpretata dagli ebrei come un’alleanza, berith, che Dio ha istituito con loro in quanto popolo
eletto, chiamato a custodire gelosamente i precetti della legge.
Il tetragramma sacro YHWH esprime il nome di Dio, che probabilmente in origine si
sarebbe dovuto pronunciare come Jaweh o Yahweh, parola riconducibile alla radice del verbo
“essere”. Infatti in un passo fondamentale del libro dell’Esodo (3:14) Dio si rivela a Mosè
proclamando: “Io sono colui che sono”, una proposizione che ha dato luogo a infinite discussioni in
sede esegetica, ma il cui significato non appare comunque discosto dall’idea esprimibile
compiutamente con le parole: “Io sono colui che è”, nel senso che Dio definisce se stesso come
entità reale e realtà suprema per eccellenza, che, nel contesto specifico dell’esodo del popolo di
Israele dall’Egitto, rende manifesta la sua presenza di liberatore della sua gente dalla schiavitù. La
tradizione israelitica considera illecito pronunciare il nome di Dio. Esso, a motivo dell’uso tipico
della scrittura ebraica di non registrare le vocali, compariva nella redazione antica della Bibbia in
forma consonantica come Yhwh, sostituito nella lettura con il termine più generico Adonai
(“Signore”), in quanto soltanto il sommo sacerdote era autorizzato, una sola volta all’anno (durante
la festa dello Yom Kippur), a pronunciare solennemente il nome ineffabile della divinità. Quando,
nel VII secolo d.C., i dotti mansoreti si accinsero a dotare di vocali i libri biblici per renderne più
sicura la tradizione testuale, inserirono nel tetragramma sacro le vocali di “Adonai”, dando luogo
alla forma “Yehowah” che sta all’origine del nome Geova.
Signore onnipotente e legislatore, Dio esige dal suo popolo un’assoluta fedeltà e
un’obbedienza incondizionata alla sua legge, promulgata solennemente sul monte Sinai ai tempi
dell’esodo e registrata compiutamente nei primi cinque libri sacri della Bibbia, detti, per l’appunto,
“Torah”, “legge” in ebraico, ai quali si affiancano i libri profetici e gli altri scritti canonici. La
vicenda storica del popolo di Israele è interpretata dalla tradizione ebraica secondo una prospettiva
teologica, come luogo privilegiato dell’intervento di Dio, che assiste costantemente il suo popolo
assicurandogli la salvezza di fronte ai numerosi e potenti nemici, in virtù dell’alleanza stabilita per
l’eternità; la sofferenza, elemento costante nella storia degli ebrei fin dall’antichità, soprattutto dopo
la vicenda drammatica della deportazione a Babilonia nel 586 a.C., è la conseguenza tangibile
dell’infedeltà del popolo eletto ai precetti della sua religione e ai doveri dell’alleanza. Dio è
comunque sempre disposto a rinnovare l’alleanza, risollevando gli israeliti prostrati
dall’oppressione e infondendo loro nuove speranze.
La fede incrollabile nell’intervento liberatore di Dio e la coscienza della necessità della
conversione al fine di ottenere la salvezza alimentano, già nei libri profetici della Bibbia, ma
soprattutto nell’ebraismo della diaspora, la speranza nell’avvento di un Messia, l’uomo dalla
missione escatologica che Dio invierà alla fine dei tempi per liberare definitivamente il suo popolo
dall’esilio e dalla dominazione straniera e instaurare nella terra promessa il regno di pace e
prosperità destinato alla stirpe eletta dei suoi fedeli.
CRISTIANESIMO
Fondamento della fede di tutte le Chiese cristiane è il riferimento costante alla persona di
Gesù Cristo, morto e risorto per la salvezza dell’umanità. In Gesù di Nazareth, infatti, che ha
predicato, guarito, perdonato, annunciato la vicinanza del Padre, accettato liberamente la morte
sulla croce ed è resuscitato dai morti, i cristiani riconoscono il Figlio stesso di Dio. Nella vicenda di
Gesù, attestata dal Nuovo Testamento e in particolare dai Vangeli, si manifesta l’amore di Dio che
vuole incontrare l’uomo partecipando alla sua storia di fronte al peccato e al rifiuto, Gesù resta
coerente alla sua logica di amore, fino ad accettare la croce. “Dio è amore” proclamano i cristiani, e
la “passione” con la quale Dio ha amato il mondo attraverso il Figlio è esperienza storica che si
manifesta nella croce di Gesù.
Dio, per manifestare il suo amore, ha creato l’universo ponendo come vertice e sigillo della
sua azione creatrice l’umanità, destinata fin da principio alla salvezza e all’incontro diretto con il
Padre nella persona di Gesù. In Gesù gli uomini diventano a loro volta “i figli di Dio” ricevendo il
battesimo “nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”, come affermano tutti i simboli
della fede cristiana. Dio si rivela come Padre, Figlio e Spirito, e l’uomo è chiamato a partecipare
alla stessa vita trinitaria.
Se il battesimo, riservato originariamente agli adulti ma poi amministrato ai fanciulli,
costituisce fin dai primordi del cristianesimo la cerimonia di iniziazione alla fede, l’Eucaristia, o
cena del Signore, è indubbiamente il rito principale, che richiama il gesto di Gesù nell’Ultima Cena
e le sue parole: “Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue”. Proprio l’interpretazione di queste
parole è tuttora motivo di divisione fra le confessioni cristiane: alcune di esse, come il
cattolicesimo, sostengono la presenza reale del Cristo nelle specie del pane e del vino; altre, di
matrice protestante, parlano generalmente di presenza simbolica. Parimenti non esiste una
prospettiva univoca concernente il concetto fondamentale di “Chiesa”, vocabolo di origine greca
che designa l’assemblea di quanti si trovano uniti dalla fede comune in Gesù: se per la tradizione
cattolica Cristo è il fondatore di una Chiesa basata sull’autorità dei successori degli apostoli, e
quindi necessariamente legata a un principio gerarchico, il pensiero protestante tende idealmente a
concepire la comunità come libera convocazione dei credenti. Se, inoltre, alle rivendicazioni
storiche della Chiesa cattolica, che si pone tradizionalmente come unica Chiesa legittima legata
direttamente al fondatore, fa riscontro la tendenza di alcune comunità protestanti a proclamarsi
unica Chiesa pura e autentica, la situazione contemporanea conosce in misura sempre maggiore
l’abbandono di tale prospettiva esclusivistica da parte di esponenti delle diverse confessioni,
nell’ambito di un movimento ecumenico il cui fine ultimo è la ricerca dell’unità fra tutti i cristiani.
La vita cristiana
Incentrata fin dalle origini sul rito eucaristico e sulla lettura della Parola di Dio, la liturgia
cristiana ha assunto nei secoli forme articolate e complesse, tuttora visibili nel patrimonio rituale
della Chiesa, differente a seconda delle diverse confessioni.
La vita spirituale cristiana, attraverso la quale ogni singolo credente è chiamato a fare
esperienza personale di Cristo, comprende molteplici espressioni culturali e individuali: la preghiera
alimenta così costantemente l’adesione della fede al Risorto. Nel “giorno del Signore”, la domenica,
la comunità cristiana si raduna per celebrarne la memoria.
La fede in Cristo, come rivelazione dell’amore del Padre, fonda per i cristiani il
comandamento dell’amore per i fratelli. Questo amore si declina nella storia e nelle diverse
condizioni e situazioni in cui il cristiano si trova a operare.
Il rispetto per ogni persona, della sua vita e della sua dignità, è principio fondamentale e
irrinunciabile, così come è dovere fondamentale del credente operare per la giustizia e la pace,
basando la propria azione sulla speranza cristiana. Tale speranza non è fuga nell’aldilà, ma certezza
che la resurrezione di Cristo è principio di salvezza per l’umanità intera.
Questa fede permette al cristiano di credere, nonostante le smentite della storia, che l’ultima
parola non sia dell’ingiustizia e della prepotenza. Il riconoscimento che comunque tale speranza
trovi giustificazione in Dio fa sì che non si posso mai identificare “regno di Dio” e realizzazioni
storiche: la parusia, ovvero il ritorno di Cristo sulla terra, anche nel suo aspetto di giudizio e di
definitiva sconfitta del male e del peccato, appartiene all’iniziativa gratuita di Dio, imprevedibile e
incalcolabile.
Le origini
Le informazioni in nostro possesso circa la vita e il messaggio di Gesù sono quelle contenute
nei testi – in primo luogo i Vangeli – che compongono il Nuovo Testamento, scritti dagli
appartenenti alle prime comunità cristiane allo scopo di diffondere la fede. Proprio questo carattere
dei documenti neotestamentari, concepiti in primo luogo come attestazione di fede in colui che si
rivelò Figlio di Dio attraverso la sua morte e resurrezione, rende complessa una ricostruzione
precisa, dal punto di vista storico, della vita di Cristo: gli episodi salienti di questa vicenda sono
stati riletti dalla comunità primitiva alla luce della fede stessa, per mezzo di procedimenti articolati
e complessi che la moderna critica biblica si è sforzata di determinare. Oggi comunque gli studi
critici si orientano a riconoscere la possibilità di ricostruire nelle sue linee essenziali la predicazione
e la vicenda storica di Gesù.
ISLAM
Religione fondata all’inizio del VII secolo d.C. da Maometto (in arabo Muhammad) e
praticata oggi da circa un miliardo di fedeli. Confessione diffusa in larghissima maggioranza non
solo in tutti i paesi del Medio Oriente, a eccezione di Israele, ma anche in Africa
centrosettentrionale (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Mauritania, Senegal, Mali, Niger,
Ciad, Sudan, Somalia), in Turchia, Iran, Afghanistan, Pakistan e Asia centrale (Azerbaigian,
Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghistan e Tagikistan), oltre che in Bangladesh, Maldive, Malesia e
Indonesia. In India costituisce una maggioranza significativa; in Europa viene professata al 70%
della popolazione dell’Albania e da oltre il 40% degli abitanti della Bosnia-Erzegovina. In Italia i
musulmani sono almeno un milione, per gran parte immigrati dai paesi nordafricani e del Senegal.
Islam è una parola araba che indica il concetto di sottomissione assoluta all’onnipotenza di
Allah, il Dio unico e invisibile: l’Islam si caratterizza infatti come espressione di un monoteismo
radicale, fin dalla formula fondamentale – “Non vi è altro Dio all’infuori di Allah, e Maometto è il
profeta di Allah” – recitata nel segno dell’appartenenza alla comunità degli adoratori dell’unico
Dio. Il seguace dell’Islam viene definito in italiano musulmano, termine coniato sulla base del
persiano musliman, forma equivalente all’arabo muslimun, plurale di muslim, la parola, che si
ritrova nella lingua inglese, utilizzata per indicare appunto chi si considera sottomesso alla divinità
unica e irraggiungibile nella sua dimensione trascendente. Questa concezione rigorosamente
monoteistica viene considerata della stessa tradizione islamitica in continuità con il credo
dell’ebraismo e del cristianesimo, religioni che costituirebbero le tappe fondamentali della
rivelazione divina. Quest’ultima culminerebbe nella predicazione di Maometto, il profeta per
eccellenza e l’ultimo dei latori della rivelazione di Allah dopo Abramo (in arabo Ibrahim), Mosè
(Musa) e lo stesso Gesù (Isa). A tal proposito occorre precisare che la tradizione musulmana,
riferendosi a Gesù come al più venerabile fra i profeti vissuti prima di Maometto, considera
esclusivamente la sua natura umana; Maometto stesso non si attribuì mai una natura sovrumana,
presentandosi unicamente come il profeta al quale Allah avrebbe consegnato, per tramite
dell’arcangelo Gabriele, la rivelazione divina destinata a essere custodita e venerata per sempre dai
fedeli. Tale rivelazione è contenuta nel Corano, il libro sacro dettato da Dio all’umanità a
completamento del messaggio parzialmente trasmesso dalla Bibbia ebraica e cristiana.
Affiancando a questa concezione teologica un corpus normativo che regolamenta con
precisione la condotta dei fedeli interamente sottomessi al volere divino, l’Islam ambisce a
identificare l’intera società con la comunità dei fedeli di Allah. A differenza del cristianesimo, il
mondo musulmano non ha mai conosciuto un’autorità suprema ritenuta depositaria della verità in
materia di fede e di etica. In assenza di una figura paragonabile a quella del papa nel cattolicesimo,
la tradizione islamica assegna all’intera comunità dei fedeli il compito di custodire i precetti della
religione e della retta condotta e accoglie con molte riserve il ruolo di custodi autorevoli
dell’ortodossia attribuito in epoca moderna ai dotti dell’Università Al-Azhar del Cairo fra i sanniti,
e alla gerarchia dei mullah iraniani fra gli sciiti.
Le origini
Vissuto nell’Arabia occidentale all’inizio del VII secolo d.C., Maometto predicò agli
abitanti di quella terra, in maggioranza seguaci del politeismo, i dettami della nuova fede rivelatagli
direttamente dall’unico Dio. Nonostante l’ostilità incontrata nella sua città natale, La Mecca, il
profeta riuscì a dar vita, nella città oggi nota come Medina, a una comunità politico-religiosa che
sarebbe riuscita, già prima del 632, anno della morte del fondatore, a imporre la propria autorità in
tutta l’Arabia, nelle città come fra le tribù nomadi, elevando l’appartenenza all’Islam al ruolo di
elemento di identificazione di una compagine politica unitaria.
L’istituzione del califfato, mirante a garantire la legittima successione di Maometto alla
guida della nazione islamica, rappresentò l’ambito privilegiato per la trasmissione delle rivelazioni
divine comunicate oralmente dal profeta ai suoi discepoli più fidati e registrate in forma scritta già
all’epoca del terzo califfo Othman (644-656) nelle 114 sure (capitoli) del Corano, accettate
dall’Islam come definitive e immutabili. I passi del libro sacro costituirono ben presto il
fondamento delle prescrizioni rituali ed etiche della comunità, che tuttavia accostò alle parole e alle
azioni del profeta anche alcune pratiche non testimoniate dal Corano: questa tradizione parallela,
detta in arabo sunnah, rappresenta tuttora una fonte autorevole soprattutto per i sanniti, che vi
scorgono un complemento indispensabile alla rivelazione divina.
Il saldo governo dei califfi e la fede comune permise i rapidi successi degli eserciti arabi.
Questi ultimi già prima del 650 sottomisero al dominio del califfato di Medina, l’Egitto, la Siria,
l’Iraq e le regioni occidentali della Persia, mentre con il passaggio del potere, intorno al 660, alla
dinastia degli Omayyadi, prese avvio la seconda fase della diffusione dell’Islam, che penetrò nel
vastissimo territorio compreso fra il Marocco e l’Afghanistan, in Spagna e nelle regioni dell’Asia
centrale.
Monoteismo, demonologia, escatologia
Se la tradizione musulmana, sottolineando il primato assoluto di Allah, gli attribuisce le
parole rivelate a Maometto e registrate nel Corano, le cui pagine altro non sarebbero che copie di un
archetipo celeste unico e immutabile, la moderna ricerca storico-religiosa mira a chiarire le origini
del monoteismo islamico considerando primariamente l’influenza esercitata in Arabia dall’ebraismo
e dal cristianesimo, in particolare nell’ambiente culturale del profeta, al quale non erano ignote le
Sacre Scritture degli ebrei e dei cristiani, salutato con rispetto come “popoli del libro”. Il Corano,
infatti, fa riferimento a Mosè come al tramite della rivelazione divina contenuta nella Torah, mentre
Gesù viene presentato come il custode di un “vangelo” in una prospettiva tendente a identificare il
fondatore del cristianesimo con l’estensore di un libro dettato dalla divinità.
Annoverando Gesù tra i profeti, analogamente ai personaggi considerati tali dall’Antico
Testamento, il Corano lo presenta come Masih, Messia, ma respinge come bestemmi suprema
l’attribuzione di una natura divina, pur condividendo con i Vangeli il racconto della sua nascita da
una vergine e dei miracoli compiuti, per poi divergere dalla tradizione cristiana in merito alla
crocifissione: Gesù sarebbe stato infatti direttamente innalzato al cielo da Dio senza conoscere
l’umiliazione del supplizio, patito in realtà da un uomo reso simile a lui agli occhi dei suoi
persecutori e degli stessi discepoli. Queste e altre asserzioni del Corano possono essere connesse
più o meno precisamente con i racconti dei Vangeli apocrifi e con le dottrine delle differenti
correnti ebraiche e cristiane diffuse, o comunque conosciute in qualche modo, in Arabia all’epoca di
Maometto, ed è significativo che lo stesso libro sacro, presentando come fatto riprovevole la
divisione dei cristiani in sette contrapposte l’una all’altra, abbia coscienza dei numerosi movimenti
sviluppatisi in seno al cristianesimo dei primi secoli e in gran parte condannati come eretici.
Fra le creature di Allah il Corano contempla pure, accanto agli angeli, la folta schiera dei
jinn, gli antichi “spiritelli” che, venerati nel paganesimo preislamico come divinità minori, sono
stati adottati dall’Islam sia come esseri benefici divenuti fedeli ad Allah sia come pericoloso
esercito di demoni, tra i quali Iblis è il minaccioso tentatore degli uomini. Per quanto concerne
l’escatologia, la tradizione islamica prevede il giudizio universale, presentato ne Corano, assieme
alla resurrezione, come momento culminante della storia di questo mondo al termine di una serie di
terrificanti cataclismi naturali (sure 81,82,94); il paradiso – adn, nome arabo dell’Eden biblico –
precluso agli infedeli e ai malvagi, destinati al fuoco dell’inferno, viene descritto (sura 52) come un
giardino di delizie, dove i beati, riconosciuti tali dopo che le loro buone azioni, pesate su una
bilancia, si saranno rivelate più consistenti di quelle cattive, potranno godere della felicità dei sensi
gustando cibi succulenti e allietandosi con la compagnia di incantevoli fanciulle.
La tradizione che arricchì successivamente i dati del Corano offre invece la suggestiva
narrazione della fine del mondo preceduta dall’apparizione del dajjal, la Bestia apocalittica,
creatura malefica che regnerà sulla terra per 40 giorni prima di essere sconfitta da Gesù, il
precursore del mahdi, figura escatologica capace di inaugurare un’epoca di felicità e di giustizia che
preclude al giudizio universale.
La legge e i riti
La professione di fede in Allah obbliga i seguaci dell’Islam all’osservanza di una serie di
norme etiche e legali che, regolamentando ogni aspetto della vita della comunità, costituiscono un
complesso e minuzioso codice giuridico concepito come modello ideale per una società teocratica.
Identificando infatti la società civile con la comunità dei fedeli, la teologia islamica innalza il
diritto, fiqh, “saggezza”, al rango di scienza religiosa, che deve essere coltivata dai dotti con la
massima dedizione per garantire nel futuro la conformità della condotta dei fedeli ai principi della
legge, la shariah. Gli esperti di giurisprudenza, detti mufti nella tradizione sunnita e mullah in
quella sciita, legiferano in relazione a ogni aspetto della vita civile e religiosa: essi elaborano sia le
norme del codice penale sia le prescrizioni del diritto di famiglia, ponendo a fondamento delle loro
decisioni non solo i dati del Corano e della sunnah, come si trovano nelel raccolte dei detti e delle
azioni del profeta, ma anche l’elemento concorde, ijma, di una o più generazioni di uomini di legge
in relazione a una determinata materia; alle indicazioni di questi cultori del diritto devono attenersi i
qadi, i giudici chiamati a pronunciare le sentenze in merito ai singoli casi loro sottoposti.
Nell’ambito di competenza della shariah rientrano anche le norme del diritto matrimoniale.
Le nozze per l’uomo possono avere anche carattere poligamico: alla libertà di sposare fino a quattro
donne si associa l’obbligo di assicurare un identico tenore di vita a ciascuna delle consorti e ai
rispettivi figli. Tale obbligo, soprattutto in epoca moderna, fa di questa pratica una possibilità
limitata agli uomini più benestanti. Il divorzio, possibile per iniziativa del marito anche in assenza
di particolari motivazioni, può essere ottenuto dalla donna solo per mezzo di una complessa
procedura giuridica, sulla base dello stesso principio che consente il matrimonio fra un musulmano
e una donna di diverso credo religioso, ma impedisce di dare in sposa una donna musulmana a un
uomo non seguace dell’Islam. Per quanto concerne l’abbigliamento femminile, l’esortazione rivolta
dal Corano alle donne affinché indossino un mantello che copra il loro corpo da capo a piedi non
può essere posta a fondamento della prescrizione di nascondere anche il volto, introdotta dai califfia
Abbasidi (750-1258) con la consuetudine di confinare le mogli nell’harem, ovvero “luogo
interdetto” agli uomini, consentendo loro di comparire in pubblico soltanto con il volto coperto.
Questo orientamento non univoco della tradizione antica fa sì che le prescrizioni in materia
di abbigliamento femminile siano tuttora più o meno rigide nei diversi paesi islamici, analogamente
alle altre norme che regolano le attività delle donne in campo sociale e professionale. Allo stesso
modo, l’applicazione letterale della shariah come espressione principale del diritto (taglio della
mano destra come pena per il furto o lapidazione per l’adulterio) è prerogativa di paesi, quali
l’Arabia Saudita e l’Iran, più inclini a una visione integralista dell’Islam. Altrove, ad esempio in
Egitto e in Siria, la pratica islamica convive con un sistema legale parzialmente ispirato a modelli
occidentali, mentre la Turchia è dal 1928 uno stato ufficialmente laico, benché non vi manchino
movimenti religiosi di indirizzo più o meno integralista.
Se questa pluralità di orientamenti costituisce indubbiamente un motivo di tensione nel
mondo musulmano, la quasi totalità dei seguaci di questa religione offre invece un’immagine di
profonda unità per quanto concerne l’osservanza di quei doveri noti come Cinque pilastri
dell’Islam: alla professione di fede, shahada, nell’unico Dio, il musulmano deve infatti affiancare la
preghiera quotidiana, salat, nelle forme rituali previste, osservando poi il digiuno, sawn, durante il
mese di Ramadan, oltre a recarsi in pellegrinaggio, hagg, almeno una volta nella vita alla città santa,
La Mecca, e a versare una certa somma di denaro come decima, zakat, a beneficio dei poveri e della
comunità. Obblighi altrettanto sentiti dai fedeli sono, oltre alla circoncisione maschile, l’astinenza
dal consumo di bevande alcoliche e di carne di maiale, e il rispetto delle norme della macellazione
rituale degli animali di cui è lecito cibarsi.
La preghiera, certamente la pratica più suggestiva dell’Islam, riunisce per cinque volte al
giorno (soltanto tre fra gli sciiti) l’intera comunità dei fedeli che, ovunque si trovino, interrompono
all’ora stabilita qualsiasi attività per compiere i gesti di un preciso cerimoniale, rivolgendosi verso
la Mecca su un tappeto, limite dello spazio sacro, a piedi scalzi e in stato di purità rituale dopo una
serie di abluzioni. La preghiera quotidiana viene recitata in forma collettiva nella moschea, il luogo
di culto dei musulmani, dove il venerdì, giorno festivo per l’Islam, si tiene a mezzogiorno il rito
solenne. Oltre alla salat, guidata da un imam, viene recitata una sorta di omelia pronunciata dal
pulpito da un khatib, figura che comunque non riveste, al pari dello stesso imam, alcuna funzione
sacerdotale in nome del principio della pari dignità di tutti i fedeli di fronte ad Allah. Al muezzin,
forma turca dell’arabo muadhdhin, è invece affidato l’incarico di annunciare dal minareto, la torre
annessa alla moschea, l’ora della preghiera quotidiana e della funzione del venerdì.
LE CITTÀ SANTE
LA MECCA
Città dell’Arabia Saudita occidentale, capoluogo della provincia omonima, situata nella
regione dell’Higiaz. Città natale del profeta Maometto, fondatore dell’Islam, e città sacra per
eccellenza del mondo musulmano, viene visitata ogni anno da un grande numero di pellegrini che,
in base alle prescrizioni del Corano, sono tenuti a compiere il pellegrinaggio alla Mecca almeno una
volta nella vita. La sua posizione di crocevia tra varie strade battute dalle carovane dei mercanti le
ha permesso di svilupparsi come luogo di mercato sin dall’antichità.
La Mecca era un centro religioso già prima della nascita di Maometto: all’interno del
perimetro della grande moschea, della al-Haram, si trovano importanti luoghi di culto dell’epoca
preislamica. La tradizione vuole che la Kaaba, un edificio di forma cubica, senza finestre, situato
nel cortile della moschea al-Haram, sia stata costruita dal patriarca ebreo Abramo; nell’angolo
sudorientale della Kaaba viene custodita la Pietra Nera, oggetto di culto in tutto il mondo islamico.
Sempre all’interno del perimetro della moschea si trova il pozzo sacro, che si dice venisse utilizzato
da Agar, schiava di Abramo.
La città fu citata per la prima volta con il nome di Makoraba dall’astronomo e geografo
Tolomeo, vissuto ne II secolo d.C.. A partire dall’epoca di Maometto, La Mecca subì numerosi
assedi: fu dapprima conquistata dagli egiziani nel XIII secolo; in seguito passò sotto il controllo dei
turchi. Dal 1517 i califfi (discendenti di Maometto attraverso Hasan, figlio di Alì, genero del
profeta) governarono la città per conto dell’impero ottomano. La Mecca si sottrasse al controllo
della Turchia solo nel 1916, quando il gran califfo Husein Ibn Alì si proclamò sovrano di Higiaz.
Nel 1924 la città fu occupata da Ibn Saud, successivamente sultano di Najd, che ne fece la capitale
religiosa dell’Arabia Saudita.
MEDINA
In arabo Medinat-en-Nabi, “Città del Profeta”, o anche Medinatpasul Allah, “Città
dell’apostolo di Dio”. Città dell’Arabia Saudita occidentale, capoluogo dell’omonima provincia. La
città, che conserva le reliquie del profeta Maometto fuggito da Medina a La Mecca nel 622, è un
luogo sacro dell’Islam. Ogni anno la sua tomba, che si trova nella moschea del Profeta, nella zona
orientale della città, viene visitata da migliaia di pellegrini. Nella stessa moschea si trovano anche le
tombe della figlia di Maometto, Fatima, e del califfo Umar I.
Nell’antichità, Medina era conosciuta con il nome di Yathrib ed è citata con il nome di
Lathrippa dal geografo Tolomeo nel II secolo d.C.. Fu la capitale del mondo arabo sino al 661,
quando il califfato fu trasferito a Damasco. In seguito venne conquistata dagli egiziani e dai turchi,
che lasciarono la città solo nel 1919, cacciati dalle truppe di Husein Ibn Ali, primo re di Al-Hijaz.
Nel 1924 le forze di Husein furono sconfitte da Ibn Saud, sultano di Najd. La città di Medina fu
annessa al regno dell’Arabia Saudita nel 1932.
GERUSALEMME
Capitale e città maggiore di Israele, situata sulle colline della Giudea, tra il mare
Mediterraneo e il mar Morto, circa 93 km a est di Tel Aviv – Giaffa. Principale centro politico e
amministrativo del paese, Gerusalemme ha recentemente sviluppato alcuni settori dell’industria
(metallurgica, chimica) ed è un attivo polo culturale. Il turismo svolge un ruolo di rilievo
nell’economia locale.
Gerusalemme è però innanzi tutto una delle capitali della religiosità mondiale, essendo la
città santa di tre delle maggiori religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo, islamismo. Sacra è
infatti per gli ebrei, in quanto simbolo storico della patria a lungo negata e capitale del primo regno
ebraico, sacra per i cristiani in quanto teatro degli ultimi giorni sulla terra di Gesù e sede della sua
sepoltura, sacra per i musulmani in quanto sito dell’ascesa al cielo del profeta Maometto.
Quattro comunità etniche, tradizionalmente chiuse all’interno dei propri quartieri, popolano
la capitale: musulmana, ebraica, cristiana e armena. Nettamente predominanti dal punto di vista
demografico sono le prime due, ebrei israeliani (73%) e arabi palestinesi (24%). Ataviche
incomprensioni, differenti ritmi di crescita economica e complicate vicende internazionali
ostacolano l’integrazione tra i vari settori di Gerusalemme, condannandola alla stridente
contraddizione di essere nel contempo città santa e luogo d’odio.