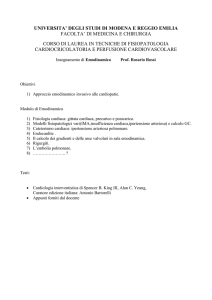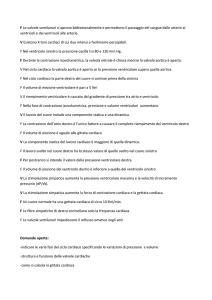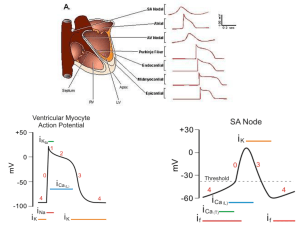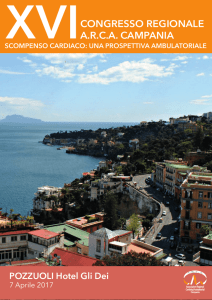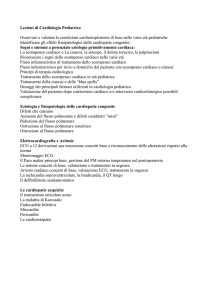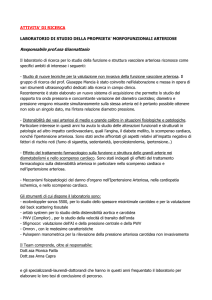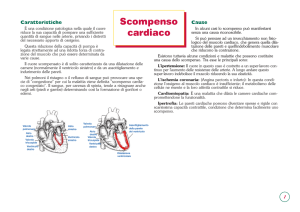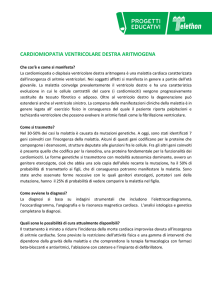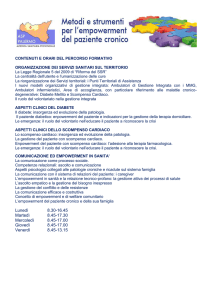Dispensa
Malattie dell’Apparato Cardio-vascolare
Dott. Alessandro Carbonaro
Le Malattie dell’Apparato Cardiovascolare rappresentano ormai da molti anni la prima
causa di morbilità e mortalità nel mondo industrializzato. Nei Paesi dell’Est europeo
tale patologia è in continuo aumento con il miglioramento del tenore di vita, mentre in
altri Paesi, come nel Centro Africa, a causa del dilagare delle patologie infettive e di
una elevatissima mortalità in età giovanile, le malattie cardiovascolari non rivestono,
per incidenza, l’importanza raggiunta in Europa, negli USA e nei Paesi più
industrializzati dell’Est Asiatico, come il Giappone.
Sembra quasi che tali affezioni costituiscano un tragico tributo da pagare al
benessere! Giova a tal fine ricordare che più elevata è la vita media di un Paese, tanto
più è possibile, nello stesso, lo sviluppo delle malattie cardiovascolari. In altre parole
laddove la durata media della vita è bassa, altre sono le cause principali di mortalità,
mentre nei Paesi nei quali l’aspettativa di vita è elevata, le malattie dell’apparato
cardiovascolare rappresentano la prima causa di morte.
Prima di trattare i Sintomi delle malattie cardiovascolari è necessario sottolineare
l’importanza determinante dell’anamnesi, che già di per sé può indirizzare verso un
approfondimento “mirato” dell’esame clinico, al fine di giungere ad una precisa
diagnosi.
I sintomi più significativi imputabili ad una patologia dell’Apparato Cardiovascolare
sono:
1) La Dispnea.
2) L’Astenia.
3) Il Dolore toracico.
4) Le Palpitazioni, definite anche Cardiopalmo.
5) La Nicturia.
LA DISPNEA
Dalla lingua greca (dus= cattivo e pneuma=respiro) è l’espressione di una difficoltà
respiratoria che può insorgere durante uno sforzo fisico (dispnea da sforzo) o
addirittura comparire a riposo. Le sue manifestazioni più gravi sono l’ortopnea, la
dispnea parossistica notturna e l’edema polmonare acuto (vedi più avanti).
Quando non imputabile a cause specifiche respiratorie, la dispnea indica il
coinvolgimento del circolo polmonare da parte di una patologia del cuore sinistro:
l’aumento della pressione in atrio sinistro o della pressione diastolica del ventricolo
sinistro provoca inevitabilmente un aumento della pressione nei capillari polmonari e
nel circolo polmonare a monte degli stessi. Una pressione idrostatica eccessiva nei
capillari provoca trasudazione di liquido dapprima nell’interstizio polmonare (edema
interstiziale) e quindi negli alveoli (edema alveolare).
La Dispnea può insorgere e manifestarsi sia in forma acuta che cronica, per una
patologia che può coinvolgere l’apparato respiratorio o l’apparato cardiovascolare; la
dispnea cardiaca è uno dei sintomi più significativi insieme all’astenia, al dolore
anginoso e alle palpitazioni, utilizzati per la valutazione clinica di gravità di uno
scompenso.
Questi sintomi sono alla base della classificazione proposta dalla New York Heart
Association (N.Y.H.A.), utile per inquadrare tutti i gradi di scompenso in relazione alla
insorgenza della dispnea per sforzi sempre più lievi o addirittura a riposo. Essa è così
strutturata:
Classe I: comprende pazienti con una patologia cardiaca i quali non hanno alcuna
limitazione della propria attività fisica. L’attività non causa dispnea, né affaticabilità,
né dolore anginoso.
Classe II: comprende pazienti con patologia cardiaca nei quali è presente una scarsa
limitazione dell’attività fisica. Questi soggetti stanno bene a riposo, ma possono avere
disturbi (dispnea, affaticabilità, palpitazioni o dolore anginoso) per una attività fisica
usuale.
Classe III: comprende pazienti con patologia cardiaca che hanno una marcata
limitazione dell’attività fisica. Stanno bene a riposo, ma possono presentare i disturbi
sopra indicati per un’attività fisica anche inferiore a quella usuale.
Classe IV: comprende pazienti con patologia cardiaca che li rende incapaci di
effettuare qualsiasi attività fisica senza presentare i disturbi sopra indicati, che
possono essere presenti anche in condizioni di riposo.
La forma più grave di dispnea che possa presentarsi nel cardiopatico è l’edema
polmonare acuto, che si realizza quando la pressione all’interno dei capillari polmonari
supera il valore della pressione colloido-osmotica. Nel capillare, infatti, agiscono due
forze contrapposte: la pressione idrostatica, che tende a far fuoriuscire il liquido dal
vaso, e quella oncotica, esercitata dalla proteine non diffusibili, che tende a
trattenere il liquido all’interno; il valore di quest’ultima è 25-30 mm Hg. Se la
pressione idrostatica nei capillari polmonari supera tale valore, è inevitabile una
ultrafiltrazione di plasma, associata, per rotture microvascolari, ad alcuni globuli
rossi. Fuoriuscendo dai vasi, il liquido si riversa dapprima nell’interstizio, da dove il
sistema linfatico cerca di rimuoverlo; successivamente, quando la capacità di
drenaggio del sistema linfatico viene superata, il fluido invade gli alveoli polmonari, e
mescolandosi all’aria forma una schiuma, talora rosata, che invade le vie aeree ed
interferisce gravemente con l’efficienza degli scambi gassosi, tanto da poter portare
a morte. All’ascoltazione del torace, in questa situazione drammatica, quando dalla
fase interstiziale si passa a quella alveolare, si assiste alla comparsa di rantoli prima a
piccole poi a grosse bolle, che iniziano dalle basi polmonari e giungono rapidamente a
coprire l’intero distretto respiratorio. Il soggetto è in posizione eretta e mette in
funzione tutti i muscoli respiratori accessori nella disperata ricerca di riuscire ad
effettuare atti respiratori utili.
IL DOLORE TORACICO
Il dolore ischemico presenta caratteristiche peculiari che vanno
dalla modalità di insorgenza, al tipo di dolore, alla sede dello stesso, alla sua irradiazio
ne. E’ questo il sintomo più importante nell’angina ed in genere delle sindromi
coronariche acute, compreso l’infarto miocardico.
Nei quadri clinici riferibili ad angina pectoris, la presenza di dolore è “condicio sine
qua non” per definire il quadro clinico. Nell’angina da sforzo stabile il dolore insorge
durante uno sforzo fisico, è di tipo costrittivo od oppressivo e nel 75% dei casi è
localizzato alla regione retrosternale bassa, con varie possibili irradiazioni, delle quali
abbastanza comune è quella al lato ulnare del braccio sinistro, e in misura minore, al
giugulo. Più raramente vengono interessati l’emitorace di destra e il braccio destro o
l’epigastrio. Il dolore cessa usualmente dopo poco la cessazione dello sforzo e recede
rapidamente con l’assunzione di nitroderivati. Nell’infarto miocardico acuto, il dolore
con le caratteristiche sopra descritte persiste in genere ben oltre i pochi minuti e può
durare addirittura diverse ore.
Il dolore toracico non è soltanto indicativo di ischemia miocardica (angina pectoris,
sindromi coronariche acute) ma può essere indicativo di numerose altre patologie
cardiovascolari quali la pericardite, la dissezione aortica, l’ipertensione polmonare,
l’embolia polmonare, e può anche dipendere da patologie di altri organi e sistemi, come
lesioni esofagee o pleuriche oppure interessamento (compressivo, infiltrativo o
flogistico) di nervi intercostali.
LE PALPITAZIONI O CARDIOPALMO
La percezione del proprio battito cardiaco è già un sintomo. La normale azione del
cuore, infatti, decorre in maniera del tutto asintomatica, sia di giorno che di notte,
per tutta la vita. Esistono due tipi fondamentali di cardiopalmo: quello tachicardico, in
cui il soggetto riferisce un’azione cardiaca rapida e continua, e quello extrasistolico,
caratterizzato dall’avvertire improvvisamente un “tonfo” o “tuffo” oppure la
“sensazione del cuore che si ferma” . Anche se in condizioni di impegno fisico od
emozionale è frequente sentire il proprio battito cardiaco, non vi è dubbio che la
perdita di ritmicità è un fenomeno che difficilmente sfugge. Talora tale sintomo viene
vissuto in maniera allarmante più del dovuto, come nel caso di extrasistolia isolata o
sporadica.
L’aritmia percepita, responsabile del cardiopalmo, può essere di scarso rilievo clinico,
o al contrario estremamente importante. E’ pur vero che le aritmie più gravi, quali la
fibrillazione ventricolare o l’asistolia, possono portare a morte senza alcun sintomo
premonitore, ma è innegabile che talora “salve di extrasistoli” o brevi episodi di
tachicardia, e dall’altra parte episodi parossistici di blocco A-V con transitoria
asistolia, possono risultare sintomatici e quindi diagnosticabili in tempo per essere
trattati con pacemaker o defibrillatore, evitando eventi gravi o fatali.
LA SINCOPE
Può essere definita
come: “Perdita improvvisa e transitoria della coscienza e del tono posturale, dovuta ad
una grave ipossia o ad una anossia cerebrale acuta”. Talora può essere accompagnata
da perdita di urine e/o di feci. Un tempo si distingueva la lipotimia come perdita
momentanea del tono posturale e talora anche dello stato di coscienza, preceduta in
genere da prodromi descritti come “senso di mancamento, nausea, appannamento della
vista, sudorazione, pallore”. Oggi si preferisce parlare di sincope e di presincope. La
sincope può riscontrarsi in varie situazioni di patologia cardiaca (vedi Capitolo 41).
LA NICTURIA
E’ uno dei sintomi che accompagna l’insufficienza cardiaca, e consiste in una riduzione
della diuresi durante il giorno con aumento della diuresi stessa durante la notte. Il
fenomeno può essere dovuto al riassorbimento notturno degli edemi soprattutto
declivi, che possono realizzarsi durante la stazione eretta nel paziente con scompenso
cardiaco congestizio, o anche perchè durante il riposo notturno il fabbisogno di sangue
da parte dei muscoli è minimo, per cui una parte relativamente elevata della portata
cardiaca può giungere al rene, il quale aumenta la produzione di urina.
CONCETTI GENERALI
Nei pazienti con Malattie dell’apparato cardiovascolare, i segni rilevabili all’esame
clinico costituiscono ancora oggi un importante capitolo perché tutte le innovazioni
tecnologiche, che hanno apportato un grande progresso nell’inquadramento diagnostico
e nella terapia, trovano una loro logica applicazione solo sulla base di una corretta
valutazione dei segni peculiari di ogni forma di cardiopatia.
I principali segni presenti nei pazienti affetti da patologie cardiovascolari sono
rilevabili con un accurato esame obiettivo che trova i suoi capisaldi nei presìdi offerti
dalla classica Semeiotica fisica: Ispezione, Palpazione, Percussione, Ascoltazione.
Tra queste, la Percussione ha perso del tutto la sua utilità, nel campo della Semeiotica
Cardiovascolare, grazie ai progressi tecnologici che hanno reso molto più precisa la
determinazione delle dimensioni cardiache. Gli altri tre capisaldi semeiologici
(Ispezione, Palpazione ed Ascoltazione, soprattutto quest’ultima) conservano la loro
validità e servono ad indirizzare, verso l’uso corretto delle tecniche diagnostiche
strumentali.
I segni di una cardiopatia si possono riscontrare all’esame obiettivo dell’apparato
cardiovascolare mediante le seguenti manovre:
1) L’osservazione del volto e delle estremità per rilevare la presenza di cianosi.
2) L’osservazione del polso venoso giugulare.
3) L’ispezione delle arterie e la palpazione del polso arterioso.
4) L’ispezione e la palpazione della zona precordiale.
5) La palpazione dell’addome per ricercare l’eventuale presenza di epatomegalia o di
pulsazioni abnormi.
6) La ricerca di eventuali edemi declivi.
7) L’ascoltazione del cuore, volta ad evidenziare anomalie dei toni e/o la comparsa di
soffi o sfregamenti.
CIANOSI
Si definisce cianosi il colorito bluastro assunto dalla pelle e dalle mucose visibili
quando il contenuto di emoglobina ridotta nel sangue capillare supera i 5 grammi per
decilitro.
La cianosi può essere centrale o periferica. La cianosi centrale è per lo più dovuta alla
presenza di uno shunt destro-sinistro o a gravi difetti della funzione respiratoria.
La cianosi periferica si realizza quando, a causa di una vasocostrizione in alcuni
distretti circolatori, si determina una desaturazione locale, con aumento
dell’emoglobina ridotta in quelle zone. La cianosi periferica può evidenziarsi, fra
l’altro, in presenza di una ridotta portata cardiaca con aumento delle resistenze
periferiche.
OSSERVAZIONE DEL POLSO VENOSO
Il polso venoso meglio valutabile è quello giugulare con il paziente in posizione seduta,
reclinato a 45° (rispetto ai 90° normali per la posizione seduta).
Il polso venoso normale presenta tre onde positive e due depressioni. Le onde positive
sono denominate onde a, c e v, mentre le depressioni sono denominate x e y.
Un’attenta osservazione del polso venoso giugulare, può fornire precise indicazioni
circa la funzione delle camere destre del cuore.
Un’evidente accentuazione dell’onda a è espressione di un aumento della pressione in
atrio destro (Stenosi tricuspidale, Anomalia di Ebstein ecc..) o della pressione
diastolica ventricolare destra, come si verifica nella Miocardiopatia restrittiva (vedi
Capitolo 30), o nella Pericardite costrittiva, (vedi Capitolo 32).
Un’accentuazione dell’onda v è talora espressione di una insufficienza tricuspidale.
+
ISPEZIONE DELLE ARTERIE E PALPAZIONE DEL POLSO ARTERIOSO.
Con l’ispezione si possono evidenziare pulsatilità arteriose anormali (come per esempio
l’eccessiva pulsazione delle carotidi, osservabile al collo in presenza di insufficienza
aortica o di altre situazioni di circolo ipercinetico). Con l’ascoltazione possono
evidenziarsi soffi vascolari. La manovra semeiologica più utilizzata per l’esplorazione
del polso arterioso è la palpazione, con la quale si possono valutare:
a) la frequenza: numero delle sistoli in un minuto;
b) il ritmo: regolarità o irregolarità delle pulsazioni;
c) l’ampiezza: entità del sollevarsi della parete arteriosa sotto il dito che palpa,
carattere che è direttamente correlato alla gittata sistolica;
d) la tensione: entità della forza che devono esercitare le dita che palpano per
sopprimere la pulsazione, espressione anche del livello pressorio;
e) la simmetria: uguale ampiezza dei polsi corrispondenti, palpati simultaneamente dai
due lati dell’organismo (per esempio, i due polsi radiali, i due polsi femorali, etc).
Le variazioni dei caratteri sopradescritti del polso arterioso, possono risultare
indicativi di particolari situazioni morbose. Ecco alcuni esempi.
A – Un polso di ridotta ampiezza (piccolo) e con picco ritardato (tardo) si riscontra
nella stenosi aortica.
B – Un polso ampio e celere (con picco precoce) è presente nell’insufficienza aortica o
negli stati circolatori ipercinetici;.
C- Un polso filiforme (frequenza notevolmente aumentata, tensione e ampiezza
nettamente ridotte) è tipico dello shock .
D – Il polso paradosso è l’esagerazione patologica di una riduzione della pressione
durante una inspirazione profonda. Tale riduzione è presente anche in condizioni
fisiologiche, ma non supera di solito i 10 mm di mercurio, mentre in presenza di
pericardite costrittiva o in situazioni nelle quali esiste una grave riduzione del
riempimento ventricolare, si può avere una caduta di oltre 20-30 mm di mercurio.
DEMI DECLIVI
Si sviluppano inizialmente nelle parti molli degli arti inferiori (piedi, zone pretibiali,
etc.) nei soggetti che rimangono per ore in stazione eretta o seduta. Nei pazienti
costretti a letto gli edemi sono più evidenti nella regione pre-sacrale. Quando si ha un
imponente stato anasarcatico, gli edemi sono diffusi e si accompagnano anche a
versamenti nelle grandi sierose (versamento pleurico, ascite, etc.).
L’ascoltazione rappresenta la manovra più importante dell’esame obiettivo del cuore,
ed è basata sull’analisi dei toni e sul riconoscimento di eventuali soffi.
I Toni
I toni cardiaci normali sono il I e il II; il III tono può essere ascoltato in assenza di
patologia nei bambini o in giovani adulti con parete toracica particolarmente sottile.
Il I tono è provocato essenzialmente della chiusura delle valvole atrio-ventricolari,
mentre il II si deve alla chiusura delle semilunari aortiche e polmonari (Figura 1).
Il I tono può risultare rinforzato in caso di stenosi mitralica (vedi Capitolo 14) o di
stenosi della valvola tricuspide, mentre è spesso indebolito nell’insufficienza
mitralica.
Il II tono è costituito dalle 2 componenti, aortica e polmonare (A2 e P2), che nella
maggior parte dei casi sono così ravvicinate da generare un tono unico, anche se la
chiusura della valvola aortica precede di poco quella della polmonare (Figura 1). A
volte, però, anche in condizioni fisiologiche, le due componenti del II tono possono
essere ascoltate distinte l’una dall’altra, per cui il II tono si presenta sdoppiato. Tale
sdoppiamento, però, e variabile con le fasi del respiro: A2 e P2 appaiono separate solo
durante l’inspirazione, mentre nella fase espiratoria sono uniti. Ciò dipende dal fatto
che con l’inspirazione aumenta il ritorno venoso per l’incremento della vis a fronte: il
ventricolo destro, perciò, riceve più sangue e la sua sistole è leggermente prolungata,
tanto da ritardare la chiusura della valvola polmonare; con l’espirazione, invece, questo
fenomeno non è più presente, e la chiusura delle due valvole semilunari è presso a poco
simultanea.
Lo sdoppiamento del II tono può essere fisso in presenza di un difetto del setto
interatriale, che comporta uno shunt sinistro-destro. In questa situazione la gittata
del ventricolo destro è sempre aumentata: in inspirazione per l’aumentato ritorno
venoso dalle vene cave, in espirazione per lo shunt attraverso il setto interatriale.
Infine, lo sdoppiamento del II tono può essere “paradosso”: in questo caso si
avvertono le due componenti separate in espirazione mentre il tono appare unico
durante l’inspirazione . Questo fenomeno è principalmente causato da un eccessivo
ritardo di A2. come accade in caso di blocco di branca sinistra o stenosi aortica
grave. In queste situazioni, il II tono è sdoppiato poiché la chiusura della valvola
aortica è ritardata per motivi elettrici (blocco di branca) o meccanici, ed è la
polmonare a chiudersi prima. Quando, durante l’inspirazione, si verifica un fisiologico
ritardo della chiusura della polmonare, legato all’aumentato ritorno venoso, A2 e P2
diventano simultanee, mentre in espirazione non vi è il ritardo di P2, per cui il II tono
appare sdoppiato.
Il II tono può risultare rinforzato in presenza di un aumento dei valori pressori
sistemici nella sua componente aortica (A2) o in presenza di un’ipertensione
polmonare, nella sua componente polmonare (P2). In queste condizioni, il livello della
pressione che fa chiudere la valvola semilunare è maggior del normale, per cui le
vibrazioni che la valvola genera nel chiudersi sono particolarmente ampie.
Il III tono corrisponde alla fase diastolica di riempimento rapido (protodiastole), e
può risultare ben evidente in caso di aumentato riempimento ventricolare o in
presenza di disfunzione ventricolare, come nello scompenso cardiaco. Normalmente il
III tono si ascolta soltanto nei bambini o nei soggetti con parete toracica
particolarmente sottile.
Il IV tono corrisponde alla sistole atriale (telediastole o presistole), e dipende dalle
vibrazioni provocate dal sangue che, spinto dalla contrazione dell’atrio, penetra nel
ventricolo. Normalmente questo fenomeno non dà luogo a un tono ascoltabile sia
perché le vibrazioni indotte dalla sistole atriale, a bassa frequenza, sono quasi in
continuità con quelle, a frequenza ben più alta, del I tono, sia perché la loro ampiezza
è molto bassa. Vi sono essenzialmente due condizioni che favorisono l’ascoltazione del
IV tono: il blocco A-V di I grado e la ridotta distensibilità ventricolare. Nel primo
caso si allunga l’intervallo P-R , per cui la sistole atriale non è seguita da quella
ventricolare immediatamente, ma dopo un tempo più lungo del normale, per cui in IV
tono è ben separato dal I. Nella seconda circostanza la ridotta distensibilità delle
pareti ventricolari, come avviene nella stenosi aortica o nella cardiopatia ipertensiva,
fa sì che aumenti l’ampiezza delle vibrazioni generate dal sangue che l’atrio spinge nel
ventricolo.
Quando il III o il IV tono si ascoltano in presenza di un aumento della frequenza
cardiaca, si può generare un ritmo a tre tempi (ritmo di galoppo). A volte sono
contemporaneamente presenti in III e il IV tono; se la frequenza cardiaca è
aumentata, si ha il cosiddetto galoppo di sommazione.
I Toni aggiunti
A parte i toni descritti, è possibile ascoltare, in particolari condizioni, patologiche, i
seguenti toni aggiunti.
1) I click sistolici, che comprendono il click del prolasso mitralico e i click eiettivi
aortico e polmonare, apprezzabili a volte in presenza di stenosi aortica o polmonare.
2) Gli schiocchi d’apertura della mitrale o della tricuspide, che si determinano al
momento dell’apertura di una valvola stenotica. Normalmente non si generano
vibrazioni udibili all’aprirsi delle valvole A-V, ma quando queste divengono stenotiche la
loro apertura provoca un tono aggiunto a tonalità alta, detto appunto schiocco
d’apertura .
I Soffi
Un soffio è il rumore che si genera quando il flusso del sangue diventa turbolento, e
può essere ascoltato col fonendoscopio non solo in corrispondenza del cuore, ma anche
sui vasi. In condizioni ideali, il flusso del sangue dovrebbe essere laminare (in base al
numero di Reynolds), ma in realtà non lo è quasi mai; la turbolenza marcata del flusso,
tale da generare vortici che poi si ascoltano come “soffi” si deve a vari motivi, inclusa
la stessa viscosità del sangue. I soffi cardiaci dipendono essenzialmente da: a) un
ostacolo anormale al flusso, come per esempio quello rappresentato da una valvola
stenotica; b) un flusso non fisiologico, come per esempio quello che si genera nel
difetto del setto interventricolare, nel quale vi è un flusso “innaturale” del sangue da
un ventricolo all’altro; c) un’aumentata velocità e/o un’aumentata quantità del flusso,
come si verifica per esempio nell’insufficienza aortica “pura” dove, in assenza di
stenosi valvolare, si può ascoltare sul focolaio aortico un soffio sistolico quando la
gittata sistolica ventricolare sinistra è notevolmente aumentata.
I soffi cardiaci si distinguono in base alla loro cronologia (cioè alla fase del ciclo
cardiaco in cui si ascoltano), al timbro, alla intensità, alla sede di ascoltazione e alla
irradiazione.
Una prima importante distinzione è fra soffi sistolici, diastolici e continui; questi
ultimi occupano tutto il ciclo cardiaco, mentre i primi sono limitati a una sola delle due
fasi. All’interno delle categorie dei soffi sistolici e diastolici, poi, se ne trovano alcuni
che occupano tutta la sistole (soffio solosistolico) o tutta la diastole (soffio
olodiastolico) e altri la cui durata è minore, che vengono definiti con i prefissi proto,
meso o tele (protosistolici, protodiastolici, etc) secondo che occupino solo la parte
iniziale della fase (sistole o diastole) in cui si ascoltano, oppure la parte intermedia o
quella finale.
Per quanto riguarda il timbro, i soffi vengono tradizionalmente definiti impiegando
termini come dolce, rude, aspro, aspirativo, raspante, e altri fra cui è molto diffuso
quello di “rullio” per indicare il soffio diastolico della stenosi mitralica, che viene
assimilato a un rullio di tamburi.
La sede di ascoltazione di un soffio cardiaco è il punto del precordio dove il soffio ha
la massima intensità. I quattro “classici” focolai dell’ascoltazione sono
quello mitralico (alla punta del cuore), tricuspidalico (all’incirca alla base dell’apofisi
ensiforme), aortico (sulla margino-sternale destra, al secondo spazio intercostale) e
polmonare (sulla margino-sternale sinistra, al secondo spazio intercostale).
L’irradiazione del soffio è la direzione in cui, partendo dalla sede, è ancora possibile
ascoltarlo bene. E’ caratteristica l’irradiazione all’ascella del soffio dell’insufficienza
mitralica e l’irradiazione al giugulo del soffio della stenosi aortica.
L’intensità dei soffi viene in genere valutata solo per quelli sistolici, secondo la scala a
6 gradini proposta da Levine, la quale tiene anche conto del fatto che quando un soffio
è molto intenso, le vibrazioni generate dalla turbolenza del flusso si possono non solo
ascoltare, ma anche palpare come fremiti, appoggiando la mano sul precordio.
1/6 è quel soffio che non si avverte immediatamente, ma solo quando si ascolta il
cuore con grande attenzione
2/6 è un soffio che si ascolta immediatamente, ma è relativamente debole
3/6 è un soffio forte ma non accompagnato da fremito
4/6 è un soffio forte accompagnato da fremito
5/6 è un soffio fortissimo, accompagnato da fremito, ma che non si ascolta più se si solleva il
fonendoscopio a 1 cm dalla cute
6/6 è un soffio fortissimo, accompagnato da fremito, che si continua ad ascoltare anche se si
solleva il fonendoscopio a 1 cm dalla cute
I soffi sistolici, inoltre, possono essere distinti in eiettivi e da rigurgito. Questa
distinzione ha molta importanza da un punto di vista clinico perché mentre i soffi
eiettivi possono essere sia organici, determinati cioè da una lesione anatomica (per
esempio, una stenosi valvolare aortica), che funzionali, legati a motivi differenti da
un’alterazione strutturale (per esempio, un’aumentata velocità del flusso), i soffi da
rigurgito sono sempre organici, espressione di un’alterazione anatomica.
I soffi eiettivi iniziano a una certa, anche se breve, distanza dal I tono. Prendiamo
come esempio il soffio eiettivo della stenosi aortica: all’inizio della sistole il ventricolo
sinistro si contrae e fa chiudere la valvola mitrale, dando origine al I tono; in questa
fase, che prende il nome di contrazione isometrica (o isovolumetrica) l’eiezione del
sangue dal ventricolo non è ancora iniziata. Solo quando la pressione endoventricolare
cresce e supera quella vigente in aorta (circa 80 mm Hg in condizioni normali) la
valvola aortica si apre e ha inizio il flusso attraverso la valvola e con esso il soffio,
assumendo che la valvola sia stenotica. Questo soffio, perciò, inizierà a una certa
distanza dal I tono, non simultaneamente ad esso.
Osserviamo ora il soffio da rigurgito della insufficienza mitralica . Questo inizia senza
alcun ritardo rispetto al I tono, ma contemporaneamente ad esso; infatti appena la
valvola mitrale si chiude e si genera il I tono inizia il rigurgito di sangue in atrio
sinistro, ben prima che la pressione intraventricolare aumenti al di sopra di quella
aortica e la valvola aortica si apra. In definitiva, il soffio sistolico da rigurgito inizia
attaccato al I tono, mentre il soffio sistolico eiettivo è staccato dal I tono.
I soffi sistolici da eiezione hanno in generale la caratteristica di essere in crescendodecrescendo, assumendo una morfologia “a diamante”, mentre i soffi da rigurgito
hanno un aspetto “a nastro” conservando la stessa intensità per tutta la loro durata.
I soffi sistolici da rigurgito sono quelli dell’insufficienza mitralica, dell’insufficienza
tricuspidale, del difetto del setto interventricolare; quelli eiettivi possono essere
organici, legati alla stenosi aortica o alla stenosi polmonare , ma possono anche essere
soltanto di natura funzionale, espressione di una stenosi relativa, dovuti non a
riduzione dell’ostio valvolare, ma semplicemente ad aumento del flusso con un’area
valvolare normale.
I soffi diastolici sono quasi sempre organici, e comprendono il soffio (rullio) diastolico
della stenosi mitralica, quello della stenosi tricuspidalica , il soffio dell’insufficienza
aortica e quello dell’insufficienza polmonare .
I soffi continui sono sempre legati ad una anormale connessione fra il circolo
arterioso e quello venoso, con shunt artero-venoso che dura per tutto il ciclo cardiaco.
Il prototipo del soffio continuo è quello generato dalla pervietà del dotto arterioso di
Botallo, che si ascolta in sede sottoclaveare sinistra.
Gli Sfregamenti
Relativamente simili ai soffi sono gli sfregamenti pericardici, che si ascoltano in alcuni
soggetti affetti da pericardite . Normalmente i foglietti pericardici viscerale e
parietale sono lisci e scorrono l’uno sull’altro senza alcuna frizione, ma in seguito
all’infiammazione il movimento dei foglietti, divenuti rugosi, genera gli sfregamenti,
che spesso si ascoltano sia in sistole che in diastole.
Lo Scompneso Cardiaco
Lo scompenso cardiaco si presenta con un quadro clinico estremamente variabile, per cui ne sono
state proposte numerose definizioni. La più tradizionale, di tipo fisiopatologico, descrive lo
scompenso cardiaco
come una sindrome in cui il cuore non è in grado di mantenere una portata cardiaca adeguata
alle richieste dei tessuti oppure, nel caso vi riesca, questo è ottenuto attraverso un aumento delle
pressioni di riempimento ventricolari.
La Società Europea di Cardiologia ha definito lo scompenso cardiaco
come una sindrome caratterizzata dai seguenti aspetti: sintomi e/o segni tipici (dispnea e/o ast
enia, a riposo e/o da sforzo, e/o edemi declivi) ed evidenza obiettiva (generalmente mediante ec
ocardiografia) di una disfunzione cardiaca sistolica e/o diastolica.
L’importanza dell’attivazione neuroumorale e delle controrisposte dei vari organi nel determinare la
progressione dello scompenso cardiaco fa ritenere necessario includere anche questi fattori nella
definizione. Per scompenso cardiaco si deve quindi
intendere una sindrome in cui ad un calo, assoluto o relativo, della portata cardiaca, comunque
determinato ma conseguente ad una causa cardiaca, corrisponde una risposta multiorganica
con attivazione cronica neuroumorale in grado di deteriorare ulteriormente la funzione mioca
rdica, nonostante una controrisposta di fattori tendenti al ripristino dell’omeostasi circolatori
a.
EPIDEMIOLOGIA
A causa del progressivo invecchiamento della popolazione e del migliorato trattamento della
maggior parte delle malattie cardiovascolari, la prevalenza dello scompenso cardiaco è in continua
crescita. La prevalenza di scompenso sintomatico è del 0.5-2% della popolazione generale: nei
paesi europei sono quindi affette da scompenso cardiaco sintomatico più di 12 milioni di persone.
Un numero simile di pazienti, inoltre, sarebbe portatore di disfunzione sistolica ventricolare sinistra
asintomatica, ed altrettanti sarebbero affetti da scompenso cardiaco con conservata funzione
sistolica ventricolare. La prognosi dello scompenso cardiaco è spesso sfavorevole: la forma acuta di
scompenso è la più importante causa di ospedalizzazione per i soggetti di età superiore ai 65 anni.
Circa la metà dei pazienti affetti da scompenso cardiaco è destinata a morire in un tempo medio di 4
anni dal momento della diagnosi, e la durata della vita può accorciarsi ad un solo anno per il 50%
dei pazienti con scompenso severo. Recenti dati indicano, tuttavia, un miglioramento della prognosi
dovuto all’applicazione di terapie con evidenza di efficacia.
CAUSE
Lo scompenso cardiaco è la via finale comune di tutte le patologie in grado di
compromettere la funzione cardiaca. Può essere causato da una disfunzione
miocardica (condizione più frequente) ma anche da valvulopatie, malattie del
pericardio o disturbi del ritmo. L’ischemia miocardica acuta, o più raramente l’anemia,
la disfunzione tiroidea, l’insufficienza renale o la somministrazione di farmaci inotropi
negativi possono peggiorare o qualche volta causare lo scompenso cardiaco.
Nei paesi occidentali, nei pazienti di età inferiore ai 75 anni, lo scompenso cardiaco è
spesso caratterizzato da una compromissione della funzione sistolica: la cardiopatia
ischemica, spesso con concomitante ipertensione arteriosa, ne è la causa più
frequente. Nei pazienti di età superiore ai 75 anni, invece, è più frequente
l’insufficienza cardiaca con conservata funzione sistolica. Non di rado questi soggetti
hanno una storia d’ipertensione arteriosa, spesso sistolica isolata, ed un’ipertrofia
ventricolare sinistra concentrica.
Oltre alla cardiopatia ischemica ed all’ipertensione arteriosa, le cardiomiopatie, in
particolare la cardiomiopatia dilatativa, e le valvulopatie sono altre importanti cause di
scompenso cardiaco.
MECCANISMI FISIOPATOLOGICI ALLA BASE DELL’ALTERATA FUNZIONE
MIOCARDICA
Determinanti della funzione cardiaca. I principali determinanti della funzione cardiaca
sono la frequenza cardiaca, il precarico, il postcarico e la contrattilità.
Il precarico è il carico a cui è sottoposto il cuore prima dell’iniizio della contrazione
(telediastole). Viene misurato dal volume o, meglio, dallo stress telediastolico.
L’aumento del precarico causa un aumento della forza di contrazione miocardica (legge
di Starling) per migliore sovrapposizione tra actina e miosina. Il cuore insufficiente è
generalmente dilatato a tal punto da avere un esaurimento della riserva di precarico
così che le variazioni di quest’ultimo non comportano più variazioni della gettata
cardiaca.
Il postcarico è il carico cui è sottoposto il cuore durante la contrazione. Viene
misurato dallo stress sistolico, ed è correlato all’impedenza aortica ed alle resistenze
periferiche. Lo stress sistolico è direttamente proporzionale al raggio ed alla
pressione intraventricolare ed inversamente proporzionale allo spessore parietale
(legge di Laplace). L’aumento della pressione arteriosa comporta quindi un aumento del
postcarico. Il cuore insufficiente è criticamente dipendente dal postcarico.
La contrattilità è la capacità del miocardio di contrarsi indipendentemente dalle
condizioni di carico. Il deficit di contrattilità miocardica è l’alterazione fondamentale
dello scompenso. Spesso questa non comporta alterazioni della potata cardiaca e delle
pressioni di riempimento ventricolari a riposo. Sotto sforzo, tuttavia, il cuore
insufficiente presenterà sempre una ridotta capacità di far fronte alle aumentate
richieste dei tessuti periferici con insufficiente incremento della contrattilità e della
portata cardiaca ed aumento delle pressioni di riempimento intraventricolari.
Vengono qui di seguito riassunti i principali meccanismi responsabili del deficit di
contrattilità.
Ipertrofia Miocardica
L’ipertrofia miocardica si verifica in risposta ad un aumento dello stress parietale.
Questo può essere dovuto sia a sovraccarico pressorio (per esempio, ipertensione,
stenosi aortica) che di volume (per esempio, rigurgito mitralico oppure aortico). Il
ruolo svolto dall’ipertrofia miocardica nella patogenesi dello scompenso cardiaco è
tradizionalmente ritenuto fondamentale: l’ipertrofia è vista come lo stadio intermedio
tra un qualsiasi danno miocardico iniziale e la successiva insufficienza miocardica.
Tuttavia, nonostante numerose dimostrazioni sperimentali, pochi studi clinici sono
stati finora in grado di confermare questa ipotesi.
L’ipertrofia comporta modificazioni di tutte le componenti del miocardio che ne
favoriscono, a loro volta, la degenerazione con dilatazione ed ipocinesia ventricolare. A
livello dei miociti, si verifica un aumento del numero dei sarcomeri, che avviene in
parallelo, con ispessimento delle fibre miocardiche, nel caso di un sovraccarico
pressorio (ipertrofia concentrica) o in serie, con loro allungamento (ipertrofia
eccentrica), nel sovraccarico volumetrico. In ogni caso, il volume delle fibre
miocardiche aumenta in misura maggiore rispetto al numero dei capillari, e all’interno
di ciascuna cellula il numero dei sarcomeri aumenta in misura maggiore rispetto ai
mitocondri, così che il miocita viene a trovarsi in una condizione di relativa carenza di
ossigeno e di energia.
L’ipertrofia comporta, inoltre, un’accelerazione dei processi di morte cellulare
(apoptosi) ed alterazioni qualitative, con aumento della sintesi di proteine di tipo
fetale che contribuiscono alla genesi della disfunzione cardiaca. La fibrosi miocardica
viene a compromettere ulteriormente l’apporto di ossigeno e substrati alle cellule
miocardiche e la capacità delle arteriole coronariche a dilatarsi.
Accelerata morte cellulare
Può verificarsi con i meccanismi sia della necrosi che dell’apoptosi. La necrosi si
realizza nei pazienti affetti da cardiopatia ischemica sia sotto forma di infarto
clinicamente evidente che di microinfarti. E’ infatti possibile rilevare un aumento della
troponina plasmatica in pazienti con scompenso cardiaco ma senza sindrome coronarica
acuta. Questa evenienza può verificarsi anche in pazienti senza coronaropatia, a causa
del relativo deficit di apporto di ossigeno ai miociti favorito dall’ipertrofia, aumento
dello stress miocardico e della pressione telediastolica ventricolare.
Differentemente dalla necrosi, l’apoptosi è un processo attivo, energia dipendente, in
cui l’attivazione di uno specifico programma genetico porta ad una cascata di eventi
con esito in degradazione del DNA cellulare. Questo processo, normalmente presente
solo in un piccolissimo numero di cellule miocardiche, è attivato in corso di scompenso
cardiaco, contribuendo al deficit di contrattilità.
Alterato rapporto fra le isoforme della miosina
Esistono due principali isoforme della catena pesante della miosina (MHC, myosin
heavy chain). Una rapida, ad elevata attività ATPasica, codificata dal gene alfa-MHC,
prevalente nella vita adulta, ed una lenta, a bassa attività ATPasica, codificata dal
gene beta-MHC, prevalente nella vita fetale. Nel cuore insufficiente si verifica la
riespressione di geni normalmente attivi durante la vita fetale, con maggiore sintesi di
beta-MHC.
Queste alterazioni si correlano con la riduzione della contrattilità miocardica e sono
antagonizzate, nella maggioranza dei pazienti, dalla terapia beta-bloccante.
Ridotto contenuto miocardico di substrati ad alto contenuto energetico
Lo scompenso cardiaco si associa a riduzione dell’apporto di ossigeno e substrati alla
cellula miocardica ed a compromissione dei meccanismi di produzione dei substrati ad
alto contenuto energetico. Questi comprendono alterazioni nell’utilizzazione dei
substrati (glucosio ed acidi grassi), nella fosforilazione ossidativa e nel trasferimento
ed utilizzazione dell’ATP. Vi è anche un’importante compromissione
dell’immagazzinamento di energia sotto forma di creatin-fosfato (CP). Il rapporto
CP/ATP è un indice della disponbilità di energia a livello miocardico e la sua riduzione
in corso di scompenso, valutabile mediante risonanza magnetica nucleare e
spettroscopia, predice un’elevata mortalità nei pazienti.
Alterato metabolismo del calcio
Indipendentemente dalle alterazioni presenti a livello dei meccanismi di produzione di
energia e dell’apparato contrattile miocardico, la cellula miocardica mantiene una
normale risposta contrattile alla somministrazione di calcio. E’quindi logico ritenere
che le alterazioni del metabolismo del calcio siano tra i principali fattori responsabili
dell’alterata funzione sistolica e/o diastolica del cuore insufficiente.
Nei pazienti con scompenso cardiaco è ridotta l’attività dell’ATPasi calcio-dipendente
del reticolo sarcoplasmatico (SERCA), responsabile della ricaptazione del calcio
durante la diastole. A questo consegue una compromissione del rilasciamento
miocardico ed un ridotto accumulo di calcio all’interno del reticolo sarcoplasmatico. Ciò
determina la liberazione di una minore quantità di calcio nella sistole successiva, con
conseguente riduzione della contrattilità.
Un’altra alterazione riguarda l’iperfosforilazione del fosfolambano con conseguente
maggiore perdita di calcio dal reticolo sarcoplasmatico al citoplasma durante la
diastole.
Fibrosi interstiziale
A carico del tessuto connettivo del cuore insufficiente si verificano modificazioni a
livello sia della componente cellulare (fibroblasti) che intercellulare. I fibroblasti
vanno incontro ad iperplasia, con un aumento di sintesi di collagene sproporzionato
rispetto alla componente miocitaria (fibrosi interstiziale). Si verificano anche
modificazioni qualitative del collagene, consistenti in aumentata sintesi di collagene
tipo I, più rigido, con maggiore suscettibilità alle fratture del collagene, scivolamento
delle fibre miocardiche le une sulle altre, disorganizzazione della normale
architettura del ventricolo sinistro, che assume una conformazione sferica. Questa
comporta un aumento dello stress parietale e minore efficienza contrattile.
La fibrosi interstiziale rappresenta, insieme alla compromissione dei processi di
ricaptazione del calcio da parte della SERCA, il maggiore meccanismo responsabile
delle alterazioni della funzione diastolica del cuore insufficiente.
ATTIVAZIONE NEURO-ORMONALE
Nello scompenso cardiaco entrano in gioco da protagonisti alcuni meccanismi (sistemi
simpato-adrenergico e renina-angiotensina-aldosterone, in particolare) la cui azione
consiste essenzialmente nel determinare vasocostrizione periferica, ritenzione idrosalina ed ipertrofia e/o iperplasia cellulare. Questi meccanismi favoriscono la
progressione dello scompenso cardiaco e, anche alla luce dei risultati degli studi clinici
con specifici antagonisti, sono da ritenerne i principali responsabili.
Attivazione simpato-adrenergica
I pazienti con scompenso cardiaco presentano, rispetto ai soggetti normali,
un’aumentata eliminazione urinaria di catecolamine ed elevate concentrazioni
plasmatiche di norepinefrina. L’incremento dell’attività simpatica non interessa in
modo uniforme tutti gli organi, ma si verifica soprattutto a livello renale e cardiaco;
qui le concentrazioni di norepinefrina sono aumentate di 5-20 volte rispetto al
normale. L’attivazione simpatoadrenergica è un fenomeno precoce nell’evoluzione dello
scompenso, ed è già presente nei pazienti con disfunzione ventricolare sinistra
asintomatica. Lo squilibrio neuroendocrino interessa globalmente tutto il sistema
neurovegetativo, poiché all’aumento dell’attività simpatica è associata la riduzione di
quella parasimpatica.
L’importanza della stimolazione simpatoadrenergica nella progressione dello
scompenso cardiaco è dimostrata dal valore prognostico indipendente dei livelli di
norepinefrina plasmatica e dall’effetto estremamente favorevole sulla prognosi della
terapia beta-bloccante.
Numerosi sono i meccanismi con cui la stimolazione simpatoadrenergica può avere
effetti dannosi sulla cellula miocardica. Essa porta ad una progressiva riduzione del
numero dei beta1 recettori miocardici, per cui il rapporto tra beta1 e beta2 recettori
miocardici si sposta dai valori normali di 80:20 a valori di 60:40. Ciò causa una ridotta
risposta cardiaca alla stimolazione simpatica che può, ad esempio, contribuire al
ridotto incremento della portata cardiaca ed alla ridotta tolleranza allo sforzo dei
pazienti..
La norepinefrina ha anche effetti dannosi diretti sulle fibre miocardiche, stimolando
apoptosi ed alterazioni dell’espressione genica nei cardiomiociti (aumento della betaMHC, riduzione dell’alfa-MHC e della SERCA). Essa può favorire l’ischemia e la necrosi
miocardica attraverso l’aumento della frequenza e della contrattilità, condizioni
entrambe in grado di incrementare il consumo di ossigeno.
Altri effetti sfavorevoli della stimolazione simpatica sono: 1) la vasocostrizione
periferica, sia diretta che indiretta, per stimolazione del sistema renina-angiotensina,
con conseguente aumento del postcarico e riduzione della gittata sistolica; 2)
l’induzione di aritmie ventricolari, potenzialmente fatali; e 3) l’attivazione del sistema
renina-angiotensina.
Sistema renina angiotensina aldosterone
L’attività reninica plasmatica aumenta soprattutto nei pazienti con più grave
compromissione emodinamica e funzionale. La sua importanza è dimostrata dagli
effetti favorevoli degli ACE inibitori e degli antagonisti dei recettori dell’angiotensina
II sulla prognosi.
I meccanismi con cui l’angiotensina II può influenzare negativamente l’evoluzione dello
scompenso sono molteplici. In primo luogo, essa causa vasocostrizione periferica,
aumento del postcarico e calo della gittata sistolica. In secondo luogo, stimola la
secrezione di aldosterone causando ritenzione idro-salina e quindi aumento del
precarico, edemi declivi e congestione venosa sistemica. Similmente alla norepinefrina,
anche l’angiotensina II ha un effetto tossico diretto sul miocardio (apoptosi).
L’aldosterone, la cui secrezione è stimolata dall’angiotensina II, oltre a causare
ritenzione idro-salina ed ipokaliemia, provoca anche ipertrofia e fibrosi miocardica,
aumento della stimolazione simpatica cardiaca e disfunzione endoteliale. Tutti questi
effetti contribuiscono alla progressione dello scompenso e rendono conto degli effetti
favorevoli dei farmaci antialdosteronici sulla prognosi.
Vasopressina
Da molti anni è stata segnalata, in corso di scompenso cardiaco, la presenza di elevate
concentrazioni plasmatiche di vasopressina, la cui secrezione, però, sembra essere
stimolata meno frequentemente che quella di renina, aldosterone o norepinefrina.
La vasopressina agisce su due diversi recettori, V1 e V2. La stimolazione dei recettori
V1 determina vasocostrizione periferica con diminuzione della gittata sistolica,
mentre la stimolazione dei recettori V2 provoca ritenzione di acqua libera per
permeabilizzazione all’acqua del tubulo collettore renale.
Differentemente che nel caso dei precedenti sistemi, in questo caso la
somministrazione di antagonisti della vasopressina non ha determinato variazioni nella
sopravvivenza.
Fattori natriuretici
La famiglia dei fattori natriuretici comprende il peptide natriuretico A o atriale
(ANP), il peptide natriuretico B o cerebrale (BNP), così chiamato perché isolato per la
prima volta nelle cellule del sistema nervoso centrale di maiale, il peptide natriuretico
C (CNP), prodotto e secreto prevalentemente dal sistema nervoso centrale e dai vasi
periferici.
La sintesi di ANP e di BNP risulta estremamente limitata nel soggetto adulto normale.
In corso di scompenso cardiaco, viceversa, l’aumento dello stress parietale miocardico
causa l’espressione di geni attivi nella vita fetale con conseguente produzione di ANP e
BNP. Il BNP viene sintetizzato sotto forma di pro-ormone (proBNP), che viene quindi
clivato a livello citoplasmatico con formazione di BNP attivo e di un frammento Nterminale (NT-proBNP). Entrambi vengono rapidamente immessi nel torrente
circolatorio.
L’ANP e il BNP vengono prodotti e secreti sia a livello atriale che ventricolare: la
concentrazione di ANP è maggiore a livello atriale mentre quella di BNP è maggiore a
livello ventricolare. Per questo motivo, oltre che per la più rapida risposta della
secrezione del BNP in condizioni di sovraccarico, si impiega attualmente nella pratica
clinica il dosaggio del BNP o del NT-ProBNP per la valutazione diagnostica e
prognostica dei pazienti con socmpenso cardiaco.
I fattori natriuretici causano vasodilatazione periferica, inibiscono l’attivazione
simpatica e la secrezione di renina e di aldosterone, e favoriscono la natriuresi. La
loro secrezione si verifica precocemente nello scompenso cardiaco. È quindi probabile
che i fattori natriuretici abbiano un ruolo importante nel mantenere un normale
equilibrio idro-salino. Nelle fasi inziali dello scompenso cardiaco, essi riuscirebbero a
controbilanciare gli effetti dell’attivazione dei sistemi simpatoadrenergico e reninaangiotensina-aldosterone.
Prostaglandine
Le prostaglandine PgE2 e Pgi2 hanno un’azione vasodilatatrice e giocano, a livello
dell’arteriola afferente renale, un ruolo importante, dimostrato indirettamente
dall’osservazione che l’inibizione della loro sintesi con antiinfiammatori non steroidei
determina un netto peggioramento della funzione renale, per vasocostrizione
dell’arteriola afferente glomerulare, e talvolta anche del compenso emodinamico, nei
pazienti con scompenso cardiaco.
Ossido nitrico
L’ossido nitrico (NO) è il più potente vasodilatatore endogeno conosciuto. Una
riduzione della vasodilatazione NO-dipendente è stata dimostrata in numerose
condizioni patologiche tra cui lo scompenso cardiaco.
Endotelina
Le endoteline sono peptidi dotati di una potente e prolungata azione vasocostrittrice.
La loro sorgente più importante sembrano essere le cellule endoteliali. Oltre a
presentare una potente e prolungata attività vasocostrittrice, le endoteline stimolano
il rilascio di catecolamine ed aldosterone, favoriscono l’ipertrofia miocardica e la
proliferazione delle cellule muscolari lisce.
Nei pazienti con scompenso cardiaco è stato dimostrato un incremento significativo
delle concentrazioni di ET-1, rispetto ai soggetti normali. Tuttavia, la
somministrazione di antagonisti dei recettori dell’endotelina non ha avuto effetti
favorevoli né nei confronti del rimodellamento ventricolare sinistro, né sui sintomi e la
prognosi dei pazienti con scompenso acuto.
Stress ossidativo
Esistono numerose evidenze di un aumento dello stress ossidativo sia a livello
miocardico che a livello vascolare sistemico nei pazienti con scompenso cardiaco. La
produzione di radicali liberi riduce la capacità di dilatazione vascolare periferica e
stimola l’ipertrofia dei miociti, la riespressione dei fenotipi fetali e l’apoptosi.
Citochine
I livelli circolanti di citochine pro-infiammatorie, incluse TNF-a e IL-6, sono
aumentati nei pazienti con scompenso cardiaco, rispetto ai soggetti normali, e sono
correlati con la severità della sintomatologia e con la prognosi. Gli effetti negativi dei
mediatori infiammatori sulla progressione dello SC sono molteplici e comprendono
un’attività inotropa negativa, l’induzione di un genotipo fetale e di apoptosi a livello dei
cardiomiociti, la cachessia e l’ipotrofia della muscolatura scheletrica. Tuttavia,
nonostante questi presupposti fisiopatologici, l’impiego di antagonisti specifici delle
citochine non ha modificato l’evoluzione dei pazienti con scompenso, e nessuna terapia
antiinfiammatoria ha permesso di migliorare la prognosi dei pazienti.
RITENZIONE IDRO-SALINA ED AUMENTO DEL PRECARICO
La ritenzione idro-salina è dovuta, nello scompenso cardiaco, a due meccanismi
fondamentali: le modificazioni dell’emodinamica renale e l’attivazione neuro-ormonale.
Flusso ematico renale e filtrazione glomerulare
Nello scompenso cardiaco, l’attivazione simpatica determina una redistribuzione della
portata cardiaca con riduzione del flusso ematico renale. A questo fa riscontro una
relativa conservazione della filtrazione glomerulare, con aumento della frazione di
filtrazione. Infatti, l’angiotensina II determina una vasocostrizione maggiore
nell’arteriola efferente che in quella afferente, per cui la pressione all’interno dei
capillari glomerulari aumenta. La filtrazione glomerulare, perciò, diminuisce in misura
minore rispetto al flusso plasmatico renale, e la frazione di filtrazione aumenta.
Ritenzione idrico-salina
La riduzione del flusso plasmatico renale e l’aumento della frazione di filtrazione
determinano ipoperfusione dei capillari peritubulari, con conseguente calo della
pressione idrostatica ed aumento della concentrazione di proteine e della pressione
oncotica al loro interno. Queste modificazioni dell’equilibrio tra pressione idrostatica
ed oncotica intratubulare e nei capillari peritubulari portano ad un maggior
riassorbimento di sodio cui consegue, per osmosi, anche un maggior riassorbimento
idrico.
L’iperattività simpatica e del sistema renina-angiotensina causano ritenzione idrosalina
anche con altri meccanismi. L’attivazione simpatica determina redistribuzione del
flusso ematico intrarenale dai nefroni corticali e quelli iuxtamidollari, dotati di più
lunghe anse di Henle e quindi in grado di maggior riassorbimento salino. L’angiotensina
II stimola la secrezione di aldosterone, con maggior riassorbimento di sodio, in
scambio con il potassio, a livello del tubulo distale e del collettore. Infine, la
vasopressina rende permeabile all’acqua il tubulo collettore e favorisce il
riassorbimento di acqua. Il riassorbimento di acqua può verificarsi in misura maggiore
del riassorbimento di sodio con conseguente iposodiemia da diluizione.
La ritenzione idro-salina viene tradizionalmente vista come una meccanismo finalistico,
attraverso il quale l’organismo cerca di mantenere un adeguato volume ematico in
condizioni in cui la portata cardiaca e la pressione di perfusione tessutale tendono a
calare per effetto della ridotta contrattilità miocardica. Queste modificazioni sono,
tuttavia, dannose per l’evoluzione dello scompenso cardiaco e rappresentano la
principale causa di molti sintomi lamentati dal paziente (edemi, dispnea) oltre che
delle ospedalizzazioni per peggioramento dello scompenso.
Modificazione del precarico
La ritenzione idro-salina è alla base della formazione di edema e comporta, a livello
cardiaco, un aumento del precarico. L’aumento di precarico può inizialmente
comportare una maggior gittata sistolica attraverso il meccanismo di Frank-Starling.
Tuttavia, il cuore insufficiente esaurisce ben presto la propria riserva di precarico
(vedi sopra). L’aumento del volume ventricolare continua, invece, a determinare un
aumento dello stress parietale miocardico e quindi, per la legge di Laplace, anche del
postcarico e del consumo miocardico di ossigeno.
VASOCOSTRIZIONE PERIFERICA ED AUMENTO DEL POSTCARICO
Nello scompenso cardiaco, l’aumento delle resistenze vascolari periferiche è dovuto
all’attivazione dei meccanismi neuroumorali ad azione vasocostrittrice ed alle
alterazioni di sistemi locali (NO, endotelina, etc). Questi fenomeni determinano
vasocostrizione arteriolare e riduzione del diametro e della compliance delle grosse e
medie arterie.
Il ventricolo normale è in grado di mantenere una normale gittata sistolica anche in
presenza di incremento del postcarico. All’opposto, il cuore insufficiente è
criticamente dipendente dal post-carico, così che anche minime variazioni dello stesso
comportano un’importante riduzione della gittata sistolica. Questo motivo ha guidato
l’introduzione della terapia vasodilatatrice nello scompenso cardiaco.
RIDUZIONE DELLA TOLLERANZA ALLO SFORZO
La ridotta tolleranza allo sforzo è uno dei sintomi fondamentali del paziente con
scompenso cardiaco.
Fattori emodinamici
La riduzione della capacità funzionale è innanzitutto conseguenza della
compromissione emodinamica del paziente con scompenso cardiaco. Nessun parametro
emodinamico, valutato a riposo, tuttavia, è correlato con la capacità funzionale. La
risposta allo sforzo, a differenza dell’emodinamica a riposo, è strettamente correlata
con la capacità funzionale. Una correlazione significativa è stata osservata
soprattutto con gli indici di funzione sistolica ventricolare sinistra (portata cardiaca,
indice di lavoro del ventricolo sinistro).
Flusso ematico muscolare scheletrico
Nei pazienti con scompenso cardiaco è stata osservata una ridotta capacità
dilatatrice dei vasi della muscolatura scheletrica. La riduzione della portata cardiaca e
della vasodilatazione muscolare fanno sì che il muscolo si venga a trovare, sotto
sforzo, in una condizione di relativa ipoperfusione responsabile, a sua volta, di più
precoce comparsa di metabolismo anaerobio e di riduzione della tolleranza allo sforzo.
A questa ridotta capacità di dilatazione dei vasi della muscolatura scheletrica
contribuiscono sia l’attivazione neuroumorale che alterazioni di sistemi locali (NO,
endotelina, citochine).
Caratteristiche biochimiche e funzionali della muscolatura scheletrica
Il 25-40% dei pazienti con scompenso cardiaco può presentare una riduzione della
capacità funzionale, con precoce comparsa di metabolismo muscolare anaerobio
nonostante un normale incremento del flusso ematico durante sforzo. In questi
pazienti la muscolatura scheletrica sembra essere la principale responsabile della
ridotta capacità funzionale.
In corso di scompenso cardiaco, i muscoli scheletrici vanno incontro a modificazioni
morfologiche (ipotrofia, fibrosi interstiziale, depositi lipidici, riduzione della densità
dei capillari) e biochimiche (riduzione degli enzimi responsabili del metabolismo
aerobio, con normale o aumentata attività degli enzimi della glicolisi anaerobia).
Similmente alla riduzione della capacità dilatatrice dei vasi, anche le alterazioni della
muscolatura scheletrica possono essere considerate come il risultato di un processo di
decondizionamento muscolare. L’importanza di questo meccanismo è dimostrata dalla
possibilità di ottenere un significativo miglioramento della capacità funzionale con
l’allenamento fisico.
Diffusione alveolo-capillare
Anche la diffusione alveolo-capillare dell’ossido di carbonio, valutata a riposo, è
correlata con la massima capacità lavorativa. Nello scompenso cardiaco, una riduzione
della capacità di diffusione alveolo-capillare può determinare incremento dello spazio
morto fisiologico e del rapporto tra spazio morto polmonare e capacità vitale (Vd/Vt).
Risposta ventilatoria allo sforzo
I pazienti con scompenso cardiaco presentano, durante sforzo, un respiro più rapido e
più superficiale, con maggiore incremento della ventilazione (VE), a parità di carico
lavorativo, rispetto ai soggetti normali.
SCOMPENSO CARDIACO ACUTO
DEFINIZIONE
L’insufficienza cardiaca è la situazione in cui il cuore è Incapace di pompare
sangue in quantità adeguata alle esigenze metaboliche dell’organismo, oppure può
far questo soltanto mediante un aumento delle pressioni di riempimento.
L’insufficienza cardiaca acuta, definita come la comparsa improvvisa di segni e
sintomi secondari a disfunzione cardiaca sistolica o diastolica, può essere
associata ad una malattia cardiaca pre-esistente, ad anomalie del ritmo o ad un
“mismatch” del pre e del post-carico; questa condizione rappresenta una minaccia
per la vita e necessita di un trattamento di emergenza.
L’insufficienza cardiaca acuta può presentarsi come prima manifestazione di
malattia in pazienti senza disfunzione cardiaca conosciuta precedentemente, o
come riacutizzazione di un’insufficienza cardiaca cronica. Perciò, l’insufficienza
cardiaca acuta comprende tre differenti gruppi di pazienti: 1) pazienti con
un’insufficienza cardiaca “de novo” secondaria ad un fattore precipitante, come ad
esempio un esteso infarto del miocardio o un improvviso aumento della pressione
arteriosa in presenza di un ventricolo sinistro deficitario; 2) pazienti con
peggioramento di un’insufficienza cardiaca cronica sistolica o diastolica; 3)
pazienti che presentano un’insufficienza cardiaca avanzata o all’ultimo stadio, e
vanno rapidamente incontro a deterioramento, con disfunzione ventricolare
prevalentemente sistolica, scarsa risposta alla terapia medica e necessità di
trattamenti non farmacologici.
EPIDEMIOLOGIA
L’insufficienza cardiaca è la principale causa di morbilità e mortalità nel mondo
occidentale. La causa più comune di insufficienza cardiaca acuta è la malattia
coronarica (~70%).
I pazienti con insufficienza cardiaca acuta hanno una prognosi severa: la mortalità è
particolarmente elevata (30% a 12 mesi) nell’infarto miocardico acuto associato ad
insufficienza cardiaca grave. Dati simili sono stati riportati per l’edema polmonare
acuto. Circa la metà dei pazienti ospedalizzati per insufficienza cardiaca acuta
vengono nuovamente ricoverati almeno una volta (e il 15% almeno due volte) entro un
anno. In questa popolazione, ogni evento acuto determina una riduzione progressiva
della capacità funzionale, per cui gli sforzi terapeutici devono essere rivolti anche ad
un’azione di cardioprotezione.
Quadri Clinici
I sintomi e i segni nel paziente con insufficienza cardiaca acuta sono riconducibili: 1)
alla diminuzione della portata cardiaca a riposo, fino a livelli che comportano
ipoperfusione tissutale e riduzione del flusso renale; 2) all’aumento delle pressioni di
riempimento ventricolari destre e sinistre con conseguente congestione sistemica e
polmonare. Tali sintomi e segni, sommandosi in vario modo, compongono i diversi quadri
clinici, correlati anche alle differenti cause di base, agli eventi scatenanti, alla
rapidità di insorgenza e alla gravità.
LA DISPNEA
Sintomo base dello scompenso acuto del ventricolo sinistro è la dispnea, che consiste
in una sensazione di sforzo o fatica nel respirare e può essere associata a fame d’aria.
È la conseguenza della congestione polmonare, dovuta alle aumentate pressioni
intracavitarie nelle sezioni sinistre del cuore, che provoca aumento del contenuto
idrico extravascolare polmonare, riducendo la distensibilità polmonare e aumentando il
lavoro dei muscoli respiratori. Nell’insufficienza cardiaca acuta la dispnea assume
spesso le caratteristiche di ortopnea e dispnea parossistica notturna.
L’ortopnea è la necessità di mantenere il torace in posizione eretta per evitare
l’insorgenza della dispnea o ridurne l’entità. La posizione supina, infatti, aumenta il
ritorno venoso al cuore e quindi peggiora la congestione polmonare.
La dispnea parossistica notturna è caratterizzata da manifestazioni accessionali,
durante le quali il paziente avverte una sensazione di mancanza di aria ed è costretto
a sedersi sul letto con i piedi penzoloni o a portarsi alla finestra alla ricerca di aria. In
alcuni casi compare tosse stizzosa e respiro sibilante dovuto a broncostenosi
(asma cardiaco).
L’EDEMA POLMONARE
L’edema polmonare è il quadro più grave dello scompenso cardiaco acuto, e viene
provocato dall’accumulo di liquido nello spazio extravascolare polmonare. Il passaggio
di liquido dal capillare all’interstizio e viceversa è, in condizioni normali, governato da
due fattori: la pressione idrostatica del sangue capillare, che tende a far fuoriuscire
la parte liquida del sangue, e la pressione osmotica delle proteine plasmatiche,
(pressione oncotica) che tende, invece, a trattenere il liquido dentro il vaso.
Quest’ultima corrisponde a una pressione di circa 25 mm Hg. Quando la pressione
all’interno dei capillari polmonari aumenta al di sopra dei 25 mmHg, si realizza
dapprima la trasudazione e l’accumulo di liquido nell’interstizio (edema interstiziale); il
sistema linfatico si adopera quindi ad allontanare il trasudato, ma quando la sua
capacità di drenaggio viene superata il liquido invade gli alveoli (edema alveolare),
compromettendo la funzione polmonare, sia da un punto di vista meccanico che degli
scambi gassosi.
La compromissione respiratoria genera ipossiemia e acidosi, le quali provocano un
ulteriore peggioramento della funzione cardiaca, riducendo la portata ed aumentando
la pressione capillare polmonare. La riduzione della portata cardiaca, inoltre, attiva il
sistema adrenergico che, attraverso la vasocostrizione cutanea, muscolare e
splancnica, tende a mantenere un’adeguata perfusione cerebrale e cardiaca, ma d’altro
canto induce tachicardia, ipertensione, pallore e contrazione della diuresi. L’aumento
delle resistenze vascolari periferiche determina un incremento del carico di lavoro in
un cuore già insufficiente, e peggiora la performance cardiaca provocando un’ulteriore
riduzione della portata; si innesca quindi un circolo vizioso, sino a quando la portata
crolla al di sotto dei valori minimi necessari per mantenere una normale perfusione
cardiaca e cerebrale, e s’instaura il quadro dello shock cardiogeno (vedi Capitolo 22).
Il paziente affetto da edema polmonare acuto non sta disteso ma seduto sul letto,
fortemente agitato, madido di sudore, dispnoico e tachipnoico, con respiro rumoroso e
gorgogliante; la sua cute è fredda e sudata, e può essere presente cianosi alle labbra
e alle estremità. Al torace si ascoltano alle basi polmonari rantoli crepitanti, che con
l’aumentare della quantità di liquido trasudato arrivano ad interessare tutto l’ambito
polmonare, come una “marea montante”, accompagnati da escreato schiumoso ed
eventualmente rosato. Se non si interviene con un trattamento tempestivo, l’edema
polmonare tende a peggiorare progressivamente sino all’arresto del respiro, oppure
evolve verso lo shock (shock cardiogeno) e l’arresto di circolo, con esito fatale.
L’esame fisico del paziente con insufficienza cardiaca acuta permette di rilevare segni
a carico dell’apparato cardiovascolare, dell’apparato respiratorio, del fegato e
dell’addome, della cute, dei reni.
La pressione arteriosa può essere elevata, soprattutto la diastolica, per effetto della
vasocostrizione arteriolare. Quando però la gittata sistolica è diminuita, anche i valori
tensivi sistemici si riducono, sino a raggiungere valori minimi nello shock cardiogeno.
La pressione venosa centrale è solitamente elevata: si può valutare osservando il grado
di turgore delle vene giugulari con il paziente in posizione semiseduta (a 45°).
La cute può apparire pallida, umida di sudore e fredda per la costrizione dei vasi
cutanei come meccanismo compensatorio dell’ipoperfusione periferica; nei casi più
gravi può comparire cianosi.
I segni di ipoperfusione renale sono rappresentati dall’oliguria (meno di 500-600 ml
nelle 24 ore) unitamente all’aumento dell’azotemia e della creatininemia. Quando la
gittata cardiaca è gravemente ridotta, si può arrivare fino all’anuria (< 100 ml nelle 24
ore).
L’edema periferico può essere presente soprattutto nei casi di peggioramento di una
condizione cronica; esso è dovuto all’aumento di pressione venosa sistemica, ma anche
e soprattutto alla ritenzione idrosalina.
L’esame obiettivo cardiaco può mostrare i segni della cardiopatia che sta alla base
dello scompenso. La frequenza cardiaca è solitamente elevata (per effetto
dell’ipertono simpatico) e all’ascoltazione è spesso presente un ritmo di galoppo,
dovuto alla presenza di un III tono cardiaco, meno spesso di un IV tono (vedi Capitolo
2). Altro segno ascoltatorio cardiaco nello scompenso può essere un soffio olosistolico
puntale da insufficienza mitralica acuta. All’esame del torace, quando l’aumento della
pressione nelle vene e nei capillari polmonari provoca trasudazione di liquido nel
tessuto interstiziale polmonare, si possono ascoltare rumori umidi (rantoli crepitanti) .
Il reperto obiettivo toracico coinvolge dapprima i campi polmonari basali,
diffondendosi progressivamente ai campi superiori in seguito all’aggravarsi della
condizione clinica ed in assenza di adeguato trattamento.
Sfruttando i segni e i sintomi dei quadri clinici dell’insufficienza cardiaca acuta è
stata formulata la classificazione di Killip, che suddivide i pazienti in quattro classi in
base alla presenza di segni di congestione polmonare e periferica, segni di bassa
portata, e segni di aumentato volume telediastolico ventricolare. La classe I è
caratterizzata dall’assenza di segni clinici di insufficienza cardiaca. I criteri
diagnostici per la II classe includono il riscontro di rantoli nella metà inferiore dei
campi polmonari, terzo tono e ipertensione venosa polmonare. La classe III include
pazienti con insufficienza cardiaca severa (rantoli estesi a tutti i campi polmonari o
edema polmonare franco). La classe IV include i pazienti in shock cardiogeno, con
pressione arteriosa sistolica = 90 mmHg, vasocostrizione periferica, oliguria e cianosi.
Un’altra classificazione, basata sulla temperatura corporea (cute calda o fredda) e sul
reperto ascoltatorio toracico (il paziente viene definito “umido” o “secco” a seconda
che presenti rantoli o no), distingue quattro gruppi di crescente gravità clinica: il
gruppo A comprende pazienti “caldi e secchi”, il gruppo B pazienti “caldi e umidi”, il
gruppo L pazienti “freddi e secchi” e il gruppo C pazienti “freddi e umidi” (Figura 3).
Lo shock cardiogeno può essere il quadro di esordio, soprattutto in caso di infarto
miocardico, oppure la fase terminale di un’insufficienza cardiaca in rapido
peggioramento: si manifesta quando la portata cardiaca scende al di sotto dei valori
minimi necessari a mantenere la funzione degli organi vitali (vedi Capitolo 22).
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
Tra le indagini di laboratorio, durante un episodio di insufficienza cardiaca acuta,
bisognerà sempre eseguire, oltre agli esami di routine, la ricerca degli indici di necrosi
miocardica. Può essere, inoltre, dosato il peptide natriuretico di tipo B (Brain
Natriuretic Peptide-BNP, che viene rilasciato dai ventricoli in risposta allo stiramento
delle pareti e al sovraccarico di fluidi, ed è stato utilizzato per escludere o
identificare la presenza di scompenso cardiaco congestizio.
Di notevole importanza è l’emogasanalisi, che rivela dati sugli scambi gassosi e sullo
stato metabolico del paziente.
La radiografia del torace fornisce informazioni sia sulle dimensioni e la morfologia
cardiaca, ma soprattutto sulla distribuzione del flusso polmonare.
L’elettrocardiogramma può essere normale, ma spesso mostra aritmie o alterazioni
dipendenti dalla cardiopatia di base.
L’esame principe nell’inquadramento del paziente con insufficienza cardiaca acuta
è l’ecocardiogramma, che valuta le dimensioni e i volumi delle cavità cardiache, gli
spessori parietali, la cinesi globale e segmentale, la frazione di eiezione e la
contrattilità. Si può analizzare la morfologia e la funzione degli apparati valvolari e di
altre strutture quali il pericardio, il tratto prossimale dell’aorta e la vena cava
inferiore. Inoltre si può esaminare la funzione diastolica, impiegando la registrazione
con il Doppler pulsato del flusso trans mitralico.
PRINCIPI DI TERAPIA
Gli obiettivi del trattamento a breve termine dei pazienti con insufficienza cardiaca
acuta sono migliorare i sintomi e l’emodinamica, preservando la funzione renale e
proteggendo il tessuto miocardico. La terapia dell’ insufficienza cardiaca acuta si
prefigge, quindi, diverse finalità: ridurre la congestione, ridurre il postcarico,
migliorare l’assetto neurormonale, migliorare la funzione cardiaca (Figura 5).
I diuretici sono farmaci che aumentano l’eliminazione di sodio e acqua e perciò
riducono la massa liquida circolante e il volume di liquido interstiziale. I diuretici più
usati sono quelli dell’ansa ad azione rapida, (furosemide e torasemide), spesso in
associazione con i risparmiatori di potassio.
Tra i farmaci che riducono il precarico vi sono i vasodilatatori venosi, che
ridistribuendo il volume ematico aumentano la capacità del distretto venoso, e
sequestrano in questa sede parte della massa circolante, riducendo il riempimento
cardiaco. I vasodilatatori venosi più importanti sono la nitroglicerina e il
nitroprussiato, che ha un effetto anche sul versante arterioso.
Gli ACE-inibitori sono farmaci che oltre a ridurre il precarico, favorendo anche una
minor ritenzione di acqua e sali, migliorano l’assetto neuro-ormonale. Sono poco usati
nello scompenso acuto. Al contrario, i farmaci che stimolano l’inotropismo, soprattutto
dopamina, dobutamina e glicosidi digitatici, possono essere di grande aiuto nella fase
acuta.
Le due amine simpaticomimetiche, dopamina e dobutamina, agiscono soprattutto sui
recettori beta-adrenergici, migliorando la contrattilità miocardica. La dopamina,
precursore naturale della noradrenalina, è utile nel trattamento degli stati ipotensivi;
a dosaggi molto bassi induce vasodilatazione dei vasi renali e mesenterici, per
stimolazione dei recettori dopaminergici, aumentando così la diuresi e l’escrezione di
sodio. A dosaggi più elevati la dopamina stimola i recettori ß1 miocardici, provocando
una modesta tachicardia riflessa, mentre a dosaggi elevati stimola anche i recettori aadrenergici, innalzando i valori tensivi sistemici. La dobutamina agendo sui recettori
ß1, ß2 e a, possiede un potente effetto inotropo, abbassa le resistenze periferiche e
determina un aumento di gittata cardiaca.
I glicosidi digitalici agiscono bloccando la pompa sodio/potassio ATP-dipendente delle
fibre miocardiche, con l’effetto ultimo di aumentare la disponibilità di calcio
intracellulare per la contrazione. Oltre a ciò, riducono la frequenza cardiaca e
rallentano la conduzione atrioventricolare (soprattutto per aumento del tono vagale),
per cui sono utili in presenza di tachiaritmie sopraventricolari, soprattutto in corso di
fibrillazione atriale.
Recenti prospettive farmacologiche sono rappresentate dai nuovi inotropi come
il levosimendan, che agisce tramite un duplice meccanismo di azione: aumenta la
sensibilità delle miofibrille al calcio, tramite il legame con la troponina C,
determinando quindi un effetto inotropo positivo senza aumentare il consumo
miocardio di ossigeno, e attiva i canali vascolari del potassio ATP-dipendenti,
provocando una vasodilatazione periferica.
SCOMPENSO CARDIACO CRONICO
QUADRI CLINICI
Sono state proposte numerose classificazioni dello scompenso cardiaco. Pur peccando
di un’eccessiva semplificazione e, spesso, di scarsa aderenza alla realtà, queste
mantengono un loro valore soprattutto didattico.
La distinzione più importante è quella tra scompenso cardiaco acuto e cronico. (vedi
capitolo 20). Nell’ambito dello scompenso cardiaco cronico, mantengono un loro valore
le distinzioni tra scompenso anterogrado e retrogrado, sinistro e destro, sistolico e
diastolico.
Secondo la teoria anterograda dello scompenso, l’origine dei sintomi e segni è da
ricercarsi nell’inadeguata portata cardiaca con insufficiente perfusione dei tessuti
periferici. Viceversa, secondo la teoria retrograda, la causa dei sintomi e segni è da
ricercarsi nell’incompleto svuotamento dei ventricoli. Questo causa un aumento della
pressione intraventricolare che si ripercuote a monte sulle pressioni atriale, dei vasi
venosi tributari ed, infine, intracapillari. L’aumento della pressione intracapillare causa
trasudazione di liquido ed edema interstiziale e, nel caso del circolo polmonare, edema
alveolare.
La distinzione tra scompenso cardiaco sinistro e destro è un’estensione della
precedente teoria retrograda. Nello scompenso sinistro predominano i sintomi da
accumulo di fluidi a monte del ventricolo sinistro con congestione ed edema polmonare.
Nello scompenso destro si ha, invece, congestione venosa sistemica ed epatica.
La distinzione tra scompenso cardiaco sistolico e diastolico è essenzialmente basata
sul riscontro o meno di bassi valori di frazione d’eiezione (<50%) in pazienti con
sintomi di scompenso cardiaco. Tuttavia, anche nei pazienti con frazione d’eiezione
normale sono presenti alterazioni di altri indici di funzione sistolica ventricolare
sinistra e, viceversa, alterazioni della funzione diastolica sono costantemente presenti
anche nei pazienti con bassa frazione d’eiezione. Per queste ragioni, si preferisce
usare il termine di scompenso cardiaco con normale frazione d’eiezione piuttosto che
quello di scompenso diastolico. I pazienti con normale frazione d’eiezione possono
corrispondere a più del 50% dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco e la loro
prognosi è sovrapponibile, o solo leggermente migliore, rispetto a quella dei pazienti
con bassa frazione d’eiezione. I pazienti con normale frazione d’eiezione sono più
spesso anziani, di sesso femminile ed affetti da ipertensione arteriosa.
SINTOMI
Dispnea. La dispnea rappresenta, insieme all’astenia, il sintomo più suggestivo di
scompenso cardiaco. Nelle fase iniziali della malattia compare prevalentemente
durante sforzi fisici, successivamente si presenta anche a riposo con le
caratteristiche dell’ortopnea, della dispnea parossistica notturna e dell’edema
polmonare acuto (vedi Capitolo 1).
La dispnea viene descritta come una spiacevole sensazione di difficoltà nel respirare.
Viene comunemente avvertita da qualsiasi persona in occasione di uno sforzo fisico
intenso. Nel paziente con scompenso cardiaco vi è una riduzione del grado di attività
associata con questo disturbo. Tanto maggiore è la severità dello scompenso cardiaco,
tanto minore è l’entità dello sforzo che causa la dispnea. Su questo è basata la
classificazione della New York Heart Associaton.
La dispnea del paziente con scompenso cardiaco viene tradizionalmente attribuita
all’aumento delle pressioni capillari polmonari con edema interstiziale ed alveolare. In
realtà la correlazione con la compromissione della funzione ventricolare sinistra,
soprattutto a riposo, è scarsa o nulla. Meccanismi che contribuiscono a causare
dispnea nei pazienti con scompenso cardiaco sono l’insufficiente incremento della
portata cardiaca sotto sforzo con ipoperfusione dei muscoli scheletrici, che eseguono
lo sforzo, ed ipoperfusione dei muscoli respiratori, decondizionamento della
muscolatura scheletrica, ridotta compliance polmonare, aumento della resistenza delle
vie aeree, eccessiva risposta ventilatoria allo sforzo.
Ortopnea. L’ortopnea viene definita come la comparsa di dispnea in posizione supina
con sua regressione sollevando la testa, in posizione seduta. Compare rapidamente,
entro pochi minuti dall’assunzione della posizione supina. E’ dovuta alla ridistribuzione
del volume ematico, con aumento del ritorno venoso e del precarico e congestione
polmonare.
Dispnea parossistica notturna. Differentemente dall’ortopnea, essa compare durante
il sonno, causando il risveglio del paziente con una sensazione di soffocamento e fame
d’aria. Questi sintomi spesso si riducono con la posizione seduta, spesso sul bordo del
letto. Obiettivamente, sono spesso presenti fischi espiratori da broncospasmo per
edema della mucosa bronchiale e compressione dei bronchioli per edema interstiziale.
Astenia e affaticabilità. Astenia e facile affaticabilità sono secondari all’insufficiente
incremento della portata cardiaca sotto sforzo. La ridotta risposta vasodilatatrice
periferica, le alterazioni biochimiche ed istologiche e l’ipotrofia della muscolatura
scheletrica sono altri meccanismi patogenetici. L’importanza relativa dei meccanismi
muscolari scheletrici, “periferici”, rispetto al meccanismo “centrale”, la riduzione della
portata cardiaca, varia da paziente a paziente.
Così come anche la dispnea, astenia ed affaticabilità sono sintomi non specifici, che
possono essere causati da numerose malattie non cardiovascolari.
Nicturia ed oliguria. La nicturia (eliminazione di urina prevalentemente nelle ore
notturne), è dovuta all’aumento di perfusione renale durante la notte, col decubito
supino. L’oliguria è un sintomo delle fasi avanzate dello scompenso cardiaco,
secondario ad ipoperfusione renale.
Sintomi gastroenterici. L’aumento della pressione venosa sistemica, presente
soprattutto quando vi è disfunzione ventricolare destra, determina epatomegalia con
conseguente distensione della capsula epatica e dolenzia all’ipocondrio destro, talvolta
descritta come tensione addominale e senso di pienezza dopo i pasti. Questi pazienti
possono avere anche anoressia, difficoltà digestive e nausea.
Sintomi cerebrali. L’ipoperfusione cerebrale cronica secondaria alla bassa portata
cardiaca può causare vertigini, cefalea, sonnolenza, insonnia o altri sintomi cerebrali.
Questi sono più frequenti nei pazienti anziani con coesistente aterosclerosi cerebrale.
SEGNI CLINICI
La maggior parte dei segni clinici sono conseguenza della ritenzione idrico-salina.
Alcuni di essi (stasi giugulare, ritmo di galoppo) hanno un importante valore
prognostico.
Aspetto generale. E’ normale nella maggior parte dei pazienti con scompenso cardiaco
cronico;. nelle fasi più avanzate di scompenso, tuttavia, il paziente potrà essere
dispnoico a riposo e presentare ortopnea e segni di attivazione adrenergica come cute
pallida, fredda, sudata e cianotica.
Obiettività cardiaca. Il reperto di un terzo tono (galoppo proto diastolico)
all’auscultazione è indicativo di un aumento della pressione atriale sinistra con brusca
decelerazione del sangue all’interno del ventricolo sinistro immediatamente dopo la
fase di riempimento rapido (vedi Capitolo 2). E’ molto raramente udibile in soggetti
normali adulti. Un soffio olosistolico da insufficienza mitralica e/o da insufficienza
tricuspidale è spesso udibile. In caso d’ipertensione polmonare si può anche
evidenziare un’accentuazione della componente polmonare del 2° tono.
Polsi periferici. La pressione arteriosa sistolica e l’ampiezza dei polsi periferici,
espressione della pressione differenziale, tendono ad essere ridotte nei pazienti con
scompenso cardiaco severo e bassa portata cardiaca.
Stasi polmonare. L’edema alveolare causa la comparsa di rantoli a piccole bolle,
crepitanti. Questi si evidenziano generalmente alle basi di entrambe i polmoni oppure,
inizialmente, soltanto alla base destra. Nei casi di maggiore gravità tendono ad
estendersi verso gli apici fino ai reperti dell’edema polmonare.
Versamento pleurico. Anche questo si evidenzia ad entrambe le basi o, nei casi meno
gravi, solo alla base destra. Dato che le vene pleuriche drenano sia nelle vene
polmonari che in quelle sistemiche, la sua comparsa è frequente soprattutto nei casi
d’ipertensione di entrambe questi distretti venosi.
Stasi giugulare. L’ispezione del polso venoso giugulare è il migliore metodo non
strumentale per valutare la presenza di ipertensione venosa sistemica. L’ispezione va
eseguita dal lato destro del collo in quanto qui vena giugulare interna ed anonima si
continuano, in modo pressoché rettilineo, nella vena cava superiore, favorendo la
trasmissione delle onde sfigmiche originate dall’atrio destro. Per esaminare il polso
giugulare, la testa del paziente deve essere adagiata su un cuscino ed il tronco
inclinato di 45° (vedi Capitolo 2).
Il reflusso epato-giugulare (distensione delle vene del collo dopo compressione per
almeno un minuto in ipocondrio destro) è segno di congestione epatica con, nello stesso
tempo, incapacità del ventricolo destro a ricevere ed eiettare l’ aumentato ritorno
venoso.
Epatomegalia. E’ dovuta a congestione venosa epatica ed è apprezzabile alla palpazione
e percussione dell’ipocondrio destro.
Ascite. È un segno tardivo di grave ipertensione venosa sistemica, dovuto ad un
aumento della pressione nelle vene epatiche ed in quelle drenanti il peritoneo con
possibile associato aumento della permeabilità dei capillari peritoneali.
Edema. Gli edemi compaiono piuttosto tardivamente. Per avere la loro comparsa, si
deve verificare l’accumulo di almeno 4 litri di volume extracellulare in eccesso. Gli
edemi dello scompenso cardiaco sono simmetrici e si manifestano nelle parti declivi del
corpo dove maggiore è la pressione idrostatica nei vasi venosi (piedi, caviglie, zona
pre-tibiale). Inizialmente, compaiono soprattutto alla sera, dopo che il paziente è
rimasto in piedi durante il giorno, e regrediscono con il riposo notturno. Nei pazienti
costretti a letto compaiono a livello sacrale. Nelle fasi avanzate l’edema tende a
generalizzarsi (anasarca).
Cachessia cardiaca. Compare nelle fasi avanzate di scompenso ed è associata con una
prognosi severa. La genesi di tale fenomeno è multifattoriale: congestione epatica ed
intestinale con malassorbimento intestinale per grassi e proteine; aumentato
metabolismo basale per maggiore lavoro respiratorio, aumento del consumo miocardico
di ossigeno; elevate concentrazioni plasmatiche di citochine.
SEGNI CLINICI
La maggior parte dei segni clinici sono conseguenza della ritenzione idrico-salina.
Alcuni di essi (stasi giugulare, ritmo di galoppo) hanno un importante valore
prognostico.
Aspetto generale. E’ normale nella maggior parte dei pazienti con scompenso cardiaco
cronico;. nelle fasi più avanzate di scompenso, tuttavia, il paziente potrà essere
dispnoico a riposo e presentare ortopnea e segni di attivazione adrenergica come cute
pallida, fredda, sudata e cianotica.
Obiettività cardiaca. Il reperto di un terzo tono (galoppo proto diastolico)
all’auscultazione è indicativo di un aumento della pressione atriale sinistra con brusca
decelerazione del sangue all’interno del ventricolo sinistro immediatamente dopo la
fase di riempimento rapido . E’ molto raramente udibile in soggetti normali adulti. Un
soffio olosistolico da insufficienza mitralica e/o da insufficienza tricuspidale è spesso
udibile. In caso d’ipertensione polmonare si può anche evidenziare un’accentuazione
della componente polmonare del 2° tono.
Polsi periferici. La pressione arteriosa sistolica e l’ampiezza dei polsi periferici,
espressione della pressione differenziale, tendono ad essere ridotte nei pazienti con
scompenso cardiaco severo e bassa portata cardiaca.
Stasi polmonare. L’edema alveolare causa la comparsa di rantoli a piccole bolle,
crepitanti. Questi si evidenziano generalmente alle basi di entrambe i polmoni oppure,
inizialmente, soltanto alla base destra. Nei casi di maggiore gravità tendono ad
estendersi verso gli apici fino ai reperti dell’edema polmonare.
Versamento pleurico. Anche questo si evidenzia ad entrambe le basi o, nei casi meno
gravi, solo alla base destra. Dato che le vene pleuriche drenano sia nelle vene
polmonari che in quelle sistemiche, la sua comparsa è frequente soprattutto nei casi
d’ipertensione di entrambe questi distretti venosi.
Stasi giugulare. L’ispezione del polso venoso giugulare è il migliore metodo non
strumentale per valutare la presenza di ipertensione venosa sistemica. L’ispezione va
eseguita dal lato destro del collo in quanto qui vena giugulare interna ed anonima si
continuano, in modo pressoché rettilineo, nella vena cava superiore, favorendo la
trasmissione delle onde sfigmiche originate dall’atrio destro. Per esaminare il polso
giugulare, la testa del paziente deve essere adagiata su un cuscino ed il tronco
inclinato di 45° .
Il reflusso epato-giugulare (distensione delle vene del collo dopo compressione per
almeno un minuto in ipocondrio destro) è segno di congestione epatica con, nello stesso
tempo, incapacità del ventricolo destro a ricevere ed eiettare l’ aumentato ritorno
venoso.
Epatomegalia. E’ dovuta a congestione venosa epatica ed è apprezzabile alla palpazione
e percussione dell’ipocondrio destro.
Ascite. È un segno tardivo di grave ipertensione venosa sistemica, dovuto ad un
aumento della pressione nelle vene epatiche ed in quelle drenanti il peritoneo con
possibile associato aumento della permeabilità dei capillari peritoneali.
Edema. Gli edemi compaiono piuttosto tardivamente. Per avere la loro comparsa, si
deve verificare l’accumulo di almeno 4 litri di volume extracellulare in eccesso. Gli
edemi dello scompenso cardiaco sono simmetrici e si manifestano nelle parti declivi del
corpo dove maggiore è la pressione idrostatica nei vasi venosi (piedi, caviglie, zona
pre-tibiale). Inizialmente, compaiono soprattutto alla sera, dopo che il paziente è
rimasto in piedi durante il giorno, e regrediscono con il riposo notturno. Nei pazienti
costretti a letto compaiono a livello sacrale. Nelle fasi avanzate l’edema tende a
generalizzarsi (anasarca).
Cachessia cardiaca. Compare nelle fasi avanzate di scompenso ed è associata con una
prognosi severa. La genesi di tale fenomeno è multifattoriale: congestione epatica ed
intestinale con malassorbimento intestinale per grassi e proteine; aumentato
metabolismo basale per maggiore lavoro respiratorio, aumento del consumo miocardico
di ossigeno; elevate concentrazioni plasmatiche di citochine.
ESAMI STRUMENTALI
Elettrocardiogramma. Un ECG normale non è frequente in un paziente con scompenso
cardiaco cronico, ma non esiste alcun quadro elettrocardiografico che indichi, di per
sé, la presenza di scompenso; tuttavia un QRS con durata >120 ms, specialmente
associato a un blocco di branca sinistra, suggerisce la probabilità di una disfunzione
ventricolare .
Radiografia del torace. La radiografia del torace è utile nell’evidenziare
cardiomegalia, congestione polmonare ed eventuali patologie polmonari associate.
Esami di laboratorio. La valutazione di routine include: emocromo, elettroliti sierici,
creatininemia, glicemia, enzimi epatici ed esame delle urine. La funzione tiroidea può
essere valutata se indicata in base ai reperti clinici.
Gli esami ematochimici hanno un importante significato prognostico. L’anemia è
presente in un 20-30% dei pazienti,. ed è più frequente nei pazienti con scompenso
cardiaco più grave . La sua patogenesi è multifattoriale: insufficienza renale, terapia
con ACE inibitori, attivazione infiammatoria cronica, etc.
L’iposodiemia è dovuta a dliluizione con ritenzione idrica maggiore di quella salina. E’
almeno parzialmente dovuta ad aumentata secrezione di vasopressina. L’ipokaliemia
può verificarsi come conseguenza della terapia con diuretici dell’ansa o tiazidici, oltre
che per aumentata secrezione di aldosterone. Va corretta in quanto possibile causa di
aritmie, anche fatali. L’iperkaliemia può svilupparsi per insufficienza renale e/o
terapia con antagonisti del sistema renina-angiotensina-aldosterone.
L’insufficienza renale con aumento della creatininemia ed azotemia è secondaria ad
ipoperfusione renale. Può essere favorita dalla terapia medica (diuretici,
antiinfiammatori non steroidei, aspirina, antagonisti del sistema renina-angiotensinaaldosterone).
Le concentrazioni plasmatiche di BNP e di NT-proBNP sono utili nella diagnosi di
scompenso cardiaco. Concentrazioni normali di peptici natriuretici in un paziente non
trattato rendono la diagnosi di scompenso poco probabile. Oltre allo scompenso
cardiaco, altre condizioni cliniche, come l’ipertrofia ventricolare sinistra, l’ischemia
miocardica, l’ipertensione e l’embolia polmonare possono causare un rialzo dei livelli
plasmatici di peptici natriuretici.
Ecocardiografia Doppler. E’ la procedura diagnostica di prima scelta per documentare
una disfunzione cardiaca. Il parametro più importante di funzione ventricolare è la
frazione d’eiezione ventricolare sinistra, misurata dal rapporto fra la gittata sistolica
e il volume telediastolico. In pratica, si sottrae dal volume telediastolico il volume
telesistolico, ottenendo la gittata sistolica, e si divide questa per il volume
telediastolico. La frazione di eiezione viene utilizzata per discriminare i pazienti con
disfunzione ventricolare sinistra sistolica da quelli con conservata funzione sistolica.
L’aumento dei volumi telesistolico e telediastolico ventricolare sinistro è un’altra
caratteristica dei pazienti con scompenso cardiaco dovuto a disfunzione ventricolare
sistolica.
La misurazione combinata del flusso trans-mitralico e della velocità di spostamento
dell’anulus mitralico mediante Eco-Doppler tessutale cardiaco permette una
valutazione della severità della disfunzione diastolica ventricolare sinistra. Più spesso,
la funzione diastolica è valutata mediante lo studio del solo flusso trans mitralico. I
tre quadri di riempimento mitralico, alterato rilasciamento, pseudo-normale e
restrittivo, corrispondono rispettivamente, ad una disfunzione diastolica di grado
lieve, moderato e grave .
Oltre allo studio della funzione ventricolare, l’eco-Doppler permette anche di
evidenziare un’eventuale insufficienza mitralica e/o tricuspidale, frequentemente
presenti in questi pazienti, o anche altre alterazioni (es. una stenosi aortica) che
possono avere causato lo scompenso cardiaco.
Risonanza magnetica (RM) cardiaca. E’ una tecnica estremamente accurata e
riproducibile per la valutazione dei volumi ventricolari destro e sinistro, della funzione
ventricolare sinistra globale e regionale, dello spessore miocardico, della rigidità di
parete, della massa miocardica e delle valvole cardiache (vedi Capitolo 7).. E’ limitata
dalla sua attuale non applicabilità ai portatori di pacemaker o di defibrillatore
automatico.
Prove di funzionalità respiratoria. La spirometria è utile nell’escludere cause polmonari
della dispnea e nel valutare la gravità di una patologia polmonare concomitante.
Coronarografia. E’ indicata nei pazienti con concomitante angina, o, comunque, segni
d’ischemia miocardica.
Test da sforzo cardiopolmonare. E’ utile per quantificare la severità della malattia e
nella valutazione prognostica.
PRINCIPI DI TERAPIA
Obiettivi. La terapia si propone di migliorare i sintomi e la qualità di vita e/o di
migliorare la prognosi (riduzione della mortalità e delle ospedalizzazioni). Un altro
fondamentale obiettivo è la prevenzione della disfunzione cardiaca nei pazienti a
rischio (esiti d’infarto, ipertensione arteriosa, valvulopatie, diabete, etc) e la
prevenzione dello scompenso cardiaco conclamato (comparsa dei sintomi) nei pazienti
con disfunzione cardiaca.
Il trattamento dello scompenso cardiaco cronico si basa su farmaci da somministrarsi
per migliorare la prognosi e farmaci volti al miglioramento dei sintomi. Alla prima
categoria appartengono gli inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone ed i
beta-bloccanti, alla seconda i diuretici e la digitale.
ACE inibitori. Gli ACE inibitori sono raccomandati come terapia di prima scelta nei
pazienti con disfunzione ventricolare sinistra sistolica, con o senza sintomi.
L’indicazione a questi farmaci è basata su ampi studi controllati con placebo che hanno
dimostrato un miglioramento della sopravvivenza, sintomi, capacità funzionale ed una
riduzione delle ospedalizzazioni nei pazienti trattati con questi farmaci. I loro effetti
favorevoli sembrano essere principalmente ascrivibili al rallentamento, se non
inibizione, dei fenomeni di rimodellamento ventricolare sinistro ed, in minore misura,
alla prevenzione di nuovi eventi ischemici e delle aritmie.
Beta-bloccanti. In assenza di controindicazioni, i beta-bloccanti devono essere
somministrati a tutti i pazienti con scompenso cardiaco cronico, in condizioni di
stabilità clinica. La loro efficacia è stata dimostrata in pazienti con scompenso
cardiaco di grado lieve, moderato e severo (classe NYHA dalla II alla IV), dovuta a
cardiopatia ischemica o non-ischemica e con ridotta frazione d’eiezione ventricolare
sinistra, già in trattamento con diuretici e ACE inibitori, nonché in pazienti con
disfunzione ventricolare sinistra postinfartuale, con o senza sintomi di scompenso. In
questi pazienti, gli studi clinici controllati hanno dimostrato una riduzione della
mortalità, ospedalizzazioni ed episodi di peggioramento dello scompenso cardiaco ed
un miglioramento della classe funzionale con la terapia beta-bloccante, rispetto al
placebo.
Antialdosteronici. Gli antagonisti dell’aldosterone sono raccomandati, in aggiunta
all’ACE-inibitore, al beta-bloccante e al diuretico, nello scompenso cardiaco avanzato
(NYHA III-IV) per migliorare la sopravvivenza, morbilità e classe funzionale.
Bloccanti dei recettori dell’Angiotensina II. I bloccanti dei recettori dell’Angiotensina
II hanno effetti simili o equivalenti agli ACE inibitori sulla mortalità e sulla morbilità
dei pazienti con scompenso cardiaco cronico e dei pazienti con recente infarto.
Possono essere quindi usati in alternativa agli ACE inibitori nei casi di intolleranza a
questi (tosse, edema angioneurotico). Hanno avuto anche effetti favorevoli sulle
ospedalizzazioni e sulla mortalità in associazione agli ACE inibitori in pazienti ancora
sintomatici per scompenso.
Diuretici. I diuretici sono essenziali per il trattamento sintomatico dello scompenso
cardiaco in presenza di ritenzione idrica con congestione polmonare e/o congestione
venosa giugulare e/o edemi declivi. Eccetto che nelle forme di scompenso cardiaco
lieve, in cui si possono impiegare anche i tiazidici, vanno preferiti i diuretici dell’ansa
(furosemide, torasemide, bumetanide). Vanno somministrati alle dosi minime
necessarie per mantenere il paziente libero da segni di ritenzione idrico-salina. La loro
somministrazione favorisce l’attivazione dei sistemi renina-angiotensina-aldosterone e
simpatoadrenergico, il peggioramento della funzione renale ed alterazioni
elettrolitiche (ipokaliemia), tutti effetti potenzialmente dannosi per il paziente con
scompenso cardiaco.
I diuretici risparmiatori di potassio (amiloride, triamterene, spironolattone) possono
essere associati agli altri diuretici per il trattamento dell’ipokaliemia. Lo
spironolattone ha altri effetti favorevoli indipendenti da quello diuretico (vedi sopra).
Glucosidi digitalici. Sono indicati nei pazienti con fibrillazione atriale e scompenso
cardiaco sintomatico. Nei pazienti in ritmo sinusale la digossina non ha effetti sulla
mortalità ma riduce le ospedalizzazioni, in particolare quelle per scompenso cardiaco.
Altri farmaci. Altri farmaci frequentemente impiegati nei pazienti con scompenso
cardiaco sono i nitrati, per il trattamento dell’ischemia miocardica e migliorare i
sintomi, gli anticoagulanti, specialmente nei pazienti con concomitante fibrillazione
atriale o precedenti episodi embolici, gli antiaggreganti piastrinici, nei casi con
cardiopatia ischemica, l’amiodarone, per il trattamento o profilassi delle tachiaritmie.
L’impianto del defibrillatore automatico e
la terapia di resincronizzazione ventricolare con pacemaker biventricolare sono
indicati in pazienti selezionati.
LO SHOCK CARDIOGENO
DEFINIZIONE
Lo shock cardiogeno è una condizione di ipotensione arteriosa e inadeguata perfusione
tissutale con ipossia causata da disfunzione cardiaca, più frequentemente di natura is
chemica, in presenza di un adeguato volume intravascolare. Questa situazione di
ipossia tissutale va distinta in una forma transitoria, cui consegue il rapido ripristino
di normali valori di pressione sistemica, chiamata collasso cardiocircolatorio, e una
forma che si protrae a lungo, con danni ipossici più marcati, che rappresenta
lo shock cardiogeno vero e proprio.
I criteri diagnostici per lo shock cardiogeno comprendono:
pressione sistolica inferiore a 80 mm Hg per almeno 30 minuti, non incrementata dalla
somministrazione di liquidi endovena;
segni di ipoperfusione (estremità fredde), alterato stato di coscienza, agitazione psico-motoria;
diuresi oraria inferiore a 20 ml;
indice cardiaco inferiore a 1,8 l/min/m2;
pressioni di riempimento ventricolare sinistro elevate (pressione capillare polmonare > 18 mm
Hg).
EPIDEMIOLOGIA
Lo shock cardiogeno rappresenta la causa più comune di morte per causa
cardiovascolare dopo l’infarto miocardico.
L’incidenza di shock cardiogeno negli anni precedenti la diffusione delle metodiche di
rivascolarizzazione (farmacologica e meccanica) era pari al 20% di tutti gli infarti
miocardici acuti con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI). Dalle più recenti
casistiche si stima che lo shock si verifichi oggi nel 7% dei pazienti con STEMI e nel
3% dei pazienti con infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST
(NSTEMI).
Quando lo shock cardiogeno non è secondario ad un fattore modificabile (per esempio
aritmie, bradicardia, alterazioni meccaniche) la mortalità a breve termine è dell’80%.
EZIOLOGIA
Lo shock cardiogeno può essere dovuto alle seguenti condizioni:
deficit di eiezione ventricolare: un deficit acuto della funzione ventricolare sistolica può
derivare dalla compromissione grave di una grande parte della massa miocardica. Tra le cause
principali di questa situazione va menzionato innanzitutto l’infarto esteso del miocardio;
tuttavia, anche infarti miocardici di piccole dimensioni, soprattutto quando si verificano in
pazienti con preesistente compromissione del ventricolo sinistro, possono evolvere in shock
cardiogeno. Un deficit di eiezione può essere, peraltro, sostenuto anche da aritmie ventricolari o
da insufficienze valvolari ad insorgenza acuta;
difetti di riempimento ventricolare: possono essere dovuti a:
cause estrinseche, quali tamponamento cardiaco, pericardite costrittiva;
cause intrinseche, quali trombi o mixomi atriali, embolia polmonare massiva, stenosi mitralica
serrata.
FISIOPATOLOGIA
La brusca riduzione della pressione sistolica al di sotto di 80 mm Hg induce la
stimolazione dei barocettori (i principali sono quelli del seno carotideo e del seno
aortico), determinando:
vasocostrizione delle arteriole e delle meta-arteriole attraverso una stimolazione del sistema
nervoso simpatico;
aumento della frequenza cardiaca attraverso l’inibizione del sistema nervoso parasimpatico.
La caduta della pressione sistemica induce:
aumento della stimolazione dei chemocettori (i principali sono situati nell’arco aortico e alla
biforcazione delle carotidi), determinando:
iperventilazione, per migliorare l’ossigenazione del sangue;
tachicardia riflessa (il riflesso tachicardizzante è di origine polmonare, prodotto
dall’iperventilazione);
aumento dei livelli di catecolamine circolanti, responsabili della vasocostrizione arteriosa e
venosa;
attivazione dell’asse renina-angiotensina-aldosterone, quale risposta renale all’ipoperfusione
sistemica, con conseguente ritenzione di sodio e di liquidi.
Tali risposte hanno come effetto l’aumento della pressione telediastolica e dei volumi
del ventricolo sinistro. Sebbene ciò compensi parzialmente la riduzione della funzione
ventricolare sinistra, un’elevata pressione telediastolica del ventricolo sinistro
determina edema polmonare, con alterazione degli scambi gassosi polmonari. La
conseguente acidosi respiratoria aumenta ulteriormente l’ischemia miocardica, la
disfunzione ventricolare sinistra e la trombosi intravascolare.
Se la causa che ha provocato il collasso cardiocircolatorio è reversibile e agisce per
breve tempo, la crisi può risolversi con il ripristino di normali valori di pressione
sistemica. Quando, invece, questa reazione compensatoria è insufficiente a far fronte
all’ipotensione, si innesca una spirale discendente che conduce, attraverso il
perpetuarsi di una condizione di ischemia miocardica, ad un progressivo peggioramento
della funzione cardiaca, fino alla morte.
In caso di shock cardiogeno secondario a infarto miocardico acuto, le porzioni di
miocardio non ischemiche diventano ipercontrattili ed aumentano il loro consumo di
ossigeno. Le conseguenze di questa risposta dipendono dall’estensione del danno e dal
precedente stato del miocardio, dalla gravità della patologia coronarica sottostante,
dalla presenza di altre patologie valvolari.
Si possono verificare tre condizioni:
compenso: ripristino della normale pressione arteriosa e normale pressione di perfusione
miocardica
compenso parziale: stato di pre-shock con portata cardiaca e pressione arteriosa moderatamente
ridotte e conseguente aumento della frequenza cardiaca ed elevata pressione telediastolica
ventricolare sinistra
shock: si sviluppa rapidamente e determina una marcata ipotensione e peggioramento
dell’ischemia miocardica globale. Senza un’immediata riperfusione, i pazienti in questa
condizione presentano una limitata possibilità di sopravvivenza.
SINTOMI E SEGNI CLINICI
A fronte di un elevato numero di segni clinici, lo shock cardiogeno può teoricamente
manifestarsi in assenza di sintomi avvertiti dal paziente; quando questi sono presenti,
si tratta per lo più dei sintomi di un infarto miocardico acuto (dolore toracico,
dispnea, cardiopalmo, nausea, vomito, astenia).
Il paziente in shock cardiogeno presenta solitamente alterazioni dello stato di
coscienza, come risultato della ridotta perfusione cerebrale; altri segni di
ipoperfusione d’organo conseguenti alla ridotta gittata cardiaca sono la contrazione
della diuresi, l’insufficienza epatica, la cianosi, la marezzatura delle estremità. Queste
alterazioni cliniche di shock conclamato non si manifestano abitualmente sino a che
l’indice cardiaco (cioè la gittata cardiaca rapportata alla superficie corporea) non
scende sotto il valore di 2,2 l/min/m2.
L’esame obiettivo mostra cute pallida ipotermica e sudata, distensione giugulare,
aumentata frequenza cardiaca. Il polso arterioso è iposfigmico, irregolare in presenza
di aritmie; un polso paradosso compare se la causa dello shock è il tamponamento
cardiaco. L’ascoltazione del torace rivela rantoli se è presente edema polmonare
alveolare.
L’obiettività cardiaca presenta spesso un ritmo di galoppo (terzo e/o quarto tono); se
lo shock cardiogeno deriva dalle complicanze meccaniche di un infarto miocardico,
possono essere udibili anche i soffi da insufficienza mitralica (vedi Capitolo 15) o da
difetto del setto interventricolare.
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
Per la diagnosi di shock cardiogeno è necessario confermare la presenza di
disfunzione cardiaca o di eventuali ostacoli meccanici al riempimento ventricolare (per
esempio tamponamento cardiaco, pericardite costrittiva, trombi o mixomi striali,
embolia polmonare massiva, stenosi mitralica serrata). E’ altresì importante escludere
altre potenziali cause di grave ipotensione come l’ipovolemia, l’emorragia e la sepsi.
L’iter diagnostico, partendo dall’anamnesi e dall’esame obiettivo del paziente, procede
considerando i seguenti esami diagnostici:
Elettrocardiogramma:
Può mostrare segni di infarto miocardico acuto o di precedenti cardiopatie, o mettere
in luce aritmie. Un ECG normale, tuttavia, non esclude la diagnosi di shock cardiogeno.
Radiografia del torace
E’ utile nel valutare le dimensioni cardiache, la presenza di congestione polmonare o di
altre eventuali patologie polmonari. Fornisce inoltre una stima approssimativa delle
dimensioni del mediastino e della radice aortica, utili per escludere una dissezione
dell’aorta.
Esami ematochimici
La determinazione dei marker di necrosi miocardica può essere fondamentale per
diagnosticare un infarto miocardico acuto quale causa di shock cardiogeno nei casi in
cui il tracciato elettrocardiografico non sia interpretabile. E’ anche utile misurare la
concentrazione dei gas ematici nel sangue arterioso (emogasanalisi arteriosa), dal
momento che la presenza di acidosi può avere effetti particolarmente dannosi sul
miocardio.
4. Ecocardiogramma
Permette di ottenere informazioni circa la funzione sistolica globale e segmentaria
dei ventricoli e consente di giungere rapidamente al riconoscimento delle cause
meccaniche di shock, quali rottura di un muscolo papillare con insufficienza mitralica
acuta, rottura acuta del setto interventricolare o della parete libera ventricolare con
tamponamento cardiaco, malfunzionamento di apparati valvolari protesici.
5. Monitoraggio invasivo e cateterismo cardiaco destro.
L’incannulamento di un’arteria permette il monitoraggio invasivo della pressione
arteriosa, mentre quello di una vena, incuneando un catetere (catetere di Swan-Ganz,
) a livello dei capillari polmonari, permette di ottenere parametri emodinamici
fondamentali per la diagnosi, quali la portata cardiaca e le pressioni di riempimento
ventricolare.
CENNI DI TERAPIA
Terapia farmacologica
Morfina: nell’infarto miocardico può alleviare l’intenso dolore toracico, contribuire a ridurre gli
elevati livelli di catecolamine circolanti e diminuire il precarico e il postcarico. La risposta deve
essere attentamente monitorata perché la morfina causa depressione respiratoria, provoca
dilatazione venosa e può ridurre la pressione arteriosa.
Agenti inotropi: se la pressione arteriosa sistemica è inferiore a 80-90 mm Hg, è necessario
infondere un agente pressorio come la dopamina. A dosi relativamente basse, 2-5 µg/kg per
minuto, il farmaco induce aumento della gittata sistolica e della gittata cardiaca, mediato dalla
stimolazione ß-adrenergica, e incremento del flusso renale mediato da recettori specifici
dopaminergici. Gli effetti vasocostrittori a-adrenergici si manifestano a dosi superiori ai 5 µg/kg
per minuto.
Se si rendono necessarie alte dosi di dopamina per mantenere una perfusione
adeguata, si deve prendere in considerazione il passaggio all’infusione di noradrenalina.
Questo farmaco è un potente costrittore arteriolare e venoso, la cui azione è mediata
attraverso una stimolazione a-adrenergica, mentre la stimolazione ß-adrenergica è
relativamente modesta.
Quando la pressione arteriosa sistemica è 90 mm Hg o superiore, il farmaco di scelta
è la dobutamina, che può produrre un aumento della pressione sistemica attraverso
l’incremento della gittata cardiaca.
Vasodilatatori: visto che questi farmaci riducono la pressione arteriosa, il loro impiego deve
essere associato a quello di un agente inotropo. Il farmaco principalmente utilizzato è il
nitroprussiato di sodio, il quale riduce sia il precarico che il postcarico del ventricolo sinistro.
Diuretici: il loro impiego è riservato ai casi di shock cardiogeno con edema polmonare acuto. I
diuretici più utilizzati sono quelli dell’ansa (per esempio, furosemide), associati ai risparmiatori
di potassio (per esempio, spironolattone).
Supporto meccanico
La stabilizzazione del paziente in shock cardiogeno può essere ottenuta mediante un supporto
circolatorio meccanico, cioè con l’impiego del contropulsatore aortico. Questo consiste in un
palloncino montato su un catetere vascolare e collegato tramite un tubo ad una consolle di
comando che è in grado di monitorizzare l’ECG e la curva di pressione arteriosa,
sincronizzando l’insufflazione e la desufflazione del palloncino con il ciclo cardiaco. Il catetere
viene inserito per via percutanea attraverso l’arteria femorale, e la sua punta è posizionata in
aorta discendente 1-2 centimetri sotto l’emergenza della arteria succlavia di sinistra e sopra
l’origine delle arterie renali.
Il gonfiaggio del pallone del contropulsatore avviene precocemente in diastole, determinando un
notevole aumento della pressione aortica diastolica fin quasi ai livelli della pressione aortica
sistolica, e aumentando di conseguenza il flusso sanguigno coronarico. Inoltre, lo sgonfiaggio
del pallone all’inizio della sistole riduce la pressione aortica, con conseguente diminuzione del
consumo di ossigeno da parte del miocardio e delle resistenze periferiche (postcarico). La
contropulsazione aortica è generalmente riservata ai pazienti in shock cardiogeno dovuto a una
condizione potenzialmente reversibile, o nei quali si prenda in considerazione il trapianto
cardiaco.
Tali condizioni comprendono l’infarto miocardico ancora in evoluzione e l’infarto
associato a una grave complicanza meccanica (insufficienza mitralica o difetto del
setto interventricolare).
In caso di shock cardiogeno secondario a infarto miocardico acuto, il ripristino del
flusso ematico coronarico è la terapia più efficace per salvare i pazienti che non
rispondono all’infusione di liquidi o al trattamento farmacologico. Le possibilità
comprendono l’angioplastica e il by-pass aorto-coronarico. Nei casi in cui, invece, lo
shock cardiogeno è causato da una complicanza meccanica dell’infarto miocardico, la
terapia chirurgica di riparazione della lesione e/o sostituzione valvolare è la sola
strada percorribile.
Fisiopatologia ischemia miocardica
Per svolgere la loro funzione contrattile, le cellule miocardiche necessitano di un
apporto continuo di ossigeno. Il loro metabolismo, infatti, è prettamente aerobico e
già di base comporta l’estrazione di circa il 70% dell’ossigeno dal sangue durante il suo
passaggio nel circolo coronarico. Ne deriva che un aumento significativo della richiesta
di ossigeno può essere soddisfatto solo da un adeguato incremento del flusso
coronarico.
Poiché la maggior parte dell’energia richiesta dalle cellule miocardiche è impiegata nel
processo di contrazione, la frequenza cardiaca (FC) costituisce il fattore principale
del consumo miocardico di ossigeno. Di fatto, un raddoppio della sola FC (ad esempio,
durante pacing atriale) comporta un raddoppio del consumo miocardico di ossigeno.
Altri fattori che influenzano in modo significativo il consumo miocardico di ossigeno
sono la pressione arteriosa (PA, postcarico), la pressione e il volume ventricolare in
diastole (precarico) e l’inotropismo cardiaco.
Durante esercizio, l’incremento della FC, della PA, dell’inotropismo cardiaco e del
ritorno venoso (precarico) contribuiscono tutti ad aumentare il consumo miocardico di
ossigeno, e quindi la richiesta di un aumento del flusso coronarico. Mentre la
misurazione precisa del consumo miocardico di ossigeno richiederebbe metodi invasivi,
una valutazione non invasiva approssimata, ma attendibile, è data dal prodotto FC x PA
sistolica (doppio prodotto), largamente utilizzato nella pratica clinica per stimare il
consumo miocardico di ossigeno, in particolare il suo incremento durante sforzo.
LA CIRCOLAZIONE ARTERIOSA CORONARICA
Dal punto di vista fisiologico, la circolazione arteriosa coronarica può essere distinta
in tre principali compartimenti, collegati in serie.
Il compartimento prossimale è costituto dalle arterie di capacitanza epicardiche, che
hanno funzione conduttiva e non oppongono resistenza significativa al flusso, per cui la
pressione rimane sostanzialmente costante lungo il loro decorso. Durante la
contrazione miocardica il sangue viene spinto in senso retrogrado dai vasi
intramiocardici verso i vasi epicardici, il cui contenuto aumenta quindi di circa il 25%.
L’energia elastica accumulata durante la sistole si trasforma in energia cinetica
durante la diastole, contribuendo a garantire un adeguato flusso coronarico in questa
fase. Le arterie coronarie di conduttanza modificano il loro tono in risposta a
variazioni di flusso, il cui aumento causa una dilatazione endotelio-dipendente dei vasi,
e per effetto di sostanze vasoattive locali o circolanti e di stimoli neurogeni.
I vasi distali sono vasi di resistenza ed hanno dimensioni inferiori a 0.5 mm. Per le loro
dimensioni, questi vasi non sono visibili all’angiografia coronarica e costituiscono la
vasta area del microcircolo coronarico. Dal punto di vista funzionale, le piccole arterie
cardiache possono essere divise in due distretti, uno prossimale, rappresentato dalle
prearteriole, ed uno distale, rappresentato dalle arteriole.
Le prearteriole hanno dimensioni di 100-500 µm e contribuiscono per il 25-30% alla
resistenza coronarica totale. La loro funzione principale è di mantenere la pressione di
perfusione all’origine delle arteriole a livelli ottimali. A tale scopo vanno incontro a
vasocostrizione miogena in presenza di un aumento, e a vasodilatazione in caso di
riduzione, della pressione arteriosa sistemica.
Le arteriole hanno dimensioni <100 µm di diametro e contribuiscono per il 40% circa
alla resistenza coronarica. Esse sono la sede della regolazione metabolica del flusso
coronarico. Per la loro posizione, infatti, esse risentono dell’attività metabolica delle
cellule miocardiche, modificando il loro tono vasale in modo da adattare il flusso
coronarico alle richieste energetiche. Così, le arteriole si dilatano in caso di un
aumento del metabolismo cardiaco, che comporta un’aumentata richiesta di ossigeno,
consentendo un adeguato aumento di flusso. Nei casi di maggiore richiesta di ossigeno
miocardico, la riduzione massimale della resistenza coronarica consente un aumento
anche di 4-5 volte del flusso coronarico, e quindi dell’apporto di ossigeno, come nel
caso di sforzi intensi. La capacità di aumento massimale del flusso coronarico rispetto
al basale costituisce la cosiddetta riserva coronarica (che è espressa
matematicamente come rapporto tra flusso durante vasodilatazione massimale e
flusso basale). Oltre che dallo stato metabolico delle cellule miocardiche, comunque, il
tono delle arteriole è anch’esso modulato da fattori autacoidi locali, da sostanze
vasoattive circolanti e da stimoli neurogeni.
CONTROLLO DEL FLUSSO CORONARICO
Diversi fattori contribuiscono alla complessa regolazione del flusso
coronarico.
Forze meccaniche extravascolari
Una caratteristica esclusiva del cuore è che esso stesso genera la pressione di
perfusione del suo sistema arterioso. Durante la sistole le forze extravascolari
intramiocardiche superano quella intravascolari: i vasi intramiocardici vengono,
quindi, occlusi e il sangue in parte addirittura espulso verso i vasi epicardici. Il
flusso anterogrado è quindi praticamente abolito durante la sistole,
soprattutto negli strati subendocardici, che ricevono quindi sangue
esclusivamente in diastole .
Regolazione del tono vascolare coronarico
I fattori che contribuiscono a regolare il tono vascolare coronarico, e quindi il
flusso coronarico, sono numerosi e possono variare nei diversi compartimenti
arteriosi.
a) La regolazione miogenica fa sì che il tono vasale arterioso aumenti quando la
pressione arteriosa aumenta, mentre si riduce quando la pressione decresce,
ed ha, quindi, lo scopo di mantenere costante il flusso in proporzione alle
variazioni della pressione di distensione del vaso. Essa sembra esplicarsi
soprattutto nelle prearteriole.
b) La regolazione metabolica del tono vascolare avviene a livello delle arteriole.
L’aumento della domanda di ossigeno causa il rilascio, da parte dei
miocardiociti, di sostanze vasodilatatrici che determinano dilatazione
arteriolare, consentendo così l’aumento del flusso. Tra le sostanze implicate
nella regolazione del flusso coronarico, un ruolo rilevante sembra essere
svolto dall’adenosina, che, con l’aumento del metabolismo energetico, viene
prodotta in maggiori quantità dai miocardiociti, in seguito alla maggiore
scissione delle molecole di adenosin trifosfato (ATP). L’adenosina agisce sui
recettori adenosinici A2 delle cellule muscolari lisce vascolari, attivando
l’adenilato-ciclasi intracellulare, che determina la produzione di AMP ciclico.
Altri fattori, tuttavia, possono contribuire alla vasodilatazione metabolica
(pressione tissutale di ossigeno, pH, concentrazione di potassio, pressione
osmotica, attivazione dei canali ATP-sensibili del potassio, bradichinina).
L’aumento del flusso conseguente alla vasodilatazione arteriolare può
continuare ad essere garantito grazie anche alla vasodilatazione flussomediata, in larga parte endotelio-dipendente, che si determina nei vasi
prossimali, in particolare nelle pre-arteriole, come conseguenza dell’aumento
della velocità di flusso.
c) La regolazione neurogenica del tono vasale è dovuta agli effetti esplicati sui
vasi dal sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico.
La stimolazione simpatica causa un aumento del tono vasomotore e della
resistenza coronarica tramite stimolazione dei recettori
1
2
da parte della
noradrenalina. Un -tono sembra presente già in condizioni di riposo, in quanto
la somministrazione di -bloccanti causa un aumento di circa il 10% del flusso
coronarico basale. D’altro canto, la stimolazione dei recettori ß 1 e ß2 determina
una vasodilatazione, con riduzione del 20-30% della resistenza coronarica.
L’effetto complessivo della stimolazione adrenergica in vivo (ad esempio,
durante uno sforzo) è comunque quello di un aumento del flusso coronarico. Ciò
è soprattutto secondario all’aumento del consumo miocardico di ossigeno che
essa determina, con conseguente vasodilatazione metabolica.
Il ruolo del sistema nervoso parasimpatico nella regolazione del circolo
coronarico non è completamente chiaro: in vivo la stimolazione vagale tende a
determinare un aumento del tono vasomotore, soprattutto come effetto
secondario alla bradicardia ed alla conseguente riduzione del consumo
miocardico di ossigeno.
d) Un ruolo molto importante è svolto dalla regolazione endotelio-mediata del
circolo coronarico, diventata evidente in anni recenti. Molti studi hanno infatti
dimostrato che l’endotelio può essere considerato come un vero e proprio
organo endocrino, in grado di produrre numerose sostanze, alcune delle quali
svolgono un ruolo cruciale nella regolazione del flusso sanguigno (vedi Capitolo
47).
Le principali sostanze prodotte dall’endotelio hanno anzitutto
attività vasodilatatrice, e comprendono l’endotheliumderived relaxing factor (EDRF), la prostaciclina (PGI2) e l’endotheliumderived hyperpolarizing factor (EDHF).
L’EDRF ha emivita breve (5 secondi) ed è stato identificato con l’ossido nitrico
(NO). Esso agisce attivando la guanilato-ciclasi delle cellule muscolari lisce, che
risulta nella fomazione di guanosin-monofosfato ciclico (cGMP). L’EDRF sembra
avere un ruolo nel determinare il tono vascolare basale; la somministrazione
dell’inibitore NG-monometil-L-arginina, infatti, riduce il flusso ematico a vari
livelli. Molte sostanze vasoattive (ad esempio, acetilcolina, serotonina,
bradichinina) esercitano il loro effetto vasodilatatore determinando il rilascio
di EDRF da parte delle cellule endoteliali (vasodilatazione endoteliomediata). L’EDRF, inoltre, sembra essere la sostanza principalmente
responsabile della vasodilatazione che si ottiene in risposta all’aumento del
flusso coronarico (vasodilatazione flusso-mediata).
La PGI2 è una prostaglandina, derivata dall’acido arachidonico. Ha anch’essa
emivita breve (10 secondi) ed è rilasciata in risposta alla pressione pulsatile e a
diverse sostanze (ad esempio., bradichinina, trombina, serotonina). Sembra
contribuire anch’essa al tono vasale basale e alla vasodilatazione flusso
mediata.
L’EDHF non è stato ancora ben identificato chimicamente; probabilmente
deriva anch’esso dall’acido arachidonico ed ha emivita breve. Dati sperimentali
suggeriscono che esso causi vasodilatazione mediante apertura dei canali del
potassio e conseguente iperpolarizzazione delle cellule muscolari lisce. Sembra
venire anch’esso rilasciato in risposta allo shear stress ed al flusso pulsatile,
oltre che a diverse sostanze (ad es., acetilcolina, sostanza P, bradichinina,
CGRP).
Le cellule endoteliali, tuttavia, sintetizzano anche sostanze vasocostrittrici, in
particolare l’endotelina-1 (ET-1), l’angiotensina II, l’endotheliumderived contracting factor (EDCF) e la prostaglandina H2, oltre ai radicali
liberi dell’ossigeno. Se queste sostanze abbiano un qualche ruolo nella
regolazione fisiologica del circolo coronarico non è chiaro. Viceversa, l’attività
vasocostrittrice dell’endotelio (attivazione dell’endotelio) può aumentare in
alcune condizioni patologiche (per esempio, ipertensione arteriosa, diabete,
aterosclerosi, ischemia miocardia, scompenso cardiaco), contribuendo ai loro
effetti negativi.
L’ET-1, in particolare, è il più potente vasocostrittore conosciuto nell’uomo,
agisce su due tipi di recettori principali, ETA ed ETB. L’azione vasocostrittrice
è svolta mediante stimolazione dei recettori ETA sulle cellule muscolari lisce.
La stimolazione di recettori ETB sulle cellule endoteliali, d’altro canto, induce
rilascio di NO ed inibisce quello di ET-1, tendendo a contrastare così gli
effetti vasocostrittori dell’ET-1.
Integrità della parete vasale
Lo svolgimento di un normale flusso coronarico comporta l’integrità della
parete vasale. Ancora una volta, è soprattutto l’endotelio a garantire questa
integrità. Esso, infatti, previene la diffusione di sostanze aterogene nella
parete arteriosa, produce costituenti della lamina basale e della matrice
extracellulare dell’intima (che possono riparare danni vasali), ed inibisce la
crescita e la migrazione cellulare mediante la sintesi di eparan-solfato ed NO.
L’endotelio ha inoltre un ruolo chiave nel preservare la fluidità del sangue, in
quanto il suo rivestimento interno con proteoglicani forma una barriera
elettronegativa che previene l’adesione delle piastrine e delle altre cellule
circolanti. La sintesi di NO e PGI2, inoltre, ostacola l’adesione e l’aggregazione
piastrinica. Infine, le cellule endoteliali secernono diverse sostanze con
attività anticoagulante, come l’eparan-solfato, che catalizza l’inattivazione
della trombina da parte dell’antitrombina III, e la trombomodulina, che si lega
a trombina e proteina C, e sostanze in grado di attivare il plasminogeno, e
quindi la fibrinolisi, come lo urokinase type plasminogen activator (u-PA) ed
il tissue type plasminogen activator (t-PA).
DEFINIZIONE
L’ischemia miocardica si verifica quando il flusso coronarico risulta inadeguato a
soddisfare le richieste di ossigeno e sostanze metaboliche necessarie alle cellule
miocardiche per svolgere le proprie funzioni. Quando sufficientemente grave e
prolungata, l’ischemia determina la necrosi delle cellule stesse. Questa, in caso di
occlusione acuta di un vaso coronarico, interessa progressivamente prima gli strati
subendocardici, più sensibili al danno ischemico (vedi più avanti) e solo più
tardivamente quelli subepicardici.
L’ischemia miocardica può essere causata da due principali meccanismi, che possono,
tuttavia, combinarsi tra loro nel determinare gli episodi ischemici: (1) impossibilità di
aumentare in modo adeguato il flusso coronarico per soddisfare un aumento della
domanda miocardica di ossigeno, in genere a causa della presenza di una stenosi
coronarica, e (2) riduzione primaria del flusso coronarico, dovuta a vasocostrizione,
spasmo o trombosi coronarica.
STENOSI CORONARICHE EPICARDICHE
Le stenosi coronariche epicardiche, causate da placche aterosclerotiche, sono il
substrato più frequente dell’ischemia miocardica. Una stenosi coronarica è
emodinamicamente significativa quando è in grado di opporre, già a riposo, una
resistenza al flusso ematico, tale da determinare una caduta della pressione a valle.
Ciò comincia a verificarsi, in genere, quando il diametro del lume viene ridotto del
50%. Oltre questa riduzione critica, ogni ulteriore aumento della stenosi causa una
sempre maggiore riduzione della pressione a valle, con una relazione di tipo
esponenziale. La relazione tra caduta pressoria e flusso a livello di una stenosi,
tuttavia, non è semplicemente lineare, essendo la riduzione del flusso superiore a
quella predetta dalla riduzione della pressione.
Poiché la pressione di perfusione è il principale determinante del flusso, la sua
riduzione a valle di una stenosi tende a ridurre il flusso. In condizioni basali, tuttavia,
in corrispondenza di una stenosi non si osserva riduzione del flusso coronarico, in
quanto la caduta della pressione è compensata dalla riduzione della resistenza
coronarica a valle, come conseguenza della dilatazione delle arteriole coronariche.
Questa vasodilatazione compensatoria, tuttavia, riduce la riserva coronarica, vale a
dire la capacità di aumento massimo del flusso in risposta all’aumento del fabbisogno
metabolico del miocardio. Il livello di lavoro cardiaco oltre il quale non è più possibile
incrementare il flusso per soddisfare le richieste metaboliche, per cui si sviluppa
ischemia, è definito soglia ischemica.
L’ischemia miocardica da discrepanza che si sviluppa in un paziente è tipicamente
limitata agli strati subendocardici, che, per varie ragioni, presentano una minore
riserva coronarica, e sono quindi più suscettibili all’ischemia, rispetto agli strati
subepicardici. Infatti, il consumo di ossigeno delle cellule subendocardiche è di base
maggiore di quello delle cellule subepicardiche, a causa del maggiore stress sistolico
parietale cui sono soggette. Come risultato, il flusso subendocardico è di base del 1520% superiore a quello subepicardico, nonostante sia sottoposto a maggiori forze
compressive extramurali, con conseguente minore capacità di incremento relativo
durante aumento della domanda di ossigeno.
Oltre queste condizioni sfavorevoli, altri fattori, in presenza di una stenosi, possono
contribuire a facilitare l’ischemia subendocardica in caso di aumento del lavoro
cardiaco, come l’accorciamento della diastole (durante una tachicardia) e un aumento
ulteriore delle forze extravascolari (per esempio, in caso di aumento della pressione
telediastolica ventricolare sinistra).
Un meccanismo particolare di ischemia miocardica è costituito
dal furto coronarico transmurale, che si verifica quando, in presenza di un vaso con
una stenosi, in genere molto critica, il flusso ematico si ridistribuisce dal
subendocardio al subepicardio come conseguenza della vasodilatazione massimale dei
vasi di resistenza subepicardici. Infatti, poiché la riserva coronarica subendocardica
e’ inferiore a quella subepicardica, una volta che la riserva subendocardica si esaurisce
(per vasodilatazione massimale dei vasi subendocardici), un’ulteriore vasodilatazione
epicardica comporterà un’ulteriore caduta della pressione post-stenotica, con
conseguente riduzione della perfusione subendocardica, che diventera’ insufficiente
per le richieste metaboliche del subendocardio.
Nella pratica clinica l’importanza emodinamica di una stenosi è in genere valutata
all’angiografia coronarica visivamente o usando metodi di misurazione quantitativa. La
semplice valutazione del grado di una stenosi coronarica all’angiografia, tuttavia, ha
diverse limitazioni. Altri fattori, infatti, possono avere importanza nel determinare le
conseguenze emodinamiche della stenosi, come il diametro del vaso originario, la
lunghezza e la concentricità o eccentricità della stenosi e la presenza di altre stenosi
nel vaso. Le conseguenze emodinamiche della stenosi possono ancora essere
influenzate dalla modulazione dinamica del tono vasale a livello della stenosi e di quello
del microcircolo distale, dalla presenza ed estensione di vasi collaterali e dalla
resistenza extravascolare.
In particolare, le stenosi coronariche sono spesso dinamiche; presentano, cioè,
variazioni vasomotorie del lume in grado di modificare il grado di stenosi, e quindi la
riserva coronarica, dando origine ad un pattern anginoso caratterizzato da una
significativa variabilità della la soglia ischemica, in contrasto con la stabilità e
predicibilità della soglia ischemica nei casi di stenosi coronariche fisse. La dinamicità
di una stenosi può essere valutata saggiando la risposta vasomotoria alla
somministrazione intracoronarica di sostanze vasodilatatrici e vasocostrittrici.
Inoltre, un fattore importante in grado di influenzare gli effetti di una stenosi
coronarica è lo sviluppo di una circolazione coronarica collaterale verso il territorio
ischemico. I collaterali possono svilupparsi sia da vasi anastomotici preesistenti, sia,
più limitatamente, come piccoli vasi di nuova formazione. Lo sviluppo e l’entità di una
circolazione collaterale varia consistentemente da paziente a paziente, e il flusso nei
vasi collaterali è influenzato sia da fattori nervosi e umorali, sia da sostanze
vasoattive autacoidi locali.
TROMBOSI CORONARICA
I fenomeni trombotici costituiscono il meccanismo fisiopatologico principale
dell’ischemia miocardica nelle sindromi coronariche acute (Figura 10). Quando
transitoria, la trombosi causa solo un’ischemia temporanea; se prolungata o
persistente, tuttavia, essa determina la necrosi di una parte più o meno estesa di
tessuto miocardico.
I meccanismi responsabili della trombosi coronarica sono complessi e ancora non del
tutto chiariti. I trombi, tuttavia, si formano in genere a livello di placche
aterosclerotiche complicate (ad esempio, da rottura, fissurazione o emorragia), che
espongono al sangue una superficie vasale non più in grado di contrastare
efficacemente, come avviene normalmente, l’attivazione di processi proaggreganti e
procoagulanti, e, quindi, trombotica .
In almeno il 30% circa dei casi, tuttavia, trombi coronarici sono riscontrati a livello di
placche non fissurate ed esenti da stenosi di rilievo e da apparenti danni della parete
vasale. In questi casi, la formazione di un trombo è probabilmente facilitata da lesioni
microscopiche (erosioni) e/o da alterazioni funzionali dell’endotelio, secondarie a
stimoli di varia natura (meccanici, anossici, chimici, infettivi, immunologici), in grado di
compromettere in modo rilevante le funzioni antitrombotiche e vasodilatatrici delle
cellule endoteliali, che sono anzi stimolate a produrre potenti sostanze
vasocostrittrici ed esporre recettori di adesione leucocitaria e
piastrinica (attivazione dell’endotelio).
Le alterazioni dell’endotelio sono più frequenti in vasi con flusso turbolento (ad es., a
livello di stenosi), e possono essere causate da molteplici fattori, meccanici (alterato
shear stress), chimici (LDL ossidate), infettivi (virus, batteri), e immunologici
(anticorpi contro antigeni di superficie, linfociti sensibilizzati). In anni recenti,
inoltre, è stata accumulata evidenza che un’importante componente patogenetica della
formazione di trombi intracoronarici, e quindi delle sindromi coronariche acute, è
costituita da processi infiammatori delle placche aterosclerotiche, che ne favoriscono
le complicanze e stimolano localmente sia meccanismi trombotici che vasocostrittori.
Indipendentemente dai meccanismi, la prima fase della formazione di un trombo è
costituita dall’adesione di piastrine alla parete vascolare danneggiata, seguita da una
serie di meccanismi che portano alla formazione di un trombo piastrinico, che, in
presenza di stenosi critiche, può di per sé causare subocclusione o occlusione del vaso
(e quindi, rispettivamente, ischemia subendocardica o transmurale). Più
frequentemente, soprattutto in presenza di stenosi meno gravi, il trombo murale
piastrinico viene seguito dalla formazione di un trombo più stabile, per l’attivazione
del sistema emostatico, che porta a deposizione anche di rilevanti quantità di fibrina,
globuli rossi e leucociti, insieme alle piastrine, con finale occlusione del vaso.
Gli effetti fisiopatologici e clinici di un trombo coronarico dipendono, oltre che da
quanto esso riduce il lume, dalla sua evoluzione. Il suo destino naturale è, infatti,
variabile. Esso può lisarsi spontaneamente in poco tempo, per cui causa solo
un’ischemia più o meno prolungata. Altre volte esso si risolve solo parzialmente,
rimanendo in parte adeso alla parete, per cui si organizza e causa la progressione della
preesistente stenosi con successiva riduzione della soglia ischemica. Altre volte,
infine, subisce una rapida crescita che causa l’occlusione totale del vaso, con grave
ischemia e necrosi miocardica. Il destino finale del trombo è il frutto di una complessa
interazione tra fattori protrombotici e antitrombotici, che coinvolge anche fattori
emodinamici, vasomotori e fibrinolitici.
Va osservato come trombi, sia ostruttivi sia non ostruttivi, possono dare origine a
microembolie distali che causano aree di ischemia o necrosi miocardica circoscritta.
Va infine ricordato come una trombosi può localmente complicare uno spasmo
coronarico, facilitando l’occlusione e l’infarto miocardico in pazienti con angina
vasospastica.
SPASMO CORONARICO
Lo spasmo coronarico consiste in un’improvvisa, intensa contrazione delle
cellule muscolari lisce di un segmento di un’arteria coronaria epicardica, che
occlude o riduce in modo critico il lume del vaso, con conseguente ischemia
miocardica, in genere transmurale. Esso può verificarsi sia in vasi stenotici sia
in vasi completamente normali e, dal punto di vista clinico, è anzitutto il
meccanismo responsabile dell’angina variante di Prinzmetal.
Il substrato che rende un vaso coronarico suscettibile allo spasmo non è noto.
E’ probabile, tuttavia, che esso risieda in una o più alterazioni delle vie
intracellulari post-recettoriali di trasmissione e modulazione dei segnali che
regolano la contrazione delle cellule muscolari lisce vasali, determinando una
loro iperreattività agli stimoli vasocostrittori. Ciò è suggerito dal fatto che lo
spasmo può essere indotto, in genere, da vari stimoli vasocostrittori
(catecolamine, acetilcolina, alcalosi, ergonovina, serotonina, istamina) che
agiscono su recettori differenti.
DISFUNZIONE DEL MICROCIRCOLO CORONARICO
Diversi dati, in anni recenti, hanno suggerito come alterazioni del flusso coronarico a
livello dei piccoli vasi coronarici di resistenza (prearteriole e arteriole), che non sono
visibili all’angiografia coronarica, possano essere responsabili di un’ischemia
miocardica. Ad esempio, è stato osservato che l’infusione intracoronarica di
neuropeptide Y o di alte dosi di acetilcolina in soggetti con arterie coronarie
epicardiche normali può indurre ischemia miocardica in assenza di variazioni
significative delle arterie epicardiche, ma in presenza di una diffusa vasocostrizione
dei rami distali e di un lento run off del mezzo di contrasto, indicativo di un’intensa
vasocostrizione microvascolare.
Una disfunzione microvascolare sembra implicata nei meccanismi che causano ischemia
miocardica in alcune condizioni cliniche. In pazienti
con occlusione totale isolata di un vaso epicardico la somministrazione di ergonovina
può causare riduzione del flusso collaterale in assenza di modificazioni dei vasi
epicardici, suggerendo che variazioni rilevanti della soglia ischemica siano conseguenti
a variazioni del tono dei vasi di resistenza. In pazienti
con stenosi isolata di un vaso coronarico, trattata con intervento di rivascolarizzazion
e percutaneo, la persistenza di sintomi anginosi e di alterazioni ischemiche dell’ECG
durante sforzo, a dispetto del successo della procedura, suggerisce una causa
microvascolare, come indicato da anomalie nell’incremento del flusso coronarico in
risposta a stimoli vasodilatatori. Alterazioni della resistenze coronariche sono state,
inoltre, dimostrate distalmente a stenosi coronariche in pazienti con cardiopatia
ischemica stabile o instabile, in vasi non stenotici di pazienti con stenosi ostruttive in
altri rami coronarici epicardici, e in pazienti con fattori di rischio per malattia
coronarica ma con arterie epicardiche angiograficamente normali. Infine, una
disfunzione microvascolare è ritenuta essere responsabile della sindrome X cardiaca,
una condizione clinica caratterizzata da episodi anginosi, indotti prevalentemente
dallo sforzo, in presenza di arterie coronarie angiograficamente normali.
I meccanismi della disfunzione dei piccoli vasi arteriosi coronarici sono al momento
poco noti, ma sono verosimilmente molteplici e differenti non solo nelle diverse
condizioni cliniche, ma anche all’interno di uno stesso gruppo di pazienti. In pazienti
con evidenza di malattia coronarica, la disfunzione microvascolare è in genere
attribuita all’aterosclerosi ed alle alterazioni neuroumorali e vasali (ad es., fibrosi
perivascolare, ipertrofia della media) associate ad eventuali malattie sistemiche
concomitanti (ad es., ipertensione, diabete). Di contro, nei pazienti con sindrome X
cardiaca, in cui non sono presenti ostruzioni epicardiche, sono state riportate
alterazioni strutturali dei piccoli vasi coronarici solo in alcuni casi, mentre sono state
descritte diverse alterazioni in grado di determinare disfunzione del microcircolo ed
ischemia miocardica.
CARDIOMIOPATIE
Il problema riguardante la definizione e la classificazione delle cardiomiopatie (CMP)
rappresenta uno dei punti maggiormente controversi nell’ambito della cardiologia.
L’introduzione nel linguaggio medico del termine “Cardiomiopatie” (= “Malattie del
Muscolo Cardiaco”) risale a circa mezzo secolo fa, ma è solo nel 1980 che venne
pubblicato – da parte di un gruppo di esperti nominato dalla World Health
Organization e dalla International Society and Federation of Cardiology (WHO/ISFC)
– il primo documento ufficiale in tema di definizione e classificazione delle CMP. In
quel documento, le CMP venivano definite come malattie del muscolo cardiaco “da
causa sconosciuta”; la loro natura “idiopatica” ne rappresentava, pertanto, uno dei
caratteri distintivi fondamentali da altre malattie cardiache ad eziopatogenesi nota
quali le cardiopatie ischemica, ipertensiva, valvolare, ecc.
Tuttavia, i progressi compiuti dalla ricerca – soprattutto nel campo della genetica – e
la sempre più ampia diffusione di nuove metodiche d’indagine non invasive, in
particolare l’ecocardiografia, hanno condotto negli anni successivi ad un significativo
incremento delle conoscenze sulle CMP, rendendo inadeguato il documento del 1980.
Pertanto, nel 1995 la WHO e la ISFC hanno redatto congiuntamente un nuovo report
che tuttora costituisce il documento di riferimento in materia di definizione e
classificazione delle CMP (Tabella I).
Gli aspetti salienti di tale documento sono:
1) la nuova definizione delle CMP come Malattie del Muscolo Cardiaco “associate a
disfunzione cardiaca” sia sistolica che diastolica. La precedente espressione “da causa
sconosciuta” veniva soppressa, essendo divenuta nel frattempo impropria alla luce
delle nuove acquisizioni eziopatogenetiche;
2) la sottoclassificazione delle CMP in 4 tipi o forme principali: la CMP dilatativa
(CMPD), la CMP ipertrofica (CMPI), la CMP restrittiva (CMPR) e la CMP/displasia
aritmogena del ventricolo destro (CMP/DAVD).
L’importanza del primo punto risiede nell’esplicito riconoscimento che, accanto ai casi
“idiopatici” di CMP, ne esistono altri in cui è viceversa possibile identificare la causa
della malattia (ad esempio, nella quasi totalità dei casi di CMPI ed in circa un terzo dei
casi di CMPD è oggi documentabile un’eziologia genetica).
L’importanza del secondo punto è dovuta invece al fatto che la sottoclassificazione
delle CMP viene operata sulla base di quadri morfo-funzionali di semplice
riconoscimento (in tal senso, un ruolo fondamentale è svolto dall’indagine
ecocardiografica), quali la dilatazione/ipocinesia ventricolare sinistra (CMPD),
l’ipertrofia ventricolare sinistra (CMPI), la severa compromissione di tipo “restrittivo”
del riempimento diastolico (CMPR), il prevalente coinvolgimento del ventricolo destro
associato a spiccata aritmogenicità (CM/DAVD). Tale approccio classificativo si rivela
di grande utilità nella pratica clinica perché richiama immediatamente gli aspetti
essenziali e caratteristici di ciascuna CMP, orientando il cardiologo verso la corretta
diagnosi e l’impiego appropriato delle strategie terapeutiche attualmente disponibili.
Restano indubbiamente margini di incertezza classificativa che riguardano disordini
aritmogeni “isolati” dovuti ad alterazioni di funzione dei canali ionici o forme con
interessamento miocardico ma difficilmente iscrivibili nei 4 gruppi principali come il
“miocardio non compatto”, la “cardiomiopatia peripartum” e la “malattia tako-tsubo”.
A differenza di quanto proposto nel documento del 1995 della WHO/ISFC, non
andrebbero invece utilizzati termini fuorvianti come “cardiomiopatia ischemica”,
“cardiomiopatia valvolare” e “cardiomiopatia ipertensiva”.
Cardiopatia ipertrofica
La cardiomiopatia ipertrofica è definita come ipertrofia ventricolare sinistra non
spiegata da cause comuni d’ipertrofia , l’ipertensione arteriosa o alcune valvulopatie
(ad esempio, stenosi aortica). La definizione si basa, clinicamente, sul rilievo
ecocardiografico di aumentato spessore parietale del ventricolo sinistro: ciò non
significa necessariamente che ci sia ipertrofia (aumento della massa muscolare da
prevalente aumento delle dimensioni dei miocardiociti), perché situazioni in cui c’è, ad
esempio, accumulo intra- o extracellulare di sostanze (come nell’amiloidosi, nella
malattia di Fabry, in alcune glicogenosi etc.) ricadono, impropriamente, in questa
definizione. Con questa definizione, la cardiomiopatia ipertrofica è malattia
relativamente frequente, con una prevalenza di 1/500, che la rende la più comune
cardiopatia su base genetica.
EZIOLOGIA E PATOGENESI
La cardiomiopatia ipertrofica è una malattia autosomica dominante a penetranza
incompleta. Le forme tipiche (a cui andrebbe riservato il nome di cardiomiopatia
ipertrofica) sono dovute a mutazioni di geni codificanti per proteine sarcomeriche. I
geni più frequentemente interessati sono quelli delle catene pesanti della betaMiosina, della proteina C legante la Miosina, e della Troponina T, ma tutti i geni
codificanti per proteine sarcomeriche (contrattili, modulatrici o strutturali) possono
determinare la malattia.
La penetranza è incompleta, cioè possono esserci individui genotipo+ e fenotipo-, e
dipende dall’età in modo variabile a seconda del gene causale: mentre la penetranza è
quasi completa entro la terza decade per le mutazioni delle catene pesanti della betaMiosina e della Troponina T, per quelle della proteina C legante la Miosina la
penetranza cresce costantemente fino alla vecchiaia.
Individui appartenenti alla stessa famiglia (e dunque portatori della stessa mutazione
causale) possono avere fenotipi molto diversi per morfologia del ventricolo sinistro e
per quadri clinici. Ciò è spiegabile solo se si pensa che la mutazione causale interagisce
con altri geni e con fattori ambientali per determinare il fenotipo. È ancora soltanto
un’ipotesi (ma basata su alcune evidenze solide) che l’incorporazione di una proteina
mutata nel sarcomero ne determini una ridotta efficienza contrattile; questa aumenta
lo stress sarcomerico con conseguente attivazione del signaling responsivo allo stress
e sintesi di fattori trofici. I fattori trofici agiscono sui miocardiociti, determinandone
ipertrofia, sui fibroblasti inducendo fibrosi interstiziale, e sulle cellule muscolari lisce
della media delle arteriole coronariche, provocandone l’iperplasia. Questa ipotesi
spiega le tre fondamentali caratteristiche morfologiche della cardiomiopatia
ipertrofica: ipertrofia e malallineamento (disarray) dei cardiomiociti con fibrosi
interstiziale ed ispessimento della media delle arteriole. Questa ipotesi patogenetica
è ulteriormente supportata dall’osservazione, finora confinata all’animale transgenico,
che il fenotipo è reversibile o prevenibile con l’uso di farmaci di cui è nota
l’interazione con lo sviluppo ed il mantenimento dell’ipertrofia.
FISIOPATOLOGIA
Le tre principali caratteristiche fisiopatologiche della cardiomiopatia ipertrofica sono
la disfunzione diastolica, l’ostruzione al tratto d’efflusso del ventricolo sinistro e
l’ischemia.
La disfunzione diastolica dipende da alterata affinità per il Ca++ delle proteine
mutate, e da rallentato re-uptake del Ca++ da parte del reticolo sarcoplasmatico. Ne
deriva un incompleto rilasciamento ed un’aumentata rigidità del muscolo. Un’altra
causa di disfunzione diastolica, forse più rilevante clinicamente, è secondaria
all’ipertrofia ed alla fibrosi interstiziale, che determinano una ridotta distensibilità
del ventricolo sinistro (cioè è richiesta una maggiore pressione atriale per riempirlo).
Altra rilevante caratteristica fisiopatologica
è l’ostruzione al tratto d’efflusso del ventricolo sinistro. Il setto ipertrofico sporge
nel tratto d’efflusso del ventricolo sinistro, e lo restringe progressivamente durante
la sistole. Il sangue è costretto ad accelerare fino al punto in cui si genera l’effetto
Venturi, cioè lo sviluppo di forze centripete che attirano il lembo della mitrale nel
tratto d’efflusso (Systolic Anterior Movement, o S.A.M.). Ciò provoca un’ulteriore
riduzione della sezione del tratto di efflusso e lo sviluppo di ostruzione. Ovviamente, il
S.A.M. determina anche insufficienza mitralica. In conseguenza del meccanismo di
generazione, l’ostruzione al tratto d’efflusso del ventricolo sinistro è meso-sistolica e
dinamica (cioè l’entità dell’ostruzione varia a seconda del volume ventricolare e dello
stato inotropo).
I pazienti con cardiomiopatia ipertrofica hanno spesso segni d’ischemia, anche in
assenza di stenosi coronariche epicardiche. L’ischemia è la conseguenza
dell’ispessimento della media arteriolare, dell’ipertrofia (a causa dell’aumentato
spessore non seguito da analogo aumento della densità capillare), e dell’aumento della
pressione telediastolica del ventricolo sinistro (che determina un aumento delle
resistenze coronariche estrinseche in diastole).
QUADRO CLINICO
La cardiomiopatia ipertrofica ha un decorso clinico benigno nella maggioranza dei
pazienti. I pazienti sintomatici lamentano soprattutto dispnea (dovuta a disfunzione
diastolica e/o ad ostruzione al tratto d’efflusso), palpitazioni, angina pectoris (anche
in assenza di malattia coronarica, vedi sopra), e sincope (in circa 1/3 dei pazienti).
La caratteristica clinica più temuta di questa malattia è la morte improvvisa. Si
definisce come tale la morte entro 24 ore dall’esordio di sintomi, ed è tipicamente
dovuta a fibrillazione ventricolare. I bambini sono maggiormente interessati, con
un’incidenza più che doppia di quella degli adulti. In questi ultimi, l’incidenza è circa
1%/anno, e declina con l’età. Non molto è noto circa i meccanismi della morte
improvvisa, ma si è osservata un’associazione epidemiologica tra alcuni eventi (definiti
fattori di rischio) e la morte improvvisa. Questi sono:
familiarità per morte improvvisa
storia di sincope recente inspiegata
presenza di ipertrofia ventricolare sinistra massiva (massimo spessore di parete >= 30 mm)
risposta pressoria anomala all’esercizio (normalmente, la pressione arteriosa cresce
costantemente durante l’esercizio; in circa 1/3 dei pazienti con cardiomiopatia ipertrofica la
pressione invece aumenta e poi diminuisce durante l’esercizio, oppure diminuisce fin
dall’inizio)
tachicardia ventricolare non sostenuta all’ECG Holter
La tachicardia ventricolare sostenuta è considerata equivalente di morte improvvisa
abortita e non un fattore di rischio.
Il paziente adulto con cardiomiopatia ipertrofica ha un rischio 6 volte maggiore
rispetto alla popolazione generale di sviluppare fibrillazione atriale parossistica o
permanente, ed infatti circa 1/3 dei pazienti soffre di questa aritmia, ed è pertanto
frequente riscontrarla o durante Holter o durante visita clinica.
DIAGNOSI
La cardiomiopatia ipertrofica è generalmente sospettata per la presenza di un soffio
cardiaco o di anomalie elettrocardiografiche. L’ostacolo all’eiezione ventricolare
sinistra dipendente dall’ipertrofia settale genera un soffio sistolico eiettivo, che si
ascolta soprattutto al mesocardio, lungo la margino-sternale sinistra. La relazione fra
l’intensità del soffio e il volume ventricolare (il soffio è tanto più intenso quanto più il
contenuto di sangue nel ventricolo si riduce) può permettere di diagnosticare
all’ascoltazione del cuore la cardiomiopatia ipertrofica, e soprattutto distinguerla
dalla stenosi valvolare aortica (vedi Capitoli 2 e 16). Se, mentre si ascolta il cuore, si
fa eseguire al soggetto la manovra di Valsalva, ci si accorge che il soffio della stenosi
valvolare aortica si riduce d’intensità mentre quello della cardiomiopatia ipertrofica
aumenta. La manovra di Valsalva (espirazione forzata a glottide chiusa), infatti, riduce
la pressione negativa endotoracica, cioè la forza “aspirativa” (vis a fronte) che
favorisce il ritorno venoso: diminuisce quindi il riempimento diastolico dei ventricoli e
con esso la gittata sistolica. La riduzione del volume ventricolare fa sì che nella
cardiomiopatia ipertrofica il soffio aumenti di intensità con la manovra di Valsalva,
mentre diminuisce nella stenosi aortica, dove l’intensità del soffio è proporzionale alla
gittata sistolica, cioè alla quantità di sangue che attraversa la valvola.
L’ECG è anormale nella quasi totalità dei casi, anche se le anomalie presenti non sono
patognomoniche e possono essere diverse: più comunemente si osserva ipertrofia
ventricolare sinistra, onde Q anomale e segni di ischemia ventricolare.
L’ecocardiogramma è esame fondamentale, che mostra ipertrofia generalmente
asimmetrica, coinvolgente il setto interventricolare. La distribuzione dell’ipertrofia è
eterogenea e in una piccola percentuale di pazienti è localizzata al solo apice
ventricolare (forma apicale, identificata dapprima nelle popolazioni orientali, ma
ubiquitaria; è caratterizzata da buona prognosi). Una stima dell’ipertrofia è data dallo
spessore parietale massimo, particolarmente rilevante poiché quando è
particolarmente aumentato (>= 30 mm) rappresenta un fattore di rischio per morte
improvvisa. In circa 1/3 dei pazienti è presente ostruzione al tratto di efflusso del
ventricolo sinistro a riposo. Nei pazienti con sintomi e senza ostruzione a riposo è
indicata l’esecuzione di esercizio fisico con valutazione del gradiente al picco
dell’esercizio; con questo approccio il 70% dei pazienti ha ostruzione.
Con la risonanza magnetica nucleare (RMN) cardiaca è possibile evidenziare tutte le
pareti miocardiche e pertanto quando la caratterizzazione anatomica risulta difficile
con l’eco, vi è indicazione ad eseguirla. Inoltre, con la RMN viene misurata la massa
ventricolare sinistra, non possibile con l’ecocardiogramma per l’eterogenea
distribuzione dell’ipertrofia. La somministrazione di un mezzo di contrasto, il
gadolinio, che si accumula tardivamente nell’interstizio (late-enhancement) consente
di avere un’immagine della distribuzione di fibrosi in questi pazienti.
Vista l’eziologia di questa malattia, dopo aver identificato un probando (primo paziente
identificato in una famiglia) si deve procedere ad uno screening familiare con ECG,
ecocardiogramma e, se disponibile, analisi genetica.
TRATTAMENTO
Dopo aver determinato il profilo di rischio per morte improvvisa, si può individuare
una strategia terapeutica. Ai pazienti con almeno 2 fattori di rischio per morte
improvvisa va consigliato l’impianto di un defibrillatore (ICD). I pazienti con un solo
fattore di rischio costituiscono una zona grigia, e l’impianto di un ICD va valutato caso
per caso.
I pazienti senza fattori di rischio per morte improvvisa ed asintomatici non
richiedono trattamento. I pazienti sintomatici vengono posti in terapia con betabloccanti e/o Ca++-antagonisti non diidropiridinici (verapamil o diltiazem o gallopamil).
La terapia ha la finalità di ridurre i sintomi, ma non ha effetto sulla prognosi.
Se è presente ostruzione al tratto d’efflusso, ai beta-bloccanti si può aggiungere la
disopiramide (un antiaritmico qui usato solo per il suo marcato effetto inotropo
negativo, che contribuisce alla riduzione dell’ostruzione). Se la terapia medica non è
efficace nella riduzione dell’ostruzione, questa può avvalersi di intervento chirurgico
di miotomia-miectomia (asportazione di un cuneo di setto sottoaortico per allargare in
tratto d’efflusso), o dell’ablazione alcoolica (iniezione di etanolo in uno o più rami
perforanti settali in modo da indurre infarto chimico della porzione alta del setto,
sempre allo scopo di allargare in tratto d’efflusso).
I pazienti che hanno fibrillazione atriale persistente o cronica debbono essere
riportati in ritmo sinusale: ciò non è sempre possibile, ma è importante tentare il
ripristino del ritmo sinusale finché è ragionevole. Il ripristino del ritmo sinusale si
ottiene mediante cardioversione elettrica o farmacologica. La prevenzione delle
recidive di fibrillazione atriale è usualmente ottenuta con l’uso di amiodarone. In caso
di fibrillazione atriale parossistica o persistente o cronica, per l’anticoagulazione si
applicano le linee guida usuali.
CARDIOMIOPATIA DILATATIVA
La cardiomiopatia dilatativa (CMPD) viene definita come “Malattia del Muscolo
Cardiaco caratterizzata da dilatazione e ridotta contrattilità del ventricolo sinistro o
di entrambi i ventricoli” e rappresenta – assieme alle forme ipertrofica, restrittiva ed
alla displasia aritmogena del ventricolo destro – uno dei quattro sottotipi principali di
Cardiomiopatia.
EPIDEMIOLOGIA
La prevalenza della CMPD nella popolazione generale è stimata essere di circa 1 caso
ogni 2.500 abitanti e l’incidenza pari a 4-8 nuovi casi/100.000 individui/anno. Tuttavia,
la sua reale frequenza è certamente superiore, considerando che la maggior parte dei
soggetti ancora asintomatici ma già con le “stimmate” della malattia (dilatazione e
disfunzione ventricolare sinistra) non vengono identificati sino a che non compaiono i
primi sintomi e segni riferibili a scompenso cardiaco o a turbe del ritmo e della
conduzione.
ANATOMIA PATOLOGICA
Il fondamentale reperto anatomo-patologico macroscopico della CMPD è
rappresentato dalla più o meno cospicua dilatazione di una od entrambe le camere
ventricolari; anche gli atri, specialmente nelle fasi avanzate della malattia, sono
dilatati (
La progressiva dilatazione delle camere cardiache associata all’insufficienza
contrattile del miocardio comportano fenomeni di stasi che facilitano la formazione di
trombi endocavitari, di riscontro non infrequente in sede autoptica e documentabili
prevalentemente a carico delle sezioni cardiache di sinistra.
La dilatazione delle camere cardiache e l’ipocinesia delle loro pareti frequentemente
concorrono anche a determinare l’allargamento degli osti atrio-ventricolari e lo
stiramento delle corde tendinee da diastasi dei muscoli papillari, con conseguente
insufficienza valvolare “funzionale” mitralica e/o tricuspidale.
Per definizione, il circolo coronarico appare angiograficamente indenne o privo di
stenosi “critiche” a carico dei grossi vasi epicardici.
Il reperto isto-morfologico è aspecifico, le alterazioni principali essendo
rappresentate da degenerazione miocellulare e diminuzione del numero delle
miocellule, ipertrofia dei miociti residui, fibrosi sostitutiva ed interstiziale, infiltrati
flogistici di tipo linfo-istiocitario in genere sparsi e presenti nell’interstizio.
EZIOPATOGENESI
Accanto ai casi “idiopatici” di CMPD, ve ne sono altri per i quali è possibile identificare
con precisione la causa. Come per le altre forme di cardiomiopatia, anche per la CMPD
i maggiori progressi in termini di conoscenze eziopatogenetiche riguardano il campo
della genetica. A differenza di quanto si riteneva in passato, le forme familiari di
CMPD sono piuttosto frequenti (circa 1/3 dei casi). Le diverse modalità di
trasmissione ereditaria (autosomica dominante, autosomica recessiva, legata al
cromosoma X) e di presentazione clinica (in relazione al grado di penetranza, all’età di
insorgenza, all’interessamento isolato o meno del miocardio, ecc) della CMPD familiare
indicano l’esistenza di una marcata eterogeneità genotipica e fenotipica. L’analisi del
tipo di trasmissione genetica, del fenotipo e, quando disponibili, dei dati di genetica
molecolare ha importanza non solo conoscitiva ma anche clinica perché le differenti
forme possono non solo avere differente quadro clinico ma anche differente prognosi
e differente rischio di malattia per i familiari.
Fattori infettivi/immunitari potrebbero rivestire un ruolo importante nel
determinismo della CMPD, anche se i meccanismi con cui in questo caso si realizza il
danno miocardico non sono del tutto chiariti. I virus possono indurre un effetto
citolitico diretto correlato alla loro virulenza come pure attivare una reazione
autoimmune secondaria a “mimetismo” molecolare tra epitopi virali e costituenti
normali del miocardio ad essi simili.
QUADRO CLINICO
La CMPD può manifestarsi in pazienti di tutte le età, ma nella maggior parte dei casi
l’esordio avviene tra i 20 ed i 50 anni. La malattia colpisce prevalentemente il sesso
maschile, con un rapporto maschi/femmine di circa 3:1.
Dal punto di vista clinico, la CMPD si manifesta più frequentemente con scompenso
cardiaco od aritmie ventricolari o sopraventricolari. In oltre il 50% dei pazienti, la
presentazione clinica è rappresentata da un quadro di scompenso cardiaco sinistro; in
una minore percentuale di casi, possono essere prevalenti i segni di scompenso destro.
Le aritmie sono un’evenienza frequente nella CMPD e non di rado costituiscono le
prime manifestazioni cliniche; tuttavia, solo raramente sincope e morte improvvisa
rappresentano l’esordio della malattia.
Un dolore toracico, per lo più da sforzo e talora con le caratteristiche di un’angina,
rappresenta il sintomo principale d’esordio della CMPD nel 10-20% dei casi; in questi
pazienti, è stata dimostrata una minore riserva coronarica.
Nel 2-4% dei casi, usualmente con avanzata compromissione della funzione
ventricolare e marcata cardiomegalia, la manifestazione clinica iniziale è costituita da
un episodio embolico sistemico o polmonare.
Talvolta, il sospetto di CMPD viene posto a paziente asintomatico. Si tratta di casi
scoperti fortuitamente in occasione di una visita medica (ad esempio, per riscontro di
un soffio cardiaco) o di un’indagine strumentale (ad esempio, per il riscontro di blocco
di branca sinistra all’elettrocardiogramma o di cardiomegalia alla radiografia del
torace) effettuate per altri motivi.
PROGNOSI
la prognosi della CMPD è caratterizzata da una elevata mortalità (all’inizio degli anni
’80 era stimata essere del 50% a 2 anni dalla diagnosi), risultando in linea di massima
tanto peggiore quanto maggiori sono le alterazioni morfo-funzionali a carico del
ventricolo sinistro (marcata dilatazione, bassa frazione di eiezione) e quanto più
severi sono i sintomi (avanzata classe NYHA). Studi recenti hanno tuttavia dimostrato
che una diagnosi precoce ed un altrettanto precoce impiego di farmaci efficaci come
gli ACE-inibitori ed i betabloccanti possono significativamente contribuire a
modificare favorevolmente la storia naturale dei pazienti con CMPD (sopravvivenza
libera da trapianto cardiaco del 60% a 10 anni dalla diagnosi).
CENNI DI TERAPIA
Non sono attualmente disponibili terapie specifiche per la CMPD. Gli obiettivi
principali del trattamento consistono nel limitare la progressione dello scompenso
cardiaco e nel controllare le aritmie. Tra le misure generali sono incluse l’educazione
del paziente, la restrizione dell’apporto di sale e fluidi con la dieta con limitazione
dell’introito alcolico, il controllo del peso corporeo e l’esecuzione di un moderato
esercizio fisico aerobico.
Terapia medica. La terapia medica si avvale degli agenti farmacologici comunemente
impiegati nel trattamento del modello dilatativo-ipocinetico di scompenso cardiaco.
Fra questi, i più importanti sono gli ACE-inibitori, gli antagonisti recettoriali
dell’angiotensina (sartani), i betabloccanti, i diuretici tiazidici e/o dell’ansa, gli
antagonisti recettoriali dell’aldosterone.
Gli ACE-inibitori ed i betabloccanti sono efficaci nei pazienti con scompenso cardiaco
da lieve a severo (NYHA II-IV); gli ACE-inibitori lo sono anche in quelli con
disfunzione ventricolare ancora in fase asintomatica (classe NYHA I). Nei casi in cui
vi sia intolleranza agli ACE-inibitori, appare giustificato l’impiego dei sartani.
I diuretici tiazidici e/o dell’ansa vanno impiegati con l’obiettivo di controllare il
fenomeno della ritenzione idro-salina, modulando le dosi in funzione del grado di
congestione polmonare e periferica. Gli antagonisti recettoriali dell’aldosterone sono
indicati solo nello scompenso cardiaco moderato-severo.
La digitale è utile per il controllo della frequenza ventricolare nei pazienti con
fibrillazione atriale e in quelli in ritmo sinusale con scompenso persistente nonostante
la terapia con antagonisti neuro-ormonali e diuretici.
Nelle fasi avanzate della malattia possono essere impiegati farmaci inotropi per via
endovenosa, particolarmente la dobutamina (farmaco simpaticomimetico con effetto
predominante beta1-agonista) o gli inibitori delle fosfodiesterasi (amrinone, milrinone
ed enoximone) che sono allo stesso tempo inotropi e vasodilatatori. Dati recenti
suggeriscono l’efficacia del levosimendan, un farmaco sensibilizzatore al calcio con
proprietà anche di vasodilatazione.
Il trattamento anticoagulante, volto a prevenire l’embolia polmonare o sistemica, viene
raccomandato nei pazienti con fibrillazione atriale o in quelli a ritmo sinusale ma con
trombosi endocavitaria e/o pregressa embolia, e anche nei soggetti con marcata
dilatazione ventricolare e frazione di eiezione < 20-25%.
Terapia meccanica. L’impiego di “device” meccanici nel trattamento dei pazienti con
CMPD, sia per quanto riguarda la prevenzione della morte improvvisa (defibrillatore
impiantabile) che per il ripristino della sincronia della contrazione cardiaca (terapia di
resincronizzazione cardiaca mediante pace-maker biventricolare), trova indicazione in
selezionati sottogruppi di pazienti.
Assistenza ventricolare meccanica e cardiochirurgia. Sono state proposte procedure
chirurgiche complementari alla sostituzione cardiaca, nell’ottica di “ponte al trapianto”
od a questo alternative. In pazienti selezionati, è possibile limitare la progressione
della malattia correggendo l’insufficienza mitralica mediante valvuloanuloplastica.
Nel corso di episodi di severa riacutizzazione della malattia oppure nei pazienti in
attesa di trapianto, giunti allo stadio terminale dello scompenso cardiaco, è possibile
utilizzare dispositivi meccanici che sostituiscono temporaneamente la funzione di
pompa del cuore (assistenza ventricolare meccanica). L’assistenza ventricolare
meccanica consente il ripristino di un’emodinamica normale e di una perfusione
tissutale adeguata sostituendo la funzione di pompa del cuore con dispositivi
meccanici di vario tipo. Sono in corso di valutazione nuove prospettive per
un’assistenza meccanica a lungo termine potenzialmente alternativa alla sostituzione
cardiaca.
Trapianto cardiaco. La sostituzione cardiaca con organo di un donatore compatibile
rimane allo stato attuale la soluzione più efficace per i pazienti con scompenso
cardiaco severo, refrattario ad ogni forma di terapia medica (vedi Capitolo 66). La
sopravvivenza ad 1 anno, 5 anni e 10 anni si è attestata rispettivamente intorno all’80,
68 e 56%. Il problema maggiore è costituito dalla carenza di donazioni.
CARDIOPATIA RESTRITTIVA
Le cardiomiopatie restrittive (CMPR) sono un gruppo eterogeneo di malattie del
muscolo cardiaco accomunate dal fatto che il ventricolo sinistro (o, più di rado,
entrambi i ventricoli) presenta(no) un pattern di riempimento diastolico di tipo
restrittivo con volume diastolico generalmente ridotto, pareti incostantemente
aumentate di spessore e funzione sistolica normale o modicamente ridotta.
L’espressione “pattern restrittivo” indica che durante la diastole vi è un ostacolo al
riempimento del ventricolo, il quale non riesce ad accogliere il sangue perché le sue
pareti sono rigide e poco distensibili. Di conseguenza, la pressione diastolica
ventricolare aumenta e tale incremento si riflette a monte per cui si manifesta
ipertensione anche nell’atrio, nelle vene tributarie dell’atrio, nei capillari, ecc.
Il termine CMPR deve essere riservato esclusivamente a quelle patologie cardiache in
cui il pattern restrittivo costituisce l’elemento caratterizzante il quadro
fisiopatologico.
EZIOPATOGENESI ED ANATOMIA PATOLOGICA
Esistono forme primitive e secondarie di CMPR. Tra le prime vanno incluse la
cosiddetta CMPR idiopatica (talvolta familiare con trasmissione di tipo autosomico
dominante), la sindrome di Löffler e la fibrosi endomiocardica. Le forme secondarie
comprendono le CMPR infiltrative (amiloidosi, sarcoidosi, ecc) e quelle da accumulo
(emocromatosi, ecc).
Ognuna di queste condizioni presenta specifici quadri istopatologici. Tuttavia, in linea
generale, il reperto macroscopico è quello di un cuore con atri marcatamente dilatati e
spesso sede di trombi, mentre i ventricoli appaiono grossolanamente normali.
QUADRO CLINICO
Nella maggior parte dei casi, le prime manifestazioni cliniche sono rappresentate da
sintomi e segni di scompenso cardiaco quali ridotta tolleranza allo sforzo, astenia,
dispnea da sforzo, dispnea parossistica notturna ed ortopnea, edemi declivi ed ascite.
La comparsa di fibrillazione atriale è un evento frequente nei soggetti con forme
idiopatiche o secondarie ad amiloidosi; circa un terzo dei pazienti può presentare
episodi tromboembolici. Nonostante la relativamente bassa frequenza di aritmie
minacciose (blocco atrio-ventricolare di III grado o tachicardia ventricolare), la
morte improvvisa rappresenta comunque un evento possibile.
L’esame obiettivo consente di rilevare valori di pressione arteriosa normali o ridotti
con tendenza all’ipotensione ortostatica in una significativa percentuale di pazienti. E’
spesso presente tachicardia a riposo. Il I ed il II tono sono in genere normali, ma si
ascoltano spesso un III e/o un IV tono. E’ possibile rilevare un soffio olosistolico da
rigurgito mitralico o tricuspidale. Particolarmente nelle fasi avanzate, il fegato si
presenta aumentato di volume e le vene giugulari sono distese.
DATI DI LABORATORIO E STRUMENTALI
In generale, nelle CMPR idiopatiche non sono presenti significative alterazioni dei
parametri ematochimici. Il riscontro di indici di flogosi alterati e di ipereosinofilia
orienta verso un’endocardite di Löffler. Nelle forme da amiloidosi possono essere
presenti diverse alterazioni quali anemia, leucocitosi, elevazione della velocità di
eritrosedimentazione e della proteina C-reattiva, ipofibrinogenemia, iposideremia,
monoclonalità all’immunoelettroforesi proteica o segni di compromissione della
funzione renale ed epatica.
La radiografia del torace può mettere in evidenza un aumento delle dimensioni
dell’ombra cardiaca, segni di congestione interstiziale od alveolare e versamento
pleurico.
Le possibili anomalie elettrocardiografiche includono i bassi voltaggi dei complessi
QRS nelle derivazioni periferiche, le onde Q di “pseudonecrosi” nelle derivazioni
antero-settali, il sottolivellamento del tratto ST; sono frequentemente descritti
anche segni di ingrandimento atriale di ipertrofia ventricolare sinistra ed aritmie di
vario tipo. Nei pazienti con amiloidosi, le alterazioni del sistema di conduzione non
sembrano particolarmente frequenti, mentre in quelli con CMPR idiopatica sono spesso
documentabili blocchi atrio-ventricolari ed intra-ventricolari.
L’ecocardiogramma è l’indagine diagnostica cardine, mediante la quale è possibile
evidenziare un ventricolo sinistro non ingrandito, con spessori parietali normali o solo
lievemente aumentati e con funzione di pompa normale o quasi. L’ispessimento e
l’aspetto granulare delle pareti del ventricolo sinistro ed in particolare del setto
interventricolare (“a vetro smerigliato”) è caratteristico delle forme amiloidosiche. Il
ventricolo destro può presentarsi dilatato, specie nei casi con ipertensione polmonare.
E’ pressoché costantemente documentabile una dilatazione biatriale. Le valvole atrioventricolari appaiono frequentemente ispessite, e spesso si associa un rigurgito
mitralico e/o tricuspidale. Lo studio del riempimento ventricolare sinistro mediante
analisi Doppler del flusso a livello della valvola mitrale documenta un pattern di tipo
“restrittivo” . L’ecocardiogramma transesofageo può essere utile per ricercare in
modo più accurato l’eventuale presenza di trombi endocavitari.
Sebbene l’integrazione degli dati ottenibili dalla valutazione clinica e dagli esami
strumentali non invasivi consenta nella maggior parte dei casi di porre correttamente
la diagnosi, il cateterismo cardiaco e la biopsia endomiocardica conservano un ruolo
importante nello studio della CMPR.
In corso di cateterismo cardiaco, l’aspetto emodinamico caratteristico è il “segno
della radice quadrata” (“dip and plateau”), che si apprezza nella curva della pressione
protodiastolica ventricolare ed è dovuto ad una ripida discesa della pressione
ventricolare all’inizio della diastole seguita da un brusco incremento e da un plateau in
protodiastole. La pressione sistolica e la pressione di riempimento ventricolare destro
possono essere elevate. Le pressioni di riempimento nelle sezioni di sinistra sono
usualmente maggiori di 5 mmHg rispetto alle sezioni di destra, e la pressione capillare
polmonare (“pressione di incuneamento”) è in genere elevata.
La biopsia endomiocardica è particolarmente utile nella differenziazione istologica,
immunoistichimica ed ultrastrutturale delle diverse CMPR.
Nelle forme idiopatiche, i reperti sono sostanzialmente aspecifici con ipertrofia
cellulare e fibrosi interstiziale in assenza, tranne che per quel che riguarda la
sindrome di Loffler, di infiltrati cellulari.
La presenza di amiloide nel miocardio è confermata dalla positività per il rosso Congo,
che conferisce al tessuto una tipica birifrangenza all’esame con luce polarizzata.
L’indagine immunoistochimica consente di differenziare i vari tipi di amiloide (catene
leggere immunoglobuliniche in corso di mieloma, transitiretina, lisozima, beta2
microglobulina, fattori natriuretici).
La biopsia endomiocardica consente inoltre di definire la causa di altre forme meno
frequenti di CMPR da accumulo miocardico. L’accumulo di ferro intramiocardico è
facilmente evidenziabile con la colorazione di Pearls; nella sindrome di Löffler, la
biopsia endomiocardica evidenzia un quadro di marcata infiltrazione eosinofila
dell’endocardio e del miocardio; nella fibrosi endomiocardica è dimostrabile la
presenza di ampie deposizioni di tessuto collageno e di connettivo che interessano
l’endocardio, il subendocardio ed il miocardio.
Studi scintigrafici mirati o metodiche di risonanza magnetica cardiaca con gadolinio
possono contribuire alla diagnosi e caratterizzazione di alcune di queste forme
DIAGNOSI DIFFERENZIALE
La CMPR presenta spesso aspetti clinici indistinguibili dalla pericardite costrittiva, con
problemi di diagnosi differenziale difficili da risolvere (vedi Capitolo 32). Una storia di
pericardite acuta, pregressa infezione tubercolare, trauma toracico, intervento
cardiochirurgico o terapia radiante del mediastino può orientare verso la diagnosi di
pericardite costrittiva. All’indagine invasiva, il rilievo di una pressione telediastolica del
ventricolo sinistro inferiore di almeno 5 mmHg rispetto alla pressione telediastolica del
ventricolo destro, di una pressione sistolica del ventricolo destro
50 mmHg ed di un
rapporto pressione telediastolica/pressione sistolica del ventricolo destro
0.33 orienta
verso una pericardite costrittiva.
La tomografia computerizzata e la risonanza magnetica sono in grado di fornire
informazioni più complete su eventuali alterazioni del pericardio e sulla struttura della
parete miocardica. Anche la biopsia endomiocardica può essere di ausilio nella
differenziazione della CMPR dalla pericardite costrittiva, particolarmente nei casi in cui è
possibile riscontare un’infiltrazione miocardica.
CENNI DI TERAPIA
In generale, la terapia farmacologica delle CMPR si avvale dei diuretici per una terapia
sintomatica della congestione secondaria allo scompenso cardiaco diastolico. Il dosaggio dei
diuretici deve essere stabilito con cautela, per evitare una sindrome da bassa portata
conseguente ad eccessiva riduzione del precarico. Nei pazienti affetti da amiloidosi
cardiaca devono essere evitati la digitale e i calcio-antagonisti in quanto questi farmaci
possono causare fenomeni tossici anche con dosaggi generalmente ritenuti terapeutici.
In caso di fibrillazione atriale, è necessario tentare di ristabilire il ritmo sinusale perché
l’assenza del contributo atriale al riempimento ventricolare comporta un sostanziale
peggioramento della disfunzione diastolica. A questo scopo, sono indicati sia la
cardioversione elettrica che quella farmacologica mediante l’impiego di agenti antiaritmici,
in particolare l’amiodarone. In casi di difetti di conduzione atrio-ventricolare di grado
avanzato può rendersi necessario l’impianto di un pace-maker.
Il trattamento anticoagulante orale appare indicato nei pazienti con rischio
tromboembolico, in particolare in quelli con riscontro ecocardiografico di trombi
endocavitari, marcata dilatazione atriale, episodi ricorrenti di fibrillazione atriale
parossistica o fibrillazione atriale cronica.
Non esiste al momento la possibilità di migliorare l’evoluzione delle forme idiopatiche con
trattamenti farmacologici specifici e, nelle fasi avanzate, il trapianto cardiaco rappresenta
l’unica valida opzione terapeutica.
PERICARDITI
DEFINIZIONE
Si tratta di affezioni acute o croniche interessanti il foglietto parietale e viscerale
del pericardio, la cui eziologia può essere infettiva, infiammatoria, neoplastica,
immunitaria. Tra le malattie del pericardio possono essere enucleate le forme
seguenti :
Pericarditi acute e subacute
Pericardite cronica essudativa
Tamponamento cardiaco
Pericardite cronica costrittiva
PERICARDITI ACUTE E SUBACUTE
P
Sono processi infiammatori del pericardio a decorso acuto o subacuto,
distinguibili in forme fibrinose, caratterizzate da abbondante formazione di
fibrina e scarso versamento, e forme essudative, caratterizzate da formazione
di versamento.
Eziologia
Il pericardio può essere interessato da infezioni virali, batteriche, micotiche o
tubercolari; le forme virali sono di gran lunga le più frequenti (virus Coxackie A
e B, echovirus, virus parotitico, citomegalovirus, herpes simplex, varicella,
adenovirus, epstein barr e virus influenzali).
Una pericardite acuta si può anche sviluppare come conseguenza dell’invasione
diretta del pericardio da parte di una neoplasia di organi adiacenti (neoplasie
polmonari, della mammella o linfomi). Altre condizioni morbose come patologie
metaboliche (uremia o mixedema) e le collagenopatie (lupus eritematoso
sistemico, sclerodermia, artrite reumatoide, dermatomiosite, poliartrite
nodosa) possono interessare il pericardio. Sono state segnalate pericarditi da
farmaci (Isoniazide, Procainamide, Idralazina e Antracicline), su base
verosimilmente immunitaria. L’infarto miocardico acuto può essere complicato
dalla pericardite epistenocardica (II-IV giornata) o dalla sindrome di Dressler,
pericardite autoimmune ad insorgenza più tardiva. Altre forme di infiammazione
asettica del pericardio sono le post-pericardiotomiche, che si osservano dopo
interventi cardiochirurgici.
Tra le patologie pericardiche sono incluse anche forme caratterizzate da
raccolta di liquido di tipo trasudatizio, come accade nello scompenso cardiaco e
nella sindrome nefrosica. Nel pericardio si può formare una raccolta ematica
(emopericardio) se si verifica rottura di strutture vascolari o cardiache. Anche
la terapia radiante ad alte dosi può essere associata a interessamento
pericardico, quando le radiazioni siano dirette sul mediastino.
Fisiopatologia
Normalmente la cavità pericardica contiene 25-50 ml di liquido sieroso, ed al
suo interno vige una pressione negativa. Quando un agente patogeno di tipo
chimico, fisico, batterico o virale lede l’integrità funzionale dei foglietti
pericardici, la quantità di liquido aumenta. Il liquido pericardico può essere
sieroso, siero-fibrinoso, ematico, purulento, colesterolico, chiloso .
Il versamento pericardico può essere di tipo trasudativo o essudativo. Il
trasudato presenta bassa densità, basso contenuto proteico, e scarse cellule
mesoteliali, mentre l’ essudato è più denso, contiene maggior quantità di
proteine e numerose cellule infiammatorie e mesoteliali. Con la formazione del
versamento, la pressione intrapericardica aumenta, cosicché viene limitato il
rilasciamento delle camere cardiache, aumentano le pressioni di riempimento
ventricolare, ed è ostacolato il ritorno venoso. La pressione intrapericardica
dipende dalla quantità di liquido e dalla sua rapidità di formazione. Se il
versamento pericardico si forma lentamente, senza che si realizzi un
tamponamento cardiaco, la pressione intrapericardica subisce solo un modesto
incremento, e la gittata sistolica, la portata cardiaca, e la pressione arteriosa
sono mantenute nei limiti della norma. Solo se la pressione intrapericardica
aumenta ulteriormente, il riempimento diastolico e la gittata sistolica
diminuiscono. In questa situazione la portata cardiaca è mantenuta entro limiti
normali dall’aumento della frequenza cardiaca.
Quadro clinico
Il quadro clinico è condizionato dalla gravità del processo infiammatorio, dalla
quantità di liquido e dalla velocità con cui questo si accumula. In genere, dopo
due–tre settimane da un episodio di tipo influenzale, compaiono i sintomi della
pericardite acuta. Il dolore precordiale è uno dei sintomi più caratteristici:
presenta irradiazione verso il collo, verso il margine del muscolo trapezio e
verso la spalla sinistra; talvolta può avere localizzazione epigastrica tanto da
simulare un addome acuto. La sua intensità può variare, esacerbandosi con l’
inspirazione, la posizione supina, la tosse, la deglutizione, mentre si riduce in
alcune posizioni antalgiche (la posizione seduta o quella genupetturale oppure
flettendo il torace in avanti). Il dolore ha di solito durata protratta (giorni), e
si riduce o scompare quando compare il versamento.
Esame obiettivo
Gli sfregamenti pericardici sono i segni più caratteristici della pericardite
acuta: essi originano dall’attrito tra i foglietti pericardici, resi scabri dalla
deposizione di fibrina. I rumori da sfregamento sono solitamente variabili,
transitori e, quando presenti, consentono di porre diagnosi sicura di
pericardite; possono accentuarsi con la compressione esercitata dal
fonendoscopio oppure facendo inclinare in avanti il paziente .
Indagini di laboratorio
Sono spesso presenti segni aspecifici di flogosi quali leucocitosi, elevazione
della PCR, rialzo della VES. I reperti di laboratorio possono essere utili per la
diagnosi di pericardite uremica (azotemia e creatininemia) o per la diagnosi di
mixedema (FT3, FT4, TSH). Si può a volte riscontrare una fluttuazione del
titolo anticorpale contro il virus responsabile. L’intradermoreazione alla
tubercolina è utile nella diagnosi di pericardite tubercolare. La determinazione
del titolo degli anticorpi antinucleo e del fattore reumatoide va eseguita nel
caso si sospetti una malattia autoimmune. L’esame del liquido prelevato con la
pericardiocentesi (reazione di Rivalta) può essere molto indicativo: si tratta di
un trasudato nelle sindromi edemigene, di un essudato nelle forme infettive, di
un liquido emorragico in caso di neoplasie, tubercolosi, sindrome di Dressler.
Esami strumentali
Elettrocardiogramma: nella pericardite acuta l’ECG mostra sopralivellamento
del tratto ST, generalmente a concavità superiore, nelle derivazioni con QRS
positivo; le onde T appaiono alte ed appuntite e il PR può risultare
sottoslivellato Successivamente il sopralivellamento di ST regredisce, e l’onda T
diventa negativa e simmetrica. Segno fondamentale per la diagnosi
differenziale elettrocardiografica con le alterazioni in corso di infarto
miocardico è l’assenza di onde q di necrosi. Quando la pericardite si accompagna
ad abbondante versamento pericardico si verifica riduzione di voltaggio di tutte
le onde dell’ECG, e a volte alternanza elettrica (vedi Capitolo 3).
Esame radiologico: le pericarditi acute prevalentemente fibrinose, con scarso
versamento, non sono evidenziabili utilizzando i metodi radiografici tradizionali
standard. L’RX del torace può essere utile solo se la raccolta di liquido è
superiore a 200-250 ml: in questa situazione l’ ombra cardiaca perde la normale
configurazione ed assume aspetto a “fiasca” .
Ecocardiogramma: è l’esame più specifico e sensibile in presenza di versamento
pericardico (vedi Capitolo 4). L’Ecocardiogramma monodimensionale mostra uno
spazio ecoprivo compreso tra il pericardio posteriore e la parete posteriore del
ventricolo sinistro; a volte, in caso di versamenti maggiori, è presente uno
spazio analogo tra il pericardio parietale anteriore e la parete anteriore del
ventricolo destro. L’indagine bidimensionale permette di visualizzare in modo
più completo il pericardio
Risonanza magnetica nucleare: la RMN cardiaca fornisce precisi dati anatomici
sullo stato del pericardio, permettendo una miglior evidenziazione dei recessi
pericardici superiori e dei versamenti posteriori, spesso misconosciuti.
Diagnosi differenziale
Il quadro può essere confuso con quello dell’ infarto miocardico acuto per il
dolore precordiale e per la presenza di alterazioni elettrocardiografiche. Gli
sfregamenti pericardici, i reperti ecocardiografici, l’assenza di aumento nel
siero dei marker di necrosi miocardica (vedi Capitolo 24) permettono di
dirimere il dubbio.
Complicanze
Si dividono in precoci (recidive precoci e miocarditi) e tardive (recidive tardive
e pericardite costrittiva). La più importante complicanza dei versamenti
pericardici è il tamponamento cardiaco (vedi più avanti).
PERICARDITE CRONICA ESSUDATIVA
Si diagnostica in presenza di versamento pericardico persistente da almeno sei
mesi. Tutti i processi infettivi cronici, le collagenopatie, le malattie
metaboliche, lo scompenso cardiaco congestizio, i tumori pericardici possono
provocare versamenti pericardici ad andamento cronico.
Quadro clinico
I pazienti possono essere asintomatici o paucisintomatici dal punto di vista
cardiaco, pur presentando versamento pericardico all’ ecocardiogramma. I
principali sintomi consistono in ridotta tolleranza all’esercizio fisico e nella
dispnea da sforzo. Versamenti massivi possono accompagnarsi a sintomi come
tosse, disfagia, disfonia dovuti alla compressione delle strutture mediastiniche.
All’ascoltazione cardiaca i toni risultano ovattati e si possono apprezzare a
volte sfregamenti pericardici . Il decorso clinico della pericardite cronica
essudativa dipende prevalentemente dalla malattia di base e dalla presenza di
cardiopatia sottostante. E’ possibile l’evoluzione verso la forma costrittiva .
Diagnosi
L’ ecocardiogramma è l’esame di scelta per la diagnosi di pericardite cronica
essudativa. L’elettrocardiogramma può essere normale, ma spesso evidenzia
QRS di basso voltaggio e alterazioni aspecifiche della ripolarizzazione. Il
radiogramma del torace può evidenziare aumento dell’ ombra cardiaca.
TAMPONAMENTO CARDIACO
E’ una sindrome caratterizzata da segni e sintomi di bassa portata associati ad
ipertensione venosa, che si verifica quando il versamento comporta un aumento della
pressione intrapericardica tale da produrre una grave limitazione del riempimento del
cuore in diastole.
Eziologia:
Le cause più frequenti sono:
pericardite acuta o recidiva
sanguinamento nello spazio pericardico per interventi cardiochirurgici, cateterismo cardiaco,
impianto di pacemaker, traumi toracici, complicanze della terapia trombolitica e anticoagulante;
rottura del cuore o di aneurismi disseccanti dell’ aorta nel sacco pericardico;
versamento pericardico di origine tubercolare o neoplastica
Fisiopatologia
Il tamponamento cardiaco si sviluppa quando la quantità di liquido che si raccoglie
supera la capacità di distensione del pericardio. Ne consegue aumento della pressione
intrapericardica cui fa seguito progressiva riduzione del rilasciamento diastolico fino
all’adiastolia (uguaglianza delle pressioni diastoliche in ventricolo sinistro, atrio
sinistro, capillari polmonari e sezioni destre), compressione del cuore e limitazione
dell’ afflusso di sangue ai ventricoli. Fattori determinanti sono la distensibilità del
sacco pericardico, la rapidità con cui si forma il versamento, la compliance diastolica
dei ventricoli e la volemia: anche modeste quantità di liquido (per esempio, 150 ml)
formatesi rapidamente possono determinare tale complicanza.
Le principali conseguenze fisiopatologiche del tamponamento sono:
1) Riduzione della gittata sistolica a causa del ridotto riempimento ventricolare
durante la diastole.
2) Aumento della pressione venosa centrale: l’ostacolato svuotamento atriale
incrementa la venosa pressione a monte degli atri.
Intervengono, inoltre, meccanismi di compenso che conseguono all’aumentato tono
adrenergico: tachicardia e vasocostrizione periferica. L’aumentata frequenza cardiaca
cerca di opporsi alla riduzione della portata, e l’incremento delle resistenze
periferiche tende a mantenere la pressione arteriosa nella norma. Quando i
meccanismi di riserva cardiaca non sono più efficaci e la perfusione tessutale tende a
ridursi, si verifica un vero e proprio stato di shock cardiogeno (vedi Capitolo 22).
Quadro clinico
E’ dominato dalla bassa portata cardiaca, dalla ipotensione e dai segni di elevata
pressione venosa, con obiettività cardiaca muta. E’ una condizione di urgenza, da
risolversi rapidamente con la rimozione del liquido (pericardiocentesi). Il paziente
appare sofferente, con obnubilamento del sensorio, stato ansioso, sudorazione fredda,
pallore, oliguria. E’ presente tachicardia, all’ascoltazione i toni cardiaci risultano
ovattati, la pressione sistolica è ridotta, il polso arterioso è frequente e “piccolo”, e
può comparire il polso paradosso, cioè l’accentuazione della fisiologica riduzione di
ampiezza del polso e della pressione arteriosa durante l’inspirazione (vedi Capitolo 2
).
Esami strumentali
L’elettrocardiogramma mostra tachicardia sinusale e bassi voltaggi dei QRS.
L’ecocardiogramma evidenzia un versamento pericardico abbondante, sia in sede
anteriore che posteriore, e numerosi altri segni fra cui un collasso diastolico della
parete libera del ventricolo destro: la riduzione del diametro telediastolico del
ventricolo destro al di sotto di 7 mm è un segno molto indicativo di tamponamento
cardiaco.
TAMPONAMENTO CARDIACO
E’ una sindrome caratterizzata da segni e sintomi di bassa portata associati ad
ipertensione venosa, che si verifica quando il versamento comporta un aumento della
pressione intrapericardica tale da produrre una grave limitazione del riempimento del
cuore in diastole.
Eziologia:
Le cause più frequenti sono:
pericardite acuta o recidiva
sanguinamento nello spazio pericardico per interventi cardiochirurgici, cateterismo cardiaco,
impianto di pacemaker, traumi toracici, complicanze della terapia trombolitica e anticoagulante;
rottura del cuore o di aneurismi disseccanti dell’ aorta nel sacco pericardico;
versamento pericardico di origine tubercolare o neoplastica
Fisiopatologia
Il tamponamento cardiaco si sviluppa quando la quantità di liquido che si raccoglie
supera la capacità di distensione del pericardio. Ne consegue aumento della pressione
intrapericardica cui fa seguito progressiva riduzione del rilasciamento diastolico fino
all’adiastolia (uguaglianza delle pressioni diastoliche in ventricolo sinistro, atrio
sinistro, capillari polmonari e sezioni destre), compressione del cuore e limitazione
dell’ afflusso di sangue ai ventricoli. Fattori determinanti sono la distensibilità del
sacco pericardico, la rapidità con cui si forma il versamento, la compliance diastolica
dei ventricoli e la volemia: anche modeste quantità di liquido (per esempio, 150 ml)
formatesi rapidamente possono determinare tale complicanza.
Le principali conseguenze fisiopatologiche del tamponamento sono:
1) Riduzione della gittata sistolica a causa del ridotto riempimento ventricolare
durante la diastole.
2) Aumento della pressione venosa centrale: l’ostacolato svuotamento atriale
incrementa la venosa pressione a monte degli atri.
Intervengono, inoltre, meccanismi di compenso che conseguono all’aumentato tono
adrenergico: tachicardia e vasocostrizione periferica. L’aumentata frequenza cardiaca
cerca di opporsi alla riduzione della portata, e l’incremento delle resistenze
periferiche tende a mantenere la pressione arteriosa nella norma. Quando i
meccanismi di riserva cardiaca non sono più efficaci e la perfusione tessutale tende a
ridursi, si verifica un vero e proprio stato di shock cardiogeno (vedi Capitolo 22).
Quadro clinico
E’ dominato dalla bassa portata cardiaca, dalla ipotensione e dai segni di elevata
pressione venosa, con obiettività cardiaca muta. E’ una condizione di urgenza, da
risolversi rapidamente con la rimozione del liquido (pericardiocentesi). Il paziente
appare sofferente, con obnubilamento del sensorio, stato ansioso, sudorazione fredda,
pallore, oliguria. E’ presente tachicardia, all’ascoltazione i toni cardiaci risultano
ovattati, la pressione sistolica è ridotta, il polso arterioso è frequente e “piccolo”, e
può comparire il polso paradosso, cioè l’accentuazione della fisiologica riduzione di
ampiezza del polso e della pressione arteriosa durante l’inspirazione (vedi Capitolo 2
).
Esami strumentali
L’elettrocardiogramma mostra tachicardia sinusale e bassi voltaggi dei QRS.
L’ecocardiogramma evidenzia un versamento pericardico abbondante, sia in sede
anteriore che posteriore, e numerosi altri segni fra cui un collasso diastolico della
parete libera del ventricolo destro: la riduzione del diametro telediastolico del
ventricolo destro al di sotto di 7 mm è un segno molto indicativo di tamponamento
cardiaco.
PERICARDITE CRONICA COSTRITTIVA
Affezione che può conseguire a malattie pericardiche acute o croniche,
caratterizzata da un addensamento sclerocicatriziale del pericardio che, riducendo di
molto la compliance del sacco pericardico, interferisce con il normale riempimento
diastolico del cuore.
Eziologia
Una pericardite cronica costrittiva può complicare qualsiasi forma di pericardite
acuta o cronica. Le principali cause di pericardite cronica costrittiva sono : le
pericarditi idiopatiche ed infettive, specie la forma tubercolare, le neoplasie, la
terapia radiante, gli interventi cardiochirurgici e l’emopericardio.
Fisiopatologia
Alcune malattie del pericardio, soprattutto le pericarditi fibrinose o siero fibrinose,
hanno come esito la formazione di tessuto fibroso denso e calcifico. Si forma, perciò,
un involucro rigido che avvolge il cuore e ostacola gravemente il riempimento dei
ventricoli. Gli effetti della costrizione pericardica si manifestano essenzialmente in
fase meso e telediastolica, mentre il riempimento protodiastolico può essere normale.
In protodiastole la pressione ventricolare è bassa, ma subito s’innalza notevolmente
perché l’afflusso del sangue ai ventricoli è limitato dall’astuccio rigido che avvolge il
cuore. La curva pressoria di entrambi i ventricoli, perciò, assume un aspetto a radice
quadrata (dip and plateau) . Il riempimento ventricolare avviene principalmente in
protodiastole, mentre nelle fasi seguenti è ridotto al minimo e la pressione
telediastolica tende ad essere equivalente in tutte le cavità cardiache (> 15-20 mmHg
nelle forme più gravi). Gli effetti della costrizione pericardica sono più marcati a
carico delle sezioni destre. Il meccanismo di Frank Sktarling non è operante, essendo
il volume telediastolico dei ventricoli fisso, mentre le modificazioni della gittata
cardiaca dipendono quasi esclusivamente dalle modificazioni della frequenza cardiaca.
Quadro clinico
La malattia ha un esordio insidioso e può decorrere misconosciuta per molti anni. Il
quadro clinico della pericardite costrittiva simula quello di uno scompenso cardiaco
congestizio, da deficit del ventricolo destro. I sintomi sono la dispnea da sforzo e
l’astenia (da attribuirsi alla riduzione del flusso anterogrado) mentre raramente si
verificano dispnea a riposo e ortopnea. L’astenia è il sintomo prevalente. I toni
cardiaci sono di intensità normale o ridotta, si può a volte ascoltare un tono aggiunto
protodiastolico (pericardial knock), da attribuirsi al brusco impedimento diastolico
dell’espansione ventricolare ad opera della costrizione pericardica). Sono presenti
segni di ipertensione venosa periferica e di congestione viscerale sistemica:
epatosplenomegalia, edemi declivi, ascite, turgore delle giugulari. Può anche essere
presente polso paradosso (vedi Capitolo 2).
Diagnosi
Non sono presenti alterazioni elettrocardiografiche specifiche, ma di solito i
complessi QRS sono di basso voltaggio e le onde P slargate e bifide, a indicare
ingrandimento atriale (vedi Capitolo 3), e nel 20-30 % dei casi si può riscontrare una
fibrillazione atriale cronica. All’RX del torace l’ombra cardiaca appare di normali
dimensioni, ed è frequente il rilievo di calcificazioni pericardiche. All’ecocardiogramma
si nota un ingrandimento atriale con dimensioni ventricolari normali, l’ispessimento del
pericardio, la dilatazione delle vene epatiche e della vena cava inferiore; l’esame
doppler mostra anomalie del riempimento ventricolare. Il cateterismo cardiaco si
rende necessario quando i sintomi e i reperti strumentali non permettono una diagnosi
certa. La TAC e la risonanza magnetica cardiaca vengono considerate il gold standard
per la diagnosi.
Diagnosi differenziale
La pericardite costrittiva va distinta, sulla base dei reperti obiettivi e dei dai
ecocardiografici, dallo scompenso cardiaco congestizio secondario a valvulopatie
acquisite (specie tricuspidali). La diagnosi differenziale con la cardiomiopatia
restrittiva (vedi Capitolo 30) è difficile: l’esame emodinamico è dirimente giacché
nella cardiomiopatia restrittiva la pressione telediastolica è maggiore nelle sezioni
sinistre che in quelle destre, mentre nella pericardite costrittiva tende ad essere
uguale in entrambe le camere ventricolari. La diagnosi differenziale con il cuore
polmonare cronico, la cirrosi epatica e l’ infarto del ventricolo destro è semplice, e si
basa sull’anamnesi, sul quadro clinico ed sui principali esami strumentali.
CENNI DI TERAPIA DELLE PERICARDITI
La terapia delle pericarditi acute e del versamento pericardico dipende dalla loro
eziologia: per esempio, nelle forme uremiche il trattamento necessario è quello
dialitico, nelle forme tubercolari quello specifico con farmaci chemioterapici. Nelle
pericarditi acute virali ed in quelle postpericardiotomiche, l’approccio terapeutico è
dato dai FANS che debbono essere somministrati per lungo tempo (almeno 6 mesi) per
impedire la comparsa di recidive. Anche la terapia corticosteroidea appare efficace
ma aumenta in maniera significativa la frequenza delle recidive entro un anno dalla
risoluzione del versamento. Nelle forme lievi con versamento modesto si consiglia l’
utilizzo dei FANS, mentre nelle forme associate a versamento pericardico importante
si possono utilizzare anche i cortisonici. Nelle forme postinfartuali sono controindicati
i farmaci corticosteroidei, che possono indebolire la formazione della cicatrice
infartuale. Il trattamento del tamponamento cardiaco è costituito dalla rimozione del
liquido pericardico mediante pericardiocentesi oppure drenaggio chirurgico con
creazione della finestra pleuropericardica.
MIOCARDITI
Le miocarditi rappresentano le malattie infiammatorie del tessuto miocardico.
Sebbene abbiano frequentemente una evoluzione benigna, recenti dati autoptici le
hanno chiamate in causa nella genesi della morte improvvisa dei giovani adulti, poiché
in una percentuale compresa tra l’8% e il 12% dei casi l’esame istologico del miocardio
di giovani deceduti improvvisamente ha mostrato i caratteristici aspetti infiammatori.
In ampi studi prospettici, le miocarditi sono state anche implicate nella genesi della
cardiomiopatia dilatativa (vedi Capitolo…) in circa il 10% dei casi.
EZIOLOGIA
I potenziali agenti eziologici delle miocarditi sono molto numerosi . La causa più
frequente è una infezione virale, spesso da enterovirus ed in particolare da virus
Coxsackie del serotipo B. Altri ceppi virali identificati come possibili cause di
miocardite sono gli adenovirus, il virus dell’epatite C (HCV) e il virus
dell’immunodeficienza acquisita (HIV). Anche alcuni batteri, miceti, protozoi e
parassiti possono agire come agenti patogeni.
Numerosi farmaci, tra cui gli antibiotici (sulfonamidi, cefaloslosporine, penicilline), i
diuretici, la digossina, gli antidepressivi triciclici e gli antipsicotici possono indurre
miocardite mediante reazioni da ipersensibilità. Tra le malattie autoimmunitarie,
anche la celiachia può determinare una miocardite.
PATOGENESI
Gran parte delle conoscenze sulla patogenesi delle miocarditi deriva da modelli animali
che hanno identificato tre fasi. Nella prima fase si verifica l’invasione diretta del
miocardio da parte di virus cardiotropi o di altri agenti infettivi. Dopo la risoluzione o
l’attenuazione della infezione virale può insorgere la seconda fase di attivazione
immunologica, nella quale si osserva una espansione clonale di linfociti B, che
determina ulteriore miocitolisi, aggravamento della infiammazione locale e produzione
di anticorpi circolanti anti-muscolo cardiaco. La terza e ultima fase è conseguenza del
danno virale e autoimmunitario, ma può continuare autonomamente dopo l’insulto
iniziale. E’ caratterizzata da infiltrazione miocardica da parte di cellule
infiammatorie, compresi i macrofagi e le Natural Killer, con la conseguente
espressione di citochine pro-infiammatorie come la interleukina-1, la interleukina-2, il
tumor necrosis factor (TNF), e l’interferone- . Il TNF, in particolare, attiva le cellule
endoteliali, recluta ulteriori cellule infiammatorie, incrementa la produzione di
citochine e ha un effetto inotropo negativo diretto.
MANIFESTAZIONI CLINICHE
Le miocarditi si possono presentare con quadri che vanno dalle semplici anomalie
elettrocardiografiche asintomatiche allo shock cardiogeno. I pazienti possono
lamentare sintomi prodromici attribuibili ad una infezione virale, quali febbre, mialgie,
sintomi respiratori o gastroenterici, prima della comparsa di sintomi e segni di
insufficienza cardiaca acuta (vedi Capitolo…). La manifestazione clinica più
drammatica è la dilatazione cardiaca ad insorgenza acuta, con grave disfunzione
sistolica del ventricolo sinistro e rapida insorgenza di scompenso.
Talora la miocardite simula una sindrome coronarica acuta. In questi casi si osserva un
aumento dei marcatori di necrosi miocardica (CK-MB, Troponina) e modificazioni
elettrocardiografiche tipiche dell’ischemia miocardica, quali sopraslivellamento del
tratto ST, inversione dell’onda T, comparsa di onde Q patologiche o sottoslivellamento
diffuso del tratto ST. L’ecocardiogramma evidenzia spesso anomalie della cinetica
ventricolare sinistra, pur in presenza di coronarie indenni da lesioni all’esame
coronarografico.
Le miocarditi possono inoltre produrre variabili effetti sul sistema di conduzione e sul
ritmo cardiaco, e sono in grado di provocare blocchi di branca (vedi Capitolo…), blocco
A-V (vedi capitolo…), battiti ectopici (vedi Capitolo…) o tachicardie. La tachicardia
ventricolare (vedi Capitolo…) si presenta raramente all’esordio della malattia, ma si
osserva frequentemente durante il follow-up a lungo termine di questi pazienti.
VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
La diagnosi di miocardite può essere sospettata sulla base dei sintomi,
dell’elettrocardiogramma, di valori elevati della proteina C reattiva e dei marker di
danno miocardico (troponina o CK-MB) e di aumento delle IgM specifiche per virus a
tropismo miocardico, ma la diagnosi di certezza si basa sulla istologia.
Elettrocardiogramma
I quadri elettrocardiografici più comuni sono caratterizzati da una diffusa inversione
dell’onda T, ma può anche comparire sopraslivellamento del tratto ST, soprattutto
nelle forme di miocardite con interessamento pericardico .
Marcatori di infiammazione e di necrosi.
La VES, la proteina C reattiva ed altri marcatori di infiammazione appaiono alterati in
caso di miocardite, ma sono del tutto aspecifici e non si sono dimostrati
particolarmente utili nella valutazione diagnostica e prognostica dei pazienti con
miocardite. I marcatori di necrosi miocardica vengono misurati nei pazienti con
sospetta miocardite, anche se la loro sensibilità diagnostica è risultata in genere
bassa e variabile.
Ecocardiogramma
In tutti i pazienti con sospetta miocardite dovrebbe essere eseguito un
ecocardiogramma per la ricerca di anomalie della contrattilità ventricolare sinistra. Il
reperto iniziale più comune è il riscontro di alterazioni della cinetica parietale del
ventricolo sinistro, in assenza di significativa dilatazione della camera. La disfunzione
del ventricolo destro è meno frequente.
Risonanza magnetica nucleare
La metodica più promettente per la diagnosi delle miocarditi è la risonanza magnetica
nucleare con contrasto di gadolinio. Tale tecnica è in grado di individuare le aree
miocardiche interessate dall’infiltrazione infiammatoria e consente l’effettuazione di
biopsie mirate per la conferma della diagnosi .
Biopsia endomiocardica
La biopsia endomiocardica è tuttora considerata il gold standard per una diagnosi di
certezza della miocardite. Il tipico quadro istologico mostra l’interstizio miocardico
occupato da edema e infiltrato infiammatorio, ricco di linfociti e macrofagi, e la
presenza di quadri di necrosi focale di miociti .Tuttavia, le classificazioni
istopatologiche proposte attualmente forniscono informazioni clinicamente utili
soltanto in una minoranza dei casi. Per tale motivo la biopsia endomiocardica è
generalmente riservata ai pazienti con una cardiomiopatia rapidamente progressiva e
refrattaria alla terapia standard o con una cardiomiopatia di origine sconosciuta
associata a progressiva alterazione del sistema di conduzione o aritmie ventricolari
minacciose per la vita.
STORIA NATURALE
La storia naturale delle miocarditi è variabile, così come la presentazione clinica. Le
miocarditi che simulano un infarto del miocardio evolvono, nella stragrande
maggioranza dei casi, verso il completo recupero. I pazienti che esordiscono con
scompenso cardiaco possono presentare una moderata disfunzione miocardica
(frazione di eiezione 40-50%), che gradualmente migliora nel giro di settimane o mesi.
In una piccola percentuale di soggetti, tuttavia, la miocardite può avere inizio con una
funzione sistolica gravemente depressa (frazione di eiezione del ventricolo sinistro
minore del 35%) e in tal caso la metà circa dei pazienti evolve verso lo scompenso
cardiaco cronico, il 25% va incontro al trapianto o alla morte, e solo nel rimanente
25% si assiste ad un progressivamente miglioramento della funzione ventricolare.
Il tasso di mortalità delle miocarditi varia dal 20 al 56%, ma raggiunge l’80% a 5 anni
nelle forme che alla biopsia mostrano un quadro istologico a cellule giganti. La
presentazione clinica caratterizzata da sincope, disturbo della conduzione
intraventricolare (blocchi di branca) o frazione di eiezione minore del 40% è gravata
da un maggior rischio di morte o di evoluzione verso il trapianto.
TERAPIA
La terapia della miocardite è principalmente di supporto. Solo i pazienti che si
presentano con un quadro di scompenso cardiaco grave hanno necessità di trattamenti
aggressivi, e in essi è indicato l’uso di farmaci inotropi positivi, diuretici, e
vasodilatatori. Dopo la stabilizzazione emodinamica iniziale, la terapia dovrebbe
includere un ACE-inibitore e un ß-bloccante e, nei casi di grave disfunzione sistolica
(III e IV classe funzionale NYHA), un diuretico.
Risultati non ancora univoci suggeriscono l’impiego di farmaci immunosoppressori nelle
miocarditi. Al momento questo tipo di terapia non è da considerare di scelta nella
gestione routinaria di questi pazienti, sebbene dati incoraggianti siano stati ottenuti
in quelli con miocardite a cellule giganti.
ENDOCARDITE
Questa malattia è stata nota, per molti decenni, con i termini di endocardite lenta o
di endocardite batterica subacuta, che definiscono il primo l’andamento abitualmente,
ma non necessariamente, torpido ed il secondo l’eziologia batterica della maggior
parte dei casi.
Si tratta di una forma morbosa che si sviluppa nell’endotelio del cuore già
precedentemente leso, per lo più sulle valvole cardiache sia native che protesiche, su
cui si impiantano dapprima le piastrine, che penetrano attraverso la lesione stessa
(endocardite abatterica). In presenza di batteriemia per penetrazione di
microrganismi da varie fonti (cavità orale in particolare), i germi colonizzano sulle
piastrine (endocardite infettiva) e formano le cosiddette vegetazioni, arricchite poi
da eritrociti, leucociti, e cellule infiammatorie. Oltre che sulle valvole, le colonie si
localizzano nei difetti del setto interventricolare, nel dotto arterioso di Botallo o
sull’endocardio murale; quest’ultima evenienza è possibile solo in caso di applicazione di
dispositivi intracardiaci come cateteri o piccoli strumenti per chiudere difetti.
Particolari condizioni, come la tossicodipendenza, le diminuite resistenze immunitarie,
e l’emodialisi favoriscono la malattia, la cui frequenza è oggi stimabile tra il 2,5 ed il
6,0 per 100.000 persone.
EZIOLOGIA
Anche se molti microrganismi, non solo batterici, ma anche fungini, possono essere
causa della malattia, non più di una decina di agenti è responsabile del 90% dei casi.
Sulle valvole native o nei difetti intracardiaci, l’85% è costituito da streptococchi,
pneumococchi o enterococchi; nei tossicodipendenti lo stafilococco aureo è presente
nel 90% dei casi; tra i funghi prevale la candida.
I microrganismi entrano nel torrente ematico da mucose, siti di infezioni focali, meno
spesso cute. Essi aderiscono ai trombi nella quasi totalità dei casi, eccetto lo
stafilococco aureo che può colpire direttamente l’endotelio sano. Una patologia
cardiaca preesistente è abitualmente necessaria per l’impianto dei germi, ma la
frequenza di complicanze endocarditiche nelle singole patologie cardiovascolari è
variabile: il rischio è massimo nell’insufficienza valvolare aortica o mitralica, seguite
dalla persistenza del dotto arterioso e dai difetti del setto ventricolare, mentre è
minima nella stenosi mitralica o nel prolasso isolato della valvola mitralica. Nei
portatori di protesi valvolari, il rischio è più o meno simile per ogni tipo di cardiopatia
che ha richiesto l’inserzione della protesi, specie se meccanica; nei tossicodipendenti
che fanno uso di siringhe non sterili con trasferimento della droga a più persone, la
sede iniziale è spesso la tricuspide, ma le forme più gravi sono la localizzazione
mitralica od aortica.
I microrganismi penetrano per lo più in seguito a manovre strumentali sulla bocca
(estrazioni dentarie) o dopo endoscopia digestiva, cateterismo delle vie urinarie,
cateterismo cardiaco, emodialisi, aghi a permanenza nelle vene, raramente a causa di
infezioni cutanee o ustioni.
PATOGENESI
Le caratteristiche del quadro clinico e gli studi sperimentali hanno dimostrato che le
manifestazioni della malattia ed i sintomi e segni clinici sono la conseguenza di tre
meccanismi attivi simultaneamente: 1) le conseguenze della infezione; 2) le metastasi
trombo-emboliche; 3) le alterazioni immunologiche. Le conseguenze dell’infezione sono
legate alla tossicità dei microrganismi ed alla intensità della loro propagazione ai vari
organi; le manifestazioni emboliche, dipendenti dalla friabilità delle vegetazioni,
colpiscono in modo particolare alcuni distretti; i fenomeni autoimmuni sono la
conseguenza della stimolazione del sistema immunitario da parte dei germi, con
formazione di autoanticorpi.
ANATOMIA PATOLOGICA
I germi si localizzano nelle strutture sopra ricordate in presenza di endotelio non
normale (quello intatto è assai resistente all’impianto di microrganismi) dal lato della
cavità a minore pressione (per esempio, sulla faccia atriale dei lembi mitralici). Si
depositano inizialmente le piastrine e quindi giungono i batteri, che formano le
“colonie”, mescolati a globuli rossi e bianchi, fibrina e materiale di distruzione del
tessuto valvolare. A volte i germi si moltiplicano in modo violento, formando vere e
proprie ulcerazioni, ma più spesso la moltiplicazione è lenta.
Poiché le vegetazioni sono costituite da materiale friabile, la loro rottura è frequente,
comportando la reimmissione in circolo del materiale che comprende i microrganismi
(batteriemia), e provocando nuove localizzazione in vari organi e tessuti: cute, mucose,
reni, milza, cervello.
QUADRO CLINICO
I sintomi e i segni della infiammazione sono precoci e numerosi, anche se aspecifici:
tra quelli generali la febbre di tipo continuo, quasi mai con brividi, con valori inferiori
a 39°, compare nell’80-90% dei casi, mancando solo negli immunocompromessi o nei
grandi anziani. Essa si accompagna ad inappetenza, perdita di peso e malessere; meno
comuni sono sudorazione e cefalea. L’ascoltazione cardiaca può rivelare la comparsa di
nuovi soffi o la modificazione di soffi preesistenti in oltre l’80% dei casi, ed indica la
valvola interessata. La tachicardia è presente nella metà dei casi. La splenomegalia,
oggi che la terapia antibiotica è disponibile, è rilevabile in non più del 50% dei casi,
essendo un segno non precoce. Nella metà dei casi, sono riscontrabili petecchie nelle
congiuntive, nella bocca, nella mucosa del palato, alle estremità; meno frequentemente
si osservano i noduli di Osler, noduli teneri, piccoli come capocchie di spillo, ben visibili
alle estremità delle dita e di durata da molte ore a pochi
giorni. Le conseguenze emboliche della malattia comprendono: le macchie di Janeway,
manifestazioni eritematose od emorragiche sulle palme delle mani o le piante dei piedi
(7-10% dei malati), l’embolia splenica, l’infarto renale, l’occlusione embolica dell’arteria
retinica; più rari gli ascessi embolici cerebrali con sindrome neurologica di focolaio.
Tra le manifestazioni da immunocomplessi le più importanti sono le lesioni renali
(insufficienza renale da glomerulonefrite con ematuria e iperazotemia), la
presenza di anticorpi specifici per il fattore reumatoide o di anticorpi antisarcolemma
tici ed antiendocardio.
Altre manifestazioni sono l’insufficienza cardiaca da rottura di corde tendinee,
l’emorragia cerebrale da rottura di emboli micotici, lo shock settico, l’insufficienza
renale, che può riconoscere più meccanismi, compresa la terapia antibiotica in eccesso
o con farmaci nefrotossici.
Il laboratorio mostra reperti aspecifici quali gradi variabili di anemia, leucocitosi
neutrofila, aumento della velocità di sedimentazione. Di estrema utilità è l’esecuzione
di ripetute emoculture, volte all’isolamento del germe responsabile. L’emocultura
conferma che si tratti di endocardite infettiva con batteriemia e permette di iniziare
una terapia antibiotica mirata. Di solito i germi patogeni abituali danno positività della
emocultura, ma in taluni casi, specie nelle forme su protesi valvolari da germi spesso
poco patogeni, l’emocultura può non essere positiva inizialmente o esserlo in ritardo.
Dati di notevole importanza offre l’ecocardiografia, per via transtoracica e
sopratutto transesofagea: tale esame è oggi obbligatorio in ogni caso sospetto di
endocardite infettiva. Esso mostra la presenza delle vegetazioni aderenti alle valvole
o alle altre sedi della infezione, sotto forma di ammassi translucidi .
L’ecografia transtoracica dà positività in circa il 65% dei casi, per cui è la prima
ricerca da eseguire, quella transesofagea dà positività vere in oltre il 90%, per cui è
obbligatoria nel sospetto fondato di endocardite se l’ecocardiografia transtoracica è
negativa. Il significato prognostico delle vegetazioni è piuttosto controverso, anche se
il rischio embolico è particolarmente frequente se le vegetazioni sono voluminose.
Durante il decorso, le vegetazioni mostrano, quando la malattia tende alla guarigione,
una riduzione, sino alla loro scomparsa nella metà dei casi, mentre restano invariate,
anche a lungo termine, negli altri. In presenza di complicanze, ascessi dell’anello
valvolare, aneurismi micotici dei seni di Valsalva, fistole, e così via, l’ecocardiografia è
di grande valore.
Elettrocardiogramma, radiografia del torace, immagini da TAC o RMN non forniscono
di solito dati utili alla diagnosi dell’endocardite infettiva.
Riconoscimento della malattia. Gli aspetti polimorfi della endocardite, specie oggi,
visto che la terapia antibiotica ha modificato il quadro clinico, hanno sempre fornito
difficoltà non piccole, per cui si è presto ricorsi alla ricerca di criteri di certezza.
Oggi i criteri della Duke University , che classifica i dati disponibili in maggiori e
minori, sono seguiti quasi senza eccezioni: due criteri maggiori o uno maggiore e tre
minori o, in modo meno attendibile, cinque minori, sono considerati necessari per la
diagnosi definiva. La difficoltà di riconoscimento della malattia, favorita dalla
dimenticanza del postulato di Osler “qualsiasi processo febbrile che dura più di 5
giorni in un cardiopatico può essere endocardite infettiva” rende spesso tardivo il
riconoscimento, per cui la diagnosi viene raggiunta dopo oltre due mesi, anche per la
difficoltà di distinguere la malattia da altre patologie infettive e no, tra cui il lupus
eritematoso, la brucellosi, la tubercolosi polmonare, le glomerulonefriti, le vasculiti, i
tumori.
Decorso, prognosi. La malattia è stata radicalmente modificata nel suo andamento e
nella prognosi dall’avvento della terapia antibiotica e, in casi particolari, dalla chirurgia
cardiaca. In assenza di trattamento, l’endocardite infettiva porta alla morte in circa il
90% dei casi; oggi oltre l’80% dei malati può guarire se la terapia, medica o chirurgica,
è ben condotta. Chiaro è che una terapia iniziata tardivamente può portare alla
compromissione della situazione cardiaca, soprattutto a un aggravamento di lesioni
valvolari preesistenti.
CENNI DI TERAPIA
La terapia antibiotica è basata sulla identificazione del microrganismo responsabile e
sulla dimostrazione della sensibilità del germe all’antibiotico. Il trattamento iniziale
dovrebbe essere condotto con i dosaggi massimi del farmaco e per via endovenosa, in
modo da assicurare una concentrazione costante per tutte le 24 ore. In caso di
risposta positiva, la terapia va condotta per 4 settimane, e a partire dalla seconda è
possibile il trattamento orale. In caso di endocardite ad emocultura negativa, si può
iniziare una terapia empirica a largo spettro, che comprenda un macrolide ed un
antibiotico attivo sui gram negativi a dosi elevate e, possibilmente, sostituito dalla
terapia più adatta quando l’emocultura ha chiarito il microrganismo responsabile.
La terapia chirurgica ha ben precise indicazioni, e può essere impiegata nelle seguenti
condizioni:
infezioni incontrollate dai farmaci, dopo due settimane, in presenza di germi particolari, quali
stafilococco aureo nei tossicodipendenti con grave endocardite o lo pseudomonas o talune
infezioni fungine;
mancata risposta alla terapia antibiotica per presenza di grave insufficienza cardiaca;
lesione valvolare mitralica aortica o di entrambe le valvole con decorso tempestoso;
ascessi anulari, batteriemia persistente nonostante una terapia medica massimale, embolie
ricorrenti;
vegetazioni molto grandi in sede valvolare.
Profilassi: poiché la malattia compare spesso dopo manovre mediche comportanti
batteriemia (vedi sopra), queste dovrebbero essere precedute e seguite
immediatamente da profilassi con antibiotici attivi sui gram positivi o negativi secondo
le sede della manovra. La profilassi non risolve definitivamente il problema del rischio,
ma ne riduce le probabilità: pertanto essa dovrebbe essere eseguita in tutti i casi in
cui la possibilità di una batteriemia è consistente. Per le manovre sull’apparato
respiratorio o dentario, l’amoxacillina è abitualmente adeguata, ma può essere
sostituita con la vancomicina o la clindamicina in caso di intolleranza: per le manovre
comportanti il rischio di germi gran negativi, la gentamicina è il farmaco più
largamente impiegato.
entricolari e ventricolari, e ciascuna di queste classi ha diverse forme. Le bradicardie
comprendono la bradicardia sinusale, il blocco seno-atriale e il blocco atrioventricolare. I battiti ectopici possono essere sopraventricolari (atriali e giunzionali)
o ventricolari.
BATTITI ECTOPICI
DEFINIZIONE
In condizioni normali, il ritmo cardiaco è governato dal nodo senoatriale, che
rappresenta il naturale pacemaker del cuore e, a intervalli regolari, emette impulsi
elettrici che depolarizzano tutto il miocardio. In particolari condizioni l’attivazione del
cuore, o anche di parte di esso, può dipendere da un impulso che origina in una sede
diversa dal nodo senoatriale; in tali casi l’impulso è definito ectopico e il battito che
ne deriva è un battito ectopico.
L’emissione di un impulso ectopico può essere “anticipata” rispetto al momento in cui è
atteso il complesso del ritmo di base; in tali casi si generano dei battiti prematuri
detti anche extrasistoli. A seconda della sede di origine, le extrasistoli possono
essere distinte in atriali, giunzionali e ventricolari.
Un battito ectopico può anche manifestarsi “in ritardo” rispetto al momento in cui era
atteso un complesso del ritmo di base; il fenomeno si può verificare quando viene meno
il battito normale, per cui un pacemaker secondario, solitamente “silente” perchè
depolarizzato dalla scarica del segnapassi primario, dà origine a un impulso che attiva
il miocardio. Questi complessi ectopici si manifestano dopo un ciclo più lungo di quello
di base e sono definiti battiti di scappamento. Come le extrasistoli, anche i battiti di
scappamento possono essere atriali, giunzionali o ventricolari.
EXTRASISTOLI ATRIALI
Sono riconoscibili per la presenza di:
onda P prematura di morfologia differente da quella delle onde P sinusali;
pausa postextrasistolica generalmente non compensatoria;
QRS solitamente identico a quelli sinusali.
Gli impulsi atriali prematuri sono generalmente condotti ai ventricoli in modo analogo a
quanto avviene nei complessi di origine sinusale; tuttavia è possibile che, a causa della
loro prematurità, trovino parte del sistema di conduzione ancora in stato di
refrattarietà e vadano incontro a un rallentamento o blocco della conduzione. Il più
delle volte è il nodo A-V a non avere ancora totalmente recuperato la propria
eccitabilità e gli impulsi prematuri atriali possono essere condotti ai ventricoli con un
intervallo PR prolungato rispetto a quello dei complessi di base o, se molto precoci,
possono addirittura bloccarsi nella giunzione atrioventricolare e, in tal caso, la P
prematura non è seguita da un QRS (extrasistole atriale non condotta). In altre
occasioni, invece, il rallentamento o blocco della conduzione interessa il sistema di
Purkinje e le extrasistoli atriali sono condotte con un blocco di branca
(extrasistoli atriali condotte con aberranza).
I battiti prematuri atriali sono una delle cause più comuni di irregolarità del ritmo
cardiaco, anche se spesso il loro riscontro è casuale; in genere, richiedono un
trattamento solo nei casi in cui sono scarsamente tollerati dal paziente o quando
costituiscono un potenziale meccanismo di innesco di aritmie maggiori, quali il flutter
e/o la fibrillazione atriale.
EXTRASISTOLI GIUNZIONALI
Questi impulsi prematuri hanno origine nel fascio di His, prima della sua suddivisione
nelle branche, e sono considerati sopraventricolari dal momento che la diffusione
dell’impulso all’interno dei ventricoli procede in modo analogo a quella degli impulsi
sinusali o atriali.
Sono caratterizzate da:
QRS prematuro uguale a quelli del ritmo di base;
assenza di rapporti tra il QRS prematuro e la P sinusale. L’onda P, infatti, può precedere il QRS
extrasistolico, ma a una distanza più breve del normale e non compatibile con la conduzione AV, oppure può coincidere con il complesso ventricolare o anche manifestarsi immediatamente
dopo di esso. In altri casi, invece, l’impulso prematuro attiva gli atri prima dell’impulso sinusale
e si manifesta un’onda P dovuta alla retroconduzione dell’impulso giunzionale agli atri; in
questo caso la P retrocondotta può precedere, seguire o anche coincidere con il QRS prematuro.
EXTRASISTOLI VENTRICOLARI
La diagnosi si basa sui seguenti elementi:
QRS prematuri, slargati, differenti da quelli del ritmo di base;
mancanza di rapporti precisi tra i QRS prematuri e le onde P sinusali o, in
alternativa, comparsa di onde P retrocondotte che seguono i QRS extrasistolici;
pausa postextrasistolica generalmente di tipo compensatorio.
La diagnosi delle extrasistoli ventricolari è meno semplice quando il ritmo di base è una
fibrillazione atriale e le onde P sono assenti. In questo caso, infatti, l’improvvisa
comparsa di QRS larghi, differenti da quelli di base, potrebbe essere l’espressione di
una conduzione aberrante degli impulsi sopraventricolari e non di un’origine ventricolare
dei QRS.
A volte asintomatiche, le extrasistoli ventricolari sono in genere più facilmente causa di
cardiopalmo di quelle sopraventricolari soprattutto per la lunga pausa
postextrasistolica che le caratterizza. La loro prognosi dipende dal contesto clinico:
generalmente è favorevole nei soggetti esenti da cardiopatia, nei quali può non essere
necessario alcun trattamento specifico, viceversa può essere sfavorevole in presenza di
una cardiopatia, in particolar modo nel corso di eventi ischemici acuti.
TACHICARDIE PAROSSISTICHE SOPRAVENTRICOLARI
Rossella Troccoli, Matteo Di Biase
DEFINIZIONE
Si definisce tachicardia parossistica sopraventricolare (TPS) una sindrome clinica
caratterizzata da una tachicardia rapida e regolare, con improvviso inizio ed
improvvisa interruzione. La maggior parte delle TPS è dovuta ad un meccanismo di
rientro (vedi Capitolo 36), che può realizzarsi nel nodo atrio-ventricolare (tachicardia
da rientro nodale) oppure in un circuito che include atri, ventricoli, il normale sistema
di conduzione (nodo AV, Fascio di His, Branche ) ed una connessione atrio-ventricolare
anomala (tachicardia da rientro atrio-ventricolare).
FIBRILLAZIONE E FLUTTER ATRIALE
DEFINIZIONE
La fibrillazione atriale (FA) è un’aritmia nella quale il ritmo cardiaco non è governato
dal nodo del seno, ma si generano negli atri impulsi a frequenza elevata (fino a 600 al
minuto), con cicli irregolari; solo alcuni di essi, però, sono condotti i ventricoli, mentre
un numero più o meno grande di impulsi atriali va incontro a un blocco nel nodo atrioventricolare, per cui la frequenza ventricolare è molto minore di quella atriale.
EZIOLOGIA
Le cause della FA possono essere molteplici. In passato la patologia sottostante più
frequente era rappresentata da patologie valvolari (soprattutto a carico della valvola
mitrale), mentre nell’ultimo ventennio le malattie che più frequentemente determinano
un aumento della pressione in atrio sinistro, con conseguente aumento di volume
atriale e quindi maggiore predisposizione alla FA, sono l’ipertensione arteriosa e le
cardiomiopatie. In circa il 30% dei casi non è identificabile nessuna patologia: in tali
casi la FA viene definita come idiopatica o “alone fibrillation”.
ELETTROGENESI E FISIOPATOLOGIA
Diversamente da altre aritmie, la FA non ha un meccanismo elettrogenetico unico, ma
più fattori concorrono a determinare la sua genesi e il suo mantenimento. Sono stati
identificati, specialmente nelle vene polmonari, segnapassi capaci di emettere impulsi
a frequenza molto elevata, ed inoltre si realizzano negli atri multipli circuiti di rientro,
che operano indipendente gli uni dagli altri. Nella FA non esiste un unico fronte di
attivazione che, partendo dal nodo del seno, invada progressivamente in maniera
ordinata tutta la massa atriale in un tempo relativamente breve, ma si realizzano
multipli fronti d’onda che, disordinatamente e in maniera continuamente variabile,
attivano ciascuno una regione più o meno limitata dell’atrio. Mentre nel ritmo sinusale
la depolarizzazione degli atri occupa solo una piccola parte del ciclo cardiaco (circa
70-90 millisecondi, come espresso dalla durata dell’onda P normale), nella FA l’atrio si
attiva ininterrottamente: in ogni momento del ciclo cardiaco, infatti, vi sono aree
atriali che si depolarizzano mentre altre zone si stanno ripolarizzando. Ciò spiega la
presenza di onde atriali (onde f, vedi più avanti) per tutto il ciclo cardiaco.
Da un punto di vista meccanico, la FA corrisponde ad una paralisi atriale: le singole
fibrocellule si contraggono, ma la loro contrazione non è efficace nel favorire la
progressione del sangue perchè non vi è sincronismo nell’attività delle diverse aree
atriali, ciascuna delle quali si contrae in un momento diverso. La mancanza della spinta
atriale non necessariamente compromette il riempimento diastolico ventricolare,
soprattutto se la frequenza ventricolare non è elevata e se non vi è disfunzione
ventricolare: anche quando il ritmo è sinusale, infatti, la maggior parte del sangue
passa dall’atrio al ventricolo durante la proto e mesodiastole, cioè passivamente, e la
contrazione dell’atrio interviene solo in telediastole a completare il riempimento
ventricolare. Quando, invece, la funzione diastolica del ventricolo sinistro è
compromessa (per esempio, per via dell’ipertrofia ventricolare) il ruolo della
contrazione atriale diviene preminente nel favorire il riempimento ventricolare, per
cui la FA, con la perdita dell’attività meccanica atriale, può provocare una importante
riduzione della gittata cardiaca, ed essere causa determinante dello scompenso
cardiaco.
QUADRO CLINICO
La sintomatologia della FA è legata alla irregolarità del ritmo ed alla frequenza
ventricolare media generalmente elevata, ed è rappresentata dalle palpitazioni. In
corso di FA vi è la perdita della contrazione atriale con conseguente possibile
riduzione della gittata cardiaca e per tale ragione essa può anche manifestarsi con
dispnea, affaticabilità, dolore toracico. In circa il 20% dei casi la FA è completamente
asintomatica: e questo avviene frequentemente in soggetti con condizioni fisiologiche
(ipertono vagale) che rallentino la conduzione atrio-ventricolare.
Con la palpazione del polso radiale è di solito possibile apprezzare la completa
irregolarità del ritmo e la variabile ampiezza dell’onda sfigmica. Quest’ultimo
fenomeno esprime il rapporto tra gittata sistolica e durata della diastole: durante una
diastole lunga il ventricolo ha la possibilità di ricevere una elevata quantità di sangue,
per cui la gittata sistolica è abbondante e il polso è ampio; dopo una diastole breve,
invece, il ventricolo è relativamente vuoto di sangue quando si contrae, e di
conseguenza la gittata sistolica è modesta e il polso piccolo. Quando la diastole
diventa brevissima, come in caso di elevata risposta ventricolare, in alcune (o in molte)
delle contrazioni il ventricolo contiene così poco sangue da non riuscire provocare
l’apertura delle cuspidi aortiche; in questo caso non si genera un’onda sfigmica e al
polso il battito è del tutto assente. In questa situazione, la frequenza cardiaca
valutata al polso è minore di quella reale (“deficit cuore-polso”): in pazienti con FA,
perciò, la frequenza cardiaca va rilevata non solo al polso ma anche mediante
ascoltazione cardiaca sul focolaio della punta.
La frequenza ventricolare durante FA è influenzata in modo significativo dal tono del
sistema nervoso autonomo: può diventare molto rapida quando aumenta il tono
simpatico e diminuisce il tono parasimpatico, come accade durante esercizio fisico.
Le complicanze della FA possono essere dovute alla sua irregolarità, alla elevata
frequenza cardiaca e alla perdita della contrazione atriale. L’irregolarità e l’elevata
frequenza cardiaca possono provocare una riduzione della funzione contrattile
ventricolare sinistra, che in presenza di altre patologie concomitanti può esitare in
scompenso cardiaco. La perdita della contrazione atriale, inoltre, determina un
rallentamento del flusso ematico che facilita la formazione di trombi all’interno degli
atri, specialmente nelle auricole. I trombi sono generalmente adesi alla parete atriale,
ma possono anche staccarsi, specialmente quando, col ripristino del ritmo sinusale,
l’atrio riprende a contrarsi. Un trombo formatosi nell’atrio sinistro può quindi,
attraverso la circolazione sistemica, embolizzare in qualsiasi distretto periferico: non
di rado viene colpito l’encefalo e si manifesta un ictus. La comparsa di scompenso, ma
soprattutto le complicanze tromboemboliche, sono la causa dell’aumentata mortalità
nei pazienti con FA.
CLASSIFICAZIONE
Sono stati proposti diversi schemi di classificazione clinica della FA, ma nessuno
comprende in modo completo tutti gli aspetti dell’aritmia. Dal punto di vista clinico è
utile distinguere un primo episodio documentato indipendentemente dai sintomi e dalla
durata. Nel caso in cui il paziente presenti 2 o più episodi, la FA è
considerata ricorrente. Se l’aritmia termina spontaneamente, la recidiva di FA viene
definita parossistica; mentre se dura più di 7 giorni, la FA viene detta persistente.
Nella FA persistente, il ripristino del ritmo sinusale (cardioversione) si ottiene con
farmaci o con mezzi elettrici (vedi più avanti). La categoria della
FA permanente comprende i soggetti nei quali la cardioversione è fallita o non è stata
tentata.
TRATTAMENTO
Profilassi degli eventi cardioembolici
Poiché la FA aumenta significativamente il rischio di eventi tromboembolici, esiste
unanime consenso sul fatto che tutti i pazienti con patologia cardiaca valvolare e FA
richiedano l’anticoagulazione con dicumarolici. In pazienti con FA non valvolare
l’indicazione al trattamento anticoagulante dipende dal rischio tromboembolico
calcolato in base ai fattori di rischio (scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, età
> 75 anni, diabete mellito, precedente storia di ictus o TIA). E’ necessario comunque
conoscere che la terapia anticoagulante con dicumarolici comporta un rischio di stroke
emorragico pari all’1% per anno.
Cardioversione
Con tale termine si definisce l’interruzione della FA, con ripristino del ritmo sinusale.
Quando la cardioversione non avviene spontaneamente, un episodio di FA persistente
può essere interrotto eseguendo una cardioversione elettrica o farmacologica.
La cardioversione elettrica (CVE) consiste nella somministrazione di una scarica
elettrica per mezzo di due piastre applicate al torace del paziente, cui consegue
l’azzeramento del potenziale di azione di tutte le cellule cardiache e quindi
l’interruzione dell’aritmia.
Numerosi farmaci antiaritmici possono essere utilizzati per eseguire
una cardioversione farmacologica; tra questi il propafenone, la flecainide e
l’amiodarone sono quelli maggiormente efficaci. Il successo della CV farmacologica
dipende dalla durata della FA, raggiungendo l’80% in caso di FA con durata minore di
24 ore, mentre la percentuale di successo è inferiore al 35% in caso di FA
persistente.
Un rischio della cardioversione, indipendente dal fatto che il ripristino del ritmo
sinusale sia spontaneo o indotto elettricamente o con farmaci, è che si verifichi
un’embolia arteriosa sistemica. Se, infatti, durante il periodo in cui l’aritmia è stata
presente si è formato un trombo in atrio sinistro, la ripresa della contrazione atriale
favorisce il distacco del trombo, che migra quindi nel circolo sistemico. Per questo
motivo si può cardiovertire elettricamente la FA se questa è insorta da meno di 48
ore, mentre se l’episodio di FA ha una durata maggiore, la cardioversione, sia elettrica
che farmacologica, deve essere preceduta da un periodo di anticoagulazione efficace
di almeno 4 settimane.
Controllo del ritmo e controllo della frequenza
Nei pazienti con FA, la terapia farmacologica può avere come scopo il mantenimento
del ritmo sinusale (controllo del ritmo) o, nella FA permanente, il mantenimento di una
frequenza ventricolare media accettabile (controllo della frequenza). La prima
strategia viene scelta solitamente in soggetti giovani o molto sintomatici o con
deterioramento emodinamico dovuto alla fibrillazione atriale. La seconda è
generalmente preferita in pazienti anziani o paucisintomatici.
Per il controllo del ritmo i farmaci antiaritmici più utilizzati (vedi Capitolo 58) sono
quelli della classe I (chinidina, flecainide, propafenone) e III
(sotalolo, amiodarone, dronedarone, azimilide). Tali farmaci hanno una efficacia nel
mantenere il ritmo sinusale ad un anno che va dal 45-50% per quelli della classe I al
70-75 % per i farmaci della classe III. Purtroppo l’incidenza di importanti effetti
collaterali coinvolge quasi un quarto dei pazienti trattati. In caso di inefficacia e/o di
effetti collaterali della terapia farmacologica, la strategia del controllo del ritmo può
essere perseguita utilizzando metodiche di ablazione transcatetere o chirurgiche che
consistono nell’isolamento elettrico delle vene polmonari e nell’esecuzione di lesioni
lineari .
Per quanto riguarda il controllo della frequenza, evidenze cliniche hanno dimostrato
come, soprattutto nei pazienti anziani, tale strategia possa risultare una valida
alternativa terapeutica. Essa può essere raggiunta con l’impiego di tre diversi farmaci:
la digossina più utilizzata nei pazienti con scompenso cardiaco, i ß-bloccanti
generalmente più efficaci per il loro effetto nel controllo della frequenza sotto
sforzo e i Calcio-antagonisti.
FLUTTER ATRIALE
DEFINIZIONE
Il flutter atriale è un’aritmia caratterizzata da un’attivazione atriale regolare e rapida con
una frequenza generalmente compresa tra i 240 e i 300/m’. La risposta ventricolare, cioè il
numero di impulsi atriali che raggiungono i ventricoli, dipende dal nodo atrio-ventricolare,
che funge da filtro, impedendo che la frequenza ventricolare raggiunga livelli troppo elevati.
Generalmente la conduzione atrio-ventricolare avviene con un rapporto 2:1 (solo un impulso
atriale su due è condotto ai ventricoli) ma talora può presentare rapporti di conduzione
diversi (3:1, 4:1, 3:2).
L’incidenza del flutter atriale nella popolazione generale è stimata in 88 su 100000 abitanti.
Molto spesso il flutter atriale si associa a fibrillazione atriale; la maggior parte dei casi si
verifica in presenza di una condizione predisponente o di una malattia cardiaca strutturale.
QUADRO CLINICO
I sintomi del flutter atriale sono simili a quelli della fibrillazione atriale e dipendono in
larga misura dalla frequenza ventricolare: il disturbo più comune è la palpitazione, ma
possono anche verificarsi vertigini, dispnea, debolezza, e raramente angina o sincope.
CLASSIFICAZIONE
Il flutter atriale si presenta all’ECG con una serie di onde atriali (onde F) regolari, a
frequenza intorno a 300 al minuto; il numero dei complessi ventricolari è quasi sempre
minore, dato che solo alcuni impulsi atriali vengono condotti ai ventricoli. In base alla
morfologia delle onde F, il flutter si distingue in tipico ed atipico.
Nel flutter atriale tipico le onde F hanno un aspetto a dente di sega, e si susseguono
senza interruzione, non essendo separate da linea isoelettrica; nel flutter atipico,
invece, le onde F non hanno morfologia a denti di sega e sono separate da linea
isoelettrica. Nel flutter tipico comune (antiorario) le onde F sono negative nelle
derivazioni inferiori (II, III, aVF) e positive in V1, mentre nella forma non comune
(oraria) hanno polarità positiva nelle derivazioni inferiori e negativa in V1.
TRATTAMENTO
Il trattamento del flutter atriale può avere come scopo il mantenimento di una
frequenza ventricolare non troppo elevata oppure l’interruzione dell’aritmia. I
calcioantagonisti e i beta-bloccanti (vedi Capitolo 58) sono farmaci di prima scelta per
rallentare la frequenza ventricolare, poiché essi aumentano la refrattarietà del nodo
A-V e quindi diminuiscono il numero degli impulsi atriali che raggiungono i ventricoli.
Per far cessare il flutter atriale e ripristinare il ritmo sinusale, viene comunemente
impiegata l’ibutilide somministrata per via endovenosa .
Un altro metodo efficace per interromper il flutter è la cardioversione elettrica (vedi
il paragrafo “Trattamento” della sezione Fibrillazione atriale). Come per la
fibrillazione, anche i pazienti con flutter atriale che dura da più di 48 ore richiedono
un opportuno periodo di scoagulazione. Anche la stimolazione elettrica atriale può
efficacemente porre fine al flutter; essa si esegue con un elettrocatetere introdotto
nell’atrio destro per via venosa oppure con un elettrodo inserito nell’esofago e posto a
stretto contatto con l’atrio sinistro, che si trova in immediata continuità con l’esofago.
Gli stimoli elettrici ad elevata frequenza, erogati da un apposito stimolatore, possono
far cessare il flutter perché rendono refrattaria una parte del circuito di rientro,
impedendo l’ulteriore progressione dell’impulso e quindi il perpetuarsi dell’aritmia.
E’ possibile curare il flutter atriale radicalmente, rendendo inagibile in modo
definitivo il circuito di rientro mediante un intervento di ablazione transcatetere
(vedi Capitolo 61). Nel flutter tipico l’ablazione viene eseguita inserendo un
elettrocatetere nel cuore destro ed inducendo, con erogazioni di energia a
radiofrequenza, una lesione stabile a livello dell’istmo cavo-tricuspidalico. Quando
questo tessuto diventa incapace di condurre l’impulso, l’aritmia non può più essere
scatenata per l’impossibilità che l’impulso percorra il circuito, una parte del quale è
divenuta ineccitabile in seguito al trattamento.
TACHICARDIE VENTRICOLARI
DEFINIZIONE
Si definisce tachicardia ventricolare (TV) una successione di almeno 3 battiti ectopici
di origine ventricolare con frequenza =100 al minuto. La TV viene classificata
come sostenuta se ha durata >30 secondi o, pur avendo durata inferiore, richiede un
immediato intervento terapeutico per l’insorgenza di grave compromissione
emodinamica, e non sostenuta se ha durata inferiore a 30 secondi. In base alla
morfologia dei complessi ventricolari all’elettrocardiogramma, la TV si
definisce monomorfa se tutti i QRS sono identici e polimorfa quando sono evidenti
variazioni nella configurazione del QRS. Si distinguono, inoltre, le forme
seguenti: TV Iterativa (episodi di TV non sostenuta a regressione spontanea,
generalmente a frequenza <150 b/m), TV Incessante (persistente per oltre l’80% della
giornata), TV lenta (a frequenza compresa tra 100 e 150 b/m).
EZIOLOGIA
Le TV possono verificarsi in presenza o in assenza di alterazioni anatomiche
macroscopicamente evidenti del cuore. In quest’ultimo caso esiste un’alterazione
anatomica di dimensioni troppo piccole per essere messa in evidenza dai comuni
presidi diagnostici (tachicardie cosiddette idiopatiche) o esiste un difetto funzionale
dei canali ionici, generalmente su base congenita (per esempio, sindrome del QT lungo
congenito, Sindrome di Brugada). Le forme idiopatiche costituiscono circa il 10% di
tutte le TV. Le TV che si associano ad una alterazione anatomica del cuore possono
complicare, talora con significato di evento terminale, tutte le cardiopatie, alcune in
particolare.
TV ASSOCIATA AD ALTERAZIONI ANATOMICHE DEL CUORE
La Cardiopatia ischemica rappresenta il principale fattore eziologico della TV:
nell’infarto miocardico acuto una TV sostenuta si presenta nel 5-10% dei casi, ed è
frequente anche in pazienti con pregresso infarto miocardico. In seguito alla necrosi
miocardica, infatti, si creano aree adiacenti non omogenee costituite da tessuto
fibroso e miocardio vitale, che rappresentano il substrato ideale per il rientro.
Nella Cardiomiopatia dilatativa, la TV fa parte della storia naturale (vedi Capitolo 29).
La morte improvvisa, in questi pazienti, è prevalentemente tachiaritmica (80%) nelle
classi NYHA meno avanzate (II-III), mentre nelle fasi più avanzate incidono anche le
bradicardie, la dissociazione elettromeccanica e le tromboembolie. La frazione
d’eiezione ridotta e la comparsa di sincope sono i fattori maggiormente predittivi di
morte improvvisa nella cardiomiopatia dilatativa.
Nella Cardiomiopatia ipertrofica la presenza, oltre che di ipertrofia ventricolare, di
malallineamento dei miociti (disarray) rappresenta il substrato per la genesi di aritmie
ventricolari (vedi Capitolo 28). Non raramente questa cardiopatia si manifesta per la
prima volta con sincope o con morte improvvisa aritmica in pazienti prevalentemente
giovani e peraltro asintomatici. La presenza di una marcata ipertrofia ventricolare
sinistra, di una storia familiare di morte improvvisa, di sincope, risultano altamente
predittivi del rischio di morte improvvisa in questi pazienti.
La Cardiomiopatia/Displasia aritmogena del ventricolo destro si manifesta
essenzialmente con aritmie ventricolari maligne e in particolare con TV sostenuta con
morfologia tipo blocco di branca sinistra (vedi Capitolo 31).
Nella Stenosi aortica circa il 20% dei pazienti muore improvvisamente per aritmie
ventricolari maligne (vedi Capitolo 16).
Anche il Prolasso valvolare mitralico, quando è di entità severa, con rilevante
insufficienza valvolare, può dare luogo alla comparsa di aritmie, inclusa la TV (vedi
Capitolo 15).
TV IN ASSENZA DI ALTERAZIONI ANATOMICHE DEL CUORE
Può verificarsi per difetto funzionale dei canali ionici (Sindrome del QT lungo,
Sindrome di Brugada), per l’effetto di farmaci, squilibri elettrolitici o ipossia.
La Sindrome del QT lungo (LQTS) è una malattia su base genetica, caratterizzata da
alterazioni strutturali dei canali ionici, in grado di provocare un’anomalia nella
ripolarizzazione delle cellule cardiache (vedi Capitolo 43). In questi pazienti, la
sincope, che può esitare in morte improvvisa, è causata dall’insorgenza di una “torsione
di punta”, una tachicardia ventricolare polimorfa, caratterizzata da complessi QRS di
ampiezza variabile e con progressiva inversione di polarità. La morte improvvisa può
essere determinata dalla degenerazione della torsione di punta in una fibrillazione
ventricolare.
La Sindrome di Brugada è una malattia elettrica primaria su base genetica, in cui
all’alterazione di un canale ionico consegue l’accorciamento del potenziale d’azione,
soprattutto a livello epicardico, per cui si crea un gradiente elettrico dopo la completa
attivazione del miocardio ventricolare. Ciò è responsabile di alcune alterazioni dell’ECG
di base (onda J, sopraslivellamento di ST in V1 e V2) e della possibilità di innesco di
tachicardia ventricolare. (vedi Capitolo 43).
Alcuni Farmaci, ad esempio digitale, simpaticomimetici, antiaritmici ed
alcuni Squilibri idroelettrolitici come Ipokaliemia, iperkaliemia, ipercalcemia, possono
provocare una TV.
CONSEGUENZE EMODINAMICHE
I principali fattori che incidono nel deterioramento emodinamico indotto dalla TV
sono: 1) la frequenza, 2) il mancato coordinamento fra gli atri e i ventricoli, 3)
l’attivazione eccentrica del miocardio.
Per frequenze elevate, la fase di riempimento diastolico risulta compromesso e diviene
insufficiente per permettere l’adeguato riempimento ventricolare, per cui la portata
si riduce la pressione arteriosa tende a cadere. Nella TV, inoltre, vi è in circa il 50%
dei casi la dissociazione fra l’attivazione atriale e quella ventricolare, mentre nel
restante 50% l’impulso ventricolare viene retrocondotto agli atri. In questi casi, la
contrazione atriale si verifica sempre (retroconduzione) o spesso (dissociazione) a
valvole AV chiuse, con aumento della pressione atriale, inversione del flusso dall’atrio
alle vene e perdita totale del contributo atriale al riempimento ventricolare.
Un altro fenomeno che caratterizza le TV è l’attivazione eccentrica del miocardio.
L’attivazione del miocardio ventricolare secondo le normali vie di conduzione del
segnale elettrico è necessaria per una contrazione efficace dei ventricoli. Nella TV,
invece, l’attivazione ventricolare è abnorme: dal punto di origine dell’ aritmia (circuito
o focus ) l’impulso segue vie non fisiologiche, con il risultato di una desincronizzazione
tra le varie parti dei ventricoli, in grado di compromettere l’efficacia della
contrazione
La funzione ventricolare sinistra e l’eziologia della TV ne influenzano in modo
determinante le manifestazioni cliniche. In un cuore sano, con normale frazione di
eiezione, il quadro emodinamico è compromesso solamente per le caratteristiche
intrinseche della TV (frequenza, dissociazione ed eccentricità). Una TV in un paziente
con severa disfunzione ventricolare sinistra (bassa frazione di eiezione), invece, può
determinare importanti riduzioni di portata cardiaca anche a frequenze non molto
elevate.
QUADRO CLINICO
La sintomatologia della TV è estremamente variabile, e si possono osservare tanto
pazienti asintomatici quanto pazienti che arrivano a presentare sincope o arresto
cardiocircolatorio. I fattori fondamentali nel determinare la sintomatologia sono la
frequenza dell’aritmia, la durata della stessa e la cardiopatia di base. La sensazione
più comunemente riportata dai pazienti è quella del cardiopalmo, legata all’aumento
della frequenza delle contrazioni ventricolari. In certi casi il paziente può
riferire angor legato in questo caso alla discrepanza (squilibrio tra richiesta e apporto
di O2) soprattutto nei pazienti che presentano di base una cardiopatia ischemica.
Altro sintomo può essere la dispnea, associata alla slatentizzazione di un sottostante
scompenso cardiaco.
All’esame obiettivo va posta particolare attenzione al polso che si presenterà
frequente, piccolo e ritmico. Un dato non raro, e generalmente sottovalutato, è la
variabilità dell’ampiezza del polso, che si rileva in presenza di dissociazione atrioventricolare, cioè in circa il 50% dei casi. Quando l’attività ventricolare è dissociata
da quella atriale, la contrazione degli atri potrà avvenire in qualunque momento del
ciclo cardiaco; se essa cade a valvole A-V chiuse non ci sarà alcun contributo dell’atrio
al riempimento ventricolare, mentre quando gli atri si contraggono poco prima della
sistole ventricolare, nella fase in cui le valvole A-V sono aperte, aumenterà il
riempimento ventricolare, e con esso la gittata sistolica di quel battito. In questa
circostanza anche l’ampiezza del polso sarà maggiore rispetto a quando gli atri si
contraggono a valvole A-V chiuse, e poiché la corretta sincronizzazione A-V (onda P
poco prima del QRS) è casuale, si avrà ogni tanto una pulsazione più ampia, pur
mantenendosi ritmico il polso. L’ascoltazione cardiaca evidenzierà toni ritmici e
tachicardici, con a volte variabile intensità del I tono (la genesi di questo fenomeno è
identica a quella che governa la variabile ampiezza del polso), mentre quella polmonare
potrà essere silente o evidenziare rumori umidi (rantoli a piccole o medie bolle) nel
caso in cui la tachicardia ventricolare porti ad un quadro di edema polmonare.
Infine, a seconda della compromissione emodinamica, subentrano quelli che sono i
sintomi legati alla bassa portata quali l’ipotensione (sudorazione, pallore, etc.), le
vertigini o la sincope (per ipoperfusione della sostanza reticolare).
CENNI DI TERAPIA
Bisogna innanzitutto differenziare la terapia da effettuare in acuto rispetto a quella
volta a prevenire le recidive. Nei casi di TV con compromissione emodinamica trovano
spazio innanzitutto presidi elettrici quali il DC Shock sincronizzato (scariche di
defibrillatore a 200-250 joules) o il pacing ventricolare (stimolazione a frequenze
superiori a quelle dell’aritmia nel tentativo di interromperla). Per quanto riguarda
l’approccio farmacologico, il farmaco più comunemente usato in acuto è la Lidocaina. In
alternativa, è possibile usare l’Amiodarone, la Mexiletina o il Propafenone a seconda
dell’eziologia della TV e dalla cardiopatia di base del paziente.
Per la prevenzione delle recidive va innanzitutto chiarita l’eziologia della TV
(strutturale o idiopatica) e va fatta un’attenta valutazione del paziente, comprendente
un Holter (ECG dinamico delle 24 ore) e, se necessarie, indagini invasive (studio
elettrofisiologico, coronarografia). La profilassi delle recidive verrà condotta
esclusivamente con terapia farmacologia (amiodarone, mexiletina, ß-bloccanti) nei
pazienti a minor rischio, mentre i farmaci verranno affiancati da supporti elettrici
(defibrillatore impiantabile) nei pazienti con rischio più elevato di recidive,
soprattutto in quelli con grave disfunzione ventricolare.
SINCOPE
La sincope è una perdita improvvisa della coscienza e del tono muscolare, di breve
durata e a risoluzione spontanea. E’ la conseguenza dell’ischemia generalizzata di
entrambi gli emisferi cerebrali e/o del tronco. La sincope è un sintomo comune a molte
malattie, al pari della febbre o dell’anemia. La sua importanza deriva da due
considerazioni: la prima, esclusivamente medica, che la sincope può essere
anticipatrice di una morte improvvisa nel futuro prossimo; la seconda, riguardante il
grande impatto emotivo sull’individuo che ne soffre e sulla famiglia, che la sincope
rappresenta una vera interruzione della vita, anche se breve ed a risoluzione
spontanea, così da far pensare che l’esperienza si possa ripetere con risultati non
altrettanto favorevoli. Se l’etimologia della parola significa “interrompere” (dal greco)
bisogna ben considerare
che “the only difference between syncope and sudden death is that in one you wake u
p”.
Il momento fisiopatologico determinate della sincope è la ipoperfusione dell’encefalo,
ma ciò non significa che il fenomeno dipenda necessariamente da una ipotensione acuta
e transitoria. I fattori determinanti la pressione arteriosa sono il volume circolante
nel distretto arterioso, la gittata cardiaca, e le resistenze periferiche. Le alterazioni
di uno o più di questi parametri possono portare alla sincope.
La riduzione della gittata cardiaca può conseguire a diminuzione della gittata sistolica,
a critiche variazioni della frequenza cardiaca (tachicardie o bradicardie estreme ) o a
diminuzione del volume circolante; la riduzione delle resistenze periferiche è l’effetto
di mediatori fisiologici o patologici (farmaci con azione simpaticolitica, eventi riflessi,
malattie neurologiche).
E’ fondamentale tener presente che varie malattie possono mimare la sincope,
soprattutto le epilessie generalizzate non convulsive (crisi di piccolo male), i disturbi
del sonno e le forme psicogene (crisi di ansia generalizzata).
EPIDEMIOLOGIA
La sincope è molto frequente. Si calcola che nel nostro paese vi siano oltre 100.000
casi/anno. Il 75% della popolazione sana va incontro ad almeno un episodio sincopale in
un arco di tempo di 26 anni; nei nostri Ospedali la sincope rappresenta il 3% delle
presentazioni, e nel 25 % dei casi si manifesta una recidiva.
La sincope colpisce tutte le età, con un’incidenza progressivamente crescente con il
passare del tempo. La ricorrenza della sincope è molto frequente, stimata al 30% della
popolazione che già ne ha sofferto.
CLASSIFICAZIONE
La sincope è una fra le transitorie perdite di coscienza. Una adeguata classificazione
deve prendere in considerazione anche quelle affezioni che possono mimare la sincope,
per poter avviare una adeguata diagnosi differenziale. Queste situazioni vengono
spesso indicate come “syncope like” La sincope può essere classificata come segue.
Neuromediata: vasovagale, situazionale, sindrome da ipersensibilità del seno carotideo,
nevralgia glossofaringea e trigeminale
Ipotensione ortostatica: disautonomia, farmaci, deplezione di volume
Aritmica
Cardiopatia strutturale: cardiopatia ischemica, cardiomiopatie , cardiopatie con ostruzione
all’efflusso
Cerebrovascolare: furto della succlavia
Syncope like
Epilessia generalizzata
Sincope psicogena: attacchi di panico, ansia generalizzata
Ipossiemia acuta transitoria: intossicazione da CO, esposizione a base concentrazioni di
ossigeno
La sincope neuromediata è la forma più comune, e consegue ad un riflesso che può
essere scatenato da molteplici fattori (odori, dolore, emozioni, vista di episodi
sgradevoli, prolungata stazione eretta). In genere si accompagna ad un insieme di
sintomi (nausea e/o vomito, pallore, sudorazione) la cui presenza permette un alto
grado di sospetto.
La sincope da ipersensibilità del seno carotideo (SSC), frequente nella popolazione
anziana, è caratterizzata dal fatto che uno stimolo anche lieve, portato nella zona del
seno carotideo (massaggio del seno carotideo – MSC) diventa efficiente nel provocare
la sintomatologia. Questo ha un’evidente corrispondenza in clinica nella comparsa degli
episodi spontanei.
La sincope situazionale, più frequente nel giovane, permette una diagnosi di certezza
solo su base anamnestica (minzione, defecazione, deglutizione).
Marker diagnostico di tutte le forme neuromediate, quando esse sono colte
dall’osservatore o provocate in laboratorio durante il tilt test o il MSC, è la presenza
di bradicardia e/o ipotensione da vasodilatazione, con differente prevalenza dei due
aspetti patogenetici
La sincope ortostatica è comune, e si manifesta a seguito dell’assunzione della
posizione eretta. Può essere accompagnata da sintomi che esprimono la riduzione più o
meno rapida della pressione arteriosa in ortostatismo (sensazione di testa vuota,
vertigine, astenia) con recupero della sensazione di benessere alla riassunzione della
posizione seduta o distesa. Una disfunzione autonomica deve essere sospettata
nell’anziano, associata o meno a sintomi di malattie sistemiche (amiloidosi e diabete) o
neurologiche degenerative (Morbo di Parkinson). Altre cause sono l’uso di farmaci
ipotensivi o di diuretici e alcune malattie endocrine (Ipocorticosurrenalismo primitivo
o secondario).
Le aritmie cardiache sono causa di sincope quando inducono un’eccessiva bradicardia o
tachicardia. Entrambi i fenomeni provocano la caduta della gittata cardiaca e quindi
della perfusione cerebrale. Le bradicardie secondarie a disfunzione del nodo del seno
(sick sinus sindrome) e quelle legate a disturbi della conduzione atrio-ventricolare
(vedi Capitolo 40), sono le più frequenti, seguite dalle tachicardie ventricolari (vedi
Capitolo 39). La perdita di coscienza si può verificare all’inizio dell’aritmia o alla fine,
quando interrompendosi improvvisamente il ritmo anomalo, si registra una pausa
prolungata che precede il recupero del ritmo normale.
La sick sinus syndrome (SSS) esprime una combinazione di bradicardia (sinusale,
pause sinusali, blocchi senoatriali ) e di tachicardia, in genere flutter o fibrillazione
atriale. I periodi di bradiaritmia sono considerati più frequentemente in causa nella
patogenesi della sincope. I disturbi della conduzione AV possono esser causa di
sincope. Si deve dare poca importanza al blocco AV di I grado e a quello di II grado
tipo Mobitz I (Wenckebach), mentre più frequente è la sincope in corso di blocco AV
di II grado tipo Mobitz II o di blocco AV di III grado.
La tachicardia ventricolare (vedi Capitolo 39) è una frequente causa di sincope.
La sindrome del QT lungo congenita o acquisita (vedi Capitolo 42) favorisce la
comparsa di una tachicardia ventricolare a torsione di punta, specialmente in
associazione a periodi di bradicardia o in concomitanza di ipokaliemia.
La tachicardie sopraventricolari sono di rado causa di sincope, solo quando si associano
a bassa gittata; in genere i soggetti anziani sono quelli che presentano più
frequentemente la sincope in corso di tachicardia sopraventricolare .
La malattie cerebrovascolari sono cause rare di sincope. In particolare il furto della
succlavia (vedi Capitolo 53) provoca, in condizione critiche, una ipoperfusione a livello
del circolo cerebrale posteriore che rientra fra gli attacchi ischemici transitori.
Le situazioni raggruppate sotto la dizione “syncope like” comprendono un’ampia varietà
di condizioni morbose, che vanno da crisi epilettiche generalizzate non convulsive
associate a ipotonia muscolare (attacchi di piccolo male), a episodi critici in corso di
ansia generalizzata (crisi di panico), a disturbi del sonno, a episodi di amnesia globale
transitoria. Alcune di queste evenienze sono di facile diagnosi, se accadono in
presenza di testimoni che possono descrivere il comportamento dei paziente, ma sono
di difficile inquadramento quando il paziente ne soffre senza che alcuno sia presente
all’episodio critico.
DIAGNOSI
L’obiettivo primario della strategia diagnostica è definire il profilo di rischio del
paziente: l’obiettivo fondamentale a cui devono mirare le indagini è l’esclusione di una
patologia cardiaca. Quando questa possa essere esclusa, l’identificazione della causa della
sincope permetterà di mettere in atto una serie di provvedimenti che migliorino la qualità
di vita e riducano la morbilità associata. Una volta esclusa la patologia aritmica
(bradicardie o tachicardie critiche), il medico ha a che fare con una sincope anamnestica.
E’ quindi necessario un algoritmo diagnostico che miri alla individuazione delle cause
cardiogene e, una volta escluse queste, alla ricerca di altre malattie.
L’anamnesi è il momento diagnostico più importante poiché permette la diagnosi in oltre il
70% dei casi, specialmente quando essa può essere confermata da un testimone. Nella
pratica clinica, occorre richiedere al paziente di concentrarsi e descrivere l’ultimo evento
critico, poiché si presuppone che esso sia più facilmente riferibile, e successivamente
valutare e confrontare con l’ultimo gli episodi precedenti. Alcuni elementi sono
fortemente indicativi per la diagnosi: si devono valorizzare precedenti patologici quali la
presenza di cardiopatia, di malattie del sistema nervoso centrale, (per esempio, malattia
di Parkinson, epilessia), di morte improvvisa nella famiglia, della recente assunzione di
farmaci, di malattie psichiatriche
Nel dare un peso ai sintomi e ai segni rilevabili durante la raccolta dell’anamnesi si deve
ricordare che nelle forme ospedalizzate la sincope neuromediata giustifica il 66% delle
osservazioni, la forma cardiogena ne comprende l’11% e le forme sincope-like
rappresentano il 6% della casistica. La perdita di coscienza in soggetto con età superiore
a 54 anni, con meno di due episodi, in associazione a palpitazioni orienta per una forma
cardiogena, mentre l’associazione di nausea, sudorazione, visione confusa o sensazione di
testa vuota che precedono o seguono la sincope è indicativo di una forma neuromediata.
La sincope cardiogena appare molto probabile quando vi è rilievo anamnestico di
cardiopatia, mentre l’assenza di cardiopatia anamnestica esclude la sincope cardiogena
nel 97% dei pazienti.
CENNI DI TERAPIA
A stretto rigore di termini dobbiamo parlare di prevenzione delle recidive sincopali
piuttosto che di terapia della sincope. I nostri sforzi sono diretti a prevenire nuovi
episodi sincopali trattando la malattia e i meccanismi patogenetici che sottendono la
sincope.
La sincope neuromediata o vasovagle, di gran lunga la forma più frequente, ha poche
possibilità di un’efficace prevenzione. Molti sono infatti i fattori scatenanti che
devono essere individuati ed evitati. Il paziente deve essere educato ad evitare tutte
le condizioni favorenti e scatenanti il riflesso patogeneticamente efficiente, come gli
ambienti affollati, i luoghi con temperatura eccessiva, le condizioni fisiche e
farmacologiche che favoriscono la disidratazione e l’ipovolemia. Egli dovrà essere
sensibilizzato al riconoscimento dei sintomi premonitori e dovrà conoscere le manovre
che sono in grado di far abortire la crisi sincopale, prima fra tutte il mettersi in
posizione supina non appena egli avverte i sintomi premonitori. Il soggetto deve essere
rassicurato sulle sue condizioni di salute e reso edotto della benignità dell’evento di
cui ha sofferto e della possibilità di una recidiva, al fine di evitare gli aspetti
psicologici, come ansia e depressione, che possono accompagnare uno o più episodi
sincopali. In caso di sincope vasovagale ricorrente e in pazienti molto motivati, la
prescrizione di periodi prolungati di postura eretta od altre manovre fisiche
specificamente orientate possono essere utili nel ridurre gli episodi ricorrenti. Scarsa
indicazione trovano oggi, alla luce delle esperienze attuali, i numerosi farmaci che sono
stati proposti in passato quali i (-bloccanti e i vasocostrittori.
L’impianto di un pacemaker si è dimostrato efficace
nella Sindrome del seno carotideo cardioinibitoria, di cui è ormai diventato il
trattamento di scelta. Lo stesso non si può dire per la sincope vasovagale, che è stata
oggetto di numerosi trial in cui il braccio terapeutico efficace era rappresentato da
un pacemaker. Dopo alcuni studi condotti su popolazioni limitate di pazienti e non in
doppio cieco, è stata dimostrata la non superiorità del trattamento con pacemaker
rispetto al placebo. L’efficacia dei pacemaker, invece, è dimostrata in tutte le forme
da disfunzione del nodo sinusale o da blocco AV (vedi Capitolo 40).
Le tachicardie parossistiche sopraventricolari hanno indicazione all’uso di farmaci
antiaritmici, ed in realtà molte se ne giovano, anche se transitoriamente. L’uso sempre
più diffuso delle tecniche di ablazione transcatetere (vedi Capitolo 60) ha permesso il
successo anche nei casi non sensibili ai farmaci, evitandone gli effetti collaterali e
rendendo permanente l’efficacia della terapia.
Quando è la tachicardia ventricolare a indurre la sincope, trova indicazione il
trattamento farmacologico o l’impiego di specifici device. I farmaci antiaritmici di
Classe I (vedi Capitolo 58) non sono indicati per il loro effetto inotropo negativo;
l’amiodarone è invece il farmaco di scelta per la virtuale assenza di effetti inotropi
negativi. In alternativa, si può impiegare il defibrillatore impiantabile
(ICD, implantable cardioverter defibrillator), che riconosce la tachicardia e la
fibrillazione ventricolare e la tratta con uno shock elettrico in grado di interromperla
IPERTENSIONE ARTERIOSA
Definizione ed epidemiologia
Per “Ipertensione arteriosa” si intende una condizione clinica morbosa caratterizzata
da un aumento anomalo stabile, e non legato a normali variazioni fisiologiche, dei livelli
di pressione arteriosa. Tale aumento riguarda più frequentemente entrambe le
pressioni sistolica e diastolica, ma esistono forme di ipertensione caratterizzate da
aumento solo della pressione sistolica (ipertensione sistolica isolata), condizione più
frequente negli anziani, o più raramente solo della diastolica.
In base alle ultime Linee Guida europee sulla gestione clinica del paziente iperteso, la
presenza di ipertensione arteriosa viene definita arbitrariamente da valori di
pressione arteriosa > 140 mmHg per quanto riguarda la pressione sistolica e/o > 90
mmHg per quanto riguarda la pressione diastolica. Sulla base dei livelli pressori
inoltre, la malattia ipertensiva può essere classificata in 3 diversi gradi di severità
clinica (grado I: 140-159/90-99 mmHg; grado II: 160-179/100-109 mmHg; grado III:
> 180/>110 mmHg) che, come è intuibile, possono avere un diverso impatto sulla storia
naturale della malattia.
L’ipertensione arteriosa viene definita “essenziale” quando non è possibile risalire ad
una eziologia chiaramente identificabile alla base del suo sviluppo, e questa rende
conto di oltre il 90% dei casi di ipertensione arteriosa. Di contro, quando l’aumento dei
valori pressori è secondario a disordini d’altra natura, l’ipertensione arteriosa viene
definita “secondaria”.
L’ipertensione arteriosa essenziale è una condizione di enorme rilevanza
epidemiologica, pressoché ubiquitaria nel nostro pianeta. Nella maggioranza dei casi,
interessa soggetti adulti con prevalenza direttamente correlata all’età. Si presume
che nel mondo vi siano circa 690 milioni di soggetti attualmente affetti da
ipertensione arteriosa. La prevalenza nella popolazione generale è di circa il 20%, ma
sale ad oltre il 50% nella popolazione d’età superiore ai 60 anni. Per quanto riguarda il
sesso, la prevalenza d’ipertensione è maggiore nei maschi quando si considerano
soggetti con età inferiore ai 50 anni, mentre è uguale tra i 2 sessi per età superiori.
In termini sociali, l’ipertensione arteriosa è più frequente nelle zone urbane rispetto a
quelle rurali, in particolare nei quartieri meno agiati, nonché nei Paesi industrializzati,
mentre per quanto riguarda la razza, la prevalenza d’ipertensione è maggiore in quella
nera. In base a queste considerazioni si prevede che entro il 2025 vi saranno nel
mondo oltre 1 miliardo e 200 milioni di ipertesi, con un impatto di gran lunga superiore
a qualunque altra condizione in termini di “carico di malattia”.
EZIOPATOGENESI E FISIOPATOLOGIA
Eziopatogenesi e fisiopatologia
Se l’ipertensione di tipo secondario riconosce i suoi fattori eziopatogenetici nella
malattia primitiva a cui è associata, alla base dello sviluppo dell’ipertensione arteriosa
essenziale vi sono molti fattori causali per lo più non identificati. L’ipertensione
arteriosa essenziale può essere definita una malattia multifattoriale, dove elementi di
tipo genetico ed ambientale agiscono sinergicamente su numerosi processi biochimici e
metabolici che a loro volta sono alla base del suo sviluppo. Tra i fattori ambientali, i
più importanti sono legati allo stile di vita e all’alimentazione, e sono la sedentarietà, lo
stress psichico, l’abitudine tabagica, una dieta ipersodica ed iperlipidica, ed il
frequente ed eccessivo consumo di alcool e caffè. Tra i fattori genetici identificati e
più probabilmente coinvolti, vanno annoverati invece quelli determinanti una maggiore
attività del sistema renina-angiotensina-aldosterone, un aumento costituzionale del
tono adrenergico, un aumento della risposta vascolare a sostanze vasocostrittrici quali
l’endotelina, una ridotta escrezione renale di sodio ed infine una ridotta sintesi
endoteliale di sostanza vasodilatanti (prostacicline, EDRF etc…).
Fisiologicamente la pressione arteriosa è determinata dal prodotto delle resistenze
periferiche per la gittata cardiaca, la quale è a sua volta la risultante del prodotto
della frequenza cardiaca per la gittata sistolica. Pertanto è proprio sulle resistenze
periferiche, la frequenza cardiaca e la gittata sistolica che agiscono i differenti
meccanismi fisiologici che regolano la pressione arteriosa. Per esempio, le resistenze
periferiche sono condizionate dal sistema simpatico, che regola il tono vascolare, così
come lo è la frequenza cardiaca, mentre la gittata sistolica è prevalentemente
regolata dalla contrattilità miocardica e dal precarico, a sua volta correlato alla
volemia. In generale, i meccanismi preposti al controllo della pressione arteriosa
possono essere distinti in meccanismi a breve, medio e lungo termine. Tra i meccanismi
a breve termine possono essere annoverati i sistemi baro- e chemo-recettoriali, che
modificano in pochi secondi il tono simpatico modulando l’attività cardiaca, il tono
arteriolare e i livelli pressori. I meccanismi a medio termine sono invece quelli di tipo
umorale mediati principalmente dal sistema renina-angiotensina-aldosterone, dalla
vasopressina e dal sistema delle chinine. Il rene è invece deputato al controllo a lungo
termine della pressione arteriosa, principalmente attraverso la regolazione della
volemia.
Pertanto qualsiasi alterazione patologica dei suddetti determinanti fisiologici della
pressione arteriosa e dei suoi meccanismi di regolazione può determinare l’insorgenza
di uno stato ipertensivo. In particolare, tra i meccanismi fisiopatologici responsabili
dello sviluppo dell’ipertensione arteriosa essenziale quelli maggiormente implicati sono
legati ad un’alterata omeostasi elettrolitica soprattutto del sodio, al rimodellamento
vascolare, ad un’iperattività del sistema renina-angiotensina-aldosterone, ad una
ridotta sensibilità insulinica ed in ultimo ad una funzione endoteliale alterata.
Un aumento delle concentrazioni organiche di sodio è sicuramente coinvolto nella
genesi della malattia ipertensiva, in particolare attraverso un aumento del volume
plasmatico ed un aumento delle resistenze periferiche. Tuttavia studi clinici hanno
mostrato come solo in una frazione (20-30%) dei soggetti ipertesi una riduzione
dell’introito di sodio determini una significativa riduzione dei valori pressori. Sulla
base di tale risposta individuale alla riduzione dell’introito di sodio è stata coniata la
definizione di ipertensione arteriosa sodio-sensibile.
Anche altri elettroliti sono coinvolti nella genesi dell’ipertensione arteriosa tra cui il
potassio ed il calcio, le cui concentrazioni sono inversamente associate ai valori
pressori. Tuttavia diversi studi che hanno valutato gli effetti di un aumento
dell’assunzione dietetica di potassio e calcio sulla riduzione della pressione hanno
fornito finora risultati controversi.
L’ipertensione arteriosa è associata nella maggior parte dei casi ad un aumento delle
resistenze periferiche, e se nelle fasi iniziali del suo sviluppo tale aumento è spesso
secondario ad una vasocostrizione arteriolare di origine funzionale, dipendente da un
aumentato stimolo da parte di sostanze vasoattive quali catecolamine, angiotensina II
o endoteline, o ad un’elevazione persistente della portata cardiaca, successivamente
un rimodellamento vascolare strutturale è implicato nel perpetuarsi di elevati valori
pressori. Infatti l’incremento della pressione ed il costante insulto meccanico sulle
pareti dei vasi stimolano lo sviluppo di un’ipertrofia delle cellule muscolari lisce
vascolari, con ulteriore riduzione del lume arteriolare, ed il conseguente aumento delle
resistenze periferiche, le quali determinano la persistenza od anche il peggioramento
dello stato ipertensivo, anche quando i potenziali fattori causali iniziali vengano a
mancare.
Tra i determinanti fisiologici del tono vascolare, ha un ruolo primario il sistema reninaangiotensina-aldosterone, il quale esercita importanti azioni regolatorie sulla
pressione arteriosa anche attraverso la regolazione dell’omeostasi elettrolitica e del
riassorbimento di sodio e acqua a livello tubulare; inoltre, attraverso effetti di tipo
autocrino e paracrino, in alcuni tessuti l’attività del sistema renina-angiotensinaaldosterone regola la crescita e la differenziazione cellulare e favorisce lo sviluppo di
fibrosi tissutale, in particolare a livello vascolare. Pertanto, una disregolazione
dell’attività del sistema renina-angiotensina-aldosterone, ad esempio un’attività
sproporzionata rispetto all’assunzione di sodio o ai livelli pressori stessi, determina un
aumento dei valori pressori e progressive modificazioni strutturali vascolari e
cardiache, tali da giustificare l’intervento farmacologico su questo sistema.
Anche l’insulina svolge delle azione regolatorie importanti sulla pressione arteriosa:
legandosi ai recettori tirosin-kinasici essa determina a livello endoteliale una cascata
trasduzionale intracellulare che porta all’aumentata trascrizione genica e
successivamente alla sintesi dell’enzima ossido nitrico sintetasi, il quale catalizza la
produzione di ossido nitrico, sostanza con potente azione vasodilatatoria ed antiinfiammatoria. Quindi nelle condizioni caratterizzate da una ridotta sensibilità
insulinica a livello vascolare si assiste ad una riduzione della sintesi di ossido nitrico
con conseguente aumento delle resistenze periferiche e dei valori pressori. Inoltre,
l’aumento compensatorio delle concentrazioni di insulina negli stati di insulinoresistenza si associa ad un incremento del tono simpatico con un ulteriore aumento del
tono vascolare ed una riduzione della funzionalità endoteliale.
Quest’ultima è sicuramente un altro importante elemento sottostante allo sviluppo di
ipertensione arteriosa. L’endotelio, infatti, svolge importanti azioni protettive a livello
vascolare, attraverso la produzione di sostanze vasodilatanti ad azione autocrina e
paracrina quali l’ossido nitrico, le prostacicline e l’endothelium-derived relaxing factor
(EDRF), ed anche attraverso la produzione di sostanze antitrombotiche (vedi Capitolo
48). Tuttavia quando questo è sottoposto all’azione dannosa dei diversi fattori di
rischio quali fumo e diabete, si realizza a livello vascolare e cellulare un’infiammazione
subclinica ed un aumento dello stress ossidativo, i quali danneggiano le cellule
endoteliali e conseguentemente portano allo sviluppo della loro disfunzione. Quando si
instaura una disfunzione endoteliale vengono meno le suddette funzioni protettive
collegate ad un endotelio integro, con conseguente aumento della reattività vascolare,
aumentata espressione di molecole d’adesione leucocitaria che portano al perpetuarsi
dell’infiammazione vascolare, ed in ultimo un’aumentata suscettibilità alla evoluzione
aterosclerotica e alla formazione di trombosi. Questi processi promuovono in ultima
istanza lo sviluppo di eventi aterotrombotici (vedi Capitolo 46).
IMPATTO CLINICO
Impatto clinico
Nella maggioranza dei casi, l’ipertensione arteriosa non determina lo sviluppo né di
sintomi o disturbi, né di complicanze a breve termine, bensì può decorrere
asintomatica per molti anni, determinando progressive e sempre più gravi alterazioni
strutturali e funzionali a carico del sistema cardiovascolare, renale e cerebrale.
Complicanze anche molto gravi, spesso precedute da alterazioni di tipo pre-clinico,
possono palesarsi improvvisamente con eventi acuti e drammatici quali l’infarto del
miocardio, l’ictus cerebrale e lo scompenso cardiaco.
La relazione tra ipertensione arteriosa ed aumento dell’incidenza di patologie
cardiovascolari fu illustrato in maniera molto chiara dalle ormai mitiche tabelle
elaborate dagli studi condotti da una compagnia assicurativa nordamericana, la
Metropolitan Life Insurance Company, che dimostravano come in una popolazione di
uomini di quarantacinque anni, valori pressori di 130/90 mmHg rispetto a valori
pressori inferiori erano in grado di determinare una riduzione dell’aspettativa di vita
di 3 anni, e, se ci si spingeva fino a valori pressori di 140 su 95 mmHg l’aspettativa di
vita si riduceva di 6 anni. Ancor più, se si consideravano uomini con valori pressori di
150 su 100 mmHg l’aspettativa di vita media si riduceva di 11.5 anni. Una conferma di
questi dati ci è stata fornita da diversi studi epidemiologici tra cui quello condotto da
Wilhelmsen, nel quale veniva dimostrato come l’aumento dei valori pressori anche se
limitato a 10 mmHg, corrispondesse ad un brusco incremento della incidenza di
coronaropatia, anche nell’ambito del range dei valori pressori normali. La Prospective
Studies Collaboration ha comunque fornito le evidenze più importanti sulla relazione
tra ipertensione arteriosa ed aumento del rischio cardiovascolare. Questa analisi ha
preso in esame circa 1 milione di pazienti in 61 studi prospettici osservazionali per 12
anni. A partire da un’età compresa tra 40 e 69 anni, ogni aumento di 20 mmHg di
pressione arteriosa o di 10 mmHg di pressione diastolica è risultato associato ad
aumenti di 2 volte di mortalità per cardiopatia ischemica e circa 4 volte per ictus. La
mortalità vascolare risultava superiore al 50% nella decade 80-89 anni, mentre il
rischio relativo era maggiore nei soggetti più giovani, con un aumento di circa 10 volte.
L’ipertensione arteriosa viene pertanto considerata un classico fattore di rischio per
lo sviluppo di malattie cardiovascolari.
Il significato ed il valore predittivo dei valori di pressione arteriosa nei confronti
delle principali malattie cardiovascolari quali la cardiopatia ischemica e l’ictus
cerebrale è stato già identificato da alcuni decenni. E’ stato a tal proposito
dimostrato che persino nell’ambito di popolazioni non ipertese il progressivo
incremento dei valori pressori corrisponde ad una graduale riduzione dell’aspettativa
di vita. Se da un lato valori pressori elevati sono associati ad un aumento del rischio
cardiovascolare, parallelamente la loro riduzione è in grado di prevenire lo sviluppo di
una considerevole percentuale di complicanze soprattutto di natura cerebrovascolare.
La relazione tra ipertensione arteriosa e rischio cardiovascolare aumentato non è
comunque secondaria solo alla presenza di elevati valori pressori, bensì è una
conseguenza anche di altri fattori di rischio cardiovascolari che sono frequentemente
presenti nel paziente iperteso, quali la dislipidemia, il diabete mellito, l’obesità ed il
fumo. La presenza contemporanea di fattori di rischio multipli è stata indagata nel
corso dello studio di Framingham che ha dimostrato come la presenza isolata
d’ipertensione arteriosa si osservi solo nel 20% dei pazienti, mentre nel 50% dei casi
elevati valori pressori si associano a 2 o 3 fattori di rischio concomitanti. Questa
frequente associazione tra ipertensione arteriosa ed altre anomalie del profilo
metabolico quali il diabete mellito e la dislipidemia suggerisce come queste
associazioni non siano casuali ma siano probabilmente legate alla presenza di fattori
eziopatogenetici comuni alla base dello sviluppo di tali anomalie.
Il riscontro di alterazioni del profilo lipidico caratterizza un’ampia percentuale della
popolazione ipertesa e contribuisce in maniera sostanziale allo sviluppo di complicanze
cardiovascolari. L’alterazione del profilo lipidico più frequentemente associata alla
presenza di ipertensione è certamente l’ipercolesterolemia, presente in oltre il 40%
dei pazienti con valori pressori francamente elevati e con una prevalenza
progressivamente crescente al crescere della gravità del quadro ipertensivo,
supportando un’eventuale correlazione tra tali due fattori di rischio anche in ambito
patogenetico. Dislipidemia ed elevati valori pressori sono inoltre elementi costitutivi
della cosiddetta sindrome metabolica, condizione clinica frequentemente associata
alla presenza di ipertensione arteriosa. Questa sindrome è caratterizzata, da un
punto di vista clinico, dalla presenza di più fattori di rischio associati, mentre da un
punto di vista fisiopatologico dalla presenza di un’obesità viscerale, particolarmente
aterogena, da una condizione di insulino-resistenza, ed infine da uno stato
infiammatorio cronico subclinico.
Anche il diabete mellito di tipo 2 risulta associato frequentemente all’ipertensione
arteriosa con la quale condivide la responsabilità di una significativa quota della
mortalità e morbilità cardiovascolare, nonché alcuni importanti tratti fisiopatologici.
Le conseguenze patologiche dell’ipertensione arteriosa possono essere di tipo
preclinico e clinico; le prime sono caratterizzate da modificazioni strutturali e
funzionali a carico degli organi bersaglio senza che queste si manifestino con sintomi o
segni clinici, le seconde consistono invece in alterazioni organiche più gravi che si
palesano con dei quadri clinici ben definiti, soprattutto l’infarto del miocardio, lo
scompenso cardiaco e l’ictus cerebri.
In generale la conseguenza patologica classica della malattia ipertensiva è lo sviluppo
di aterosclerosi, che vede maggiormente coinvolti il cuore con i vasi arteriosi, il rene
ed il sistema nervoso centrale.
Le principali alterazioni precliniche cardiache associate all’ipertensione sono legate ai
processi di rimodellamento ventricolare sinistro in risposta allo stato ipertensivo e
sebbene siano asintomatiche, configurano comunque una condizione clinica fortemente
predittiva di eventi cardiovascolari futuri, condizione identificata con il termine di
“cardiopatia ipertensiva”. Tali alterazioni cardiache riconoscono nell’ipertrofia
ventricolare sinistra e nella disfunzione diastolica le manifestazioni principali. La
prima è caratterizzata dall’aumento della massa cardiaca soprattutto in risposta
all’aumento dello stress sistolico determinato dalla pressione elevata, e può essere di
tipo concentrico od eccentrico. Il primo tipo è caratterizzato dall’ispessimento delle
pareti ventricolari per la classica apposizione di nuovi sarcomeri “in parallelo”, senza
un aumento della cavità ventricolare, il secondo tipo è invece caratterizzato
dall’aumento del diametro ventricolare consensuale all’aumento degli spessori parietali,
secondariamente all’apposizione, a livello miocardico, di nuovi sarcomeri “in serie”.
La prevalenza di ipertrofia ventricolare sinistra, diagnosticata all’ECG (vedi Capitolo
3) è del 3-8% nei pazienti con ipertensione lieve-moderata, mentre all’esame
ecocardiografico (vedi Capitolo 4) la massa ventricolare è aumentata in ipertesi non
selezionati dal 12 al 30%, e dal 20 al 60% nei centri di riferimento.
L’ ipertrofia ventricolare sinistra diagnosticata con l’ecocardiogramma è un potente
fattore di rischio indipendente per eventi avversi cardiovascolari maggiori, ed aumenti
progressivi della massa ventricolare sono correlati continuativamente con il rischio
cardiovascolare sia negli uomini che nelle donne, come dimostrato in numerosi studi.
Per disfunzione diastolica del ventricolo sinistro s’intende invece l’incapacità di questa
camera cardiaca, durante la diastole, di accogliere il sangue a basse pressioni di
riempimento, per cui il ventricolo può raggiungere un volume telediastolico tale da
garantire un’adeguata gittata sistolica solo a spese di un’aumentata pressione
diastolica la quale, a sua volta, si riflette in un incremento della pressione in atrio
sinistro e nelle vene polmonari.
Dal punto di vista fisiopatologico, la disfunzione diastolica può essere conseguenza di
alterazioni funzionali della fase attiva del rilasciamento ventricolare in protodiastole,
o essere secondaria ad alterazioni della geometria ventricolare sinistra o
dell’architettura miocardica tali da compromettere le fisiologiche proprietà elastiche
del ventricolo sinistro coinvolte nel riempimento telediastolico.
La prevalenza di disfunzione diastolica negli ipertesi anziani è stata stimata intorno al
25%, ed è stato dimostrato come questa rappresenti un predittore indipendente di
eventi cardiovascolari avversi.
Le manifestazioni cliniche cardiache più gravi e comuni dell’ipertensione arteriosa
sono identificate invece nella cardiopatia ischemica, rappresentando l’infarto del
miocardio la più frequente causa di mortalità nel paziente iperteso, e la complicanza
meno efficacemente influenzata dal trattamento antiipertensivo. Le manifestazioni
ischemiche nell’ipertensione arteriosa sono per lo più secondarie alla presenza di
placche aterosclerotiche coronariche, ma spesso possono essere caratterizzate da
una disfunzione del microcircolo subendocardico che determina una riduzione della
riserva coronarica.
La malattia ipertensiva si manifesta anche con lo scompenso cardiaco, di tipo sistolico
o diastolico (vedi Capitolo 19). Il primo si verifica nei pazienti con disfunzione
ventricolare sinistra sistolica insorta secondariamente alla presenza di una
cardiopatia ischemica o di una cardiopatia ipertensiva evoluta attraverso lo sviluppo di
una disfunzione contrattile (evoluzione ipocinetica), il secondo tipo si associa invece ad
una normale funzione contrattile ventricolare e sembra essere secondario alla
presenza di una disfunzione diastolica.
In ultimo, altre complicanze cardiache comuni nell’ipertensione arteriosa sono le
aritmie, in particolare la fibrillazione atriale. Questa aritmia è considerata secondaria
alle modificazioni strutturali dell’atrio sinistro conseguenti all’ aumento cronico delle
pressioni atriali solitamente secondario alla presenza di una disfunzione diastolica.
Complicanze aritmiche più temibili sono invece quelle ventricolari che possono
precipitare in una morte improvvisa. In questo contesto è verosimile che giochino un
ruolo fenomeni di rientro elettrico ventricolare causati da un progressivo
disarrangiamento dell’architettura miocardica, caratterizzato soprattutto da un
aumento della fibrosi interstiziale, frequentemente osservabile nelle alterazioni della
geometria ventricolare sinistra.
L’ipertensione arteriosa ha effetti patologici importanti anche sui reni, infatti circa il
20% degli ipertesi è affetto da insufficienza renale cronica. Tuttavia la progressione
dall’ipertensione non complicata all’insufficienza renale non è rapida, bensì dura anni,
periodo nel quale si verificano progressive alterazioni strutturali a carico dei reni che,
se dapprima non hanno delle ripercussioni funzionali importanti, successivamente
determinano una progressiva riduzione del filtrato glomerulare e lo sviluppo di
insufficienza renale.
Un indice precoce di danno renale preclinico, in particolare negli ipertesi diabetici, è la
presenza di microalbuminuria, che consiste in un’aumentata escrezione di albumina
nelle urine, compresa per definizione tra i 30 ed i 300 mg/die, infatti oltre i 300 mg
questa si definisce invece macroalbuminuria. Un aumento dell’escrezione di albumina
può semplicemente rappresentare una conseguenza dell’aumento della pressione
idrostatica intraglomerulare, ma può anche derivare da un danno della barriera
glomerulare, o da un’alterazione del riassorbimento tubulare dell’albumina filtrata.
Anche la microalbuminuria rappresenta un predittore di rischio indipendente per
eventi cardiovascolari maggiori, particolarmente negli ipertesi diabetici, ed è stato
dimostrato come un rischio aumentato sussiste già per valori di microalbuminuria al di
sotto del “cut-off” di normalità.
Se non trattata, l’ipertensione arteriosa determina con il tempo una progressione
inesorabile del danno renale, particolarmente quando si associa al diabete, verso una
riduzione significativa del filtrato glumerulare con lo sviluppo d’insufficienza renale
cronica, che è anche conseguente all’aumento importante delle resistenze vascolari
intraparenchimali renali. Questa evoluzione spinge i valori pressori ad aumentare
ulteriormente rendendo ancor più grave il quadro clinico e più difficile il trattamento.
Infine, va sottolineato che il danno vascolare tipico dell’ipertensione coinvolge in modo
significativo l’encefalo, in conseguenza dell’accelerato processo di aterosclerosi,
nonché attraverso lo stimolo meccanico costituito dagli elevati valori pressori.
Alterazioni relativamente precoci sono osservate a carico del distretto carotideo, e
possono essere caratterizzate da un lieve ispessimento del complesso intima-media
carotideo, o da lesioni aterosclerotiche non stenosanti, oppure da placche che
determinano stenosi di variabile severità del lume vascolare. Tutte queste alterazioni,
anche quando ancora nello stato preclinico, sono associate ad un rischio aumentato di
sviluppare eventi acuti cerebrovascolari, e per tal motivo una loro precoce
individuazione permette una migliore stratificazione del rischio del paziente iperteso
e di conseguenza la scelta corretta della strategia terapeutica più efficace.
Quando si manifesta clinicamente, la cerebrovasculopatia ipertensiva può essere
caratterizzata da un quadro di emorragia cerebrale, o più frequentemente dall’ictus
ischemico o da un attacco ischemico transitorio (TIA), da un infarto lacunare, od in
ultimo da un’encefalopatia acuta ipertensiva.
IPERTENSIONE ARTERIOSA SECONDARIA
Ipertensione arteriosa secondaria
L’ipertensione arteriosa secondaria rappresenta circa il 5% dei casi di ipertensione ed
è la conseguenza di un disordine primitivo soprattutto di tipo renale od
endocrinologico.
La ricerca di un’ipertensione secondaria dev’essere attuata con massimo scrupolo,
soprattutto nei soggetti giovani, in quanto nella maggior parte dei casi la sua causa può
essere rimossa ed in questi casi l’ipertensione può essere curata evitando una terapia
per il resto della vita. Per tal motivo, quando vi è il sospetto di un’ipertensione
arteriosa secondaria è necessario procedere con la valutazione strumentale del
paziente con l’ausilio di esami specifici.
Ipertensione nefroparenchimale. Tutte le patologie parenchimali renali che determinino una
riduzione dell’escrezione di acqua e sodio, ed un’attivazione del sistema renina-angiotensinaaldosterone provocano lo sviluppo di ipertensione. Uno stato ipertensivo si associa infatti a
malattie renali acute quali l’insufficienza acuta secondaria a cause renali e post-renali o le
sindromi nefritiche, o a disordini di tipo cronico quali il rene policistico e l’insufficienza renale
cronica. Cause più rare di ipertensione nefroparenchimale sono i tumori secernenti renina.
Nel sospetto di un’ ipertensione nefroparenchimale sono utili gli esami ematochimici
per valutare la funzionalità renale, l’esame dell’urine, e in alcuni casi l’ecografia renale.
Ipertensione nefrovascolare. Questa frequente causa di ipertensione secondaria è associata ad
una stenosi mono o bilaterale dell’arteria renale dovuta ad un processo aterosclerotico, o, nel
caso di soggetti giovani soprattutto se donne, alla presenza di una displasia fibro-muscolare. La
riduzione del flusso renale secondaria alla stenosi determinerà un’aumentata e non regolata
secrezione di renina e la successiva formazione di angiotensina II con un aumento della
vasocostrizione periferica, aumento del riassorbimento di acqua e sodio, e incremento rapido dei
valori di pressione arteriosa. Ed è proprio uno sviluppo rapido di uno stato ipertensivo non
controllabile con la terapia medica, od insorto in un paziente giovane, che deve assolutamente
porre il sospetto di un’ipertensione nefrovascolare.
Questa dal punto di vista ematochimico si manifesta con ipopotassiemia, e con un
aumento combinato dei livelli di renina ed aldosterone. Esami strumentali molto utili ai
fini diagnostici sono l’ecocolor-Doppler dell’arterie renali nel caso di stenosi
prossimali, o alternativamente l’angio-TC e l’angio-RM renali. La metodica “gold
standard”, anche se raramente viene impiegata per la prima diagnosi, è l’angiografia
delle arterie renali. Nel sospetto di un’ipertensione nefrovascolare bisogna
prescrivere con estrema cautela ed a bassi dosaggi i farmaci ACE-inibitori, per il
rischio di ipotensioni acute o di una riduzione brusca della perfusione renale con lo
sviluppo di insufficienza acuta.
Iperaldosteronismo primitivo. Le sindromi da eccesso primitivo di mineralcorticoidi sono
rappresentate nel 30% dei casi da un adenoma surrenalico, più frequente nelle donne e nei
bambini, e nel 70% dei casi da un’iperplasia surrenalica. Condizioni più rare sono secondarie al
carcinoma surrenalico o all’iperaldosteronismo sensibile ai glucocorticoidi. Un
iperaldosteronismo va sospettato in presenza di un’ipertensione resistente alla terapia,
eventualmente associata ad astenia, crampi muscolari, poliuria, polidipsia e palpitazioni. Il dato
ematochimico più importante è l’ipopotassiemia associata ad un’aumentata potassiuria, con un
pH ematico che risulta aumentato per incremento dei bicarbonati. I livelli di aldosterone sono
aumentati, mentre quelli di renina soppressi, per cui il rapporto aldosterone plasmatico/attività
reninica plasmatica è generalmente aumentato. Per la diagnosi definitiva di iperaldosteronismo
primario ci si può avvalere di test dinamici di conferma. Tra questi il più diffuso è quello del
”carico salino”: se i livelli sierici di aldosterone non risultano soppressi dopo il test si può fare
diagnosi di iperaldosteronismo primitivo. La diagnosi di iperaldosteronismo può essere
confermata anche dal test di soppressione al fludrocortisone. In presenza di iperaldosteronismo
primario la somministrazione per 4 giorni di fludrocortisone non determina la soppressione dei
livelli plasmatici di aldosterone.
Feocromocitoma. Il feocromocitoma è un tumore del tessuto cromaffine della midollare del
surrene o del tessuto paragangliare, e si manifesta clinicamente attraverso l’ aumentata
increzione di adrenalina e noradrenalina. Il feocromocitoma rappresenta una causa rara di
ipertensione arteriosa, ma se non riconosciuta mette seriamente in pericolo la vita del paziente.
Uno stato ipertensivo è presente in tutti i soggetti affetti, più frequentemente a crisi o talora
cronico. I sintomi più comuni sono l’ansietà, le palpitazioni, la cefalea, l’arrossamento
improvviso del viso (flushing) e le sudorazioni profuse.
La diagnosi di feocromocitoma può essere fatta mediante il dosaggio delle
catecolamine plasmatiche ed urinarie e dei loro metaboliti, più facilmente se i
campioni vengono ottenuti durante le crisi ipertensive. I dosaggi dell’acido
vanilmandelico e delle metanefrine plasmatiche e urinarie frazionate rappresentano gli
esami più attendibili. Nel sospetto diagnostico si può ricorrere anche all’impiego di
test farmacologici di inibizione o stimolazione, con clonidina e glucagone
rispettivamente, o utilizzare subito metodiche d’”imaging” quali l’ecografia, la TC o la
RMN, di solito impiegate per localizzare il tumore.
Coartazione Aortica. La coartazione aortica (vedi Capitolo 52) consiste in una stenosi congenita
dell’aorta generalmente distale all’origine del dotto arterioso che si associa frequentemente ad
altre anomalie quali la bicuspidia aortica gli aneurismi “a bacca” cerebrali. Questa è una causa
rara di ipertensione arteriosa secondaria soprattutto nei bambini e negli adolescenti. La diagnosi
è di solito clinica ed è legata al riscontro di un’ipertensione esclusivamente a livello degli arti
superiori e di un ipotensione a livello degli arti inferiori, alla presenza di un ritardo del polso
femorale rispetto a quello radiale, all’ascoltazione di un soffio continuo al dorso, nella regione
interscapolare, ed alla presenza di una spiccata pulsatilità delle arterie intercostali. La diagnosi
di conferma invece può essere fatta invece agevolmente mediante un angio-TC del torace ed
un’aortografia. La terapia della coartazione aortica può essere percutanea, mediante
l’apposizione di stent, o chirurgica.
Ipertensione indotta da farmaci. Alcune sostanze e farmaci possono determinare
un’ipertensione arteriosa e queste sono: la liquirizia, gli spray nasali vasocostrittori, i
contraccettivi orali, i FANS, i corticosteroidi, la ciclosporina e l’eritropoietina. Fondamentale
pertanto è la ricerca anamnestica dell’uso di tali sostanze per poter effettuare una diagnosi
rapida.
TRATTAMENTO
Trattamento
La finalità principale del trattamento dell’ipertensione arteriosa consiste soprattutto
nella prevenzione dello sviluppo delle sue complicanze cardio- e cerebrovascolari, e tali
benefici terapeutici possono essere raggiunti non solo mediante la riduzione dei valori
pressori, peraltro implicati direttamente nello sviluppo di alcune complicanze, ma
anche attraverso la correzione dei diversi fattori di rischio frequentemente associati
all’ipertensione. Di conseguenza è molto importante, prima di iniziare un trattamento
antiipertensivo, una valutazione clinica globale del paziente che miri a definire al
meglio il suo profilo di rischio cardiovascolare, sia sulla base dell’entità della malattia
ipertensiva, sia sulla base degli altri fattori di rischio associati.
Gli interventi terapeutici antipertensivi possono essere divisi in interventi di tipo non
farmacologico, basati sulle modifiche dello stile di vita e delle abitudini
comportamentali, ed in interventi di tipo farmacologico, basati sull’impiego di diverse
classi di farmaci sia da soli che in associazione tra loro. Sulla base delle ultime Linee
Guida emanate dall’ESH/ESC del 2007 sulla gestione clinica dell’ipertensione
arteriosa, nei pazienti a rischio cardiovascolare basso-moderato in generale è indicato
iniziare solo un trattamento non farmacologico rivalutando dopo pochi mesi i soggetti,
ed associando successivamente un trattamento farmacologico qualora i valori pressori
non risultino controllati. Di contro, nei soggetti a rischio elevato è in genere opportuno
un approccio terapeutico più aggressivo, combinando gli interventi non farmacologici
con una terapia farmacologica (monoterapia o terapia di associazione) (Figura 2).
Interventi di tipo non farmacologico
Gli interventi non farmacologici possono contribuire a ridurre i valori pressori ed il
rischio cardiovascolare globale del paziente iperteso, nonché a favorire un ricorso più
contenuto alla terapia farmacologica. Sebbene siano spesso di non facile attuazione
pratica e non ne siano mai stati documentati in maniera completa gli effetti a lungo
termine sulla morbilità e mortalità cardiovascolare e globale, gli interventi non
farmacologici non presentano (al contrario di quelli farmacologici) controindicazioni di
impiego.
Tre approcci terapeutici si sono dimostrati in grado di esercitare documentati effetti
antipertensivi: il calo ponderale, la dieta iposodica e l’esercizio fisico regolare.
Considerata l’evidenza epidemiologica di una relazione diretta tra peso corporeo,
distribuzione anatomica del grasso corporeo e pressione, non sorprende che una
restrizione dell’apporto calorico si sia dimostrata in grado di ridurre i valori pressori,
essendo l’entità dell’effetto antipertensivo medio pari ad una diminuzione di circa 1,5
mmHg di pressione arteriosa sistolica e 1,3 mmHg di diastolica per ciascun chilo di
peso corporeo perso.
Gli effetti antipertensivi di una restrizione alimentare sodica sono stati oggetto di
numerose meta-analisi, che complessivamente hanno evidenziato un’azione
antipertensiva piuttosto modesta (3-5 mmHg per la sistolica e 2-3 per la diastolica).
La restrizione sodica inoltre, non deve essere marcata (consumo giornaliero <2 grammi
NaCl), perché è stato dimostrato come questa induca effetti metabolici sfavorevoli e
stimoli il sistema renina-angiotensina ed il sistema nervoso adrenergico.
Allo stato attuale pertanto, una modica restrizione sodica (consumo giornaliero <4
grammi NaCI) è indicata nel trattamento del paziente iperteso, specie considerando
come questo intervento non farmacologíco si sia dimostrato in grado di potenziare
l’efficacia antipertensiva della stessa terapia farmacologica.
Infine studi clinici controllati hanno pressoché uniformemente dimostrato che
l’esercizio fisico regolare di moderata intensità (rappresentato da un incremento pari
a circa il 40% del consumo di ossigeno valutato a riposo) è in grado, dopo un congruo
periodo di tempo, di ridurre i valori pressori sisto-diastolici (circa 6-8 mmHg a
seconda dei valori pressori di partenza e del tipo di attività fisica). Tali modificazioni
si accompagnano ad un miglioramento del profilo di rischio cardiovascolare in virtù
degli effetti emodinamici (vasodilatazione) e metabolici favorevoli (miglioramento dell’
insulino-sensibilità e del profilo lipidico) di un training fisico costante.
Interventi antiipertensivi di tipo farmacologico
Il trattamento farmacologico dell’ipertensione arteriosa deve essere intrapreso
quando non si ottengono risultati sufficienti con gli interventi non farmacologici, o
quando i valori pressori basali ed il rischio cardiovascolare del paziente sono molto
elevati.
L’obiettivo terapeutico essenziale della terapia farmacologica è il raggiungimento di
valori pressori ottimali, e se questo non è possibile con l’impiego di un solo farmaco è
consigliabile adottare un’associazione tra due o, se necessario, più molecole. La scelta
del tipo di farmaco da prescrivere ad un paziente iperteso non è però basata solo sulla
efficacia antiipertensiva, bensì anche sui possibili effetti benefici sulla riduzione del
danno d’organo cardiovascolare e renale, su eventuali sue azioni positive sulle
alterazioni metaboliche concomitanti, quali il diabete o la dislipidemia, ed in ultimo,
deve tener conto della tipologia del paziente (età, sesso, comorbidità), degli effetti
collaterali, delle preferenze del paziente, di precedenti esperienze terapeutiche e di
aspetti socio-economici .
Le principali classi di farmaci anti-ipertensivi (vedi Capitolo 58) sono:
Ace-inibitori: sono una classe di farmaci con documentata efficacia antipertensiva, caratterizzata
da effetti benefici sull’apparato cardiovascolare, particolarmente nei pazienti con cardiopatia
ischemica, disfunzione ventricolare sinistra e scompenso cardiaco. Sono molto utili per
rallentare la progressione del danno renale, in particolare nei diabetici, ed hanno un profilo
metabolico sostanzialmente neutro. Principali effetti collaterali sono la tosse, l’ipotensione da
prima dose e raramente l’angio-edema della glottide. Le principali controindicazioni sono
l’insufficienza renale cronica, la gravidanza e la stenosi bilaterale delle arterie renali.
Calcio-antagonisti: i calcio-antagonisti possono svolgere i loro effetti prevalentemente sul cuore
(non diidropiridinici, diltiazem o verapamil) od essere principalmente dei vasodilatatori
periferici (diidropiridinici); quest’ultimi in particolare hanno una spiccata azione antiipertensiva e si sono dimostrati efficaci nel ridurre gli eventi cardiovascolari. Sono molto utili in
prescrizione singola od in associazione con altri farmaci in particolare gli inibitori del sistema
renina-angiotensina-aldosterone.
Bloccanti recettoriali dell’angiotensina II (o sartanici): sono farmaci efficaci e molto ben
tollerati anche in quanto caratterizzati da un’azione farmacologia molto selettiva (blocco dei
recettori AT-1 dell’angiotensina II). Questa classe è particolarmente utile nell’ipertensione
arteriosa, in particolare nei pazienti con danno d’organo sia cardiaco che renale, e con presenza
di diabete o sindrome metabolica.
Diuretici: sono i farmaci antiipertensivi più lungamente sperimentati, e quelli tiazidici sono
particolarmente efficaci nel ridurre l’insorgenza di complicanze cardiovascolari maggiori. Sono
inoltre spesso prescrivibili in associazione precostituita con farmaci inibitori del sistema reninaangiotensina. Le controindicazioni all’uso dei diuretici sono soprattutto la scarsa “compliance”
del paziente legata ad effetti indesiderati ed alcuni effetti collaterali quali lo squilibrio
elettrolitico, in particolare l’ipopotassemia, l’iperuricemia e le alterazioni del metabolismo
glico-lipidico.
Beta-bloccanti: sono particolarmente indicati nei pazienti ipertesi affetti da cardiopatia
ischemica, disfunzione ventricolare sinistra sistolica, tachicardia, oppure ipertiroidismo. Sono
controindicati nei pazienti bradicardici o con turbe della conduzione atrio-ventricolare, con
asma o con broncopneumopatia cronica ostruttiva, con vasculopatia periferica o con insulinoresistenza.
I farmaci antiipertensivi appartenenti a queste classi farmacologiche possono essere
associati tra loro specialmente se presentano meccanismi d’azione diversi e
complementari, se l’efficacia ipotensivante è superiore quando associati rispetto a
quando somministrati in monoterapia, ed in ultimo se l’associazione è ben tollerata.
Altri farmaci antiipertensivi da usare in terapia addizionale, qualora non vengano
raggiunti gli obiettivi, includono gli alfa-bloccanti, in particolare nei pazienti con
ipertrofia prostatica, gli anti-ipertensivi ad azione centrale, soprattutto alfametildopa e clonidina, ed i farmaci anti-aldosteronici, che trovano indicazione
soprattutto nelle forme legate ad iperaldosteronismo e nell’ipertensione refrattaria o
resistente.
URGENZE ED EMERGENZE IPERTENSIVE
Urgenze ed emergenze ipertensive
Le urgenze ed emergenze ipertensive sono forme cliniche caratterizzate da un
notevole rialzo pressorio (solitamente PAD >130 mmHg) che richiedono un
abbassamento rapido della pressione. Queste condizioni possono essere distinte in
urgenze ed emergenze ipertensive. Per urgenza ipertensiva s’intende un marcato e
rapido rialzo pressorio peraltro non associato a segni di danno d’organo acuto cardiaco
o neurologico e possono essere risolte nell’arco delle 24 ore. Le emergenze ipertensive
sono invece quelle situazioni nelle quali, per la presenza di segni di danno d’organo
collegati al rialzo pressorio, e per grave pericolo di vita, è indispensabile una
riduzione della pressione arteriosa entro 1 ora.
Le alterazioni d’organo che possono essere riscontrate nell’emergenza ipertensiva
sono l’infarto miocardico acuto o l’angina instabile, lo scompenso cardiaco acuto, la
dissezione aortica e l’emorragia cerebrale. Un altro tipo particolare ed altrettanto
grave di emergenza ipertensiva è l’encefalopatia ipertensiva, caratterizzata da
disturbi neurologici reversibili come la cefalea, alterazioni visive e dello stato di
coscienza, nausea e vomito. Questa, se non trattata può evolvere rapidamente in uno
stato di coma e successivamente in exitus. La fisiopatologia dell’encefalopatia
ipertensiva è legata alla presenza di una necrosi fibrinoide arteriolare generalizzata e
di una dilatazione sproporzionata delle arterie cerebrali con un conseguente
iperafflusso sanguigno.
Nelle emergenze ipertensive il trattamento deve essere iniziato il più rapidamente
possibile con l’obiettivo non di ottenere l’immediato ripristino di livelli pressori
normali, ma di arrivare a limiti di “sicurezza” senza indurre, nello stesso tempo,
complicanze cerebrali, coronariche o renali legate all’induzione di ipotensione troppo
rapida.
I farmaci di elezione nell’emergenza ipertensiva somministrati per via endovenosa
sono la clonidina, il nitroprussiato o nitroglicerina ed il labetalolo. Di solito è sempre
consigliabile embricare alla terapia endovenosa una terapia per via orale.
CUORE POLMONARE CRONICO
DEFINIZIONE
Si definisce “cuore polmonare” la dilatazione e/o l’ipertrofia del ventricolo destro per
aumento del postcarico dovuto a malattie dei polmoni, della parete toracica, dei vasi
polmonari o dei centri del controllo della ventilazione. Sono escluse dalla definizione di
cuore polmonare le patologie del cuore destro dovute a cardiopatie congenite o a
malattie del cuore sinistro.
FISIOLOGIA DEL CIRCOLO POLMONARE
La circolazione polmonare è interposta tra il ritorno venoso sistemico e
l’atrio sinistro; oltre a rivestire un ruolo chiave negli scambi dei gas, il circolo
polmonare concorre alla regolazione biochimica, termica ed umorale del
sangue. In condizioni normali, la forza che guida il sangue attraverso il
polmone dipende in ugual misura dal ventricolo destro e dalla respirazione. La
funzione di pompa del ventricolo destro, tuttavia, diviene rilevante solo in
condizioni patologiche. In alcune procedure cardiochirurgiche (ad esempio
l’intervento di Fontan), infatti, si esegue un by-pass del ventricolo destro,
mettendo in comunicazione diretta l’atrio destro con l’arteria polmonare,
senza che il ritorno venoso al cuore sinistro venga compromesso; ciò dimostra
come la circolazione polmonare possa avvenire normalmente anche senza il
contributo del ventricolo destro.
La caratteristica principale del circolo polmonare è che le pressioni sono
basse. Per generare ed aumentare il flusso del sangue occorre superare la
pressione di apertura dei vasi, reclutare progressivamente nuovi vasi e
dilatare quelli già aperti. La relazione tra la pressione guida (differenza tra
pressione arteriosa polmonare media e pressione atriale sinistra) e il flusso,
perciò, è curvilinea e non origina dallo zero degli assi cartesiani
La resistenza vascolare è la relazione tra pressione e flusso. Nel circolo
polmonare si misura la resistenza vascolare arteriolare, con la formula
seguente:
e la resistenza vascolare totale, la cui formula è:
FISIOPATOLOGIA DEL CUORE POLMONARE CRONICO
Il ventricolo destro assume un ruolo molto importante in presenza di malattie del
polmone o del circolo polmonare. In un cuore normale, la portata cardiaca comincia a
ridursi quando la pressione polmonare sistolica è 30-40 mm Hg. Il ventricolo destro
non è in grado di tollerare pressioni di 60-80 mm Hg, ma se il sovraccarico di
pressione si instaura gradualmente, il ventricolo si ipertrofizza e si dilata, riuscendo a
mantenenere pressioni molto più alte, in alcuni casi addirittura superiori a quelle del
ventricolo sinistro.
Ci può essere ipertensione polmonare in caso di: a) malattie cardiache congenite, b)
malattie a carico del cuore sinistro (atrio, valvola mitrale, ventricolo, valvola aortica),
c) malattie respiratorie, e d) malattie che interessano il circolo polmonare. Per
definizione solo le condizioni c e d possono essere causa di cuore-polmonare.
Vasocostrizione ipossica
In presenza di ipossia alveolare, i vasi che portano sangue agli alveoli interessati dalla
ipossia si costringono. Se localizzato, questo è un meccanismo di difesa utile perché
riduce la perfusione di alveoli poco efficienti, favorendo la perfusione di alveoli
normossici. Se il fenomeno è generalizzato, o comunque interessa una grossa parte del
polmone, si sviluppa ipertensione polmonare ipossica. Questa permette di reclutare
nuovi vasi polmonari ma, se la portata si mantiene, fa aumentare il lavoro del ventricolo
destro. L’ipossia alveolare può essere acuta (apnee del sonno), subacuta (ARDS, edema
polmonare da alta quota) o cronica (patologia polmonare, della parete toracica o del
controllo della ventilazione). In presenza di ipossia cronica, le arterie polmonari
sviluppano uno strato muscolare che aumenta progressivamente, in rapporto alla
durata ed all’entità dell’ipossia alveolare. Esistono fattori che aumentano la risposta
ipertensiva all’ipossia alveolare, quali l’aumento della PaCO2, l’aumento dell’ematocrito
che incrementa la viscosità del sangue, l’aumento o la riduzione importante del volume
polmonare ed, infine, la riduzione anatomica o funzionale del letto vascolare
polmonare. Bisogna ricordare che la resistenza vascolare polmonare dipende dal
volume polmonare: per i vasi alveolari aumenta con l’aumento del volume polmonare,
mentre per i vasi extra-alveolari si riduce con l’aumento del volume polmonare. La
somma dà la effettiva resistenza vascolare alla capacità funzionale residua.
Episodi di ipossia alveolare, come quelli associati alle apnee notturne, possono causare
o concorrere a causare cuore polmonare. Un esempio classico di questo è il cuore
polmonare della sindrome di Pickwick (obesità, sonnolenza, policitemia) o quello dei
“russatori” per alcool, bronchite cronica, obesità.
L’ipossia alveolare cronica si sviluppa in corso di ipoventilazione alveolare e si associa
ad ipercapnia. Le cause includono enfisema, fibrosi polmonare, patologia polmonare
restrittiva e bronchite cronica.
Restringimento meccanico dei vasi
Le modificazioni dei volumi polmonari hanno un ruolo importante nella genesi dell’
ipertensione polmonare. In presenza di malattia polmonare ostruttiva, il volume del
polmone aumenta. Inoltre si può sviluppare il fenomeno del “air-trapping” per
l’insufficiente flusso espiratorio. Se la ventilazione aumenta, questo fenomeno diviene
sempre più rilevante con zone di polmone che per l’insufficiente espirazione sono ad
alta pressione e comprimono i vasi. In questo caso, per mantenere il flusso deve
esserci un ulteriore aumento della pressione vascolare. Anche la riduzione del volume
polmonare si associa ad aumento della resistenza vascolare polmonare.
Sovraccarico pressorio attorno al cuore destro
Il cuore è circondato in gran parte dal polmone. Nel cuore polmonare la rigidità del
polmone è significativamente aumentata, e ciò aumenta il lavoro esterno, quello
soprattutto del ventricolo destro, le cui pareti sono sottili e meno potenti di quelle del
ventricolo sinistro. Il movimento del cuore in sistole e diastole è a maggiore costo
energetico in presenza di polmone rigido.
Aumento della portata cardiaca
L’ ipossia alveolare riduce il contenuto arterioso di ossigeno. Questa riduzione è
compensata da un aumento dell’emoglobina e dall’aumento della portata cardiaca.
Quest’ultima è un ulteriore elemento di sovraccarico per il cuore destro.
QUADRO CLINICO
Non ci sono sintomi specifici di dilatazione e/o ipertrofia del ventricolo destro, ma il
quadro clinico è dominato dalla malattia che causa il sovraccarico ventricolare. In
presenza di scompenso del cuore destro si ha un aumento della pressione venosa
sistemica, da cui dipendono edemi declivi, turgore giugulare, epatomegalia ed ascite.
Le sindromi che possono essere alla base del cuore polmonare cronico sono: a) malattia
polmonare ostruttiva, b) malattia polmonare restrittiva, c) malattia polmonare mista
(ostruttiva e restrittiva) e d) malattie vascolari polmonari.
Malattia polmonare ostruttiva
Il quadro clinico è quello del fumatore, con frequenti episodi di bronchite soprattutto
nei mesi invernali. Il paziente riferisce a volte sintomi correlati all’incremento della
CO2, quali confusione mentale e disorientamento. I segni più frequenti sono quelli
legati all’aumento della pressione venosa (turgore giugulare, epatomegalia, edemi
declivi) e quelli dipendenti dall’ipossia, come la cianosi labiale e delle estremità; è quasi
sempre presente tachicardia sinusale e non di rado fibrillazione atriale.
La radiografia del torace dimostra un cuore ingrandito, salienza del secondo arco di
sinistra per dilatazione dell’arteria polmonare ed aspetto ad albero potato della
vascolatura polmonare in periferia.
I test di funzione respiratoria dimostrano riduzione di FEV1, FEV1/FVC e capacità
vitale, ed aumento consistente del volume residuo. La diffusione alveolo-capillare è
ridotta.
L’emogasanalisi dimostra ipossiemia e ipercapnia. La somministrazione incongrua di
ossigeno può peggiorare il quadro emogasanalitico.
L’ECG mostra ingrandimento dell’atrio destro e ipertrofia ventricolare destra (vedi
Capitolo 3).
L’ecocardiogramma rivela l’ipertrofia e la dilatazione del ventricolo destro, ed anche
l’ipertensione polmonare, valutata con metodica Doppler. La terapia è la sospensione
del fumo, la riduzione del rischio di recidiva delle infezioni delle vie aeree e dei
polmoni, la riabilitazione respiratoria, l’uso di broncodilatatori e mucolitici, l’impiego
congruo di ossigeno .
La terapia farmacologia dell’ipertensione polmonare secondaria non ha successo.
Malattia polmonare restrittiva
Le malattie restrittive che portano al cuore polmonare cronico hanno prognosi
infausta. Si possono riconoscere due gruppi di malattie restrittive: il primo comprende
le alveoliti fribrotizzanti, le pneumoconiosi, le malattie della gabbia toracica e del suo
apparato neuro-muscolare. Tutte queste malattie portano ad insufficienza ventilatoria
con iperventilazione.
Il secondo gruppo di malattie restrittive che portano a cuore polmonare è
caratterizzato fin dall’ inizio da ipoventilazione. La terapia delle fasi più avanzate è
solo il supporto ventilatorio.
Malattia polmonare mista (ostruttiva e restrittiva)
I due quadri possono essere presenti: l’ aspetto clinico più tipico è quello del fumatore
obeso.
Malattie vascolari polmonari
L’ostruzione o la distruzione del letto vascolare polmonare può causare ipertensione
polmonare che, a sua volta, porta a cuore polmonare. In questo caso la pressione
polmonare può essere molto elevata, più che nelle forme ipossiche.
L’ipertensione polmonare può essere post-embolica, di solito successiva a molti episodi
embolici più o meno sintomatici e spesso clinicamente non riconosciuti, oppure causata
da vasculopatia per ipertensione polmonare primitiva (vedi Capitolo 51) o associata a
varie vasculiti.
L’incidenza dell’ipertensione polmonare post-embolica è minore di quanto ci si
potrebbe aspettare dal numero di embolie ritrovate all’autopsia: ciò dipende
verosimilmente dall’estensione del letto vascolare polmonare e dai potenti meccanismi
trombolitici dell’endotelio polmonare.
EMBOLIA POLMONARE
DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA
L’embolia polmonare (EP) è l’occlusione acuta del tronco o di un ramo dell’arteria
polmonare, che determina un ostacolo allo svuotamento del ventricolo destro e
un’interruzione del flusso ematico nel distretto polmonare a valle dell’occlusione. Il
grado di compromissione emodinamica e respiratoria dipende dalla dimensione
dell’embolo, che può interessare la biforcazione dell’arteria polmonare (embolo a sella)
o un suo ramo
L’incidenza dell’EP è dello 0.5-1‰, con un rapido incremento dopo i 60 anni di età. La
mortalità per EP è >15% nei primi 3 mesi dalla diagnosi.
FISIOPATOLOGIA
Un aumento della resistenza arteriosa polmonare è l’effetto dell’ostruzione del vaso
da parte dell’embolo e, in parte, della liberazione di serotonina dalle piastrine del
trombo. Sul versante respiratorio si verifica una diminuzionedegli scambi gassosi – con
ipossiemia nelle forme più gravi – derivante da: a. dissociazione tra ventilazione e
perfusione polmonare, con estensione dello spazio morto respiratorio all’area
interessata dall’EP; b. shunt di circolo a livello polmonare, per apertura di anastomosi
artero-venose; c. ridotta compliance polmonare, dovuta a perdita di surfactante e ad
edema alveolare. Il subitaneo innalzamento del postcarico per l’ostruzione vascolare
polmonare può produrre dilatazione del ventricolo destro e rigurgito tricuspidale. La
dilatazione del ventricolo destro, cui può accompagnarsi aumento dei livelli circolanti
di BNP, determina una deviazione del SIV verso sinistra, limitando il riempimento
diastolico del ventricolo sinistro. Questo evento, insieme con il ridotto precarico
ventricolare sinistro secondario all’insufficienza ventricolare destra può causare
diminuzione della gittata sistolica, della pressione arteriosa sistemica e della
perfusione coronarica.
QUADRO CLINICO
La dispnea è il sintomo più frequente dell’EP. Un dolore toracico tipico è presente in
caso di ischemia miocardica, specie in soggetti con precedente cardiopatia. Altri
sintomi comuni sono la tosse, la sincope e l’emottisi. L’esame clinico mostra quasi senza
eccezione tachicardia, e a volte distensione delle vene del collo, accentuazione della
componente polmonare del II tono e cianosi. E’ utile classificare l’EP in diversi quadri
clinici, per attuare la migliore strategia terapeutica e determinare la prognosi.
Un’EP massiva interessa almeno la metà del circolo arterioso polmonare, è spesso
bilaterale e induce facilmente cianosi, ipotensione arteriosa, sincope e shock
cardiogeno.
I pazienti con EP da moderata a sub-massiva, che interessa all’incirca 1/3 del circolo
polmonare, mostrano una PA normale, che maschera l’instabilità emodinamica del
ventricolo destro (ipocinesia, insufficienza tricuspidale).
Nell’EP lieve un trombo di modeste dimensioni si disloca nella periferia del parenchima
polmonare e può interessare il foglietto pleurico con comparsa di dolore pleuritico e
tosse. Un infarto polmonare può prodursi in questa sede in capo a 3-7 giorni,
associandosi a febbre, leucocitosi, emottisi ed un quadro radiologico tipico. La
pressione arteriosa è normale e la funzione del ventricolo destro conservata.
DIAGNOSI
Per giungere alla diagnosi di EP è di grande importanza maturarne il sospetto, sulla
base del profilo di rischio, dell’anamnesi e della recente storia clinica. Peculiare dell’EP
è la rapida insorgenza dei sintomi, inaspettata rispetto alle preesistenti condizioni
cliniche del paziente. Occorre poi integrare questi dati con l’esame fisico e con gli
esiti delle indagini di laboratorio e strumentali.
Test clinici e di laboratorio.
Il test semi-quantitativo a punti di Wells, rappresentato da 7 domande da porre al
paziente, ha un valore diagnostico di esclusione dell’EP quando rivela un punteggio =4.
Il dosaggio del D-dimero nel plasma è molto sensibile ma poco specifico, perché esso
può aumentare nel decorso post-chirurgico come pure in caso di IMA, sepsi, cancro e
patologie sistemiche in generale. Elevatissimo è il suo potere predittivo negativo
(>99%): virtualmente, nessun paziente con EP in atto risulta negativo al dosaggio del
D-dimero. Elevati valori ematici di biomarker cardiaci, quali troponina e BNP correlano
con il grado di compromissione funzionale del ventricolo destro e rappresentano un
indice predittivo di eventi e di morte cardiaca. La troponina si libera in presenza di
microinfarti; il BNP è secreto dai cardiomiociti in risposta all’aumentato stress di
parete.
La misura dell’ipossiemia non appare discriminante per la diagnosi di EP poiché non
meno del 20% dei pazienti mostra una PaO2 normale. Inoltre, per quanto la maggior
parte dei pazienti con EP siano ipocapnici a causa dell’iperventilazione, la differenza in
O2 alveolo-arteriosa è normale nel 15-20% dei casi.
Tecniche strumentali e di imaging.
Pazienti con EP possono mostrare un ECG del tutto normale, ovvero con manifestazioni
di interessamento ventricolare destro (blocco di branca incompleto o completo), un
aspetto S1Q3T3 (onda S in D1, onda Q e T invertita in D3), sopraslivellamento di ST
in V1-V2 e T negative da V1 a V4 . Inoltre, l’ECG serve ad escludere un infarto
miocardico acuto.
La radiografia del torace presenta anormalità in non più del 25% dei casi; il reperto
più comune è la cardiomegalia. In taluni casi l’esame identifica aspetti patognomonici,
quali l’oligoemia zonale, indice di un’EP massiva e centrale, una densità periferica a
forma di cuneo, indice di infarto polmonare, o una distensione dell’arteria polmonare
discendente destra .
L’ecocardiografia transtoracica (ETT) è una tecnica aspecifica, poiché l’esame risulta
nella norma in circa la metà dei pazienti con EP. Del resto, l’enorme diffusione e
rapidità d’esecuzione dell’ETT, insieme con l’elevata sensibilità nell’apprezzare la
dilatazione e la disfunzione del ventricolo destro, la rendono preziosa per la
stratificazione del rischio in pazienti con EP già diagnosticata. Segni di EP deducibili
con l’ETT sono la rara visualizzazione diretta del trombo, il movimento anormale del
setto interventricolare, il rigurgito tricuspidale, la dilatazione dell’arteria polmonare,
il mancato collasso inspiratorio della vena cava inferiore. Infine, l’ETT può escludere
altre patologie, quali infarto miocardico acuto, dissezione aortica o pericardite.
La TC del torace con contrasto e.v. è divenuta il test di imaging elettivo nella maggior
parte dei pazienti con fondato sospetto di EP (potere predittivo negativo >99%;).
Apparecchi di ultima generazione sono destinati a soppiantare l’angiografia polmonare
come gold standard per la diagnosi dell’EP, consentendo l’acquisizione in pochi secondi
dell’intero torace con una risoluzione inferiore a 1 mm. D’altra parte, la TC fornisce
informazioni dettagliate sulle dimensioni e la funzione del ventricolo destro.
La scintigrafia polmonare rappresenta oggi un’indagine di seconda scelta in caso di
sospetta EP, mentre è riservata a pazienti in gravidanza, oppure con insufficienza
renale o allergia al contrasto.
La risonanza magnetica (RM) angiografica utilizza un mezzo di contrasto non
nefrotossico e pressoché esente da reazioni allergiche. Sensibilità e specificità
diagnostiche sono paragonabili a quelle della TC di prima generazione, consentendo
l’identificazione di EP segmentarie. La RM è in grado di valutare anche la funzione del
ventricolo destro.
Tecniche invasive
L’angiografia polmonare è idonea a riconoscere emboli di 1–2 mm quali difetti di
riempimento vasale intraluminale. Segni secondari di EP sono la netta interruzione di
un vaso, l’oligoemia segmentale o una totale mancanza di circolo ed una fase arteriosa
prolungata. L’angiografia è riservata ai pazienti con TC non diagnostica o che devono
essere sottoposti ad embolectomia transcatetere o trombolisi mirata.
Nella pratica clinica, è auspicabile un approccio diagnostico integrato, esemplificato
dal diagramma in Esso prevede a. l’anamnesi indirizzata al profilo di rischio
tromboembolico, l’esame fisico e il calcolo dell’indice di Wells; b.un ECG ed una
radiografia del torace; c. il dosaggio del D-dimero che, se negativo, esclude l’EP in
soggetti con indice di Wells =4; d. la TC o la scintigrafia polmonare, nonché l’ecografia
venosa degli arti.
In sintesi, l’EP può essere esclusa in pazienti con bassa probabilità clinica e D-dimero
negativo, così come in quelli a rischio elevato, ma con TC negativa.
Purtroppo, per quanto il test del D-dimero per l’esclusione dell’EP e quello della TC per
la sua visualizzazione abbiano nettamente perfezionato la sensibilità diagnostica, l’EP
rimane ancora ardua da diagnosticare e quadri di EP sub-massiva o moderata
rimangono non riconosciuti in non meno del 50% dei pazienti.
ANEURISMA E ANEURISMA DISSECANTE
L’aneurisma è una dilatazione localizzata permanente di un’arteria. Nel caso di
interessamento dell’aorta si parla di aneurisma se si verifica un aumento del diametro
di almeno il 50% rispetto a quello normale del vaso. Laclassificazione degli aneurismi
aortici è cruciale per formulare una diagnosi corretta e pianificare il trattamento.
Essa si basa sulla forma (fusiforme se coinvolge l’intera circonferenza del
vaso, sacciforme se solo una parte risulta dilatata), sulle dimensioni
(macroaneurisma e microaneurisma), sulla struttura (vero o falso) e sulla eziologia (gli
aneurismi possono essere la conseguenza di un
processo congenito, degenerativo, infettivo, infiammatorio o meccanico-traumatico).
Particolare importanza riveste poi l’individuazione della sede. Sulla base
della localizzazione, infatti, gli aneurismi aortici si distinguono in toracici, toracoaddominali ed addominali . Dal punto di vista eziologico, la causa più frequente è quella
degenerativa, visto che l’aterosclerosi è responsabile del 90% degli aneurismi aortici.
Il processo aterosclerotico (vedi Capitolo 46), che induce nella parete arteriosa la
formazione di placche fibrose o ateromatose, può creare un’atrofia della tonaca media
che a sua volta esita in indebolimento della parete, con conseguente ectasia e
dilatazione aneurismatica. Tra le cause congenite si distinguono quelle idiopatiche da
quelle dovute a un difetto del tessuto connettivo, come la sindrome di Marfan o a
quella di Ehlers-Danlos. Tra quelle infettive distinguiamo le forme micotiche,
sifilitiche e tubercolari; gli aneurismi che ne derivano vengono classificati come falsi o
pseudoaneurismi, in quanto sono conseguenti alla rottura del vaso con formazione di un
ematoma delimitato da tessuto connettivo periavventiziale, che risulta connesso al
lume originario attraverso un orifizio a livello del punto di rottura. Infine, tra le cause
infiammatorie sono la malattia di Takayasu, l’arterite a cellule giganti, la malattia di
Behcet, la poliarterite nodosa e il lupus eritematoso sistemico. Dal punto di
vista patogenetico, vi sono due fattori comuni a tutte le forme aneurismatiche: la
debolezza strutturale e la forza meccanica che, insieme alle cause specifiche per
ciascuna forma (deficit genetico del tessuto connettivo, infezione, infiammazione,
traumi), contribuiscono alla genesi e alla progressione degli aneurismi. Si suppone che
il cedimento strutturale del vaso sia conseguente alla disgregazione del collagene (alla
cui composizione concorre in maniera preponderante la presenza di elastina) contenuto
nell’avventizia aortica.
La predisposizione del tratto addominale dell’aorta a subire questa patologia dilatativa
è dovuta a una ridotta presenza di lamelle elastiche nel contesto del tessuto
connettivo avventiziale, che comporterebbe la diminuita elasticità del vaso.
A ciò si aggiunge il fatto che i vasi nutritivi della parete arteriosa, i vasa vasorum,
sono quasi del tutto assenti a livello dell’aorta sottorenale. Questi dati anatomici
possono predisporre alla degenerazione aneurismatica il tratto sottorenale dell’aorta,
se esposto a fattori locali o sistemici sfavorevoli, come accade in presenza di una
patologia aterosclerotica. Lo sviluppo dell’aneurisma, a sua volta, provoca localmente
stasi di sangue che, unitamente al danno intimale, favorisce il deposito di trombi e
quindi l’ulteriore indebolimento della parete arteriosa.
L’assottigliamento della parete che ne deriva, accompagnato a progressiva dilatazione,
comporta una riduzione della resistenza, favorendo l’ulteriore dilatazione. Applicando
la legge di Laplace, che mette in correlazione la tensione parietale con il raggio del
vaso e la pressione transmurale, si può affermare che per una data pressione
transmurale, la tensione parietale è direttamente correlata al raggio, per cui
all’aumentare del diametro del vaso si assiste a un incremento della tensione
esercitata sulla parete arteriosa e quindi ad una ulteriore tendenza alla dilatazione.
SINTOMI E SEGNI CLINICI
Esistono manifestazioni sintomatologiche e segni clinici comuni per tutte le forme
aneurismatiche e altre specifiche a seconda del distretto interessato.
Il sintomo principe di ogni malattia, il dolore, varia la sua localizzazione che può essere
toracica, addominale o posteriore con localizzazione lombare e/o dorsale. La
compressione da parte dell’aneurisma su strutture contigue può comportare, nel caso
di un aneurisma a localizzazione addominale, disturbi gastrointestinali quali nausea,
perdita di peso o ittero. In caso di erosione duodenale si può assistere a
sanguinamento intermittente o ad emorragia massiva. Possono essere presenti sintomi
correlati all’apparato urinario in caso di compressione ureterale. Se, invece, la
compressione avviene a livello di strutture poste nella cavità toracica come la trachea
o i bronchi possono manifestarsi dispnea e tosse. L’erosione del parenchima polmonare
o delle vie aeree può provocare emottisi, e l’erosione dell’esofago disfagia od
ematemesi. La trazione del nervo vago a livello dell’arco aortico può provocare paralisi
del nervo laringeo ricorrente, con raucedine. Sono comuni l’embolizzazione distale di
trombo o di frammenti ateromasici e la graduale ostruzione e trombosi dei rami
viscerali e delle arterie degli arti inferiori.
Circa tre quarti dei pazienti portatori dell’aneurisma aortico più comune, quello
addominale, sono asintomatici al momento della diagnosi, che viene generalmente
effettuata in seguito al riscontro di una massa pulsante addominale o come rilievo
occasionale in corso di altre indagini. Un vago e discontinuo dolore addominale è spesso
presente, ma questo diventa costante e importante solo quando, in seguito a una
rapida espansione dell’aneurisma, si verifica uno stiramento del sovrastante peritoneo.
In questo caso la palpazione in sede epigastrica accentua la dolenzia che si può anche
irradiare posteriormente in sede lombo-dorsale. Lo shock è conseguenza di una
fissurazione o di una franca rottura aneurismatica.
L’esame clinico può evidenziare una pulsazione addominale patologica sia all’ispezione,
in particolar modo se il soggetto è magro, che alla palpazione, che permette di
individuare la massa pulsante in sede epigastrica. Talvolta l’aneurisma si accompagna a
un soffio addominale. L’ecografia rappresenta l’esame di primo livello in caso di
sospetto aneurisma aortico. Per l’aneurisma toracico, la metodica diagnostica è
l’ecocardiografia transesofagea, mentre nel caso di localizzazione addominale si
esegue più semplicemente un esame ecografico con metodica Doppler o color-Doppler
che, oltre a visualizzare e a permettere di misurare con accuratezza la dilatazione
vasale fornisce informazioni sul flusso e consente di distinguere il lume canalizzato
dal trombo parietale e di visualizzare con accuratezza l’origine dei vasi che nascono
dall’aorta.
E’ possibile ottenere delle informazioni, seppur parziali, anche da una radiografia, che
sia a livello toracico che addominale può mostrare uno slargamento dell’immagine del
vaso sottolineata dalle calcificazioni della parete.
L’aortografia ha il limite di valutare solo il lume pervio dell’aorta. L’esame
imprescindibile in previsione di un intervento chirurgico è rappresentato dalla TC, in
particolar modo con mezzo di contrasto (Angio-TC) , che analizza la parete aortica, il
lume ed i rami emergenti. Le nuove metodiche TC permettono anche una ricostruzione
tridimensionale dell’intera estensione aortica).
SINDROME AORTICA ACUTA
La sindrome aortica acuta può insorgere per rottura aneurismatica, dissezione
aortica, ulcera penetrante, ematoma intramurale o lesioni traumatiche (penetranti o
contusive). In questi casi ci si trova davanti a una condizione di emergenza chirurgica
gravata da un alto tasso di complicanze. L’evenienza più frequente è la rottura
dell’aneurisma, che presenta una mortalità operatoria del 50% circa; la mortalità,
tuttavia, aumenta a oltre il 90% se si prende in considerazione anche il decesso che
avviene prima dell’arrivo in ospedale. Il forte dolore toracico o addominale con
irradiazione posteriore, accompagnato da shock, indirizza verso la diagnosi di rottura.
La terapia chirurgica è volta ad arrestare il sanguinamento e a ripristinare la
continuità aortica. Il successo della procedura è strettamente condizionato dal tipo di
rottura (libera o tamponata), dallo stato emodinamico del paziente e dalla possibilità
di un rapido controllo del sanguinamento della lesione aortica quando il paziente si
presenta instabile per un’emorragia attiva.
Il trattamento si avvale delle due opzione terapeutiche già descritte: la terapia
convenzionale o quella endovascolare. La morbilità legata all’esposizione chirurgica e al
clampaggio aortico sempre toracico, o comunque sopra-renale, anche in caso di
aneurismi addominali, rende in particolari condizioni vantaggioso l’approccio
endovascolare, che risulta efficace e sicuro anche in condizioni anatomiche
favorevoli.
ISSEZIONE AORTICA
La dissezione aortica, in precedenza definita come aneurisma dissecante, è la
condizione in cui il sangue penetra nella parete aortica attraverso una lacerazione
intimale, e si fa strada all’interno della tonaca media, creando un “falso lume”. La
dissezione della media può estendersi per un lungo tratto (anche per tutta l’aorta) e
interessare i rami che nascono dall’aorta; in diversi casi il sangue che riempie il falso
lume torna poi nel lume vero attraverso una breccia distale.
Dal punto di vista anatomo-patologico, questa lesione dell’aorta è uno
pseudoaneurisma, perché l’intima (il lume vero) non è realmente aneurismatica, ma la
dilatazione del falso lume (che di solito è il più ampio dei due lumi) dà luogo a un
allargamento dell’aorta al di là delle sue dimensioni normali, per cui è stato attribuito
a questa condizione il termine di “aneurisma”.
Esistono due sistemi di classificazione quello di Standford e quello di DeBakey: se è
interessata l’aorta ascendente, l’arco dell’aorta e l’aorta discendente si parla di tipo A
secondo Stanford, che corrisponde al tipo I e II di DeBakey . Se l’aorta ascendente
non è interessata si parla di tipo B di Stanford, che corrisponde al tipo III di
DeBakey.
La lesione anatomo-patologica tipica riscontrata nei pazienti con dissezione aortica
acuta di tipo B (che sono di solito anziani e spesso ipertesi) è la degenerazione
muscolare liscia all’interno della tonaca media. Nei pazienti con dissezione di tipo A,
che sono in genere più giovani, si assiste invece a un’alterazione congenita del tessuto
connettivo della tonaca media dell’aorta (medionecrosi cistica) con conseguente
degenerazione del tessuto elastico.
Quadro clinico. Le dissezioni aortiche diagnosticate entro due settimane dall’inizio del
dolore o degli altri sintomi d’esordio vengono classificate come acute, mentre quelle
diagnosticate più tardivamente sono definite croniche.
Il sintomo più comune è un fortissimo e lancinante dolore toracico anteriore o
posteriore, interscapolare, dovuto allo stiramento dell’avventizia aortica da parte
dell’ematoma dissecante. La migrazione del dolore fa pensare che la dissezione si stia
espandendo o estendendo. Si può anche manifestare un quadro di shock (per rottura
intra-pericardica dell’aorta con tamponamento cardiaco o per rottura intra-toracica
con sanguinamento). L’esordio può avvenire, sebbene di rado, con un quadro di infarto
miocardico causato da dissezione coronarica. L’ampia costellazione di sintomi e segni
concomitanti (ictus, paraplegia, ischemia degli arti superiori o inferiori, anuria, dolore
addominale per ischemia renale o mesenterica) è correlata al coinvolgimento, da parte
della dissezione, dei rami aortici distali e alla conseguente compromissione della
perfusione dei diversi organi irrorati da tali rami.
Il dolore toracico va distinto da quello di tutte le altre malattie, cardiovascolari e non,
che possono essere responsabili di questo sintomo: infarto miocardico, pericardite,
embolia polmonare, pneumotorace, malattie dell’esofago, affezioni ossee, nevralgie,
etc. A parte i casi non frequenti di dissezione coronarica e correlato infarto
miocardico, l’Elettrocardiogramma e il dosaggio dei marker di necrosi miocardica sono
normali nei pazienti con dissezione aortica, permettendo una immediata esclusione
della cardiopatia ischemica.
In una percentuale non minima dei casi l’ascoltazione del cuore rivela un’insufficienza
aortica massiva, prima assente, provocata dalla dilatazione della radice aortica, con
mancato collabimento delle cuspidi valvolari in diastole.
La diagnostica strumentale si avvale dell’ecocardiografia transtoracica, ma
soprattutto di quella transesofagea e della TC con mezzo di contrasto.
Nella dissezione acuta di tipo A, il primo obiettivo terapeutico è rappresentato, in
attesa dell’intervento chirurgico, daltrattamento dell’ipertensione, per prevenire la
rottura dell’aorta nel pericardio o nello spazio pleurico, ed evitare il coinvolgimento
degli osti coronarici o della valvola aortica o il danno irreversibile multiorgano.
L’intervento chirurgico consiste nella sostituzione protesica dell’aorta ascendente e
della parte prossimale dell’arco.
Nel caso di dissezione acuta di tipo B spesso si preferisce la terapia medica, mentre
l’intervento chirurgico viene riservato a pazienti giovani, a basso rischio, con
dissezione non complicata, allo scopo di prevenire una rottura, e consiste nella
sostituzione protesica del segmento di aorta toracica discendente che contiene le
lesioni più gravi. Nella dissezione cronica, sia di tipo A che B, l’indicazione chirurgica
tiene presente che i fattori di rischio più frequenti per una rottura aortica sono il
diametro aortico, l’eccentricità della dilatazione e una rapida espansione (maggiore di
1 cm per anno). Pertanto, si pone indicazione all’intervento chirurgico in caso di
dilatazione dell’aorta ascendente superiore a 5,5 cm oppure pari a 5 cm, quando
coesistano patologie del tessuto connettivo, specialmente la Sindrome di Marfan, o in
caso di dilatazione dell’aorta discendente superiori o pari a 6 cm o più, o se è presente
una familiarità per connettivopatie.
L’approccio endovascolare prevede l’impianto di una endoprotesi a copertura della
dissezione prossimale per ripristinare il flusso ematico nel lume vero compresso. La
procedura, che prevede l’eventuale stenting del flap intimale in caso di malperfusione
d’organo, si pratica soprattutto nei casi di dissezioni di tipo B non complicate.
L’ULCERA PENETRANTE AORTICA consiste in una lesione della lamina elastica
interna da parte di un processo ateromatoso che si estende sino alla tonaca media. La
sua evoluzione naturale è rappresentata dall’ematoma intramurale, dalla dissezione o
dallo pseudoaneurisma, con conseguente possibile rottura vasale. Il suo riscontro
occasionale non implica necessariamente il trattamento, che si rende invece
necessario in caso di sintomatologia o di rapida progressione. La metodica terapeutica
maggiormente indicata è rappresentata dal trattamento endovascolare atto a
escludere la lesione.