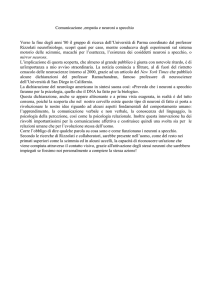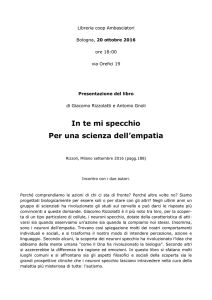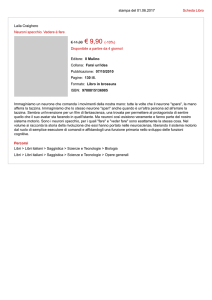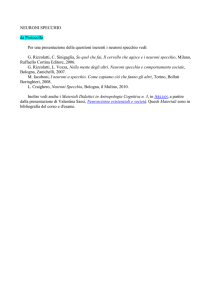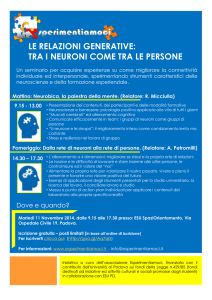All’origine dell’interazione con gli altri
Marina Savi intervista Vittorio Gallese
All’inizio degli anni novanta l’equipe di neurofisiologi dell’Università
di Parma diretta dal professor Giacomo Rizzolatti ha individuato, in un’area
del cervello normalmente deputata al controllo dei movimenti, la presenza
di neuroni, denominati poi neuroni specchio, che rendono possibile in modo immediato la comprensione delle azioni e delle emozioni altrui. La scoperta dei neuroni specchio ha avuto un grande impatto filosofico, soprattutto in relazione a un tema centrale della riflessione teoretica come l’intersoggettività. Proprio per la rilevanza che questo ha rivestito nell’indagine fenomenologica, si è avviato un proficuo dialogo tra neuroscienze e filosofia
che ha visto tra i suoi maggiori protagonisti il professor Vittorio Gallese.
Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo rivolto alcune domande sulla sua attività.
Come si è giunti alla scoperta dei neuroni specchio?
La scoperta dei neuroni specchio è stata compiuta nel corso di ricerche
sull’area premotoria della corteccia cerebrale dei macachi. Deriva dall’osservazione di un fenomeno che non era l’oggetto della nostra ricerca, eppure l’esito del nostro lavoro era già in qualche modo implicato nell’impostazione epistemologica che stavamo seguendo. Alla fine degli anni settanta il
nostro gruppo, sotto la direzione del professor Giacomo Rizzolatti, era impegnato nello studio di un settore della corteccia motoria che fino ad allora
si riteneva fosse deputato unicamente al controllo dei movimenti. Da una
serie di esperimenti risultò invece che quest’area non è un campo uniforme,
ma al suo interno comprende regioni che funzionalmente svolgono attività
diverse. Innanzitutto qui si trovano neuroni che non hanno solo proprietà
motorie, ma anche sensoriali, per cui ‘scaricano’ non solo quando la scimmia compie dei movimenti, ma anche quando, per esempio, riceve uno stimolo tattile su una parte del suo corpo o osserva degli oggetti. Infine la sco-
La società degli individui, n. 35, anno XII, 2009/2
perta più importante di tutte: questi neuroni motori non sono unicamente
deputati al controllo dei movimenti ma di atti motori, cioè di movimenti eseguiti per conseguire uno scopo. Viene perciò introdotto il concetto di teleologia, che entra a pieno titolo fra le caratteristiche dell’architettura funzionale del sistema motorio. Nonostante questo concetto incontri molta diffidenza anche presso ampi settori scientifici, un’altra serie di esperimenti ne
ha confermato la pertinenza a descrivere i fenomeni osservati: i neuroni del
sistema motorio non hanno infatti solo un ruolo esecutivo, non servono cioè
unicamente a contrarre i muscoli, ma possono mappare qualcosa di astratto
come uno scopo. Con un’altra serie di esperimenti si è poi dimostrato che
alcuni di questi neuroni – i neuroni canonici – hanno la proprietà di attivarsi anche quando la scimmia si limita a osservare un oggetto, senza nessun
impegno motorio da parte sua. Ma c’è di più: i neuroni ‘scaricano’ solo se
l’oggetto ha le stesse caratteristiche di prensione, come quello codificato
dal punto di vista motorio. L’aspetto più interessante è perciò costituito dal
fatto che questi neuroni sono verosimilmente responsabili di quel processo
che chiamiamo trasformazione visuo-motoria per cui la forma di un oggetto, che è l’oggetto di una nostra azione potenziale, viene tradotta nel programma motorio richiesto qualora si desideri conseguire uno scopo particolare che prevede l’interazione attiva con l’oggetto. Questo dimostra come
già nella scimmia, cioè in una specie prelinguistica, l’osservazione di un
oggetto non sia un processo unicamente visivo. Al di là dell’aspetto puramente passivo della sensorialità visiva, vedere un oggetto significa non solo
ricostruirne iconicamente la forma, ma anche catalogarlo in modo implicito, dal punto di vista motorio, catturandone l’intrinseca inerenza al soggetto
che lo percepisce. Questa inerenza è naturalmente di tipo pragmatico. Secondo questa prospettiva l’oggetto acquista una valenza significativa solo
in virtù della propria relazione dinamica con il soggetto, rispetto al quale è
il polo di una sua azione potenziale. Mi permetto perciò di sottolineare la
pertinenza dell’esito dei nostri studi con la concezione heideggeriana per la
quale all’uomo il mondo si dischiude come progetto delle sue azioni. Gli
oggetti del nostro mondo acquistano significato non solo in virtù della mera
presenza, del loro starci dinanzi, secondo la modalità propria dell’approccio
teoretico-conoscitivo, ma anche grazie al loro essere per noi a portata di
mano (zuhanden), cioè del loro appartenere al nostro orizzonte pragmatico.
Il sistema motorio gioca anche una funzione decisiva nel rapporto con i
nostri simili?
Il passo ulteriore è stata la scoperta che alcuni di questi neuroni non
‘scaricano’ nel momento in cui presentiamo l’oggetto alla scimmia, ma in
116
un momento antecedente, quando cioè noi andiamo ad afferrare l’oggetto
per presentarglielo. Questa è una genuina risposta di tipo visivo a uno stimolo evocato dall’osservazione di un movimento analogo a quello che veniva eseguito dalla scimmia. Nasce da qui la metafora del rispecchiamento
per connotare la proprietà di questi neuroni – i neuroni specchio – presenti
nella corteccia premotoria dei primati non umani e dell’uomo, che si attivano sia quando compiamo un’azione sia quando la vediamo eseguire dagli
altri. Ci consentono quindi di comprendere il significato di un’azione compiuta da un altro, proprio in virtù del fatto che questa fa parte del nostro patrimonio pragmatico ed esperienziale. In altri termini, chi osserva utilizza le
proprie risorse neurali per penetrare il mondo dell’altro dall’interno, mediante un meccanismo automatico e prelinguistico di simulazione motoria.
Questi neuroni permettono perciò una modalità diretta, sicuramente non
mediata linguisticamente, di rapportarci con l’agire dell’altro che ci mette
in grado di comprendere implicitamente il significato di ciò che l’altro fa,
dal momento che questo viene mappato dai circuiti nervosi che consentono
a noi di compiere gli stessi atti motori.
Secondo il modello cognitivista classico si possono comprendere le azioni e le emozioni solamente nei termini di lettura della mente altrui, con
un’inferenza: quali nuove prospettive introducono i neuroni specchio?
Questa scoperta neuroscientifica permette di interpretare in termini radicalmente nuovi il rapporto fra azione, percezione e cognizione. Il modello
del cognitivismo classico è stato rappresentato nella sua versione standard
in modo caricaturale da una filosofa americana, Susan Hurley, con la metafora del sandwich: parte fondamentale è la cognizione, in periferia stanno
azione e percezione, oltretutto connesse da un flusso di informazione unidirezionale. Ciò significa che io costruisco una rappresentazione del mondo
esterno che si origina attraverso i miei canali sensoriali attraverso la percezione, la quale a sua volta fornisce le informazioni ai miei apparati cognitivi che prendono deliberazioni. Il sistema motorio entra in gioco solo alla
fine per tradurre in movimenti ciò che è stato deliberato al livello più astratto della cognizione. Questo modello risulta falso, in primo luogo perché il funzionamento dei neuroni specchio dimostra che il rapporto fra azione e percezione è bidirezionale. Azione e percezione sono intrinsecamente connesse e questa interconnessione tra il dominio sensoriale e quello
dell’azione gioca un ruolo decisivo anche in molti aspetti cognitivi della
nostra vita di relazione. Nel caso specifico dei neuroni specchio l’intera-
117
zione fra azione e percezione è fondamentale per determinare processi di
base che rendono possibile l’intersoggettività: capire che cosa fa l’altro.
118
La società degli individui, n. 35, anno XII, 2009/2
Thomas Jones, Case a Napoli, 1782
Al sistema dei neuroni specchio è correlato il meccanismo della simulazione incarnata: in che cosa consiste? In che cosa questa teoria si distingue da quella del filosofo analitico Goldman?
In breve tempo queste evidenze empiriche hanno suscitato l’interesse
del mondo filosofico, innanzitutto sul versante fenomenologico. Il primo
che si è interessato ai neuroni specchio è infatti il fenomenologo francese
Jean-Luc Petit, che mi sollecitò a leggere Husserl. Anche sul versante analitico si manifestò interesse: nel 1998 presentai i risultati della nostra ricerca nel corso della conferenza Toward a science of consciousness a Tucson,
in Arizona. In quell’occasione conobbi il filosofo analitico Alvin Goldman,
che mi espose il suo modello della teoria della simulazione: secondo questa
ipotesi la comprensione reciproca delle persone richiede che ci si metta ‘nei
panni altrui’, utilizzando la propria mente per identificarsi con gli altri mediante l’immaginazione. Proprio in quella conferenza progettammo di scrivere insieme un lavoro, pubblicato nello stesso anno col titolo I neuroni
specchio e la teoria della simulazione. Da allora ho continuato a sviluppare
le mie riflessioni su questi argomenti, al punto che attualmente mi sento di
prendere distanza da molte delle affermazioni espresse in quell’articolo. In
primo luogo, la teoria della simulazione elaborata da Goldman è un modello ancora molto debitore a un’idea della mente di tipo rappresentazionalista; tanto è vero che Goldman negli scritti successivi e soprattutto nel saggio che ha pubblicato nel 2006, Simulating Minds: The Philosophy, Psichology and Neuroscience of Mindreading, opera una distinzione di livelli: una
simulazione di basso livello, supportata dall’attivazione dei neuroni specchio che consentirebbe un approccio interpersonale nei termini di un meccanismo di rispecchiamento, e una simulazione di livello superiore. Quest’ultimo processo avviene mediante una forma di introspezione: mi metto
nei panni dell’altro, per poi attribuire all’altro il risultato della mia attività.
La simulazione di alto livello non esclude comunque una componente di tipo teoretico. Anzi, per Goldman, gli aspetti più sofisticati della simulazione
sono di tipo logico-inferenziale. Mi è stato necessario parecchio tempo per
approfondire queste tematiche. Le ho sviluppate sia nella direzione della
ricerca empirica e della riflessione teorica, sia sulla base dei principali temi
della letteratura fenomenologica. Sono giunto in questo modo all’ipotesi
della «simulazione incarnata» (embodied simulation). Con questo aggettivo
sottolineo il mio distacco dalla teoria della simulazione proposta da Goldman. Il termine «incarnata» nel suo significato più immediato sta a indicare
che riposa su una proprietà del nostro sistema cervello-corpo. Ma è incarnata in un senso più interessante, e cioè in quanto descrive un meccanismo
119
funzionale fondato su una codifica di tipo isomorfo. Ciò significa che noi
comprendiamo implicitamente le azioni e le emozioni altrui utilizzando la
simulazione correlata all’attivazione dei neuroni motori e viscero-motori
che sottendono la nostra esperienza in prima persona di azioni ed emozioni.
Per esempio, mappo il disgusto altrui sui correlati viscero-motori che si attivano quando sono io a provare disgusto. Ciò vale anche per l’espressione
del dolore altrui, che innesca quella matrice di circuiti nervosi che si attivano quando sono io a provare dolore. Quindi l’aggettivo «incarnato» indica
proprio l’isomorfismo rappresentazionale su cui poggia il meccanismo della simulazione. Il termine «rappresentazione» è però impiegato qui in una
accezione molto diversa da quella impiegata dal cognitivismo classico,
perché prescinde da una codifica di tipo linguistico, sebbene possa essere
anche astratta. Per esempio, nel caso dell’azione, il suo scopo è mappato in
un formato rappresentazionale che è motorio, ma nello stesso tempo astratto perché prescinde da chi fa l’azione, da come la fa e da qual è il canale
sensoriale attraverso cui percepiamo l’azione. Gli stessi neuroni si attivano
infatti sia quando la scimmia rompe la nocciolina, sia quando la vede rompere da qualcun altro, sia quando sente soltanto il rumore prodotto caratteristicamente da quell’azione.
Una delle principali difficoltà del dialogo tra le neuroscienze e la filosofia riguarda il linguaggio che subisce uno scarto nel passaggio da un
ambito di ricerca a un altro. Quale difficoltà ha incontrato a questo riguardo?
Possiamo iniziare dalla denominazione dei neuroni che abbiamo scoperto: la metafora dello specchio non rende pienamente conto del fenomeno
che inizialmente pensavamo potesse descrivere. E ciò è emerso anche nel
dialogo con la fenomenologia. Lo specchio infatti si limita a riflettere quello che c’è, mentre questi neuroni ‘rispecchiano’ tenendo conto del vissuto
del soggetto; quindi quest’attività non è qualcosa di fisso, ma un meccanismo che si costruisce nello sviluppo ontogenetico, basandosi sulle esperienze pregresse del soggetto, quando si trova a ‘rispecchiare’ il comportamento dell’altro. Questo aspetto è stato messo a fuoco solamente negli ultimi anni. Vale la pena ricordare che le neuroscienze sono giovanissime, se
paragonate alla filosofia, e che quella dei neuroni specchio è una scoperta
piuttosto recente. Non sorprende perciò che molte domande risultino ancora
inevase. Ritengo quindi particolarmente proficuo il dialogo con la filosofia
perché consente alle neuroscienze di formulare correttamente le questioni
fondamentali. D’altra parte credo che i risultati della ricerca neuroscientifica possano contribuire allo sviluppo della riflessione filosofica, non però
120
in un senso verificazionista, ma nella direzione di incoraggiare la ricerca su
quelle tematiche che possono avere una traduzione sul piano empirico, seppure con tutte le cautele che si richiedono dal punto di vista epistemologico
quando si passa da un ambito di indagine a un altro. Non è nelle finalità
della ricerca neuroscientifica porsi come arbitra nelle riflessioni filosofiche,
ma credo possa aiutare nella decostruzione di certi termini. L’aspetto più
problematico è sicuramente la costitutività linguistica: solo per il fatto che
usiamo delle parole, crediamo che a queste debba corrispondere ontologicamente un oggetto a cui quelle parole si riferiscono. Il problema è sapere
quale sia la natura dell’oggetto denotato dall’espressione linguistica. Questo diventa cruciale quando ci s’imbatte, per esempio, in un programma di
ricerca che intende localizzare in una determinata area del cervello le intenzioni e i desideri. Una simile impostazione dell’indagine risulta inficiata da
una difficoltà, che le neuroscienze possono aiutare a decostruire. Definizioni linguistiche, come quella di intenzione, non si traducono necessariamente in entità reali nel cervello. Per quanto riguarda le intenzioni, infatti,
lo stato delle ricerche attesta che la loro possibilità rientra nelle complesse
funzioni del sistema motorio, come è venuto delineandosi nel corso dell’evoluzione. Indagini che adottano un modello teorico ritenuto valido a priori
e lo applicano sperimentalmente individuandone una sede nel cervello, sono destinate al fallimento. Talora accade infatti che, dopo aver localizzato
nel cervello le false credenze per esempio, si scopra che i soggetti, in cui
quelle aree cerebrali risultano compromesse, continuano ad attribuire false
credenze.
E a proposito del termine empatia, che è certamente fra i più problematici dal punto di vista filosofico?
Ho infatti cercato di impiegarlo il meno possibile. Per questo nel 2001
ho coniato l’espressione «sistema della molteplicità condivisa» (shared manifold of intersubjectivity) per indicare uno spazio intersoggettivo noi-centrico, in cui ci relazioniamo agli altri riconoscendoli come nostri simili. La
problematicità del termine «empatia» deriva dal fatto che è stato utilizzato
per descrivere fenomeni dell’intersoggettività molto diversi, che vanno dal
contagio emozionale all’empatia cognitiva alla partecipazione emotiva e alla simpatia. Se a questo si aggiunge che negli ultimi anni soprattutto nella
letteratura anglosassone il termine «empatia» è impiegato per caratterizzare
esclusivamente la sfera emozionale-affettiva dell’intersoggettività, escludendo completamente la dimensione dell’azione, allora l’espressione non
risulta pertinente ai risultati della nostra ricerca. Diversi filosofi si sono impegnati a fare chiarezza intorno all’uso di questo termine; ritengo però che
121
Edith Stein abbia dato il contributo più convincente in questo senso nel suo
saggio espressamente dedicato al problema, in cui definisce l’empatia come
una forma di intersoggettività che ci consente di cogliere la nostra somiglianza con l’altro. La simulazione incarnata spiega quei fenomeni che possiamo definire «empatia» solo in senso lato. Questa è una condizione necessaria, ma verosimilmente non sufficiente perché si possa infatti parlare
di condivisione.
È forse a questo punto che la filosofia può intervenire per fornire un
quadro generale del fenomeno della relazione intersoggettiva, che tenga
conto dei diversi livelli su cui si articola?
Le neuroscienze si trovano a fronteggiare un altro problema, quello della ‘fallacia mereologica’, vale a dire la tendenza ad attribuire alle parti di un
organismo caratteri che sono propri dell’intero. Avendo come oggetto un
organo, il cervello, non possono rendere conto naturalmente dell’individuo
nella sua totalità. Il modo in cui spieghiamo il comportamento e le emozioni altrui richiede necessariamente un livello di competenza personale che
non può essere interamente ridotto all’attività subpersonale di gruppi di
neuroni. Dalla secca della fallacia mereologica si esce con una necessaria
cautela epistemologica maturata anche nel dialogo con la filosofia. Le neuroscienze contribuiscono a definire i meccanismi funzionali dell’intersoggettività, sul piano subpersonale, che permettono poi al filosofo di interpretare la relazione con l’altro sul piano personale in modo diverso, indicando
i vari livelli in cui si articola l’esperienza intersoggettiva. Gli studi sperimentali mettono così a disposizione della riflessione filosofica un patrimonio di osservazioni che può dare un nuovo impulso al dibattito su questi
temi.
Sulla base del fenomeno del rispecchiamento, attivato dalla simulazione
incarnata, possiamo comprendere l’altro non solo nell’aspetto per cui ci
somiglia, ma anche nella sua differenza?
Già a livello di simulazione incarnata io faccio parte di un mondo in cui
l’altro costituisce l’altro polo della relazione. Noi ‘non nasciamo autistici’,
poi acquisiamo competenze interpersonali. Costruiamo la nostra identità già
a partire da uno spazio ‘noi-centrico’, quindi nel nostro Sé è già implicata
l’esperienza di un altro, e di un altro che ha somiglianze con noi, ma anche
differenze, altrimenti cadremmo nell’aporia di ritenere possibile solo la conoscenza di noi stessi. Il rispecchiamento infatti non è mai totale. Il carattere di alterità dell’altro può essere identificato prendendo in considerazio122
ne per esempio il fatto che quando sono io a compiere un’azione o a provare un’emozione vi sono aree del cervello che si attivano esclusivamente o
con una maggiore intensità rispetto a quando è l’altro a farlo. Da recenti
studi sperimentali sul disgusto, per esempio, risulta che esperienze diverse,
come provarlo in prima persona, vederlo espresso sul volto dell’altro o solamente immaginarlo, pur avendo alla base un sostrato neuronale comune,
attivano anche altre aree differenti di volta in volta. Rimangono naturalmente aperte diverse questioni, che però possiamo studiare in modo proficuo solo se le affrontiamo da una molteplicità di punti di vista. Prima di tutto da una prospettiva comparativa per cercare di costruire la conoscenza
dell’uomo in una cornice genetico-evolutiva: nella scimmia infatti, diversamente che nell’uomo, abbiamo la possibilità di registrare i singoli neuroni,
quindi possiamo leggere gli studi sui primati per interpretare i risultati delle
indagini sulla nostra specie. Un contributo significativo è anche fornito dagli studi sull’età evolutiva, per quanto riguarda l’importanza del comportamento mimetico, che caratterizza la nostra specie fin dalle prime fasi di sviluppo post-natale. Fondamentale è infine il rapporto con la fenomenologia,
con cui condividiamo l’interrogativo sul modo in cui si costruisce la nostra
identità intersoggettiva. Ricordiamo che Husserl nell’ultima fase della sua
riflessione si è dedicato in particolare alla difficoltà di coniugare l’alterità
dell’altro con la radice del riconoscimento che è comunque, per lui, egologica.
Se già a livello neuronale possiamo identificare un meccanismo che favorisce l’instaurarsi di una relazione intersoggettiva, come spiegare allora
le così gravi forme di intolleranza diffuse nella società odierna?
Interpretare i neuroni specchio come il fondamento dell’altruismo su basi organiche è inesatto e fuorviante. La simulazione incarnata crea uno spazio intersoggettivo in cui riconosco nell’altro un mio simile; ma questo processo non va inteso necessariamente in termini positivi. Se si tiene conto
che è in questione il riconoscimento dell’altro, possiamo pensare si tratti,
più verosimilmente, dello spazio del conflitto. Sotto questo riguardo, mi sono avvicinato al pensiero dell’antropologo francese René Girard e in particolare alla sua teoria del desiderio mimetico. Mi riferisco in modo specifico
all’idea che la tendenza all’imitazione, connaturata in noi, ci porta a desiderare gli oggetti desiderati dagli altri. Non desideriamo però l’oggetto dell’altro per le sue proprietà intrinseche, ma in quanto è proprio l’oggetto dell’altro che per noi è un modello da imitare. Quindi l’altro media i contenuti
dei miei desideri. Ne deriva un rapporto ambivalente: l’altro è un modello
ma contemporaneamente un rivale. In questo caso la mediazione si trasfor123
ma in conflitto, perché l’altro è colui che compete con me per l’appropriazione dell’oggetto. La rivalità mimetica è perciò all’origine della disgregazione del gruppo sociale. L’umanità trova la soluzione a questo con il sacrificio vittimario, poiché indirizza la violenza sul capro espiatorio. Il confronto con Girard è interessante perché permette di mettere in luce che la
mimesi porta al conflitto ma anche all’identificazione con l’altro con cui
condivido diverse caratteristiche. Questo confronto però è tuttora in fase di
approfondimento; ciononostante mi preme metterlo in evidenza perché conferma il mio impegno per un approccio ampio e interdisciplinare al problema dell’intersoggettività e dell’intelligenza sociale.
124