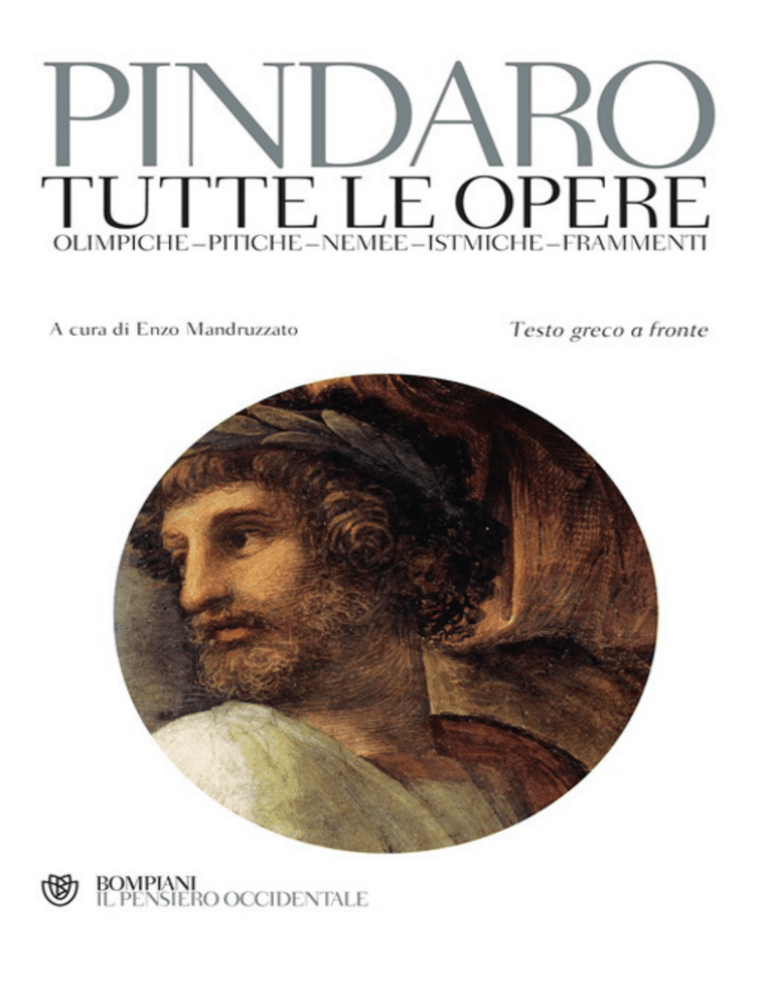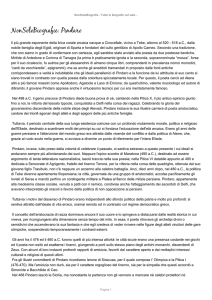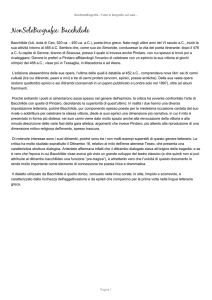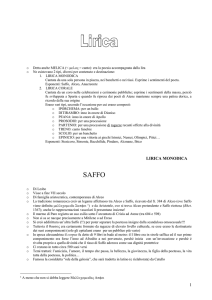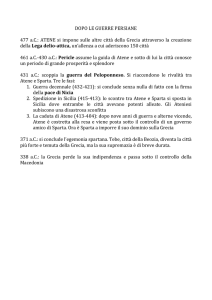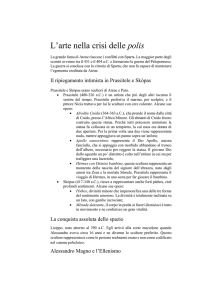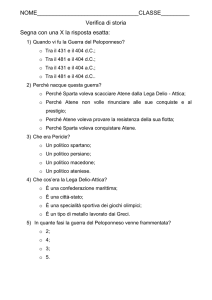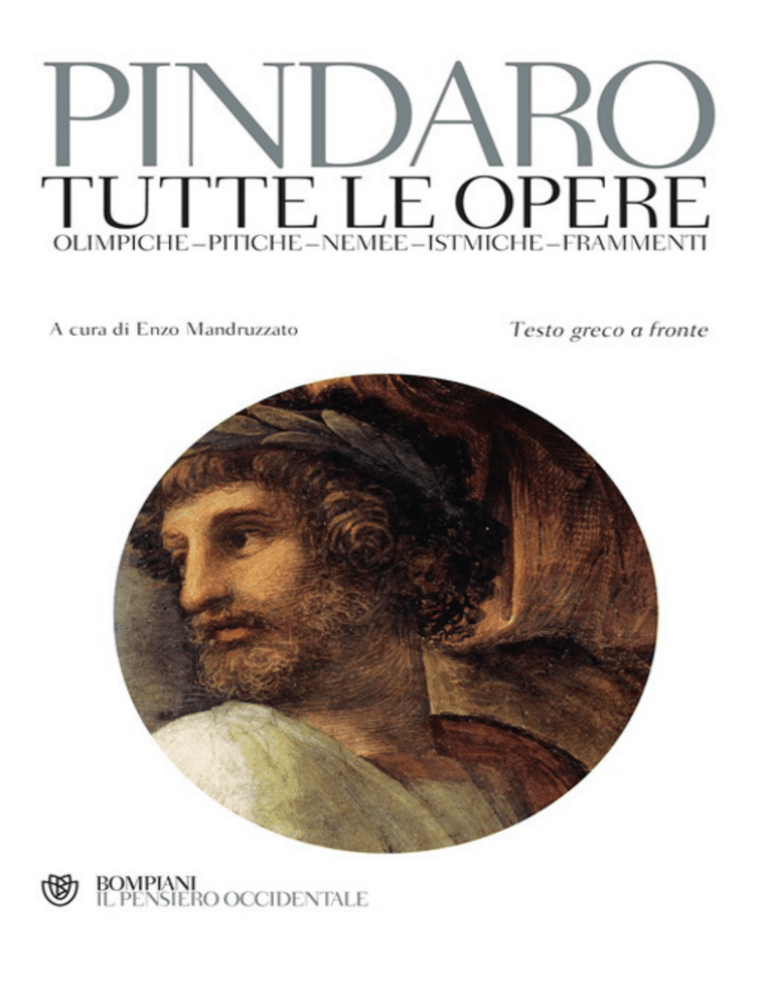
Nella presente edizione vengono pubblicate tutte le opere di Pindaro (520-518 a.C.), il più grande esponente della
lirica corale arcaica. Nell’edizione alessandrina, la produzione di Pindaro, eccezionalmente ampia, occupava 17 libri
ordinati per generi: Inni, Peani, Prosodi, Parteni, Iporchemi, Encomi, Treni, Epinici. Sopravvivono integralmente solo
quattro libri degli Epinici, divisi secondo le gare panelleniche di cui celebravano i vincitori: essi contengono
rispettivamente 14 odi Olimpiche, 12 Pitiche, 11 Nemee, 8 Istmiche. Le altre opere sono note solo da numerosi
frammenti in cui appaiono grandiose descrizioni del mondo divino, racconti mitici, solenni enunciati etici e anche
tratti di arguta grazia e voci d’amore. L’epinicio di Pindaro si articola secondo tre linee tematiche svolte con grande
varietà di motivi: l’elogio, che contiene un succinto riferimento al vincitore e all’occasione sportiva; il mito,
collegato sovente con la famiglia o con la patria del celebrato, che costituisce la parte di maggiore ampiezza e
impegno poetico; e la gnome, ossia l’enunciazione di sentenze religiose e morali. Enzo Mandruzzato ci restituisce con
la sua traduzione un “Pindaro arcaico” in tutta la sua lontananza: considerato per tutta l’antichità di gran lunga il
maggiore dei lirici, come diceva Quintiliano, parrebbe infatti inassimilabile al mondo moderno. Eppure il soggiorno
nel suo mondo arcaico — è la tesi del saggio introduttivo — non è meno attraente di quelle civiltà lontane che
proprio oggi si cerca di conoscere e di non lasciar perire. Ma con la luce del mondo greco, l’energia dell’intelligenza e
il gusto del gratuito, che sono il seme di tutte le conquiste della civiltà occidentale.
Enzo Mandruzzato (Bologna, 1934) è uno dei più noti grecisti e latinisti italiani: sue sono le traduzioni dal greco di
Esopo, Eschilo ed Euripide (oltre che di Pindaro) e dal latino di Fedro, Catullo, Marziale e Orazio. Ha scritto anche
numerosi saggi, poesie e romanzi. Tra gli ultimi scritti ricordiamo: Il piacere del latino (Mondadori, 1991), Omero. Il
racconto del mito (Mondadori, 1998), Diario di un dopoguerra 1918-1922 (Rizzoli, 2005) e I dèmoni. Undici confessioni
apocrife (Il Poligrafo, 2006).
BOMPIANI
IL PENSIERO OCCIDENTALE
direttore
GIOVANNI REALE
segretari:
Alberto Bellanti
Vincenzo Cicero
Diego Fusaro
Giuseppe Girgenti
Roberto Radice
© 2010 RCS Libri S.p.A., Milano
978-88-58-70050-1
Prima edizione digitale 2010 da edizione Bompiani
Il Pensiero Occidentale gennaio 2010
Immagine di copertina: Raffaello, Il Parnaso, Pindaro (part.).
Stanza della Segnatura dei Musei Vaticani Cover design: Polystudio.
Visita il sito www.bompiani.eu e diventa fan di Bompiani su Facebook
(http://www.facebook.com/pages/Bompiani/111059814766)
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
E’ vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata
INTRODUZIONE
di
Enzo Mandruzzato
PINDARO E IL SUO TEMPO
La Beozia, d’estate — la stagione vera della Grecia — è un’immensa ciotola gialla e tragica,
tra monti dai nomi memorabili, feconda e brulla, dove il lago Copaide — da cui si recidevano
le canne per i auti — è scomparso e quello di Ilice s’a ossa netto, irregolare e atroce come
una piaga. Tebe (Tive) è un villaggio rozzo e afoso, i ricordi di Orcomeno o di Cheronea o di
Gla, un tempo sospesa sulle acque, sono sperduti nella calura. Il turista, quasi contento che
non ci sia «niente da vedere», ha fretta di risalire gli orli della ciotola e di scorgere il mare o
l’acropoli di Atene o Delfi.
Anche per un turista di due millenni fa, Strabone, Tebe non aveva «neppure l’aspetto di
quello che si dice un villaggio». Né Pausania più tardi la trovò molto diversa. Eppure, con
l’aiuto delle guide, girò la Cadmea dalle sette porte, ricettacolo di tante memorie, vide le
tombe di Melanippo, dei gli di An one, il luogo del loro rogo dove ancora restava la cenere,
le sepolture dei personaggi del teatro attico, Giocasta e Tiresia, Eteocle e Polinice ai cui riti
funebri si ripeteva ogni anno, fedele come il miracolo di S. Gennaro, il fenomeno del fumo
che si divideva. Molti i templi, nei dintorni, tra cui quello caro a Pindaro di Apollo Ismenio,
con opere di artisti come Prassitele o Fidia. Ma ciò che contava di più erano i ‘luoghi’: dove
Cadmo vinse il Serpe, dove sedeva la profetessa Manto, dove la terra inghiottì An arao, e
nessun animale veniva a brucarvi l’erba né alcun uccello si posava sulle colonne che
delimitavano quello spazio. Al tempo di Pausania si confondevano le rovine già mitiche, come
la dimora e il talamo di Alcmena, dove fu concepito Eracle, con quelle storiche come le
tombe dei morti della guerra contro Filippo o della stessa casa di Pindaro, che Alessandro
Magno aveva ordinato di risparmiare dalla distruzione.
Pareva e pare ancora questo il prodigio della Beozia. Gli scavi non offrono che ‘luoghi’. Non
si trovano pietre squadrate e si può sospettare che le famose mura di An one non fossero che
terrapieni; del resto quelle da lui mosse per magia — «col canto» —, indicate a Pausania,
erano informi. La terra — la Dea Madre — è in tutto ed eguaglia tutto. Non c’è neppure la
sublime civetteria delle solitudini della campagna romana al tempo di Goethe o di Micene già
al tempo di Strabone. Terra bonaria e senza tempo dove l’Ismeno si perde nella sterpaglia e
tra i pollai e la fonte di Dirce, conosciuta solo dagli abitanti più umili che non si sono mai
mossi di lì, si nasconde in un muretto di ciottoli come una serpe. Allora nalmente ci si può
rendere conto di trovarsi in uno dei luoghi più segreti e spirituali d’Europa, nella Palestina
della religiosità greca e veramente occidentale.
Qui nacque Pindaro, a Tebe, la «madre mia» come diceva, e che onorò sempre con fedeltà,
dolore e orgoglio; o più esattamente a Cinoscefale, nell’immediata campagna, dove la
famiglia avrà avuto le sue terre ed egli avrà eretto il sacello della Dea Madre dove officiarono
le glie. A Del si celebravano le Pitiche; «la festa del quinto anno» — così lui stesso
immaginò il suo più antico ricordo — «con i suoi cortei di bovi, quando ebbi il primo nido tra
le fasce, nell’amore». Era dunque l’agosto di quel deducibile 518 a.C.1 La famiglia era una
delle più illustri di tutta la Beozia, gli Egidi, venuti da Sparta, poi ancora migratori ed
«ecisti», in Laconia, a Tera, a Cirene, dove il ramo dei Battìadi sopravviveva a vicissitudini
secolari (P. IV). Questo signi cava essere di sangue reale; il vero regno, come a Sparta, era
fuso con il sacerdozio e non identi cato con il potere. Il culto avito era quello di Apollo
Carnèo (P. V, 79-81), del cui tempio di Tera restano i ruderi con gra ti del tempo di
Pindaro, devoti ed erotici.
Della parlata beote non restano in Pindaro tracce pure, e non è vero che «atticizzasse»
troppo come diceva Corinna, la celebre poetessa di Tanagra; ma è vero che il linguaggio della
poesia lo portò presto lontano. Le prime fonti della poesia erano in Beozia ma da secoli vi
attingevano poeti d’altri paesi, e attualmente il maestro della lirica corale era uno ionio, il
brillante Simonide di Ceo. Beote fu invece l’autore della Teogonia, la Genesi dei greci, Esiodo,
lettura primaria come quella di Omero, ma più data. Nulla però lo formò come le memorie
viventi, i segni di ciò che noi diciamo «mito» e che per lui e per tutti era semplicemente la
verità, la «parola» che è il ricordo e il ricordo che è, come ogni verità, presenza. Il suo
patriottismo restò sempre qualcosa di cultuale e di universale; Pindaro poteva sentirsi al
centro dell’Ellade e perciò del mondo, come molti greci, ma con un certo privilegio anche
rispetto la ben più potente Sparta e la progredita Ionia. La vicina Del era il centro anche
geogra co della terra. All’esterno, all’orizzonte, c’erano il grandioso e il favoloso: i regni
d’oriente, la Lidia e l’Egitto, ora uni cati nell’Impero persiano, e nell’occidente di Ulisse
l’avventurosa Sicilia, gli Etruschi e i Fenici, le isole dei Beati, e le colonne di Eracle che
rimasero sempre per Pindaro il simbolo del limite umano, e i remoti Cimmerii (i Celti?),
ospiti di Apollo, dai quali venivano ogni anno a Delo le offerte, avvolte nella paglia.2
Della sua prima giovinezza tebana restano pochi versi e alcuni aneddoti riguardanti sempre
Corinna. Pare che la poetessa, bellissima donna del resto, non lo lasciasse in pace. Lo batté in
gare di poesia (merito della bellezza, dice Pausania, o forse del purismo) ed è chiaro che
quando rimproverò la collega Mìrtide di mettersi in gara con Pindaro — lei, «nata donna» —
nascondeva una risata impertinente. Lo incolpò anche di fare poco uso del mito; Pindaro
replicò con un inno a Tebe così copioso di mitologia che Corinna esclamò: «ma con la mano si
semina, non col sacco!», al che Pindaro sbottò in un «porca beote!» che, in italiano, non suona
bene. Ma è un esempio di traduzione come calco-errore. Non solo il porco non era
nell’antichità animale discriminato, ma sia l’epiteto che l’ambiguo aggettivo erano condivisi
da Pindaro, con suo vero sdegno (O. VI, 141-3). Rapporti allegramente borgognoni, com’è
nello stile di certe vecchie aristocrazie.
Oltre i monti c’erano due grandi richiami: la sacra Del e la già intelligente, la già nemica
Atene. Quando vi andasse Pindaro e quanto e come vi stesse è problematico, perché la guerra
era scoppiata subito dopo le riforme democratiche di Clistene del 508 e durò incattivita per
un numero di anni e con una conclusione che Erodoto si dimenticò di precisare. Ma non si
può credere che Pindaro ci andasse prima, in età infantile; dovettero esserci schiarite che
aprirono, almeno eccezionalmente, quei con ni pieni di rancore comunale. Certo ad Atene
ebbe il suo principale maestro, Laso di Ermione, riformatore del ditirambo, ricordato da
Pindaro con considerazione. Vi conobbe forse Simonide e certo Eschilo, di cui ammirò «il
linguaggio grande». Molte cose avrà ammirato ad Atene, e soprattutto gli ateniesi, la loro
cultura acerba e pia, già protetta dai Pisistratidi, la loro «agorà tutta arte», come la evocò
dopo la distruzione quando non poteva essere in gran parte che un indimenticabile ricordo.
Ma la rivoluzione democratica non possiamo pensare che l’approvasse: una ristrutturazione
numerica, che ignorava i dolci legami feudali, le tradizioni senza tempo delle fratrie, per no i
patronimici, per no il ritmo lunare dell’anno e il sacrale numero dodici sostituiti dal computo
solare e dall’aritmetico dieci. Pindaro avrà ignorato queste anticipazioni della Convention e
avrà continuato a vedere «l’altra» Atene. Ma, da ragazzo e dopo, avrà anche trovata naturale
la crociata del vecchio mondo, Sparta in testa, braccio secolare di Del , contro quella città
orgogliosa. È notevole tuttavia che non dicesse mai una parola contro Atene. Potendo, loderà
per no gli Alcmeonidi, se non come democratici, almeno come esuli che avevano tanto
operato per la ricostruzione del tempio del co di Apollo distrutto da un incendio. Sarà felice,
un giorno lontano, di poter celebrare Atene «cittadella dell’Ellade» e — nalmente —
«divina».
Se di Atene fu ospite, a Del fu di casa. L’aureo particolarismo greco permetteva più patrie,
e Del era quella della fede, era la città di Apollo, il Dio per cui aveva, osserva Jaqueline
Duchemin, una devozione più segreta. Dobbiamo pensarlo nell’intimità sacerdotale degli
hosioi («i santi»), partecipe dei segreti del santuario in cui il misticismo più sincero si fondeva
con quella che diciamo la «politica», categoria di cui non solo Pindaro e il vecchio mondo, ma
neppure i nuovi uomini che venivano creandola avevano la minima coscienza. Avrà
partecipato alla trascrizione e alla delicata interpretazione dei messaggi del Dio, trasmessi
dalla voce della Pizia. Ciò poteva far parte delle competenze di un poeta o, come ancora si
diceva, d’un «cantore», aoidós. «L’esprit de Delphes», quella Empfindlichkeit, quel riformismo
sottile e quasi inconscio, quell’illuminismo devoto, hanno in uenzato e incoraggiato
profondamente lo spirito e la poesia di Pindaro. Il culto è anche luogo, e particolarmente nel
mondo antico il divino non era «dovunque». Pindaro è impensabile senza quelle pietre, quelle
rovine ancora oggi incomparabili e diverse, nella valle solitaria dominata dalle Fedriadi, e
soprattutto non deve essere pensato senza il suo sacerdozio, a cui l’oracolo stesso diede un
eccezionale crisma3 e che sarà ricordato per secoli con un rito commosso.4 I dialoghi «del ci»
di Plutarco danno un’idea chiara di quel mondo, in una fase molto più moderna ma non più
interiore. Le eterne sentenze che brillavano sul tempio di Apollo erano sempre il punto di
partenza di ogni meditazione. La più celebre, il «conosci te stesso», o meglio il suo signi cato
ben de nito da Plutarco — la nullità del mortale di fronte all’eterno5 — appare in Pindaro
non solo con frequenza, ma con la perentorietà non petita e la violenza del dogma. Così l’arte
si faceva davvero servizio divino. E «servire » diventava gioia: un giorno — Pindaro era già
un «celebrato profeta», aóidimos prophata — appena gli venne all’orecchio che nel santuario,
per le Prossenie, mancavano i coreuti del sacro peana, Pindaro accorse «per togliere di
di coltà i fedeli»: «sono sceso col cuore di un ragazzo che obbedisce alla nobile madre» (fr.
Peani 6). Sono sceso: era il termine che si usava per la Pizia,6 di regola una ragazza delle
montagne intorno a Del , il Parnasso di Apollo, l’Elicona dove Esiodo aveva «visto» la danza
delle Muse. Non può essere casuale che le prime composizioni sicuramente databili siano
connesse con il santuario.
La prima senza controversie è la decima pitica, in onore di un campione degli Alèuadi, la
più potente dinastia della Tessaglia con gli Scopadi, commissionata dal più autorevole,
Torace, «tiranno» di Làrissa. Si apre con un’invocazione o meglio un nesso quasi
programmatici: «Felice Lacedèmone, / fortunata Tessaglia, / l’una e l’altra regnate da una
stirpe / del sangue di Eracle dalla nobile guerra…». Era il 498 e Pindaro aveva vent’anni. E
evidente l’orgoglio del giovanissimo per quella «ospitalità cortese» e sono probabili suoi
disegni o speranze su quella dinastia di cui approvava senza riserve la «giustizia nella Città»
o, diremmo noi, la «politica». Ma era già una pericolosa, nuovissima politica.
Nel 498, senza che nessuno se ne fosse veramente accorto, il memorabile scontro «tra la
Grecia e l’Asia» era cominciato. Il cinquantennio delle «guerre mediche» avrebbe trasformato
nel profondo la civiltà greca, e si sa che è quasi impossibile prescindere dall’avvenuto.
Per no uno storico come Polibio rimprovera Pindaro d’avere tradito la storia, cioè la causa
della Grecia, e cita questo passo di un iporchema: «dolce è la guerra per chi non ne ha
esperienza: ma a chi la conosce ne trema in nitamente il cuore, se si avvicina…», completato
da un’altra testimonianza: «ogni cittadino dia serenità alla vita pubblica e miri alla Pace, che
fa grandi i cuori, che è tutta luce; tolga dalle menti il Disordine con le sue vendette, che porta
povertà e nutre di odio la giovinezza…».
Parole così responsabili, idealistiche e pindariche che postulano un «momento»
giusti catore, in realtà non abbastanza precisato da Polibio. Ma i grecisti moderni, più
patrioti dei greci, hanno calcato la mano; Ticho von Wilamowitz per esempio vide addirittura
nella decima pitica un minaccioso sottinteso contro Nasso colpevole di difendersi dall’attacco
persiano. Semplicemente, l’ode è al di fuori degli eventi; a parte lo spirito del ‘genere’ poetico
e della gara liturgica, concepita sempre come «tregua», per Pindaro quegli eventi erano
piuttosto gravi e minacciosi che giudicabili con un sentimento sicuro. Al tempo dell’ode si
sapeva in concreto: che la Ionia, tributaria di Dario, il «re senza pari» come lo chiamerà un
combattente, Eschilo, si era ribellata; che la rivolta era guidata da Aristagora ex tiranno di
Mileto e suddito di Dario, compartecipe della spedizione contro la libera Nasso e geloso rivale
dell’ammiraglio persiano; che aveva chiesto e non ottenuto l’aiuto di Sparta e che Atene ed
Eretria avevano mandato alle consorelle ioniche un aiuto, poco più che formale, di dieci
triremi; che i ribelli erano stati battuti e, con orrore universale, avevano incendiato il
santuario della Dea Madre a Sardi. Il giudizio e il volere divino non si erano chiariti.
Sui tragici sviluppi che seguirono, invece, non è pervenuta alcuna parola di Pindaro: la dura
repressione della rivolta, la distruzione di Mileto che sconvolse il popolo ateniese, la
spedizione punitiva di Dario contro Atene ed Eretria. Il «re senza pari» certo ebbe la mano
pesante; non solo non ammise riparazioni, ma impose a tutte le Città greche una scelta tra la
guerra e il vassallaggio; ma era anche vero che alla sua immensa forza univa la più provata
venerazione per gli Dei della Grecia. Il mondo laico, lo stesso dualistico mondo cristiano, non
può capire del tutto che cosa signi casse. Ci limitiamo a riferire il giudizio conclusivo che
darà un politico realista e protagonista dei fatti come Temistocle: «tutto hanno fatto gli Dei e
gli Eroi», e ad aggiungere che questo giudizio va inteso alla lettera.
Prima di quegli eventi il volere degli Dei poteva trapelare solo attraverso le parole della
profetessa di Del ; e Del era estremamente prudente o, come si dirà più tardi, «medizzava».
Ma sarebbe un errore pensare alla banalità del calcolo o dello spavento. Più tardi il santuario
non mancherà di coraggio e di una dignità che daranno pieno credito ai miracoli tramandati
da Erodoto (VIII, 36-39). Questo Vaticano greco, che non godeva dei vantaggi del
razionalismo e del dualismo moderni, sentiva tragicamente la propria responsabilità.
L’ammiraglio di Dario, navigando verso l’Attica, si fermò a onorare Delo, dove era «nato»
Apollo. Pareva continuare, accanto alla intollerabile violenza — la hybris —, la sfarzosa pietà
di Creso di Lidia, compensata da un miracolo celebrato da Bacchilide.7 Ippia, il philómusos, il
pio, pareva ricondurre ad Atene nonostante tutto il buon tempo, «il tempo saturnio» come fu
ricordato, di suo padre Pisistrato. Era come se gravasse sull’Ellade una forma di vita così
nuova da giusti care lo sgomento e il silenzio. Tutte le scelte delle Città ebbero una riserva
non propriamente politica e non si risolsero in azione, tranne quelle di Atene. Ma la vittoria
di Maratona fu l’evento chiari catore. Gli spartani, i primi soldati dell’Ellade, trattenuti senza
disapprovazione di nessuno dalla particolare fase della luna, arrivarono tardi sul campo di
battaglia e manifestarono una profonda soddisfazione su cui nessuno avrebbe ironizzato. Era
una liberazione non solo dai persiani, ma dall’oscurità del futuro. Sul campo erano rimasti
dalla parte «giusta» — come a Jemappes nel 1792 — duecento caduti.
Il prudente Dario non ripeté la spedizione. Certo a Ecbàtana ci si proponeva di riprendere e
risolvere de nitivamente la questione greca, ma in Grecia, proprio per la grandezza del
pericolo passato, si poteva pensare che fosse nito e che si fosse tornati al mondo normale.
Le odi di Pindaro del 490, 488 e 486 celebrano la virtù liale di Antìloco, il prodigio della
Gorgone decapitata, la bellezza delle Càriti venerate ad Orcomeno. La democrazia ha esiliato
un amico, Megacle, e Pindaro è lieto di celebrarne la vittoria, a Del (P. VII). Sempre a Del
ha conosciuto il giovane, meraviglioso Trasibulo, degli Emmenidi di Agrigento, vincitori alle
quadrighe, ai quali il poeta rende un omaggio eccezionale (P. VI). E Trasibulo, perfetto nelle
gare pubbliche, è nel convito «dolce come un favo» e la sua presenza, come quella di Attide
per Sa o, dissolve i duri con ni del reale in una tras guranione dionisiaca, leonardesca.
L’«inganno» è prezioso, perciò reale, è un «grande mare d’oro» (fr. enc. 5).
Nel 481, dopo una decisione travagliatissima8 e quattro anni di preparativi, il glio e
successore di Dario, Serse, riprese la marcia, con mezzi e organizzazione enormemente più
radicali. Anche la preparazione politica dovette essere adeguata. La storiogra a moderna
nega fede sia all’alleanza preventiva con Cartagine che alle trattative per un soccorso da parte
di Gelone di Siracusa, il più potente ‘tiranno’ di tutta l’Ellade; parrebbe impossibile che
Gelone promettesse in buona fede 20.000 opliti mentre l’isola era minacciata dalla
tradizionale nemica. Ma forse le due notizie si confermano reciprocamente: la grandiosità e
l’ambizione un po’ ‘coloniale’ di Gelone erano altrettanto vere della repentinità delle alluvioni
cartaginesi. Anche questa ebbe il carattere dell’imprevisto. In tal caso l’orgoglio di Sparta e
Atene, che nonostante il pericolo ri utarono l’aiuto di Gelone perché condizionato da una
proporzionata partecipazione al comando generale, fu la salvezza proprio della Sicilia e perciò
il trionfo completo dell’Ellade.
Nulla sappiamo meglio sulla spedizione di Serse che lo spirito con cui mosse il
processionale esercito asiatico, gigantesca pantomima liturgica che ra gurava la marcia
stessa di Zeus, presente e non visibile sul suo carro che precedeva quello del Re dei re; la
presenza e il nome stesso di Serse erano sostitutivi di quelli del Dio supremo.9 La otta
navigava di conserva all’esercito. L’uno e l’altra rappresentavano tutti i popoli, compresi i
greci dei tre principali dialetti. Dalla solita imposizione di vassallaggio discrezionale — «dare
la terra e l’acqua» — furono escluse Sparta e Atene, contro cui puntava la spedizione. Per
tutti gli altri popoli la scelta fu penosa e non omogenea, in particolare tra i tessali dove
Torace e gli Alèuadi erano lomedi accaniti, e in Beozia. All’assemblea di Corinto, Sparta,
Atene, Platea e molte città soprattutto peloponnesiache giurarono la resistenza a oltranza e
imposero ad Egina la pace con Atene e ne ottennero la preziosa alleanza. Nasceva, mal
definibile anche per noi, un concetto nuovo. Per tutti, Atene dimostrò una larghezza di vedute
che non signi cava meno del suo valore militare. Fallita la difesa nella valle di Tempe, la
seconda strozzatura, le Termopili, sarebbero state una difesa indispensabile ma non
de nitiva. Alle spalle si sarebbe forti cato l’Istmo, tagliando fuori Atene. La Pizia, con
materna avvedutezza e misteriosa durezza verso i delegati ateniesi, ingiunse a questi di
difendersi dietro «mura di legno». Con uguale intelligenza Temistocle interpretò giusto,
trasferirsi sui mare. Quando Temistocle lo disse nell’assemblea sgomenta, si vide Cimone
levarsi e appendere vistosamente il morso del suo cavallo al tempio di Pallade. Un gesto che
forse spiega la ragione per cui a Posidone si sacri cavano cavalli, da tempo immemorabile,
da quando i migratori si trovarono di fronte il mare. La popolazione civile fu trasferita quasi
tutta a Salamina e un intero popolo si a dò alle navi. Del sancì il nuovo culto dei Venti;
poco dopo un’eccezionale tempesta ristabilì a danno dei persiani una relativa parità di forze
navali.
La resistenza alle Termopili e il sacri cio di Leonida simboleggiarono la qualità del valore
spartano, l’alké, la resistenza, come Salamina dimostrò quella di Atene, la vera vincitrice della
battaglia e della guerra. Merito non poco contestato. E Pindaro da Egina, dove eseguiva la
quinta istmica in onore di un campione della famiglia amatissima degli Psalichidi, lo
rivendicava intero alle poche navi della sacra isola dorica:
ma ora, in Ares, ora è testimone
una terra d’Aiace, Salamina,
che marinai d’Egina hanno salvata
nella morte di uomini infiniti
mentre il cielo di Zeus pioveva sangue.
Ma subito, con uno dei suoi tratti di alta eloquenza, s’interrompe:
— No, spegni il vanto nel silenzio. Zeus
comparte bene e male,
Zeus di tutto signore…
E il futuro era davvero sulle ginocchia di Zeus: la guerra non solo non era nita, ma il
destino di Tebe restava particolarmente e tragicamente incerto. L’oligarchia beote non aveva
nulla a che fare con i ‘tiranni’ che si appoggiavano ai persiani contro le rivendicazioni
popolari, e un « popolo» beote e patriota, vittima dell’oligarchia, dev’essere un anacronismo
di Tucidide (III, 62, 4). C’era semplicemente divisione e smarrimento. La vecchia Beozia non
aveva ‘accettato’ la guerra, cioè la realtà, e il sentimento dominante doveva essere stato
proprio quello manifestato da Pindaro nei versi citati da Polibio. Alle Termopili molti tebani
si erano battuti più come ostaggi che come alleati dei greci. Le città erano state salvate in
extremis dalla rappresaglia persiana per intercessione e testimonianza dei macèdoni. Ora la
Beozia aveva scelto duramente la fedeltà alla causa dell’invasore, e Tebe era divenuta il
quartier generale di Mardonio che ora conduceva le operazioni. Serse, dopo Salamina,
logicamente, era tornato; la cerimonia della presa di possesso, con l’alleanza di tutti gli Dei
dei luoghi, si era trasformata in una guerra.
Nell’anno seguente, a Platea, avvenne lo scontro decisivo, con la piena vittoria degli alleati
sotto il comando di Pausania, re di Sparta. I beoti, che avevano di fronte proprio gli ateniesi,
si batterono con tetro valore. Pausania assediò Tebe e impose la consegna dei responsabili
dell’alleanza con Serse. Dolorosa scelta che si risolse con la loro consegna volontaria, favorita
da qualche lusinga. Ma Pausania li fece uccidere tutti. La Beozia, distrutta e disonorata, era
stata la maggiore vittima della guerra. Nessuno poteva capirlo più di Pindaro, ospite a Egina,
insieme vicino e più staccato dagli avvenimenti. Pare che avesse anche lui i suoi morti, come
quei «quattro valorosi» cui accenna nella quarta istmica, e compiangerà il comandante
Asopodoro caduto per la causa sbagliata. Nella ottava istmica, scritta appunto ora a Egina e
per un egineta, si solleva con immensa pena e volontà al mondo luminoso del mito e alla
speranza: «Anche a me, / sebbene la mia anima sia triste, / domandano per lui la Musa
d’oro… ».
Si augurava che le due patrie, la vincitrice e la vinta, in una guerra ugualmente imposta e
subita, si ricordassero di essere glie dello stesso padre, come era avvenuto al tempo della
sua infanzia. E credeva ancora, come prima, nella Hesychia, la Pace, l’Ordine. Vedeva quella
che diremmo — non c’è l’espressione nelle lingue moderne — una Provvidenza dell’evento,
nella liberazione dal «macigno di Tantalo» dell’annessione persiana. Ma quando più tardi nel
nome di questa «libertà» — non quella della democrazia — farà l’elogio di Atene, pare che i
compatrioti se ne sdegnassero e lo multassero. Gli Ateniesi invece lo compensarono col
doppio dell’ammenda, con la prossenìa, una statua e soprattutto una oggettiva ammirazione.
Era nello stile delle due Città.
Nel 476 Pindaro andò a visitare la patria di Trasibulo, la sfarzosa Sicilia.
È pensabile che viaggiasse con Agesìdamo, olimpionìca di quell’anno e dedicatario della
undicesima olimpica e della futura decima, già solennemente promessa, entrambe piene di
letizia; e che si fermasse ospite suo a Locri Epize rii, dove scoprì il poeta Senocrate e il suo
misterioso ritmo «locrese», una vera rivelazione per Pindaro, anzi una «provocazione» che lo
lasciò felice e febbrile, simile (forse navigava) «al del no nel mare, mosso da un dolce suono
di auto». pensabile in ne che la prima tappa siciliana fosse la reggia-fortezza di Ierone a
Siracusa.
La vittoria di Gelone sui cartaginesi — nello stesso giorno di Salamina, dice Erodoto —
aveva aperto il periodo più splendido forse di tutta la storia della Sicilia. Non solo l’incubo
fenicio pareva dissipato per sempre — e in e etti per settant’anni non si fece più sentire —
ma pareva realizzato un miracolo anche maggiore, l’uni cazione dell’isola, sotto il duplice
scettro degli Emmènidi di Agrigento e dei Dinomènidi di Siracusa, legati da studiati vincoli di
matrimoni e uniti dal prestigio di Gelone. Il passato tempestoso — lotte spietate di classe,
tirannie atroci, trapianti di intere popolazioni, costruzioni e distruzioni titaniche, uniche forse
nella storia dell’antichità — pareva più remoto del mito. Gelone, eroico e democratico, saggio
anche nella vittoria, riconosciuto «re» dal popolo siracusano per riconoscenza e ammirazione,
aveva chiuso i tempi di Falaride e iniziato quelli di Creso. «L’abbondanza regnava ovunque»,
scrive Diodoro. Decine di migliaia di schiavi cartaginesi, prigionieri di guerra, lavoravano alla
costruzione dei superbi templi di Agrigento e Siracusa, volti al sole nascente. Chi conosce la
Sicilia ricorda i simbolici rocchi di colonne rimasti per sempre sbozzati nelle cave di Cusa.
Agrigento, «la più bella delle città dei mortali», sul suo gigantesco tamburo dorato, e Siracusa,
con i suoi chilometri di mura con uenti nel castello di Eurialo («la Borchia»), sono le sole
città antiche che umilino anche per estensione le loro discendenti moderne. Quando Gelone
morì, circa un anno prima della venuta di Pindaro, «tutta la folla dei cittadini — racconta
Diodoro — l’accompagnò alla sepoltura e il popolo poi gli innalzò qui un monumento
magni co e in seguito gli decretò gli onori dovuti agli Eroi»: una vera beati cazione. Per sua
precisa volontà, gli era succeduto il fratello Terone e un altro fratello, Polizalo, aveva sposato
la vedova, Damarete, figlia di Terone re di Agrigento.
L’ammirazione di Pindaro era legittima, e anche una certa soggezione che traspare dalla
prima olimpica, sebbene fosse accolto, possiamo credere, come meritava un poeta famoso che
aveva già celebrato il re morto e onorato con due odi la città e la famiglia della regina (P. XII
e VI). Si sentì simile a Demodoco nella reggia dei Feaci « molto cari agli Dei », quando «staccò
dal chiodo la cetra» (vv. 21-22). Sapeva che lo ascoltavano «spiriti sapienti». Forse anche
Simonide? Bacchilide mandava da lontano il suo quinto epinicio. Eschilo, certo presente alla
prossima rappresentazione delle sue Etnee, era almeno atteso. Lì nell’«Isola», a Ortigia, dove
la fonte Aretusa sgorgava dalle acque sacre dell’Alfeo di Olimpia, la più celebre delle odi
pindariche legava Ierone a Pelope, il grande regno dell’occidente alle più remote tradizioni
dell’Ellade cavalleresca. L’e etto sarà stato magni co; e solenne anche fu l’ode di un grado
minore per il condottiero Cromio, cognato del re, la prima nemea, evocatrice di Eracle
infante. Ma poi la con denza e l’amicizia nasceranno; due frammenti di un iporchema
mostrano un Pindaro che sollecita dal re con molta grazia il dono di uno dei carri siciliani,
unici al mondo. Poi, per molti anni, la distanza dello spazio e del potere faranno
quell’amicizia sempre più delicata e grave.
Ma ad Agrigento il poeta non fu più simile a Demodoco; qui si trovò tra amici e
correligionari. Le Teossenie della terza olimpica erano un rito quasi di casa, e vi si
celebravano i Dioscuri ed Elena, cioè la fraternità della giovinezza eroica e l’eterna bellezza;
culto dorico che Pindaro fu commosso di riscoprire. La seconda olimpica contiene tutti i
trion , quello dell’amicizia consolatrice, del sangue e del «mistero» comune, la sorte delle
anime e la sorte di Terone. La critica tende più o meno a sentirci il neo ta (e niente può
essere più stonato d’un neo ta) che molto avrebbe imparato nell’isola di Persefone e nella
patria di Empedocle. Ma Pindaro veniva da Del , non meno di Eleusi e con più universale
autorità madre dei ‘misteri’, L’eccezionalità del discorso non deve ingannarci. L’antico, e
meno che mai del tempo di Pindaro, non nominava l’anima invano; e ancora in piena età
imperiale neppure sospetteremmo nel sereno Plutarco tanta violenza mistica e un concetto
dell’oltretomba così puntiglioso e addirittura medioevale se non ci fosse pervenuto il suo De
sera. Quella eccezionalità ci dà invece la misura della spiritualità e della reciproca fede
dell’ospitalità emmenide. Né fu la sola fraternità di spirito. La seconda istmica ci rivela a gran
distanza e in certo senso per caso che Senocrate, il padre di Trasibulo, tranquillamente
ignorato dalle fonti, incarnò quello che diremmo l’ideale cavalleresco di Pindaro, l’uomo «dal
dolce fuoco» — glykéia orghé — che ispirava «gli a anni e gli agi» e la valorosa eleganza della
vita cortese. Non mancava neppure il legame dei ri uti e delle inimicizie comuni, quei
«corvi» che «stridono contro la sacra aquila di Zeus», e in cui gli scoliasti videro — ma
tacendo prove e riferimenti che sarebbero stati in grado di conoscere — e molti moderni
vedono ancora, i rivali Simonide e Bacchilide. Proprio per quella alta ‘cortesia’ ci
domandiamo se era verosimile, in quell’atmosfera sacrale e regale, una polemica così
personalistica a danno di due poeti autorevoli e molto bene accolti nelle due corti. La rivalità
c’era, ma bisogna vedere quale tono poteva avere; una polemica letteraria in un’età senza
‘letteratura’ non è meno anacronistica che importuna. Si pensa a un altro duale (l’uso del
duale — O. II 158 — è l’argomento principe), al dantesco « giusti son due» del canto di
Ciacco, così poco chiaro — e lì si poteva essere più espliciti — che neppure gli immediati
lettori e posteri seppero fare nomi plausibili. L’apparente invettiva deve conservare la nobile
genericità o veridicità della gnome innica. Qui si parla dei falsi «sapienti», falsi perché non
hanno la sapienza nativa, evidentemente mistica, posseduta dal re e dal cantore e altri
presenti e assenti. Poteva esserci posto anche per il profano Simonide e il facile Bacchilide. Il
quale, del resto, imitando palesemente Pindaro nel suo terzo epinicio, ha tutta l’aria di
rispondere (magari proclamandosi, a scanso di equivoci, «usignolo di Ceo») con ugualmente
alta «cortesia».
Non sappiamo quanto durasse il soggiorno siciliano, cioè quando e come altre gare e
vittorie lontane abbiano richiamato il poeta. Non sappiamo particolarmente se nel 474 fosse a
Del , per la vittoria del dedicatario della nona pitica, o anche a Tebe, dove è stato accusato
di dimenticarsi — proprio lui — non solo della Città, ma delle sue memorie; o se era ancora
in Sicilia nell’anno dei due massimi trion del proprio ideale e di Ierone, la vittoria sugli
Etruschi a Cuma e la fondazione di Etna. Quella ripeteva Salamina, assicurando i con ni
dell’Ellade, questa simboleggiava — in certo senso tutti i trion erano simbolici agli occhi di
Pindaro — l’a ermazione o la restaurazione del mondo dorico. Per altri era la cacciata dei
vecchi cittadini ionici di Catania e la loro sostituzione con diecimila veterani ed emigrati di
origine dorica, ma per Pindaro era la continuazione della marcia dell’antico Egimio e della
sua «buona legge», una di quelle che non si scrivono e non si insegnano, esse pure «innate»; e
per noi non meno mute e remote delle lapidi anonime e dei minuti dókana della pingue
Laconia.
Ma anche Pindaro, come Platone tanti anni dopo e in tutt’altro modo, doveva restare
deluso nel sogno d’una «eunomìa», o «buona legislazione», siciliana. Il contrario di essa,
l’«isonomìa», o «la legge uguale per tutti», trionfò rapidamente nell’isola. Nel 472 morì il
buon Terone e gli successe il disastroso Trasideo che mosse guerra a Ierone, fu battuto,
deposto e condannato a morte. Agrigento rivendicò la sua libertà, anche se non senza la
protezione del re siracusano. Non sappiamo la sorte degli altri due Emmenidi di nostra
conoscenza, Senocrate e Trasibulo. Pindaro celebrò la prestigiosa vittoria di Ierone del 470
mandandogli l’attuale prima pitica, una delle sue odi più solenni e gravi, in cui paragona il re
a Filottete, gli indica l’esempio di Creso e gli ricorda l’avvenire, cioè il glio e la città dorica
di cui questi era signore. Più tardi (si direbbe) gli inviò la seconda pitica, una delle più
misteriose, il cui centro non è certo una vittoria agonale; forse è la comune tristezza, il
solidale orgoglio di credere sempre e soltanto al proprio valore. Il paradigma non è più Creso
ma Radamanto, il giusto dell’oltretomba, al di là del tempo e delle opinioni umane. Come
nella seconda olimpica per Terone, crediamo che ci siano anche qui nemici comuni o meglio
resi comuni dal sentimento del poeta. A loro è riservata la parte nale dell’ode, che ribadisce
in tono minore e oscuro, d’intesa, ciò che è stato detto con l’a resco grandioso della prima
parte. Quei «fanciulli» che prediligono le scimmie (le prepongono a un Radamanto,
penseremmo, ma nessuno ha saputo spiegare de nitivamente questo simbolo), e così le
«volpi» calunniatrici, debbono essere i nemici del re. Con i propri, Pindaro è più iroso e
pronto alla vendetta — salva sempre la legge divina — ma sa anche che la vendetta, dal caso
e prima dalla cattiva coscienza, verrà certo. Pindaro, che scrive da Tebe, era stato
profondamente o eso, e certo in ciò che gli era più caro. In tal caso, non tanto da un’accusa
di filo-tirannia come si suppone, quanto nella sua missione di poeta dei giusti.
Nel 466 il pio re morì. In quell’istante a Del piombò a terra uno dei suoi doni votivi, la
colonna di bronzo che secoli dopo ancora si mostrava; così rovinò la sua signoria. Il fratello
minore dovette fuggire a Locri, le istituzioni d’un tempo furono ripristinate, i vecchi cittadini
di Catania scacciarono i Dori e abolirono il nome di Etna. Quella che Pindaro aveva chiamato
uno «stuolo rapace» — la maggioranza popolare — tenne il potere non senza imitare anche
certi abusi della democrazia, come l’ostracismo, il diritto del popolo sovrano di esiliare senza
processo qualunque cittadino. Non sappiamo né quando né dove Pindaro mandò a Trasibulo
la sua seconda istmica, ma crederemmo senz’altro in occasione della morte di Senocrate. E la
nostra memoria non può non evocare il dantesco Guido del Duca e la sua nostalgia del buon
tempo antico.
Non andava certo meglio nella madre patria. Con l’espandersi della potenza ateniese la
democrazia ripullulava ovunque. Dalla dorica Egina Pindaro guardava con di denza e a volte
con dolorosa disapprovazione le vicende di quella città scandalosa. Non è da escludere che
contrapponendo la solida e forte «gloria del sangue» di un campione egineta (N. III) a
quell’uomo «buio» che «assaggia innumerevoli valori», pensi ad Atene, al suo sperimentalismo
politico, a quella violenta dialettica troppo lontana dall’ideale pindarico della Hesychia. Certo
avrà riconosciuto le benemerenze di Cimone come difensore dell’Ellade e non poteva non
ammirare quell’ateniese così ‘dorico’ e così leale sostenitore della leadership a due, Sparta e
Atene, «le gambe» dell’oplita greco, come diceva, in lotta contro la Persia. Nel 468,
all’Eurimedonte, Cimone aveva battuto il nemico, si sarebbe detto de nitivamente, e fu
probabilmente allora che Pindaro levò il suo inno ad Atene, con grande sdegno dei
concittadini. Ma le vittorie sul mondo extraellenico erano per lui qualcosa di sublime e
negativo, il salvataggio da un male che avrebbe voluto inesistente; le celebrava ma poi
tendeva a dimenticarle.10 Il suo ideale inconscio era un’Ellade articolata in spazi solenni e
rispettati, dove i «fondatori di città» si avventuravano rari dietro l’imperioso consiglio di
Apollo (P. IV).
Soprattutto, il prestigio di Cimone era precario. Una ‘sinistra’, quella del giovane Pericle e
dell’odiato E alte, guadagnava spazio, non senza l’irresistibile forza dell’imponderabile, della
propaganda spicciola, dei piani inclinati. Ne era complice qualcosa di maligno che nasceva nel
mondo dorico, di cui Pausania fu il terribile esempio. Non si era mai visto nella storia — ma
la storiogra a non era nata — un caso Pausania. Il re, il vincitore di Platea, è corrotto dallo
sfarzo persiano, ha rapporti con il nemico, mira a una signoria personale, profana la
tradizione, lo stile, tutto quello che Pindaro chiama «la legge di Egimio». Tucidide lo dirà
chiaro che Pausania distrusse il prestigio morale di Sparta, ciò che era anche una grande forza
politica. Nel 464 a Sparta ne decisero la morte. Si era rifugiato nel tempio di Pallade; i luoghi
sacri godevano d’un diritto d’asilo assolutamente inviolabile. Allora si vide la madre del re, in
silenzio, posare una pietra sulla soglia. Su quella fu costruito il muro e la porta bloccata; lo
spiarono e non permisero che spirasse nel luogo sacro, ma il sacrilegio restò. Al quale molti,
probabilmente anche Pindaro, attribuirono il disastroso terremoto che avvenne poco dopo,
che rase al suolo Sparta, provocò l’insurrezione dei Messeni e degli eterni schiavi Iloti e in ne
causò la rottura con Atene. Mai si toccò meglio con mano quanto la serena Sparta fosse un
accampamento di dominatori militari — gli Spartiati — su un mondo di schiavi pieni di odio.
Cimone non tollerò, e accorse in aiuto all’assedio di Itome, la fortezza degli insorti. Non solo
Itome non fu espugnata, ma gli spartani licenziarono quelle truppe, dice Plutarco, troppo
ardimentose. Tornarono furiosi e la Città si vendicò dello smacco ostracizzando Cimone. La
politica delle «due gambe» della Grecia era nita. Sormontò la democrazia di E alte, che osò
diminuire non poco il potere della cittadella della tradizione, l’Areopago, del quale Eschilo
nell’Orestea (458) difese con energia l’origine divina.
L’assassinio di E alte non rallentò l’imperialismo democratico. Atene si lanciò in una
guerra su tutti i fronti e di scala grandiosa, contro la Persia, a Cipro, in Egitto, e
contemporaneamente contro i vicini, Corinto, Epidauro e naturalmente Egina. Sparta aveva
ri utato nobilmente l’alleanza proposta dal nuovo Re dei re, Artaserse; ma poi non poté non
intervenire, prima per procura e in ne direttamente. La provocazione più grave fu l’invasione
da parte dei Focesi della piccola Doride, la culla della loro gente. Sparta vi mandò 11.500
opliti e pensò di fare della Beozia un antemurale contro Atene. Permise che Tebe ricostruisse
le mura e diventasse ancora la capitale e la fortezza dell’antico paese. Come tanti anni prima,
le due glie dell’Asopo, come si esprimevano la Pizia e Pindaro, combattevano a anco
contro la hybris. Ma furono ancora meno fortunate. Atene batté Egina per mare e si lanciò
sulla Beozia, saccheggiandola orrendamente e mirando a tagliare fuori gli opliti
peloponnesiaci che marciavano per il ritorno. Ci si scontrò presso Tanagra, passata alla storia
come una scon tta di Atene perché così la de nirono Tucidide (I, 108) e sulle sue orme il
beote Plutarco. Ma Diodoro, che disponeva di più fonti e si pose già il problema, parla
circostanziatamente di vittoria e Polieno ha letto da altre parti dettagli militari.
Probabilmente Tucidide la giudicò una scon tta nella sostanza, perché gli ateniesi, nonostante
le gravi perdite, non riuscirono ad impedire il ritorno degli opliti, che durante la marcia
fecero allegramente strage dei preziosi olivi attici. Ad ogni modo, solo due mesi dopo, la
guerra fu decisa a Enò ta, chiara e de nitiva scon tta dei beoti, che si batterono con
disperazione. In una di queste due battaglie cadde quello Strepsiade che Pindaro rievoca nella
settima istmica con dolore e ammirazione. Poco dopo tramontò anche Egina, per sempre.
Atene le impose il disarmo, un pesante tributo e l’«alleanza». Era il 457, Pindaro aveva
superato i sessant’anni.
Verrà la pace e verrà anche la rivincita, col tempo. Dopo un decennio quando Atene,
domata dalla sua stessa energia, aveva stabilito un con ne di zone d’in uenza con la Persia
(450) e una tregua con Sparta, Tebe batté gli ateniesi a Coronea (448) e tornò il centro d’una
risorta confederazione beote, con la restaurazione dei suoi antichi governi aristocratici. Tre
anni dopo fu sancita una «pace di trent’anni» tra Sparta e Atene. In astratto, Pindaro morì —
a ottant’anni, in Argo, a fianco dell’amato, meraviglioso Teòsseno — rasserenato e vendicato.
Nei suoi epinici la severa tristezza viene sempre velata, perché non ci si presenta in
gramaglie agli Dei, e la deprecazione, non meno del dolore, si puri ca nella gnome perché
l’«invettiva» archilochea Pindaro si era severamente proposto di bandirla; e consigliava di
chiudere nell’ombra il dolore dell’uomo. Ma sentì certo molto acutamente il tramonto di ciò
che aveva amato e creduto eterno e mai veramente veduto, quello che noi diciamo troppo
esternamente il suo ‘ideale aristocratico’ o, meglio, il suo arcaico mondo dorico. Soprattutto
proprio nella sua apparente vittoria. Non era più il regno degli Eroi, quello di Pausania, o
quello del tristo e corrotto Leotichide. I «buoni» erano spesso di là, erano un Aristide, un
Cimone, un Temistocle; di là, lo sentiva, avvenivano tutti gli scandali, compresi quelli che
Sofocle chiamava, con parola ambivalente e sacrale, deiná, qualcosa di terribile, bellissimo e
invincibile, e nulla, aggiungeva, è più deinón dell’uomo. Di quell’uomo che per Pindaro era
sempre «un sogno d’ombra», nulla senza il divino, anzi nulla proprio nella luce del divino.
PINDARO «ARCAICO»
Il tempio e l’ode, accostamento spontaneo che per primo fece Pindaro, è l’analogo della
Divina Commedia come cattedrale gotica. Similitudini opposte per due poeti e due civiltà che
le in nite distanze lasciano consimili. Si richiamano per la loro eccezionalità e per la comune
distanza dal nostro punto di osservazione.
Innanzi tutto il tempio dorico non era solo quello che vediamo, maestose colonne e misure
simmetriche, l’opposto perciò del gotico. C’erano i fregi, il colore, gli ornati, il tetto — questa
ovvietà così di cile da sostituire con l’immaginazione — il chiuso, il folto, l’abitato, il
cultuale. Il peristilio non era che la cornice d’un quadro dominato dall’horror vacui. L’uomo
arcaico colma sempre le pareti bianche. Vive in un mondo sonoro, pullulante e multicolore da
cui non sa appartarsi. Si direbbe che l’avvento del razionale comporti la rarefazione e la
solitudine, nel cielo e nella terra. Allora la geometria e il bianco trionfano: il Cinquecento,
Versailles, i parchi all’italiana, i boulevards, le ville, i piani regolatori… A volte un incendio
risolse il trapasso, come fu per la Roma neroniana. Le città moderne sono divenute tali prima
delle necessità del traffico.
Anche il cielo si fa spoglio, soprattutto di divinità. Sì allontanano (con i progressi
dell’astronomia) e si riducono di numero. Nell’età di Cicerone, Varrone recuperò i nomi di
decine di migliaia di antichissime divinità romane. I superstiti templi dell’India
sovrabbondano di «Dei sconosciuti». Le odi di Pindaro avevano saghe già dimenticate nell’età
ellenistica. Ogni angolo della Grecia ne era pieno, anzi del mondo. Erodoto reperiva un culto
speci co nella minuscola Halo nell’Acaia Ftiotide (VII, 197). Il rapporto numerico uomodivinità era opposto a quello delle età moderne; intorno alla coppia Adamo-Eva alitarono
innumerevoli potenze, quegli «angeli» la cui sola sezione ribelle ha per sempre costituito
«legione» e, come si sa, non difettò mai nel mondo; nel monologo biblico di Jahweh non
mancano strani plurali, com’è noto, e Jahweh stesso, ingiungendo di non onorare altro Dio,
ne ammetteva implicitamente una pluralità nel vasto mondo «delle genti», gettata nell’ombra
dalla «fedeltà» del suo popolo; ma non senza di coltà e tradimenti. Su questo politeismo
esclusivista s’innesterà facilmente il monoteismo loso co. L’uomo era minimo e bisognoso
del divino anche in questa povertà numerica, oltre che nella mortalità, nella debolezza e
nell’ignoranza. Il mondo divino era la realtà, non meno di quella che le età della scienza
hanno chiamato la «materia», concetto molto più incomprensibile per un Pindaro che per uno
Schelling.
Tutto questo ricordiamo brevemente per comprendere un poco questo poeta eccezionale,
non meno unico di Dante, ma non altrettanto favorito dall’equivoco di tradizioni, principi e
concezioni che riteniamo uguali o simili. I santi e i dogmi di Dante restano quelli della fede
tradizionale. La lingua, l’imitazione, l’abitudine e la retorica ci illudono di capirlo. A Firenze
c’è la sua «casa». Dante nella vita liturgica, o il Dante che assiste a un autodafé con orrore
non ideologico (Purg. XXVII, 16-18), lo capiamo. Abbiamo un nome per quasi tutte le cose
che furono sue, continuate o no. Ma per Pindaro non abbiamo nessun nome, neppure
equivoco. Gli stessi «agoni» non esistono; ‘Dio’ si traduce in tutte le lingue moderne, ma non
in greco; siamo tutti d’accordo, per no gli atei, che il politeismo è una forma inferiore di
religiosità, senza considerare che il popolo più religioso del mondo, gli indiani, è politeista e
che il Mahatma, colpito a morte, cadde invocando Rama. Ma per il politeismo non c’è
tolleranza neppure in questi tempi di mani tese tra fedi che si sono selvaggiamente
combattute. Non c’è storico che non si rallegri di promuovere al monoteismo (o ‘quasi’)
Eschilo, o Pindaro, o Seneca. I quali non avrebbero capito, esattamente come Gandhi, poiché
‘politeismo’ e ‘monoteismo’ non erano termini opposti e neppure legittimi. Il divino (to
theion) era inesauribile, molto più della stessa foltissima vita. Tutti i luoghi avevano Dei e,
dice Pindaro, «Dio è tutto». Ovunque si era loro ospiti e viaggiando ci si informava del loro
nome «oggettivo».11 Durante la sua marcia, Serse dava ordini severi perché i luoghi sacri
fossero individuati e rispettati. I più antichi abitatori erano i più informati sui loro Dei e sulle
loro vicende; era questo il «mito» o il «logos», cioè la «parola» dei popoli. Da essa attingevano
i logogra e la stessa «ricerca» — o in greco «storia» — di un Erodoto. Ci fu una suprema
responsabilità della trasmissione della parola veridica, il logos étymos come si dirà poi,
distinta dalle parole irresponsabili. Alla base del mito — come della liturgia — c’è l’orrore
della smemoratezza, cioè del mito senza fede. In età mature, Cesare, a contatto con i Celti,
popolo di civiltà arcaica, stupì che i loro bardi ricordassero con esattezza lunghissimi poemi, e
osservò che la scoperta della scrittura aveva ridotto la capacità mnemonica. Non pensò che la
perdita consapevole del proprio passato non è meno orribile per un popolo che per un
individuo.
Pindaro ereditò questo concetto solenne del mito come verità, cioè come «ricordo», ciò che
salva dall’oblio (lethe) ed è appunto a-létheia; e perciò del dovere, indefettibile come il
Giuramento (orkos), d’un’assoluta veridicità. Non c’è nessuna retorica nel suo continuo «in
verità vi dico», in quella «verità» che sente inerente alle stesse gare panelleniche, che sono
tradizione e rivelazione. Ascoltava certo con devozione le memorie delle famiglie, delle
comunità e dei sacerdoti e ne nutriva la propria cultura, anzi, come diceva, la propria
«sapienza», sophía. Sentiva troppo bene che il logos è idealmente anteriore a qualunque parola
scritta, era la rivelazione data dal tempo degli Eroi, alle origini, in un tempo la cui perdita gli
rendeva più preziosa la «parola» e più venerandi i segni e i simboli che erano sopravvissuti,
come immagini o formule sacre, alla loro stessa intelleggibilità. Ma non senza che mancassero
da parte sua — il sophós è un interprete12 — cautelosi ritocchi e revisioni.13
Colla parola scritta il mito — e la liturgia, «ripetizione» del non dimenticabile —
perderanno la loro vera ragione di essere. Il logos assumerà progressivamente un signi cato
opposto. Con la verità nascerà la menzogna e il sophós diventerà un personaggio libresco,
problematico e isolato, quello che diciamo l’uomo di cultura.
È signi cativo che ci manchi la parola per il ‘medioevo’ pindarico. ‘Arcaismo’ resta il
termine più accettabile, ma non riscattato dall’accezione implicita dell’incompiutezza e da
quella gratuita della cupezza e della ‘barbarie’. Vico concepiva l’uomo omerico come una
sorta di centauro. Tutta la secolare riscoperta e la rivalutazione dell’antichità è avvenuta in
chiave di razionalismo e poi illuminismo. Per no la nostalgia romantica della grecità era
rivolta al momento più maturo del grande secolo, e il caso di Goethe, entusiasta di Euripide e
non di un Eschilo, era tutt’altro che eccezionale. Eccezionale, anche in questo, fu Hölderlin.
La grande lologia ottocentesca, di ispirazione positivista, cercò con venerazione intuizioni e
precorrimenti scienti ci, frugando e illuminando gli sparsi frantumi. Si fecero severe
distinzioni fra tempi, popoli e classi, Ioni illuminati e Dori retrivi, democrazie progressiste e
aristocrazie chiuse, aggrappate ai propri privilegi, «al vecchio mondo della mitologia», ai
giochi panellenici e alla poesia corale. Non abbastanza il merito estetico e l’analogia
ideologica — «Pindaro come Bossuet» — salvarono quel tempo corrusco e sconosciuto.
Eppure ciò che più l’uomo arcaico ignora è proprio il senso dell’incompletezza, il
petrarchesco e già romantico inexpletum quiddam. Le proprie esperienze, le proprie
«sentenze», riempiono il mondo; neppure l’esclusione dal mistero e dall’impossibile, dalle
«colonne d’Eracle» motivo così insistente in Pindaro, dà la tristezza della privazione
spirituale. Il titanismo non tenta e il dottor Faust non è ancora nato. Dante si appaga senza
pentimenti del «quia», del quale del resto conosce benissimo i limiti; per quanto lo riguarda,
sa anche ciò che l’attende nell’al di là, un purgatorio particolarmente laborioso per ciò che
concerne la «superbia» (Purg. XIII, 136-8). Solo questa assenza dell’inde nito rese possibile
un poema esaustivo della verità, come quello dantesco. Ma non occorreva tanta scienza. Per
quanto il mondo fosse lacunoso, i conti tornavano sempre. Dio era in nito e la storia era
nulla.
Anche per Pindaro la storia era nulla e il tempo qualcosa di unitario. C’erano due piani
speculari, come il cielo e la terra, il divino e l’umano. Erodoto distingue due sole età, quella
degli Dei e degli Eroi, alla quale appartiene anche Minosse, e «quella che diciamo la
generazione degli uomini» (III, 123). Ma la atemporalità di quel cielo, che non si cala più
all’umano, ma lo illumina e lo muove, gli comunica la stessa natura meravigliosamente
fenomenica. La storia non fa, non si svolge, non ha progetti e ni. Come per Dante, dopo gli
«avventi», non ci sono che eventi; per Dante, veri turni di potere14 e per Pindaro misteriosi
corsi e ricorsi delle grandi casate.15 Su un piano privo della terza dimensione, gli uomini sono
uguali nella virtù e nella colpa. Non c’è progresso né preistoria né «mito» (Dante non dubita
della realtà storica di un Ulisse o di un Rifeo) e neppure la poesia e l’arte, come categoria
pura.
Al di fuori del «vero» non c’è che il presente, quel multicolore presente di cui la vista non si
stancava. La vista è il sentimento principale dell’uomo arcaico; non solo Pindaro è un grande
visivo. La stessa sintesi dei fatti è di regola una visione ed è inevitabile pensare alle «metope»
delle sculture arcaiche, greca e romanica, agli artisti di Selinunte come a Wiligelmo o
all’Antelami. Le distanze non dividono e il mondo arcaico, ripetiamolo, è l’opposto
dell’uniformità. La quarta pitica, la più narrativa e la più «romantica» delle odi di Pindaro, è
un immenso fregio in cui spiccano le metope dell’apparizione di Giasone o della venuta di
Pelia. In Erodoto, narratore di fatti umani, sono forse ancora più evidenti. Al centro di tutta
la saga shakespeariana di Cleomene, ricchissima di motivi potenzialmente psicologici e
patologici, il narratore vede soprattutto un gesto, le dita del re che fanno il computo delle
lune della gravidanza della sposa (VI, 69). L’ultima visione della saga presenta il maligno
seduto sul sacco del denaro del tradimento (VI, 72). Arione appare in una prima metopa sulla
poppa della nave da cui si getterà in mare e in una seconda a Corinto, già salvato da un
del no, ma in entrambe con l’abito di gala dell’aedo (I, 24). Il particolare (le dita di
Cleomene, il sandalo di Giasone ecc.) come ‘centro’ visivo e sintesi narrativa ha una logica
fantastica di misteriosa necessità. In Erodoto la successione degli eventi ha a volte le tipiche
sequenze del Novellino.16 Cominciamo a non meravigliarci dei «voli pindarici», e vedremo
che in sostanza il modo di raccontare di Pindaro non di erisce molto da quello del «padre
della storia».
Questa gioia di guardare spiega l’amore per l’eleganza, la vita bella, l’‘oggetto’ in
particolare. Erodoto, che semina lacune e le colma qualche volta per caso, descrive da tecnico
la corazza di lino che fu per gli spartani (e per lui) un casus belli molto più onorevole di quello
puramente politico (III, 47). (Anche Elena di Sparta fu casus belli: mai donna fu più onorata di
essere oggetto.) Signi cativo l’episodio di Policrate, signore di Samo, minacciosamente
perseguitato dalla buona fortuna. Timoroso dell’«invidia degli Dei», accettò il consiglio di
sacri care a loro «la cosa a cui più dava valore». Pensò a lungo e dovette riconoscere che era
un suo splendido anello, ben descritto da Erodoto. Lo gettò in mare con profondo dolore. Fu
il suo sacri cio di Isacco, anche perché l’invidia degli Dei non puniva la fortuna ma la sempre
presunta autonomia umana. E come ad Abramo, il dono fu graziosamente reso (sia pure con
stile occidentale, attraverso l’allegro Caso, che glielo fece trovare a banchetto nel ventre d’un
pesce).
Inutile ricordare, durante la «barbarie ritornata» (molto signi cativa l’infelice espressione
del Vico), il fascino delle pietre preziose, i lucenti versi dell’Intelligenza, le «preziose gioie»
del Paradiso dantesco, il suo Eden che è una prodigiosa ore ceria su un nitido smalto. Non
altrimenti sentiva Pindaro. L’oro, il simbolo con cui s’apre la prima olimpica, «che la tarma
non guasta ed è fortissimo sul cuore dei mortali», può ben essere « glio di Zeus» (fr. inc. 97).
Il simbolo della poesia, anche per Pindaro missione e allegoria di verità, è un irrepetibile
manufatto che la Musa fonde in «oro e candido avorio e ordaliso / raccolto lungo il mare
alla rugiada» (N. VII, 1179).
Altro che cupezza e ieraticità. L’uomo arcaico sente tutto in chiave di quella che diceva la
heorté, la festa-solennità in cui l’onnipresente vita associata trionfava come la natura in una
giornata di sole. Manca del tutto il concetto di festa come ‘riposo’ e non c’è niente di meno
pindarico d’una «triste domenica». La festa comincia già nel concetto di dolore come una
sorta di vergogna: «ed è bene nascondere nell’ombra / la sventura, divina e inaccettabile» (fr.
Inni. 4), e culmina proprio nella grande gara rituale, di cui l’inno è il « ore», per tradurre
l’irrepetibile áoton, che è orealità ma sta ai ori conosciuti come un animale araldico a
quelli della storia naturale. Pindaro condanna con tutta l’anima «chi amministra nel chiuso
della casa / la sua ricchezza, e intanto ingiuria e irride…». Tra le sue virtù cardinali c’è quella
che Erodoto chiama la megaloprépeia e che si traduce perfettamente — concetto, accezioni e
rilievo sociale — con la «larghezza» raccomandata da Brunetto Latini17 o la «magni cenzia»
esaltata nella giornata culminante del Decameron. L’episodio erodoteo di Silosonte18 potrebbe
essere benissimo di Boccaccio e molti gesti della decima giornata sono di un mondo pindarico.
«Donare» è la grande virtù che Pindaro raccomanda al re Ierone (P. I, 174); e «profondere è
gioia». Davvero non vede soddisfazione più schietta della «gioia di contendere / con tutti i
greci, e il lusso dei cavalli» (I. IV, 51-52). Senza questo sentimento non possiamo capire come
«allevare cavalli» sia virtù così alta e commovente; è il commovente del gratuito. Osservare
che il cavallo è il simbolo delle aristocrazie è vero ma un po’ astratto; ed è vero anche che se
l o potevano permettere solo i ricchi, come dice Aristotele, ma mettere sullo stesso piano la
quadriga pindarica e la Rolls-Royce non è «discrezione» di storico. L’oro, il dono, la stessa
«mercede» (misthós) data al poeta — tanto rilevata da scoliasti e da critici, particolarmente
italiani — fa sempre parte di quella luce, non è concetto economico; un’economia pura non
esiste per Pindaro, come per Dante e per no per Machiavelli, così medioevale di tempra e di
gusto al confronto con l’amico Guicciardini. Pindaro fu certo poeta delle aristocrazie, ma con
uno spirito che tutte quelle che noi diciamo classi contribuivano, secondo i ruoli, a
perpetuare, nonostante certi sordi, ineguali sconvolgimenti. Le maturazioni sociali sono
sempre collettive e inespresse fino alle rivoluzioni.
Tutto questo reclama l’analogia con quel gotico che cori termine pindarico chiamiamo
« orito», quando le età ferree — per Pindaro, il mondo di Esiodo — versavano la loro
energia nella copiosità e la forza nella grazia o nel sorriso, senza perdere il loro massiccio
patrimonio di certezze. L’analogia ci fa pensare che gli eccezionali Rinascimenti — Fidia,
Sofocle o Michelangelo — sono una falda labile tra queste due lunghe età di cui, a dispetto
dell’equivoco concetto di derivazione, è necessario riconoscere l’autonomia e la compiutezza.
Abbiamo parlato di ‘gusti’ e ‘ruoli’ più che di personalità come ormai le intendiamo: non la
scienza mancava, sebbene episodica e inseparabile da quella aneddotica esemplare con la
quale è stata tramandata (il caso Talete); mancava ciò che diciamo la psicologia. Per questo
non abbiamo potuto fare la storia di Pindaro, che pure fu un personaggio; lui stesso non
avrebbe saputo farla. Contemporanei e posteri immediati non ci hanno tramandato di lui che
miracoli,19 nomi,20 luoghi e sentenze, appunto le categorie della letteratura arcaica. Non si
può parlare di reticenza, perché Pindaro non vedeva ragione di tacere di sé nonostante
l’u cialità dell’inno, né si può incolpare la pochezza quantitativa delle notizie che è di quasi
tutti gli scrittori dell’antichità. Solo l’ombra dell’età si avverte, e magari a dispetto dei dati
cronologici esterni: di solito fredde cifre tramandate dagli scoliasti che disponevano degli
elenchi dei vincitori delle gare olimpiche e pitiche. Ne consegue che le Nemee e le Istmiche
a ondano quasi tutte nel buio. Le puntigliose questioni cronologiche si basano sulla scelta tra
cose eterogenee, dati esterni e poesia, cifre e stile, cifre e storia interiore. Il caso più urtante
è quello dell’undicesima pitica, per la quale la scelta tra il 474 e il 454 delle tabelle
cronologiche signi ca attribuire un sentimento così eccezionalmente oraziano (vv. 85 sgg.) o
a un Pindaro nel ore degli anni o a un Pindaro vegliardo, e fare della sua inaspettata lode
per la mediocritas, sociale e non, o uno stato d’animo o una sorta di estrema conversione. Per
di più, il più probabile 474 non è a atto all’unisono con la Stimmung della pitica nona,
certamente di questo anno. Complessivamente, tranne la breve aurora almeno riconoscibile
della decima pitica, e il tardo tramonto dell’austera ottava, la poesia di Pindaro non ha storia.
Analoga delusione sul piano concettuale. Si direbbe che l’uomo arcaico abbia realizzato alla
lettera l’ideale storicistico più maturo, espresso da Ernesto Renan, «la convivence de toutes
les choses». È stata molto rilevata l’osservazione di Erodoto sulla relatività della morale,
passo che in realtà non ha nulla a che fare con lo scetticismo etico (III, 38). Ma Pindaro può
dare sorprese anche maggiori. La sua severa dirittura non gl’impedisce di raccomandare
l’adattabilità del polipo, consiglio pratico che condivide con il prosaico e rancoroso Teognide
(fr. inc. 10). Nessuno più di lui onora gli Dei e la loro giustizia, ma gli capita di asserire che
«nelle opere vince la Tyche, non la forza», e dobbiamo ricordarci con un po’ di sforzo che la
Tyche è anche un «Dio in incognito» (fr. inc. 9); un altro frammento elogia la legge del più
forte (fr. inc. 49) e una nemea asserisce che «un più forte elimina l’anteriore diritto» (N. IX,
35-6). Dobbiamo ancora ricordarci del signi cato sacro dell’evento, che dà luogo a una sorta
di amoralismo religioso. È interessante — lo notiamo di sfuggita come un esempio — il
termine «sventura» (symphoré) che Erodoto usa per ciò che noi diremmo soltanto uxoricidio
(III, 50). Del resto l’aretà viene dagli Dei; l’autonomia umana, che è sempre colpa, si estende
in qualche misura sul piano etico. Tutti ricordano come l’amore fosse per Elena una vera e
propria imposizione della spietata Afrodite. Ma appunto, la psicologia non esiste. L’arte
gurativa dà di tutto questo un equivalente in quello che diciamo il sorriso eginetico, croce
del naturalismo e delizia dell’estetismo. Variabilissimo nella sua sostanza, esprime il
sentimento anteriore al giudizio e all’analisi di esso. Ma è notevole che si comunichi di più e
si realizzi più assolutamente in chiave di serenità e di luce.
Per tutto questo la personalità di Pindaro ti attrae come quella di certi personaggi del
Paradiso dantesco, un Cacciaguida o un San Pietro, la cui aureola paradisiaca non impedisce
una solida umanità. Tratti umani e caserecci spiccano sul fondo grandioso dei convincimenti.
C’è un candore beote, paesano e sanguigno, in contrasto col rigore o la fantasia severa di
Eschilo, di cui non si può mai sorridere. C’è un fondo di letizia che fa perdonare ingenuità,
grandezza ed esclusioni. C’è una meravigliosa svagatezza nei suoi grandi consensi. Questo
«sapiente» sa sorridere come nessuno delle cinquanta belle etere che il suo inno presenta agli
Dei, ma non soltanto agli Dei (fr. enc. 3). La poesia dà l’immortalità e Pindaro ne è
religiosamente certo, ma nessun poeta moderno avrebbe mai paragonato la gioia dell’arte a
un bel bagno caldo (N. IV, 5-7). Certi interni, soprattutto nei frammenti delle opere perdute,
hanno un’intimità placida che doveva a ascinare Orazio. I suoi eroi s’impongono sempre,
tanto se ne intendeva, per quanto non si capisca sempre bene che cosa abbiano fatto di bello
(non ne esisteva il problema), ma capita anche di trovare un Eracle piccolotto (I. IV, 96) e di
sorprenderlo cucinarsi con cura la carne (fr. inc. 48). Ciò che manca è l’altra faccia del
«tragico», il «satiresco», il parodistico, ma non già l’umorismo; è quello dell’ammirazione che
si fa con denziale, e che serpeggia sempre nell’epos, non solo omerico. Si rinviene anche nei
Fioretti, epos dei santi umbri, d’una civiltà cioè che non possiede Sigfrido e Rolando.21
Ma nessun poeta moderno supera Pindaro nella rappresentazione dell’eroico, della morte e
del divino. L’eroico è sempre giovinezza, quella dell’efebo Pelope che scende nella notte
purissima a invocare da Posidone il rischio mortale per odio della vita e della morte
meschine, o di Castore che supplica Zeus di condividere col fratello il giogo della morte (N.
X, 144 sgg.). La morte non è mai né il nulla né — a parte il «mistero», ciò di cui si tace —
resurrezione, è l’inesprimibile, austeramente surreale: pire che fumano bianche, fuori del
tempo (N. IX, 53). Ignora sempre il melodrammatico, questo poeta per eccellenza musicale.
La morte è sempre presente e non è né prova né dramma: è limite, è realtà. A un felice, a un
vincitore, ricorda che le sue belle membra sono un mantello che dovrà mutare con quello
della terra (N. XI, 24-26). Pindaro parla della mortalità con l’austera e cacia che oggi è solo
dei semplici che non conoscono l’inganno e il potere delle parole.
Il divino è rappresentato con una «verità» che lo riscatta da tutto il preteso
antropomor smo a cui lo inchioda la prodigiosa bellezza della statuaria classica. Neppure il
velo magico dell’arte arcaica lo copre con più pudore della luminosa parola pindarica. Nulla
negli Dei è prevedibile e perciò umano, neppure la bontà. Appaiono immediati come il
pensiero ma anche con la totalità ovvia e imprescindibile del pensiero; per questo non sono
mai spettacolo. L’arte di Pindaro è sempre casta, anche nel colorismo e nel barocco arcaico,
mai però come nella visione e nella parola degli Dei. «Tu sei glio mio…» dice Zeus a Polluce
quando «gli andò di faccia» (N. X, 152). Resta di loro il ricordo frammentario del sogno.
Epiteti e attributi sono allusioni più che particolari, e nulla è più completo del loro nome.
A volte il poeta osserva le sue visioni. Quando Pallade appare in sogno a Bellerofonte per
donargli il morso di Pegaso e destano all’azione, dice: «La potenza divina / edi ca leggera /