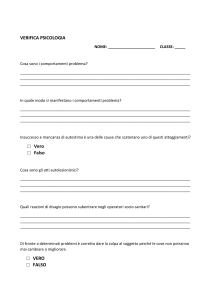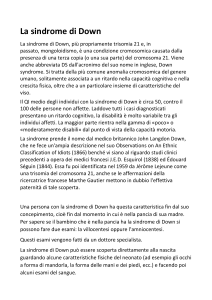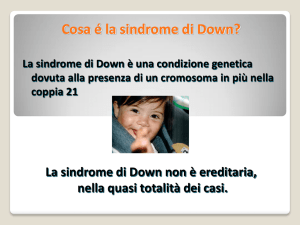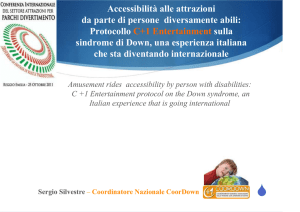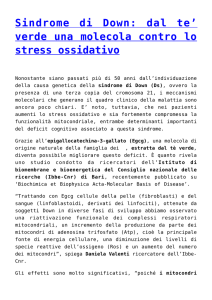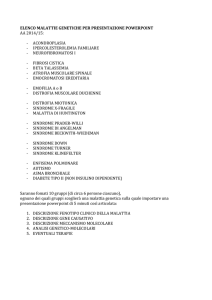caricato da
common.user21696
Sindrome di Down: Valutazione Interventi e Strategie

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della comunicazione Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità scuola secondaria di secondo grado ELABORATO DI APPROFONDIMENTO TEORICO SU: LA SINDROME DI DOWN: IMPLICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI Un’analisi delle strategie di presa in carico multidisciplinare nei bambini e negli adulti Candidato Maria Correale Matricola AD3006630 Anno Accademico 2023 - 2024 1 “Conoscerò il rumore dei tuoi passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra, il tuo mi farà uscire della tana, come una musica” (Il Piccolo Principe) 2 INDICE INTRODUZIONE……………………………………………………………………4-5 CAPITOLO I 1.1 COS’E’ LA SINDROME DI DOWN……………………………….……….........6-7 1.2 LE CARATTERISTICHE FENOTIPICHE DELL’ABERRAZIONE CROMOSOMICA………………………………………......................................8-10 1.3 PROBLEMI NEUROLOGICI LEGATI ALLA SINDROME DI DOWN…......10-12 CAPITOLO II 2.1 JOHN LANGDON DOWN E LA DENOMINAZIONE “SINDROME DI DOWN” …………………………………….................……………………...........................13-14 2.2 LA DISABILITA’ INTELLETTIVA NELLA SINDROME DI DOWN………14-16 2.3 LA MEMORIA A BREVE E LUNGO TERMINE………………………….…16-18 2.4 LE PAROLE E LA COMUNICAZIONE NELLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN………………………………………......………………………………….18-19 2.5 DIAGNOSI INVASIVE E NON INVASIVE……………………….................19-21 CAPITOLO III 3.1 L’ATTO DEI BISOGNI EDUCATIVI: VERSO L’INCLUSIONE SCOLASTICA ………………………...................……………………………………….…………22-23 3.2 APPROCCI E POSSIBILI INTERVENTI EDUCATIVI NELLA SINDROME DI DOWN ………………………………………...................……………………...…23-25 3.3 INSERIMENTO NELLA SOCIETA’ MODERNA PER LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN: LA STORIA DI GIORGIO E PIERPAOLO……………25-28 3.4 LA FAMIGLIA E LA SCUOLA ………………………………………............28-30 3.5 LE COPERATIVE SOCIALE: TECNICHE E TERAPIE PER CREARE BENEFICI A LUNGO TERMINE ………………………………...…......………………….…30-32 3.6 ASSOCIAZIONI, EVENTI E MANIFESTAZIONI PER LA SINDROME DI DOWN ……………………………………………………………………..............32-34 CONCLUSIONE……………………………………………………………………34-36 BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………36-39 SITOGRAFIA………………………………………………………………….………39 3 INTRODUZIONE Ho scelto di approfondire questo tema perché, durante gli anni delle scuole medie, ho avuto una compagna affetta da sindrome di Down. Nonostante presentasse una forma lieve della condizione, riusciva a seguire le lezioni senza particolari difficoltà. La sua presenza in classe era fonte di gioia: era sempre allegra, disponibile e rappresentava per tutti noi un esempio di positività. Pur incontrando qualche ostacolo in alcune materie, è riuscita a concludere il percorso scolastico insieme a noi. In seguito, però, le nostre strade si sono divise a causa di un suo trasferimento in un’altra città. Questa esperienza mi ha fatto riflettere sull’importanza dell’educazione inclusiva, non solo per chi vive direttamente la disabilità, ma anche per l’intero gruppo classe. L’inclusione rappresenta infatti un’occasione di crescita personale e sociale, capace di arricchire profondamente la nostra esperienza quotidiana. La sindrome di Down, come altre condizioni simili, non è una malattia, ma una caratteristica che accompagna la persona per tutta la vita. È fondamentale, quindi, promuovere una società che sappia accogliere senza restrizioni o pregiudizi. Per comprendere meglio questa realtà, possiamo immaginare di aprire un libro scritto con un alfabeto diverso e con ritmi inusuali: all’inizio potremmo sentirci spaesati, ma è proprio questa diversità che caratterizza la visione del mondo di chi è affetto dalla sindrome di Down. Una diversità cromosomica che si traduce in una percezione unica e ricca di sfumature. Storicamente, la percezione della sindrome di Down e, più in generale, delle disabilità, è profondamente cambiata. Durante la Rivoluzione francese del 1789, questa condizione era considerata una malattia e i soggetti venivano spesso emarginati dalla società. Nel corso dell’Ottocento, grazie a studiosi come Pinel, Esquirol e Gugghenbuehl, iniziò un lento processo di riconoscimento della dignità umana delle persone con disabilità. Nel tempo, la terminologia è cambiata notevolmente: da “anormali”, “idioti” e “minorati” si è passati a espressioni più rispettose come “disabili”, “diversamente abili” e “persone con disabilità” (Pesci G., Pesci S., 2005; Cesaro, 2015). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea che il termine “handicap” non indica una persona con deficit, ma una condizione di svantaggio che limita o impedisce la realizzazione di attività considerate normali per un essere umano. Secondo la 4 classificazione dell’OMS, la disabilità è il risultato di una complessa interazione tra la condizione di salute dell’individuo e i fattori personali e ambientali che lo circondano. La sindrome di Down è una delle poche condizioni in cui la diagnosi viene effettuata subito dopo la nascita, generando spesso una situazione di forte stress emotivo nei genitori, che si trovano ad affrontare sfide a lungo termine. È importante ricordare che ogni bambino è unico e non è possibile prevedere con certezza le sue potenzialità. Come vedremo nei capitoli successivi, interventi come la pet therapy, la musicoterapia, le arti terapie e lo sport rappresentano strumenti preziosi, offrendo occasioni di socializzazione e contribuendo al benessere sia mentale che fisico della persona. 5 CAPITOLO I 1.1 Che cos’è la sindrome di down La sindrome di Down rappresenta la causa più frequente di disabilità intellettiva di origine genetica a livello mondiale, con una prevalenza stimata di circa 1 caso ogni 1000-1100 nati vivi secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta di una condizione dovuta alla presenza di un cromosoma 21 soprannumerario (trisomia 21), che comporta caratteristiche fenotipiche specifiche e può coinvolgere diversi organi, tra cui il cuore, con una frequenza elevata di cardiopatie congenite. La sindrome è inoltre associata a un aumentato rischio di sviluppare patologie come la malattia di Alzheimer ad esordio precoce, leucemie, alcuni tipi di cancro e la malattia di Hirschsprung1. Le manifestazioni cliniche della sindrome di Down possono variare notevolmente da individuo a individuo, sia per quanto riguarda le caratteristiche fisiche che le capacità cognitive e adattive. Dal punto di vista del funzionamento intellettivo, il ritardo mentale associato alla sindrome di Down può essere classificato secondo i livelli di gravità individuati dal DSM-IV: lieve (QI 50-70), moderato (QI 35-49), grave (QI 20-34) e gravissimo (QI inferiore a 20). La maggior parte dei soggetti presenta un livello di disabilità lieve o moderato, che si traduce in difficoltà di linguaggio, ragionamento, memoria, attenzione e competenze sociali. Tuttavia, alcuni individui possono raggiungere una buona autonomia nella vita quotidiana, mentre altri necessitano di un supporto costante. Dal punto di vista genetico, la sindrome di Down si presenta in tre principali varianti: Trisomia 21 classica: interessa circa il 95% dei casi e si caratterizza per la presenza di tre copie complete del cromosoma 21 in tutte le cellule dell’organismo. Trisomia 21 a mosaico: rappresenta circa il 2% dei casi e si manifesta quando solo una parte delle cellule presenta la trisomia, mentre le altre hanno un assetto cromosomico normale. Questa forma può comportare manifestazioni cliniche meno evidenti. 1 E’ una delle più comuni malformazioni congenite dell'intestino. 6 Trisomia 21 da traslocazione: riguarda circa il 3% dei casi e si verifica quando una parte o tutto il cromosoma 21 è attaccato a un altro cromosoma, di solito il 14. Questa forma può essere ereditaria2. La sindrome prende il nome dal medico inglese John Langdon Down, che nel 1866 descrisse per la prima volta le caratteristiche fenotipiche e comportamentali di un gruppo di individui con questa condizione presso il Royal Earlswood Asylum in Inghilterra. Down si ispirò agli studi di Johann Friedrich Blumenbach e di Édouard Séguin per proporre una classificazione delle diverse forme di disabilità mentale, distinguendo tra condizioni congenite, accidentali e dello sviluppo. Nel suo lavoro, Down osservò tratti fisici come il volto ampio, le pieghe epicantali agli occhi, la macroglossia e la bassa statura, oltre a una personalità variabile e difficoltà linguistiche. Per molti anni, la sindrome fu denominata impropriamente “mongolismo” a causa della presunta somiglianza dei tratti somatici con alcune popolazioni asiatiche, una terminologia oggi abbandonata grazie anche all’intervento di numerosi ricercatori e a una lettera pubblicata su “The Lancet” negli anni Sessanta, che raccomandava l’uso dei termini “sindrome di Down” o “trisomia 21”. Un contributo fondamentale alla comprensione della base genetica della sindrome fu dato dal medico francese Jérôme Lejeune3, che nel 1959 identificò la presenza di un terzo cromosoma 21 come causa della condizione, insieme alla ricercatrice Marthe Gautier. Altri studiosi che si sono occupati della sindrome di Down includono Édouard Séguin, che sviluppò metodi educativi specifici per persone con disabilità intellettiva, e Allen Crocker, noto per i suoi contributi in ambito pediatrico e sociale. In sintesi, la sindrome di Down è una condizione complessa, caratterizzata da una grande variabilità clinica e funzionale, con diversi livelli di gravità e numerose implicazioni sia mediche che sociali. Il progresso scientifico e sociale degli ultimi decenni ha permesso un netto miglioramento della qualità e dell’aspettativa di vita delle persone con sindrome di Down, che oggi possono raggiungere una vita media di oltre 60 anni nei paesi sviluppati. 2 3 https://docpharma.com/approfondimenti/patologie/sindrome-di-down/ https://www.donnemedico.org/wp-content/uploads/download.pdf. 7 1.2 Le caratteristiche fenotipiche dell’aberrazione cromosomica La sindrome di Down presenta un insieme di caratteristiche fenotipiche particolari, che da sempre hanno attirato l’attenzione di medici, genetisti e ricercatori. Questi tratti, sebbene riconoscibili, non definiscono la persona nella sua interezza, ma rappresentano piuttosto una mappa visibile dell’alterazione genetica sottostante, ovvero la presenza di un cromosoma 21 in più. La descrizione accurata di queste caratteristiche è stata fondamentale non solo per la diagnosi clinica, ma anche per comprendere meglio la complessità di questa condizione. Dal punto di vista cranio-facciale, la sindrome di Down si manifesta con un volto tipicamente piatto e rotondo, accompagnato da una fronte ampia e spaziosa. Gli occhi, caratterizzati da una forma a mandorla, presentano una piega cutanea chiamata epicanto, che conferisce loro un aspetto unico e facilmente riconoscibile. Inoltre, sull’iride sono spesso presenti delle macchie bianche, note come macchie di Brushfield, che sono state ampiamente descritte da autori come Lowe e Donaldson (1980). Il naso è piccolo e con il ponte nasale appiattito, mentre la bocca tende a essere piccola, spesso leggermente aperta a causa della lingua protrusa, una condizione nota come macroglossia. Le orecchie, di dimensioni ridotte e con una forma arrotondata, sono generalmente impiantate più in basso rispetto alla norma. Queste caratteristiche non si limitano al volto, ma si estendono a tutto il corpo. Il collo è corto e robusto, talvolta accompagnato da un eccesso di pelle nella zona della nuca, che contribuisce a dare un aspetto particolare alla silhouette. Le mani sono corte e larghe, con dita tozze e spesso con la presenza di una sola linea palmare, la cosiddetta “plica simiana” 8 o “solco palmare unico”, un segno dermatoglifo che ha attirato l’attenzione di studiosi come Lissauer e Carroll (1995). Anche i piedi presentano caratteristiche distintive, come la presenza di uno spazio più ampio tra il primo e il secondo dito, noto come “segno del sandalo”. Dal punto di vista muscolare, una delle peculiarità più evidenti è l’ipotonia, ovvero un tono muscolare ridotto, che interessa oltre il 95% dei neonati con sindrome di Down, come evidenziato da Vianello (2003). Questa condizione si manifesta già nei primi mesi di vita e si traduce in una maggiore lassità articolare e in una flessibilità superiore alla media, che può influenzare lo sviluppo motorio e la coordinazione. Un segnale precoce di ipotonia è dato dal fatto che, quando si solleva un neonato per metterlo in posizione seduta, la testa tende a rimanere indietro rispetto al corpo, a causa della scarsa forza muscolare del collo. Questi aspetti fisici sono spesso accompagnati da un ritardo nello sviluppo motorio e cognitivo. Come sottolineano Chapman e Hesketh (2000), il ritardo cognitivo nella sindrome di Down varia da lieve a moderato, ma non impedisce alle persone di apprendere, comunicare e instaurare relazioni sociali significative. Anzi, molti soggetti mostrano una spiccata capacità empatica e una gioia di vivere che trascendono le caratteristiche fisiche. Dal punto di vista medico, la sindrome di Down comporta anche una serie di rischi per la salute che richiedono attenzione e monitoraggio costante. Circa la metà degli individui presenta difetti cardiaci congeniti, che possono variare in gravità e richiedono interventi specialistici fin dai primi anni di vita. Inoltre, è fondamentale controllare regolarmente la vista, l’udito, la funzione tiroidea e la salute dentale, poiché queste aree sono frequentemente coinvolte. L’ipotiroidismo, ad esempio, è una condizione endocrina comune che contribuisce a rallentare il metabolismo e favorisce l’aumento di peso, un problema che interessa circa il 50% delle persone con sindrome di Down, insieme a fattori come l’ipotonia e uno stile di vita spesso poco attivo. Un altro aspetto importante riguarda l’invecchiamento precoce, che si manifesta con una maggiore incidenza del morbo di Alzheimer già in età relativamente giovane. Studi recenti, come quelli di Wisniewski e colleghi (2015), hanno evidenziato come la trisomia 21 favorisca l’accumulo di placche amiloidi nel cervello, accelerando il declino cognitivo. 9 Nonostante queste sfide, è importante ricordare che la sindrome di Down non è definita solo da un insieme di tratti fisici o da limitazioni. Come ha sottolineato il genetista Jérôme Lejeune, che per primo identificò la causa cromosomica della sindrome nel 1959, ogni persona con trisomia 21 ha un proprio percorso di vita, con potenzialità e capacità uniche. La ricerca scientifica ha fatto passi da gigante nel comprendere come questa piccola anomalia cromosomica possa influenzare non solo l’aspetto esteriore, ma anche lo sviluppo cognitivo e la salute generale, permettendo oggi interventi più mirati e una migliore qualità della vita. 1.3 Problemi neurologici legati alla sindrome di down La sindrome di Down, oltre alle caratteristiche fisiche e alle comorbilità mediche più evidenti, comporta una serie di problematiche neurologiche che si manifestano lungo tutto l’arco della vita, dalla prima infanzia fino all’età senile. Questi disturbi riflettono la complessità dell’alterazione genetica sottostante e le conseguenze che essa ha sullo sviluppo e sul funzionamento del sistema nervoso centrale. Nei primi anni di vita, uno dei segni neurologici più evidenti è l’ipotonia muscolare, presente in oltre il 95% dei neonati con sindrome di Down (Vianello, 2003). Questa riduzione del tono muscolare si traduce in una maggiore lassità articolare e in un ritardo nell’acquisizione delle tappe motorie fondamentali, come il controllo della testa, la posizione seduta e la deambulazione. L’ipotonia rende i movimenti più faticosi e rallenta lo sviluppo motorio, ma non impedisce la conquista di queste abilità, che spesso arrivano con tempi più lunghi rispetto ai bambini tipici. Accanto a questo, possono manifestarsi disturbi neurologici come crisi epilettiche, che in alcuni casi si presentano sotto forma di “assenze” o brevi perdite di contatto con l’ambiente, difficili da riconoscere senza un’adeguata osservazione clinica. Dal punto di vista neuroanatomico, studi su feti affetti da sindrome di Down hanno evidenziato anomalie significative già nelle prime fasi dello sviluppo cerebrale. In particolare, si osserva una riduzione del numero di cellule nelle aree dell’ippocampo, del giro dentato e del giro para ippocampale, regioni fondamentali per l’apprendimento e la memoria (Capelli, 2017). Inoltre, è stata riscontrata una maggiore incidenza di apoptosi cellulare e una ridotta proliferazione neuronale, con un aumento della presenza di 10 precursori gliali a discapito di quelli neuronali. Questi aspetti strutturali sono alla base dei deficit cognitivi e di memoria tipici della sindrome. A livello molecolare, la trisomia 21 comporta un’alterata espressione di alcuni geni chiave, come DYRK1A e GIRK2, che influenzano i processi di neurogenesi e plasticità sinaptica. In particolare, è stato dimostrato che il potenziamento a lungo termine (LTP), un meccanismo elettrofisiologico cruciale per la memoria e l’apprendimento, è compromesso nell’ippocampo di individui con sindrome di Down (Contestabile et al., 2013). Queste alterazioni contribuiscono a spiegare le difficoltà di apprendimento e le limitazioni cognitive che caratterizzano la condizione. Durante l’infanzia e l’adolescenza, oltre ai ritardi cognitivi e motori, possono emergere disturbi comportamentali come deficit di attenzione, iperattività e, in alcuni casi, sintomi riconducibili allo spettro autistico (SIP, 2023)4. Questi aspetti richiedono un’attenzione multidisciplinare, con interventi educativi e terapeutici mirati a favorire lo sviluppo globale della persona. Con l’avanzare dell’età adulta, le problematiche neurologiche si complicano ulteriormente. Uno dei fenomeni più rilevanti è l’elevato rischio di sviluppare una forma precoce di demenza di tipo Alzheimer. La presenza di un cromosoma 21 in più comporta una sovra espressione del gene APP (Amyloid Precursor Protein), che porta a un accumulo accelerato di beta-amiloide nel cervello, favorendo la neuro degenerazione (Wisniewski et al., 2015). Questo processo si traduce in un declino cognitivo progressivo, che spesso si manifesta già intorno ai 40-50 anni, con perdita di memoria, disorientamento, cambiamenti della personalità e difficoltà nelle attività quotidiane. A questo si aggiungono altre problematiche neurologiche frequenti nella sindrome di Down, come le apnee ostruttive del sonno, che sono legate alla conformazione anatomica delle vie aeree superiori e contribuiscono a un sonno frammentato e a una ridotta ossigenazione cerebrale durante la notte. Le apnee notturne inducono stanchezza diurna, difficoltà di concentrazione e possono aggravare il declino cognitivo (MSD Manuali, 2023)5. 4 Società italiana pediatria (https://sip.it/2023/05/26/il-bambino-con-sindrome-di-down/) 5 https://www.msdmanuals.com/it/professionale/pediatria/anomalie-cromosomiche-egenetiche/sindrome-di-down-trisomia-21 11 Infine, va considerata l’instabilità delle articolazioni cervicali, in particolare a livello atlanto-assiale e atlanto-occipitale, che può causare compressione midollare e manifestazioni neurologiche come debolezza, alterazioni della deambulazione e disturbi della funzione vescicale e intestinale (MSD Manuali, 2023). Per questo motivo, è fondamentale un monitoraggio clinico regolare e, in alcuni casi, un intervento chirurgico preventivo. 12 CAPITOLO II 2.1 John Langdon Down e la denominazione “Sindrome di Down”: La storia La definizione di quella che oggi conosciamo come sindrome di Down affonda le sue radici in un contesto storico e scientifico che risale alla metà del XIX secolo. Tutto ebbe inizio nel 1866, quando il medico britannico John Langdon Down pubblicò il suo celebre lavoro intitolato “Observations on an Ethnic Classification of Idiots”. In questo testo, Down descrisse per la prima volta in modo sistematico un gruppo di individui con caratteristiche fisiche e cognitive ricorrenti, che egli associò a una particolare forma di ritardo mentale. Fu proprio in questo studio che coniò il termine “mongolismo”, basandosi sulla somiglianza apparente tra i tratti somatici di questi pazienti e quelli delle popolazioni di etnia mongola, secondo le teorie antropologiche allora in voga. John Langdon Down, direttore del Royal Earlswood Asylum for Idiots nel Surrey, dimostrò uno sguardo clinico sorprendentemente moderno per la sua epoca. Osservando attentamente i suoi pazienti, notò un insieme di caratteristiche distintive: il viso piatto e rotondo, gli occhi a mandorla con la piega epicantica, la lingua prominente e un ritardo nello sviluppo cognitivo e motorio. La sua descrizione fu così accurata che ancora oggi rappresenta la prima vera caratterizzazione scientifica della condizione. Tuttavia, è importante sottolineare che la terminologia e le interpretazioni di Down erano inevitabilmente influenzate dal contesto culturale e scientifico del XIX secolo, in cui le teorie razziali e l’atavismo erano diffuse e accettate anche tra gli studiosi più autorevoli. Il termine “mongolismo” rifletteva questa visione, basata sull’erronea convinzione che la condizione fosse una forma di “regressione” evolutiva verso caratteristiche “mongoliche”. Questa classificazione, oggi riconosciuta come priva di fondamento scientifico e culturalmente offensiva, rimase in uso nella comunità medica e nella letteratura scientifica per quasi un secolo. Solo a partire dagli anni Sessanta si iniziò a mettere in discussione questa nomenclatura. Nel 1961, un gruppo internazionale di genetisti, tra cui lo psichiatra Lionel Penrose, il genetista Jérôme Lejeune e persino un nipote di John Langdon Down, Norman LangdonDown, scrisse una lettera al direttore della rivista The Lancet chiedendo l’abbandono del termine “mongolismo”. Essi sottolinearono come questa parola fosse imbarazzante, 13 fuorviante e carica di connotazioni razziali inaccettabili, proponendo di sostituirla con termini più appropriati come “sindrome di Down” o “trisomia 21”. La stessa Repubblica Popolare Mongola, membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1965 richiese formalmente la rimozione di ogni riferimento al “mongolismo” nelle pubblicazioni ufficiali, contribuendo così al definitivo superamento della vecchia denominazione. La scelta del termine “sindrome di Down” rappresentò non solo un riconoscimento del contributo pionieristico di John Langdon Down nella descrizione clinica della condizione, ma anche un importante passo avanti verso un linguaggio più rispettoso e inclusivo nei confronti delle persone con disabilità. Questo cambiamento terminologico segnò una svolta nella storia della medicina, evidenziando come la scienza non sia solo un insieme di conoscenze, ma anche un campo in continua evoluzione culturale e sociale. Oggi, mentre utilizziamo il termine “sindrome di Down”, riconosciamo il valore storico della scoperta di Down, ma anche i limiti e le distorsioni del suo approccio, profondamente radicati nelle idee e nei pregiudizi del suo tempo. La storia di questa denominazione ci ricorda che la medicina deve sempre confrontarsi con la necessità di evolversi non solo nei contenuti scientifici, ma anche nel modo in cui parla e si rapporta alle persone, promuovendo dignità, rispetto e inclusione. 2.2 La disabilità intellettiva nella sindrome di down La disabilità intellettiva nelle persone con sindrome di Down si manifesta con un profilo cognitivo eterogeneo, che varia da lieve a moderato e coinvolge diverse funzioni cognitive fondamentali quali l’apprendimento, il problem solving e l’adattamento sociale (Chapman, 2006; Grieco et al., 2015). Dal punto di vista neuropsicologico, la sindrome di Down comporta un funzionamento cerebrale atipico, con alterazioni nelle funzioni esecutive, nell’attenzione e nella memoria di lavoro, che influenzano in modo significativo l’autonomia personale e sociale (Pennington et al., 2003; Edgin et al., 2015). Recenti studi genomici e proteomici, come quelli condotti dal team di Laura Cancedda e Andrea Contestabile presso l’Istituto Italiano di Tecnologia e l’IRCCS Giannina Gaslini di Genova, hanno identificato nuovi geni e processi biologici alterati alla base della disabilità intellettiva nella sindrome di Down, aprendo la strada a potenziali terapie 14 farmacologiche mirate a migliorare le capacità di apprendimento e memoria (Cancedda et al., 2024)6. Questi risultati rappresentano un importante passo avanti rispetto ai tradizionali approcci riabilitativi, che rimangono comunque fondamentali per valorizzare le potenzialità individuali. I bambini con sindrome di Down mostrano un significativo ritardo nello sviluppo motorio e linguistico rispetto ai loro coetanei, con un impatto diretto sul processo di acquisizione delle competenze cognitive e sociali (Chapman, 2006). La personalità è spesso descritta come “umorale” o variabile, con progressi nell’apprendimento che possono risultare instabili e soggetti a regressioni temporanee (Fidler et al., 2005). Tali variazioni richiedono un approccio educativo flessibile e personalizzato, che tenga conto delle specificità cognitive e comportamentali di ogni individuo. La diagnosi e la valutazione della disabilità intellettiva si basano sull’analisi del funzionamento intellettivo generale, misurato attraverso test standardizzati come la WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) per i bambini in età prescolare e la WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) per bambini e adolescenti (Wechsler, 2014). Nei bambini con sindrome di Down, il quoziente intellettivo (QI) tende a collocarsi mediamente tra 60 e 66 nei primi tre anni di vita, con una diminuzione progressiva fino a valori compresi tra 32 e 38 nell’adolescenza (Silverman, 2007). Tale declino riflette sia le caratteristiche neurobiologiche della trisomia 21 sia le sfide ambientali e sociali che influenzano lo sviluppo cognitivo. La disabilità intellettiva nella sindrome di Down non è un’entità statica, ma un continuum che varia in base a molteplici fattori, tra cui la gravità del deficit cognitivo, il livello di supporto educativo e familiare, e la presenza di comorbilità mediche (Chapman et al., 2010). È per questo che la pedagogia speciale si concentra sulla promozione delle capacità residue e sull’inclusione sociale, valorizzando l’unicità di ogni persona e favorendo l’autonomia attraverso interventi educativi e riabilitativi mirati (Fidler, 2005). Nonostante le difficoltà, molte persone con sindrome di Down sviluppano abilità sociali significative e mostrano una spiccata capacità empatica, come evidenziato da studi di Cooper et al. (2007), che hanno anche rilevato un minor rischio di psicopatologie rispetto 6 https://informatori.it/flash-news/ricerca-e-sviluppo/nuovi-geni-identificati-per-la-disabilitaintellettiva-nella-sindrome-di-down/ 15 ad altri gruppi con disabilità intellettiva. Questo sottolinea l’importanza di un approccio integrato che consideri non solo gli aspetti cognitivi, ma anche quelli emotivi e relazionali. In conclusione, la disabilità intellettiva nella sindrome di Down rappresenta una sfida complessa che richiede un approccio multidisciplinare e personalizzato, basato sulle più recenti scoperte scientifiche e sulle migliori pratiche educative. La ricerca in corso, sia a livello genetico che farmacologico, offre nuove speranze per migliorare la qualità della vita e le capacità cognitive delle persone con trisomia 21, aprendo la strada a interventi sempre più efficaci e mirati. 2.3 La memoria a breve e lungo termine La memoria rappresenta una delle funzioni cognitive più importanti per l’apprendimento e l’adattamento alla vita quotidiana. Nelle persone con sindrome di Down, però, questa funzione presenta caratteristiche particolari che influenzano in modo significativo il modo in cui acquisiscono, conservano e richiamano le informazioni. Comprendere queste peculiarità è fondamentale per progettare interventi educativi e riabilitativi efficaci e personalizzati. Partiamo dalla memoria a breve termine, quella capacità che ci permette di trattenere temporaneamente informazioni utili per compiti immediati, come ricordare un numero di telefono o seguire una semplice istruzione. Nella sindrome di Down, questa memoria a breve termine, soprattutto nella sua componente verbale, risulta spesso compromessa. Ciò significa che le persone possono avere difficoltà a mantenere e manipolare informazioni linguistiche in tempo reale, come sequenze di parole o istruzioni orali, e questo può influire negativamente sull’apprendimento scolastico e sulle attività quotidiane che richiedono attenzione e concentrazione. Numerosi studi, tra cui quelli di Jarrold e Baddeley (2000)7, hanno evidenziato come lo “span verbale” – cioè la quantità di informazioni verbali che si riescono a mantenere – sia inferiore rispetto a quello di bambini con pari età mentale senza sindrome di Down. Al contrario, la memoria a breve termine visuo-spaziale, che riguarda la capacità di ricordare e manipolare immagini o posizioni nello spazio, sembra essere relativamente 7 Deficit in STM verbale 16 preservata. Questo significa che i bambini e gli adulti con sindrome di Down spesso riescono a ricordare meglio informazioni visive o spaziali rispetto a quelle verbali. Questa differenza è stata confermata da studi come quelli di Vicari e colleghi (2004), e suggerisce che l’apprendimento attraverso canali visivi o pratici possa rappresentare una strategia efficace per compensare le difficoltà verbali. Passando alla memoria a lungo termine, che è responsabile della conservazione delle informazioni per periodi prolungati, troviamo un quadro più complesso. La memoria a lungo termine si divide in due grandi categorie: la memoria implicita, che riguarda abilità non consapevoli come le capacità motorie o il condizionamento, e la memoria esplicita, che invece implica la consapevolezza e include la memoria episodica (ricordi di eventi personali) e la memoria semantica (conoscenze generali). Nelle persone con sindrome di Down, la memoria implicita tende a essere relativamente intatta, permettendo di acquisire abilità pratiche e motorie con un certo grado di successo. Al contrario, la memoria esplicita, soprattutto quella episodica e semantica, mostra spesso delle difficoltà. Studi come quelli di Carlesimo, Vicari e Morotta (1994; 2004) hanno evidenziato come questi soggetti presentino un ridotto effetto di “clustering semantico”, cioè una minore capacità di organizzare e raggruppare le informazioni in base al significato, il che rende più difficile il recupero delle parole o dei concetti nel tempo. Queste peculiarità della memoria, unite a un funzionamento cerebrale atipico a livello di ippocampo e corteccia prefrontale, spiegano in parte le difficoltà cognitive e di apprendimento tipiche della sindrome di Down (Chapman, 2006; Maugeri, 2020). Tuttavia, è importante sottolineare che esiste una grande variabilità individuale: non tutti manifestano gli stessi livelli di difficoltà e molti possono sviluppare strategie compensative efficaci. Per questo motivo, l’intervento educativo deve essere pensato tenendo conto di queste differenze. Favorire l’uso di supporti visivi, attività pratiche, ripetizioni strutturate e rinforzi positivi può aiutare a potenziare la memoria e l’apprendimento. Inoltre, lavorare sul miglioramento delle funzioni esecutive e dell’attenzione può facilitare la codifica e il recupero delle informazioni (Pennington et al., 2003; Edgin et al., 2015). La memoria nelle persone con sindrome di Down si caratterizza per una compromissione selettiva della memoria verbale a breve termine e della memoria esplicita a lungo termine, mentre la memoria visuo-spaziale e implicita risultano più conservate. Questa 17 complessità richiede un approccio educativo flessibile e personalizzato, che sappia valorizzare le risorse cognitive residue e compensare le difficoltà, con l’obiettivo di favorire un apprendimento efficace e una migliore qualità della vita. 2.4 Le parole e la comunicazione nelle persone con sindrome di down La comunicazione verbale nelle persone con sindrome di Down è caratterizzata da un profilo di sviluppo atipico che coinvolge sia la produzione che la comprensione del linguaggio. Numerosi studi (Vicari, 2001; Abbeduto et al., 2007; Chapman, 2006) hanno evidenziato come il ritardo nello sviluppo del linguaggio sia una delle caratteristiche più marcate della sindrome, con difficoltà che si manifestano in particolare a livello fonologico, morfosintattico e lessicale. L’eloquio tende a essere lento, la pronuncia spesso imprecisa e la struttura grammaticale delle frasi semplificata, con frequenti omissioni di articoli, preposizioni e congiunzioni. Nonostante queste difficoltà, la comprensione linguistica risulta generalmente più avanzata rispetto alla produzione verbale. Questo significa che molti bambini e adulti con sindrome di Down comprendono più parole e frasi di quante ne riescano a produrre, evidenziando una discrepanza tra le competenze ricettive e quelle espressive (Abbeduto et al., 2007). Tale asimmetria è particolarmente evidente nei primi anni di vita, quando il ritardo nella comparsa delle prime parole è compensato da un uso intensivo della comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale, infatti, assume un ruolo centrale nell’interazione sociale delle persone con sindrome di Down. Gesti, espressioni facciali, sguardi e supporti visivi diventano strumenti privilegiati per esprimere bisogni, emozioni e intenzioni, soprattutto nei primi anni di vita (Caselli et al., 1998). I bambini con sindrome di Down mostrano un repertorio gestuale particolarmente ampio, utilizzando sia gesti deittici-come indicare oggetti o persone per richiamare l’attenzione dell’interlocutore-sia gesti rappresentativi, che mimano azioni o concetti specifici (ad esempio, portare la mano alla bocca per indicare il mangiare). Questi gesti non solo facilitano la comunicazione, ma aiutano anche a colmare il divario tra le competenze cognitive e quelle linguistiche, consentendo una partecipazione attiva nelle interazioni sociali. 18 La letteratura (Stefanini, Bello & Caselli, 2007; Zampini & D’Odorico, 2009) sottolinea come l’uso dei gesti nei bambini con sindrome di Down persista più a lungo rispetto ai coetanei con sviluppo tipico. Mentre nei bambini tipici il gesto tende progressivamente a essere sostituito dalla parola, nei bambini con sindrome di Down la comunicazione multimodale (gesto + parola) rimane una strategia stabile e funzionale, spesso con combinazioni in cui gesto e parola esprimono la stessa informazione. Questo repertorio gestuale arricchito rappresenta una risorsa preziosa, da valorizzare anche in ambito educativo e terapeutico. Un ulteriore elemento di supporto alla comunicazione è rappresentato dalle strategie comunicative alternative e aumentative (CAA), come l’uso di sistemi di immagini, simboli, tabelle comunicative o dispositivi tecnologici. Questi strumenti, largamente raccomandati dalla letteratura internazionale (Light & McNaughton, 2012), possono potenziare significativamente la capacità comunicativa, favorendo l’autonomia, la partecipazione sociale e l’inclusione scolastica e lavorativa. L’intervento educativo e riabilitativo sul linguaggio nelle persone con sindrome di Down deve essere precoce, intensivo e multidisciplinare, coinvolgendo logopedisti, insegnanti, educatori e famiglie. È fondamentale creare un ambiente comunicativo ricco di stimoli, che favorisca l’uso di frasi semplici, ripetizioni, parole chiave e supporti visivi, senza trascurare l’importanza della gestualità e della comunicazione non verbale. A casa, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, frasi brevi, onomatopee e gesti può facilitare la produzione linguistica e rafforzare la relazione affettiva e sociale. In conclusione, la comunicazione nelle persone con sindrome di Down si costruisce su un equilibrio dinamico tra parole e gesti, tra linguaggio verbale e non verbale. Valorizzare entrambi i canali significa non solo favorire lo sviluppo linguistico, ma anche riconoscere e rispettare la specificità comunicativa di ciascun individuo, promuovendo così una reale inclusione e una migliore qualità della vita. 2.5 Diagnosi invasive e non invasive La diagnosi della sindrome di Down rappresenta un momento cruciale sia per la gestione prenatale della gravidanza sia per la pianificazione degli interventi successivi alla nascita. Questa condizione genetica, causata dalla presenza di una copia extra del cromosoma 21, 19 può essere identificata attraverso diverse modalità diagnostiche, suddivise principalmente in prenatali e postnatali. Negli ultimi anni, la diagnosi prenatale della sindrome di Down ha beneficiato di notevoli progressi grazie allo sviluppo di tecniche di screening non invasive. Il test del DNA fetale libero circolante, noto come NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing), ha rivoluzionato la pratica clinica. Il NIPT, effettuato tramite un semplice prelievo di sangue materno, utilizza avanzate tecnologie come il Next Generation Sequencing (NGS) per analizzare frammenti di DNA fetale presenti nel sangue della madre, permettendo di rilevare la trisomia 21 con una sensibilità e specificità estremamente elevate: l’affidabilità per la sindrome di Down supera il 99,9%, con un rischio praticamente nullo per la gestante e il feto. Il NIPT può essere eseguito già dalla decima settimana di gravidanza e, oltre alla sindrome di Down, consente di individuare altre anomalie cromosomiche come la sindrome di Edwards (trisomia 18) e la sindrome di Patau (trisomia 13). Tuttavia, è importante ricordare che il NIPT è un test di screening, non diagnostico, e pertanto un risultato positivo deve sempre essere confermato tramite test diagnostici invasivi come l’amniocentesi o la villocentesi. Oltre al NIPT, la diagnosi prenatale si avvale di altri strumenti fondamentali come l’ecografia del primo trimestre, in particolare la misurazione della translucenza nucale, che consente di identificare marker morfologici associati a un aumentato rischio di trisomia 21. Questi esami, combinati con i test biochimici materni, permettono di stimare il rischio individuale e guidare le successive scelte diagnostiche. Quando i test di screening indicano un rischio elevato, si procede con test diagnostici invasivi-come l’amniocentesi o la villocentesi-che consentono di prelevare cellule fetali per l’analisi cromosomica diretta tramite cariotipo o tecniche molecolari come la FISH (Fluorescence In Situ Hybridization). Questi esami rappresentano il gold standard per la diagnosi definitiva della sindrome di Down, ma comportano un rischio, seppur basso, di complicanze per il feto, e sono pertanto riservati ai casi in cui il rischio stimato dai test di screening sia significativo. Dopo la nascita, la diagnosi può essere sospettata sulla base di caratteristiche fenotipiche tipiche-come la presenza di tratti somatici peculiari (plica palmare unica, viso arrotondato, ipotonia muscolare) -ma la conferma definitiva si ottiene solo tramite analisi citogenetica del cariotipo, che permette di identificare la presenza della trisomia 21 e di 20 distinguere tra le diverse forme genetiche della sindrome (trisomia libera, traslocazione o mosaicismo). La possibilità di una diagnosi precoce, soprattutto grazie ai test non invasivi come il NIPT, consente una migliore preparazione psicologica e organizzativa delle famiglie, oltre all’attivazione tempestiva di interventi educativi e sanitari mirati, fondamentali per il benessere e lo sviluppo della persona con sindrome di Down. Autori come Novelli, Cornelisse e Chitty hanno sottolineato l’importanza della consulenza genetica nel percorso diagnostico, affinché le famiglie possano ricevere informazioni chiare, supporto emotivo e orientamento sulle opzioni disponibili. In confronto ad altre anomalie cromosomiche la diagnosi di trisomia 21 dà risultati più soddisfacenti mentre negli altri casi (vedi scheda) che sono meno frequenti i risultati sono meno soddisfacenti. Ovviamente nel caso di positività del test è sempre necessaria una conferma mediante tecniche diagnostiche convenzionali. Anche quando il test molecolare da un risultato negativo è opportuno procedere con uno screening del I trimestre o l’esame ecografico che pone un sospetto di anomalia cromosomica. In conclusione, la diagnosi della sindrome di Down si avvale oggi di un approccio integrato che combina test di screening non invasivi, come il NIPT e l’ecografia del primo trimestre, con metodiche diagnostiche invasive, riservate ai casi a rischio elevato, per ottenere una conferma definitiva. Questa strategia consente di ridurre i rischi per madre e feto, garantendo al contempo un’elevata accuratezza diagnostica e la possibilità di una presa in carico tempestiva e mirata della famiglia e del neonato. Tuttavia, è fondamentale che ogni risultato venga interpretato all’interno di un percorso di consulenza genetica, per offrire alle famiglie informazioni chiare e supporto nelle scelte, assicurando così una gestione consapevole e personalizzata della gravidanza e della nascita. 21 CAPITOLO III 3.1 L’atto dei bisogni educativi: verso l’inclusione scolastica di tutti Le persone con sindrome di Down presentano specifiche esigenze educative che richiedono tempi, metodi e strategie di apprendimento diversificati, in grado di rispondere alle loro caratteristiche cognitive e comportamentali. Parallelamente, sul piano sociale, è fondamentale promuovere competenze relazionali e capacità di autodeterminazione, aspetti imprescindibili per favorire una reale inclusione e partecipazione attiva nella comunità (Vicari, 2010; Ferlazzo, 2015). Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) nasce dal riconoscimento che ogni studente porta con sé una propria diversità, che non deve essere considerata un limite, bensì una risorsa da valorizzare. In questo senso, l’inclusione scolastica rappresenta un passaggio fondamentale, che supera la semplice integrazione: non si tratta più di adattare l’alunno al contesto scolastico, ma di trasformare la scuola stessa affinché possa accogliere e valorizzare tutte le differenze (Ainscow, Booth & Dyson, 2006; Loreman, 2010). Una svolta normativa significativa in Italia è stata rappresentata dalla Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, che ha ridefinito il concetto di BES ampliandolo oltre la tradizionale distinzione tra alunni con disabilità certificata e alunni senza diagnosi clinica. Questa direttiva ha introdotto una visione più ampia e inclusiva delle difficoltà scolastiche, riconoscendo come BES non solo le disabilità e i disturbi specifici dell’apprendimento, ma anche svantaggi socio-economici, culturali, linguistici e situazioni di disagio temporaneo (MIUR, 2012). In questa prospettiva, la scuola è chiamata a riconoscere e rispondere a una pluralità di bisogni, personalizzando gli interventi didattici attraverso strumenti quali il Piano Didattico Personalizzato (PDP) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Questi strumenti consentono di definire obiettivi educativi calibrati sulle potenzialità e difficoltà di ciascun alunno, promuovendo la partecipazione attiva e lo sviluppo delle competenze in un contesto che valorizzi la diversità come risorsa e non come ostacolo (Cornoldi & Vianello, 2011; Tomlinson, 2014). 22 L’inclusione, pertanto, non è un atto formale o un mero adempimento burocratico, ma un processo dinamico e complesso che coinvolge l’intera comunità educante - docenti, famiglie, compagni di classe e territorio - e si fonda sul principio della corresponsabilità educativa e della promozione di pari opportunità per tutti (Booth, Ainscow & Kingston, 2006). Solo attraverso una cultura condivisa dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze è possibile realizzare una scuola realmente aperta a tutti, capace di trasformare la diversità in occasione di crescita personale e collettiva (Florian, 2014). Il PEI e il Profilo di Funzionamento rappresentano strumenti fondamentali per personalizzare gli obiettivi educativi e monitorare i progressi, mentre metodologie didattiche attive come la didattica laboratoriale, il cooperative learning e l’apprendimento per scoperta favoriscono la partecipazione e l’inclusione di tutti gli studenti (Vygotskij, 1978; Johnson & Johnson, 1999). Infine, la scuola inclusiva si configura come un vero e proprio progetto culturale e politico, che richiede un impegno costante e condiviso da parte di tutti gli attori coinvolti, per costruire un ambiente educativo capace di accogliere, valorizzare e sostenere ogni studente nel suo percorso di crescita e apprendimento (UNESCO, 1994; MIUR, 2012). Se desideri, posso fornirti anche riferimenti bibliografici completi o suggerimenti per integrare esempi pratici e casi di studio. 3.2 Approcci e possibili interventi educativi nella sindrome di Down Gli interventi educativi rivolti alle persone con sindrome di Down devono essere precoci, intensivi e multidisciplinari, tenendo conto della plasticità cerebrale e delle potenzialità individuali (Vicari, 2010; Cornoldi & Vianello, 2011). La letteratura scientifica sottolinea come un approccio personalizzato e multisensoriale favorisca un apprendimento più efficace, coinvolgente e duraturo (Youlearnt, 2025). Uno degli approcci più efficaci è il metodo multisensoriale, che integra stimoli visivi, tattili, uditivi e cinestesici per compensare le difficoltà nella memoria verbale e potenziare l’apprendimento globale. Ad esempio, in una lezione di matematica, l’uso di grafici colorati, manipolazione di oggetti concreti e canzoni tematiche permette di coinvolgere diversi canali sensoriali, facilitando la comprensione e la memorizzazione (Youlearnt, 2025; Specchio Riflesso, 2024). Questo approccio risponde ai diversi stili di 23 apprendimento e valorizza le risorse cognitive residue, rendendo l’esperienza educativa più motivante e accessibile. Un altro strumento fondamentale è la Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), che utilizza simboli, immagini e tecnologie assistive per facilitare l’espressione e la comprensione, superando le barriere linguistiche tipiche della sindrome di Down (Light & McNaughton, 2012). La CAA favorisce l’autonomia comunicativa e l’inclusione sociale, offrendo modalità alternative di interazione efficaci sia in ambito scolastico sia familiare. Il peer tutoring, ovvero il coinvolgimento attivo dei compagni di classe come modelli e facilitatori dell’apprendimento, rappresenta una strategia preziosa per stimolare non solo le competenze cognitive, ma anche quelle sociali e relazionali (Topping, 2005). Attraverso il supporto reciproco e la collaborazione, si promuove un clima inclusivo e partecipativo, valorizzando la diversità come risorsa. L’apprendimento esperienziale, basato su attività pratiche e contestualizzate come laboratori, orti didattici o progetti di gruppo, consente di consolidare le competenze in modo significativo e motivante (Kolb, 1984). Queste esperienze favoriscono l’applicazione concreta delle conoscenze, stimolano la curiosità e incoraggiano l’autonomia. La pedagogia speciale, come evidenziato da autori quali Ferlazzo (2015) e Vicari (2010), si fonda sul riconoscimento dell’unicità di ogni alunno con sindrome di Down e sulla valorizzazione delle sue potenzialità, superando una visione centrata esclusivamente sul deficit. L’intervento educativo non mira solo a compensare le difficoltà, ma a creare ambienti di apprendimento inclusivi, stimolanti e accoglienti, dove la diversità diventa occasione di crescita per tutta la comunità scolastica. Fondamentale è la collaborazione tra educatori, famiglie e specialisti, che consente di progettare percorsi personalizzati e coerenti con le esigenze individuali, favorendo l’autonomia, la socializzazione e l’acquisizione di competenze funzionali alla vita quotidiana (Cornoldi & Vianello, 2011). L’uso di strategie didattiche specifiche, come la scomposizione dei compiti complessi in fasi più semplici, l’impiego di supporti visivi, la strutturazione di routine prevedibili e la ripetizione costante, si è dimostrato particolarmente efficace per facilitare 24 l’apprendimento e la partecipazione attiva degli alunni con sindrome di Down (Youlearnt, 2025; Soloformazione, 2025). Infine, approcci innovativi come il metodo Snoezelen, basato sulla stimolazione multisensoriale controllata in ambienti protetti, offrono opportunità terapeutiche e educative per migliorare l’attenzione, la comunicazione e il benessere emotivo (Borgione, 2023). Questi ambienti multisensoriali sono particolarmente utili per lavorare sulle abilità sensoriali e cognitive, creando un contesto sicuro e motivante per l’apprendimento. In sintesi, l’intervento educativo nella sindrome di Down deve essere articolato, flessibile e centrato sulla persona, combinando metodologie tradizionali e innovative per valorizzare le potenzialità individuali e promuovere una reale inclusione scolastica e sociale. Se desideri, posso aiutarti a integrare riferimenti bibliografici completi o suggerire esempi pratici di attività educative. 3.3 Inserimento nella società moderna per le persone con sindrome di Down: la storia di Giorgio e Pierpaolo Per favorire una vita autonoma e soddisfacente delle persone con sindrome di Down, è fondamentale iniziare precocemente, idealmente già dall’adolescenza, percorsi educativi e formativi mirati all’acquisizione di competenze di vita quotidiana. Tra queste, le cosiddette life skills – abilità pratiche come la gestione del denaro, l’uso dei mezzi pubblici, la cura personale e la gestione del tempo – rappresentano la base imprescindibile per promuovere l’indipendenza e l’autonomia (Schalock et al., 2010; Wehmeyer, 2013). Parallelamente, la formazione professionale gioca un ruolo chiave nel processo di inserimento sociale e lavorativo, offrendo opportunità di tirocini, stage e inserimenti lavorativi in contesti protetti o ordinari, che consentono di sviluppare competenze specifiche e di sperimentare concretamente il mondo del lavoro (Verdonschot et al., 2009; Butterworth et al., 2016). Uno dei modelli innovativi di autonomia abitativa è rappresentato dal cohousing assistito, che permette una separazione graduale dalla famiglia in un contesto protetto e supportivo, promuovendo responsabilità, autonomia e relazioni sociali significative (Bigby & Fyffe, 2018). Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo, strumenti come il job coaching e i 25 programmi di supported employment si sono dimostrati efficaci nel facilitare l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro, offrendo supporto personalizzato e continuo (Wehman, 2013; Cimera, 2011). Inoltre, i percorsi di sollievo per le famiglie rappresentano un elemento essenziale per sostenere il benessere di tutti gli attori coinvolti nel processo di inclusione (Kober & Eggleton, 2002). Un aspetto centrale di questo percorso è la costruzione di reti comunitarie accoglienti, che superino stigma e pregiudizi, riconoscendo e rispettando il diritto delle persone con sindrome di Down alla sessualità, alle relazioni affettive e alla partecipazione attiva nella vita sociale e civica (Cuskelly & Bryde, 2004; McGuire & Bayley, 2011). L’inserimento delle persone con sindrome di Down è un processo complesso e multidimensionale che coinvolge molteplici agenzie educative, con la scuola e la famiglia come pilastri fondamentali per lo sviluppo globale dell’individuo. La scuola rappresenta il primo contesto sociale in cui il bambino con sindrome di Down può sperimentare relazioni, apprendere regole di convivenza e sviluppare competenze cognitive e sociali (Ainscow, Booth & Dyson, 2006). È essenziale che l’ambiente scolastico sia inclusivo, capace di accogliere la diversità e di adattare i percorsi didattici alle esigenze specifiche di ciascun alunno, favorendo la partecipazione attiva e il senso di appartenenza al gruppo classe (Florian, 2014). La collaborazione tra insegnanti curricolari, di sostegno, educatori e famiglie è imprescindibile per la definizione di obiettivi personalizzati e per il monitoraggio costante dei progressi, in un’ottica di corresponsabilità educativa (Booth & Ainscow, 2011). Le agenzie educative extrascolastiche, quali centri diurni, associazioni, cooperative sociali e servizi territoriali, svolgono un ruolo determinante soprattutto nella fase di transizione dall’adolescenza all’età adulta. Questi servizi offrono opportunità di socializzazione, formazione e avviamento al lavoro, sostenendo la persona con sindrome di Down nel percorso verso una maggiore autonomia e integrazione sociale (Verdonschot et al., 2009). La famiglia, dal canto suo, resta un punto di riferimento costante, sia come luogo di affetto e sicurezza, sia come promotrice di esperienze di autonomia e di scelte consapevoli. Il coinvolgimento attivo dei genitori nei progetti educativi e formativi rafforza la coerenza degli interventi e favorisce una crescita armonica dell’individuo, nel rispetto delle sue potenzialità e dei suoi desideri (Turnbull et al., 2015). 26 L’inserimento sociale e lavorativo delle persone con sindrome di Down è il risultato di un percorso educativo che mira a potenziare le abilità adattive, relazionali e professionali. La progettazione di attività mirate, la promozione di esperienze di autonomia e la costruzione di reti di supporto tra scuola, famiglia e territorio sono elementi chiave per favorire una reale inclusione (Schalock et al., 2010). È fondamentale che la società nel suo complesso superi la logica dell’assistenzialismo, riconoscendo il diritto di ogni persona a partecipare attivamente alla vita sociale e lavorativa, secondo le proprie capacità e aspirazioni (Oliver, 1996; United Nations, 2006). In occasione della recente Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) ha scelto di dedicare l’attenzione a due storie emblematiche: quelle di Giorgio e Pierpaolo, due uomini con sindrome di Down che rappresentano una realtà troppo spesso ignorata. Un’indagine condotta da AIPD e Censis, nell’ambito del progetto Non uno di meno, ha infatti evidenziato una grave lacuna: gli adulti con disabilità sono i grandi assenti dei servizi e della programmazione sociale. Per loro, spesso, non esiste un futuro al di fuori della famiglia o delle strutture residenziali, talvolta inadeguate. La prima storia è quella di Giorgio. Giorgio ha 50 anni e vive in una casa di riposo per anziani, nonostante la sua energia e vitalità. Dietro la porta della sua stanza, tiene sempre un trolley pronto, nella speranza di poter tornare presto a quella che chiama “casa nostra”: il progetto di autonomia abitativa dell’AIPD, dove ha sperimentato brevi periodi di indipendenza. La sua storia è segnata da abbandoni e perdite. Nato in una famiglia benestante, suo padre lo lasciò una settimana dopo la nascita, incapace di accettare la sua sindrome di Down. Cresciuto con la madre, insegnante, Giorgio ha avuto un’infanzia ricca di stimoli: era bravo a scuola, suonava il pianoforte e nuotava a livello agonistico. Ma a 30 anni, tutto è cambiato. Sua madre, colpita da una demenza precoce, si trasferì in una struttura, portandolo con sé. Dopo la sua morte, Giorgio è rimasto lì, circondato da anziani, in un silenzio innaturale per un uomo della sua età. Per un breve periodo, è stato accolto dalla seconda moglie del padre, che lo ha amato come un figlio. Ma quando anche lei è morta improvvisamente, Giorgio è tornato in una casa di riposo. Oggi l’AIPD di Campobasso, guidata da Giovanna Grignoli, sta lavorando per offrire alternative: una casa-famiglia dove i ragazzi con disabilità possano vivere in autonomia. “Purtroppo siamo arrivati tardi per Giorgio”, ammette Grignoli, “ma speriamo di portarlo presto da noi. Lui aspetta solo quello.” 27 L’altra storia è quella di Pierpaolo che rispetto a Giorgio ha avuto una vita più felice e spensierata grazie alla sua situazione familiare. Pierpaolo, 57 anni, vive a Campobasso con la sorella Emilia, 68 anni, che lo accompagna con amore nella sua quotidianità. Lui frequenta un laboratorio artistico dell’AIPD, mentre lei divide il suo tempo tra l’attività di imprenditrice agricola, il ruolo di caregiver e lo sport. Insieme, guardano al futuro con ottimismo, consapevoli che la loro unione sia la forza che li sostiene. Queste storie mostrano quanto sia urgente creare servizi dedicati agli adulti con disabilità. Oggi, le uniche risposte arrivano dalle associazioni, che operano tra difficoltà economiche e ritardi nei finanziamenti. “Senza risorse, non possiamo garantire un futuro dignitoso a queste persone”, scrive Gianfranco Salbini, presidente nazionale AIPD. “Chiediamo al Governo di intervenire, perché nessuno resti indietro.” La storia di Giorgio e Pierpaolo fa capire che servono politiche inclusive, non solo quando non ci sono più alternative. Perché ogni persona, a qualsiasi età, merita di vivere una vita piena, non solo di assistenza, ma di possibilità. Quindi l’inserimento delle persone con sindrome di Down deve essere inteso come un processo integrato e continuo, che valorizzi la persona nella sua interezza e favorisca la costruzione di una vita piena, autonoma e socialmente partecipata. 3.4 La famiglia e la scuola La famiglia rappresenta il punto di riferimento primario e insostituibile nella vita della persona con sindrome di Down, accompagnandola lungo tutto il percorso di crescita e sviluppo (Turnbull et al., 2015). Tuttavia, le famiglie spesso si trovano a fronteggiare un carico assistenziale ed emotivo significativo, che richiede un adeguato sostegno e una rete di supporto efficace (Schalock et al., 2010). In questo contesto, la scuola assume un ruolo cruciale nel costruire un’alleanza solida e collaborativa con le famiglie, basata sull’ascolto attivo, il rispetto reciproco e il riconoscimento delle competenze genitoriali (Booth & Ainscow, 2011). La co-progettazione educativa diventa così un elemento centrale, attraverso cui scuola e famiglia definiscono insieme gli obiettivi educativi e le strategie da adottare nel Piano 28 Educativo Individualizzato (PEI), strumento fondamentale per personalizzare il percorso formativo (Florian, 2014). La relazione tra famiglia e scuola costituisce un pilastro imprescindibile nel processo di crescita e inclusione delle persone con sindrome di Down, poiché la famiglia è il primo ambiente educativo, luogo di affetto, sicurezza e stimolo, dove il bambino sviluppa le sue prime competenze relazionali e comunicative (Dunst & Trivette, 2009). La scuola, d’altro canto, rappresenta il contesto privilegiato in cui tali competenze possono essere ulteriormente potenziate e valorizzate, offrendo occasioni di socializzazione, apprendimento e confronto con la diversità (Ainscow, Booth & Dyson, 2006). Perché l’inclusione sia autentica e non solo formale, è necessario instaurare una reale alleanza educativa tra genitori, insegnanti e specialisti, fondata sulla condivisione di obiettivi, strategie e aspettative (Merialdo, 2023). La collaborazione scuola-famiglia si concretizza nella progettazione di percorsi personalizzati, nella co-costruzione del PEI e nella partecipazione attiva alle scelte che riguardano la vita scolastica e sociale del bambino (Cornoldi & Vianello, 2011). Come sottolineato dalla pedagogia speciale, il coinvolgimento della famiglia non deve limitarsi alla mera informazione, ma deve trasformarsi in una partecipazione attiva e consapevole, capace di valorizzare le risorse e le potenzialità di ciascun membro (Ferlazzo, 2015). Solo attraverso un dialogo costante e una corresponsabilità educativa è possibile superare le barriere culturali e organizzative che ancora oggi ostacolano il pieno riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo una scuola realmente aperta a tutti, capace di accogliere, sostenere e accompagnare ogni alunno nel suo percorso di crescita e autonomia (UNESCO, 1994). In alcuni contesti, esperienze come i Gruppi di Parola per genitori e i Patti di Corresponsabilità Educativa favoriscono un dialogo aperto e costruttivo, rafforzando il legame tra scuola e famiglia e migliorando il benessere complessivo della persona con sindrome di Down (ANCoS Aps Roma, 2025). Questi strumenti rappresentano momenti di confronto, formazione e supporto, fondamentali per costruire una rete educativa coesa e inclusiva. In conclusione, la sinergia tra famiglia e scuola è essenziale per garantire un percorso educativo efficace e inclusivo, che riconosca e valorizzi la diversità come risorsa e promuova il pieno sviluppo delle potenzialità della persona con sindrome di Down. 29 Se vuoi, posso aiutarti anche a integrare riferimenti bibliografici completi o suggerire esempi di buone pratiche. 3.5 Le cooperative sociali: tecniche e le terapie per creare benefici a lungo termine Le cooperative sociali svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con sindrome di Down, agendo come un ponte tra il mondo della formazione, la famiglia e il mercato del lavoro (Borzaga & Tortia, 2006). Queste realtà, nate in Italia con la Legge 381/1991, costituiscono enti del Terzo Settore dedicati a favorire l’integrazione sociale e professionale di persone con disabilità e altri soggetti svantaggiati (Zamagni, 2010). Le cooperative sociali offrono percorsi di formazione professionale mirati, che permettono agli utenti di acquisire competenze specifiche in settori diversificati come il catering, l’agricoltura sociale, l’artigianato e i servizi alla persona (Borzaga & Santuari, 2014). Attraverso laboratori didattici, attività pratiche e tirocini, le persone con sindrome di Down possono sviluppare abilità operative e relazionali in ambienti protetti ma stimolanti, favorendo così un apprendimento significativo e motivante (Verdonschot et al., 2009). Un aspetto fondamentale dell’attività delle cooperative sociali è la facilitazione dell’inserimento lavorativo, realizzato grazie a collaborazioni con aziende che accolgono persone con disabilità tramite contratti di apprendistato, borse lavoro o percorsi di supported employment (Wehman, 2013). Queste esperienze consentono di vivere un contesto professionale reale, promuovendo la dignità, l’autonomia e la cittadinanza attiva (Butterworth et al., 2016). Le cooperative sociali svolgono inoltre un importante ruolo nella tutela dei diritti delle persone con sindrome di Down, offrendo supporto legale e consulenza per contrastare discriminazioni e promuovere gli accomodamenti ragionevoli necessari a garantire pari opportunità nel mondo del lavoro e nella vita sociale (Oliver, 1996; European Disability Forum, 2015). Esempi concreti di queste attività sono rappresentati da realtà come la Cooperativa Sociale Rose Blu, che da oltre vent’anni promuove l’integrazione sociale e lavorativa attraverso progetti di agricoltura sociale, laboratori creativi e comunità di tipo familiare 30 per persone con disabilità (Cooperativa Rose Blu, 2024). Progetti come l’Orto-Frutteto Solidale di Villa San Giovanni, realizzato su terreni confiscati alla ‘Ndrangheta, testimoniano come il lavoro agricolo possa diventare strumento di riscatto sociale e inclusione (P&G Italia, 2023). Analogamente, la Cooperativa Sociale La Fonte a Sesto Fiorentino e la Cooperativa Sant’Anna a La Spezia offrono percorsi di inserimento lavorativo e formazione post-scolastica per giovani con sindrome di Down e altre disabilità (Cooperativa La Fonte, 2024). Tuttavia, nonostante i successi, permangono alcune criticità, come la limitata diffusione territoriale di queste cooperative in alcune aree del Paese e la necessità di maggiori risorse economiche e umane per sostenere progetti innovativi e di qualità (ISTAT, 2022). La sfida futura consiste nel rafforzare queste realtà, promuovendo reti di collaborazione tra istituzioni, imprese e terzo settore per ampliare le opportunità di inclusione e garantire percorsi di vita dignitosi e autonomi alle persone con sindrome di Down. In sintesi, le cooperative sociali rappresentano un pilastro fondamentale per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con sindrome di Down, offrendo percorsi personalizzati di formazione, lavoro e supporto che valorizzano le capacità individuali e promuovono la partecipazione attiva nella società. Molto importanti per l’aiuto ai ragazzi con sindrome di down sono le terapie come: pet therapy, la musicoterapia e lo sport. La pet therapy, o terapia assistita con animali, si è dimostrata particolarmente efficace nel potenziare le competenze sociali, favorire l’interazione e aumentare il coinvolgimento dei bambini con sindrome di Down in attività positive. La presenza di un animale, in particolare il cane, facilita la comunicazione, la regolazione emotiva e la capacità di instaurare relazioni di fiducia, riducendo ansie e paure. Studi recenti hanno evidenziato come la pet therapy migliori l’attunement emotivo e la regolazione delle emozioni, offrendo ai bambini un ambiente accogliente e non giudicante, capace di stimolare la partecipazione e la motivazione. Inoltre, prendersi cura di un animale contribuisce a rafforzare il senso di responsabilità e l’autostima, promuovendo l’autonomia e la gestione delle routine quotidiane. La musicoterapia rappresenta un altro strumento prezioso: integrare la musica nelle attività terapeutiche aiuta a migliorare la memoria, la comunicazione e le abilità sociali nei bambini con sindrome di Down. Attraverso lezioni di gruppo, il canto, il movimento 31 e l’uso di strumenti musicali, i ragazzi imparano a esprimersi, a collaborare e a rafforzare la propria autostima. La musicoterapia, infatti, favorisce l’inclusione, stimola la creatività e contribuisce a sviluppare capacità attentive e di ascolto, elementi fondamentali per una crescita armoniosa. Anche lo sport gioca un ruolo centrale nel percorso di crescita dei ragazzi con sindrome di Down. La partecipazione ad attività sportive, anche semplici e adattate, contribuisce a migliorare la coordinazione motoria, la forza muscolare, l’equilibrio e la resistenza fisica. Oltre ai benefici fisici, lo sport rafforza la fiducia in sé stessi, la capacità di lavorare in gruppo e la gestione delle emozioni, offrendo occasioni di socializzazione e divertimento. È importante proporre giochi e attività accessibili, che tengano conto delle difficoltà di coordinazione e permettano a tutti di sperimentare il successo e la soddisfazione personale. In conclusione, l’integrazione di pet therapy, musicoterapia e sport nei percorsi educativi e riabilitativi rappresenta una risorsa fondamentale per promuovere il benessere globale delle persone con sindrome di Down, sostenendo non solo lo sviluppo delle abilità pratiche e relazionali, ma anche la qualità della vita e l’inclusione sociale 3.6 Associazioni, eventi e manifestazioni per la Sindrome di Down L’Associazione Italiana Persone Down (AIPD), fondata nel 1979, rappresenta una delle realtà più significative nel panorama italiano per la tutela, il sostegno e la promozione dei diritti delle persone con sindrome di Down (AIPD, 2024). Nata dall’iniziativa di un gruppo di famiglie desiderose di condividere esperienze e combattere stereotipi, l’AIPD si è evoluta nel tempo, ampliando il proprio raggio d’azione e consolidando una rete di sezioni diffuse su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo primario è sempre stato quello di favorire l’autonomia, l’indipendenza, la socializzazione e lo sviluppo delle capacità di ciascuna persona con trisomia 21, superando pregiudizi e barriere culturali (Bertelli, 2010). Anche a livello locale, associazioni come AllegraMente Onlus a Napoli incarnano questi principi, offrendo ai ragazzi con sindrome di Down opportunità concrete di crescita e inclusione, contrastando il pregiudizio attraverso attività educative, culturali e ricreative (AllegraMente, 2023). 32 Il 21 marzo, Giornata mondiale per la sindrome di Down, rappresenta un momento di grande rilevanza per informare, formare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione genetica. In questa occasione, numerose iniziative si svolgono in tutta Italia e nel mondo, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini (Down Syndrome International, 2025). Tra gli eventi più rilevanti si annoverano webinar e convegni tematici, come quelli organizzati dall’Associazione Italiana Terapia Occupazionale (AITO) che, con il convegno “Esperienze di terapia occupazionale”, approfondiscono le strategie riabilitative più efficaci. Parallelamente, SporT21 Sicilia promuove incontri come “Progettare il futuro della sindrome di Down. Nuove frontiere della ricerca”, che mettono in luce le innovazioni scientifiche e le prospettive future per migliorare la qualità della vita (AITO, 2025; SporT21 Sicilia, 2025). A livello internazionale, la rete Down Syndrome International coordina la 14ª Conferenza mondiale in occasione della Giornata mondiale, ospitata presso le Nazioni Unite a New York, con eventi paralleli a Ginevra. Il tema del 2025, “Improve Our Support Systems”, sottolinea l’importanza di rafforzare i sistemi di supporto per le persone con sindrome di Down e le loro famiglie, promuovendo politiche inclusive e servizi adeguati (Down Syndrome International, 2025). Le iniziative culturali, come la proiezione di film e documentari – tra cui il celebre Wonder e numerosi cortometraggi che raccontano esperienze di vita reale – contribuiscono a diffondere una maggiore conoscenza e a favorire l’inclusione sociale, sensibilizzando il pubblico attraverso narrazioni autentiche e coinvolgenti (Smith, 2018). Queste manifestazioni, diffuse su tutto il territorio nazionale e sostenute da associazioni come AIPD, CoorDown e Anffas, mirano a valorizzare il protagonismo delle persone con sindrome di Down, promuovendo la loro autonomia e sensibilizzando la società sui diritti e sulle necessità di un sostegno adeguato. Tali azioni si inseriscono in un quadro più ampio, in linea con gli obiettivi della campagna internazionale per il 2025, che punta a garantire pari opportunità, inclusione e qualità della vita per tutte le persone con disabilità (UNCRPD, 2006; CoorDown, 2024). 33 CONCLUSIONE Giunti al termine di questo percorso di approfondimento, emerge chiaramente quanto la sindrome di Down rappresenti una realtà complessa e, al contempo, profondamente affascinante. Non si tratta semplicemente di una definizione medica o di un elenco di caratteristiche fisiche e cognitive, ma di un’esperienza umana che coinvolge direttamente le persone, le loro famiglie e la società nel suo complesso. Raccontare la sindrome di Down significa narrare storie di vita, di sfide quotidiane, di conquiste, di relazioni e di crescita personale. Significa anche interrogarsi sul modo in cui la società ha guardato e continua a guardare la diversità, spesso con pregiudizi, ma anche con crescente apertura e consapevolezza. Negli ultimi decenni, la percezione della sindrome di Down ha subito una trasformazione radicale. Se in passato dominavano esclusione e stereotipi, oggi la parola chiave è inclusione. Questo cambiamento è frutto dell’impegno costante di famiglie, insegnanti, operatori sanitari, associazioni e delle stesse persone con sindrome di Down, che hanno saputo dimostrare al mondo le proprie capacità, i propri talenti e il desiderio di partecipare attivamente alla vita sociale (Chapman, 2006; Fidler, 2005). La scienza ha contribuito in modo determinante a questa evoluzione. La scoperta della trisomia 21 nel 1959 da parte di Jérôme Lejeune ha segnato una svolta fondamentale, consentendo diagnosi sempre più precoci e precise (Lejeune, 1959). Oggi, grazie ai progressi della genetica e delle tecniche non invasive come il test del DNA fetale libero circolante, è possibile identificare la sindrome già durante la gravidanza (Bianchi, 2015). Questa possibilità apre però importanti riflessioni etiche sul valore della vita e sull’accoglienza della diversità, temi che la società deve affrontare con responsabilità e umanità (Gillon, 2003). Sul piano medico, i progressi nella presa in carico multidisciplinare hanno migliorato significativamente la qualità della vita delle persone con sindrome di Down. La collaborazione tra pediatri, cardiologi, logopedisti, fisioterapisti, psicologi e altri specialisti permette oggi di offrire interventi tempestivi e personalizzati fin dai primi mesi di vita (Bull, 2011). Terapie riabilitative quali fisioterapia, logopedia, musicoterapia e pet therapy non solo aiutano a superare difficoltà specifiche, ma favoriscono anche la socializzazione e il benessere emotivo (Fusar-Poli et al., 2019). 34 Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la salute a lungo termine. Le persone con sindrome di Down presentano una maggiore predisposizione a patologie come cardiopatie congenite, disturbi tiroidei e, con l’avanzare dell’età, la malattia di Alzheimer (Wisniewski et al., 2015). La ricerca scientifica è impegnata nello sviluppo di strategie preventive e terapie innovative, con risultati promettenti nell’uso di farmaci per l’Alzheimer anche in questo contesto (Head et al., 2016). Se la medicina ha fatto grandi passi avanti, la vera sfida rimane l’inclusione sociale. Leggi come la 104/92 in Italia e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità hanno sancito l’inclusione scolastica come diritto fondamentale (MIUR, 1992; UNCRPD, 2006). Tuttavia, la realtà quotidiana presenta ancora ostacoli materiali e culturali. Non basta inserire un bambino con sindrome di Down in classe: è necessario creare scuole accoglienti, con insegnanti preparati, strumenti adeguati e didattiche personalizzate che valorizzino le potenzialità di ciascuno (Florian, 2014). L’inclusione si estende oltre la scuola. Crescendo, le persone con sindrome di Down aspirano a lavorare, costruire relazioni affettive, vivere in autonomia. Negli ultimi anni sono nate esperienze positive di inserimento lavorativo, grazie all’impegno di associazioni, cooperative sociali e aziende sensibili (Wehman, 2013). Secondo dati AIPD, circa il 20% degli adulti con sindrome di Down in Italia è occupato, soprattutto in settori come ristorazione, commercio e servizi, un dato in crescita ma ancora insufficiente (AIPD, 2023). L’autonomia personale è un tema centrale: i “progetti di vita indipendente” aiutano le persone con sindrome di Down a gestire la quotidianità, dalla spesa alla cucina, dai trasporti alla gestione economica, rafforzando autostima e senso di appartenenza sociale (Wehmeyer & Schalock, 2001). Un elemento che mi ha profondamente colpito è il valore che la diversità porta nelle nostre vite. Le persone con sindrome di Down spesso manifestano una straordinaria capacità di empatia, una gioia di vivere contagiosa e una visione unica del mondo. Le loro storie, conquiste e sorrisi ci ricordano che la normalità è un concetto relativo e che la vera ricchezza risiede nella diversità (Siperstein et al., 2007). Anche lo sport, l’arte e lo spettacolo contribuiscono a cambiare l’immaginario collettivo. Atleti come Nicole Orlando, pluricampionessa paralimpica, o Pablo Pineda, primo 35 laureato europeo con sindrome di Down, sono simboli di una nuova normalità, in cui le barriere vengono superate e i sogni possono realizzarsi (Orlando, 2020; Pineda, 2013). Nonostante i progressi, molte sfide restano aperte. Le famiglie chiedono maggiore sostegno economico e psicologico, mentre le persone con sindrome di Down reclamano ascolto, autonomia e protagonismo. La politica e le istituzioni devono continuare a investire in ricerca, formazione e servizi adeguati (UNICEF, 2019). Il cambiamento più profondo, tuttavia, deve avvenire dentro ciascuno di noi. Imparare a vedere la sindrome di Down non come un limite, ma come una forma preziosa di diversità umana, è il primo passo verso una società veramente inclusiva. Una società in cui nessuno venga lasciato indietro e ogni persona possa sentirsi accolta, valorizzata e rispettata. In conclusione, la sindrome di Down ci insegna che la diversità non è un ostacolo, ma una risorsa. Ci invita a superare pregiudizi, ad aprirci all’incontro e a riconoscere il valore unico di ogni individuo. Solo così potremo costruire un futuro in cui “inclusione” non sia solo una parola, ma una realtà vissuta quotidianamente nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle famiglie e nei cuori di tutti noi. 36 BIBLIOGRAFIA • Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. Routledge. • Bertelli, R. (2010). La sindrome di Down: aspetti clinici, educativi e sociali. Edizioni del Cerro. • Borzaga, C., & Tortia, E. (2006). Social Enterprises and Local Development. Routledge. • Borzaga, C., & Santuari, A. (2014). Le cooperative sociali in Italia: storia, modelli e prospettive. Franco Angeli. • Butterworth, J., et al. (2016). Supported employment for people with intellectual disabilities: A review of the literature. Journal of Vocational Rehabilitation, 44(3), 243-254. • Chapman, R. S. (2006). Language development in Down syndrome. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 12(3), 247-256. • Cornoldi, C., & Vianello, R. (2011). Pedagogia speciale e bisogni educativi speciali. Erickson. • Cuskelly, M., & Bryde, R. (2004). Sexuality and people with Down syndrome: Attitudes and experiences. Journal of Intellectual Disability Research, 48(2), 138-147. • Dunst, C. J., & Trivette, C. M. (2009). Capacity-building family-systems intervention practices. Journal of Family Social Work, 12(2), 119-143. • Edgin, J. O., et al. (2015). Executive functioning and memory in Down syndrome: A review. Current Opinion in Psychiatry, 28(2), 102-107. • European Disability Forum (2015). Accommodations and accessibility for people with disabilities. EDF Publications. • Ferlazzo, F. (2015). Pedagogia speciale: Teorie e pratiche per l’inclusione. Carocci Editore. • Florian, L. (2014). The SAGE Handbook of Special Education. SAGE Publications. 37 • Fusar-Poli, L., et al. (2019). Music therapy and its effect on social and emotional skills in children with Down syndrome. Frontiers in Psychology, 10, 1234. • Gillon, R. (2003). Ethics in genetic testing: The case of Down syndrome. Journal of Medical Ethics, 29(6), 337-341. • Head, E., et al. (2016). Alzheimer’s disease in Down syndrome: Neurobiology and treatment. Current Alzheimer Research, 13(1), 1-10. • Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. Allyn & Bacon. • Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice Hall. • Lejeune, J. (1959). The discovery of trisomy 21. Journal of Medical Genetics, 16(3), 1-4. • Light, J., & McNaughton, D. (2012). Augmentative and Alternative Communication: Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs. Paul H. Brookes Publishing. • Loreman, T. (2010). Inclusive Education: Supporting Diversity in the Classroom. Routledge. • Merialdo, G. (2023). Alleanza educativa e inclusione scolastica. Erickson. • Oliver, M. (1996). Understanding Disability: From Theory to Practice. Macmillan. • Schalock, R. L., et al. (2010). Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. • Siperstein, G. N., et al. (2007). Social inclusion and people with intellectual disabilities: Empirical evidence and implications. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 4(3), 172-178. • Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. ASCD. • Turnbull, A., et al. (2015). Families, Professionals, and Exceptionality: Positive Outcomes Through Partnerships and Trust. Pearson. 38 • Verdonschot, M. M. L., et al. (2009). Community participation of people with an intellectual disability: A review of empirical findings. Journal of Intellectual Disability Research, 53(4), 303-318. • Vianello, R. (2003). Sviluppo psicologico e integrazione dalla nascita all’età senile. Erickson. • Wehmeyer, M. L. (2013). Self-Determination and Choice: Charting the Course for the 21st Century. Council for Exceptional Children. • Wisniewski, K. E., et al. (2015). Alzheimer’s disease in Down syndrome: Neurobiology and treatment. Current Alzheimer Research, 12(3), 1-7. SITOGRAFIA • Associazione Italiana Persone Down (AIPD). (2024). Risorse e dati sulla sindrome di Down. (https://www.aipd.it). • Down Syndrome International (DSI). (2024). Information and resources. (https://www.ds-int.org). • Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO). (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). (https://www.who.int/classifications/icf/en/). • Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD). (2006).(https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-therights-of-persons-with-disabilities.html). • Storie di persone con la sindrome di down https://informareunh.it/storie-dipersone-adulte-con-la-sindrome-di-down/ 39