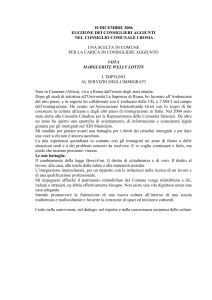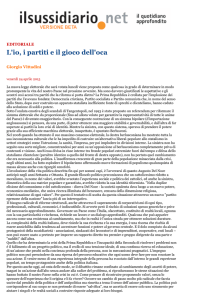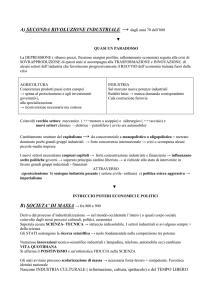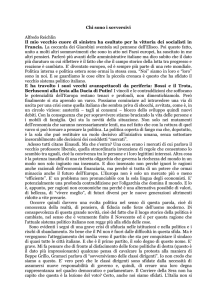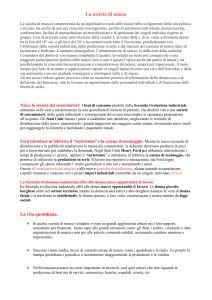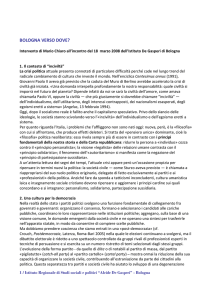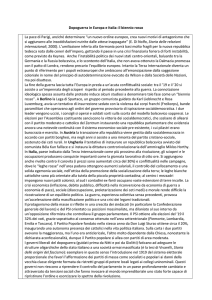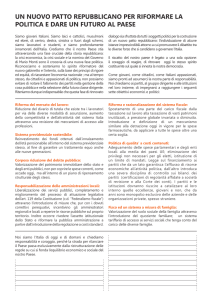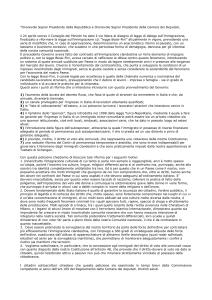caricato da
sperfig
Boeri T. - Populismo e stato sociale

i Robinson / Letture Tito Boeri Populismo e stato sociale Editori Laterza © 2017, Gius. Laterza & Figli Edizione digitale: maggio 2017 www.laterza.it Proprietà letteraria riservata Gius. Laterza & Figli Spa, Bari-Roma Realizzato da Graphiservice s.r.l. - Bari (Italy) per conto della Gius. Laterza & Figli Spa ISBN 9788858129968 È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata Sommario Premessa 1. Chi sono i populisti? Democrazia diretta e corpi intermedi 2. Le ragioni della resurrezione dei partiti populisti 3. Meglio affrontare i problemi alla radice anziché inseguire i populisti 4. Una proposta modesta, ma fattibile Riferimenti bibliografici Appendice. I partiti populisti europei Premessa Da Jacques Delors in poi si è soliti descrivere il processo di integrazione europea con la metafora della bicicletta: “o pedali e vai avanti oppure ti fermi e quindi cadi”. Vi confesso che non mi è difficile cedere a questa convenzione. Ma permettetemi di notare che i presunti pedalatori hanno oggi di fronte a loro una salita particolarmente impegnativa e, almeno a giudicare dalle foto che si trovano su Internet, i leader europei non sempre si trovano a loro agio pedalando sulle due ruote. La salita che sta loro di fronte è come il muro di Sormano, con pendenze del 20%, impegnative anche per chi sale a piedi e tali da far rischiare il ribaltamento. Non è il primo muro che l’Europa si trova di fronte: quello di Berlino era ancora più ripido ed è stato superato brillantemente, demolito, dal gruppo compatto. Frammenti del muro di Berlino sono oggi visibili a Potsdamer Platz e vengono sorpassati in scioltezza dai ciclisti del Velothon Berlin. Ma a questa nuova dura e pericolosa prova l’Europa sta arrivando divisa, con defezioni già annunciate e un pubblico tutt’altro che ben disposto verso chi affronta la salita. A rischio non è solo la moneta unica, ma anche l’Unione Europea, almeno per come la conosciamo. Il pericolo ha un nome ben preciso. Si chiama populismo, la possibile affermazione di partiti che offrono un messaggio semplice quanto pericoloso: interrompere il processo di integrazione europea e chiudere le frontiere agli immigrati, per meglio proteggere le persone più vulnerabili dalle sfide della globalizzazione. È un messaggio che mina alle basi il principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea su cui si fonda, a partire dal Trattato di Roma, il processo di integrazione politica ed economica europea. È un messaggio che toglie soprattutto ai giovani la migliore assicurazione sociale contro la disoccupazione di cui oggi possano disporre. Trovare lavoro in un altro paese dell’Unione è un’opzione per molti quando le cose vanno male dove si è vissuti sin lì. Lo testimonia il vero e proprio esodo di giovani italiani verificatosi negli ultimi sei anni, contestuale alla forte crescita della disoccupazione giovanile nel nostro paese. Un esodo esploso soprattutto negli ultimissimi anni di questa interminabile crisi, quando sono emigrati più di 100.000 italiani all’anno. Lo documenta la figura 1, che mostra il numero di italiani che ha fatto domanda di iscrizione all’AIRE, Anagrafe italiana residenti all’estero (linea nera continua, asse di sinistra), in parallelo all’andamento del tasso di disoccupazione giovanile (linea grigia tratteggiata, asse di destra). Gli anni di recessione sono ombreggiati. Figura 1. Disoccupazione giovanile ed esodo La mobilità del lavoro è tanto più necessaria nell’ambito dell’unione monetaria. Le differenze nei livelli della disoccupazione tra paesi dell’euro non sono mai state così grandi come dopo la Grande Recessione e la crisi dell’area euro. Mentre Austria e Germania hanno mantenuto tassi di disoccupazione relativamente stabili e inferiori alle due cifre anche per i giovani, la Francia ha conosciuto un aumento della disoccupazione soprattutto tra i lavoratori poco qualificati di tutte le età, mentre nei paesi del Sud Europa si è verificata un’impennata nei livelli di disoccupazione, con punte del 40-60% fra i più giovani. La mobilità territoriale nell’ambito dell’Unione Europea è anche un potente fattore di integrazione culturale. Non è un caso che i giovani, la componente più mobile della popolazione, si riconoscano molto di più dei loro genitori nell’identità europea. Un’Europa che ripristina rigidi confini nazionali, che erige muri al suo interno, diventa una mera entità geografica, anziché un progetto di integrazione. Nelle pagine che seguono vorrei, innanzitutto, cercare di offrire una definizione del populismo un po’ meno generica di quella di uso corrente e, soprattutto, capire le ragioni del crescente successo elettorale dei partiti populisti e della loro capacità di dettare l’agenda anche agli altri partiti. Intendo, successivamente, affrontare il rapporto fra populismo e stato sociale, un rapporto strettamente legato alla questione dell’immigrazione. Una delle conclusioni di questa analisi è che i populisti offrono le risposte sbagliate a problemi reali, profondi, vissuti da milioni di persone. Di qui la scelta di discutere, nel terzo capitolo, possibili riforme dello stato sociale che, assieme a un diverso ruolo dei corpi intermedi, possano affrontare alla radice questi problemi. Infine, consapevole delle difficoltà che queste riforme incontrano e dei tempi lunghi che richiedono, vorrei avanzare una proposta, che può apparire modesta alla luce della dimensione dei problemi sin lì affrontati, ma che ha il pregio di avere un alto valore simbolico e di essere immediatamente realizzabile. 1. Chi sono i populisti? Democrazia diretta e corpi intermedi Chi sono i populisti? Secondo l’Enciclopedia Britannica, “I populisti affermano di essere i protettori dell’interesse del cittadino medio contro le élites: assecondano le paure e gli entusiasmi del popolo e si fanno promotori di politiche senza considerarne le conseguenze per il Paese”. Il pregio di questa definizione è che mette in luce gli orizzonti angusti della strategia politica di questi partiti: offrono una protezione di brevissimo respiro, apparentemente immediata, ma al tempo stesso del tutto inefficace nel volgere di poco tempo. Chiudere le frontiere a persone e a prodotti provenienti da altri paesi può sembrare un modo per proteggere la popolazione autoctona dalla concorrenza degli immigrati e dei paesi a basso costo del lavoro. Ma una strategia politica basata sui muri ignora le possibili reazioni degli altri paesi. Questi possono rispondere chiudendo a loro volta le frontiere ai beni prodotti internamente causando la perdita di molti posti di lavoro. Inoltre, le importazioni dei paesi avanzati consistono spesso in beni intermedi che servono a rendere più competitive le esportazioni: rendendo più costose le prime, si inibiscono le seconde. Anche il protezionismo nel mercato del lavoro, piuttosto che in quello dei beni, è di breve respiro e può rivelarsi presto controproducente. Il rischio è quello di sostituire immigrazione regolare con immigrazione clandestina, molto più difficile da gestire. La regolarizzazione degli immigrati, come documenta una recente ricerca svolta nell’ambito del progetto VisitINPS basata sull’accesso ai verbali ispettivi e ai dati degli archivi sui versamenti contributivi individuali e delle aziende coinvolte, porta a una emersione, persistente nel tempo, di base contributiva. Chi invece arriva in modo illegale e non ha alcuna opportunità di regolarizzarsi, non solo non paga i contributi, ma è anche esposto a un rischio più alto di venire coinvolto in qualche attività criminale. Un effetto causale della mancanza di regolarizzazione sul coinvolgimento in attività illegali è stato riscontrato dagli studi che hanno comparato le sorti di chi ce l’ha fatta e di chi non ce l’ha fatta in uno dei click days per la regolarizzazione degli immigrati. Se poi gli altri paesi reagiscono chiudendo a loro volta le frontiere, questo finirà per trattenere da noi persone che avrebbero migliori opportunità d’impiego altrove. E non bisogna mai dimenticare che gli immigrati hanno reso più competitive le nostre imprese e risolto i problemi di molte famiglie italiane nel colmare le falle evidenti del nostro stato sociale nell’aiutare le persone non-autosufficienti. Analogamente, tagliare le tasse e aumentare la spesa pubblica, un altro Leitmotif della propaganda populista, può nell’immediato migliorare la situazione di molte persone, ma rapidamente porta all’isolamento internazionale e al collasso di un paese, con un forte peggioramento delle stesse condizioni di vita iniziali dei più deboli. Il tutto mentre un pesante fardello di debito pubblico viene lasciato in eredità alle generazioni future. La definizione di populismo che, a mio giudizio, è ancora più utile nel circoscrivere e insieme capire questo fenomeno è quella offerta dal politologo olandese Cas Mudde. Si tratta di una ideologia (e di una conseguente strategia politica) “leggera” che considera la società come composta da due gruppi omogenei, da due blocchi monolitici, tra di loro contrapposti: da una parte il popolo, dall’altra l’élite corrotta (declinata al singolare). Il pregio di questa definizione è che mette in luce come il peggior nemico del populismo sia “tutto ciò che sta nel mezzo”, i cosiddetti corpi intermedi della società civile: dall’associazionismo ai partiti, dalle rappresentanze di interessi (a partire dai sindacati) alle istituzioni di garanzia, dalle autorità indipendenti di controllo ai dirigenti indipendenti di amministrazioni pubbliche. La democrazia dei populisti è la democrazia diretta che assegna un potere assoluto alla maggioranza, trasformandosi paradossalmente nella dittatura della maggioranza paventata da Alexis de Tocqueville in La democrazia in America. Quella dei populisti è una visione della democrazia ben diversa da quella propria delle democrazie liberali o industrializzate, in cui sono presenti molte istituzioni a tutela delle minoranze, che garantiscono il rispetto dei principi fissati nella Costituzione e che fungono da contrappeso al potere dell’esecutivo (i cosiddetti sistemi di checks and balances). Questi corpi istituzionali intermedi (a partire dalle associazioni politiche e dai partiti) rafforzano anche i legami sociali, permettendo che la delega al potere pubblico insita nella democrazia rappresentativa non porti al “dominio di un’autorità lontana e irraggiungibile, fondata sull’isolamento fra uomo e uomo, dove tutti diventano estranei a tutti”. La storia ha dato ragione a Tocqueville: molte dittature sono nate da argomenti populisti. E sono in molti, oggi, a intravvedere il rischio di evoluzioni di questo tipo anche in Europa, soprattutto fra i paesi dell’ex blocco sovietico. I partiti populisti hanno una lunga storia, raramente coronata da esperienze di governo, almeno nell’ambito delle democrazie industrializzate. Il termine populismo si deve al People’s Party che conquistò cinque Stati nelle elezioni presidenziali del 1892 negli Stati Uniti. In Europa il precedente più rilevante è il movimento poujadista (dal nome di Pierre Poujade) del dopoguerra francese; in Italia troviamo tracce indelebili di populismo, in mezzo a tante altre cose, nel partito dell’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini. Le esperienze di governo nazionale dei populisti sono per lo più concentrate in America Latina, con generazioni di politici ai due estremi dell’ideologia politica: dalla sinistra dei Perón e Vargas, alla destra di Fujimori, alla nuova generazione di sinistra di Chávez, Morales e Correa. Coerentemente con una strategia che guarda ai risultati immediati ignorando le conseguenze di lungo periodo, i primi mesi dei populisti al governo sono idilliaci: politiche espansive e un ottimismo che rapidamente contagia i mercati. Poi, quando i vincoli macroeconomici impongono le loro leggi, inizia la discesa lungo il maelstrom. Valga per queste esperienze il giudizio lapidario di Rudiger Dornbusch e Sebastian Edwards, due illustri economisti che hanno studiato a fondo l’America Latina: Più e più volte, Paese dopo Paese, i populisti hanno sposato programmi economici che richiedevano un uso massiccio di politiche fiscali espansive e una valuta sopravvalutata per accelerare la crescita e ridistribuire il reddito. L’implementazione di queste politiche si è normalmente accompagnata ad una indifferenza nei confronti dell’esistenza di vincoli fiscali e delle leggi economiche che presiedono alla determinazione del tasso di cambio. Dopo un breve periodo di ripresa economica e di crescita si creano dei colli di bottiglia che provocano pressioni macroeconomiche insostenibili le quali, in ultima analisi, si traducono in un crollo dei salari reali e in serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Il risultato finale di questi esperimenti ha provocato, in genere, inflazione galoppante, crisi e collasso dei sistemi economici. All’indomani di questi esperimenti non c’è alternativa se non implementare, solitamente con l’aiuto del Fondo Monetario Internazionale, un drastico e costoso programma di stabilizzazione. Il carattere autodistruttivo del populismo si nota in particolare nella brusca riduzione del reddito pro capite e dei salari reali che si verifica sul finire di queste esperienze. Ci sono sicuramente differenze importanti fra i partiti populisti oggi presenti nei vari paesi europei. Alcuni sono ideologicamente più vicini alla destra, altri alla sinistra, altri ancora sono partiti trasversali, che superano la dicotomia destra-sinistra in nome della contrapposizione fra popolo ed élite. Ma tutti questi partiti hanno in comune una forte vocazione antieuropeista, sovranista e, nella quasi totalità dei casi, anti-immigrazione. Hanno acquisito sempre più rilievo negli anni della Grande Recessione e, poi, in quelli della crisi dell’Eurozona, traendo infine nuova linfa vitale dall’esplosione del problema dei rifugiati. Fatto sta che oggi ci sono partiti populisti che raccolgono almeno il 10% dei voti in venti paesi europei. Mediamente contano per il 17% dell’elettorato. In cinque paesi, tra cui l’Italia, sono il primo partito; in sette paesi (Finlandia, Grecia, Lituania, Norvegia, Slovacchia, Svizzera e Ungheria) sono al governo. E i sondaggi per le prossime elezioni li danno quasi ovunque in crescita. L’avanzata del populismo e, più in generale, la sfiducia nella classe politica che questa esprime si riflette anche in una riduzione della partecipazione alle elezioni. In genere populismo e astensionismo vanno di pari passo ed esprimono un rifiuto diffuso per la classe dirigente. Oltre alla loro influenza diretta, alla loro capacità di porre al centro del confronto i temi a loro più congeniali, i partiti populisti riescono a spostare le piattaforme degli altri partiti. Questi, nel cercare di non perdere terreno, spesso inseguono il nazionalismo e sono disposti anche a rinunciare a principi fondamentali, come ad esempio quello della libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. Molto anti-europeismo oggi acquisito da partiti e leader politici in passato favorevoli all’integrazione europea può essere letto in questo modo: il tentativo di occupare uno spazio che altrimenti sarebbe destinato ai partiti populisti. Per questo è importante trovare antidoti al populismo anche quando non c’è un rischio concreto che questi partiti possano andare al potere. Per certi aspetti, al potere lo sono già. E dove non sono al governo, quasi sempre detengono il monopolio dell’opposizione, obbligando gli altri partiti a formare coalizioni altamente eterogenee e perciò particolarmente inefficaci nell’affrontare le sfide che molti paesi hanno di fronte dopo una lunga crisi. 2. Le ragioni della resurrezione dei partiti populisti Dietro al successo recente dei partiti populisti c’è una tensione latente fra domanda e offerta di protezione sociale. Da una parte, una crescente vulnerabilità ai cambiamenti tecnologici e alla globalizzazione di vasti strati della popolazione alimenta una forte domanda di protezione. Dall’altra, non ci si fida di chi dovrebbe offrire questa protezione e, dunque, si avverte la necessità di rivolgersi ad outsiders che non abbiano apparentemente alcun legame con la classe dirigente. C’è, dunque, una ragione economica (la perdita di reddito e di sicurezza) e una motivazione di tipo culturale (la sfiducia verso le classi dirigenti) alla base della resurrezione dei populisti. È il loro incrocio a produrre il populismo come fenomeno diffuso e potenzialmente maggioritario. Uno dei due ingredienti, da solo, probabilmente non basterebbe. I dati sulla distribuzione planetaria del reddito ci dicono che esiste un ceto medio-alto del mondo, costituito soprattutto dalle persone poco istruite nei paesi avanzati, che negli ultimi venti anni ha pagato un prezzo elevato alla globalizzazione. La figura 2 mostra, sull’asse orizzontale, la scala dei redditi mondiali nel 1988, a sinistra quelli più bassi, a destra quelli più alti. L’asse verticale, invece, ci dice di quanto questi redditi sono variati in termini reali nei venti anni successivi. L’avvallamento che si nota fra il 75° e il 95° percentile documenta che coloro che si trovavano trent’anni fa fra il 25% e il 5% più ricco della popolazione mondiale hanno subìto, nei venti anni successivi, un brusco peggioramento della loro posizione relativa nella scala dei redditi, non partecipando alla crescita globale. Si tratta per lo più di lavoratori poco qualificati nelle economie avanzate. Non è avvenuto così in altre parti della distribuzione del reddito mondiale, ad esempio tra i lavoratori poco qualificati dei paesi emergenti, localizzati per lo più fra il 20° e il 50° percentile, dove i redditi reali sono aumentati anche in modo consistente. Figura 2. Cambiamenti percentuali del reddito reale a diversi percentili della distribuzione globale del reddito In aggiunta alla globalizzazione, il progresso tecnologico di molte democrazie industrializzate ha comportato una polarizzazione delle opportunità di impiego, esponendo la parte inferiore del ceto medio al rischio di povertà, rendendo socialmente vulnerabili persone che non avrebbero mai pensato di esserlo. Tutto ciò è avvenuto mentre lunghi anni di crisi e l’affievolirsi delle opportunità di mobilità sociale hanno portato a una profonda sfiducia nei confronti di chi dovrebbe offrire protezione sociale. Poco importa se le classi dirigenti dei diversi paesi hanno effettivamente responsabilità nella crisi o se questa sia dovuta a fattori esterni. Quel che conta è che le classi dirigenti vengono percepite come corrotte e lontane anni luce dai cittadini. Si chiede protezione, ma al contempo si rifiuta chi potrebbe offrirtela, è il “grande paradosso” che Arlie Russell Hochschild rinviene nel suo viaggio, da straniera a casa propria, fra gli elettori di Donald Trump. Dietro al successo elettorale dei populisti ci sono, dunque, fenomeni di lungo periodo – la globalizzazione e il progresso tecnologico – accanto ai perduranti effetti della Grande Recessione. E c’è anche un tentativo disperato di riguadagnare sovranità nazionale per redistribuire risorse a favore di chi è rimasto indietro. Come si evince chiaramente dalla figura 3, nel referendum sulla Brexit sono state le componenti del paese con un reddito più basso, qui misurato in termini di salario orario (asse orizzontale), a votare massicciamente per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Viceversa, al crescere del salario i voti a favore dell’uscita tendono a diminuire drasticamente. Figura 3. Standard di vita e voto per Brexit Il dato paradossale è che l’Unione Europea sin qui non ha tolto sovranità nazionale ai singoli Stati membri nel disegno delle politiche sociali. Non esiste, del resto, una sola “Europa sociale”, ma tante Europe sociali distinte. I casi di interferenza di istituzioni sovranazionali europee nel disegno delle politiche sociali sono relegati alla crisi del debito dell’Eurozona, alle politiche imposte dalla Troika ai paesi che hanno accettato di cedere sovranità nazionale per non uscire dall’Europa. Questi diktat imposti da Bruxelles (e Francoforte) possono spiegare il successo dei populisti in Grecia, forse più in generale nel Sud Europa, ma non nei paesi dell’Europa continentale e settentrionale. C’è un’altra forma di minaccia alla sovranità nazionale sulle politiche del welfare nei paesi con uno stato sociale più generoso, sulla quale i partiti populisti capitalizzano consensi. È una minaccia indiretta. Si basa sulla relazione fra stato sociale e immigrazione. Sarebbe quest’ultima a togliere sovranità ai paesi nel disegno del proprio welfare state. Gli immigrati hanno, in effetti, tutte le caratteristiche di un comodo capro espiatorio: visibili, circondati spesso da pregiudizi, con forti difficoltà di integrazione culturale e sociale. L’immigrazione è un tema che polarizza l’opinione pubblica, il terreno ideale per chi vuole scomporre, ricomporre e riallineare gruppi di elettori. Come documenta questa breve rassegna di citazioni di politici populisti in paesi con uno stato sociale relativamente generoso, tutti gli immigrati – comunitari o extracomunitari – vengono descritti come vere e proprie “spugne dello stato sociale”. Secondo questi mistificatori di professione, è per colpa degli immigrati che la spesa sociale deve essere tagliata, che bisogna allontanare l’età in cui si va in pensione, che bisogna tagliare il welfare. Vi assicuro per conoscenza diretta che i tagli al welfare alimentano odi feroci. Scaricare queste responsabilità sugli immigrati significa additarli all’odio di molti nostri concittadini. I dati, peraltro, ci dicono esattamente il contrario. In Italia, ad esempio, gli immigrati versano ogni anno otto miliardi di contributi sociali e ne ricevono tre in termini di pensioni e altre prestazioni sociali, con un saldo netto di circa cinque miliardi per le casse dell’INPS. Certo, a fronte di questi contributi netti vi saranno un domani prestazioni: gli immigrati di oggi faranno parte dei pensionati di domani. Ma è anche vero che in molti casi i contributi previdenziali degli immigrati non si traducono poi in pensioni. L’INPS ha calcolato che sin qui gli immigrati ci hanno “regalato” circa un punto di PIL di contributi sociali a fronte dei quali non sono state loro erogate delle pensioni. E ogni anno questi “contributi a fondo perduto” degli immigrati valgono circa 300 milioni di euro di entrate aggiuntive nelle casse dell’INPS. Stime condotte sugli altri paesi europei, a partire da fonti campionarie, raffrontando le tasse e i contributi versati dagli immigrati con l’insieme delle prestazioni sociali (pensioni, sussidi di disoccupazione, assistenza sociale) loro erogate dai sistemi di protezione sociale nazionali, evidenziano ovunque un contributo positivo degli immigrati. Questi sono sottorappresentati fra i beneficiari di prestazioni di tipo contributivo, mentre, soprattutto nei paesi del Nord Europa, sono sovrarappresentati fra i beneficiari di assistenza sociale. Dato che i trasferimenti assistenziali assorbono una quota molto più bassa della spesa sociale dei trasferimenti contributivi, il saldo complessivo è positivo. Più difficile valutare l’impatto fiscale dell’immigrazione quando si tenga conto della spesa sanitaria e per l’istruzione. Gli immigrati, essendo più giovani della popolazione autoctona, hanno in genere meno bisogno di assistenza sanitaria dei nativi. Avendo più figli, almeno una volta completata la riunificazione famigliare, tendono invece a fruire proporzionalmente di più del sistema educativo. Come nel caso dei trasferimenti sociali, una valutazione completa degli effetti fiscali dell’immigrazione richiede di considerare la posizione fiscale netta per generazioni di immigrati durante la loro intera vita, anziché soltanto in un dato momento. Tutti gli studi di cui siamo a conoscenza che hanno compiuto queste valutazioni in Europa, nell’ambito di modelli di contabilità generazionale, hanno concluso che il saldo netto è positivo soprattutto se gli immigrati arrivano – come nella stragrande maggioranza dei casi – da giovani e lasciano il paese che li accoglie quando invecchiano per tornare al luogo d’origine. Oltre a disinformare riguardo all’impatto fiscale dell’immigrazione, i partiti populisti offrono le ricette sbagliate per affrontare eventuali forme di welfare shopping, di turismo sociale. Impedire la mobilità del lavoro significa, come già accennato, precludere l’accesso, soprattutto da parte dei giovani, alla migliore assicurazione contro la disoccupazione oggi disponibile in Europa: vale a dire cercare lavoro nei paesi che offrono le migliori opportunità di impiego. È un’assicurazione contro la disoccupazione che ha, peraltro, il vantaggio di alleggerire la pressione fiscale sui bilanci nazionali. Chi si sposta e trova lavoro altrove rende il finanziamento dello stato sociale meno oneroso, non rendendo più necessari i trasferimenti destinati a chi perde il lavoro. Gli slogan dei populisti trovano oggi spazio in Europa a seguito dell’impennata delle richieste di asilo. Il numero di coloro che richiedono aiuto umanitario è più che quintuplicato negli ultimi anni, passando da meno di mezzo milione a più di due milioni e mezzo all’anno secondo i dati dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (figura 4). Molti dei richiedenti asilo arrivano in Europa dall’Asia, essendo la Siria il principale terreno di conflitto. Figura 4. Il boom delle richieste d’asilo L’immigrazione associata allo stato di rifugiato è molto diversa da quella economica per almeno tre motivi. Primo, origina da conflitti da cui si cerca di fuggire anziché essere alimentata dalla ricerca di migliori standard di vita sul piano prettamente economico. Perciò è una migrazione dettata principalmente da eventi in atto nel paese d’origine piuttosto che dal richiamo dei paesi di destinazione (dominano i fattori push rispetto a quelli pull). Il rifugiato raramente può scegliere dove andare e questo limita fortemente la possibilità che poi si verifichino un inserimento rapido nel mercato del lavoro e un incontro fra domanda e offerta di competenze. In secondo luogo, i rifugiati solitamente arrivano per grandi ondate associate all’aprirsi di nuovi teatri di conflitto, dunque con molta minore gradualità rispetto all’immigrazione economica. Questo rende l’integrazione dei nuovi arrivati più difficile. A ciò si aggiunga il fatto che gli stessi rifugiati hanno minori incentivi a una rapida integrazione, giacché ritengono che si tratti di una sistemazione temporanea (ciò che, in genere, ex post non risulta vero). Infine, la normativa è diversa. La domanda di asilo deve essere presentata all’arrivo, mentre l’immigrazione economica legale richiede generalmente che la domanda venga inoltrata prima di lasciare il paese d’origine. Inoltre, in attesa dell’accettazione della domanda, il richiedente asilo non può lavorare e perciò inevitabilmente riceve trasferimenti pubblici, dipende cioè dallo stato sociale senza potervi contribuire. Queste differenze normative e associati ritardi nel processo di integrazione sono confermati dai dati. I rifugiati hanno il 50% in meno di probabilità di lavorare rispetto agli immigrati economici nei primi tre anni dopo il loro arrivo. Convergono ai tassi di occupazione degli immigrati economici solo nel giro di quindici anni. Non sorprende, dunque, che la percezione degli immigrati sia peggiorata dopo l’impennata nel flusso di rifugiati, nonostante le ragioni umanitarie che dovrebbero giustificare l’ospitalità loro concessa dai paesi che li accolgono. L’integrazione sociale è inscindibilmente legata all’integrazione nel mercato del lavoro e, come si è visto, i rifugiati hanno tempi più lunghi di integrazione nel mercato del lavoro rispetto agli immigrati economici. A riprova di quanto conti l’integrazione nel lavoro, c’è il fatto che generalmente la percezione degli immigrati è migliore nei centri urbani, dove è più facile trovare un’occupazione, rispetto ai piccoli centri o alle zone rurali. Le grandi città possono offrire ancora più opportunità di impiego ai rifugiati che, come si è sottolineato, non sono nella condizione di scegliere dove andare. Le città hanno un mercato del lavoro più ampio, con maggiori probabilità di valorizzare le competenze di questi lavoratori, di trovare un incontro fra domanda e offerta. Il populismo rischia dunque di mettere in moto un circolo vizioso in cui restrizioni alla mobilità rendono più difficile la ricerca di un’occupazione da parte dei giovani europei e degli stessi immigrati, portandoli a competere per un impiego in aree che offrono scarse opportunità di lavoro. Questo può, a sua volta, rendere più oneroso lo stato sociale e creare forti tensioni anche nell’accesso alle prestazioni sociali. In altre parole, il populismo, in nome di una virtuale protezione temporanea contro gli immigrati, finisce per peggiorare le condizioni di vita non solo degli immigrati, ma anche della popolazione autoctona. E rende più difficile finanziare le prestazioni dello stato sociale. Il disagio diffuso può, a quel punto, portare ad un ulteriore aumento della domanda di politiche populiste, magari affidate ad altri attori. 3. Meglio affrontare i problemi alla radice anziché inseguire i populisti Il populismo offre, come si è visto, risposte sbagliate ai problemi da cui trae la propria forza. Di più: induce a pensare che i problemi più spinosi possano essere risolti semplicemente sostituendo i politici corrotti con rappresentanti del popolo, che possibilmente non abbiano alcuna esperienza di governo. Il modo migliore di evitare nuove cocenti delusioni a chi oggi, quasi per disperazione, è disposto a scommettere su persone di cui non si sa nulla, tranne che apparentemente “sono come noi”, è affrontare i problemi alla radice anziché accettare le libere associazioni della propaganda populista. Bisogna rimuovere quelle iniquità che trasmettono all’opinione pubblica l’immagine di una classe dirigente corrotta che pensa esclusivamente ai propri interessi. Dimostrare nei fatti che le regole dello stato sociale si applicano anche a chi ha posizioni di potere. Bisogna poi rispondere in modo convincente alla richiesta di protezione, separando i problemi dello stato sociale da quelli dell’immigrazione. Si tratta di due problemi disgiunti, che vanno affrontati a un differente livello di governo. Il problema dello stato sociale riguarda principalmente le singole giurisdizioni nazionali. Quello dell’immigrazione è un problema che non può che essere affrontato a livello europeo. Nei singoli paesi è importante che avanzi la riforma dei sistemi di protezione sociale, nella direzione di renderli sostenibili di fronte alle grandi sfide di questo secolo, dalla globalizzazione al cambiamento tecnologico. I sistemi di protezione sociale europei sono stati costruiti soprattutto per rispondere a crisi temporanee, imposte dal ciclo economico. I sussidi di disoccupazione consentono a chi perde il lavoro di cercare un impiego alternativo, evitando che si impoverisca fin dal giorno dopo il licenziamento. In questa loro funzione sociale i sussidi di disoccupazione hanno anche un ruolo importante dal punto di vista macroeconomico: impediscono che la crisi diventi più profonda e più duratura evitando che si metta in moto un circolo vizioso di calo ulteriore della domanda di beni prodotti dalle imprese e di distruzione di posti di lavoro. Analogamente, strumenti che sussidino riduzioni dell’orario di lavoro come la Cassa Integrazione Guadagni sono adatti per recessioni relativamente brevi: tengono i lavoratori attivi e impediscono alle imprese, temporaneamente in difficoltà, di perdere il capitale umano accumulato, una forza lavoro che nel tempo ha imparato a fondo il proprio mestiere e che sarebbe difficile sostituire con altri lavoratori una volta che la recessione è finita. Prestazioni sociali di questo tipo non possono però gestire crisi strutturali, che per lunghi anni o addirittura per sempre rendono obsolete certe lavorazioni o le spostano in altre parti del mondo. Di fronte a sfide di questa portata i sussidi di disoccupazione, inevitabilmente di durata limitata, sono, alla lunga, un’arma spuntata. I trasferimenti in costanza di rapporto di lavoro possono addirittura rivelarsi controproducenti, legando persone a lavori e imprese che non hanno prospettive. Per trasformare la protezione sociale ciclica in protezione sociale strutturale bisogna pensare a strumenti che facilitino la ricollocazione professionale, il cambiamento di lavoro, anche quando questo comporta inizialmente un salario più basso di quello avuto in precedenza e un posto sulla carta “meno sicuro”. Assicurazioni salariali che integrino i salari nei primi anni in cui si accetta un nuovo lavoro, meno remunerato del precedente, possono svolgere questa funzione. Fondamentale è anche proteggere senza inibire la mobilità territoriale, la ricerca di lavoro altrove. Ed è importante che i regimi di protezione dell’impiego incoraggino un costante investimento in formazione sul posto di lavoro da parte del lavoratore e dell’azienda, perché è proprio il miglioramento costante dell’incontro fra domanda e offerta di competenze che può proteggere dalla competizione dei paesi a basso costo del lavoro e dall’automazione. Per chi proprio non ce la fa e rischia di cadere in condizioni di indigenza, invece, ci vuole un paracadute, un reddito minimo, in grado di riportare il beneficiario al di sopra della soglia di povertà. L’accesso a questo reddito minimo garantito è subordinato all’accertamento che le condizioni reddituali e patrimoniali delle famiglie siano effettivamente al di sotto della soglia di povertà. Per chi è disoccupato e in condizioni di lavorare, la possibilità di continuare a ricevere il trasferimento deve essere condizionata ad un impegno attivo nella ricerca di un impiego. Offrire protezione sociale strutturale significa anche rendere i sistemi di welfare sostenibili, in grado di mantenere nel tempo gli impegni che prendono con i cittadini e con i contribuenti. Uno stato sociale sostenibile deve essere efficace nel raggiungere chi ha davvero bisogno d’aiuto, senza disperdere risorse a favore di persone che occupano una posizione intermedia o addirittura medio-alta nella scala dei redditi. Uno stato sociale sostenibile deve basarsi in gran parte su un principio assicurativo, in cui le prestazioni vengono erogate a partire dai contributi versati, come premi assicurativi. Uno stato sociale sostenibile deve porre in essere un solido patto fra generazioni, in cui non vi siano stridenti asimmetrie fra il trattamento riservato a chi oggi è in pensione e a chi oggi entra per la prima volta nel mercato del lavoro. La classe dirigente potrà riguadagnarsi la fiducia dei cittadini solo se si mostrerà capace di autoriforma: non può chiedere agli altri di fare ciò che non vuole o non è in grado di imporre a se stessa. Come documentano le barre verticali della figura 5, oggi ci sono circa 2.600 vitalizi in pagamento per cariche elettive alla Camera o al Senato. Si dica quel che si vuole, ma i vitalizi sono pensioni concesse con regole molto più vantaggiose di quelle riservate agli altri lavoratori. Già da tempo, a partire da metà degli anni Settanta, la gestione delle pensioni dei parlamentari ha presentato evidenti e crescenti squilibri che sono letteralmente esplosi a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, proprio mentre le pensioni degli italiani venivano fortemente ridimensionate. Con le regole attuali, la spesa per vitalizi (linea nera) è destinata, anche nel prossimo decennio, a continuare ad eccedere di circa 100 milioni l’anno i contributi versati da deputati e senatori (linea grigia). Figura 5. Spesa per vitalizi, per cariche elettive, contributi e numero dei percettori Applicando le regole del sistema contributivo oggi in vigore per tutti gli altri lavoratori italiani all’intera carriera contributiva dei parlamentari, la spesa per vitalizi si ridurrebbe del 40%, con un risparmio di circa 57 milioni. Supponendo poi che il rapporto fra vitalizi in essere e vitalizi ricalcolati sia lo stesso per i consiglieri regionali, il risparmio complessivo in caso di ricalcolo per l’insieme delle cariche elettive salirebbe a 125 milioni di euro (e a circa un miliardo e 235 milioni nei primi dieci anni). Non sono cifre simboliche. Non si vuole farlo? Ci si vuole trincerare dietro alla possibile censura della Corte costituzionale? Si cominci quantomeno a fare un’operazione di trasparenza, procedendo a un ricalcolo dei vitalizi col sistema contributivo oggi applicato a tutti gli italiani. Nel corso di audizioni parlamentari e di incontri con l’associazione degli ex parlamentari ho invitato gli attuali e futuri percettori di vitalizi a darci tutte le informazioni per procedere a questo ricalcolo a livello individuale. Ma sin qui nessuno, dico nessuno, ha raccolto questo invito. Ci vuole inevitabilmente del tempo affinché le riforme dei sistemi di protezione sociale vengano portate a compimento. Mentre questo lavoro procede, è fondamentale che le esigenze di chi si sente al margine, di chi è più vulnerabile, trovino voce. C’è una ragione profonda per cui i populisti odiano i corpi intermedi: sono il miglior antidoto contro il populismo. Non solo perché resistono all’occupazione totale dei poteri, come il potere giudiziario o i sindacati che in Venezuela si sono opposti alla dittatura di Chávez, ma anche perché offrono alternative al populismo a chi sin qui non ha avuto voce in capitolo. Chi appartiene a una qualche associazione della società civile, chi ha una tessera del sindacato in tasca, difficilmente cade nella propaganda populista. La figura 6 mostra stime di quanto vari la probabilità di votare per un qualche partito populista in base alle caratteristiche individuali e all’appartenenza a una qualche associazione della società civile. I dati sono tratti dallo European Social Survey, un’indagine condotta in Europa da ormai venti anni sulla base di un questionario armonizzato tra paesi, e sono di tipo retrospettivo (si chiede agli intervistati come hanno votato alle elezioni precedenti). I partiti populisti sono quelli della classificazione curata dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti (cfr. Appendice). Figura 6. Variazioni percentuali nel voto per partiti populisti in base alle caratteristiche individuali e all’appartenenza ad associazioni della società civile Nota: La variabile dipendente è dicotomica: è uguale a 1 quando l’intervistato ha votato per un partito populista, e a zero altrimenti. La figura 6 ci dice che appartenere ad associazioni della società civile riduce la probabilità di votare per un partito populista di circa il 4% a parità di altre condizioni. Anche il fatto di possedere un titolo di studio universitario o superiore sembra incidere in maniera significativa: sono infatti soprattutto i cittadini meno istruti a votare per i partiti populisti. Vi sono tanti modi di spiegare il ruolo dell’istruzione nel condizionare il voto populista. L’istruzione è, ad esempio, positivamente correlata al reddito e inversamente alle reazioni emozionali (delusione, rabbia, frustrazione, desiderio di aggressione) che, come vedremo in seguito, spiegano il voto ad outsiders sconosciuti. Il documentato ruolo dell’associazionismo nello scoraggiare il voto populista ha spiegazioni meno ovvie. I contesti collettivi, i movimenti politici e i social network, possono diventare un’arena in cui coltivare rancori, dare fiato all’odio contro l’establishment e la “casta”. Il risultato illustrato nella figura 6 sembra allora discendere proprio dal ruolo esercitato dai corpi intermedi della società civile nello scardinare la contrapposizione fra popolo ed élite e nel rafforzare il rapporto fiduciario che deve instaurarsi in ogni democrazia rappresentativa fra elettori e classe dirigente. È una questione di fiducia, prima ancora che di rappresentanza. Quando sei debole e insicuro cerchi qualcuno di cui poterti fidare. Se non lo trovi, non ti rimane che scommettere con la forza della disperazione sulle promesse di qualche bravo oratore, pur sapendo che molto probabilmente non verranno mantenute. La frustrazione ti spinge solo a punire chi ti ha deluso, al di là della razionalità di questo comportamento. È il desiderio di aggressione – un meccanismo psicologico studiato anche nell’ambito dell’economia comportamentale – secondo cui la frustrazione conseguente alla delusione delle aspettative porta al desiderio sfrenato di punire chi ha provocato la delusione. Questo stesso meccanismo spiega il desiderio di votare per un partito populista, indipendentemente dalle specifiche piattaforme proposte. In altre parole, chi vota populista lo fa più che altro per soddisfare il desiderio di punire una classe politica che si è dimostrata in passato inadeguata in rapporto alle aspettative. Ovviamente, i partiti tradizionali non sono adeguati a svolgere questo ruolo punitivo nei confronti della classe politica: non per un problema di credibilità, ma perché sono essi stessi la classe politica da punire. Il partito populista, al quale è delegato il compito di punire la vecchia classe politica, deve invece necessariamente essere un nuovo partito al di fuori della vecchia classe dirigente. Occorrono, però, non solo partiti nuovi, ma anche nuovi leader alla loro guida. Il sindacato, come tutti i corpi intermedi, potrebbe contribuire a ridurre fortemente il richiamo dei partiti populisti. Ha perciò oggi grandi responsabilità di fronte alla sua avanzata. In Italia forse ancora di più che in altri paesi. Che credibilità può avere un sindacato che si oppone all’introduzione di un salario minimo in Italia, nonostante fosse previsto dai decreti attuativi del Jobs Act? Perché non pensa innanzitutto a proteggere i più poveri, selezionando i beneficiari di assistenza in base alla situazione economica e patrimoniale della famiglia nel suo complesso? Perché ha chiesto e ottenuto, con l’incremento generalizzato della cosiddetta quattordicesima, di dare più soldi anche ai pensionati che vivono in famiglie con redditi e patrimoni elevati, invece di pensare prima di tutto ad aiutare i più poveri, quale che fosse la loro età? In Italia solo tre euro su cento erogati per prestazioni sociali vanno al 10% più povero della popolazione, mentre spendiamo quasi cinque miliardi di euro in misure assistenziali destinate al 40% della popolazione con redditi più alti. Alla luce di queste cattive proprietà distributive del nostro sistema di protezione sociale non ci può essere giustificazione di sorta per la mancanza in Italia di una rete di protezione sociale contro la povertà, di un reddito minimo garantito, basato su criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Sin qui abbiamo visto risposte nazionali al populismo. A livello europeo vanno, invece, gestiti i problemi comuni, a partire da quelli dell’immigrazione e dei rifugiati. Affinché l’Unione Europea sopravviva come area in cui vige la libera circolazione dei lavoratori occorre avere una politica dell’immigrazione a livello comunitario e una gestione comune del problema dei rifugiati, con una profonda revisione della convenzione di Dublino. Bisognerebbe, innanzitutto, decidere sulle domande d’asilo prima che le persone in cerca d’asilo entrino nel territorio dell’Unione Europea. Questo servirebbe a frenare l’ecatombe di disperati che perdono la vita nel tentativo di raggiungere un paese in cui poter fare domanda d’asilo. A supporto di questa gestione comune delle domande ci dovrebbe essere un accordo comunitario su ciò che rende una domanda d’asilo accoglibile e investimenti comunitari volti alla creazione di strutture di prima accoglienza al di fuori dei confini dell’Unione. Occorrerebbe, inoltre, un accordo sulla condivisione fra i singoli Stati della prima accoglienza dei rifugiati, una volta che questi siano entrati nell’Unione. Forme di compensazione fra paesi, o addirittura un sistema di quote che possano essere oggetto di negoziati bilaterali e di scambi fra i diversi paesi, servirebbero a rendere sostenibile nel tempo questa condivisione dei costi iniziali dell’accoglienza. Inutile sottolineare che siamo molto lontani dal poter realizzare questo disegno, anche perché i partiti populisti, come si è detto, sono già al potere in cinque paesi dell’Unione (Finlandia, Grecia, Lituania, Slovacchia e Ungheria) oltre che in due paesi membri dell’Area economica europea (EEA), ovvero la Norvegia e la Svizzera. 4. Una proposta modesta, ma fattibile C’è comunque qualcosa che si può fare sin d’ora e in gran parte per via amministrativa, senza bisogno di nuove leggi, per venire incontro alle preoccupazioni di molti europei riguardo al futuro dello stato sociale. Non si può negare che l’Unione Europea sin qui non si è mai data strumenti adeguati per monitorare la mobilità dei lavoratori all’interno delle sue frontiere, non ha ancora costruito un’infrastruttura informatica e amministrativa adeguata per mettere pienamente in pratica i principi sanciti dal Trattato di Roma, nonostante i sessant’anni di storia che ci separano da quell’accordo. In particolare, sin qui non c’è stato coordinamento tra le amministrazioni dello stato sociale nei singoli paesi per ridurre l’evasione contributiva e per prevenire potenziali abusi da parte dei lavoratori che si spostano da una nazione all’altra. È oggi possibile, ad esempio, ricevere i sussidi di disoccupazione in un paese e lavorare in un altro paese dell’Unione. Il fatto è che attualmente gli Stati membri dell’Unione Europea, per individuare i contribuenti, utilizzano Codici nazionali di Identificazione Fiscale (CIF), strumenti utili all’interno dei singoli paesi ma eterogenei e quindi poco funzionali per una visione europea complessiva, a causa delle differenze nei sistemi di codificazione. Accade così che quando un contribuente – sia esso cittadino di uno dei paesi dell’Unione oppure extracomunitario – lascia un paese UE per emigrare in un altro paese UE se ne perde traccia. Certo, esistono accordi bilaterali per la valorizzazione dei contributi previdenziali fra i diversi paesi, ma devono essere attivati dai diretti interessati. È fondamentale, dunque, che le amministrazioni dello stato sociale nei diversi paesi dell’Unione si dotino di un unico codice identificativo contributivo, che segua nei loro spostamenti i lavoratori che cambiano paese e faciliti l’aggiornamento dei relativi dati fiscali e contributivi, grazie ad un sistema che accomuni ogni codice di identificazione fiscale in un’unica chiave di lettura, per avere una verifica costante delle informazioni utili. Un codice unico, oltre a contenere notevolmente il rischio di frodi contributive e fiscali, permetterebbe di rendere più efficiente e veloce lo scambio di informazioni fra paesi, riducendo la burocrazia oggi necessaria per operazioni quali, ad esempio, la totalizzazione dei contributi ai fini pensionistici. Per questi motivi è importante avviare un confronto fra le amministrazioni nazionali che gestiscono i programmi di protezione sociale in Europa, con l’obiettivo di istituire un codice di protezione sociale che valga per tutti i paesi dell’Unione Europea. Ci sono soluzioni tecniche, già studiate all’INPS, in grado di minimizzare i problemi di adeguamento delle strutture informatiche nei diversi paesi e di rispettare le più stringenti normative sulla privacy, consentendo a ciascun paese di continuare ad utilizzare i propri codici identificativi, integrandoli in modo da creare un formato standardizzato, sul modello dei codici IBAN. Questo European Social Security Identification Number (ESSIN) dovrebbe permettere la piena portabilità dei diritti sociali tra paesi e un migliore monitoraggio dei flussi migratori all’interno dell’Unione, impedendo il welfare shopping. Il codice di protezione sociale europeo può diventare anche un fattore identitario, un modo di acquisire nei fatti la cittadinanza europea da parte di chi regolarmente contribuisce a finanziare lo stato sociale dei singoli paesi, così come è stato il Social Security Number nella storia degli Stati Uniti. Peraltro, un simile strumento, permettendo la tracciabilità dei lavoratori nel mercato unico, getterebbe le basi per l’adozione di misure condivise a livello comunitario, come un sussidio di disoccupazione europeo. Certo, il codice unico è solo una goccia nell’oceano dei problemi che abbiamo affrontato. Ma può essere un simbolo, e i simboli contano. Inoltre è realizzabile, ed è ispirato proprio da quei corpi intermedi, le pubbliche amministrazioni, chiamiamole pure burocrazie, che possono battere il populismo. Bisogna tornare a pedalare se non si vuole cadere, sapendo che bisogna utilizzare un rapporto molto agile per la salita. È infatti illusorio pensare di poter contare sulle reazioni a catena su cui si è retta per decenni la filosofia dell’integrazione europea, la visione di Jean Monnet e degli altri padri fondatori. Il processo di integrazione politica non andrà avanti da solo, come semplice conseguenza dell’integrazione economica, ed è la stessa integrazione economica che oggi rischia di andare indietro. Eppure di questa integrazione, di un maggiore coordinamento sovranazionale, non possiamo fare a meno. Perché senza l’Europa, senza una forte voce collettiva, saremo sempre troppo piccoli per contare quando si tratterà di affrontare e, speriamo, risolvere i grandi problemi di governance della globalizzazione e del progresso tecnologico. Riferimenti bibliografici Questo scritto è largamente basato sul testo della lectio magistralis tenuta per l’apertura di Biennale Democrazia al Teatro Regio di Torino il 29 marzo 2017 (dal titolo Populismo e stato sociale nelle democrazie industrializzate). Vorrei qui ringraziare la città di Torino – rappresentata nell’occasione dal sindaco Chiara Appendino – e il presidente di Biennale Democrazia, Gustavo Zagrebelsky, per l’invito e per avermi concesso di riprodurre quanto da me espresso in quella occasione. Alcuni spunti e soprattutto la proposta dello European Social Security Identification Number (ESSIN) erano già contenuti, in forma embrionale, in un mio contributo a un volume collettaneo per la Luiss University Press (Europa: sfida per l’Italia) a cura di Marta Dassù, Stefano Micossi e Riccardo Perissich. Ringrazio la Luiss University Press per l’autorizzazione a riprodurre parte di quel materiale. Nella stesura ho tratto grande beneficio dalle discussioni con Francesco Passarelli e Antonio Spilimbergo. I dati sull’esodo dei giovani italiani riprodotti nella figura 1 sono stati raccolti da Massimo Anelli e Giovanni Peri (Does Emigration Delay Political Change? Evidence from Italy during the Great Recession, NBER Working Paper n. 22350, 2016). L’evidenza empirica sulla diminuzione della distanza fra le posizioni dei partiti populisti e quelle degli altri partiti è offerta da Luigi Guiso, Helios Herrera, Massimo Morelli e Tommaso Sonno (Demand and Supply of Populism, CEPR Discussion Papers n. 11871, 2017). La definizione di populismo di Cas Mudde è tratta dal suo libro Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge University Press, 2007. Il riferimento alla disoccupazione in Europa mai così diversa tra paesi è tratto da un mio lavoro scritto con Juan Francisco Jimeno (Learning from the Great Divergence in Unemployment in Europe during the Crisis, “Labour Economics”, 2016). Lo studio VisitINPS sugli effetti della regolarizzazione del 2002 sull’emersione di base contributiva è stato condotto nel 2017 da Edoardo Di Porto, Enrica Maria Martino e Paolo Naticchioni ed è in corso di pubblicazione nella serie dei WorkINPS Papers. Lo studio sul click day e sul coinvolgimento di immigrati in attività illegali è di Paolo Pinotti (Clicking on Heaven’s Door: The Effect of Immigrant Legalization on Crime, “American Economic Review”, 2017). Una trattazione rigorosa, in chiave di economia della politica, del ruolo dei sistemi di checks and balances nell’impedire la dittatura della maggioranza viene fornita da Philippe Aghion, Alberto Alesina e Francesco Trebbi (Endogenous Political Institutions, “Quarterly Journal of Economics”, 2004). La citazione di Rudiger Dornbusch e Sebastian Edwards è tratta dall’introduzione di The Macroeconomics of Populism in Latin America edito da Chicago University Press nel 1991. I dati sulla distribuzione mondiale del reddito e la figura 2 sono tratti da un lavoro di Christoph Lakner e Branko Milanovic (Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession, World Bank Working Paper n. 6719, 2013). Il riferimento al “grande paradosso” messo in luce da Arlie Russell Hochschild trae spunto dal suo libro più recente (Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right, The New Press, 2016). La figura 3 è tratta da un post di Torsten Bell dal titolo The Referendum, Living Standards and Inequality sul sito della Resolution Foundation (http://www.resolutionfoundation.org/media/blog/the-referendum-living-standards-andinequality/). I rilievi sulla posizione fiscale netta degli immigrati rispetto allo stato sociale sono tratti da un mio lavoro sui dati EU-Silc (Immigration to the Land of Redistribution, “Economica”, 2009) e da una rassegna di Robert Rowthorn (The Fiscal Impacts of Immigration on Advanced Economies, “Oxford Review of Economic Policy”, 2008). Gli studi di contabilità generazionale sull’impatto fiscale dell’immigrazione cui mi riferisco sono sulla Spagna (M. Dolores Collado, Iñigo Iturbe-Ormaetxe e Guadalupe Valera, Quantifying the Impact of Immigration on the Spanish Welfare State, “International Tax and Public Finance”, 2004), sulla Svezia (Kjetil Storesletten, Fiscal Implications of Immigration: A Net Present Value Approach, “Scandinavian Journal of Economics”, 2003) e sull’Olanda (Hans Roodenburg, Rob Euwals e Harry ter Rele, Immigration and the Dutch Economy, CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis, 2003). La figura 4 e l’evidenza sulla diversa rispondenza del voto ai partiti populisti ai flussi migratori nei grandi e piccoli centri urbani sono riprese da un lavoro di Christian Dustmann, Francesco Fasani, Tommaso Frattini, Luigi Minale e Uta Schönberg (On the Economics and Politics of Refugee Migration, CReAM Discussion Papers n. 16, 2016). Appendice. I partiti populisti europei L’elenco che segue è stato elaborato dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti a partire dal lavoro di Ronald Inglehart e Pippa Norris, Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash (HKS Faculty Research Working Paper Series RWP16-026, 2016) e da una analisi delle posizioni politiche (sentimento anti-establishment, euroscetticismo e/o avversione all’immigrazione) dei diversi partiti europei. Si è fatto riferimento anche ai raggruppamenti presso il Parlamento europeo per rintracciare altri partiti con posizioni simili. Austria Austria Belgio Belgio Bulgaria Bulgaria Danimarca Estonia Finlandia Finlandia Francia Germania Germania Germania Grecia Grecia Grecia Grecia Italia Italia Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Montenegro Norvegia Paesi Bassi Paesi Bassi Polonia Regno Unito Repubblica ceca Repubblica ceca Repubblica ceca Romania Slovacchia Alleanza per il futuro dell’Austria Partito della libertà austriaco Partito popolare Vlaams Belang Ataka IMRO – Movimento nazionale bulgaro Partito del popolo danese Partito popolare conservatore estone Fronte bianco-blu Partito dei finlandesi Fronte nazionale Alternativa per la Germania I repubblicani Partito nazionaldemocratico di Germania Greci indipendenti Lega popolare – Alba dorata Raggruppamento popolare ortodosso Syriza – Coalizione della sinistra radicale Fratelli d’Italia Lega Nord Movimento 5 Stelle Alleanza nazionale Ordine e giustizia Partito riformista di alternativa democratica Partito dei radicali serbi Partito del progresso Partito per la libertà Partito socialista Diritto e giustizia Partito per l’indipendenza del Regno Unito Alba – Coalizione nazionale Partito dei lavoratori della giustizia sociale Partito dei liberi cittadini Partito grande Romania Partito nazionale slovacco Spagna Svezia Svizzera Svizzera Ucraina Ungheria Ungheria Podemos Democratici svedesi Movimento dei cittadini di Romandia Partito del popolo svizzero Svoboda Fidesz – Unione civica ungherese Jobbik – Movimento per un’Ungheria migliore