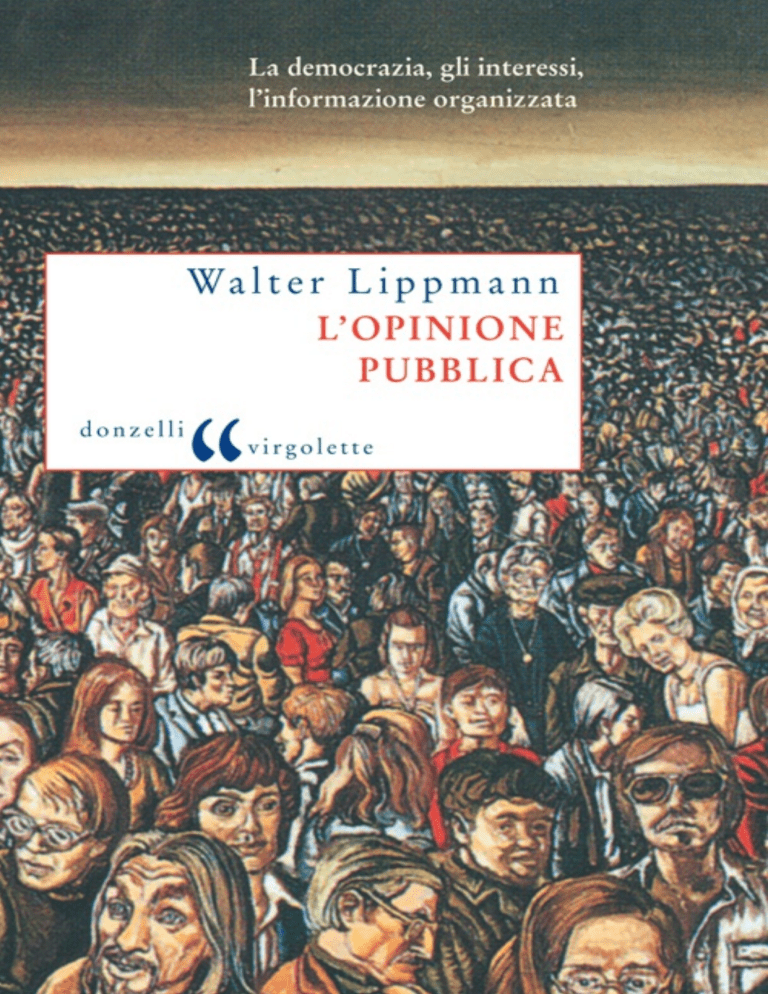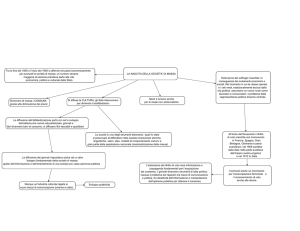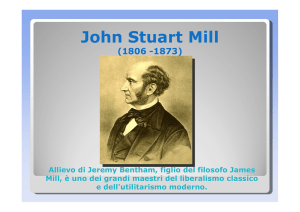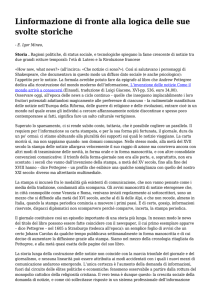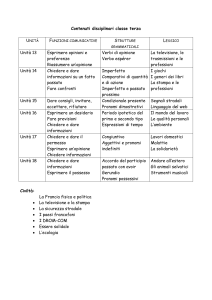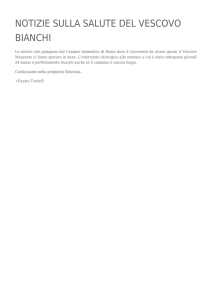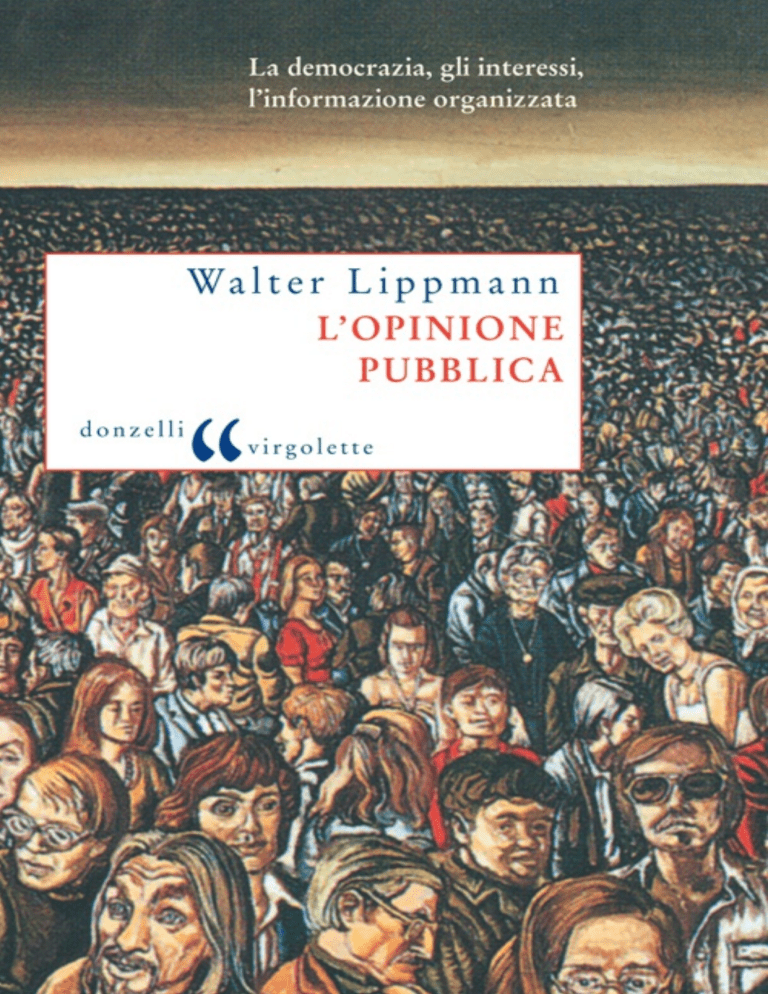
LDB
2
Giornalista e saggista, nel 1917 Walter Lippmann ricoprì la carica di
sottosegretario aggiunto Usa alla Guerra: un breve interludio, che pure
rappresentò uno strategico punto di osservazione delle convulsioni
comunicative di una società democratica, apparentemente inconsapevole
della propria complessità. Pubblicato nel 1922, L’opinione pubblica
conserva la sua carica euristica, la sua lucida provocatorietà e ricchezza
descrittiva. L’assunto è limpido: come avviene quel complesso e solo
apparentemente «normale» processo attraverso cui le nostre opinioni
diventano Opinione pubblica, Volontà nazionale, Mente collettiva, Fine
sociale? Come «l’opinione pubblica» costruisce i proprimiti, i propri eroi, i
propri nemici, strappandoli alla storia e catapultandoli in una leggenda
paradossalmente effimera? Lippmann indaga e descrive i meccanismi
attraverso cui le immagini «interne» elaborate nelle nostre teste ci
condizionano nei rapporti con il mondo esterno, gli ostacoli che limitano le
nostre capacità d’accesso ai fatti, le distorsioni provocate dalla necessità di
comprimerle, «raccontando» un mondo complicato con un «piccolo
vocabolario»; infine, la paura stessa dei fatti che potrebbero minacciare la
vita consueta. A partire da questi limiti, l’analisi ricostruisce come i
messaggi provenienti dall’esterno siano influenzati dagli scenari mentali di
ciascuno, da preconcetti e pregiudizi. Il testo di Lippmann ci offre anche
una lucida critica del sistema politico democratico che ambisce a
governare società sempre più complesse.
3
Walter Lippmann (New York 1889-1974) fu inizialmente socialista, in
seguito, nei primi anni dell’amministrazione rooseveltiana, si orientò verso
posizioni liberali. Fu uno dei più noti pubblicisti repubblicani: direttore
(1914-18) di «New Republic» e «World», collaboratore della «New York
Herald Tribune» e di molti altri giornali, autore di The Good Society
(1937), U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic (1943), The Cold War
(1948), Isolation and Alliance (1952), The Public Philosophy (1955;
tradotto in italiano dalle Edizioni di Comunità).
4
Virgolette / 2
5
Walter Lippmann
L’OPINIONE PUBBLICA
Prefazione di Nicola Tranfaglia
Traduzione di Cesare Mannucci
DONZELLI EDITORE
6
Titolo originale: Public Opinion
© 1999, 2000, 2004 Donzelli editore, Roma
Via Mentana 2b
INTERNET www.donzelli.it
E-MAIL [email protected]
ISBN 978-88-6843-308-6
7
Indice
Prefazione
di Nicola Tranfaglia
I.
Introduzione
I.
II.
Il mondo esterno e le immagini che ce ne facciamo
Accessi al mondo esterno
II. La censura e la segretezza
III. Il contatto e la possibilità
IV. Il tempo e l’attenzione
V. La velocità, le parole e la chiarezza
III.
Gli stereotipi
VI. Gli stereotipi
VII. Gli stereotipi come difesa
VIII. I punti ciechi e il loro valore
IX. I codici e i loro nemici
X. La scoperta degli stereotipi
IV.
Gli interessi
XI.
XII.
V.
Suscitare l’interesse
L’interesse personale riconsiderato
La formazione di una volontà comune
XIII. Il trasferimento
XIV. Sì o no
XV.
VI.
dell’interesse
I capi e i seguaci
L’immagine della democrazia
XVI. L’uomo egocentrico
XVII. La comunità autosufficiente
XVIII. Il ruolo della forza, del favoritismo
e del privilegio
XIX. La vecchia immagine in una forma nuova: il socialismo corporativo
XX. Una nuova immagine
8
VII.
I giornali
XXI. Il pubblico come consumatore
XXII. Il fedele lettore
XXIII. La natura delle notizie
XXIV. Le notizie, la verità e una conclusione
VIII.
L’informazione organizzata
XXV. Il cuneo iniziale
XXVI. Il lavoro d’informazione
XXVII.
XXVIII.
L’appello al pubblico
L’appello alla ragione
9
Prefazione
di Nicola Tranfaglia
1. Un brusco risveglio.
Questo libro, divenuto assai presto un classico degli studi internazionali
sulla comunicazione, fu scritto dal giovane – ma già noto – Walter
Lippmann all’indomani della prima guerra mondiale, nel 1921, e venne
pubblicato l’anno dopo dalla casa editrice Macmillan a New York,
suscitando l’interesse e il dibattito che meritava in tutto il mondo
anglosassone.
In Italia arrivò con enorme ritardo, più di quarant’anni dopo, nel 1963,
grazie all’interesse per il mondo americano di Renzo Zorzi, animatore
culturale e organizzativo delle giovani Edizioni di Comunità create da
Adriano Olivetti e all’interesse che ai problemi della comunicazione
rivolgeva fin da allora uno studioso come Cesare Mannucci, autore di
saggi importanti e pionieristici sulla televisione e sulla società di massa,
che lo tradusse. Ma per il nostro paese era ancora una volta troppo presto,
giacché la cultura italiana continuava a essere quasi completamente sorda,
nel suo complesso, malgrado l’espandersi ormai evidente della televisione,
ai problemi posti dall’opera di Lippmann1.
Il libro cadde così in un concorde e imbarazzato silenzio come se i temi
posti dallo scrittore americano fossero estranei e lontani dalla penisola, di
scarso o nullo interesse per una democrazia «speciale» come quella
italiana. Nei due decenni successivi, del resto, gli studi sulla
comunicazione, cresciuti a poco a poco, quasi di nascosto, in alcune
università fino a dar luogo assai di recente alla nascita di veri e propri corsi
di laurea in Scienze della comunicazione, incontrarono un riscontro
episodico o addirittura un vero e proprio disinteresse anche presso i
politici, i giornalisti e gli operatori dell’informazione, come se il nostro
fosse un paese, per così dire, refrattario a considerare i problemi legati agli
aspetti etici e politici della comunicazione come uno dei temi centrali per
una democrazia moderna.
Il risveglio, assai brusco, è avvenuto nella primavera del 1994 quando
Silvio Berlusconi, l’imprenditore che aveva costruito, anche – ma non solo
10
– grazie ai favori del potere politico, un impero televisivo privato, riuscì in
pochi mesi (pur dopo una lunga, sotterranea preparazione negli anni
ottanta) a creare un movimento politico-aziendale in grado di raggiungere
la maggioranza relativa alle elezioni politiche, e, insieme, con la Lega di
Bossi e gli eredi del Movimento sociale, quella assoluta, necessaria per
governare il paese con il nuovo sistema maggioritario voluto, attraverso un
referendum popolare, dalla stragrande maggioranza degli italiani.
Da quel momento, malgrado la fulminea caduta di Berlusconi dopo
sette mesi di governo, il problema dell’influenza della televisione, e in
generale dei mezzi di comunicazione, sulla lotta politica è divenuto un
tema centrale del dibattito e per mesi (ma si potrebbe dire ormai per anni)
si è scritto di blind trust, di legislazione antitrust, di cosiddetta par
condicio, in altri termini di strumenti politici e legislativi ipotizzati per fare
in modo che l’«opinione pubblica» – proprio quella di cui parla Lippmann
– non sia egemonizzata, in maniera più o meno stabile e pregiudiziale da
chi dispone della proprietà o della gestione (o di entrambe) dei mezzi di
comunicazione, a cominciare da quello per ora più potente e diffuso in
Italia, la televisione via etere.
Ma sovente si è discusso di tali questioni, e si continua a farlo, con
scarsa o insufficiente consapevolezza dei problemi di fondo, vorremmo
dire sul piano teoretico e concettuale, che caratterizzano la comunicazione
in una società industrializzata, illudendosi a volte di riuscire, con strumenti
giuridici arretrati, a ingabbiare un fenomeno dirompente, o di risolvere, a
livello politico o di accordo tra i partiti, difficoltà che attengono proprio
alla natura e al ruolo degli strumenti di comunicazione.
Esemplare, da questo punto di vista, è stato il recente dibattito sulla
limitazione delle reti televisive in un mondo nel quale satelliti e cavi – solo
che lo si voglia e se ne attrezzino le strutture – sono in grado di modificare
radicalmente i termini della questione.
C’è peraltro da sottolineare che, al di là della peculiarità non
entusiasmante della vicenda italiana, siamo di sicuro di fronte a nuovi
mutamenti. «Quello di oggi – ha osservato di recente Peppino Ortoleva – è
un periodo di riassetto forse senza precedenti storici, da un lato perché
tocca simultaneamente tutte le forme di comunicazione, dall’altro perché
coincide con l’ascesa dell’“industria dell’informazione” nel suo complesso
a settore cruciale, e in qualche misura trainante, dell’intera economia»2.
La pubblicazione di un classico come L’opinione pubblica di Lippmann
in un’edizione riveduta e aggiornata si inserisce in questa mutata (almeno
all’apparenza) congiuntura culturale e può contribuire a chiarire quelli che
restano i concetti di fondo del problema, sfatando miti duri a morire e
11
introducendo elementi significativi, e talora decisivi, in un dibattito che
oscilla ancora tra il livello della politica contingente e quello di un
tecnicismo che non di rado resta fine a se stesso.
La personalità dell’autore (politicamente impegnato prima come
socialista, poi da liberale di sinistra, infine da repubblicano), il quale
scrisse un originale saggio di teoria politica su La filosofia pubblica (edito
in Italia sempre da Comunità) e dedicò altri lavori ai temi della
comunicazione, e fu a lungo uno dei più ascoltati consiglieri di politica
estera del governo di Washington ma anche, per un cinquantennio, uno
degli editorialisti più seguiti del «Herald Tribune» e di altri importanti
giornali, non è priva di rilievo per la valutazione del libro.
Nelle sue pagine (anche in questo lavoro scritto a poco più di
trent’anni) accade di trovare insieme la riflessione dello studioso
indipendente e i frutti di un’esperienza giornalistica vissuta in prima
persona, intensa ed appassionata, in un paese, gli Stati Uniti, dove una
salda tradizione democratica ha motivato non di rado chi si dedica al
giornalismo a intendere quella professione come costante servizio a favore
dell’interesse generale piuttosto che esclusivamente di quello del
proprietario dell’impresa in cui lavora.
Si è trattato anche lì, a quanto pare, di eccezioni sia pure numerose
piuttosto che di una regola generale, ma basta leggere questo o altri libri di
Lippmann per toccare con mano le differenze profonde tra il caso
americano e quello italiano: da noi una lunga abitudine a sostenere, per
non dire servire, già nell’età liberale, i governi del momento si è
consolidata grazie alla dittatura fascista nel periodo delicato della crescita
e d’una contraddittoria modernizzazione ed è proseguita, pur con indubbie
differenze, nel periodo repubblicano grazie all’identificazione del maggior
partito di governo con le istituzioni statali che ha caratterizzato i primi
trent’anni del dopoguerra.
Né si può dire, purtroppo, che nei vent’anni successivi, fino al crollo
della «prima Repubblica», stampa e radiotelevisione abbiano dato in
generale prova di effettivo distacco critico dai partiti maggiori come dal
potere economico e finanziario3.
2. L’ambiente invisibile.
All’indomani di un evento epocale come la prima guerra mondiale, il
giovane Lippmann aveva pubblicato un saggio intitolato Liberty and the
News: di fronte a quel che era accaduto prima, durante e dopo il conflitto,
si era reso conto appieno del peso crescente che andavano assumendo i
12
mezzi di comunicazione nella vita politica dell’Occidente. Riflessioni su
problemi analoghi costituiscono i punti di partenza da cui muove nel
successivo L’opinione pubblica.
Lippmann parte da una constatazione, per così dire ovvia, ma gravida
di conseguenze per l’impostazione del problema: «In qualsiasi società –
scrive nelle pagine iniziali del saggio – che non sia talmente assorbita nei
suoi interessi né tanto piccola che tutti siano in grado di sapere tutto ciò
che vi accada, le idee si riferiscono a fatti che sono fuori del campo visuale
dell’individuo e che per di più sono difficili da comprendere». Se questo è
vero, ed è difficile negarlo in una società come quella che esce dalla
«grande guerra» e vede crescere il ritmo degli scambi, la rapidità dei
trasporti, la presenza dei mezzi di comunicazione di massa, ne deriva
necessariamente che «ciò che l’individuo fa si fonda non su una
conoscenza diretta e certa ma su immagini che egli si forma o che gli
vengono date».
Esiste in altri termini un «ambiente invisibile» per la maggior parte
degli individui, come dei gruppi sociali, di cui ciascuno ha le immagini che
gli vengono trasmesse appunto dai mezzi di comunicazione. «Cos’è la
propaganda – si chiede Lippmann – se non lo sforzo di modificare le
immagini a cui reagiscono gli individui, di sostituire un modello sociale a
un altro?»1.
Non per caso lo studioso americano parla di immagini piuttosto che di
parole. Lippmann ha letto con attenzione ed acume le opere essenziali
della psicologia del profondo: Freud, Jung, Adler e gli autori più
importanti della psicoanalisi sono presenti in quest’opera con citazioni
essenziali che mostrano come l’autore abbia intuito la novità e
l’importanza degli studi psicologici ai fini della scienza politica e della
sociologia e ne proponga un’applicazione assai pertinente nel campo della
comunicazione. Qui si rivelano di estrema importanza, da una parte, le
reazioni razionali e non razionali dell’individuo come dei gruppi sociali di
fronte alle notizie, dall’altra lo sfruttamento di quelle reazioni da parte di
chi fa i giornali e, a maggior ragione (ma Lippmann nel 1921 non poteva
saperlo), di chi sostituirà alle parole della stampa scritta le immagini e i
suoni propri del mezzo televisivo, in grado di influire, in maniera più forte
e diretta di quanto facciano le notizie scritte, sulla produzione di immagini
propria di ogni individuo.
Tornando all’«ambiente invisibile» di cui parla l’autore e alle immagini
che individui e gruppi sociali si fanno delle notizie che ricevono di
quell’ambiente che non conoscono direttamente, Lippmann parte di qui per
dare una definizione stringata ma ancora oggi, a mio parere, valida
13
dell’opinione pubblica: «Le immagini in base a cui agiscono gruppi di
persone o individui che agiscono in nome di gruppi, costituiscono
l’Opinione Pubblica con le iniziali maiuscole».
E si arriva così al vero oggetto del libro che si propone di condurre il
lettore anzitutto ad analizzare gli ostacoli di vario genere che limitano
l’accesso di tutti all’ambiente invisibile, quindi a cercare di costruire
quella che si potrebbe definire una «teoria democratica dell’opinione
pubblica».
Il nocciolo della mia tesi – afferma lo scrittore americano – è che la democrazia,
nella sua forma originaria, non abbia seriamente affrontato il problema derivante
dalla non automatica corrispondenza delle immagini, che gli individui hanno nella
loro mente, alla realtà del mondo esterno. […] Il governo rappresentativo, tanto
nella sfera che solitamente viene detta politica che in quella dell’economia, non può
funzionare bene, quale che sia la base del sistema elettorale, se non c’è
un’organizzazione indipendente che renda i fatti non visti comprensibili a quelli che
devono prendere le decisioni2.
Emergono da queste affermazioni quelli che mi paiono anche oggi i
pilastri di una «teoria democratica della comunicazione». In primo luogo,
Lippmann osserva che il pensiero democratico moderno, quello degli
ultimi due secoli seguito alle grandi rivoluzioni settecentesche, per
intenderci, non ha elaborato questa teoria, non si è posto il problema nei
termini che gli paiono pertinenti alla luce delle scoperte della psicologia
del profondo. Quindi sottolinea un aspetto che è di singolare attualità in
questa fine secolo: la necessità di un’organizzazione indipendente che si
assuma l’onere di un’informazione corretta di quel che avviene,
particolarmente utile per chi deve prendere le decisioni in un paese, è
indiscutibile e non è legata alla peculiarità del sistema elettorale adottato.
Lippmann si riferiva, con tutta evidenza, al sistema maggioritario
vigente negli Stati Uniti e sosteneva, a ragione, che la parte politica che
consegue la maggioranza non ha per questo diritti particolari
sull’informazione, la quale, viceversa, deve poter essere gestita, almeno in
parte (per ciò che concerne la documentazione da fornire a tutti
sull’operato delle forze dominanti) da un’organizzazione autonoma
dall’una e dall’altra parte politica.
Impostato così, con estrema chiarezza, il problema di fondo, la parte
centrale dell’opera affronta in maniera analitica, alla luce dell’esperienza
illuminante della guerra mondiale ma anche della modernizzazione in
corso dei mezzi di comunicazione di massa, prima di tutti i quotidiani,
proprio i problemi che nascono dalla difficoltà di comunicare a tutti
l’«ambiente invisibile», dagli ostacoli di ogni genere che vi si
14
frappongono, dai complessi meccanismi
comunicazione nella società industriale.
che
condizionano
la
3. Per una teoria democratica della comunicazione.
Lippmann dedica particolare spazio e complessità di ragionamento a tre
aspetti che restano, a mio avviso, di grande interesse per una teoria della
comunicazione.
Il primo riguarda gli ostacoli che il governo, o altre istituzioni dello
stato democratico, pongono alla conoscenza di alcuni fatti di rilevante
interesse pubblico. La grande guerra ha esaltato questo fattore e l’autore
analizza i comunicati del Quartier Generale Alleato mettendo in luce come
la censura che i militari esercitavano sull’andamento degli scontri avesse
motivazioni, per così dire, politiche come la preoccupazione di evitare il
diffondersi dell’allarmismo nella popolazione, la necessità di infondere
coraggio ai civili in una fase particolarmente difficile, l’obiettivo
propagandistico più o meno esplicito.
Lippmann si rende conto perfettamente del fatto che gli obiettivi
politici di un partito o di un governo reggano in maniera ferrea l’uso del
segreto e contrappone, ad esempio, la segretezza della diplomazia
mantenuta dall’Intesa nelle trattative precedenti la prima guerra mondiale
all’abolizione di quel segreto da parte dei bolscevichi nel 1917 quando
conquistarono il potere in Russia. L’osservazione con cui conclude la sua
tesi – «la storia del concetto di segretezza, di riserbo, sarebbe divertente» –
ha per l’Italia un peso assai maggiore rispetto agli altri stati democratici
dell’Occidente giacché è ormai accertato che nella recente storia
repubblicana (ma anche in quella dell’età liberale e fascista) l’istituto del
«segreto di stato» o anche quello del riserbo governativo è stato usato più
volte per ragioni che poco o nulla hanno avuto a che fare con l’interesse
generale e sono state legate, piuttosto, all’esigenza da parte di singoli
uomini di governo o partiti politici di non far conoscere azioni che
sarebbero andate incontro con ogni probabilità a severe censure di una
parte almeno della stampa e della pubblica opinione. Purtroppo, fino ad
oggi, nessuno studioso ha tentato di ricostruire questo aspetto singolare
della nostra storia recente.
Il secondo aspetto di cui parla Lippmann è costituito dalle barriere
economiche, sociali e culturali che impediscono a tanti di accedere alle
fonti di informazione: «Ci sono interi settori – osserva –, vastissimi gruppi,
ghetti, isole e classi che hanno solo un vago sentore di ciò che succede. La
loro vita scorre come su binari, sono rinchiusi nei propri affari, esclusi
15
dagli avvenimenti più grandi, incontrano poche persone appartenenti a
strati diversi dal loro, leggono poco»1.
A prima vista, l’affermazione non ha resistito all’impatto della radio e
della televisione, i media che hanno caratterizzato l’ultimo settantennio,
ma in realtà, pur limitata dall’espandersi di quei nuovi mezzi di
comunicazione, mantiene gran parte della sua validità nel senso che –
secondo studi recenti condotti anche nel nostro paese – le limitazioni di
reddito, di ambiente sociale, di preparazione culturale influiscono
negativamente anche sul modo di recepire le notizie attraverso il mezzo
radiotelevisivo. La fruizione dei telegiornali e in genere dei notiziari
all’interno di contesti come quelli propri di alcune televisioni commerciali
spesso fa sì che l’attenzione sia rivolta non verso i grandi avvenimenti ma
piuttosto verso fatti ed episodi della piccola cronaca locale.
Del resto, Lippmann insiste a ragione sui limiti alla comunicazione
provocati dalla permanenza senza interruzioni nel luogo di residenza e
ricorda che i viaggi sono negli anni venti (ma in parte anche oggi)
prerogativa di una parte relativamente limitata della popolazione. «Ciascun
ambiente – ricorda – determina più o meno da solo gli affari che rientrano
nella sua immediata competenza, soprattutto determina la
somministrazione specifica del giudizio. Ma il giudizio stesso si forma su
modelli che possono venir ereditati dal passato, trasmessi o imitati da altri
ambienti sociali».
C’è in questo passaggio un’intuizione importante, strettamente legata
agli sviluppi della nuova psicologia, ed è quella che si riferisce ai
«modelli» che influenzano a fondo chi riceve la comunicazione, nel senso
che è a determinati «modelli» che fa sempre riferimento l’utente di ogni
informazione, cogliendo del messaggio che riceve in particolare quella
parte omogenea e armonica rispetto ad essi. Di qui parte, nel saggio di
Lippmann, un’analisi approfondita del ruolo centrale che simboli e
stereotipi esercitano nella comunicazione, condizionando al tempo stesso i
comunicatori e i dirigenti dell’informazione, che ne hanno bisogno per
costruire un ritratto coerente e ordinato delle notizie, e gli utenti, che se ne
servono a loro volta per codificare i fatti e darne una prima, sommaria
interpretazione.
«Di solito – conclude Lippmann – tutto ciò culmina nell’edificazione di
un sistema del male e di un altro, che è il sistema del bene. Allora si rivela
il nostro amore dell’assoluto. Infatti non abbiamo simpatia per gli avverbi
che qualificano e limitano, poiché ingombrano le frasi e ostacolano il
sentimento irresistibile». Certo, la guerra è stato un esempio
particolarmente eloquente di questa scomoda verità: eppure lo scrittore
16
americano è persuaso, e a ragione, che il conflitto abbia soltanto esaltato,
per così dire, la tendenza della società umana a intraprendere la scorciatoia
degli stereotipi e a costruire una visione dicotomica della realtà nella quale
la collocazione di un «bene» più o meno determinato costituisce il punto di
riferimento essenziale di chi fornisce come di chi riceve le notizie da un
ambiente sempre più grande che giunge alla fine a includere l’intero
pianeta2.
Il terzo aspetto cui l’autore dedica molto spazio riguarda le novità
introdotte, nel campo della comunicazione, dalla psicologia del profondo,
che consente di analizzare in maniera assai più rigorosa le motivazioni
psicologiche che spingono individui e gruppi sociali a seguire quel che
succede al di fuori del microcosmo in cui si svolge la vita della maggior
parte dei cittadini di uno stato e del mondo intero. Anche in questa parte
del libro troviamo osservazioni e punti di vista che si adattano assai bene
non soltanto agli anni in cui Lippmann scriveva ma anche ai tempi nostri, a
quelli caratterizzati – potremmo dire – da una sorta di vera e propria
elefantiasi dei mezzi di comunicazione di massa.
Faccio alcuni esempi che possono forse restituire, almeno in parte, il
modo di procedere concreto e pragmatico di Lippmann.
Sulle notizie che si riferiscono alla politica, non ha dubbi: «La politica
– osserva – è interessante quando c’è un conflitto o, come diciamo, una
questione. E per rendere popolare la politica si debbono trovar problemi
anche quando, a onor del vero, non ce ne sono affatto: non ce ne sono, nel
senso che le differenze di giudizio o di principio, o di fatto, non richiedono
un ricorso all’aggressività».
Sul ruolo che hanno alcune persone – amate o autorevoli – nel modo in
cui ciascuno si avvicina al «mondo invisibile»: «In tutti i campi – salvo
pochissimi e per brevi periodi della nostra vita – la massima indipendenza
che possiamo esercitare è quella di moltiplicare le autorità alle quali
prestiamo benevola attenzione […]. Le persone da cui dipendiamo per i
nostri contatti con il mondo esterno sono quelle che sembrano dirigerlo».
Infine sull’organizzazione del consenso nella moderna società di
massa:
È un’arte vecchissima che era stata data per morta quando apparve la
democrazia. Ma non è morta. In realtà ne è stata migliorata enormemente la tecnica,
perché ora si fonda sull’analisi piuttosto che sulla pratica. E così, per effetto della
ricerca psicologica abbinata ai moderni mezzi di comunicazione, la prassi
democratica ha subito una svolta. Sta avvenendo una rivoluzione, infinitamente più
significativa di qualsiasi spostamento di potere economico3.
17
4. Il giornalismo investigativo.
L’ultima parte del lavoro assai denso di Lippmann è dedicata a quello
che era nel 1921 il mezzo di comunicazione di massa per eccellenza, i
giornali, ma che restano ancora oggi centrali per una teoria della
comunicazione giacché hanno costituito a lungo (e in parte continuano a
costituire) il modello per i nuovi media, per i radiogiornali come per i
telegiornali.
Tra i tanti punti che l’autore tocca con rapide osservazioni, ce ne sono
alcuni che meritano di essere ricordati per il valore – verrebbe da dire –
profetico (se non si trattasse, come in verità si tratta, di un solido
ragionamento fondato sull’esperienza e su una riflessione già matura) e
sono tutti punti che attengono al rapporto tra il giornale e i suoi lettori e
alla natura dell’attività giornalistica in una società moderna.
Lippmann considera il giornale come un’impresa che ha anzitutto
obiettivi economici (di qui il ruolo centrale della pubblicità divenuto negli
Stati Uniti decisivo già nei primi due decenni del secolo, assai prima che
nella vecchia Europa) e afferma, a proposito della stampa americana in
quel momento, che «approssimativamente il sostegno economico della
raccolta delle notizie generali sta nel prezzo che pagano per i prodotti
reclamizzati i settori discretamente agiati delle città che superano i
centomila abitanti». Nel 1921, secondo la valutazione di Lippmann, sono
175 i quotidiani-chiave negli Stati Uniti e rientrano tutti nel meccanismo
descritto dallo scrittore; ad essi si affiancano oltre 2100 quotidiani locali
che, per le notizie generali, utilizzano agenzie o si collegano ai grandi
quotidiani nazionali o di una grande regione.
Lippmann non ritiene tuttavia che gli inserzionisti (e in particolare il
singolo inserzionista per quanto importante) siano in grado di dettare legge
su un giornale se questo ha costruito intorno a sé un pubblico di lettori
fedeli e affezionati alla testata.
Un giornale – scrive – può maltrattare un inserzionista, può attaccare un potente
interesse bancario o commerciale, ma se si aliena le simpatie del pubblico che ha
potere di acquisto, perde il solo patrimonio indispensabile alla sua esistenza. […]
Un corpo di lettori che resti fedele, nei tempi buoni come nei cattivi, è una forza
maggiore di quella di cui può disporre il singolo inserzionista e una forza
abbastanza grande per spezzare una combinazione di inserzionisti.
Ci troviamo qui di fronte a un punto delicato dell’analisi dei mezzi di
comunicazione di massa che respinge il determinismo di certe
interpretazioni tutte fondate sugli interessi economici (Lippmann qui
critica le tesi che si collegano in qualche modo al socialismo, in particolare
18
a quello «corporativo» inglese teorizzato da Cole) che guidano i giornali e
individua nel rapporto tra lettori e giornali una zona di possibile, sia pure
limitata, autonomia del lavoro giornalistico anche nella società
contemporanea.
Lo scrittore peraltro nota un fenomeno che diventerà più accentuato nei
decenni successivi del Novecento ma che si può individuare già
all’indomani della prima guerra mondiale:
Non sono le loro notizie politiche e sociali che mantengono in primo luogo la
diffusione. L’interesse per queste notizie è intermittente e pochi editori possono
farvi affidamento in modo esclusivo. Perciò il giornale assume tutta una serie di
altre funzioni, tutte aventi lo scopo di mantenere unito un certo corpo di lettori che
non sono in grado di essere critici di fronte alle grandi notizie.
Lippmann insiste quindi sul problema della necessaria
«standardizzazione» delle notizie che si ritrova nei giornali: una
standardizzazione – aggiungiamo noi – che dovrebbe mettere in guardia gli
storici dall’utilizzare senza cautela nelle loro ricerche le fonti
giornalistiche: «Il giornalismo – osserva – fuorché in casi eccezionali non
è un’esposizione di prima mano del materiale grezzo. È un’esposizione di
questo materiale più o meno stilizzata». E ancora, con maggior chiarezza:
«Senza una standardizzazione, senza degli stereotipi, senza dei giudizi
precostituiti, senza una noncuranza spietata per le sottigliezze, il direttore
morirebbe ben presto di agitazione»1.
L’ultimo punto affrontato nell’analisi dello scrittore riguarda la natura,
i limiti, le peculiarità dell’attività giornalistica intesa anzitutto come
pubblico servizio in una società moderna. E qui le sue conclusioni
appaiono a chi scrive non solo chiarificatrici rispetto al dibattito attuale ma
preziose per allargare l’ottica visuale con cui in questi anni si affronta il
problema della comunicazione nel mondo contemporaneo.
Lippmann non si fa illusioni sugli obiettivi di fondo che può conseguire
la professione anche perché è convinto assertore, secondo un credo
empirico e positivista ancora assai diffuso in quegli anni, della superiorità
che le scienze naturali hanno acquisito su quelle umane:
L’assenza di precisi criteri di verifica – osserva – spiega, meglio di qualunque
altra cosa, il carattere della professione. C’è un piccolissimo corpo di conoscenze
esatte che non richiede alcuna capacità o preparazione eccezionali. Il resto rientra
nella discrezionalità del giornalista. […] E la sua sicurezza viene temperata da
questa consapevolezza. Potrebbe avere tutto il coraggio del mondo, e talvolta lo ha,
ma gli manca la sottostante cultura di una tecnica come quella che ha finalmente
liberato le scienze fisiche dal controllo teologico.
Qui lo scrittore sembra non tener conto delle riflessioni quasi
19
contemporanee di Max Weber che negli anni precedenti aveva teorizzato
la possibilità di applicare anche nelle scienze sociali (e dunque umane)
criteri di valutazione in qualche modo staccati dalla contingenza
politicoideologica, ma non c’è dubbio che, almeno per quanto riguarda il
giornalismo, le intuizioni di Lippmann sull’ampiezza della discrezionalità
giornalistica colpiscono nel segno, anche se sono sempre di meno gli
operatori della comunicazione che se ne ricordano a tempo debito…
Del resto, l’autore è consapevole di una relazione per così dire ferrea
che esiste tra due termini del suo discorso e che spiega lo stato differente
della comunicazione in paesi di antica e consolidata tradizione
democratica rispetto a quelli che questa tradizione o non l’hanno o l’hanno
fragile e incerta: «In generale – scrive – la qualità dell’informazione nella
società moderna è un indice della sua organizzazione sociale […] la
stampa non è un sostituto delle istituzioni»2.
Lippmann è preoccupato soprattutto di un aspetto fondamentale per una
teoria democratica della comunicazione, che di rado viene richiamato
nell’attuale dibattito sul dovere e sul diritto all’informazione. Egli è
convinto che in una società democratica il primo obiettivo dei giornalisti
sia quello di documentare in modo esauriente l’attività dei ceti dirigenti:
solo così infatti i cittadini-elettori potranno giudicare in maniera adeguata
l’operato del governo compiere scelte oculate nelle competizioni politiche
che via via si presenteranno. Ma la sua esperienza lo fa essere pessimista
di fronte alla possibilità che ciò avvenga giacché, a suo avviso, «la stampa
ha a che fare con una società in cui le forze dominanti sono assai
imperfettamente documentate […] normalmente può documentare solo
quello che è stato documentato per lei dalle istituzioni nel corso del loro
funzionamento»3.
Non si può dire che le cose siano cambiate in maniera decisiva nel
corso degli ultimi settant’anni. In apparenza giornalisti e telecamere
penetrano dovunque e non hanno limiti di investigazione ma, nella realtà,
si formano due immagini sempre più differenziate: quella da offrire ai
giornalisti perché la trasmettano al grande pubblico, più superficiale e
meno attenta ai punti essenziali e, di contro, quella più importante ma
segreta dei colloqui confidenziali, degli incontri non ufficiali, ormai anche
delle telefonate segrete che la stampa e la televisione non sono in grado di
documentare e di rivelare ai milioni di lettori e di spettatori che le seguono
con attenzione più o meno grande.
5. Il potere dei media.
20
Rispetto agli anni venti, oggi il sistema dei media vive, come è ovvio,
una fase per molti aspetti nuova e diversa a livello tecnologico come a
livello economico, sociale e istituzionale.
Ortoleva nel suo bel libro, intitolato significativamente Mediastoria,
individua negli ultimi due secoli quattro periodi «esplosivi» in cui le
innovazioni nel campo della comunicazione si addensano e si
sovrappongono l’una all’altra: il primo è quello degli anni 1830-40, con la
sperimentazione del telegrafo, l’introduzione del francobollo, le tecniche
di fotografia rapida; il secondo si colloca nel ventennio che va dal 1875 al
1895 in cui nascono la linotype, le macchine di piegatura veloce dei gior
nali, la macchina da scrivere, il fonografo, il grammofono, il cinema, il
telefono, la telescrittura e la radiotelegrafia; il terzo è rappresentato dal
periodo 1920-35 in cui compaiono la stampa a rotocalco, la telefotografia,
la fotocopiatrice, lo sviluppo delle reti di radiodiffusione circolare, le
prime sperimentazioni televisive, il cinema sonoro e quello a colori; il
quarto periodo esplosivo è quello che stiamo vivendo1.
Si tratta di una periodizzazione, a mio avviso, largamente accettabile;
ed è significativo che rispunti in questi anni, e acquisti mordente, un
dibattito già presente nel libro di Lippmann, che costituisce anzi uno dei
fili che guidano la ricerca e la riflessione dello scrittore americano: quali
sono gli effetti dei media, e del sistema che ormai li accomuna e per così
dire coordina, sulle opinioni politiche e culturali di chi li legge, li vede e li
ascolta?
Il quesito ha acquistato un sapore di stretta attualità nell’Italia degli
ultimi due anni ma viene riproposto di continuo nel mondo anglosassone
come in quello tedesco, francese o spagnolo e continua a essere più che
mai aperta la disputa tra chi sottolinea la scarsa influenza dei mezzi di
comunicazione sulle opzioni politiche e culturali (della maggioranza,
almeno) del pubblico dei lettori e dei radio-telespettatori e chi invece tende
a stabilire un nesso diretto tra i modelli proposti dai media, soprattutto
quelli televisivi, e le scelte degli utenti della comunicazione.
In realtà, leggendo Lippmann, si può giungere a una visione che rifugge
dall’accettazione dell’uno o dell’altro atteggiamento estremo, giacché lo
scrittore americano da una parte insiste sull’importanza che hanno le
«autorità» (quelli che oggi si chiamerebbero opinion leaders) del proprio
circolo primario nella formazione delle opinioni di ciascuno, dall’altra
mette in luce il peso rilevante dei media quando riescono ad adottare
simboli e stereotipi già presenti e attivi nella mentalità dei propri lettori o
spettatori. Naturalmente l’influenza tende ad aumentare in periodi in cui i
valori dominanti in una società o in determinati gruppi sociali sono in crisi,
21
le «autorità» (ad esempio la classe dirigente) sono screditate, cioè nei
periodi di transizione.
«Il potere della comunicazione», ha affermato, del resto, uno studioso
al termine di un serrato bilancio su «Il potere dei media»,
deve essere considerato in termini di influenza mediata […] anche nel caso degli
effetti a lungo termine sui processi di costruzione della realtà, oltre che in quello
degli effetti a breve termine. Ciò vale, evidentemente, qualora si sia in presenza di
situazioni in cui, da un lato, il sistema dei media sia pluralistico e regolamentato e,
dall’altro, siano operanti i fattori e le condizioni che rendono possibile la
mediazione, a ribadire la relatività del potere dei media e la sua dipendenza dalla
presenza attiva delle altre agenzie di socializzazione primaria e secondaria2.
Il problema, visto così, necessariamente si allarga e coinvolge, come è
inevitabile, l’assetto generale della società: dove la famiglia, la scuola, le
istituzioni non svolgono compiutamente la propria funzione, il potere dei
media tende a crescere, e in maniera più accentuata e incontrollata, se
difettano pluralismo e leggi antitrust.
A Lippmann, prima e più che ad altri studiosi, dobbiamo una diagnosi
lucida del problema e riflessioni che, a distanza di settant’anni, restano
essenziali per chi si accosta ai problemi complessi e affascinanti del
rapporto tra i media e le forme di potere proprie di una società industriale
quali erano già gli Stati Uniti negli anni venti ed è ora l’Italia alla fine del
secolo ventesimo.
Torino, settembre 1995
N. T.
Questa nuova edizione dell’Opinione pubblica di Walter Lippmann ripropone, senza
modifiche particolari, quella pubblicata da Comunità nel 1963. Tutti gli interventi
operati sul testo sono stati sottoposti all’attenzione di Cesare Mannucci che ne aveva
curato la traduzione. Su questo terreno le differenze fra le due edizioni sono minime.
Più consistente risulta invece la rielaborazione delle note, poiché si è cercato di
completare le indicazioni bibliografiche, fornite spesso in maniera sommaria
dall’autore, indicando anche, là dove era utile e possibile, le traduzioni italiane esistenti.
La maggior parte delle informazioni relative ai testi citati da Lippmann sono state
ritrovate sul National Union Catalog. La revisione della traduzione e il completamento
delle note sono stati curati da Maria Pia Donat-Cattin.
L’editore ringrazia per la preziosa e gentile collaborazione Gabriella Miggiano
dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana e Francesca Donat-Cattin della Biblioteca
Nazionale di Torino. La competenza e la disponibilità del professor Luciano Mecacci
hanno consentito la soluzione degli ultimi dubbi.
22
Del lavoro pionieristico di Cesare Mannucci vorrei ricordare almeno il saggio sulla
televisione Lo spettatore senza libertà, edito da Laterza nel 1961,equello su La società
di massa, apparso nel 1967 presso le Edizioni di Comunità.
2 P. Ortoleva, Mediastoria. Comunicazione e cambiamento sociale nel mondo
contemporaneo, Nuove Pratiche editrice, Parma 1995, p. 107.
3 Sui mutamenti e le continuità nella stampa e nella televisione italiana dal 1975 ad
oggi cfr. la prefazione dei curatori e il saggio di P. Murialdi e N. Tranfaglia nel volume
La stampa italiana nell’età della televisione, a cura di V. Castronovo e N. Tranfaglia,
Laterza, Roma-Bari 1995.
1 Le citazioni di Lippmann alle pp. 19 e 20 di questo volume.
2 In questo volume, p. 23.
1 In questo volume, p. 36.
2 Cfr. pp. 80-1 e 181. Per un’analisi delle leggende di guerra compiuta da uno
storico, il riferimento d’obbligo è a M. Bloch, Rilessioni di uno storico sulle false
notizie della guerra, in La guerra e le false notizie. Ricordi (1914-1915) e Riflessioni
(1921), Donzelli, Roma 1994.
3 Cfr. pp. 179, 232, 255.
1 Cfr. pp. 327, 329, 335, 349, 353-4.
2 Cfr. pp. 361, 363-4. Per le tesi di M. Weber cfr. Il metodo delle scienze storicosociali (1922), a cura di P. Rossi, Einaudi, Torino 1958.
3 In questo volume, p. 261.
1 Ortoleva, Mediastoria cit., pp. 55-107.
2 G. Losito, Il potere dei media, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1994, p. 154. Si
veda anche la rassegna di M. Wolf, Gli effetti sociali dei media, Bompiani, Milano
1992.
1
23
L’opinione pubblica
a Fay Lippmann
24
– Dopo ciò, dissi, assomiglia tu la nostra natura, per quanto riguarda sapienza
e ignoranza, a un fenomeno di questo genere: considera degli uomini chiusi in
una specie di dimora sotterranea a mo’ di caverna, avente l’ingresso aperto alla
luce e lungo per tutta la lunghezza dell’antro, e quivi essi racchiusi sin da
fanciulli con le gambe e il collo in catene, sì da dover star fermi e guardar solo
dinanzi a sé, ma impossibilitati per i vincoli a muovere in giro la testa; e che la
luce di un fuoco arda dietro di loro, in alto e lontano, e che tra il fuoco e i
prigionieri corra in alto una strada, lungo la quale è costruito un muricciolo,
come quegli schermi che hanno i giocolieri a nascondere le figure, e sui quali
esibiscono i loro spettacoli.
– Vedo, disse.
– Guarda ora degli uomini che lungo questo muretto trasportino utensili
d’ogni genere, sporgenti oltre il muro, e statue e altre immagini animali di pietra
e di legno, e ogni sorta di oggetti; e, come è naturale, alcuni di questi
trasportatori parlino, e altri stiano in silenzio.
– D’una strana immagine tu parli, disse, e di ben strani prigionieri!
– Simili a noi, diss’io, ché questi cotali credi tu anzitutto che di se stessi e gli
uni degli altri vedano altro fuorché le ombre riflesse dal fuoco sulla parete
dell’antro di fronte a loro?
– Come potrebbe essere altrimenti, se son costretti a tenere per tutta la vita
immobile la testa?
– E che vedrebbero degli oggetti trasportati? Non forse lo stesso?
– Come no?
– E se fossero in grado di discorrere fra loro, non pensi tu che essi
prenderebbero per realtà quel che appunto vedessero?
Platone, Repubblica, VII
(traduzione di Francesco Gabrieli)
25
I.
Introduzione
26
I.
Il mondo esterno e le immagini che ce ne facciamo
1.
C’è un’isola, nell’oceano, dove nel 1914 vivevano insieme alcuni
inglesi, francesi e tedeschi. L’isola non era in grado di ricevere
cablogrammi, e solo ogni due mesi vi approdava un postale inglese. Nel
settembre di quell’anno gli abitanti, attendendo l’arrivo della nave,
discutevano ancora dei fatti di cui parlava l’ultimo giornale che avevano
ricevuto: l’imminente processo a madame Caillaux per l’uccisione di
Gastone Calmette. Fu, dunque, con un’impazienza maggiore del solito che
l’intera colonia, una mattina verso la metà di settembre, si trovò riunita al
molo per apprendere la sentenza dal capitano del postale. Vennero a sapere
invece che da più di sei settimane quelli di loro che erano di nazionalità
inglese, insieme a quelli di nazionalità francese, si trovavano in guerra, in
omaggio alla santità dei trattati, con quelli di loro che erano di nazionalità
tedesca. Durante quelle sei curiose settimane si erano comportati
reciprocamente da amici, mentre, di fatto, erano già nemici.
Ma la loro situazione non era poi gran che diversa da quella della
maggior parte della popolazione europea. L’errore per loro era durato sei
settimane; sul continente l’intervallo era stato forse di sei giorni o di sei
ore, ma un intervallo comunque c’era stato. C’era stato un momento in cui
l’immagine di un’Europa dove gli individui continuavano a dedicarsi alle
proprie faccende non corrispondeva in alcun modo all’Europa che stava
per mettere in subbuglio le loro vite. Ciascuno per qualche tempo si era
sentito ancora legato a un ambiente che in realtà non esisteva più. Fino al
25 luglio in tutto il mondo la gente aveva continuato a produrre merci che
non sarebbe più stata in grado di spedire, a ordinarne altre che non sarebbe
più stata in grado di importare, a far piani per le proprie carriere, a studiare
nuove iniziative, e coltivare speranze e aspettative, tutto nella convinzione
che il mondo che conoscevano fosse il mondo reale. C’era anche chi
scriveva libri che illustravano quel mondo, credendo seriamente alle
immagini che se n’era fatto. E poi, quattro anni dopo, un giovedì mattina,
arrivò la notizia dell’armistizio, e la gente provò l’indescrivibile sollievo di
sapere che il massacro era finito. Tuttavia, nei cinque giorni precedenti la
27
cessazione effettiva della guerra, e nonostante che questa fosse già stata
celebrata, varie migliaia di giovani morirono sui campi di battaglia.
Guardando al passato ci è possibile capire quanto sia indiretto il modo
in cui veniamo a conoscere l’ambiente in cui nondimeno viviamo. Ci
accorgiamo che ce ne giungono notizie più o meno rapidamente, ma che se
ne possediamo un’immagine che riteniamo veritiera, la trattiamo proprio
come se fosse l’ambiente stesso. È difficile tenerne conto quando si tratta
delle convinzioni su cui fondiamo ora la nostra azione, ma rispetto ad altri
popoli e ad altre epoche ci lusinghiamo di poter capire facilmente quando
siamo caduti nell’errore di prendere terribilmente sul serio immagini
ridicole del mondo circostante. Per la presunta superiorità della nostra
visione retrospettiva, siamo pronti a dire che il mondo che avrebbero
dovuto vedere, e il mondo che effettivamente videro, erano spesso due
cose totalmente contraddittorie. Ci accorgiamo inoltre che essi, mentre
governavano e combattevano, commerciavano e facevano riforme nel
mondo come se l’immaginavano, conseguivano o non conseguivano
risultati nel mondo come effettivamente era. Partivano per le Indie, e
scoprivano l’America. Diagnosticavano il male, e impiccavano delle
vecchie donne. Pensavano di poter diventare ricchi vendendo sempre e non
comprando mai. Un califfo, obbedendo a quello che riteneva il Volere di
Allah, dava fuoco alla biblioteca di Alessandria.
Scrivendo intorno al 389 sant’Ambrogio difendeva il prigioniero della
caverna platonica, che decisamente si rifiuta di volgere il capo.
Quanto alla terra nulla gioverebbe alla visione del futuro trattare della sua qualità
o della sua posizione. Onde ci basti di sapere quanto si contiene nel corso delle
divine Scritture: che Iddio «sospese la terra nel vuoto» (Gb XXVI, 7). Che interesse,
infatti, per noi di discutere se essa stia sospesa nell’aria o sull’acqua, onde farne poi
nascere la controversia come mai la natura dell’aria, più tenue e arrendevole, possa
sostenere la mole della terra; o come, se questa sta sull’acqua, non si sommerga e
non vi rovini dentro col suo peso? […] Non è già che la terra stia sospesa in
equilibrio, perché si trova nel mezzo del mondo; ma perché la maestà di Dio ve la
obbliga, colla legge della sua volontà1.
Non ci agevola nella nostra speranza della vita futura. Basta sapere ciò
che afferma la Sacra Scrittura. Perché disputare, allora? Ma un secolo e
mezzo dopo sant’Ambrogio, l’opinione si sentì di nuovo turbata, e questa
volta dal problema degli Antipodi. Un monaco di nome Cosma, famoso
per il suo sapere scientifico, venne perciò incaricato di scrivere una
Topografia Cristiana, ovvero «L’opinione cristiana intorno al mondo»2. È
chiaro che egli sapeva benissimo che cosa ci si aspettasse da lui, perché
basò tutte le sue conclusioni sulle Scritture, così come lui le interpretava.
28
Ne risulta, dunque, che il mondo è un piatto parallelogramma, due volte
più esteso in larghezza, da Est a Ovest, che in lunghezza, da Nord a Sud.
Nel centro sta la terra circondata dall’oceano, che a sua volta è circondato
da un’altra terra, dove gli uomini erano vissuti prima del diluvio.
Quest’altra terra era il punto d’imbarco di Noè. A Nord c’è un’alta
montagna conica, intorno alla quale girano il sole e la luna. Quando il sole
sta dietro la montagna, è notte. Il cielo è incollato ai margini della terra
esterna. Consiste in quattro alte pareti che s’incontrano in una volta
concava, sicché la terra è il pavimento dell’universo. Dall’altra parte del
cielo c’è un altro oceano, che costituisce le «acque che stanno sopra il
firmamento». Lo spazio tra l’oceano celeste e la volta ultima dell’universo
appartiene ai beati. Lo spazio tra la terra e il cielo è abitato dagli angeli.
Infine, siccome san Paolo ha detto che tutti gli uomini sono creati per
vivere sulla «faccia della terra», come potrebbero vivere sul retro, dove si
suppone siano gli Antipodi? «Con questo brano davanti agli occhi, ci vien
detto, un cristiano non dovrebbe “nemmeno nominare gli Antipodi”»3.
E ancor meno dovrebbe andarci, agli Antipodi; né alcun principe
cristiano dovrebbe dargli una nave per fare il tentativo; né alcun pio
marinaio dovrebbe desiderare di tentare. Per Cosma non c’era nulla di
assurdo nella sua pianta. Solo tenendo presente la sua assoluta convinzione
che questa fosse la pianta dell’universo, possiamo capire quale orrore
avrebbe provato per Magellano o per Peary, o per l’aviatore che rischiasse
una collisione con gli angeli e con la volta del cielo volando a sette miglia
di altezza nell’aria. Allo stesso modo possiamo ben capire le furie della
guerra e della politica, tenendo presente che la quasi totalità dei membri di
ognuna delle parti in lotta crede assolutamente alla propria immagine della
parte avversaria, e che considera realtà non ciò che è reale, ma ciò che
suppone essere reale. E che perciò, come Amleto, potrà pugnalare Polonio,
dietro la tenda frusciante, scambiandolo per il re, e forse, come Amleto,
soggiungere:
Miserabile, temerario, importuno buffone, addio!
ti ho preso per uno a te superiore: prendi la tua fortuna.
2.
Di solito i grandi uomini, anche durante la loro vita, sono noti al
pubblico soltanto attraverso una personalità fittizia: per cui c’è una parte di
vero nel vecchio detto che nessuno è un grand’uomo per il suo cameriere.
Soltanto una parte di vero, però, perché il cameriere e il segretario privato
29
sono spesso immersi anche loro nella finzione. I personaggi regali, ad
esempio, sono personalità costruite. Credano essi stessi nel proprio
personaggio pubblico, o si limitino a permettere al proprio ciambellano di
metterlo in scena, ci sono in loro perlomeno due esseri distinti; quello
pubblico e regale, e quello privato e umano. Le biografie dei grandi
possono essere facilmente classificate tra le storie dell’uno o dell’altro
essere. Il biografo ufficiale presenta la vita pubblica, quello non ufficiale le
memorie rivelatrici. Il Lincoln di Charnwood, ad esempio, è un nobile
ritratto che raffigura non un essere umano reale, ma un personaggio epico,
pieno di significato, che si muove allo stesso livello di realtà di un Enea o
di un san Giorgio. E anche lo Hamilton di Oliver è una maestosa
astrazione, la scultura di un’idea, «un saggio», come lo stesso Oliver
dichiara, «sull’unione americana». È un monumento solenne alla politica
del federalismo, piuttosto che la biografia di una persona vera. A volte,
poi, la gente crea la propria facciata esteriore proprio nel momento in cui
crede di rivelare il proprio mondo interiore. I diari di Repington e quelli di
Margot Asquith sono un genere di autoritratto nel quale il dettaglio intimo
è illuminante soprattutto come rivelazione del modo in cui gli autori
amano considerare se stessi.
Ma il genere più interessante di ritratto è quello che nasce
spontaneamente nella mente della gente. Quando Vittoria salì al trono, dice
Strachey1,
una grande ondata di entusiasmo pervase il pubblico, perché il sentimento e le
romanticherie erano di moda e lo spettacolo della piccola regina innocente e
modesta, con i suoi biondi capelli e le sue guance rosate, che passava in carrozza per
le strade della capitale, riempiva i cuori dei londinesi di entusiastica e affettuosa
fedeltà. Soprattutto ciascuno era colpito, e in modo vivissimo, dal contrasto tra la
regina Vittoria e i suoi zii; quei vecchi sgradevoli, viziosi ed egoisti, testardi e
ridicoli, con il loro perpetuo peso di debiti, di impicci e di cattiva fama, erano svaniti
come la neve d’inverno, e ora, finalmente, coronata e radiosa, giungeva la
primavera.
Jean de Pierrefeu2 poté osservare il culto dell’eroe da vicino, essendo
stato ufficiale di Stato maggiore di Joffre nel momento della sua maggior
fama:
Per due anni il mondo tributò un omaggio quasi divino al vincitore della Marna. I
portalettere erano letteralmente piegati dal peso delle cassette, dei pacchi e delle
lettere mandatigli da ignoti come entusiastica testimonianza della loro ammirazione.
Credo che nessun altro comandante di questa guerra abbia potuto quanto lui farsi
un’idea di quello che veramente è la gloria. Gli mandavano scatole di cioccolatini
dalle più famose pasticcerie del mondo, casse di champagne, grandi vini di ogni
30
marca, frutta, selvaggina, ninnoli e utensili, vestiti, servizi da fumatori, calamai,
fermacarte. Ogni regione mandava la sua specialità. Il pittore mandava il suo
quadro, lo scultore la sua statuetta, la buona vecchietta una coperta o delle calze, il
pastore, nella sua capanna, intagliava una pipa per lui. Tutti i fabbricanti del mondo
ostili alla Germania gli mandarono i loro prodotti: l’Avana i suoi sigari, il Portogallo
il suo rosso Porto. Ho conosciuto un parrucchiere che non trovò di meglio che fare
un ritratto del generale con i capelli dei suoi cari; un calligrafo ebbe la stessa idea,
ma i lineamenti erano fatti di migliaia di frasi inneggianti al generale tracciate in
caratteri minutissimi. Quanto a lettere, ne riceveva di scritte nelle più diverse
calligrafie, da tutti i paesi, in tutti i dialetti, lettere affettuose, riconoscenti,
traboccanti d’amore, piene d’adorazione. Lo chiamavano Salvatore del Mondo,
Padre della Patria, Strumento di Dio, Benefattore dell’Umanità eccetera… E non
soltanto i francesi, ma gli americani, gli argentini, gli australiani… Migliaia di
bambini, all’insaputa dei genitori, prendevano la penna per scrivergli il loro amore;
moltissimi lo chiamavano Padre. E c’era qualcosa di struggente in queste effusioni,
in questa adorazione, in questi sospiri di sollievo che uscivano da migliaia di cuori
per la sconfitta della barbarie. A tutte queste anime ingenue Joffre appariva come
san Giorgio che sconfigge il drago. Per la coscienza dell’umanità era certamente
l’incarnazione della vittoria del bene sul male, della luce sulle tenebre.
Persino i pazzi, i sempliciotti, gli squilibrati e i maniaci volgevano verso di lui le
menti ottenebrate come verso la ragione stessa. Ho letto la lettera di una persona che
viveva a Sidney, la quale implorava il generale di liberarla dai suoi nemici; un
neozelandese lo pregava di mandare dei soldati a casa di uno che gli doveva dieci
sterline e si rifiutava di pagare.
Infine centinaia di ragazzine, superando la timidezza del sesso, gli chiedevano
appuntamenti segreti; altre desideravano solo servirlo.
Questo Joffre ideale era un composto di varie cose: la vittoria
conquistata insieme ai suoi ufficiali e alle sue truppe, la disperazione della
guerra, i lutti personali, la speranza nella vittoria futura. Ma accanto
all’adorazione dell’eroe c’è anche l’esorcizzazione dei diavoli. Con lo
stesso meccanismo con cui si creano gli eroi, si fanno anche i diavoli. Se
ogni bene doveva venire da Joffre, Foch, Wilson, Roosevelt, ogni male
doveva risalire al Kaiser Guglielmo, a Lenin e a Trockij. Essi erano
onnipotenti nel male quanto gli eroi lo erano nel bene. Agli occhi di molte
creature semplici e terrorizzate non c’era al mondo rivolgimento politico,
sciopero, rinvio, morte misteriosa o incendio che non dovesse essere
riportato a queste fonti personali del male.
3.
Una convergenza così universale su una personalità simbolica è un
fatto abbastanza raro da diventare memorabile; e ogni scrittore ha una
31
certa debolezza per gli esempi lampanti e inconfutabili. L’analisi della
guerra ne rivela molti, ma non li crea dal nulla. Nella normale vita
pubblica le immagini simboliche non influiscono certamente meno sul
comportamento, ma ciascun simbolo è meno comprensivo, perché ce ne
sono molti in concorrenza. E perciò non solo è meno carico di emozione,
perché al massimo rappresenta i sentimenti di una parte soltanto della
popolazione, ma anche all’interno di questa parte le differenze individuali
sono molto meno livellate. In tempi di moderata sicurezza, i simboli
dell’opinione pubblica sono soggetti a controlli, a confronti e a discussioni.
Si formano e si disfanno, si consolidano e vengono dimenticati, e non
realizzano mai perfettamente il sentimento di un gruppo intero. In fondo
c’è una sola attività umana in cui si riesca ad attuare l’unione sacra di
popolazioni intere: quest’unione si compie appunto in quelle fasi centrali
di una guerra in cui la paura, la bellicosità e l’odio hanno raggiunto il
completo dominio dell’animo umano, schiacciando o assorbendo ogni
altro istinto, e non è ancora cominciata la stanchezza.
In quasi tutte le altre situazioni, e persino durante la guerra quando si
arriva a un punto morto, c’è sempre una gamma sufficientemente ampia di
sentimenti per consentire conflitti, scelte, esitazioni, compromessi. Il
simbolismo dell’opinione pubblica porta di solito, come vedremo1, i segni
di questo equilibrarsi degli interessi. Si pensi, ad esempio, alla rapidità con
cui, raggiunto l’armistizio, è svanito il simbolo precario e tutt’altro che ben
fondato dell’Unità Alleata, e si è disgregata di conseguenza l’immagine
simbolica che ogni nazione aveva delle altre: l’Inghilterra tutrice del
Diritto Internazionale, la Francia sentinella alla Frontiera della Libertà,
l’America paese della Crociata. E si pensi come sia franata l’immagine
simbolica che ogni nazione aveva di se stessa, non appena la lotta dei
partiti e delle classi e le ambizioni personali hanno ricominciato ad agitare
le questioni rimaste in sospeso. Ed anche come siano venute meno, una
alla volta, le immagini simboliche dei capi; e Wilson, Clemenceau, Lloyd
George abbiano cessato di essere incarnazioni della speranza umana,
diventando semplicemente i negoziatori e gli amministratori di un mondo
deluso.
Ovviamente qui non importa stabilire se tutto ciò sia uno dei sommessi
mali della pace o se si debba salutarlo come un ritorno alla salute. La
nostra prima preoccupazione di fronte alle finzioni e ai simboli è di
disinteressarci del valore che hanno per l’ordine sociale esistente, e di
considerarli semplicemente una parte importante del meccanismo della
comunicazione umana.
Ora, in qualsiasi società che non sia talmente assorbita nei suoi interessi
32
né tanto piccola, che tutti siano in grado di sapere tutto su ciò che vi
accade, le idee si riferiscono a fatti che sono fuori del campo visuale
dell’individuo, e che per di più sono difficili da comprendere. Miss
Sherwin di Gopher Prairie2 sa che in Francia si combatte una guerra, e
cerca di figurarsela. Non è mai stata in Francia, e certamente non ha mai
percorso quella che ora è la linea del fronte. È vero che ha visto fotografie
di soldati francesi e tedeschi, ma le riesce impossibile immaginare tre
milioni di uomini. Nessuno, difatti, riesce a immaginarseli, e nemmeno i
militari di professione tentano di farlo: li pensano, poniamo, come
duecento divisioni. Ma Miss Sherwin non ha la possibilità di vedere le
carte militari con lo schieramento delle forze opposte, e perciò, se pensa
alla guerra, si affretta a pensare a Joffre e al Kaiser come se fossero
impegnati in un duello personale. Forse, se potessimo entrare nella sua
mente, scopriremmo qualcosa di simile a un’incisione settecentesca di un
grande soldato. La figura, più grande del normale, spicca audace e
composta contro un indistinto esercito di minuscole figurine che tendono a
sfumare nel paesaggio. Non sembra, del resto, che gli stessi grandi uomini
rifuggano da queste fantasticherie. Pierrefeu racconta della visita di un
fotografo a Joffre. Il generale stava «nel suo ufficio di aspetto borghese,
davanti al tavolo completamente sgombro dove era solito mettersi per
firmare i documenti. Improvvisamente si notò che non c’erano carte
geografiche, si provvide a sistemarne lì per lì alcune, che vennero tolte
appena il fotografo ebbe finito»3.
Il solo sentimento che si può provare per un fatto di cui non si ha
un’esperienza diretta è il sentimento che viene suscitato dall’immagine
mentale di quel fatto. Ecco perché, finché non sappiamo quello che gli altri
ritengono di sapere, non possiamo nemmeno capire davvero le loro azioni.
Una volta ho visto una ragazza, cresciuta in un centro minerario della
Pennsylvania, passare improvvisamente dall’allegria al dolore più cupo
allorché una raffica di vento incrinò il vetro della finestra della sua cucina.
Per ore intere restò inconsolabile, e a me la cosa riusciva incomprensibile.
Ma quando finalmente fu in grado di parlare, si riuscì a capire che per lei
la rottura di un vetro significava che era morto un parente stretto. Perciò
piangeva per suo padre, che l’aveva spaventata abbandonando la casa.
Naturalmente il padre era vivo e vegeto, come subito dimostrò un
accertamento fatto a mezzo di telegrafo. Ma fino a quando non arrivò il
telegramma, il vetro incrinato continuò ad essere un autentico messaggio
agli occhi della ragazza. Perché fosse autentico, solo l’esame paziente e
approfondito di uno psichiatra avrebbe potuto stabilirlo. Ma anche
l’osservatore meno esperto era in grado di capire che la ragazza,
33
terribilmente sconvolta dalle sue difficoltà familiari, s’era costruita
un’allucinazione sulla base di un fatto esterno, cui s’erano mescolati il
ricordo di una superstizione, il rimorso, la paura e l’amore del padre.
In questi casi l’anormalità è solo una questione di grado. Quando un
Procuratore generale, terrorizzato da una bomba esplosa sulla soglia della
sua casa, si convince in seguito alla lettura di scritti rivoluzionari che il 1°
maggio 1920 scoppierà una rivoluzione, dobbiamo riconoscere che
praticamente si è messo in moto lo stesso meccanismo che ha agito nella
ragazza della Pennsylvania. Naturalmente la guerra ha fornito parecchi
esempi di questo genere: il fatto imprevisto, l’immaginazione che si mette
a lavorare, la volontà di credere, e, dall’insieme di questi tre elementi, una
contraffazione della realtà verso la quale c’era stata una violenta reazione
istintiva. Infatti è abbastanza chiaro che in certe situazioni gli individui
reagiscono alle finzioni con la stessa forza con cui reagiscono alla realtà, e
che in molti casi contribuiscono a creare proprio quelle funzioni a cui
reagiranno. Scagli la prima pietra chi non ha creduto che un esercito russo
stesse attraversando l’Inghilterra nell’agosto del 1914, o chi non ha
accettato dei racconti di atrocità senza averne le prove dirette, o non ha
mai creduto di vedere un complotto, un traditore, una spia dove non ce
n’era alcuno. Scagli la prima pietra chi non ha mai fatto circolare come
verità autentica quello che aveva sentito dire da qualcuno che non ne
sapeva affatto più di lui.
In tutti questi casi c’è un fattore comune che è particolarmente degno di
nota: l’inserimento di uno pseudo-ambiente tra l’individuo e il suo
ambiente. Il comportamento dell’individuo è appunto una reazione a
questo pseudo-ambiente. Ma dato che è un comportamento, le sue
conseguenze, se si tratta di atti, non operano nello pseudo-ambiente nel
quale è stato stimolato, ma nell’ambiente reale nel quale l’azione accade.
Se il comportamento non è un atto pratico, ma ciò che grossolanamente
chiamiamo pensiero ed emozione, può passare anche parecchio tempo
prima che si possa notare una rottura nel tessuto del mondo immaginario.
Ma se lo stimolo dello pseudo-fatto dà luogo a un’azione che ha per
oggetto cose o altre persone, la contraddizione si sviluppa subito. Allora
subentra la sensazione di battere la testa contro un muro, di apprendere per
esperienza diretta quella che Herbert Spencer chiamava la tragedia
dell’assassinio di una Bellissima Teoria da parte di una Gang di Fatti
Brutali; in breve, il disagio di un mancato adeguamento. E infatti è certo
che, a livello della vita sociale, quello che si è soliti chiamare
l’adattamento dell’uomo all’ambiente avviene per mezzo di finzioni.
Per finzioni non intendo affatto menzogne. Intendo invece una
34
rappresentazione dell’ambiente fabbricata, in maggiore o minor misura,
dall’individuo stesso. La gamma delle finzioni va dalla completa
allucinazione all’uso perfettamente cosciente di un modello schematico da
parte dello scienziato, o alla decisione che per un determinato problema
l’esattezza, al di là di una certa cifra decimale, non ha importanza. Un
prodotto dell’immaginazione può avere un grado anche notevole di fedeltà,
e finché di questo grado di fedeltà si riesce a tener conto, la finzione non è
fuorviante. In realtà la cultura umana è in larga misura la selezione, il
riordinamento, la schematizzazione e la stilizzazione di quelle che William
James chiamava «le irradiazioni e le ridistemazioni casuali delle nostre
idee»4. L’alternativa all’uso di finzioni è l’imposizione diretta al flusso
delle sensazioni. Ma non è poi una vera alternativa, giacché, per quanto
rinfrescante possa essere a volte il guardare con occhio perfettamente
innocente, l’innocenza in sé non è saggezza, ma semmai una fonte e un
correttivo della saggezza.
Infatti l’ambiente reale, preso nel suo insieme, è troppo grande, troppo
complesso e troppo fuggevole per consentire una conoscenza diretta. Non
siamo attrezzati per affrontare tante sottigliezze, tanta varietà, tante
mutazioni e combinazioni. E pur dovendo operare in questo ambiente,
siamo costretti a costruirlo su un modello più semplice per poterne venire a
capo. Per attraversare il mondo gli uomini debbono possedere carte
geografiche. La persistente difficoltà è di assicurarsi mappe sulle quali la
propria esigenza, o quella altrui, non sia tracciata sulla costa della Boemia.
4.
Lo studioso dell’opinione pubblica deve quindi cominciare col
riconoscere il rapporto triangolare esistente tra la scena dell’azione, la
rappresentazione che l’uomo si fa di questa scena e la reazione a tale
rappresentazione, rioperante a sua volta sulla scena dell’azione. È come
uno spettacolo che venga suggerito agli attori dalla loro esperienza
personale, in cui la trama si compia nelle vite reali degli attori, e non solo
nei loro ruoli teatrali. Il cinema mette spesso in risalto con grande efficacia
questo duplice dramma del movente interiore e del comportamento
esteriore. Due uomini, ad esempio, litigano apparentemente per questioni
di denaro; ma la loro collera riesce incomprensibile. Poi c’è una
dissolvenza, e subito dopo appare la scena che l’uno o l’altro dei due vede
con l’occhio della mente. Litigavano, seduti davanti a un tavolo, per
questioni di denaro. Ma nella memoria rievocavano gli anni della
giovinezza, quando una certa ragazza aveva abbandonato uno dei due per
35
l’altro. Il dramma esteriore è dunque spiegato: il protagonista non è avido
di denaro, ma innamorato.
Una scena non molto diversa da questa è stata recitata al Senato degli
Stati Uniti. La mattina del 29 settembre 1919, all’ora della prima
colazione, alcuni senatori lessero sul «Washington Post» la notizia dello
sbarco di marines americani sulla costa della Dalmazia. Il giornale diceva
così:
ACCERTATI ORMAI I FATTI
Sembrano ormai definitivamente accertati i seguenti importanti fatti. Gli ordini
impartiti al contrammiraglio Andrews, comandante delle forze navali americane
nell’Adriatico, sono giunti dall’Ammiragliato inglese tramite il Consiglio di guerra e
il contrammiraglio Knapps in Londra. L’approvazione o la disapprovazione del
Dipartimento americano della Marina non sono state richieste.
ALL’INSAPUTA DI DANIELS
Si ammette che Daniels si è venuto a trovare in una situazione imbarazzante
quando sono giunti qui dei cablogrammi attestanti che le forze che dovrebbero
dipendere esclusivamente da lui a sua insaputa erano ingaggiate in un’azione navale.
D’altra parte era evidente che l’Ammiragliato inglese poteva sentire l’esigenza di
ordinare al contrammiraglio Andrews di agire per conto della Gran Bretagna e dei
suoi alleati, poiché se si volevano contenere i seguaci di D’Annunzio la situazione
richiedeva uno sforzo da parte di qualche nazione.
È apparso anche chiaro che sotto il nuovo regime della Società delle Nazioni,
degli stranieri si troverebbero nella posizione di dare ordini alle forze navali
americane in casi di emergenza con o senza il consenso del Dipartimento americano
della Marina (I corsivi sono miei).
Il primo senatore a commentare questa notizia è Knox della
Pennsylvania. Chiede indignato un’inchiesta. Nel senatore Brandegee del
Connecticut, che parla subito dopo, l’indignazione ha già destato la
credulità. Mentre Knox indignato vuole sapere se la notizia è vera,
Brandegee, mezzo minuto dopo, vorrebbe sapere che cosa sarebbe
accaduto se dei marines fossero stati uccisi. Knox, interessandosi al
problema, dimentica di aver domandato un’inchiesta, e risponde che se dei
marines americani fossero stati uccisi, ci sarebbe stata la guerra. Siamo
ancora ai verbi condizionali. Ma il dibattito continua. McCormick
dell’Illinois ricorda al Senato che l’amministrazione Wilson è portata a
intraprendere piccole guerre non autorizzate; e ripete la battuta di
Theodore Roosevelt sul «combattere la pace». Brandegee osserva che i
marines hanno agito «per ordine di un Consiglio supremo insediato da
qualche parte», ma non riesce a ricordare chi rappresenti gli Stati Uniti.
Perciò il senatore New dell’Indiana presenta un ordine del giorno che
invita perentoriamente chi di dovere ad esporre i fatti.
36
Fino a questo punto i senatori sono ancora vagamente consapevoli che
stanno discutendo sulla base di una semplice voce. Dal momento che sono
degli avvocati, hanno ancora presenti alcune delle caratteristiche che deve
avere l’evidenza. Ma come uomini sanguigni provano già tutta
l’indignazione che si conviene al fatto che dei marines americani siano
stati mandati in guerra per ordine di un governo straniero e senza il
consenso del Congresso americano. Emotivamente vogliono crederlo,
perché sono dei repubblicani che osteggiano la Società delle Nazioni. Ciò
suscita la reazione del capo del gruppo democratico, il senatore Hitchcock
del Nebraska. Questi difende il Consiglio supremo: ha agito in base ai
poteri di guerra. La pace non è ancora stata conclusa perché i repubblicani
la fanno andare per le lunghe. Perciò l’azione era necessaria e legale. A
questo punto ambedue le parti danno per scontato che il resoconto del
giornale corrisponda a verità, e le conclusioni che ne traggono sono le
conclusioni della loro parte politica. Tuttavia questo incredibile assunto
prende corpo durante un dibattito su un ordine del giorno che chiede di
indagare sulla verità dell’assunto. Tutto ciò rivela quanto riesca difficile,
persino a degli esperti avvocati, sospendere il giudizio fino a quando non
siano disponibili tutti i dati. La reazione è istantanea: la finzione viene
presa per la verità, perché la finzione soddisfa una profonda esigenza.
Qualche giorno dopo un rapporto ufficiale dimostrava che i marines
non erano sbarcati per ordine del governo inglese o del Consiglio supremo;
non avevano combattuto contro gli italiani; erano stati fatti sbarcare su
richiesta del governo italiano per proteggere gli italiani e il comandante
americano era stato ufficialmente ringraziato dalle autorità italiane. I
marines non si trovavano in guerra con l’Italia e avevano agito secondo
una vecchia consuetudine internazionale, che non aveva nulla a che vedere
con la Società delle Nazioni.
La scena dell’azione era l’Adriatico. L’immagine di questa scena era
stata fornita ai senatori a Washington, in questo caso probabilmente
nell’intento di ingannare, da qualcuno a cui non importava nulla
dell’Adriatico, ma importava molto il fallimento dell’idea della Società
delle Nazioni. A questa immagine il Senato reagì infatti accentuando le
divisioni tra i due partiti a proposito della Società.
5.
Non è necessario qui stabilire se in questo caso particolare il Senato
fosse al di sopra o al di sotto del suo livello normale. E neppure interessa
stabilire se il Senato regga bene il confronto con la Camera dei
37
rappresentanti, o con altri parlamenti. Vorrei soffermarmi solo sullo
spettacolo universale di uomini che agiscono sul proprio ambiente, mossi
da stimoli provenienti dai propri pseudo-ambienti. Infatti, tenuto
largamente conto degli inganni deliberati, la scienza politica deve ancora
spiegare certi fatti, come i reciproci attacchi di due nazioni, ognuna delle
quali è persuasa di agire per legittima difesa, o di due classi, ciascuna delle
quali è certa di parlare a nome dell’interesse comune. Siamo tentati di dire
che vivono in mondi diversi; però è più esatto dire che vivono nello stesso
mondo, ma pensano e sentono in mondi diversi.
È rispetto a questi mondi particolari, rispetto a queste elaborazioni
personali, o di gruppo, o di classe, o di regione, o professionali, o
nazionali, o di setta, che si compie l’adattamento politico degli uomini
nella Grande Società. È impossibile descrivere la loro varietà e la loro
complessità. Eppure queste finzioni determinano in grandissima parte il
comportamento politico degli uomini. Dobbiamo cominciare col tener
conto di una cinquantina di parlamenti sovrani comprendenti almeno un
centinaio di assemblee legislative. A questi corrispondono almeno una
cinquantina di gerarchie di assemblee provinciali e municipali, le quali,
con i loro organi esecutivi, amministrativi e legislativi, costituiscono nel
mondo l’autorità formale, ma tutto ciò non dà neppure una pallida idea
della complessità della vita politica. Infatti, entro ciascuno di questi
innumerevoli centri di autorità ci sono partiti, e questi partiti sono
anch’essi gerarchie le cui radici affondano nelle classi, nelle categorie,
nelle conventicole e nei clan; e all’interno di questi ci sono i singoli
uomini politici, ciascuno dei quali è al centro di una rete di legami e di
memorie e di speranze e di timori.
In un modo o nell’altro, per ragioni spesso inevitabilmente oscure, per
effetto di una supremazia, o di un compromesso, o di un accordo,
emergono da questi organi politici gli ordini che mettono in moto gli
eserciti o dettano la pace, o impongono la coscrizione, le tasse, l’esilio, il
carcere, proteggono la proprietà o la confiscano, incoraggiano un tipo
d’iniziativa economica e ne scoraggiano un’altra, facilitano
l’immigrazione o la bloccano, migliorano le comunicazioni o le censurano,
istituiscono scuole, costruiscono flotte, proclamano delle «politiche» o dei
«destini», elevano barriere economiche, creano o disfano patrimoni,
sottomettono un popolo al dominio di un altro o favoriscono una classe nei
confronti di un’altra. Per ognuna di queste decisioni si dà per definitiva
una certa visione dei fatti, la si accetta come base delle deduzioni che si
traggono e come stimolo del sentire. Quale visione dei fatti, e perché
proprio quella?
38
E tuttavia neanche questo permette di cogliere tutta la complessità della
politica. La struttura politica formale è inserita in un ambiente sociale, che
comprende innumerevoli corporazioni e istituzioni grandi e piccole,
associazioni volontarie e semivolontarie, raggruppamenti nazionali,
provinciali, cittadini e di vicinato, che assai spesso prendono la decisione
di cui il corpo politico prende atto. Su che cosa si basano queste decisioni?
La società moderna – dice Chesterton – è intrinsecamente insicura perché si
fonda sull’idea che tutti gli uomini faranno la stessa cosa per ragioni diverse […] e,
come dentro la testa di un qualsiasi detenuto può esserci l’inferno di un delitto
assolutamente unico, così nella casa o sotto il cappello di un qualunque impiegato di
periferia può esserci il limbo di una filosofia del tutto personale. Il primo può essere
un perfetto materialista, che sente il suo corpo come un’orribile macchina intenta a
fabbricare la sua mente; può darsi che ascolti i suoi pensieri come se fossero il
monotono ticchettìo di un orologio. Il nostro vicino può essere un Christian
Scientist, e vedere il proprio corpo come in qualche modo meno reale della sua
ombra; può arrivare quasi a convincersi che le sue braccia e le sue gambe siano
illusioni, al pari dei serpenti che si muovono nell’allucinazione del delirium
tremens. Il terzo uomo che incontriamo per via può essere non un Christian
Scientist, ma, al contrario, un cristiano. Forse vive in una fiaba, come direbbero i
suoi vicini, in una fiaba segreta ma solida, piena dei volti e delle presenze di amici
ultraterreni. Il quarto uomo può essere un teosofo, purtroppo molto probabilmente
un vegetariano; e non vedo perché dovrei rinunciare al piacere di immaginare che il
quinto sia un adoratore del diavolo […]. Ora, quale che sia il nostro giudizio sul
valore di questa varietà, è che l’unità raggiungibile tra questi uomini è precaria.
Aspettarsi che gli uomini continuino sempre a pensare cose diverse, e tuttavia a
comportarsi nello stesso modo, è una speculazione dubbia. Così si fonda una società
non su una comunione, né su una convenzione, ma piuttosto su una coincidenza.
Può darsi che quattro uomini s’incontrino sotto lo stesso lampione; il primo per
verniciarlo in verde pisello, in seguito ad una riforma decisa dal municipio; un
secondo per leggere il breviario sotto la sua luce; un terzo per abbracciarlo con
ardore in un eccesso di entusiasmo da ubriachezza; e il quarto solo perché il
lampione color verde pisello è un punto bene in vista per un rendez-vous con la
ragazza. Ma è poco sensato attendersi che questo avvenga ogni sera1.
Al posto dei quattro uomini al lampione si mettano i governi, i partiti,
le aziende, le associazioni, gli ambienti sociali, i mestieri e le professioni,
le università, le sette e i gruppi etnici del mondo. Si pensi al legislatore che
vota una legge che influirà su popoli lontani, a un uomo di governo che
prende una decisione. Si pensi alla Conferenza della pace che ricostituisce
le frontiere d’Europa, a un ambasciatore presso un paese straniero che
cerca di individuare le intenzioni del proprio governo e del governo
straniero, a un imprenditore che sfrutta una concessione in un paese
arretrato, ad un direttore di giornale che reclama la guerra, ad un prete che
39
chiede alla polizia di porre dei limiti a certi divertimenti, ai membri di un
club che si formano un’opinione su uno sciopero, ad un circolo femminile
che si accinge a controllare le scuole, a nove giudici che decidono se
l’assemblea legislativa dell’Oregon può fissare l’orario di lavoro per le
donne, alla riunione di Gabinetto per decidere sul riconoscimento di un
governo, al congresso di partito per scegliere un candidato ed elaborare un
programma, a ventisette milioni di elettori che mettono le loro schede
nell’urna, a un irlandese di Cork che pensa ad un irlandese di Belfast, alla
Terza Internazionale che progetta di ricostruire l’intera società umana, ad
un consiglio di amministrazione di fronte ad una serie di rivendicazioni dei
propri dipendenti, a un giovane che sceglie una professione, a un
commerciante che calcola la domanda e l’offerta per la prossima stagione,
allo speculatore che cerca di indovinare il corso dei titoli, al banchiere che
decide se finanziare o no una nuova iniziativa, all’inserzionista, al lettore
delle inserzioni […]. Si pensi ai diversi tipi di americani che riflettono
sulle loro idee di «Impero britannico», di «Francia» o di «Russia» o di
«Messico». Tutto ciò non è molto diverso dai quattro uomini di Chesterton
accanto al lampione verde pisello.
6.
E perciò, prima di addentrarci nella giungla delle oscurità circa le
differenze innate tra gli uomini, faremo bene a fissare la nostra attenzione
sulle straordinarie differenze che corrono tra le conoscenze che gli uomini
hanno del mondo1. Non metto in dubbio che vi siano importanti differenze
biologiche, poiché gli uomini sono animali, sarebbe strano che non ce ne
fossero. Ma poiché sono anche esseri razionali, sarebbe peggio che
superficiale avventurarsi in una qualsiasi generalizzazione sui
comportamenti comparati finché non ci fossero delle similarità misurabili
tra gli ambienti rispetto ai quali il comportamento è una reazione.
Il valore pratico di quest’idea è che colloca a un livello più raffinato
l’antica controversia circa la natura e l’educazione, le qualità innate e
l’ambiente. Infatti lo pseudo-ambiente è un ibrido risultante da una
combinazione di «natura umana» e di «condizioni ambientali». Tutto ciò,
dal mio punto di vista, dimostra l’inutilità del pontificare su quello che
l’uomo è, e sarà, sempre sulla base di ciò che gli vediamo fare, o su quali
siano le condizioni necessarie della società. Infatti non sappiamo in che
modo gli uomini si comporterebbero in reazione ai fatti della Grande
Società. Sulla base di dati come questi non si può onestamente pervenire
ad alcuna conclusione circa l’uomo o la Grande Società.
40
Questo, allora, sarà il punto di partenza della nostra indagine. Il nostro
assunto è che ciò che l’individuo fa si fonda non su una conoscenza diretta
e certa, ma su immagini che egli si forma o che gli vengono date. Se il suo
atlante gli dice che il mondo è piatto, l’uomo non farà rotta verso ciò che
ritiene essere l’orlo del nostro pianeta per paura di cadere giù. Se le sue
mappe comprendono una fontana dell’eterna giovinezza, Ponce de León
continuerà a cercarla. Se qualcuno tira su con la pala della terra gialla che
sembra oro, per un po’ agirà proprio come se avesse trovato dell’oro. Il
modo in cui il mondo viene immaginato determina in ogni momento il
comportamento dell’uomo. Non determina quello che gli uomini
conseguiranno: determina i loro sforzi, i loro sentimenti, le loro speranze,
ma non le conquiste e i risultati. E proprio gli uomini che proclamano più
forte il loro «materialismo» e il loro disprezzo per gli «ideologi», cioè i
comunisti marxisti, in che cosa pongono le loro speranze? Nella
formazione, mediante la propaganda, di un gruppo dotato di coscienza di
classe. Ma cos’è la propaganda se non lo sforzo di modificare l’immagine
a cui reagiscono gli individui, di sostituire un modello sociale a un altro?
Che cos’è la coscienza di classe se non un modo di vedere il mondo? E che
cos’è la coscienza nazionale se non un altro di questi modi? E che cos’è la
«coscienza dell’affinità», di cui parla il professor Giddings, se non una
disposizione a credere che in mezzo alla moltitudine degli uomini
possiamo, da certi segni, riconoscere come affini alcuni di loro?
Si cerchi di spiegare la vita sociale come impegno a cercare il piacere e
a evitare il dolore; si dirà ben presto che l’edonista sfugge al problema,
perché, anche supponendo che l’uomo davvero persegua questi fini, il
problema cruciale, del perché ritenga che una vita sia più atta di un’altra a
produrre il piacere, non viene neppure sfiorato. La guida della coscienza
può essere una spiegazione? E allora da dove deriva la sua particolare
coscienza? È valida allora la teoria dell’egoismo economico? Ma come
arrivano gli uomini a concepire il loro interesse in un modo piuttosto che
in un altro? La spiegazione va dunque cercata nel desiderio di sicurezza, o
di prestigio, o di supremazia, o di ciò che viene vagamente chiamato
autorealizzazione. Come concepiscono gli uomini la loro sicurezza, che
cosa considerano prestigio, come individuano i mezzi per la supremazia, o
quale idea di se stessi vogliono realizzare? Piacere, dolore, coscienza,
acquisizione,
protezione,
perfezionamento,
predominio
sono
indubbiamente nomi per indicare taluni comportamenti degli uomini.
Possono esserci disposizioni istintive che operano a questi fini, ma nessuna
formulazione del fine, o descrizione delle tendenze a raggiungerlo,
possono spiegare la condotta che ne risulta. Il fatto stesso che gli uomini si
41
fanno delle teorie prova che i loro pseudo-ambienti, le loro
rappresentazioni interiori del mondo, sono un elemento determinante del
pensiero, del sentimento e dell’azione. E infatti se il rapporto tra realtà e
reazione umana fosse diretto e immediato, invece che indiretto e inferito,
non si conoscerebbero né l’indecisione né l’insuccesso, e (se ognuno di noi
fosse inserito nel mondo con la stessa comodità del bimbo nel grembo
materno) Bernard Shaw non sarebbe stato in grado di dire che nessun
essere umano, tranne nei primi nove mesi della sua esistenza, conduce le
sue cose con la stessa efficienza di una pianta.
È proprio qui che sorge la principale difficoltà ad adattare la teoria
psicoanalitica al pensiero politico. I freudiani si preoccupano del mancato
adattamento di singoli individui ad altri individui e a concrete circostanze.
Il loro assunto è che se si potessero sciogliere i nodi interni ben
difficilmente si creerebbe confusione intorno a quello che è il rapporto
ovviamente normale. Ma l’opinione pubblica ha a che fare con realtà
indirette, non viste e sconcertanti, e non c’è nulla di ovvio in esse. Le
situazioni a cui si riferiscono le opinioni pubbliche sono note solo come
opinioni. Lo psicoanalista, d’altro canto, presume quasi sempre che
l’ambiente sia conoscibile, e, qualora non sia conoscibile, almeno
sopportabile da ogni intelligenza non obnubilata. Questo suo postulato è il
problema dell’opinione pubblica. Invece di dare per acquisito un ambiente
facilmente conoscibile, l’analista della società si preoccupa soprattutto di
studiare in che modo venga concepito l’ambiente politico più vasto, e se
sia possibile concepirlo più fedelmente. Lo psicoanalista esamina
l’adattamento ad un’incognita, che egli chiama l’ambiente; l’analista
sociale esamina quell’incognita che definisce pseudo-ambiente.
Naturalmente ha un debito permanente e costante verso la nuova
psicologia, non solo perché essa, quando è ben applicata, aiuta le persone a
reggersi da sole, qualsiasi cosa succeda, ma perché lo studio dei sogni,
della fantasia e delle razionalizzazioni ha chiarito notevolmente il processo
di formazione dello pseudo-ambiente. Ma non può assumere come criterio
di giudizio né quello che viene chiamato un «normale curriculum
biologico»2 entro l’ordine sociale esistente, né un curriculum «liberato
dalla repressione religiosa e dalle convenzioni dogmatiche» che si svolge
fuori di quest’ordine3. Per un sociologo che cos’è un normale curriculum
sociale? O un curriculum libero da repressioni e convenzioni?
Naturalmente gli studiosi conservatori assumono il primo, e quelli
romantici il secondo. Ma nell’assumerli danno per scontato tutto il mondo.
Dicono, in sostanza, o che la società è quella cosa che corrisponde alla loro
idea della normalità, oppure che è quella cosa che corrisponde alla loro
42
idea di ciò che è libero. Entrambe le idee sono soltanto delle opinioni
pubbliche, e mentre lo psicanalista, come medico, può forse assumerle, il
sociologo non può servirsi dei prodotti dell’opinione pubblica esistente
come criteri per lo studio dell’opinione pubblica.
7.
Il mondo con cui dobbiamo avere a che fare politicamente è fuori dalla
nostra portata, fuori dal nostro campo visuale, fuori dai nostri pensieri.
Dev’essere esplorato, riferito e immaginato. L’uomo non è un dio
aristotelico, capace di contemplare con un solo sguardo l’intera esistenza.
È la creatura di un’evoluzione, appena in grado di abbracciare una
porzione di realtà che gli consenta di sopravvivere e di strappare al tempo
pochi attimi di intuizione e felicità. Eppure questa stessa creatura ha
inventato mezzi per vedere quello che non si può vedere a occhio nudo, di
sentire quello che l’orecchio non può sentire, di pesare masse immense e
masse infinitesime, di contare e dividere più voci di quante, come singolo,
riesce a ricordare. Impara a vedere con la mente vaste zone del mondo che
non potrebbe mai vedere con gli occhi, o toccare, o odorare, o udire, o
ricordare. Un po’ alla volta si costruisce nella mente un’immagine
attendibile del mondo che sta al di là della sua portata.
Chiamiamo grossolanamente affari pubblici quegli aspetti del mondo
esterno che hanno a che fare con il comportamento di altri esseri umani, in
quanto questo comportamento si incroci col nostro, dipenda da noi, o ci
interessi. Invece le immagini che sono nella mente di questi esseri umani,
le immagini di se stessi, di altri, delle loro esigenze, dei loro intenti e dei
loro rapporti, sono le loro opinioni pubbliche. Le immagini in base a cui
agiscono gruppi di persone, o individui che agiscono in nome di gruppi,
costituiscono l’Opinione Pubblica con le iniziali maiuscole. E così nei
prossimi capitoli esamineremo anzitutto alcuni dei motivi per cui
l’immagine interna così spesso fuorvia gli uomini nei loro rapporti con il
mondo esterno. Per prima cosa considereremo i principali fattori che
limitano il loro accesso ai fatti. Sono le censure artificiose, le limitazioni
dei contatti sociali, il tempo relativamente scarso che ogni giorno si può
dedicare a seguire gli affari pubblici, la distorsione prodotta dalla necessità
di comprimere i fatti in messaggi brevissimi, la difficoltà di esprimere un
mondo complicato con un piccolo vocabolario, e infine la paura di
affrontare quei fatti che sembrerebbero minacciare il consueto svolgimento
della vita degli individui.
L’analisi passerà poi da questi limiti più o meno esterni al problema di
43
come questo rigagnolo di messaggi provenienti dall’esterno venga
influenzato dalle immagini riposte nella mente, dai preconcetti e dai
pregiudizi che interpretano, completano e a loro volta fortemente
indirizzano il movimento della nostra attenzione e la nostra stessa visione.
Di qui procederà a esaminare in che modo i limitati messaggi provenienti
dall’esterno, e organizzati in uno schema di stereotipi, si identifichino nel
singolo individuo con quelli che egli sente e immagina essere i suoi
interessi. Nelle parti successivi esamineremo in che modo le opinioni si
cristallizzino in quella che si è soliti chiamare l’Opinione Pubblica, e come
si formi una Volontà Nazionale, una Mente Collettiva, un Fine Sociale, o
come si preferisce chiamarli.
Le prime cinque parti costituiscono la sezione descrittiva del libro.
Segue quindi un’analisi della teoria democratica tradizionale dell’opinione
pubblica. Il nocciolo della mia tesi è che la democrazia, nella sua forma
originaria, non abbia mai seriamente affrontato il problema derivante dalla
non automatica corrispondenza delle immagini, che gli individui hanno
nella loro mente, alla realtà del mondo esterno. E poi, dal momento che la
teoria democratica è stata sottoposta a critiche da parte socialista, segue un
esame delle più moderne e coerenti di queste critiche, cioè di quelle mosse
dai socialisti corporativi inglesi. Il mio intento è di accertare se questi
riformatori abbiano presenti le principali difficoltà dell’opinione pubblica.
Sono arrivato alla conclusione che essi le ignorano al pari dei primi
democratici, perché anch’essi sostengono – e in una civiltà molto più
complicata – che in qualche misterioso modo esiste nei cuori degli uomini
una conoscenza del mondo che sta al di là della loro portata diretta.
La mia tesi è che il governo rappresentativo, tanto nella sfera che
solitamente vien detta politica che in quella dell’economia, non può
funzionare bene, quale che sia la base del sistema elettorale, se non c’è
un’organizzazione indipendente di esperti che renda comprensibili i fatti
non visti a quelli che devono prendere le decisioni. Sostengo perciò che
solo la reale accettazione del principio, che la rappresentanza personale
dev’essere integrata dalla rappresentazione dei fatti non visti,
permetterebbe un decentramento soddisfacente, che ci consentirebbe di
liberarci dall’intollerabile e inefficace funzione secondo cui ciascuno di
noi deve farsi un’opinione da competente su tutti gli affari pubblici.
Sostengo inoltre che il problema della stampa resta confuso perché sia i
suoi critici che i suoi apologeti pretendono che sia la stampa stessa a dar
corpo a questa finzione, pretendono che essa compensi tutto ciò che non
era stato previsto dalla teoria democratica; e affermo che i lettori
pretendono che questo miracolo si compia senza spesa o fatica da parte
44
loro. I giornali vengono considerati dai democratici come la panacea dei
loro difetti, mentre l’analisi della natura delle notizie e della base
economica del giornalismo sembrano dimostrare che i giornali
necessariamente e inevitabilmente riflettono – e perciò, in maggiore o
minor misura, intensificano – i difetti dell’organizzazione della pubblica
opinione. La mia conclusione è che le opinioni pubbliche debbano essere
organizzate per la stampa, se si vuole che siano sensate, e non dalla
stampa, come avviene oggi. Vedo questa organizzazione in primo luogo
come il compito di una scienza politica che abbia conquistato il suo giusto
posto di chiarificatrice dei dati su cui si dovranno basare le decisioni reali,
invece che di apologeta, critica o cronista delle decisioni già prese.
Cercherò di dimostrare che le perplessità del governo e del mondo
economico concorrono a dare alla scienza politica questa grande
possibilità di arricchirsi e di servire il pubblico. E naturalmente spero che
queste pagine aiutino almeno qualcuno a comprendere questa possibilità
con maggiore chiarezza e perciò a perseguirla con maggiore
consapevolezza.
Sant’Ambrogio, L’Esamerone ossia dell’origine e natura delle cose (Sei, Torino
1937, trad. di E. Pasteris, pp. 44-6), L, 6, citato in H. O. Taylor, The Medieval Mind,
Macmillan, New York 1919, I, p. 73.
2 W. E. H. Lecky, History of the rise and influence of the spirit of rationalism in
Europe, Longmans, Green and Co., New York-London 1914, I, pp. 276-8.
3 Ibid.
1 L. Strachey, La regina Vittoria, trad. di S. Caramella, Mondadori, Milano 1930, pp.
40-50; ed. or. Queen Victoria, Harcourt, Brace and Co., New York 1921, p. 72.
2 J. de Pierrefeu, G. Q. G. Secteur 1. Trois ans au Grand Quartier Général par le
rédacteur du «Communiqué», L’Édition française illustrée, Paris 1920, pp. 94-5.
1 Cfr. la parte V.
2 Cfr. S. Lewis, Main Street, Harcourt, Brace, and Howe, New York 1920; trad. it.
La via principale, Rizzoli, Milano 1957.
3 Pierrefeu, G.Q.G. Secteur 1 cit., p. 99.
4 W. James, Principles of Psychology, H. Holt and Co., New York 1918, III, p. 638;
trad. it. Principii di psicologia, Società Editrice Libraria, Milano 1901.
1 G. K. Chesterton, The Mad Hatter and the Sane Householder, in «Vanity Fair»,
gennaio 1921, p. 54.
1 Cfr. G. Wallas, Our Social Heritage, Yale University Press, New Haven (Conn.)
1921, pp. 77 sgg.
2 E. J. Kempf, Psychopathology, C. V. Mosby, St. Louis 1920, p. 116.
3 Ibid., p. 151.
1
45
II.
Accessi al mondo esterno
46
II.
La censura e la segretezza
1.
L’immagine di un generale che presiede una conferenza-stampa
nell’ora più terribile di una delle grandi battaglie della storia sembra più
una scena de Il soldato di cioccolata che un episodio vero. Eppure
l’ufficiale che redigeva i comunicati francesi ci fa sapere che queste
conferenze rientravano nella normale condotta della guerra; che nel
momento peggiore di Verdun il generale Joffre e il suo Stato maggiore si
riunirono per discutere sui sostantivi, gli aggettivi e i verbi da stamparsi
nei giornali la mattina seguente.
Il comunicato serale del 23 (febbraio 1916) – dice Pierrefeu1 – fu redatto in
un’atmosfera drammatica. Berthelot, della segreteria del Primo Ministro, aveva
appena telefonato per ordine di questi chiedendo al generale Pellé di rendere più
forte il comunicato e di sottolineare la portata dell’attacco nemico. Occorreva
preparare il pubblico al peggio per il caso che la faccenda si fosse risolta in una
catastrofe. Questa sua preoccupazione dimostrava chiaramente che il Governo non
aveva trovato motivo di fiducia né al Quartier generale né al ministero della Guerra.
Mentre Berthelot parlava, il generale Pellé prendeva appunti. Mi passò il foglio su
cui aveva scritto le volontà del governo insieme all’ordine del giorno emanato dal
generale von Deimling, e trovato addosso ad alcuni prigionieri, in cui si affermava
che l’attacco era l’offensiva suprema per conseguire la pace. Tutto ciò doveva
abilmente dimostrare che la Germania si era impegnata in uno sforzo gigantesco, in
uno sforzo senza precedenti, e che dal suo successo si riprometteva la fine della
guerra. Il senso del documento era che nessuno avrebbe dovuto sorprendersi di una
nostra ritirata. Mezz’ora dopo, quando scesi con il mio testo, trovai riuniti
nell’ufficio del colonnello Claudel, che però non era presente, Pellé, il generale
Janin, il colonnello Dupont e il tenente colonnello Renouard. Temendo che non
sarei riuscito a dare l’impressione desiderata, il generale Pellé aveva preparato
personalmente una bozza di comunicato. Lessi quello che avevo scritto. Lo si
giudicò troppo moderato. Quello di Pellé, d’altro canto, sembrò troppo allarmante.
Avevo omesso di proposito l’ordine del giorno di von Deimling. Inserirlo nel
comunicato avrebbe significato rompere il cliché a cui il pubblico era abituato,
trasformarlo in una sorta di supplica. Sarebbe stato come dire: «In che modo credete
che possiamo resistere?».
C’era da temere che il pubblico si sarebbe disorientato per questo cambiamento
di tono e avrebbe creduto che tutto fosse perduto. Esposi le mie ragioni e suggerii di
47
dare ai giornali il testo di von Deimling come nota separata.
Poiché le opinioni non concordavano, il generale Pellé andò a chiamare il
generale de Castelnau perché prendesse la decisione definitiva. Il generale arrivò
sorridente, calmo e di buon umore, disse qualche piacevolezza su questa nuova
specie di consiglio letterario di guerra, e diede un’occhiata ai testi. Scelse il più
semplice, rafforzò la prima fase, inserì le parole «come era stato previsto», che
appaiono sempre rassicuranti, e si oppose recisamente all’inserimento dell’ordine
del giorno di von Deimling; ma approvò l’idea di trasmetterlo alla stampa come nota
speciale.
Quella sera il generale Joffre lesse attentamente il comunicato e lo
approvò.
Nel giro di poche ore quelle due o trecento parole sarebbero state lette
in tutto il mondo. Avrebbero dipinto un quadro di ciò che stava accadendo
sui pendii di Verdun, e di fronte a questo quadro la gente avrebbe provato
sollievo o disperazione. Si doveva infondere speranza nel bottegaio di
Brest, nel contadino della Lorena, nel deputato di palazzo Borbone, nel
giornalista di Amsterdam o di Minneapolis, e nello stesso tempo si doveva
prepararli ad accettare l’eventuale sconfitta senza cedere al panico. Perciò
si dice loro che la perdita di terreno non è una sorpresa per il comando
francese. Li si induce a considerare la cosa come grave, ma non strana. Di
fatto, però, lo Stato maggiore francese non era del tutto preparato
all’offensiva tedesca. Non si erano scavate trincee di rinforzo, non si erano
costruite strade d’emergenza, mancava il filo spinato, ma una simile
ammissione avrebbe suscitato nella mente dei civili immagini capaci di
mutare in disastro una sconfitta. L’Alto comando poteva dolersi della cosa,
e tuttavia riprendersi; invece la popolazione della Francia e dei paesi
alleati, piena di incertezze e priva dell’unicità d’intenti del militare di
carriera, sapendo tutta la verità, forse avrebbe perduto di vista la guerra per
abbandonarsi a polemiche sulla competenza degli ufficiali, invece di
lasciare che il pubblico reagisse sulla base di tutti i dati che erano a
conoscenza dei generali, le autorità presentavano solo certi fatti e anche
questi solo nel modo più adatto a rafforzare lo spirito pubblico.
In questo caso gli uomini che prepararono lo pseudo-ambiente
sapevano com’era quello reale, ma qualche giorno dopo avvenne un fatto
di cui lo stesso Stato maggiore francese non era a conoscenza. I tedeschi
comunicarono2 che il pomeriggio del giorno precedente avevano preso, in
seguito a un assalto, Fort de Douaumont. Al Quartier Generale francese di
Chantilly nessuno riuscì a capire questa notizia, infatti la mattina del 25,
dopo il combattimento del XX Corpo, la battaglia aveva preso una piega
favorevole. Nel frattempo il comunicato tedesco aveva fatto il giro del
48
mondo e i francesi dovevano pur dichiarare qualcosa, perciò il Quartier
Generale fornì una spiegazione. «Data la totale ignoranza di Chantilly
circa le modalità dell’attacco, costruimmo, nel comunicato serale del 26,
un piano dell’attacco che certamente aveva mille probabilità contro una
d’esser vero». Il comunicato di questa battaglia immaginaria suonava così:
È in corso un arduo combattimento intorno al Fort de Douaumont, un posto
avanzato del primitivo sistema di difesa di Verdun. La posizione conquistata questa
mattina dal nemico, dopo vari assalti infruttuosi che gli sono costati gravissime
perdite, è stata di nuovo raggiunta e sorpassata dalle nostre truppe, che il nemico
non è riuscito a respingere.
Ciò che realmente era accaduto differiva sia dalla versione francese sia
da quella tedesca. Durante un avvicendamento di truppe in prima linea, la
posizione era stata in qualche modo dimenticata nell’incrociarsi degli
ordini. Solo un comandante di batteria e pochi uomini rimasero nel forte.
Alcuni soldati tedeschi, vedendo la porta aperta, erano entrati strisciando
nel forte, ed avevano fatto prigionieri tutti gli occupanti. Poco dopo i
francesi, che stavano sui fianchi della collina, rimasero esterrefatti nel
vedersi presi di mira dal forte.
A Douaumont non v’era stata alcuna battaglia, né v’erano state perdite
e le truppe francesi non l’avevano oltrepassato, come il comunicato pareva
dire. Le posizioni erano più avanzate da ambedue i lati, certamente, ma il
forte era nelle mani del nemico. Eppure tutti credettero di capire dal
comunicato che il forte fosse semiaccerchiato. Le parole non lo dicevano
esplicitamente, ma «la stampa, come sempre, ha affrettato il passo». I
commentatori militari conclusero che i tedeschi sarebbero stati costretti
presto ad arrendersi. Nel giro di pochi giorni cominciarono a domandarsi
perché mai la guarnigione, dal momento che era a corto di cibo, non si
fosse ancora arresa. «Si dovette chiedergli, tramite l’ufficio stampa, di
lasciar cadere il tema dell’accerchiamento»3.
2.
Il redattore del comunicato francese racconta che, prolungandosi la
battaglia, lui e i suoi colleghi si accinsero a neutralizzare l’ostinazione dei
tedeschi insistendo continuamente sulle loro terribili perdite. È necessario
ricordare che a quel punto, e anzi fin verso la fine del 1917, l’orientamento
ortodosso di tutti i popoli alleati era che la guerra sarebbe stata decisa per
«logorio». Nessuno credeva a una guerra di movimento. Si sosteneva che
la strategia, o la diplomazia, non contavano; si trattava semplicemente di
49
ammazzare tedeschi. Il pubblico in genere più o meno credeva al dogma,
ma si doveva continuamente ricordarglielo di fronte agli spettacolari
successi dei tedeschi.
Quasi non passava giorno che il comunicato […] non attribuisse ai tedeschi, con
qualche parvenza di verosimiglianza, perdite gravi, estremamente gravi, e non
parlasse di sacrifici cruenti, mucchi di cadaveri, ecatombi. Analogamente l’agenzia
telegrafica usava regolarmente le statistiche dell’Ufficio informazioni di Verdun, il
cui capo, maggiore Cointet, aveva inventato un metodo per calcolare le perdite
tedesche che ovviamente dava meravigliosi risultati. Ogni quindici giorni le cifre
aumentavano di un centinaio di migliaia, o giù di lì. Questi 300 000, 400 000, 500
000 caduti esibiti, suddivisi in perdite giornaliere, settimanali, mensili, ripetuti in
tutti i modi, creavano un effetto strabiliante. Le nostre formule variavano poco:
«Secondo i prigionieri, le perdite tedesche nel corso dell’attacco sono state
considerevoli»; «è dimostrato che le perdite»; «il nemico stremato dalle perdite non
ha rinnovato l’attacco» formule, successivamente abbandonate perché troppo logore,
venivano usate ogni giorno: «Sotto il fuoco della nostra artiglieria e delle nostre
mitragliatrici». La ripetizione costante impressionava i neutrali e la stessa Germania,
e contribuiva a creare uno sfondo sanguinoso nonostante le smentite da Nauen
(l’agenzia telegrafica tedesca), che cercò invano di distruggere l’effetto nocivo di
questa perpetua ripetizione1.
La tesi che il comando francese intendeva far valere pubblicamente,
attraverso questi dispacci, veniva formulata come segue per l’orientamento
dei censori:
Questa offensiva impegna le forze attive dei nostri avversari, il cui potenziale
umano sta diminuendo. Abbiamo appreso che la classe del 1916 è già al fronte.
Resterà la classe del 1917, già in corso di mobilitazione, e le risorse della terza
categoria (uomini al di sopra dei 45 anni, o convalescenti). Tra poche settimane le
forze tedesche, esaurite dallo sforzo, si troveranno di fronte a tutte le forze della
coalizione (dieci milioni contro sette milioni)2.
Secondo de Pierrefeu, il comando francese si era persuaso della verità
della cosa. «Per un’incredibile aberrazione mentale, si vedeva solo il
logorìo del nemico; sembrava che le nostre forze non fossero soggette a
logorio. Il generale Nivelle condivideva queste idee. Ne vedemmo i
risultati nel 1917».
Ormai chiamiamo tutto questo propaganda. Un gruppo di persone, in
grado di impedire il libero accesso ai fatti, ne manipolano la notizia in
vista di un loro fine. Che il fine in questo caso fosse patriottico non inficia
la validità della considerazione. Usavano il loro potere affinché il pubblico
dei paesi alleati vedesse le cose come essi desideravano che fossero viste.
Le cifre delle perdite del maggiore Cointet, che venivano diffuse in tutto il
50
mondo, sono dello stesso genere. Con esse si intendeva provocare un
particolare tipo di deduzione, e cioè che la guerra di logoramento stava
procedendo in modo favorevole ai francesi. Ma la deduzione non viene
tratta formalmente nell’argomentazione. Deriva quasi automaticamente
dalla creazione di un quadro mentale di teorie interminabili di tedeschi
massacrati sulle colline presso Verdun. Mettendo al centro del quadro i
caduti tedeschi, e omettendo di menzionare i caduti francesi, si costruiva
un panorama assai particolare della battaglia. Era un panorama inteso a
neutralizzare gli effetti delle conquiste territoriali tedesche e l’impressione
di potenza creata dalla persistenza dell’offensiva. Era anche un panorama
che tendeva a far accettare al pubblico la demoralizzante strategia
difensiva a cui gli eserciti alleati erano costretti. Infatti il pubblico,
avvezzo all’idea che la guerra è fatta di grandi movimenti strategici,
attacchi laterali, accerchiamenti e drammatiche capitolazioni, doveva
gradualmente dimenticare questo quadro per sostituirvi la terribile idea che
la guerra sarebbe stata vinta opponendo vite ad altre vite. Grazie al
controllo esercitato su tutte le notizie dal fronte, lo Stato maggiore
generale sostituiva una versione dei fatti coerente con questa strategia.
Lo Stato maggiore di un esercito in campo si trova in una posizione che
gli consente, entro limiti piuttosto ampi, di controllare ciò che il pubblico
percepirà. Controlla la selezione dei corrispondenti che vanno al fronte,
controlla i loro movimenti al fronte, legge e censura i loro messaggi dal
fronte e controlla le linee telegrafiche. Il Governo che sta dietro
all’esercito, accresce ulteriormente il controllo, regolando cablogrammi e
passaporti, poste, dogane e posti di blocco. Lo rafforza coi poteri legali
esercitati sugli editori, sulle riunioni pubbliche, e anche attraverso il
servizio segreto, ma nel caso di un esercito il controllo è lungi dall’essere
perfetto. C’è sempre il comunicato del nemico, che con la radiotelegrafia
non può essere nascosto ai neutrali. Soprattutto ci sono le indiscrezioni dei
soldati, che rifluiscono dal fronte e si diffondono rapidamente quando sono
in licenza. Un esercito è poco maneggevole. Ed ecco perché la censura
navale e diplomatica è quasi sempre molto più completa. Meno persone
sanno che cosa sta succedendo, più facilmente le loro azioni vengono
controllate.
3.
Senza qualche forma di censura la propaganda nel senso stretto della
parola è impossibile. Per poter esercitare la propaganda dev’esserci
qualche barriera tra il pubblico e l’avvenimento. L’accesso all’ambiente
51
reale deve venir limitato, prima che qualcuno possa creare uno pseudoambiente che gli sembri adatto od opportuno. Infatti, mentre coloro che
hanno diretto accesso al teatro degli avvenimenti possono fraintendere
quello che vedono, nessun altro può decidere in che modo lo
fraintenderanno, sempreché non sia in grado di decidere dove guarderanno
e che cosa. La censura militare è la forma più semplice di barriera, ma non
è affatto la più importante, perché si sa che esiste e perciò in una certa
misura è accettata e scontata.
In momenti diversi e in materie diverse alcune persone impongono e
altre accettano una particolare regola di segretezza. La frontiera che
delimita ciò che viene celato perché la pubblicazione non è, come si suol
dire, «compatibile con l’interesse pubblico», sfuma gradualmente in ciò
che viene celato perché si ritiene che non riguardi il pubblico. La nozione
di ciò che costituisce un affare privato della persona è elastica. Così la
consistenza del patrimonio di un individuo viene considerata un affare
privato, e la legge relativa all’imposta sul reddito provvede con cura a
mantenerla il più possibile privata. La vendita di un pezzo di terreno non è
privata, ma il prezzo può esserlo. Gli stipendi in genere vengono
considerati più privati dei salari, e i redditi più privati delle eredità. Alla
solvibilità di un individuo viene data solo una pubblicità limitata. I profitti
delle grandi società sono più pubblici di quelli delle piccole. Certe specie
di conservazione, tra marito e moglie, avvocato e cliente, medico e
paziente, prete e comunicando, sono privilegiate. Le riunioni dei
consiglieri d’amministrazione sono, in genere, private. Così molte riunioni
politiche. La maggior parte di ciò che viene detto a una riunione di
Gabinetto, o da un ambasciatore al ministro degli Esteri, o in colloqui
privati, o a pranzo, è privato. Molte persone considerano privato il
contratto tra datore di lavoro e dipendente. Una volta gli affari di tutte le
aziende erano ritenuti privati quanto lo è oggi la fede religiosa del singolo.
Prima ancora c’è stato un tempo in cui la fede veniva considerata un fatto
pubblico quanto il colore degli occhi. D’altro canto le malattie infettive
erano, un tempo, altrettanto private che i processi digestivi. La storia del
concetto di segretezza, sarebbe una storia divertente. Talvolta i modi di
concepirla sono in violento contrasto, come quando i bolscevichi
pubblicarono i trattati segreti, o quando Hughes investigò sulle compagnie
di assicurazione, o quando i fatti scandalosi di qualcuno passano dalle
pagine della cronaca cittadina alle prime pagine dei giornali di Hearst.
Buone o cattive che siano le ragioni a favore della segretezza, le
barriere esistono. Nel campo di quelli che vengono definiti gli affari
pubblici si insiste sul riserbo. Perciò spesso è molto illuminante chiedersi
52
da dove si sono derivati i fatti su cui ci si forma le proprie opinioni. Chi
realmente vide, udì, sentì, contò, nominò la cosa su cui si ha un’opinione?
Era colui che ce l’ha detto, o colui che glielo ha detto, o qualcuno ancora
più remoto? E quanto gli fu consentito vedere? Quando ci informa che la
Francia pensa questo o quello, quale parte della Francia ha potuto
osservare? In che modo poté osservarla? Dov’era quando l’osservava? Con
quali francesi gli fu consentito di parlare, quali giornali ha letto e dove
appresero questi ultimi ciò che affermano? Ci possiamo porre queste
domande, ma di rado siamo in grado di dare una risposta. Tuttavia servono
a ricordarci la distanza che spesso separa la nostra opinione pubblica
dall’intervento cui si riferisce. E il ricordo è di per sé una protezione.
53
III.
Il contatto e la possibilità
1.
Mentre la censura e la segretezza bloccano molte notizie alla fonte, una
massa ancor più grande di dati non arriva alla generalità del pubblico, o vi
arriva solo lentamente. Infatti esistono limiti molto precisi alla circolazione
delle idee.
Se si considera la propaganda del governo durante la guerra ci si può
fare un’idea approssimativa dello sforzo che occorre per raggiungere
«tutti». Tenendo presente che la guerra era già in corso da due anni e
mezzo quando l’America vi entrò, e che erano stati diffusi milioni e
milioni di pagine stampate ed erano stati tenuti innumerevoli discorsi,
soffermiamoci sul resoconto che George Creel fa della sua battaglia «per
le menti degli uomini, per la conquista delle loro convinzioni» affinché «il
vangelo dell’americanismo possa essere portato in ogni angolo del
globo»1.
Creel dovette mettere in piedi un’organizzazione, la quale comprendeva
una sezione notizie che diramò, ci dice, più di seimila veline, e dovette
reperire 75 000 Four Minute Men2 che tennero almeno 755 190 discorsi a
un pubblico che superò i 300 000 000 di persone. Fu affidato ai Boy Scouts
il compito di consegnare copie commentate dei discorsi del presidente
Wilson alle famiglie americane. Periodici quindicinali furono inviati a 600
000 insegnanti. Vennero fornite 200 000 lastre per conferenze con
proiezioni. Vennero prodotti 1438 disegni per manifesti, locandine, avvisi
sui quotidiani, vignette, bolli e distintivi. Per la distribuzione ci si
appoggiò alle Camere di Commercio, alle chiese, alle associazioni, alle
scuole. E tuttavia lo sforzo di Creel, della cui ampiezza le cose che ho
menzionate non possono davvero dare un’idea, non comprendeva la
stupenda organizzazione di McAdoo per i prestiti di guerra, né la
vastissima propaganda di Hoover contro lo spreco alimentare, né le
campagne della Croce Rossa, dell’Ymca, dell’Esercito della Salvezza, dei
Cavalieri di Colombo, del Comitato Ebraico d’Assistenza, per non parlare
dell’attività indipendente di società patriottiche come la Lega per la Difesa
della Pace, la Lega dell’Associazione delle Nazioni Libere, la Lega per la
54
Sicurezza Nazionale, e nemmeno l’attività degli uffici propaganda degli
alleati e delle Nazioni oppresse.
Si tratta probabilmente del più vasto e intenso sforzo mai fatto per
trasmettere rapidamente a tutta la popolazione di un paese un complesso di
idee in modo abbastanza uniforme. Il proselitismo di vecchio stampo
procedeva più lentamente, forse più sicuramente, ma non in modo così
generale. Ma se occorrono misure talmente estreme per giungere a tutti in
tempo di crisi, quanto sgombre sono in realtà le normali vie che
conducono alle menti degli uomini? Il governo cercava – e per tutta la
durata della guerra ci riuscì, credo, in larghissima misura – di creare
qualcosa che si potrebbe quasi chiamare una sola pubblica opinione in
tutta l’America. Ma si pensi al lavoro accanito, alle complicate trovate, al
denaro e al personale che si resero necessari. In tempo di pace non c’è
nulla di simile, ed anzi ci sono interi settori, vastissimi gruppi, ghetti, isole
e classi che hanno solo un vago sentore di ciò che succede.
La loro vita scorre come su binari, sono rinchiusi nei propri affari,
esclusi dagli avvenimenti più grandi, incontrano poche persone
appartenenti a strati diversi dal loro, leggono poco. I viaggi e i commerci,
la posta, il telegrafo e la radio, le ferrovie, le autostrade, le navi, le
automobili e nel prossimo futuro gli aeroplani, sono certamente di
importanza primaria per la circolazione delle idee. Ognuno di questi mezzi
influisce in maniera molto intricata sull’offerta e sulla qualità delle notizie
e delle opinioni. Ciascuno è a sua volta condizionato da fatti tecnici,
economici, politici. Ogniqualvolta un governo rende più facile il rilascio e
il controllo dei passaporti, o le ispezioni doganali, ogniqualvolta si apre
una nuova ferrovia o un nuovo porto, o si inaugura una nuova linea
marittima, ogniqualvolta le tariffe salgono o scendono, la posta viaggia più
rapidamente o più lentamente, i cablogrammi non vengono censurati e
scendono di prezzo, si costruisce, o si allarga, o si migliora un’autostrada,
la circolazione delle idee ne resta influenzata. I livelli delle tariffe doganali
e le sovvenzioni influiscono sull’orientamento dell’impresa commerciale,
e perciò sulla natura dei contatti tra gli uomini. E così può accadere, come
ad esempio è accaduto nel caso di Salem, nel Massachusetts, che un
mutamento nell’arte delle costruzioni navali trasformi un’intera città da
centro di rapporti internazionali in graziosa cittadina di provincia. Non
sono necessariamente tutti buoni gli effetti immediati di un trasporto più
rapido. Sarebbe difficile dire, ad esempio, che il sistema ferroviario
francese, tutto gravitante su Parigi, sia stato soltanto una fortuna per i
francesi.
È certamente vero che i problemi derivanti dai mezzi di comunicazione
55
sono della massima importanza, e che uno degli aspetti più costruttivi del
programma della Società delle Nazioni è stato lo studio dei trasporti
ferroviari e degli accessi al mare. L’accaparramento dei cavi sottomarini,
dei porti, delle stazioni di rifornimento di benzina, dei varchi montani, dei
canali, degli stretti, delle vie fluviali, dei nodi ferroviari, dei luoghi di
mercato è molto più importante dell’arricchimento di un gruppo di uomini
d’affari, o del prestigio di un governo. Esso costituisce una barriera allo
scambio di notizie e di opinioni, ma il monopolio non è la sola barriera. Il
costo e la disponibilità di mezzi di trasporto sono barriere ancora più
grandi, perché se il costo del viaggiare o del commerciare è proibitivo, se
la domanda di mezzi di trasporto eccede l’offerta, le barriere esistono
anche in assenza del monopolio.
2.
L’entità del reddito di un individuo ha notevoli conseguenze sulle sue
possibilità di accesso al mondo che sta al di là del suo vicinato. Con il
denaro può superare quasi ogni tangibile ostacolo alla comunicazione, può
viaggiare, comprare libri e periodici ed estendere la propria attenzione a
quasi tutti i fatti noti del mondo. Il reddito dell’individuo e il reddito della
collettività determinano l’entità del flusso di comunicazione possibile. Ma
le idee degli uomini determinano come si spenderà quel reddito, e ciò a sua
volta influisce alla lunga sulla misura del reddito di cui disporranno. Così
vi sono anche delle limitazioni che non sono meno reali per il fatto di
essere spesso autoimposte e frutto di debolezze.
Ci sono settori del popolo sovrano che impiegano gran parte del loro
tempo libero e dei risparmi andando in automobile e confrontando le
automobili, giocando a bridge e discutendo poi le partite, andando al
cinema o a vedere drammoni, parlando sempre con le stesse persone delle
stesse vecchie cose, solo con varianti minime. Non si può dire che essi
davvero soffrano a causa della censura, o del segreto o dell’alto costo o
della difficoltà della comunicazione. Soffrono di anemia, di mancanza di
appetito e di curiosità per la scena umana. Il loro non è un problema di
accesso al mondo esterno; mondi interessanti attendono di venir esplorati
da loro, ma loro non vi entrano.
Si muovono, come se stessero al guinzaglio, entro un raggio
prestabilito di conoscenze e secondo le regole e il vangelo del loro
ambiente sociale. Tra gli uomini la cerchia della conversazione d’affari e
al club e nello scompartimento per fumatori è più ampia dell’ambiente al
quale appartengono. Tra le donne l’ambiente sociale e la cerchia della
56
conversazione sono spesso quasi identici. È nell’ambiente sociale che le
idee derivate dalla lettura e dalle conferenze e dalla conversazione
convergono, vengono classificate, accettate, respinte, giudicate e
sanzionate. È là, infine, che viene deciso ad ogni fase di una discussione
quali autorità e quali fonti di informazione sono ammissibili, e quali no.
Il nostro ambiente sociale si compone di coloro che nella frase «la
gente dice» costituiscono la gente; sono la gente la cui approvazione ha per
noi l’importanza più intima. Nelle grandi città, tra gli uomini e le donne di
vasti interessi e forniti dei mezzi per spostarsi, l’ambiente sociale non è
così rigidamente definito; ma anche nelle grandi città ci sono quartieri e
vie che racchiudono ambienti sociali autosufficienti. Nelle piccole
comunità può esserci una circolazione più libera, un cameratismo più
genuino da dopo colazione fino a prima di cena. Tuttavia sono poche le
persone che non sanno qual è l’ambiente cui appartengono, e quale non lo
è.
Di solito, il segno distintivo di un ambiente sociale è la presunzione che
i figli possono sposarsi tra di loro. Sposarsi al di fuori dell’ambiente
implica, come minimo, un momento di dubbio prima che il fidanzamento
possa venir approvato. Ogni ambiente sociale ha un’immagine piuttosto
chiara del posto che occupa nella gerarchia sociale. Tra ambienti che
stanno allo stesso livello, i rapporti sono facili, gli individui vengono
rapidamente accettati, l’ospitalità è normale e priva di imbarazzo. Ma nei
contatti tra ambienti che sono più «su» e più «giù», c’è sempre
un’esitazione reciproca, un lieve disagio, e la consapevolezza della
differenza. Naturalmente in una società come quella americana gli
individui si spostano con una certa facilità da un ambiente all’altro,
specialmente dove non c’è la barriera razziale e dove la posizione
economica è soggetta a rapidi mutamenti.
La posizione economica, tuttavia, non si misura dall’ammontare del
reddito. Infatti, almeno nella prima generazione, non è il reddito che
determina la posizione sociale, ma il tipo di lavoro che uno fa, e può
volerci una o due generazioni prima che questo scompaia dalla tradizione
familiare. Così l’attività bancaria, quella legale, la medicina, i giornali, la
chiesa, il commercio di qualità, l’attività di Borsa, l’industria hanno un
valore sociale diverso da quello dell’attività del venditore, del capo
reparto, del tecnico, dell’infermiera, della maestra, del bottegaio; e queste
attività, a loro volta, vengono valutate diversamente da quelle
dell’idraulico, dell’autista, della sarta, del subappaltatore o della
stenografa, così come queste, a loro volta, hanno un posto diverso da
quelle del maggiordomo, della cameriera, dell’addetto alla proiezione
57
cinematografica, o del macchinista di treno. E tuttavia le entrate finanziarie
non coincidono necessariamente con tali valutazioni.
3.
Quali che siano le prove di ammissione, l’ambiente sociale, una volta
formatosi, non è una mera classe economica, ma qualcosa che assomiglia
di più a un clan biologico. L’appartenenza è connessa intimamente
all’amore, al matrimonio e ai figli, o, per parlare più esattamente, agli
atteggiamenti e ai desideri che vi sono implicati. Perciò nell’ambiente
sociale le opinioni si imbattono nei canoni della Tradizione Familiare,
della Rispettabilità, del Decoro, della Dignità, del Gusto e della Forma, i
quali compongono l’immagine che l’ambiente sociale ha di sé,
un’immagine inculcata con assiduità nei figli. In questo quadro viene dato
tacitamente ampio spazio a una versione autorizzata di ciò che ogni
ambiente sociale è invitato ad accettare nel suo intimo come posizione
sociale degli altri. I più volgari ambiscono a un’espressione esteriore della
deferenza dovuta, gli altri hanno la sensibilità e la delicatezza di tacere
sulla propria consapevolezza che una tale deferenza esiste in modo
invisibile. Ma questa consapevolezza, diventando manifesta quando c’è un
matrimonio, una guerra, o una sollevazione sociale, è il nesso di un grande
fascio di disposizioni, classificata da Trotter1 sotto la definizione generale
di istinto del gregge.
All’interno di ciascun ambiente sociale ci sono degli àuguri come i van
der Luydens e la signora Manson Mingott dell’Età dell’innocenza2, che
vengono riconosciuti custodi e interpreti del suo modello sociale. Sei
arrivato, dicono, se i van der Luydens ti accolgono; gli inviti ai loro
ricevimenti sono il segno visibile dell’essere arrivati e del rango. Le
elezioni ai club universitari, graduate con cura, e le classificazioni
universalmente accettate, determinano chi conti nell’università. I leader
sociali, gravati della responsabilità eugenetica definitiva, sono
straordinariamente sensibili. Non solo debbono stare attentissimi a quanto
costituisce l’omogeneità del loro ambiente, ma debbono maturare in se
stessi la capacità di sapere che cosa stanno facendo gli altri ambienti
sociali. Agiscono come una specie di ministero degli Esteri. Mentre la
maggior parte dei membri di un ambiente vive tranquilla e soddisfatta
all’interno del proprio ambiente, considerandolo a tutti gli effetti pratici
come il mondo, i leader sociali debbono abbinare a un’intima conoscenza
dell’anatomia del proprio ambiente una coscienza persistente del suo posto
nella gerarchia degli ambienti.
58
La gerarchia, in realtà, è tenuta assieme dai leader sociali; a ciascun
livello c’è qualcosa che si potrebbe quasi chiamare l’ambiente sociale dei
leader sociali. Ma verticalmente il vero cemento della società, nella misura
in cui questa è davvero tenuta assieme dai contatti sociali, è costituito da
quelle persone eccezionali, spesso sospette, le quali, come Julius Beaufort
e Ellen Olenska nell’Età dell’innocenza, circolano tra gli ambienti. Così si
vengono a stabilire vie personali di comunicazione tra un ambiente e
l’altro, lungo le quali operano le leggi di imitazione di Tarde. Ma per vasti
settori della popolazione queste vie non esistono. Per loro debbono bastare
i racconti autorizzati della vita mondana e i film sull’alta società. Essi
possono elaborare una propria gerarchia sociale, quasi ignorata, come
hanno fatto i neri e «l’elemento straniero» ma tra quella massa assimilata
che sempre si considera la «nazione», esiste, nonostante la grande
separazione degli ambienti, una molteplicità di contatti personali,
attraverso i quali ha luogo una circolazione di convenzioni.
Alcuni ambienti sono collocati in modo da diventare ciò che il
professor Ross ha definito «punti radianti di convenzionalità»3. Così il
superiore sociale probabilmente verrà imitato dall’inferiore sociale; il
detentore di potere viene imitato dai subordinati, il più riuscito dal meno
riuscito, il ricco dal povero, la città dalla campagna. Ma l’imitazione non si
ferma alla frontiera. L’ambiente sociale potente, socialmente superiore,
riuscito, ricco, urbano è fondamentalmente internazionale in tutto
l’emisfero occidentale, e per molti versi Londra è il suo centro. Conta tra i
suoi membri le persone più influenti del mondo, dal momento che
comprende i diplomatici, i finanzieri, i circoli superiori dell’esercito e della
marina, alcuni principi della Chiesa, e alcuni grandi proprietari di giornali,
le loro mogli e madri e figlie, che tengono lo scettro degli inviti. È nello
stesso tempo un grande circolo di conversazione e un vero ambiente
sociale, ma la sua importanza proviene dal fatto che qui finalmente la
distinzione tra affari pubblici e privati praticamente scompare. Gli affari
privati di questo ambiente sono questioni pubbliche e le questioni
pubbliche sono suoi affari privati, spesso suoi affari di famiglia. I parti di
Margot Asquith, come quelli reali, appartengono, come dicono i filosofi,
più o meno alla stessa categoria di conversazione in cui rientrano una
proposta di legge doganale o un dibattito parlamentare.
Vi sono vaste zone dell’attività di governo a cui questo ambiente
sociale non è interessato e, almeno in America, esso ha esercitato solo un
controllo fluttuante sul governo nazionale. Ma il suo potere sul campo
degli affari internazionali è sempre grandissimo, e in tempo di guerra il
suo prestigio cresce enormemente. Ciò è abbastanza naturale, perché
59
questi cosmopoliti hanno col mondo esterno contatti che la maggior parte
della gente non possiede. Hanno pranzato assieme nelle capitali, e il loro
senso dell’onore nazionale non è una mera astrazione; è la concreta
esperienza di venir snobbati o accettati dai loro amici. Al dottor Kennicott
di Gopher Prairie importa assai poco l’opinione di Winston e moltissimo
quella di Ezra Stowbody, ma alla signora Mingott, che ha una figlia
sposata al conte di Swithin, importa moltissimo quando fa visita alla figlia,
o quando ospita Winston stesso. Il dottor Kennicott e la signora Mingott
sono entrambi socialmente sensibili, ma la signora Mingott è sensibile ad
un ambiente sociale che governa il mondo, mentre l’ambiente sociale del
dottor Kennicott governa solo Gopher Prairie. Ma nelle questioni che
toccano le più ampie relazioni della Grande Società4, spesso il dottor
Kennicott si troverà ad avere delle opinioni che ritiene puramente sue,
mentre, di fatto, sono arrivate fino a Gopher Prairie dall’Alta Società,
trasformandosi lungo il passaggio attraverso gli ambienti sociali di
provincia.
4.
Non rientra nella nostra indagine il tentativo di descrivere il tessuto
sociale. Dobbiamo solo tener presente quanto sia importante la parte
giocata dall’ambiente sociale nei nostri contatti spirituali col mondo, come
essa tenda a fissare ciò che è ammissibile, e a determinare come sarà
giudicato. Ciascun ambiente determina più o meno da solo gli affari che
rientrano nella sua immediata competenza, soprattutto determina la
somministrazione specifica del giudizio. Ma il giudizio stesso si forma su
modelli1 che possono venir ereditati dal passato, trasmessi o imitati da altri
ambienti sociali. L’ambiente sociale più alto si compone di coloro che
incarnano la guida della Grande Società. Diversamente da quasi tutti gli
altri ambienti sociali, in cui la più parte delle opinioni sono concrete solo
per quanto riguarda gli affari locali, in questa Altissima Società le grandi
decisioni sulla guerra e sulla pace, sulla strategia sociale e sulla
distribuzione definitiva del potere politico, sono esperienze intime entro il
giro di quelle che, almeno potenzialmente, sono conoscenze personali.
Dato che la posizione e i contatti giocano una parte così grande nel
determinare che cosa si riesce a vedere, sentire, leggere e sperimentare,
nonché che cosa è permesso vedere, sentire, leggere e sapere, non
sorprende che il giudizio morale sia tanto più comune del pensiero
costruttivo. E tuttavia, per pensare in modo veramente efficace, la cosa più
importante è liquidare i giudizi, riacquistare l’occhio innocente, metter
60
ordine nei sentimenti, essere curiosi e di cuore aperto. Dato che la storia
dell’uomo è quella che è, l’opinione politica al livello della Grande Società
richiede una dose di equanimità spersonalizzata che difficilmente si
mantiene per molto tempo. Ci interessiamo degli affari pubblici, ma siamo
immersi nei nostri affari privati. Il tempo e l’attenzione che possiamo
dedicare alla fatica di non accettare ad occhi chiusi le opinioni, sono
limitati, e siamo soggetti a continue interruzioni.
61
IV.
Il tempo e l’attenzione
1.
Naturalmente si può valutare in modo approssimativo solo la quantità
di attenzione che la gente ogni giorno dedica ad informarsi intorno agli
affari pubblici. Però è interessante notare che tre valutazioni, che ho
esaminato, concordano piuttosto bene, benché siano state fatte in epoche
diverse, in luoghi diversi e con metodi diversi1.
Hotchkiss e Franken hanno mandato un questionario a 1761 studenti
universitari, maschi e femmine, di New York, a cui hanno risposto quasi
tutti. Scott ha usato un questionario per 4000 importanti uomini d’affari e
professionisti di Chicago, ottenendo risposte da 2300. Un’aliquota
oscillante tra il 70 e il 75 per cento di coloro che hanno risposto alle due
inchieste riteneva di dedicare un quarto d’ora al giorno alla lettura dei
giornali. Solo il 4 per cento del gruppo di Chicago calcolava di dedicare un
tempo minore, e il 25 per cento calcolava un tempo maggiore. Tra i
newyorkesi un po’ più dell’8 per cento riteneva di leggere i giornali per
meno di un quarto d’ora, e il 17,5 per cento per un tempo più lungo.
Pochissime persone hanno un’idea precisa di cosa sia un quarto d’ora, e
perciò le cifre non vanno prese alla lettera. Inoltre gli uomini d’affari, i
professionisti e gli studenti universitari tendono spesso ad avere una strana
riluttanza ad apparire troppo dediti alla lettura dei giornali, e forse in loro
c’è anche un lieve desiderio di farsi credere rapidi lettori. Tutto quello che
si può correttamente ricavare da queste cifre è che più di tre quarti degli
appartenenti a questi gruppi selezionati stimano piuttosto bassa
l’attenzione che dedicano alle notizie stampate concernenti il mondo
esterno.
Queste valutazioni del tempo sono discretamente confermate da un test
che è un po’ meno soggettivo. Scott ha chiesto ai suoi intervistati di
Chicago quanti giornali leggessero ogni giorno, e ne ricavò che:
il 14 per cento
il 46 per cento
il 21 per cento
leggeva un solo giornale
leggeva due giornali
leggeva tre giornali
62
il 10 per cento
il 3 per cento
il 2 per cento
il 3 per cento
leggeva quattro giornali
leggeva cinque giornali
leggeva sei giornali
leggeva tutti i giornali
(che erano 8 al tempo dell’inchiesta).
I lettori di due e tre giornali sono il 67 per cento, cifra che si avvicina
abbastanza al 71 per cento del gruppo di Scott che ritiene di leggere
quindici minuti al giorno. I lettori onnivori di quattro o più giornali
coincidono approssimativamente con il 25 per cento che ritiene di leggere
più di quindici minuti.
2.
È ancora più difficile valutare come sia distribuito il tempo. Agli
studenti universitari fu chiesto di indicare «i cinque argomenti che vi
interessano di più». Un 25 per cento scarso indicò le «notizie generali», un
15 per cento scarso gli editoriali, quasi il 12 per cento «la politica», un po’
più dell’8 per cento la finanza, e, a neanche due anni dall’armistizio, un
po’ più del 6 per cento le notizie dall’estero, il 3,5 la cronaca locale, circa
il 3 l’attività economica, e lo 0,25 per cento le notizie «sindacali». Alcuni
dissero di essere più interessati allo sport, ai servizi speciali, al teatro, agli
annunci commerciali, ai disegni umoristici, alle recensioni di libri,
all’«esattezza», alla musica, al «tono morale», alla cronaca mondana, alle
brevi, all’arte, ai racconti, al movimento marittimo, alle notizie sulla
scuola, alle notizie d’attualità, alla stampa. Trascurando questo gruppo,
circa il 67,5 per cento indicò come interessanti le notizie e le opinioni
attinenti agli affari pubblici.
Si trattava di un gruppo universitario misto. Le ragazze professavano
un interesse maggiore dei ragazzi per le notizie generali, il teatro, la
musica, l’arte, i racconti, le vignette umoristiche, gli annunci commerciali
e «il tono morale». Dal canto loro i ragazzi si sentivano più attirati dalla
finanza, dallo sport, dalla pagina economica, dall’«esattezza» e dalla
«brevità». Queste discriminazioni corrispondono un po’ troppo agli ideali
di ciò che è perbene e morale, virile e positivo, per non far nascere sospetti
sull’obiettività delle risposte.
Tuttavia sono abbastanza in armonia con le risposte dei professionisti e
degli uomini d’affari di Chicago. Scott chiese loro non quali argomenti li
interessassero di più, ma perché preferissero un giornale ad un altro. Quasi
63
il 71 per cento fondava la propria consapevole preferenza sulla cronaca
locale (17,8%), o politica (15,8%), o finanziaria (11,3%), o estera (9,5%),
o generale (7,2%), o sugli editoriali (9%). L’altro 30 per cento decideva
per ragioni non connesse alla vita pubblica. Andava da uno scarso 7 per
cento, che decideva in virtù del «tono morale», fino a un ventesimo
dell’uno per cento che attribuiva il primo posto all’umorismo.
In che rapporto stanno queste preferenze con lo spazio che i giornali
riservano alle varie materie? Purtroppo su questo punto non esistono dati
per i giornali letti dai gruppi di Chicago e New York all’epoca in cui i
questionari vennero formulati. Abbiamo un’interessante analisi condotta
più di vent’anni fa da Wilcox. Egli studiò centodieci giornali di quattordici
grandi città, e classificò il contenuto di più di novemila colonne.
Fatta una media nazionale, le proporzioni delle materie trattate dai
giornali erano le seguenti:
Per potersi servire di questa tabella per un confronto è necessario
escludere lo spazio dedicato alla pubblicità e ricalcolare le percentuali.
Infatti la pubblicità occupava solo una parte infinitesima della preferenza
consapevole del gruppo di Chicago e del gruppo universitario. Credo sia
lecito ai nostri scopi, perché la stampa pubblica la pubblicità che può
procurarsi1, mentre il resto del giornale si rivolge al gusto dei lettori.
La tabella diventa allora la seguente:
64
In questa tabella riveduta, sommando le voci che possono ritenersi
attinenti agli affari pubblici, vale a dire le notizie belliche, estere, politiche,
altre, economiche e le opinioni, si ha che il 76,5 per cento dello spazio del
giornale era dedicato nel 1900 al 70,6 per cento delle ragioni indicate nel
1916 dagli uomini d’affari di Chicago per preferire un giornale piuttosto
che un altro, e ai cinque argomenti che interessavano di più nel 1920 il
67,5 per cento degli studenti universitari di New York.
Questo sembrerebbe dimostrare che i gusti degli uomini d’affari e degli
studenti universitari delle grandi città corrispondono ancora oggi, più o
meno, ai giudizi medi dei direttori dei giornali delle grandi città di
vent’anni addietro. Da allora la proporzione dei servizi speciali rispetto
alle notizie è indubbiamente aumentata, e sono aumentate anche la tiratura
e le dimensioni dei giornali. Perciò, se oggi si potessero ottenere risposte
precise da gruppi più tipici di quanto non siano gli studenti universitari o i
professionisti e gli uomini d’affari, ci si dovrebbe aspettare di scoprire che
è minore la percentuale di tempo dedicata agli affari pubblici, così come è
più piccola la percentuale di spazio. D’altro canto ci si aspetterebbe di
scoprire che l’uomo medio dedica più di un quarto d’ora al suo giornale, e
che mentre la percentuale di spazio riservata agli affari pubblici è inferiore
a quella di vent’anni fa, l’ammontare effettivo è maggiore.
Non si può pretendere di trarre da queste cifre delle deduzioni
complesse. Esse contribuiscono semplicemente a rendere un poco più
concrete le nostre idee circa lo sforzo che si dedica giorno per giorno
all’acquisizione dei dati che stanno alla base delle nostre opinioni.
Naturalmente i giornali non sono i soli mezzi, ma sono certamente i
65
principali. Le riviste, i discorsi pubblici, i giri di conferenze in provincia,
la chiesa, le riunioni politiche, le riunioni sindacali, i circoli femminili e i
cinegiornali integrano la stampa. Ma calcolando tutto nel modo più
favorevole possibile, il tempo durante il quale siamo ogni giorno
direttamente esposti a informazioni provenienti dal nostro ambiente
invisibile è piccolo.
66
V.
La velocità, le parole e la chiarezza
1.
Il mondo che non vediamo ci viene rappresentato soprattutto con le
parole. Queste parole vengono trasmesse per telegrafo o per radio dai
corrispondenti ai redattori, che le inseriscono nel giornale. Il telegrafo è
costoso, e le sue possibilità di impiego sono spesso limitate. Le notizie
d’agenzia vengono perciò di solito codificate. Così un dispaccio che
suona: «Washington, DC, 1° giugno. Gli Stati Uniti considerano un
incidente chiuso la questione delle navi tedesche confiscate in questo paese
all’inizio delle ostilità» può venir trasmesso per telegrafo nella forma
seguente: «Washing. 1. USA consid incdnt chiuso navi ted confisc qusto
pae inizio ost»1.
Una notizia che dica:
Berlino, 1° giugno. Il cancelliere Wirth, nell’esporre oggi al Reichstag per
sommi capi il programma del governo, ha detto che «la ricostruzione e la
riconciliazione saranno il caposaldo della politica del nuovo governo». Ha aggiunto
che il Gabinetto è deciso a procedere lealmente al disarmo e che il disarmo non sarà
la ragione dell’imposizione di nuove sanzioni da parte degli alleati
può essere trasmessa per cablogramma in questa forma:
Berlino, 1. Cancelliere Wirth oggi Reichstag esponendo sc prog gov detto
ricostruz et riconcil caposaldo pol nuovo gov. Aggiunto Gabinetto è dcs procedere
lealmente disarmo et che dsrm non sarà rag imposiz nuove sanzn parte alleati.
In questa seconda notizia la sostanza, trascelta da un lungo discorso
pronunciato in una lingua straniera, è stata tradotta, codificata e poi
decodificata. Gli operatori che ricevono questi messaggi li trascrivono a
mano a mano che li ricevono, e mi si dice che un buon operatore possa
scrivere quindicimila o anche più parole in un orario di otto ore, con
mezz’ora di intervallo per la colazione e due periodi di riposo di dieci
minuti.
2.
67
Spesso poche parole debbono rappresentare un’intera serie di atti,
pensieri, sentimenti e conseguenze. Leggiamo:
Washington, 23 dic. Una dichiarazione che accusa le autorità militari giapponesi
di atti più «terribili e barbari» di quelli che si dice siano accaduti in Belgio durante
la guerra, è stata oggi formulata qui dalla Commissione coreana, sulla base, ha detto
la commissione, di resoconti autentici avuti dalla Manciuria.
Qui i testimoni oculari, della cui esattezza non si sa nulla, riferiscono
agli estensori di «resoconti autentici»; ed essi a loro volta li trasmettono a
una commissione distante cinquemila miglia. Questa prepara una
dichiarazione, probabilmente troppo lunga per la pubblicazione, dalla
quale un corrispondente ricava una notizia lunga tre pollici e mezzo. Il
significato deve essere ridotto in modo tale da consentire al lettore di
giudicare quanto peso si debba dare alla notizia.
C’è da dubitare che persino un sommo maestro di stile possa ficcare
tutti gli elementi di verità, che una completa imparzialità richiederebbe, in
un resoconto di cento parole su ciò che è accaduto in Corea nel corso di
vari mesi. In verità il linguaggio non è affatto un veicolo perfetto di
significati. Le parole, come la moneta, vengono voltate e rivoltate, sì da
suscitare una serie di immagini oggi, un’altra serie domani. Non c’è alcuna
certezza che la medesima parola susciti nella mente del lettore esattamente
la stessa idea che suscitò in quella del cronista. In teoria, se ogni fatto e
ogni relazione avessero un nome unico, e se tutti fossero d’accordo sui
nomi, sarebbe possibile comunicare senza fraintendimenti. Nelle scienze
esatte si è arrivati abbastanza vicino a questo ideale, ed è in parte per
questa ragione che di tutte le forme di cooperazione mondiale l’indagine
scientifica appare la più efficace.
Le parole di cui gli uomini dispongono sono meno delle idee da
esprimere, e il linguaggio, come disse Jean Paul, è un dizionario di
metafore sbiadite1. Il giornalista che si rivolge a mezzo milione di lettori,
di cui ha solo una vaga immagine, come l’oratore le cui parole vengono
trasmesse a remoti villaggi e al di là del mare, non possono mai sperare
che poche frasi riescano a portare l’intero fardello del loro significato. «Le
parole di Lloyd George, mal capite e mal trasmesse», disse Briand alla
Camera dei Deputati2, «parevano dare ai pangermanisti l’idea che fosse
venuto il momento di muoversi». Un primo ministro inglese, parlando in
inglese al mondo intero in ascolto, esprime il proprio concetto nel suo
linguaggio ad ogni genere di persone, che in queste parole vedranno i
propri concetti. Importa assai poco che sia ricco di idee o sottile: o
piuttosto, quanto più ricco e sottile è il suo discorso, tanto più ne
68
risentiranno i concetti, nel momento in cui verranno riversati in frasi fatte e
quindi redistribuiti tra cervelli stranieri3.
Milioni di coloro che lo seguono leggono solo a stento. Altri milioni di
persone possono leggere le parole, ma non riescono a capirle. Si può
ritenere che tre quarti buoni di coloro che riescono sia a leggere che a
capire dispongano di meno di mezz’ora al giorno da dedicare alla materia.
In loro le parole così acquisite sono la scintilla che mette in moto una
sequela di idee, sulle quali alla fine può fondarsi un voto dalle
conseguenze meno prevedibili. Necessariamente le idee che consentiamo
alle parole lette di suscitare in noi formano la parte più cospicua dei dati
originari delle nostre opinioni. Il mondo è immenso, le situazioni che ci
riguardano sono intricate, i messaggi sono pochi, la parte più consistente
dell’opinione dev’essere costruita nell’immaginazione.
Quando usiamo la parola «Messico», qual è l’immagine che essa
suscita in un abitante di New York? Probabilmente si tratta di un composto
di sabbia, cactus, pozzi di petrolio, «greasers»4, indios che bevono rum,
vecchi cavalieri permalosi sbandieranti basette e nazionalismo, o magari
un contadiname idillico alla Jean-Jacques, assalito dalla prospettiva di un
fumoso industrialismo, e in lotta per i Diritti dell’Uomo. Che cosa
richiama alla mente la parola «Giappone»? Forse una vaga orda di uomini
gialli con gli occhi obliqui, circondati da Pericoli Gialli, spose da quadro,
ventagli, Samurai, banzai, arte e fiori di ciliegio? O la parola «straniero»?
Secondo un gruppo di studenti universitari del New England, intervistati
nell’anno 1920, uno straniero era una delle seguenti cose5:
Una persona ostile a questo paese.
Una persona che è contro il governo.
Una persona che sta dalla parte opposta.
Un nativo di un paese ostile.
Un forestiero col cui paese si è in guerra.
Un forestiero che cerca di nuocere al paese in cui si trova.
Un nemico proveniente da un paese estero.
Una persona che è contro un paese ecc.
Eppure la parola «straniero» è un termine legale insolitamente esatto,
molto più esatto di parole come «sovranità», «indipendenza», «onore
nazionale», «diritti», «difesa», «aggressione», «imperialismo»,
«capitalismo», «socialismo», su cui siamo così pronti a dichiararci «pro» o
«contro».
3.
69
La capacità di distinguere le analogie superficiali, di intendere le
differenze e di apprezzare la varietà è lucidità di mente. Essa è una facoltà
relativa. Infatti le differenze di lucidità sono grandi, come potrebbe essere
quella tra un neonato e un botanico che esaminino un fiore. Per il neonato
c’è ben poca differenza tra le dita dei propri piedi, l’orologio del padre, la
lampada sul tavolo, la luna in cielo e un’edizione di Guy de Maupassant
rilegata in un bel colore giallo. Per non pochi membri dell’Union League
Club non esiste un’apprezzabile differenza tra un membro del partito
democratico, un socialista, un anarchico e uno svaligiatore, mentre agli
occhi di un anarchico molto raffinato passa un universo intero tra Bakunin,
Tolstoj e Kropotkin. Questi esempi dimostrano quanto potrebbe riuscire
difficile ottenere un giudizio fondato su Maupassant nel mondo dei
bambini; o sui democratici nell’ambiente dell’Union League Club.
Un uomo che non ha l’automobile forse non riuscirà a cogliere
distinzioni più fini di quelle tra una Ford, un tassì e un’automobile di
lusso. Ma se questo stesso uomo si compra la macchina e la guida, e, come
direbbero gli psicoanalisti, proietta la sua libido sulle automobili, coglierà
una differenza in fatto di carburatore semplicemente guardando la parte
posteriore di un’automobile distante un intero isolato. Ecco perché è
spesso un vero sollievo il fatto che la conversazione passi dai «problemi
generali» a ciò che appassiona il singolo individuo. È come passare dal
paesaggio appeso in salotto al vero campo arato. È un ritorno al mondo
tridimensionale, dopo un soggiorno nella rappresentazione che il pittore dà
alle reazioni emotive provocate dal proprio impreciso ricordo di ciò che
immagina di dover aver visto. Noi identifichiamo facilmente, dice
Ferenczi, due cose solo parzialmente simili1: il fanciullo più facilmente
dell’adulto, la mente primitiva o minorata più prontamente di quella
matura. La coscienza, al suo apparire nel fanciullo, sembra un insieme
incontrollabile di sensazioni. Il bambino non ha il senso del tempo, e quasi
non ha il senso dello spazio: stende la mano per prendere il lampadario con
la stessa fiducia con cui si protende verso il seno della madre, e in un
primo momento quasi con la stessa speranza. Solo molto lentamente la
funzione assume una configurazione precisa. Per l’inesperienza assoluta
questo è un mondo coerente e indifferenziato, nel quale, come qualcuno ha
detto a proposito di una certa scuola di filosofi, tutti i fatti nascono liberi e
uguali. Quei fatti che nel mondo sono realmente collegati non sono stati
ancora separati da quelli che per caso si vengono a trovare fianco a fianco
nel flusso di coscienza.
In un primo momento, dice Ferenczi, il bambino ottiene piangendo
alcune delle cose che vuole. Questo è «il periodo dell’onnipotenza
70
incondizionata». Nella sua seconda fase il bambino indica le cose che
vuole, e queste gli vengono date. «Onnipotenza con l’aiuto di gesti
magici». In seguito il bambino impara a parlare, chiede le cose che vuole e
in parte riesce ad averle. «Il periodo dei pensieri magici e delle parole
magiche». Ogni fase può persistere in certe situazioni, benché sommersa e
visibile solo a tratti: come ad esempio nelle piccole innocue superstizioni
da cui solo pochi di noi sono del tutto liberi. In ciascuna fase il successo
parziale tende a confermare quel modo di agire, mentre l’insuccesso tende
a stimolare l’elaborazione di un altro modo.
Molti individui, partiti e persino nazioni, sembrano trascendere solo di
rado l’organizzazione magica dell’esperienza. Ma nei settori più avanzati
dei popoli più avanzati, gli esperimenti compiuti dopo ripetuti insuccessi
hanno portato all’invenzione di un nuovo principio. La luna, imparano,
non si muove perché le si abbaia. La terra non dà il raccolto in virtù di
feste propiziatorie o di maggioranze repubblicane, ma per opera del sole,
dell’umidità, dei semi, del concime e del lavoro2.
Tenendo presente il valore puramente schematico delle categorie di
reazione di Ferenczi, la qualità che individuiamo come decisiva è la
capacità di distinguere tra le percezioni grezze e le analogie vaghe. Questa
capacità è stata studiata con garanzie scientifiche3. Gli studi
dell’Associazione di Zurigo indicano chiaramente che una leggera
stanchezza mentale, un turbamento interno dell’attenzione o una
distrazione esterna, tendono ad «appiattire» la qualità della reazione. Un
esempio del tipo più «piatto» è l’associazione acustica (cane-pane), una
reazione al suono e non al senso della parola-stimolo. Una delle prove, ad
esempio, indica un aumento di associazione acustica del nove per cento nel
secondo centinaio di parole. Ora l’associazione acustica è quasi una
ripetizione, una forma molto primitiva di analogia.
4.
Se le condizioni relativamente semplici di un laboratorio possono
appiattire così facilmente le nostre capacità di discernimento, quale sarà
l’effetto della vita urbana? Nel laboratorio la fatica è piuttosto lieve, la
distrazione abbastanza trascurabile: entrambe sono compensate
dall’interesse e dalla consapevolezza del soggetto. Ma se il battito di un
metronomo deprime l’intelligenza, che effetto avranno otto o dodici ore di
rumori, odori e caldo di una fabbrica, o giornate intere passate tra il
ticchettio delle macchine per scrivere e tra squilli di telefono e porte che
sbattono, sui giudizi politici che si formano leggendo dei giornali in tram o
71
nella metropolitana? Si può udire nel brusio qualcosa che non si manifesti
con urli, o vedere nel bagliore generale qualcosa che non s’accenda e
spenga come un’insegna elettrica? La vita del cittadino difetta di
solitudine, silenzio, scioltezza. Le notti sono rumorose e accecanti. Gli
abitanti della grande città sono assaliti da suoni incessanti, ora violenti e
ineguali, ora scanditi in ritmi interrotti, ma senza fine e senza pietà. Nella
moderna civiltà industriale il pensiero procede in un bagno di rumore. Se
le sue distinzioni sono spesso piatte e sciocche, almeno una parte della
spiegazione la troviamo in questo stato di cose. Il popolo sovrano decide
questioni di vita e di morte e di felicità in condizioni nelle quali sia
l’esperienza che l’esperimento dimostrano che il pensiero è molto difficile.
«Il peso intollerabile del pensiero» è un peso quando le condizioni
ambientali lo rendono gravoso. Non è un peso quando esse sono
favorevoli. Pensare è eccitante come lo è danzare, ed è altrettanto naturale.
Chiunque per ragioni professionali debba adoperare la mente sa che
durante una parte della giornata avrà bisogno di crearsi intorno una zona di
silenzio. Ma in mezzo a quel caos che abbiamo la civetteria di chiamare
civiltà, il cittadino conduce nelle peggiori condizioni possibili la pericolosa
impresa di governarsi. Il movimento per l’accorciamento della settimana
lavorativa, per l’allungamento delle vacanze, per ottenere più luce, aria,
ordine, sole e dignità nelle fabbriche e negli uffici è ispirato da un vago
riconoscimento di questa verità. Ma questo, se si vuole migliorare il tono
intellettuale della nostra vita, non può essere che un inizio. Finché molte
occupazioni continueranno ad essere una routine senza fine, e, per
l’operaio, senza scopo, una sorta di automatismo che impegna un solo
gruppo di muscoli in un solo monotono schema di attività, la vita intera
dell’individuo tenderà ad un automatismo in cui nessuna cosa, salvo che
sia preannunciata da un colpo di tuono, è destinata ad essere distinta da
tutto il resto. Finché resterà imprigionato dalla folla di giorno, e persino di
sera, la sua attenzione sarà intermittente e priva d’intensità. Essa non
reggerà, né analizzerà con chiarezza, là dove egli è la vittima di tutti i tipi
di rumore, in una casa che avrebbe bisogno di essere depurata del suo
concentrato di monotonia, di bambini strillanti, di aspre recriminazioni, di
cibo indigesto, di aria stagnante e arredamento soffocante.
Magari ogni tanto entriamo in un edificio che è sereno e spazioso;
andiamo in un teatro la cui scenografia ha eliminato ciò che distrae, o ci
rechiamo al mare, o in un posto tranquillo, e ci ricordiamo di quanto
affollata, capricciosa, superflua e chiassosa sia la normale vita urbana del
nostro tempo. Comprendiamo allora perché le nostre menti confuse
afferrino così poco con precisione, perché vengano catturate e sballottate,
72
in una specie di tarantella, da titoli di stampa e parole d’ordine, perché così
spesso non siano in grado di vedere le differenze tra le cose o di cogliere
l’identità tra cose apparentemente diverse.
5.
Ma questo disordine esterno è ulteriormente complicato da quello
interno. Gli esperimenti dimostrano che la velocità, la precisione e la
qualità intellettuale dell’associazione vengono sconvolte da quelli che
abbiamo imparato a chiamare conflitti emotivi. Misurata in quinti di
secondo, una serie di cento stimoli contenenti parole sia neutrali che
eccitanti può offrire una variazione tra 5 e 32 o anche la mancanza totale di
reazione1. Ovviamente, la nostra opinione pubblica è in contatto
intermittente con complessi di ogni sorta: con l’ambizione e l’interesse
economico, con il risentimento personale, il pregiudizio razziale, il
sentimento di classe e così via. Essi sviano la nostra lettura, il nostro
pensiero, la nostra conversazione e il nostro comportamento in molti e
svariati modi.
E infine, poiché le opinioni non si limitano ai membri normali della
società, dato che per gli scopi di un’elezione, di una propaganda, di un
movimento il numero è potenza, la qualità dell’attenzione viene a scadere
ancora di più. La massa degli individui totalmente analfabeti, deboli di
mente, gravemente nevrotici, denutriti e frustrati, è assai cospicua: molto
più cospicua, c’è motivo di credere, di quanto generalmente pensiamo.
Così un messaggio di carattere generale viene diffuso tra persone che sono
mentalmente dei ragazzi o dei barbari, tra persone le cui vite sono una
palude piena di grovigli, tra persone la cui vitalità è esaurita, tra persone
chiuse in se stesse e tra persone la cui esperienza non contiene alcun
riferimento al problema in discussione. La corrente della pubblica opinione
viene fermata da costoro in piccoli gorghi di fraintendimento, dove viene a
tingersi di pregiudizi e di analogie assurde.
Un «appello generale» tiene conto della natura dell’associazione di idee
e si rivolge al tipo di sensibilità più diffuso. Un appello «ristretto» o
«speciale» è quello che si rivolge a sensibilità insolite. Ma lo stesso
individuo può reagire in modo molto diverso a stimoli diversi, o anche agli
stessi stimoli in momenti diversi. Le sensibilità umane sono come una
regione alpina. Ci sono cime isolate, ci sono altipiani estesi ma separati, e
ci sono strati più profondi che sono piuttosto continui attraverso tutta
l’umanità. Perciò gli individui la cui sensibilità raggiunge la rarefatta
atmosfera di quelle cime ove esiste una squisita differenza tra Frege e
73
Peano, o tra periodi diversi del Sassetta, possono essere dei repubblicani
solidamente tradizionalisti a un altro livello di reazione, e quando sono
affamati e terrorizzati, sono indistinguibili da qualsiasi altra persona
affamata e terrorizzata. Non sorprende che le riviste a grande diffusione
preferiscano il viso di una bella ragazza a qualsiasi altro segno di
riconoscimento: un viso abbastanza grazioso per attirare, ma abbastanza
innocente per riuscire accettabile. Infatti è il «livello psichico» su cui
agisce lo stimolo a determinare se il pubblico è potenzialmente largo o
esiguo.
6.
Così l’ambiente di cui si occupano le nostre opinioni pubbliche viene
rispecchiato in molti modi: dalla scarsa attenzione, dalla povertà di
linguaggio, dalla distrazione, da costellazioni inconsce di sentimenti, da
attriti, violenza, monotonia. Queste limitazioni al nostro accesso a
quell’ambiente si uniscono all’oscurità e alla complessità dei fatti stessi
per frustrare la chiarezza e la fedeltà della percezione, per sostituire
costruzioni illusorie a idee concrete e per privarci di adeguati controlli su
coloro che consapevolmente si adoperano per mettere fuori strada.
Pierrefeu, G. Q. G. Secteur 1 cit., pp. 126-9.
2 Il 26 febbraio 1916. Cfr. ibid., pp. 133 sgg.
3 Cfr. ibid., pp. 134-5.
1 Ibid., pp. 138-9.
2 Ibid., p. 147.
1 G. Creel, How we advertised America, Harper & brothers, New York-London
1920.
2 Nella rivoluzione delle colonie americane contro l’Inghilterra, venivano detti
Minute Men coloro che s’erano impegnati a scendere in piazza armati, al minimo
allarme, senza por tempo in mezzo. Four Minute Men è una derivazione scherzosa, la
quale indica le persone che prima della guerra mondiale si erano messe a disposizione
dei servizi di propaganda per tenere brevi discorsi, quasi senza preavviso, in qualsiasi
località venisse loro indicata [n.d.t.].
1 W. Trotter, Instincts of the Herd in War and Peace, T. F. Unwin, London 1916.
2 E. Wharton, L’età dell’innocenza, Corbaccio, Milano 1995; ed. or. The Age of
Innocence, The Modern Library, New York 1920.
3 Cfr. E. A. Ross, Social Psychology, an outline and source book, Macmillan, New
York 1908, capp. IX, X, XI.
4 Nel testo: «Great Society». L’espressione designa la società civile nel suo insieme
[n.d.t.].
1 Cfr. la parte III.
1
74
Nel luglio 1900: D. F. Wilcox, The American Newspaper: A Study in Social
Psychology, Annals of the American Academy of Political and Social Science, XVII, p.
56 (le tabelle statistiche sono state riportate da James Edward Rogers in The American
Newspaper), The University of Chicago Press, Chicago 1909. Nel 1916 (?): W D. Scott,
The Psychology of Advertising, theory andpractice (Leipzig 1900), Mainard & Co.,
Boston, pp. 226-48; cfr. anche H. F. Adams, Advertising and its Mental Laws,
Macmillan, New York, cap. IV. Nel 1920: Newspaper Reading Habits of College
Students, di G. B. Hotchkiss e R. B. Franken, pubblicato dalla Association of National
Advertisers.
1 Salvo quella che considera disdicevole, e quella che, in rari casi, non rientra nello
spazio disponibile.
1 Nel testo l’esempio è reso col codice Phillips. Si è cercato di dare un equivalente
approssimativo che rendesse l’idea [n.d.t.].
1 Citato da W. A. White, Mechanisms of Character Formation. Introduction to
psychoanalysis, Macmillan, New York 1916.
2 Cablogramma speciale per il «New York Times» del 25 maggio 1921, inviato da
Edwin L. James.
3 Nel maggio 1921 le relazioni tra l’Inghilterra e la Francia divennero tese in seguito
all’insurrezione di Korfanty nell’Alta Slesia. La corrispondenza da Londra del
«Manchester Guardian» (20 maggio 1921) conteneva il seguente passo: «Lo scambio di
parole franco-inglese. Negli ambienti che conoscono bene il costume e il carattere
francesi c’è la tendenza a ritenere che la nostra stampa e la nostra opinione pubblica
abbiano mostrato una eccessiva sensibilità verso il linguaggio vivace e in qualche caso
intemperante adottato dalla stampa francese nel corso dell’attuale crisi. Un osservatore
neutrale bene informato mi ha spiegato la cosa nei seguenti termini. Le parole, come il
denaro, sono simboli di valore. Esse rappresentano un significato, perciò, e, come il
denaro, il loro valore rappresentativo va su e giù. La parola francese “étonnant” venne
usata da Bossuet con un significato molto pesante, che oggi ha perduto. Una cosa
analoga può essere osservata nel caso della parola inglese “awful”. Alcune nazioni
tendono costituzionalmente ad attenuare, altre a esagerare. Quello che il Tommy inglese
chiamava un luogo insalubre poteva esser descritto da un soldato italiano solo grazie a
un ricco vocabolario, aiutato da una mimica esuberante. Le nazioni che attenuano,
mantengono solida la loro moneta verbale. Le nazioni che esagerano soffrono di
un’inflazione nel linguaggio. Espressioni come «un insigne studioso», «un bravo
scrittore» debbono essere tradotte in francese come «un grande sapiente», «uno squisito
maestro». È una pura questione di scambio, proprio come in Francia una sterlina rende
quarantasei franchi, e tuttavia si sa che ciò non aumenta il valore in patria. Gli inglesi,
leggendo la stampa francese, dovrebbero sforzarsi di compiere un’operazione mentale
simile a quella del banchiere che trasforma i franchi in sterline, e non dimentica, nel
farlo, che mentre in tempi normali il cambio era a venticinque, ora a causa della guerra,
è a quarantasei. Infatti c’è una fluttuazione di guerra sugli scambi di parole così come
sugli scambi monetari. L’argomento, si spera, vale nei due sensi, e i francesi debbono
comprendere che la reticenza inglese ha lo stesso valore della loro esuberanza
espressiva».
4 Termine americano spregiativo per «messicani. Letteralmente «unti» [n.d.t.].
5 «The New Republic», 29 dicembre 1920, p. 142.
1
75
«Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse», 1913. Tradotto e
ripubblicato dal dottor Ernest Jones in S. Ferenczi, First Contributions to
Psychoanalysis, R. G. Badger, Boston 1916, cap. VIII, «Fasi evolutive del senso della
realtà»; trad. it. in Id., Opere 1913–1919, Raffaello Cortina, Milano 1990.
2 Essendo un patologo, Ferenczi non descrive questo periodo più maturo in cui
l’esperienza è organizzata sotto forma di equazioni, la fase del realismo fondato sulla
scienza.
3 Si vedano, ad esempio, i Diagnostische Assoziazionsstudien, (1906) condotti alla
clinica psichiatrica dell’università di Zurigo sotto la direzione di Jung. [I risultati di
queste ricerche, pubblicati dapprima, fra il 1904 e il 1905, con il titolo Experimentelle
Untersuchungen uber Assoziationen Gesunder sono inclusi nel vol. II, t. 1 delle Opere,
Boringhieri, Torino 1984, n.d.t.]. Queste prove vennero svolte principalmente sotto la
classificazione cosiddetta Kràpelin-Aschaffenburg. Esse indicano il tempo di reazione,
classificano la reazione associativa alla parola-stimolo in termini di interiore, esteriore e
acustico, riportano risultati distinti per il primo e per il secondo centinaio di parole, per
il tempo di reazione e per la qualità della reazione quando il soggetto è distratto perché
ha in mente un’idea, o quando risponde mentre batte il tempo con un metronomo.
Alcuni dei risultati sono riassunti in C. G. Jung, Collected Papers on Analytical
Psychology, 1917, cap. II.
1 Id., Clark Lectures (1909); trad. it. in Id., Opere, vol. II, t. 2, Bollati Boringhieri,
Torino 1987.
1
76
III.
Gli stereotipi
77
VI.
Gli stereotipi
1.
Ciascuno di noi vive e opera su una piccola parte della superficie
terrestre, si muove in un cerchio ristretto e solo di pochi dei suoi
conoscenti giunge ad essere intimo. Di tutti gli avvenimenti pubblici che
hanno vasti effetti, vediamo al massimo solo una fase e un aspetto. Questo
vale sia per gli eminenti personaggi che redigono trattati, legiferano, ed
emanano ordini, sia per quelli per i quali questi trattati vengono redatti,
queste leggi vengono promulgate e questi ordini vengono dati.
Inevitabilmente le nostre opinioni coprono uno spazio più ampio, un
tempo più lungo, un numero maggiore di cose di quanto possiamo
direttamente osservare. Debbono, perciò, essere costruite sulla base di ciò
che ci viene riferito da altri, e di ciò che noi stessi riusciamo ad
immaginare.
D’altronde, nemmeno il testimone oculare riporta un’immagine
semplice della scena che ha visto1. Infatti l’esperienza sembra dimostrare
che alla scena che poi porta con sé egli già in partenza reca degli elementi,
e che più spesso di quanto si creda ciò che egli crede il resoconto di un
fatto è già in realtà la sua trasfigurazione. Sono pochi i fatti che sembrano
venire registrati dalla coscienza come sono; la maggior parte dei fatti
contenuti nella coscienza appaiono in parte costruiti. Il resoconto è il
prodotto congiunto di colui che conosce e della cosa conosciuta, in cui il
ruolo dell’osservatore è sempre selettivo e di solito creativo. I fatti che
vediamo dipendono dal punto di vista in cui ci mettiamo, e dalle abitudini
contratte dai nostri occhi.
Una scena non familiare è come il mondo del bambino: «Una grande
confusione, fiorente e ronzante»2. È in questo modo, dice John Dewey3,
che ogni cosa nuova colpisce l’adulto, sempre che la cosa sia davvero
nuova e insolita.
Le lingue straniere che non comprendiamo ci danno sempre l’impressione di un
confuso chiacchierio, un cicaleccio in cui non è possibile fissare alcun gruppo di
suoni nettamente definito e ben individualizzato. Accade lo stesso al provinciale in
una affollata via cittadina, all’abitante della terra ferma sul mare, all’ignorante in
78
faccende sportive che assiste a una discussione fra competenti a proposito di una
partita complicata. Ponete un uomo privo di esperienza in una fabbrica, ed il lavoro
gli sembrerà sulle prime un miscuglio di cose senza significato. Gli stranieri di
un’altra razza proverbialmente si somigliano tutti, agli occhi del visitatore forestiero.
In un gruppo di pecore, ognuna delle quali è perfettamente individualizzata per il
pastore, un estraneo percepisce soltanto grossolane differenze di grandezza e di
colore. Ciò che non comprendiamo ha per noi il carattere di un indiscriminato
mutamento, di una macchia in espansione. Il problema dell’acquisto dei significati
dalle cose, o (detto in altro modo) il problema di formare abiti di apprensione diretta
è dunque quello di introdurre: a) definitezza o distinzione e b) coerenza, costanza, o
stabilità di significati in cose che altrimenti sono vaghe e fluttuanti.
Come siano questa precisione e questa costanza dipende però da chi le
introduce. In un brano successivo4 Dewey fornisce un esempio di come
possano differire le definizioni del termine «metallo», date rispettivamente
da un profano che ha qualche esperienza in proposito e da un chimico. «La
levigatezza, la durezza, la lucentezza e lo splendore, il notevole peso in
rapporto alla grandezza; […] proprietà utili come la capacità di essere rese
malleabili dal calore ed essere indurite dal freddo, di conservare la forma e
la figura date, di resistere alla pressione ed al logoramento», entrerebbero
probabilmente nella definizione del profano. Ma il chimico probabilmente
trascurerebbe queste qualità estetiche e utilitarie, e definirebbe metallo «un
elemento chimico che entra in combinazione con l’ossigeno in modo da
formare una base».
Nella maggior parte dei casi noi definiamo non dopo, ma prima di aver
visto. Nella grande, fiorente e ronzante confusione del mondo esterno
trascegliamo quello che la nostra cultura ha già definito per noi, e
tendiamo a percepire quello che abbiamo trascelto nella forma che la
nostra cultura ha stereotipato per noi. Dei grandi uomini che si sono riuniti
a Parigi per decidere le sorti dell’umanità, quanti erano davvero in grado di
vedere qualcosa dell’Europa? Se qualcuno avesse potuto entrare nella
mente di Clemenceau, vi avrebbe trovato le immagini reali dell’Europa del
1919 o non piuttosto un forte sedimento di idee stereotipate accumulate e
irrigiditesi nel corso di una lunga e combattiva esistenza? Vedeva i
tedeschi del 1919, o il tipo germanico che aveva imparato a vedere fin dal
1871? Vedeva proprio quest’ultimo, e tra i vari rapporti che gli arrivavano
dalla Germania dava peso a quelli – e, a quanto pare, solo a quelli – che si
attagliavano al tipo che aveva nella mente. Se uno junker diventava
minaccioso, quello era un autentico tedesco; se un dirigente sindacale
riconosceva la colpa dell’impero, non poteva essere un vero tedesco.
A un congresso di psicologia, svoltosi a Gottinga, è stato fatto un
interessante esperimento su un gruppo di osservatori presumibilmente
79
addestrati5.
Non lontano dalla sala delle riunioni c’era una festa pubblica, con ballo in
maschera. Improvvisamente la porta della sala si apre, un clown si precipita come
un folle inseguito da un negro armato di pistola. I due si fermano in mezzo alla sala
e si insultano; il clown cade, il negro gli salta addosso, spara e subito entrambi
escono dalla sala. Il tutto dura appena venti secondi. Il presidente pregò i membri
presenti di scriver subito un rapporto perché sicuramente ci sarebbe stata
un’inchiesta giudiziaria. Furono consegnati quaranta rapporti. Uno solo aveva meno
del venti per cento di errori relativi al preciso svolgersi dei fatti; quattordici avevano
dal venti al quaranta per cento di errori, dodici dal quaranta al cinquanta per cento, e
tredici più del cinquanta per cento. Inoltre, in ventiquattro rapporti il dieci per cento
dei dettagli erano puramente inventati, e questa percentuale di invenzione era ancora
maggiore in dieci rapporti e minore in sei. In definitiva un quarto dei rapporti
dovette essere considerato come falso. Non è necessario dire che tutta la scena era
stata concordata e anche fotografata prima. I dieci rapporti falsi sono dunque da
inserire nella categoria dei racconti e delle leggende, altri ventiquattro sono
semileggendari e i sei rimanenti hanno più o meno il valore di testimonianza esatta.
Sicché, di quaranta osservatori allenati che hanno scritto un resoconto
responsabile di una scena appena accaduta dinanzi ai loro occhi, più della
maggioranza ha visto una scena che non aveva avuto luogo. Che cosa
avevano visto allora? Sembrerebbe più facile raccontare ciò che è
accaduto, che inventare qualcosa che non è accaduto. Essi hanno visto il
loro stereotipo di una zuffa. Tutti nel corso della loro vita avevano
acquisito una serie di immagini di zuffe, e queste immagini sfilarono
dinanzi ai loro occhi. In uno solo di loro queste immagini soppiantarono
meno del 20 per cento della scena reale; in tredici di loro più della metà. In
trentaquattro dei quaranta osservatori gli stereotipi si appropriarono di
almeno un decimo della scena. Un eminente critico d’arte ha scritto6 che
date le forme quasi innumerevoli che assume un oggetto […] data la nostra
insensibilità e la nostra scarsa attenzione, le cose difficilmente avrebbero per noi
tratti e contorni così precisi e chiari da poter essere richiamati a volontà, se non
fosse per le forme stereotipate che l’arte ha prestato loro.
La verità è ancor più ampia di quel che lui pensasse, perché le forme
stereotipate fornite al mondo non provengono solo dall’arte, intesa nel
senso di pittura e scultura e letteratura, ma anche dai nostri codici morali,
dalle nostre filosofie sociali e dalle nostre agitazioni politiche.
Sostituiamo, in quest’altro brano di Berenson, le parole «politica»,
«economia» e «società» alla parola «arte», e le sue affermazioni resteranno
egualmente vere:
80
A meno che anni e anni dedicati allo studio di tutte le scuole artistiche non ci
abbiano insegnato anche a vedere con i nostri occhi, cadiamo ben presto
nell’abitudine di modellare tutto quello che osserviamo nelle forme che ci offre
quella sola arte che ci è familiare. Essa è la misura con cui giudichiamo la realtà
artistica. Basta che qualcuno ci dia forme e colori che non trovano riscontro
istantaneo nel nostro misero repertorio di forme e tinte trite e ritrite, ed ecco che
scuoteremo la testa perché questi non ha riprodotto le cose come sappiamo che
debbono essere, o lo accuseremo di insincerità.
Berenson parla del disappunto che proviamo quando un pittore «non
visualizza gli oggetti esattamente come noi», e della difficoltà di
apprezzare l’arte del medioevo perché da allora «la nostra maniera di
visualizzare le forme è cambiata in mille modi»7. Passa poi a dimostrare in
che modo ci è stato insegnato a vedere quello che vediamo della figura
umana.
Creato da Donatello e Masaccio, e sanzionato dagli umanisti, il nuovo canone
della figura umana, la nuova forma dei lineamenti […] presentava alle classi
dirigenti di quell’epoca il tipo di essere umano che con maggiori probabilità poteva
affermarsi nello scontro delle forze umane […] chi aveva il potere di spezzare
questo nuovo cliché visivo e di scegliere dal caos delle cose forme più precisamente
espressive della realtà di quelle fissate da uomini di genio? Nessuno aveva un tale
potere. La gente doveva per forza vedere le cose in quel modo e in nessun altro, e
vedere solo le forme ritratte, amare solo gli ideali offerti8.
2.
Se non riusciamo a comprendere pienamente le azioni degli altri finché
non sappiamo che cosa credono di sapere, allora, per essere equi,
dobbiamo vagliare non solo le informazioni che erano a loro disposizione,
ma anche le menti con cui le hanno filtrate. Infatti i tipi accettati, gli
schemi correnti, le versioni standard intercettano le notizie prima che
arrivino alla coscienza. L’americanizzazione, ad esempio, è, almeno
superficialmente, la sostituzione di stereotipi americani a stereotipi
europei. Così il contadino che magari vedeva il proprietario come il
signore del castello, e il suo datore di lavoro come il magnate locale,
impara dall’americanizzazione a vedere il proprietario e il datore di lavoro
secondo i canoni americani. Ciò costituisce un mutamento di mentalità,
che in sostanza, quando l’inoculazione riesce, è un mutamento del modo di
vedere. Il suo occhio vede in modo diverso. Un’amabile gentildonna
confessava che gli stereotipi sono di un’importanza così soverchiante che,
quando i suoi vengono contrastati, lei da parte sua non riesce nemmeno più
81
ad accettare la fraternità umana e la paternità divina.
I vestiti che portiamo ci influenzano stranamente. L’abbigliamento crea
un’atmosfera psicologica e sociale. Che cosa si può sperare dall’americanismo di un
individuo che insiste a farsi fare i vestiti a Londra? Il cibo stesso influisce
sull’americanismo di una persona. Che specie di americanismo può maturare in
un’atmosfera di crauti e di formaggio di Limburgo? Che cosa ci si può aspettare
dall’americanismo dell’individuo il cui fiato puzza continuamente d’aglio?1
Questa signora avrebbe potuto essere la patrona di una parata a cui
assistette una volta un mio amico. S’intitolava «Il Crogiuolo», ed ebbe
luogo un 4 luglio in un centro dell’industria automobilistica dove lavorano
molti operai di origine straniera. Al centro del campo di baseball,
all’altezza della seconda base, era stato messo un enorme pentolone di
legno e tela. Su due lati c’erano delle scalinate che portavano fino all’orlo.
Dopo che il pubblico si fu sistemato e la banda musicale ebbe suonato,
entrò da un’apertura ad un lato del campo una processione. Era composta
di uomini di tutte le nazionalità straniere presenti nelle fabbriche.
Indossavano i costumi del loro paese d’origine, cantavano i loro canti
nazionali, danzavano i loro balli popolari e portavano le bandiere di tutti i
paesi d’Europa. Fungeva da maestro di cerimonie il direttore della scuola
elementare, vestito da Zio Sam. Fu lui a condurli al pentolone; li fece
salire per le scalinate e li portò dentro. Poi si mise dall’altra parte e li
invitò ad uscire. Ricomparvero in bombetta, giacca, pantaloni, gilet,
colletto duro e cravatta a pallini – e senza dubbio, diceva il mio amico,
ognuno con una matita Eversharp nel taschino – cantando tutti insieme
l’inno nazionale americano.
I promotori di questa parata, e probabilmente la maggior parte dei
protagonisti, credevano di essere riusciti ad esprimere quella che
costituisce la difficoltà più intima di associazione amichevole tra le
vecchie stirpi americane e le nuove. Il conflitto dei loro stereotipi impediva
il pieno riconoscimento della loro comune umanità. Le persone che hanno
cambiato il loro nome lo sanno; intendono cambiare se stessi e
l’atteggiamento degli altri nei loro confronti. Naturalmente c’è un nesso
fra la scena esterna e la mente con cui la osserviamo, proprio come nelle
riunioni della sinistra ci sono uomini con i capelli lunghi e donne con i
capelli corti. Ma per l’osservatore frettoloso è sufficiente un nesso
superficiale: se tra il pubblico ci sono due donne con i capelli alla
maschietta, e quattro barbe, agli occhi del cronista il quale sa in
precedenza che queste riunioni sono frequentate da persone che hanno
questi gusti in fatto di acconciatura, quello sarà un pubblico tutto alla
82
maschietta e barbuto. C’è un nesso tra la nostra visione e i fatti, ma spesso
è un curioso nesso. Un tale, supponiamo, non ha mai guardato un
paesaggio se non per esaminare la possibilità di dividerlo in lotti
fabbricabili, ma ha visto invece un certo numero di paesaggi appesi in
salotto. E da questi ha appreso a concepire il paesaggio come un tramonto
rosato o come una strada di campagna con un campanile e una luna
d’argento. Un giorno va in campagna e per varie ore non vede un solo
paesaggio. Poi il sole cala e in quel momento sembra rosa. Di colpo
riconosce un paesaggio ed esclama che è bellissimo. Ma due giorni dopo,
quando cerca di ricordare quello che ha visto, nove volte su dieci ricorderà
soprattutto un paesaggio visto in salotto.
Se non era ubriaco, e non sognava, e non era pazzo, ha visto un
tramonto; ma ci ha visto, e soprattutto ne ricorderà, più quello che le
oleografie gli hanno insegnato ad osservare di quello che un pittore
impressionista, ad esempio, o un giapponese colto, ci avrebbe visto e ne
avrebbe riportato. E il giapponese e il pittore a loro volta avranno visto e
ricordato soprattutto la forma che avevano imparato, a meno che per caso
non fossero tra quei pochissimi che scoprono all’umanità nuovi modi di
vedere. L’osservatore inesperto sceglie nell’ambiente dei segni
riconoscibili: i segni stanno al posto di idee, e queste idee vengono
riempite del nostro repertorio di immagini. Non è che vediamo davvero
quest’uomo e quel tramonto; ma piuttosto notiamo che l’oggetto è un
uomo o un tramonto, e poi vediamo soprattutto ciò di cui la nostra mente è
già piena al riguardo.
3.
Un atteggiamento di questo genere risparmia energie. Infatti il tentativo
di vedere tutte le cose con freschezza e in dettaglio, invece che nella loro
tipicità e generalità, è spossante; e quando si è molto occupati, è
praticamente impossibile. In un circolo di amici, e nei confronti di stretti
collaboratori o correnti, non esistono scorciatoie – né surrogati – ad una
conoscenza individualizzata. Quelli che ammiriamo di più sono gli uomini
e le donne la cui coscienza è popolata fittamente di persone piuttosto che
di tipi; che conoscono noi piuttosto che la classificazione nella quale
potremmo essere fatti rientrare. Infatti, anche senza formularlo
chiaramente a noi stessi, avvertiamo per intuizione che tutte le
classificazioni sono in funzione di fini che non sono necessariamente i
nostri; che nessun’associazione tra due esseri umani ha vera dignità se in
essa ciascuno non consideri l’altro come un fine in sé. C’è un vizio
83
organico in ogni contatto tra due persone in cui non si affermi come un
assioma l’inviolabilità personale di entrambi.
Ma la vita è affannosa e multiforme e soprattutto la distanza fisica
separa uomini che spesso si trovano in un rapporto reciproco
fondamentale, come il datore di lavoro e il suo dipendente, l’elettore e
l’eletto. Non c’è il tempo né la possibilità per una conoscenza profonda. E
così ci limitiamo a notare un tratto, che caratterizza un tipo ben conosciuto,
e riempiano il resto dell’immagine grazie agli stereotipi che ci portiamo in
testa. Quello è un agitatore: fin lì notiamo, o ce lo dicono. Ebbene, un
agitatore è fatto così e colà, e quindi anche lui è fatto così e colà. È un
intellettuale. È un plutocrate. È uno straniero. È un «sudeuropeo». È un
«bramino» di Boston1. È uno di Harvard. Com’è diverso dal dire: è uno di
Yale. È una brava persona. È uno che è stato a West Point. È un vecchio
sergente di carriera. È un abitante del Greenwich Village: cosa non
sappiamo di lui, o di lei, allora? È un banchiere internazionale. È un
abitante di Main Street.
Le più sottili e contagianti influenze sono quelle che creano e
conservano il repertorio degli stereotipi. Sentiamo parlare del mondo
prima di vederlo. Immaginiamo la maggior parte delle cose prima di
averne esperienza. E questi preconcetti, se non siamo stati resi molto
avvertiti dall’educazione, incidono profondamente nell’intero processo
della percezione. Contrassegnano certi oggetti come familiari o estranei,
mettendone in risalto la differenza, sicché ciò che conosciamo appena ci
sembra ben noto, e quello che ci è un po’ estraneo ci appare decisamente
alieno. Vengono suscitati da piccoli segni, che possono variare dal vero
indice alla vaga analogia. Una volta suscitati, inondano la visione fresca e
immediata di vecchie immagini, e proiettano nel mondo ciò che la
memoria ha fatto risuscitare. Se nell’ambiente non ci fossero delle
uniformità di fatto, non ci sarebbe economia, ma soltanto errore
nell’abitudine umana di accettare la previsione come visione. Ma ci sono
invece delle uniformità abbastanza costanti, e la necessità di economizzare
l’attenzione è così inevitabile che l’abbandono di tutti gli stereotipi, per un
atteggiamento completamente innocente di fronte all’esperienza,
impoverirebbe la vita umana.
Ciò che conta è la natura degli stereotipi, e la credulità con cui li
adoperiamo. E questo in ultima analisi dipende da quegli schemi generali
che costituiscono la nostra filosofia della vita. Se in questa filosofia
assumiamo che il mondo è codificato secondo un codice di cui siamo in
possesso, probabilmente descriveremo, nei nostri resoconti degli
avvenimenti, un mondo retto dal nostro codice. Ma se la nostra filosofia ci
84
dice che ogni uomo è solo una particella del mondo, che la sua intelligenza
ne cattura, nel migliore dei casi, solo qualche frase e qualche aspetto in
una rozza trama di idee, allora, quando usiamo i nostri stereotipi tendiamo
a renderci conto che sono soltanto degli stereotipi, li consideriamo senza
troppo impegno, e li modifichiamo di buon grado. Tendiamo anche a
renderci conto sempre più chiaramente del momento in cui le nostre idee
sono sorte, della loro origine, di come sono arrivate sino a noi, e del
motivo per cui le abbiamo accettate. Tutta la storia utile è antisettica allo
stesso modo. Ci consente di sapere quale fiaba, quale testo scolastico,
quale tradizione, quale romanzo, dramma, quadro, frase abbia seminato un
preconcetto in questa mente, un altro preconcetto in quell’altra.
4.
Almeno quelli che vogliono censurare l’arte non sottovalutano questa
influenza. In genere la fraintendono, e quasi sempre si intestardiscono
scioccamente nel voler impedire agli altri di scoprire qualcosa che loro non
hanno sanzionato. Ma ad ogni modo, come Platone quando parla dei poeti,
essi intuiscono vagamente che spesso i tipi acquisiti attraverso
l’invenzione della fantasia vengono poi imposti alla realtà. Così non c’è
dubbio che il cinema sta continuamente costruendo immagini, che
vengono poi richiamate alla mente dalle parole che la gente legge nei
giornali. Nell’intera esperienza della specie umana non c’è stato un altro
strumento di visualizzazione della potenza del cinema. Se un fiorentino
voleva avere un’immagine dei santi, poteva andare a guardare gli affreschi
della sua chiesa, dove gli veniva offerta una visione dei santi che era stata
standardizzata per la sua epoca da Giotto. Se un ateniese voleva farsi
un’immagine degli dei, andava in un tempio. Ma il numero di oggetti che
venivano ritratti non era molto grande. E in Oriente, dove lo spirito del
secondo comandamento era largamente accettato, la rappresentazione di
cose concrete era ancora più scarsa; ed è forse proprio per questa ragione
che la capacità di decisione pratica è risultata lì così ridotta. Nel mondo
occidentale, invece, c’è stato nel corso degli ultimi secoli un enorme
aumento, sia in volume che in ampiezza, della rappresentazione laica,
attraverso la descrizione verbale, la narrativa, la narrativa illustrata, e
infine il cinema e forse il cinema sonoro.
Le fotografie hanno sull’immaginazione odierna lo stesso tipo di
autorità che ieri aveva la parola stampata e in precedenza aveva avuto la
parola parlata. Sembrano del tutto vere. Ci figuriamo che arrivino sino a
noi direttamente, senza intromissioni umane; e sono per la mente il cibo
85
più facile. Ogni descrizione verbale, o anche ogni immagine inerte,
richiede uno sforzo di memoria prima che l’immagine si produca nella
mente. Ma sullo schermo l’intero processo dell’osservare, descrivere,
riferire e poi immaginare, è già stato compiuto per noi. Senza uno sforzo
maggiore di quello richiesto per restar svegli, il risultato a cui
costantemente mira la nostra immaginazione viene proiettato sullo
schermo. L’idea nebulosa diventa vivida: la nostra confusa idea, poniamo,
del Ku Klux Klan, acquista chiarezza e intensità, grazie a Griffith, quando
assistiamo a La nascita di una nazione. Storicamente può essere
un’immagine sbagliata, moralmente può essere perniciosa, ma è
un’immagine, ed io dubito che qualcuno che abbia visto il film, e non
sappia del Ku Klux Klan più di quanto ne sapeva Griffith, potrà mai più
sentirlo nominare senza vedere quei cavalieri bianchi.
5.
E allo stesso modo, quando parliamo della mente di un gruppo di
persone, della mente francese, della mente militarista, della mente
bolscevica, andiamo soggetti a gravi confusioni se non accettiamo di
separare le disposizioni istintive dagli stereotipi, dagli schemi e dalle
formule che giocano una parte così decisiva nella costruzione del mondo
mentale cui il carattere originario si adatta e risponde. La mancata
distinzione tra questi due ordini di fatti spiega i fiumi di chiacchiere che si
sono fatte a proposito di menti collettive, anime nazionali e psicologia
delle razze. Naturalmente uno stereotipo può esser così coerentemente e
autorevolmente trasmesso di padre in figlio da sembrare quasi un fatto
biologico. Sotto certi aspetti, forse siamo davvero diventati, come dice
Wallas1, biologicamente parassitari nei confronti del nostro retaggio
sociale. Ma certamente non esiste la minima prova scientifica che consenta
di sostenere che gli uomini nascano con gli atteggiamenti politici del paese
in cui vedono la luce. Nella misura in cui in una nazione gli atteggiamenti
politici sono simili, i primi luoghi in cui si deve cercare una spiegazione
sono la stanza dei bambini, la scuola, la chiesa, e non quel limbo abitato
dalle Menti di Gruppo e dalle Anime Nazionali. Finché non si dimostra
che non esiste una trasmissione di tradizioni da parte dei genitori, degli
insegnanti, dei preti e degli zii, si cade in un errore madornale attribuendo
le differenze politiche alla cellula embrionale.
Si può fare qualche generalizzazione, e sempre con la dovuta umiltà,
sulle differenze comparative entro la stessa categoria di educazione e di
esperienza. Ma anche questa è impresa piena di trabocchetti. Infatti
86
nemmeno due esperienze sono veramente identiche, nemmeno quelle dei
due bambini cresciuti nella stessa famiglia. Il figlio maggiore non fa mai
l’esperienza di essere il minore. E perciò, finché non siamo in grado di
valutare le differenze di formazione, dobbiamo sospendere il giudizio sulle
differenze di natura. Sarebbe come giudicare la produttività di due terreni,
confrontando la loro resa prima di sapere quale dei due si trova nel
Labrador, e quale nello Iowa, e se sono stati coltivati e concimati, oppure
eccessivamente sfruttati o lasciati incolti.
87
VII.
Gli stereotipi come difesa
1.
C’è un’altra ragione, oltre all’economia dello sforzo, che spiega perché
così spesso ci atteniamo ai nostri stereotipi quando potremmo avere una
visione più disinteressata. I sistemi di stereotipi possono essere il centro
della nostra tradizione personale, le difese della nostra posizione nella
società.
Formarono un’immagine ordinata e più o meno coerente del mondo, a
cui le nostre abitudini, i nostri gusti, le nostre capacità, i nostri agi e le
nostre speranze si sono adattati. Forse non sono un’immagine completa del
mondo, ma sono l’immagine di un mondo possibile a cui ci siamo adattati.
In questo mondo le persone e le cose hanno un loro posto preciso e si
comportano secondo certe previsioni. In esso ci sentiamo a nostro agio; vi
siamo inseriti; ne siamo membri; sappiamo come rigirarci. Vi troviamo il
fascino del familiare, del normale, del sicuro; le sue scanalature e le sue
forme stanno là dove siamo abituati a trovarle. E anche se abbiamo dovuto
abbandonare molte cose che ci avrebbero tentato prima che ci
accomodassimo alle pieghe di questo stampo, una volta che ci stiamo ben
dentro, troviamo che esso calza comodamente come una vecchia scarpa.
Nessuna meraviglia, quindi, che ogni attacco agli stereotipi prenda
l’aspetto di un attacco alle fondamenta dell’universo: infatti è un attacco
alle fondamenta del nostro universo, e quando sono in gioco cose grosse
non siamo affatto disposti ad ammettere che ci sia una distinzione tra il
nostro universo e l’universo. Un mondo che si dimostri così fatto, per cui
quelli che onoriamo sono indegni, e quelli che disprezziamo sono nobili, è
semplicemente sconvolgente. Se la nostra scala di valori non è la sola
possibile, allora c’è anarchia. Infatti se i mansueti dovessero davvero
ereditare la terra, se gli ultimi dovessero davvero essere i primi, se soltanto
quelli che sono senza peccato potessero scagliare la prima pietra, e se a
Cesare si dessero solo le cose che spettano a Cesare, allora i fondamenti
del rispetto di sé davvero vacillerebbero in coloro che hanno organizzato la
loro vita come se queste massime non fossero vere.
Nessuno schema di stereotipi è naturale. Non è solo un modo per
88
sostituire l’ordine alla grande, fiorente, ronzante confusione della realtà.
Non è soltanto una scorciatoia. È tutto questo, e anche qualcos’altro. È la
garanzia del rispetto di noi stessi; è la proiezione nel mondo del nostro
senso, del nostro valore, della nostra posizione e dei nostri diritti. Perciò
gli stereotipi sono fortemente carichi dei sentimenti che gli sono associati.
Costituiscono la forza della nostra tradizione, e dietro le sue difese
possiamo continuare a sentirci sicuri della posizione che occupiamo.
2.
Ad esempio, quando Aristotele scrisse nel quarto secolo a.C. la sua
difesa della schiavitù in un clima di crescente scetticismo1, gli schiavi
ateniesi erano ormai in buona parte indistinguibili dai liberi cittadini.
Zimmern cita un divertente brano del Vecchio Oligarca, che illustrava il
buon trattamento ricevuto dagli schiavi: «Se fosse legale battere gli
schiavi, accadrebbe spesso che un ateniese possa venire scambiato per uno
schiavo o per uno straniero, e ricevere delle percosse; dal momento che il
popolo ateniese non è vestito meglio dello schiavo o dello straniero, né
l’aspetto personale rivela alcuna superiorità». Quest’assenza di segni
distintivi naturalmente tenderebbe a far scomparire l’istituzione. Se gli
uomini liberi e gli schiavi si somigliavano, che base c’era per trattarli in
modo così diverso? È proprio questa confusione che Aristotele si studiò di
chiarire nel primo libro della Politica. Con istinto sicuro capì che per
giustificare la schiavitù doveva insegnare ai greci un modo di vedere i loro
schiavi adatto al perdurare della schiavitù.
Così, diceva Aristotele, ci sono esseri che sono schiavi per natura2: «È
schiavo per natura chi può appartenere a un altro (per cui è di un altro)».
Tutto quello che dice in realtà è che chi si trova ad esser schiavo è
destinato dalla natura ad esserlo. Dal punto di vista logico, l’affermazione
non ha alcun valore, ma in realtà non è affatto una proposizione, e la logica
non c’entra affatto. È uno stereotipo, o piuttosto fa parte di uno stereotipo:
il resto segue quasi immediatamente. Dopo aver asserito che gli schiavi
hanno la ragione, ma sono privi del dono di usarla, Aristotele dichiara che
«la natura vuol segnare una differenza nel corpo dei liberi e degli schiavi:
gli uni l’hanno robusto per i servizi necessari, gli altri eretto e inutile a
siffatte attività, ma adatto alla vita politica […]. È evidente che taluni sono
per natura liberi, altri, schiavi».
Se ci chiediamo ora che cos’è che non funziona nel ragionamento di
Aristotele, troviamo che egli ha cominciato coll’erigere una grossa barriera
tra sé e i fatti. Dicendo che quelli che sono schiavi sono destinati dalla
89
natura ad esserlo, egli escludeva automaticamente la questione decisiva se
gli specifici individui che si trovavano ad essere schiavi erano gli specifici
individui destinati dalla natura ad essere schiavi. Infatti questo
interrogativo avrebbe gettato il dubbio su ogni caso di schiavitù. E dal
momento che il fatto di essere schiavi non era la prova che un individuo
fosse destinato ad esserlo, non sarebbe rimasto più alcun criterio atto a
fornire la certezza. Perciò Aristotele escludeva del tutto questo dubbio
distruttivo: quelli che erano schiavi erano destinati ad esserlo. Ogni
possessore di schiavi doveva considerare queste sue proprietà degli schiavi
per natura. Quando il suo occhio si fosse allenato a vederli in questo modo,
avrebbe notato, a conferma della loro natura servile, il fatto che
eseguivano un lavoro servile, che erano competenti a compiere il lavoro
servile e che avevano i muscoli per fare il lavoro servile.
Questo è il perfetto stereotipo. Il suo contrassegno è che esso precede
l’uso della ragione: è una forma di percezione, che impone un certo
stampo ai dati dei nostri sensi prima che i dati arrivino all’intelligenza. Lo
stereotipo è come le vetrate color lavanda di Beacon Street, come il
portiere che a un ballo mascherato giudica se l’invitato ha un
abbigliamento appropriato. Non c’è nulla di più refrattario all’educazione,
o alla critica, dello stereotipo. Si imprime sull’evidenza nell’atto stesso di
constatarla. Ecco perché i racconti dei viaggiatori sono spesso un
resoconto interessante di quello che il viaggiatore ha portato con sé nel suo
viaggio. Se si è portato dietro soprattutto l’appetito, la fissazione per le
stanze da bagno piastrellate, la convinzione che la carrozza Pullmann è il
non plus ultra della comodità, e l’idea che si deve dare la mancia ai
camerieri, ai tassisti e ai barbieri, ma in nessun caso ai bigliettai e alle
mascherine, allora la sua odissea traboccherà di buoni e cattivi pasti, di
avventure nella stanza da bagno, di incontri galanti sui treni e di voraci
richieste di danaro. O forse, se è un tipo più grave, si sarà trovato, durante
il viaggio, in luoghi celebri. Raggiunta la meta, e gettato uno sguardo
furtivo al monumento, avrà affondato la testa nel Baedecker leggendone
ogni parola, e sarà partito alla volta di un altro luogo celebre; tornando alla
fine con un’impressione compatta e ordinata dell’Europa, con accanto una
stelletta o due.
In qualche misura gli stimoli esterni, soprattutto quando sono parole
scritte o parlate, richiamano alla mente una parte o l’altra di un sistema di
stereotipi, sicché la sensazione reale e il preconcetto occupano la coscienza
contemporaneamente. I due elementi si fondono, come se guardassimo il
rosso attraverso lenti azzurre, e vedessimo il verde. Se ciò che guardiamo
corrisponde bene a quello che abbiamo previsto, lo stereotipo viene
90
rafforzato per l’avvenire, come succede all’individuo il quale sa che i
giapponesi sono astuti e ha la cattiva sorte di imbattersi in un paio di
giapponesi disonesti.
Se invece l’esperienza contraddice lo stereotipo, può accadere l’una o
l’altra di queste due cose: se l’individuo non è più duttile, o se un interesse
potente rende molto scomoda la revisione degli stereotipi, egli liquida la
contraddizione come un’eccezione che conferma la regola, scredita il
testimone, trova un difetto da qualche parte e riesce a dimenticarla. Ma se
è ancora curioso e di mente aperta, la novità viene accolta nell’immagine e
lasciata libera di modificarla. A volte, se l’incidente è abbastanza
impressionante, e se egli già provava un certo disagio per il suo schema
precostituito, può darsi che si senta scosso a tal punto da diffidare di tutti i
modi accettati di considerare la vita, e da attendersi che di norma nessuna
cosa sarà mai ciò che in genere dovrebbe essere. Nei casi estremi,
particolarmente se si tratta di un letterato, può concepire una passione per
l’inversione dei canoni morali, facendo di Giuda, di Benedict Arnold o di
Cesare Borgia i suoi eroi.
3.
La funzione svolta dallo stereotipo può essere osservata nei racconti
tedeschi sui franchi tiratori belgi. Questi racconti, strano a dirsi, vennero
confutati per la prima volta da un’organizzazione di preti cattolici tedeschi
denominata Pax1. L’esistenza di racconti di atrocità non è di per sé cosa
sorprendente, né sorprende che i tedeschi fossero felici di crederci. Ma
invece sorprende che una grande organizzazione conservatrice di buoni
patrioti tedeschi si sia messa già il 16 agosto 1914, a contraddire una
raccolta di calunnie sul nemico, sebbene tali calunnie fossero
preziosissime per blandire la travagliata coscienza dei loro compatrioti. E
in particolare, perché l’ordine dei Gesuiti avrebbe dovuto mettersi a
distruggere un’invenzione così importante per lo spirito bellico della
Germania?
Cito dal resoconto di van Langenhove:
Le armate tedesche erano appena entrate nel Belgio che già cominciavano a
circolare strane voci. Si diffusero da un luogo a un altro, vennero riportate dalla
stampa e ben presto invasero l’intera Germania. Si diceva che la popolazione belga,
istigata dal clero, fosse intervenuta perfidamente nelle ostilità; che avesse attaccato
di sorpresa dei distaccamenti isolati; che avesse segnalato al nemico le posizioni
occupate dalle truppe tedesche; che dei vecchi, e persino dei fanciulli, si fossero resi
colpevoli di orrende atrocità nei confronti di soldati tedeschi feriti e inermi,
91
strappando loro gli occhi e tagliandogli dita, naso e orecchie; che i preti dai pulpiti
avessero esortato la popolazione a commettere questi crimini, promettendole per
ricompensa il regno dei cieli, e che avessero persino dato l’esempio di questi atti di
barbarie.
In questo modo l’opinione pubblica tedesca restò turbata e manifestò una vibrata
indignazione, rivolta specialmente contro i preti, che erano tenuti responsabili degli
atti di barbarie attribuiti ai belgi […]. Per naturale derivazione l’ira cui erano caduti
in preda fu rivolta dai tedeschi contro il clero cattolico in generale. I protestanti
lasciarono che si riaccendesse nei loro cuori il vecchio odio religioso e si lanciarono
in attacchi contro i cattolici. Si scatenò un nuovo Kulturkampf.
I cattolici non esitarono a reagire a questo atteggiamento ostile2.
Forse qualche azione di franchi tiratori c’è stata. Sarebbe stato ben
strano che ogni belga adirato si precipitasse in biblioteca, aprisse un
manuale di diritto internazionale, e si informasse se aveva il diritto di tirare
su quella scocciatura infernale in marcia lungo le sue strade. Sarebbe stato
non meno strano che un esercito, che non si era mai trovato sotto il fuoco,
non considerasse ogni proiettile sparatogli contro come non autorizzato,
perché scomodo, e anzi quasi come una violazione delle regole del
Kriegsspiel, che fino a quel momento costituiva la sua sola esperienza
bellica. È facile immaginarsi i più sensibili intenti a convincersi che la
gente a cui stavano facendo cose tanto terribili dovesse essere gente
terribile. E così la leggenda può essersi propagata fino ad arrivare ai
censori e agli addetti alla propaganda, i quali, ci credessero o no, ne
compresero l’utilità e la rovesciarono sulla popolazione civile tedesca. E
non è che a questa spiacesse molto di scoprire che la popolazione che stava
maltrattando era subumana. Per di più, dato che la leggenda proveniva dai
suoi eroi, non solo era legittimo prestarvi fede, ma sarebbe stato
antipatriottico rifiutarsi di farlo.
Ma quando, proprio per il fatto che il teatro degli avvenimenti si perde
nelle nebbie della guerra, la fantasia gioca una parte così importante, non
esistono più freni né controlli. La leggenda dei feroci preti belgi fece
risorgere un odio antico: infatti nella mente di moltissimi protestanti
tedeschi nazionalisti, soprattutto nelle classi superiori, il quadro delle
vittorie di Bismarck comprendeva una lunga controversia con i cattolici.
Per un processo di associazione, i preti belgi diventarono semplicemente
dei preti, e l’odio per i belgi diventò una valvola attraverso cui potevano
sfogare tutti i loro odi. Questi protestanti tedeschi fecero proprio come
certi americani i quali sotto la pressione della guerra, e accomunando il
nemico a tutti i loro avversari interni, crearono un oggetto composito su
cui sfogarono il loro odio. Contro questo nemico sintetico, l’Unno tedesco
e l’Unno interno, gettarono tutto il malanimo che avevano dentro di sé.
92
La reazione cattolica ai racconti delle atrocità fu naturalmente
difensiva. Mirò soprattutto a quegli elementi che suscitavano ostilità verso
tutti i cattolici, piuttosto che verso i soli cattolici belgi. Le Informations
Pax, dice van Langenhove, avevano un carattere esclusivamente
ecclesiastico, e «limitavano la propria attenzione quasi soltanto alle azioni
reprensibili attribuite ai preti». E tuttavia non si può fare a meno di
domandarsi che cosa abbia messo in moto nella mente dei cattolici
tedeschi questa rivelazione su ciò che l’impero di Bismarck significava nei
loro riguardi; e inoltre se ci sia stato un qualche oscuro nesso tra questa
scoperta e il fatto che l’eminente uomo politico tedesco che al momento
dell’armistizio si dimostrò pronto a firmare la condanna a morte
dell’impero è stato Erzberger3, il capo del Centro Cattolico.
93
VIII.
I punti ciechi e il loro valore
1.
Ho parlato di stereotipi, anziché di ideali, perché il termine «ideale» di
solito viene riservato a ciò che consideriamo il buono, il vero e il bello.
Contiene perciò implicitamente l’idea che ci sia qualcosa da copiare o da
raggiungere. Ma il nostro repertorio di impressioni fisse è più ampio,
poiché abbraccia truffatori ideali, politicanti ideali, sciovinisti ideali,
agitatori ideali, nemici ideali. Il nostro mondo stereotipato non è
necessariamente il mondo come lo vorremmo: è semplicemente il mondo
come ce lo aspettiamo. Se i fatti reali vi corrispondono, si prova come un
senso di familiarità, e si ha l’impressione di muoversi secondo l’andazzo
delle cose. Se siamo degli ateniesi che non vogliono provare rimorsi, il
nostro schiavo dev’essere uno schiavo per natura. Se, dopo aver detto ai
nostri amici che al golf facciamo 18 buche in 95 colpi, le facciamo invece
in 110, sosterremo con loro che oggi non siamo noi stessi. In altre parole,
ci è ignoto quell’incapace che ha fallito 15 colpi.
La maggior parte di noi affronterebbe le cose con un assortimento
piuttosto casuale e mutevole di stereotipi, se non ci fosse in ogni
generazione un numero relativamente piccolo di persone che s’impegnano
costantemente a disporli, standardizzarli e migliorarli in sistemi logici, noti
come le Leggi dell’Economia Politica, i Princìpi della Politica, e via
dicendo. Quando scriviamo sulla cultura, sulla tradizione e sulla mentalità
di gruppo pensiamo di solito a questi sistemi perfezionati da uomini di
genio. Ora, non si può certo contestare la necessità di uno studio e di una
critica costanti di queste versioni idealizzate, ma lo storico, il politico e il
pubblicitario non possono fermarsi qui. Infatti ciò che opera nella storia
non è l’idea sistematica che un genio può formulare, ma le imitazioni
cangianti, le copie, le contraffazioni, le analogie e le distorsioni delle menti
degli individui.
E così il marxismo non è necessariamente ciò che ha scritto Karl Marx
nel Capitale, ma tutto ciò che credono le varie fazioni in lotta, ognuna
delle quali pretende di essere quella ortodossa. Non è possibile dedurre la
storia del cristianesimo dai Vangeli, né la storia politica americana dalla
94
Costituzione. Bisogna risalire al Capitale come l’intendono i marxisti, ai
Vangeli come vengono predicati e alla predicazione come viene recepita,
alla Costituzione come viene interpretata e applicata. Infatti, pur essendoci
un’influenza reciproca tra la versione standard e le versioni correnti, sono
queste ultime distribuite tra gli uomini ad influire sul loro comportamento1.
La teoria della relatività – afferma un critico le cui palpebre, come quelle di
Monna Lisa, sono un po’ pesanti – promette di diventare un principio suscettibile di
applicazione universale, pressappoco come la teoria dell’evoluzione. Quest’ultima,
che era nota come ipotesi tecnico-biologica, si trasformò rapidamente in una guida
stimolante per studiosi di tutti i rami del sapere. Usi e costumi, princìpi morali,
religiosi, filosofie, arti, vaporiere, tranvai elettrici: tutto aveva subito
un’«evoluzione». Questa parola diventò un termine generalissimo, ma diventò anche
talmente imprecisa che in molti casi il suo significato originario andò perduto, e la
teoria che avrebbe dovuto indicare venne fraintesa. Ci azzardiamo a preconizzare
una vicenda e un destino analoghi alla teoria della relatività. Questa teoria, oggi
imperfettamente compresa, diventerà ancor più vaga e nebulosa. La storia si ripete, e
la relatività, dopo aver ricevuto, come l’evoluzione, un certo numero di esposizioni
popolari comprensibili, ma piuttosto imprecise dal punto di vista scientifico, verrà
lanciata alla conquista del mondo. Lasciateci suggerire che, a quel punto,
probabilmente si chiamerà relativismus. Molte di queste applicazioni più vaste
saranno senza dubbio giustificate; ma talune saranno assurde, e un buon numero di
loro, pensiamo, non sarà altro che un cumulo di banalità. E la nuova teoria fisica,
semplice seme di questa possente crescita, tornerà ad essere il problema
esclusivamente tecnico degli uomini di scienza2.
Ma per conquistare il mondo un’idea deve corrispondere, sia pure in
modo impreciso, a qualcosa. Il professor Bury ha dimostrato che per molto
tempo l’idea di progresso fu soltanto un giocattolo speculativo.
È difficile – scrive3 – che una nuova idea di carattere speculativo si propaghi e
venga accolta nella coscienza generale di una collettività prima di aver assunto una
forma esteriore concreta, o di esser stata sottolineata da una vistosa prova materiale.
Nel caso dell’idea di progresso tutt’e due le condizioni si realizzarono (in
Inghilterra) nel periodo 1820-1850.
La prova più vistosa venne fornita dalla rivoluzione meccanica. Gli
uomini nati all’inizio del secolo avevano visto, prima di raggiungere i
trent’anni, il rapido sviluppo della navigazione a vapore e
dell’illuminazione a gas delle città e delle case, e anche l’apertura della
prima ferrovia. Nella coscienza del normale cittadino sono stati miracoli
come questi a gettare le basi della fede nella perfettibilità della razza
umana.
Tennyson, che in materia filosofica era una persona piuttosto normale,
95
racconta che quando andò con il primo treno da Liverpool a Manchester
(1830) era convinto che le ruote corressero dentro scanalature. Allora
scrisse questo verso.
Che il grande mondo rotoli per sempre lungo le sonanti Scanalature del
mutamento4.
E così un pensiero più o meno applicabile a un viaggio da Liverpool a
Manchester venne generalizzato a modello dell’universo «per sempre».
Questo modello, raccolto da altri e rafforzato da scintillanti invenzioni,
impresse un tono ottimistico alla teoria dell’evoluzione. Naturalmente
questa teoria, come dice il professor Bury, resta neutrale di fronte al
pessimismo e all’ottimismo. Ma prometteva il continuo mutamento, e i
mutamenti visibili nel mondo indicavano conquiste della natura talmente
straordinarie che la coscienza popolare fuse insieme le due cose.
L’evoluzione – prima nello stesso Darwin, e poi, in modo più complicato,
in Herbert Spencer – era un «progresso verso la perfezione».
2.
Lo stereotipo rappresentato da termini come «progresso» e
«perfezione» si componeva fondamentalmente di invenzioni meccaniche.
E meccanico è rimasto, nel complesso, fino ad oggi. In America più che in
tutto il resto del mondo, lo spettacolo del progresso meccanico ha creato
un’impressione così profonda da permeare l’intero codice morale. Un
americano è disposto a sopportare quasi ogni insulto, ma non l’accusa di
non essere proteso verso il progresso. Sia egli di antica ascendenza, ovvero
un recente immigrato, l’aspetto che sempre ha colpito la sua attenzione è
l’immenso sviluppo materiale della civiltà americana. Esso costituisce uno
stereotipo fondamentale attraverso cui vede il mondo: il villaggio di
campagna diventerà la grande metropoli, il modesto edificio un grattacielo,
ciò che è piccolo dovrà essere grosso, ciò che è lento dovrà essere veloce,
ciò che è povero dovrà essere ricco; le poche cose debbono diventare le
molte; tutto ciò che è lo dovrà essere ancor di più.
Naturalmente non tutti gli americani vedono il mondo in questo modo.
Non lo vedeva così Henry Adams, e non lo vede così William Allen
White. Ma lo vedono così gli uomini che nelle riviste consacrate alla
religione del successo figurano come i Costruttori dell’America; essi
intendono pressappoco questo quando predicano l’evoluzione, il
progresso, la prosperità, l’essere costruttivi, il modo di agire americano. È
facile ridere, ma in realtà essi usano un grandissimo modello dello sforzo
96
umano: un modello che in primo luogo implica un criterio impersonale, in
secondo luogo implica un criterio mondano, e in terzo luogo abitua gli
uomini a pensare quantitativamente. Certamente l’idea confonde
l’eccellenza con le grandi dimensioni, la felicità con la velocità, e la natura
umana con un congegno meccanico. Tuttavia vi operano le stesse
motivazioni che da sempre animano ogni codice morale, e sempre lo
animeranno. Il desiderio di avere il più grosso, il più veloce, il più alto, o,
se si è fabbricanti di orologi da polso e di microscopi, il più piccolo; in
breve l’amore del superlativo e del «senza pari», che nella sua essenza e
potenzialmente è una nobile passione.
Certamente la concezione americana del progresso si è dimostrata
efficace in moltissime situazioni economiche e psicologiche. Ha
trasformato in attività produttiva un’aggressività, una sete di denaro e una
volontà di potenza assolutamente eccezionali. E non si può dire che abbia,
almeno in passato, frustrato gravemente la natura attiva dei membri attivi
della collettività. Questi ultimi hanno creato una civiltà che fornisce quelle
che a loro sembrano ampie soddisfazioni nel lavoro, nell’amore e nello
svago, e la foga della loro vittoria sulle montagne, sulle terre vergini, sulle
distanze e sulla concorrenza degli uomini ha rimpiazzato persino quella
parte del sentimento religioso che si manifesta in un senso di comunione
con l’universo. Il modello, nella sua successione di idea, azione e risultato,
si è dimostrato un successo così prossimo alla perfezione che ogni
tentativo di metterlo in dubbio viene considerato antiamericano.
Eppure questo modello è una maniera molto parziale e inadeguata di
rappresentarsi il mondo. La consuetudine di concepire il progresso come
«sviluppo» significa che molti aspetti dell’ambiente sono stati puramente e
semplicemente ignorati. Avendo davanti agli occhi questo stereotipo del
«progresso», la massa degli americani ha visto ben poco che non si
accordasse con quel concetto. Essi hanno visto l’espansione delle città, ma
non l’accrescimento dei quartieri poveri; hanno esaltato le statistiche del
censimento, ma si sono rifiutati di vedere il sovraffollamento; hanno
messo in risalto con orgoglio la loro crescita, ma non si sono curati dello
spopolamento delle campagne o dell’immigrazione non assimilata. Hanno
sviluppato furiosamente l’industria, con un irresponsabile spreco di risorse
naturali; hanno creato complessi industriali giganteschi, ma senza curarsi
dei rapporti umani. Si sono avviati a diventare una delle nazioni più
potenti della terra, ma senza curarsi di preparare le istituzioni e la mente
alla fine dell’isolamento. Si sono trovati coinvolti nella guerra mondiale
senza essere né moralmente né fisicamente preparati, e alla fine si sono
ritrovati alquanto delusi, ma non molto più esperti di prima.
97
La buona e la cattiva influenza dello stereotipo americano è stata
chiaramente visibile nella guerra mondiale. L’idea che la guerra potesse
essere vinta mobilitando eserciti illimitati, lanciando sottoscrizioni
illimitate, costruendo un numero illimitato di navi, producendo una
quantità illimitata di munizioni e fissandosi illimitatamente su queste sole
cose, rispondeva indubbiamente allo stereotipo tradizionale; e perciò ha
dato luogo a una sorta di miracolo materiale1. Ma quelli che più subivano
l’influsso di questo stereotipo non ponevano mente a quali dovessero
essere i frutti della vittoria e a come si dovesse conseguirli. Perciò non si
parlava dei fini, o li si considerava automatici, e non si riusciva a
concepire la vittoria, dato che lo stereotipo lo esigeva, se non come una
vittoria annientatrice sul campo di battaglia. In tempo di pace non si
chiedeva a che cosa serviva l’automobile più veloce, e in guerra non si
chiedeva a che cosa doveva servire la vittoria più completa. Ma a Parigi il
modello non corrispondeva alla realtà. In tempo di pace si può
indefinitamente sostituire a cose piccole cose grosse, e a cose grosse cose
ancora più grosse; in guerra, dopo che si è conquistata la vittoria assoluta,
non si può passare ad una vittoria più assoluta. Bisogna agire secondo un
modello totalmente diverso. E quando non si possiede questo modello, la
fine della guerra diventa, come è capitato a molta brava gente, un
«anticlimax» in un mondo grigio e scipito.
A questo punto lo stereotipo e i fatti, che non possono essere ignorati,
divergono in modo definitivo. Ci si arriva fatalmente, poiché la nostra
immagine delle cose è più semplice e più immobile del flusso degli
avvenimenti. Viene il momento, perciò, in cui i punti ciechi si spostano dai
margini al centro della visione, e allora, in mancanza di spiriti critici che
abbiano il coraggio di levare un grido d’allarme, e di leader capaci di
comprendere il mutamento, e di un popolo abituato alla tolleranza, lo
stereotipo, invece di risparmiare lo sforzo ed incanalare le energie come
fece nel 1917 e nel 1918, può render vano lo sforzo e sprecare le energie
degli uomini accecandoli, come è accaduto a coloro che invocavano una
pace cartaginese nel 1919 e deplorarono il Trattato di Versailles nel 1921.
3.
Accettato acriticamente, lo stereotipo non solo censura molte cose di
cui invece si dovrebbe tener conto, ma per di più è molto probabile che nel
giorno in cui si spezza si infranga con lui anche ciò di cui saggiamente
teneva conto. Questa è la punizione che Bernard Shaw assegna al Libero
Scambio, alla Libertà di Contrattazione, alla Libera Concorrenza, alla
98
Libertà Nazionale, al Laissez-faire e al Darwinismo. Cent’anni fa – ed egli
allora sarebbe stato sicuramente uno dei più mordaci paladini di queste
dottrine – non le avrebbe viste come le vede oggi nel Mezzo Secolo
Infedele1, semplici pretesti per
schiacciare il prossimo impunemente, mentre ogni interferenza da parte di un
governo dirigista, ogni organizzazione tranne quella della polizia intesa a proteggere
la truffa legalizzata dai pugni, ogni tentativo di introdurre nel caos industriale fini e
progetti e preveggenza sarebbero «contrari alle leggi dell’economia politica».
Come pioniere della marcia verso i pascoli del cielo2, avrebbe
compreso che del tipo di fini e di progetti e di preveggenza che poteva
offrire un governo come quello degli zii della regina Vittoria meno ce
n’era e meglio era. Avrebbe visto non già il forte schiacciare il debole, ma
lo sciocco schiacciare il forte. Avrebbe visto fini, progetti e preveggenza
all’opera per bloccare le invenzioni, per bloccare l’iniziativa, per bloccare
quello che egli infallibilmente avrebbe salutato come il prossimo stadio
dell’Evoluzione Creatrice.
Anche ora Shaw non mostra molto entusiasmo per gli interventi dei
governi dirigisti esistenti, ma in teoria è schierato al polo opposto del
laissez-faire. Prima della guerra il pensiero più avanzato si era anch’esso
schierato contro l’idea tradizionale che, dando libero gioco a tutti i fattori,
la saggezza si sarebbe fatta strada da sola, creando l’armonia. Dopo la
guerra e l’esperienza che questa ha fornito in fatto di governi dirigisti,
assistiti da censori, propagandisti e spie, Roebuck Ramsden e la Libertà
Naturale sono stati riammessi nella cerchia dei pensatori seri.
C’è un elemento comune a questi cicli. In ogni sistema di stereotipi c’è
un punto in cui cessa lo sforzo e le cose accadono spontaneamente, proprio
come si vorrebbe. Lo stereotipo del progresso, possente promotore di
attività, soffoca quasi totalmente il tentativo di decidere in quale attività
lanciarsi e per quale motivo in quella e non in un’altra attività. Il laissezfaire, provvidenziale liberazione dalla stupida burocrazia, presume che gli
uomini si avvieranno per combustione spontanea verso un’armonia
prestabilita. Il collettivismo, antidoto all’egoismo spietato, presuppone
nella visione marxista un determinismo economico verso l’efficienza e la
saggezza dei funzionari socialisti. Infine il governo forte, l’imperialismo
all’interno e all’estero, che nei suoi esempi migliori è profondamente
conscio del prezzo del disordine, si affida all’idea che tutto ciò a cui i
governanti danno importanza sarà noto ai governanti. In ogni teoria vi è un
punto di cieco automatismo.
Questo punto cieco occulta qualche fatto che, se fosse tenuto presente,
99
frenerebbe il movimento fondamentale che lo stereotipo provoca. Se colui
che crede nel progresso dovesse chiedersi, come il cinese della storiella,
che cosa vuol fare del tempo che ha risparmiato superando il record, se il
paladino del laissez-faire dovesse contemplare non le libere ed esuberanti
energie degli uomini, ma ciò che taluni chiamano la natura umana, se il
collettivista mettesse al centro della sua attenzione il problema del come
garantirsi i suoi funzionari, se l’imperialista osasse dubitare della propria
ispirazione, vedremo più Amleti e meno Enrichi Quinti. Infatti questi punti
ciechi tengono lontane quelle immagini distraenti che, con le relative
emozioni, potrebbero provocare esitazione e far vacillare la risoluzione. Di
conseguenza lo stereotipo non solo risparmia tempo in una vita già molto
impegnata, ed è perciò una difesa della nostra posizione nella società, ma
tende anche a proteggerci dagli effetti spossanti del tentativo di vedere il
mondo con sguardo fermo, e di vederlo nella sua totalità.
100
IX.
I codici e i loro nemici
1.
Chiunque abbia aspettato un amico in fondo al marciapiede di una
stazione ferroviaria ricorderà quante strane persone abbia scambiato per
lui. La foggia di un cappello, un passo un po’ caratteristico suscitavano
alla mente in modo vivido l’immagine della persona attesa. Nel sonno un
tintinnìo può sembrare il rintocco di una grande campana; il lontano colpo
di un martello può sembrare uno scoppio di tuono. Le nostre costellazioni
di immagini risponderanno a uno stimolo che forse somiglia solo
vagamente a un qualche loro aspetto. Nell’allucinazione possono invadere
tutta la coscienza. Oppure possono entrare appena nella zona della
percezione, benché io tenda a credere che una tale esperienza sia
estremamente rara e molto raffinata, come quando fissiamo una parola o
un oggetto familiare, ed esso cessa a poco a poco di essere familiare. È
certo che per lo più il modo in cui vediamo le cose è una combinazione di
quello che c’è e di quello che ci aspettavamo di trovare. Il cielo non è lo
stesso per un astronomo e per una coppia di innamorati; una pagina di
Kant provocherà un corso di pensieri diverso in un kantiano e in un
empirista assoluto; la bella di Tahiti è più attraente agli occhi del suo
corteggiatore tahitiano che a quelli dei lettori del «National Geographic
Magazine».
La competenza in una materia è, in realtà, il moltiplicarsi degli aspetti
che siamo preparati a scoprire, più l’abitudine a fare la tara sulle nostre
aspettative. Mentre all’ignorante tutte le cose sembrano uguali, e la vita
non è che una cosa dopo l’altra, per lo specialista le cose hanno un alto
grado di individualità. Per un autista, un buongustaio, un intenditore, un
membro del Gabinetto presidenziale, o la moglie di un professore vi sono
distinzioni e qualità evidenti, che non sono affatto evidenti alla persona
comune che discute di automobili, vini, opere d’arte, repubblicani e facoltà
universitarie.
Ma nelle opinioni pubbliche pochi possono essere esperti, dal momento
che la vita, come Bernard Shaw ha reso chiaro, è così breve.Quelli che
sono esperti lo sono soltanto in poche materie. Anche tra i militari di
101
professione, come abbiamo imparato durante la guerra, gli specialisti di
cavalleria non si dimostravano necessariamente brillanti in fatto di trincee
e di carri armati. Anzi, qualche volta un po’ di competenza in una modesta
materia può semplicemente esasperare la normale tendenza umana a
cercare di fare entrare a forza negli stereotipi tutto ciò che può esservi fatto
entrare a forza, e a gettar via ciò che non vi si adatta.
Se non stiamo molto attenti, tendiamo a figurarci tutto quello che ci
sembra conosciuto con l’ausilio di immagini già presenti nella nostra
mente. Così, nella visione americana del Progresso e del Successo, c’è
un’immagine precisa della natura e della società. È il tipo di natura umana
ed è il tipo di società che producono logicamente il tipo di progresso che
viene considerato ideale. E quindi, quando cerchiamo di descrivere o
spiegare davvero gli uomini riusciti, e gli avvenimenti che sono realmente
accaduti, ascriviamo ad essi le qualità che sono presupposte negli
stereotipi.
Queste qualità vennero standardizzate piuttosto candidamente dagli
economisti di altri tempi. Essi si misero a descrivere il sistema sociale
sotto cui vivevano, e lo trovarono troppo complicato per essere espresso in
parole. Così costruirono quello che sinceramente speravano fosse un
diagramma semplificato, non troppo diverso, come principio e come
verosimiglianza, dal parallelogramma con zampe e testa con cui il
bambino disegna una complicata mucca. Lo schema comprendeva un
capitalista che aveva diligentemente messo via un capitale con i risparmi
del suo lavoro, un imprenditore che immaginava una domanda socialmente
utile e organizzava una fabbrica, una raccolta di operai che contrattavano
liberamente, prendere o lasciare, il loro lavoro; un proprietario terriero e
un gruppo di consumatori che compravano sul mercato più conveniente
quei beni che secondo un rapido calcolo piacere-dolore sapevano che
avrebbero dato loro il massimo piacere. Il modello funzionava, e le
persone del tipo postulato dal modello, che vivevano nel tipo di mondo
postulato dal modello, invariabilmente collaboravano in modo armonioso
nei libri dove il modello veniva descritto.
Con modifiche e abbellimenti, questa finzione usata dagli economisti
per semplificare il loro pensiero fu smerciata e volgarizzata finché per
vasti settori della popolazione s’impose come la mitologia economica del
giorno. Forniva una versione-tipo del capitalista, dell’imprenditore,
dell’operaio e del consumatore a una società che naturalmente era più
impegnata a conseguire il successo che a spiegarlo. Gli edifici che
sorgevano, e i conti in banca che si accumulavano, erano la prova che lo
stereotipo del modo in cui si era arrivati a tutto ciò era corretto. E quelli
102
che più beneficiarono del successo arrivarono a credere d’essere il tipo di
uomini che s’immaginava che fossero. Non sorprende che gli amici
ingenui degli uomini di successo, quando leggono la biografia ufficiale e il
necrologio, debbano faticare a non domandarsi se quello sia proprio il loro
amico.
2.
Naturalmente il ritratto ufficiale riusciva irriconoscibile agli sconfitti e
alle vittime. Infatti, mentre coloro che impersonavano il progresso ben di
rado si soffermavano a indagare se erano arrivati per la via tracciata dagli
economisti, o per un’altra via ugualmente accettabile, i falliti indagavano.
«Nessuno – disse William James1 – penetra una generalizzazione al di là
della sua conoscenza dei dettagli». I capitani d’industria vedevano nei
grandi monopoli i monumenti del (loro) successo; i concorrenti sconfitti
vedevano in essi i monumenti del (loro) insuccesso. Perciò i primi
magnificavano le economie e le virtù della grande industria, chiedevano
mano libera, dicevano di essere gli agenti della prosperità e i promotori del
commercio. I vinti mettevano l’accento sugli sprechi e le brutalità dei
monopoli, e reclamavano a gran voce che il Dipartimento della Giustizia
liberasse l’economia dalle cospirazioni. Nella stessa situazione una parte
vedeva il progresso, l’economia e uno splendido sviluppo; l’altra parte
vedeva la reazione, il dispendio esagerato e la limitazione delle attività
economiche. Per dimostrare i due lati della disputa si pubblicarono volumi
di statistiche e aneddoti sulla verità effettiva e sulla verità nascosta, sulla
verità più profonda e sulla verità più generale.
Infatti, quando un sistema di stereotipi è ben stabilito, la nostra
attenzione si rivolge a quei fatti che lo appoggiano e si distoglie da quelli
che lo contraddicono. Ed è forse proprio perché sono già predisposte che le
persone bonarie scoprono tante occasioni di bontà e le persone maligne
tante ragioni di malanimo. Si parla giustamente di persone che vedono
attraverso occhiali rosa o al contrario con occhio invidioso. Se, come
scrisse una volta Philip Littell di un celebre professore, noi vediamo la vita
riflessa oscuramente nello specchio di classe, i nostri stereotipi di come
sono i ceti superiori e le classi inferiori non saranno contaminati dalla
comprensione. Ciò che è estraneo sarà respinto, ciò che è diverso cadrà
sotto sguardi che non vedono. Noi non vediamo quello che i nostri occhi
non sono abituati a considerare. Noi siamo colpiti, talvolta
consapevolmente, più spesso senza saperlo, da quei fatti che si attagliano
alla nostra filosofia.
103
3.
Questa nostra filosofia è una serie più o meno organizzata di immagini
per descrivere il mondo che non si vede. Ma non solo per descriverlo:
anche per giudicarlo. E perciò gli stereotipi sono carichi di preferenze,
soffusi di simpatia o antipatia, abbarbicati a timori, brame, passioni,
orgoglio, speranze. Ciò che evoca lo stereotipo viene giudicato con il
sentimento più appropriato; tranne quando deliberatamente teniamo in
sospeso il pregiudizio, noi non giudichiamo cattivo un uomo dopo averlo
esaminato. Vediamo un uomo cattivo. Vediamo un’aurora rugiadosa, una
fanciulla verginale, un prete santo, un inglese privo di spirito, un
pericoloso rosso, uno spensierato bohémien, un pigro indù, uno scaltro
orientale, uno slavo sognatore, un capriccioso irlandese, un cupido ebreo,
un americano al cento per cento. Nel mondo di ogni giorno il vero modo di
giudicare è spesso questo, molto in anticipo sui dati di fatto: un modo che
già contiene in sé la conclusione che i dati di fatto quasi certamente
confermeranno. In questo tipo di giudizio non entrano giustizia, né pietà,
né verità, perché il giudizio ha preceduto i dati di fatto. D’altronde un
popolo senza pregiudizi, un popolo che abbia una visione del tutto
neutrale, è talmente impensabile in qualsiasi delle civiltà, di cui mette
conto parlare, che nessun sistema educativo potrebbe mai basarsi su
quell’ideale. Possiamo individuare il pregiudizio, tenerne conto e renderlo
più sofisticato, ma fintantoché gli uomini saranno costretti dalla loro
finitezza a comprimere in un breve periodo d’istruzione scolastica la
preparazione ad affrontare un’immensa civiltà, dovranno portare con sé
immagini di essa e avere pregiudizi. I loro pregiudizi potranno essere o
non essere benevoli, benevoli verso gli altri, verso altre idee; potranno
suscitare l’amore di ciò che si ritiene un bene positivo, oppure l’odio di ciò
che non è compreso nella loro versione del bene: la natura dei pregiudizi
condizionerà la qualità dei pensieri e delle azioni degli individui.
La moralità, il buon gusto e le buone maniere dapprima standardizzano
e quindi accentuano taluni di questi pregiudizi latenti. Adattandoci al
nostro codice, adattiamo ad esso pure i fatti che vediamo. Dal punto di
vista razionale i fatti sono neutrali rispetto a tutti i nostri concetti di bene e
male. Di fatto i nostri canoni determinano in larga misura ciò che
percepiamo e il modo in cui lo percepiamo.
Infatti un codice morale è uno schema di comportamento applicato a un
certo numero di occasioni tipiche. Comportarsi come prescrive il codice è
servire lo scopo che il codice persegue. Questo può essere la volontà
divina, o quella del re, o la salvezza individuale in un paradiso
104
tridimensionale ben tangibile, il successo sulla terra o la dedizione al
genere umano. In ogni caso gli autori del codice scelgono certe situazioni
tipiche, e quindi, mercé una qualche forma di ragionamento o intuizione,
deducono il tipo di comportamento che condurrebbe alla meta che
riconoscono. Le regole valgono dove valgono.
Ma nella vita quotidiana come fa un uomo a sapere se la sua situazione
è quella che aveva in mente il «legislatore»? Gli si ingiunge di non
uccidere. Ma se i suoi figli vengono aggrediti, gli è consentito di uccidere
per impedire un’uccisione? I dieci comandamenti non si pronunciano su
questo punto. Perciò ogni codice ha intorno un nugolo di interpreti che
deducono casi più specifici. Supponiamo allora che i dottori della legge
decidano che gli è consentito uccidere per autodifesa. Per un altro
individuo il dubbio è quasi altrettanto forte; come fa a sapere che la sua
definizione dell’autodifesa è giusta, o che non si tratta invece di un
malinteso, che l’aggressione se l’è immaginata e che l’aggressore in realtà
è lui? Forse ha provocato lui l’aggressione. Ma che cos’è una
provocazione? Proprio questo genere di confusione infettava le menti di
moltissimi tedeschi nell’agosto 1914.
Nel mondo moderno assai più grave di qualsiasi differenza di codice
morale è la differenza nell’assunzione dei fatti a cui il codice viene
applicato. Le formule religiose, morali e politiche non distano le une dalle
altre quanto i fatti supposti dai loro fedeli. In tal caso, anziché confrontare
gli ideali, è utile riesaminare le visioni dei fatti. Perciò la regola di fare agli
altri quello che si vorrebbe che gli altri facessero a noi, poggia sulla
convinzione che la natura umana sia uniforme. L’affermazione di Shaw
che non si deve fare agli altri quello che si vorrebbe che gli altri facessero
a noi, perché i loro gusti possono essere diversi, poggia sulla convinzione
che la natura umana non sia uniforme. La massima che la concorrenza è
l’anima del commercio sintetizza un intero tomo di postulati circa i
moventi economici, i rapporti di lavoro e il funzionamento di un
particolare sistema commerciale. La tesi che l’America non avrà mai una
marina mercantile, se non sarà posseduta e gestita dai privati, presume
l’esistenza provata di un certo nesso tra un certo tipo di profitto e un certo
tipo di incentivo. La giustificazione della dittatura, dello spionaggio e del
terrore da parte del propagandista bolscevico, perché «ogni stato è un
apparato di violenza»1, è un giudizio storico la cui verità non è affatto
evidente di per sé al non-comunista.
Alla base di ogni codice morale c’è un’immagine della natura umana,
una carta dell’universo e un’interpretazione della storia. Le regole del
codice si applicano alla natura umana (così come la si immagina), in un
105
universo (così come lo si immagina), dopo una storia (interpretata in un
dato modo). Nella misura in cui i fatti della personalità, dell’ambiente e
della memoria sono diversi, è difficile applicare con successo le regole del
codice. S’intende che ogni codice morale deve concepire in un modo o
nell’altro la psicologia umana, il mondo materiale e la tradizione. Ma nei
codici che subiscono l’influsso della scienza, si sa che la concezione è
un’ipotesi, mentre nei codici che ci giungono acriticamente dal passato, o
che sgorgano dalle caverne dello spirito, la concezione non viene vista
come un’ipotesi da verificare o da contraddire, ma come una convenzione
che si accetta senza avanzare dubbi. Nel primo caso l’uomo considera con
umiltà le sue convinzioni, perché sa che sono problematiche e incomplete;
nel secondo è dogmatico, perché la sua convinzione è mito conchiuso. Il
moralista che accetta la disciplina scientifica, pur non conoscendo tutto, sa
di essere sulla via di conoscere qualcosa; il dogmatico, col suo mito, crede
di partecipare dell’onniscienza, pur non possedendo i criteri con cui
distinguere la verità dall’errore. Infatti il segno distintivo del mito è che la
verità e l’errore, la realtà e la favola, il documento e la fantasia, stanno tutti
sullo stesso piano di credibilità.
Sicché il mito non è necessariamente falso. Può anche darsi che sia
completamente vero. Può darsi che sia parzialmente vero. Se è da lungo
tempo che influenza la condotta umana, è quasi certo che conterrà molte
cose profondamente vere e importanti. Ciò che un mito non contiene mai è
il potere critico di separare la sua verità dai suoi errori. Infatti a questo
potere si perviene solo quando ci si renda conto che nessuna opinione
umana, quale che sia la sua presunta origine, è troppo alta per misurarsi
con i fatti, che qualsiasi opinione è solo l’opinione di qualcuno. E se si
chiede perché la prova dei fatti sia preferibile a qualsiasi altra, non è
possibile rispondere se non si ha intenzione di usare la prova per provarla.
4.
L’affermazione che i codici morali presuppongono una particolare
visione dei fatti è suscettibile, mi sembra, di schiaccianti dimostrazioni.
Nell’espressione «codici morali» comprendo ogni tipo di codice:
personale, familiare, economico, professionale, legale, patriottico,
internazionale. Al centro di ognuno c’è un complesso di stereotipi sulla
psicologia, sulla sociologia e sulla storia. È raro che la stessa visione della
natura umana, delle istituzioni o della tradizione resti costante in tutti i
nostri codici. Si confrontino, ad esempio, il codice economico e quello
patriottico. È in atto una guerra che si suppone coinvolgere egualmente
106
tutti. Due uomini sono soci in affari. Uno si arruola volontario, l’altro
ottiene una commessa bellica. Il soldato sacrifica tutto, forse anche la vita.
Viene pagato un dollaro il giorno, e nessuno dice, nessuno crede, che si
potrebbe renderlo un soldato migliore con una qualche forma di incentivo
economico. Questo movente scompare dalla sua natura umana. Il socio
invece sacrifica molto poco, intasca un bel profitto e pochi dicono o
credono che produrrebbe le munizioni in mancanza di un incentivo
economico. Forse gli fanno un torto. Sta di fatto che il codice patriottico
convenzionale presuppone un certo tipo di natura umana, il codice
commerciale ne presuppone un altro. E i codici probabilmente aderiscono
alla realtà in una misura tale che quando un individuo adotta un certo
codice tende a mostrare il tipo di natura umana che il codice richiede.
Ecco perché è così pericoloso generalizzare sulla natura umana. Un
padre amorevole può essere un duro padrone, un fervente riformatore
municipale e un rapace sciovinista quando è all’estero. La sua vita
familiare, la sua attività economica, la sua politica interna e la sua politica
estera poggiano su interpretazioni totalmente diverse di come è fatto il suo
prossimo e di come lui deve comportarsi. Queste interpretazioni
differiscono nella stessa persona a seconda dei codici, i codici differiscono
in qualche modo tra persone dello stesso ambiente sociale, differiscono
largamente da un ambiente sociale ad un altro, e tra due nazioni o due
razze; possono differire a tal punto da escludere la possibilità di un
presupposto comune. Ecco perché individui professanti lo stesso bagaglio
di convinzioni religiose possono combattersi in guerra. L’elemento della
loro fede che determina la condotta è l’interpretazione dei fatti da essi
accolta.
È qui che i codici entrano così sottilmente e in modo così contagiante
nella formazione dell’opinione pubblica. La teoria ortodossa afferma che
un’opinione pubblica costituisce un giudizio morale su un gruppo di fatti.
La teoria che avanzerei io è che, allo stato attuale dell’istruzione,
un’opinione pubblica è soprattutto un’interpretazione moralizzata e
codificata dei fatti. Mi sembra che la costellazione di stereotipi che sta alla
base dei nostri codici determini largamente in quale ordine di fatti li
noteremo e in quale luce li vedremo. È per questo che, con la migliore
volontà del mondo, la politica dell’informazione seguita da un giornale
tende ad appoggiare il suo orientamento generale; è per questo che un
capitalista vede un complesso di fatti, e certi aspetti della natura umana, e
li vede davvero; è per questo che il suo avversario socialista vede un altro
complesso di fatti e altri aspetti, e ciascuno considera l’altro irragionevole
o perverso, mentre la differenza reale tra di loro è una differenza di
107
percezione. Questa differenza è determinata dalla differenza esistente tra
l’insieme degli stereotipi capitalisti e l’insieme di quelli socialisti. «In
America non ci sono classi», scrive un giornalista americano. «La storia di
tutte le società sinora esistite è una storia di lotte di classe», afferma il
Manifesto comunista. Se si ha in mente lo schema del giornalista, si
vedranno con gran chiarezza i fatti che lo confermano, in modo vago e
inefficace quelli che lo contraddicono. Se si ha in mente lo schema
comunista, non solo si vedranno cose diverse, ma si vedrà con un risalto
completamente diverso quello che per avventura si sta vedendo insieme al
giornalista.
5.
E dato che il mio sistema morale si basa sull’interpretazione dei fatti
che io accetto, colui che nega i miei giudizi morali o la mia interpretazione
dei fatti appare ai miei occhi perverso, estraneo, pericoloso. Come debbo
spiegarmelo? L’avversario deve sempre venire spiegato, e l’ultima
spiegazione che andiamo a cercare è che egli veda un diverso ordine di
fatti. Evitiamo una tale spiegazione perché mina i fondamenti stessi della
nostra sicurezza di aver visto la vita diligentemente e di averla vista nella
sua interezza. Solo quando ci abituiamo a riconoscere nelle nostre opinioni
un’esperienza parziale vista attraverso i nostri stereotipi, diventiamo
veramente tolleranti verso l’avversario. Senza quest’abitudine noi
crediamo nell’assolutezza della nostra visione, e di conseguenza nel
carattere perfido di ogni opposizione. Infatti gli uomini, pur essendo
disposti ad ammettere che esistono due lati di una «questione», non
credono che vi siano due lati di quello che considerano un «fatto». E
davvero non se ne convincono se non quando, dopo una lunga educazione
critica, si rendono pienamente conto di quanto la loro percezione dei dati
sociali sia soggettiva e indiretta.
Così quando due fazioni vedono con intensità ciascuna il suo aspetto,
ed escogitano le loro spiegazioni di ciò che è vero, è quasi impossibile che
si riconoscano reciprocamente dell’onestà. Se lo schema si adatta alla loro
esperienza in un momento cruciale, non lo considerano più
un’interpretazione. Lo considerano «realtà». Può anche non somigliare alla
realtà, se non in quanto perviene a una conclusione che si attaglia ad
un’esperienza reale. Posso rappresentare il mio viaggio da New York a
Boston tirando una linea diritta su una carta geografica, proprio come un
individuo può vedere il suo trionfo come il termine di una via diritta e
stretta. La strada per cui sono andato davvero a Boston può essere stata
108
piena di deviazioni, svolte e contorcimenti, proprio come il suo cammino
può aver comportato molte cose oltre l’iniziativa, l’applicazione e il
risparmio. Ma sempre che io raggiunga Boston ed egli il successo, il
tragitto in linea d’aria e la via diritta possono andare come diagrammi
bell’e pronti. Solo quando qualcuno cerca di seguirli, e non arriva,
dobbiamo rispondere a delle obiezioni. Se noi insistiamo sui nostri
diagrammi ed egli insiste a respingerli, ben presto noi tendiamo a
considerarlo uno sciocco pericoloso, ed egli tende a considerarci bugiardi e
ipocriti. Così gradualmente dipingiamo ritratti l’uno dell’altro. Infatti
l’avversario si presenta come colui che dice: male, sii il mio bene. Egli è
una seccatura che non rientra nel nostro schema di cose. Ciò nondimeno vi
si intromette. E poiché nella nostra mente questo schema si fonda su fatti
incontrovertibili corroborati da una logica irresistibile, è necessario
trovargli un posto nello schema. È raro che in politica o nelle vertenze
sindacali gli si faccia posto mediante la semplice ammissione che egli ha
guardato la stessa realtà e ne ha visto un altro aspetto. Questo metterebbe
in pericolo l’intero schema.
Così, a Parigi, Fiume per gli italiani era italiana. Non era
semplicemente una città che sarebbe stato opportuno includere nel regno
d’Italia; era italiana. Fissavano la loro attenzione esclusivamente sulla
maggioranza italiana residente entro i confini legali del nucleo urbano. I
delegati americani, avendo visto più italiani a New York che a Fiume,
senza per questo considerare italiana New York, guardavano a Fiume
come ad un porto di accesso all’Europa centrale. Vedevano con chiarezza
gli jugoslavi nei sobborghi e il retroterra non italiano. Perciò a Parigi
alcuni italiani cercarono una spiegazione convincente della perversità
americana. La trovarono in una voce, partita da chi sa dove, secondo cui
un influente diplomatico americano era nelle mani di un’amante jugoslava.
Lei era stata vista… lui era stato visto… a Versailles appena fuori del
boulevard… la villa dai grandi alberi.
Questo è un modo piuttosto comune di svuotare di contenuto
un’opposizione. Nella loro forma più calunniosa queste accuse di rado
raggiungono la pagina stampata, e un Roosevelt può essere obbligato ad
aspettare degli anni, e un Harding dei mesi, prima di poter far scoppiare il
bubbone e porre fine ad una campagna di voci che si è diffusa in ogni
circolo. I personaggi pubblici debbono sopportare una dose paurosa di
velenosa maldicenza nei club, nelle sale da pranzo e nelle camere da letto;
una maldicenza ripetuta, elaborata, fonte di riso e considerata deliziosa.
Queste cose, credo, sono più comuni in Europa che in America, e tuttavia è
raro che ci sia un funzionario americano su cui qualcuno non stia
109
raccontando uno scandalo.
Trasformiamo gli oppositori in scellerati e cospiratori. Se i prezzi
salgono spietatamente, vuol dire che i profittatori hanno cospirato; se i
ricchi sono troppo ricchi, è perché hanno rubato; se un’elezione molto
combattuta è stata persa, l’elettorato è stato corrotto; se un uomo di
governo fa qualcosa che si disapprova, è stato comprato o influenzato da
qualche losco individuo. Se gli operai sono inquieti, sono vittime di
agitatori; se sono inquieti in vaste zone, è in atto una cospirazione. Se non
si producono abbastanza aeroplani, è opera di spie; se ci sono disordini in
Irlanda, è l’«oro» tedesco o bolscevico. E se si è alla ricerca nevrastenica
di complotti, si finisce per vedere tutti gli scioperi, il Piano Plumb, la
ribellione irlandese, la sommossa araba, la restaurazione di re Costantino,
la Società delle Nazioni, i disordini messicani, il movimento per ridurre gli
armamenti, il cinema alla domenica, le gonne corte, l’infrazione delle leggi
proibizionistiche, il risveglio dei neri, come ramificazioni di un qualche
grandioso complotto macchinato da Mosca, o da Roma, o dalla
Massoneria, o dai giapponesi, o dai Savi di Sion.
110
X.
La scoperta degli stereotipi
1.
I diplomatici provetti, costretti ad indirizzarsi pubblicamente ai popoli
belligeranti, hanno imparato a usare un vasto repertorio di stereotipi.
Avevano a che fare con un’alleanza precaria di potenze, ciascuna delle
quali riusciva a mantenere l’unità interna soltanto in virtù di una guida
attentissima. Il soldato semplice e sua moglie, eroici e disinteressati al di là
di ogni limite registrato negli annali del coraggio, non erano però
abbastanza eroici per affrontare lietamente la morte in nome delle varie
idee che i ministeri degli Esteri di potenze straniere definivano essenziali
per l’avvenire della civiltà. Pochi soldati avrebbero attraversato volentieri
la terra di nessuno per conquistare a beneficio degli alleati certi porti,
miniere, passi montani e villaggi.
In uno dei paesi accadde che la fazione guerrafondaia che controllava il
ministero degli Esteri, l’Alto comando e la maggior parte della stampa,
rivendicasse certe parti dei territori di vari paesi vicini. Queste
rivendicazioni venivano chiamate la Grande Ruritania dalle classi colte
che consideravano Kipling, Treitschke e Maurice Barrès ruritani al cento
per cento. Ma quest’idea grandiosa non suscitava alcun entusiasmo
all’estero. E così, stringendo al cuore il più bel fiore del genio ruritano –
come diceva il loro vate – gli statisti della Ruritania si avviarono a dividere
e conquistare. Divisero la rivendicazione in settori. Per ciascun attore
evocarono lo stereotipo a cui ad uno o più dei loro alleati riusciva difficile
resistere, avendo anch’essi delle rivendicazioni per cui speravano di
guadagnarsi l’approvazione proprio grazie allo stesso stereotipo.
Il primo territorio era una regione montana abitata da contadini
appartenenti a un altro gruppo etnico. La Ruritania la esigeva per
completare i suoi confini geografici naturali. Fissando l’attenzione
abbastanza a lungo sul valore ineffabile di ciò che è naturale, quei
contadini stranieri si dissolvevano come nebbia al sole, e solo il profilo
delle montagne restava visibile. Il secondo territorio era abitato da ruritani,
e per il principio che nessun popolo deve vivere sotto il dominio straniero,
essi vennero riannessi. E poi veniva una città di notevole importanza
111
commerciale, non abitata da ruritani. Ma fino al Settecento aveva fatto
parte della Ruritania, e per il principio del Diritto Storico venne annessa.
Un po’ più in là c’era un magnifico giacimento minerario posseduto da
stranieri e sfruttato da stranieri. Fu annesso per il principio delle
riparazioni per danni. Al di là di questo c’era un territorio abitato per il 97
per cento da stranieri, che costituiva il confine geografico naturale di un
altro paese, mai appartenuto nella storia alla Ruritania. Ma in passato una
delle province che erano state federate nella Ruritania aveva avuto
commerci con quei mercati, e la cultura della classe superiore era ruritana.
Le terre vennero rivendicate per il principio della superiorità culturale e
della necessità di difendere la civiltà. Infine c’era un porto totalmente
estraneo alla Ruritania geograficamente, etnicamente, economicamente,
storicamente, tradizionalmente: fu rivendicato perché si sosteneva che era
necessario ai fini della difesa nazionale.
Nei trattati che hanno posto fine alla grande guerra di questi esempi se
ne trovano in abbondanza. Non è, beninteso, che io creda che fosse
possibile dare un nuovo assetto all’Europa sulla base di uno di questi
principi. Sono certo che non lo era. L’uso stesso di questi principi, così
pretenziosi e così assoluti, significava che non c’era alcuno spirito di
accomodamento e che perciò mancava la sostanza della pace. Infatti
quando si comincia a discutere di fabbriche, miniere, montagne, o anche
autorità politica, come esempi perfetti di qualche principio eterno o giù di
lì, non si discute più, si combatte. Questo principio eterno censura tutte le
obiezioni, isola il problema dal suo retroterra e dal suo contesto e mette in
moto nell’individuo forti emozioni, assai adatte al principio, estremamente
inadatte ai moli, ai magazzini e alla proprietà immobiliare. E quando si è
cominciato in questo stato d’animo non ci si può più fermare: esiste un
vero pericolo. Per farvi fronte si debbono invocare principi ancora più
assoluti, per poter difendere ciò che è esposto all’attacco. Poi si debbono
difendere le difese, erigere paracolpi e paracolpi per i paracolpi, finché
l’intera faccenda diventa così ingarbugliata che sembra meno pericoloso
combattere che continuare a discutere.
Spesso ci sono certi indizi che consentono di scoprire la falsa
assolutezza di uno stereotipo. Nel caso della propaganda ruritana i principi
si cancellavano a vicenda così rapidamente che si poteva agevolmente
capire com’era stato costruito l’argomento. La serie delle contraddizioni
dimostrava che per ogni territorio si impiegava lo stereotipo che avrebbe
annullato tutti i fatti che venivano a conflitto con la rivendicazione. La
contraddizione di questo tipo è spesso un buon indizio.
112
2.
Un altro indizio è l’incapacità di tener conto dello spazio. Nella
primavera del 1918, ad esempio, parecchie persone, inorridite dal ritiro
della Russia, chiedevano la «ricostituzione di un fronte orientale». La
guerra, com’essi la concepivano, si svolgeva su due fronti, e quando uno di
questi scompariva si creava un’esigenza subitanea di ricrearlo. L’esercito
giapponese, che non era impegnato, avrebbe dovuto tenere il fronte
sostituendo i russi. Ma c’era un ostacolo insuperabile. Tra Vladivostok e la
linea orientale c’erano cinquemila miglia di territorio, attraversate da una
sola decrepita ferrovia, ma gli entusiasti non riuscivano a tener presenti
quelle cinquemila miglia. La loro convinzione che un fronte orientale fosse
necessario era così soverchiante, e la loro fiducia nel valore dell’esercito
giapponese era così grande, che mentalmente avevano proiettato
quell’esercito da Vladivostok alla Polonia sul tappeto magico. Invano le
nostre autorità militari sostenevano che uno sbarco di truppe sulla costa
della Siberia aveva tanto poco a che fare col dare addosso ai tedeschi
quanto l’arrampicarsi dalla cantina al tetto del palazzo Woolworth aveva a
che fare con il raggiungere la luna.
In questo caso lo stereotipo era la guerra su due fronti. Sin dal
momento in cui la gente aveva cominciato ad immaginarsi la grande
guerra, aveva concepito la Germania come stretta in mezzo alla Francia e
alla Russia. Una generazione di strateghi, e forse due, erano vissute avendo
questa immagine visiva come punto di partenza di tutti i loro calcoli. Per
circa quattro anni ogni cartina che avevano visto aveva approfondito
l’impressione che questa fosse la guerra. Quando le cose presero un’altra
piega, non fu facile vederle come erano. Venivano viste attraverso lo
stereotipo, e i fatti in conflitto con quest’ultimo, come la distanza tra il
Giappone e la Polonia, non potevano presentarsi con chiarezza alla
coscienza.
È interessante notare che le autorità americane affrontarono i nuovi fatti
più realisticamente di quelle francesi. In parte perché (prima del 1914) non
avevano alcun preconcetto di come potesse essere una guerra sul
continente; in parte perché gli americani, tutti intenti alla mobilitazione
delle loro forze, avevano una visione del fronte occidentale che era essa
stessa uno stereotipo il quale escludeva dalla loro coscienza una
percezione veramente chiara degli altri teatri di guerra. Nella primavera
del 1918 questo modo di vedere americano non poteva competere con il
tradizionale modo di vedere francese, perché mentre gli americani
credevano enormemente nelle proprie forze, i francesi a quel punto (prima
113
di Cantigny e della seconda Marna) erano in preda ai più gravi dubbi. La
fiducia americana pervadeva lo stereotipo americano; gli dava quel potere
di possedere la consapevolezza, quella vivacità e quel sensato mordente,
quell’effetto stimolante sulla volontà, quell’interesse emotivo in quanto
oggetto di desiderio, quell’aderenza all’attività in corso, che James
considera caratteristici di ciò che consideriamo «reale»1. I francesi,
disperati, restavano ancorati all’immagine consueta. E quando le
grossolane realtà geografiche non si adattavano al preconcetto, venivano
censurate dalla mente, oppure venivano deformate. Perciò il problema di
far raggiungere i tedeschi dai giapponesi veniva in una certa misura
superato col far compiere ai tedeschi metà del cammino per incontrarli.
Tra il marzo e il giugno 1918 s’immaginò che un esercito tedesco stesse
operando nella Siberia orientale. Questo esercito fantasma era costituito da
alcuni prigionieri tedeschi realmente visti, da altri prigionieri tedeschi
immaginati, e soprattutto dall’illusione che quelle cinquemila miglia di
distanza in realtà non esistessero2.
3.
Un’immagine veritiera dello spazio non è cosa semplice. Se traccio su
una carta geografica una linea diritta tra Bombay e Hong Kong, e misuro
la distanza, non ho appreso assolutamente nulla sulla distanza che dovrei
percorrere in un viaggio che mi portasse fin lì. E anche se misuro
l’effettiva distanza che debbo percorrere, ne so ancora pochissimo finché
ignoro quali navi facciano quella linea, in quali date, con quale velocità, se
riuscirò a prenotare un posto e se ho mezzi sufficienti per pagare il
biglietto. Nella vita pratica lo spazio è una questione di mezzi di trasporto
disponibili, non di piani geometrici: come ben sapeva il vecchio magnate
delle ferrovie che minacciò di far crescere l’erba sulle strade di una città
che lo aveva offeso. Se viaggio in automobile e chiedo quanto disti il
luogo dove sono diretto, considero un perfetto idiota l’individuo che mi
dice tre miglia, e non fa menzione di una deviazione di sei miglia. Non mi
serve niente sapere che sono tremiglia a piedi: tanto varrebbe che mi si
dicesse che è un miglio a volo d’uccello. Io non volo come un uccello, e
nemmeno sto camminando. Mi serve sapere che per un’automobile sono
nove miglia, e anche, se questo è il caso, che sei di esse sono accidentate.
Mi secco con il pedone che mi dice che sono tre miglia, e penso male
dell’aviatore che mi ha detto che era un miglio soltanto. Parlano entrambi
dello spazio che devono coprire loro, non di quello che devo percorrere io.
Nel tracciare le frontiere l’incapacità di concepire la geografia pratica
114
di una regione ha fatto sorgere assurde complicazioni. Sotto qualche
formula generale, come quella dell’autodeterminazione, gli statisti in
momenti diversi hanno tracciato sulle carte geografiche linee, le quali,
constatate sul posto, correvano attraverso una fabbrica, tagliavano la strada
di un villaggio, spezzavano la navata di una chiesa o dividevano la cucina
e la stanza da letto di una casa colonica. In una regione messa a pascolo
sono state tracciate frontiere che separavano i pascoli dall’acqua o dal
mercato, e in una zona industriale frontiere che separavano gli scali
ferroviari dalle strade ferrate. Sulla carta etnica a colori la linea era
etnicamente giusta, cioè giusta nel mondo di quella carta etnica.
4.
Ma anche il tempo, non meno dello spazio, viene strapazzato. Un
esempio comune è quello dell’individuo che con un complicato testamento
cerca di controllare il suo denaro per lungo tempo dopo la sua morte.
Era intento del primo William James – scrive il suo pronipote Henry James1 –
assicurare che i figli (alcuni dei quali alla sua morte erano minorenni) si
qualificassero con la laboriosità e l’esperienza al godimento dell’ingente patrimonio
che egli prevedeva di trasmetter loro, e a questo fine lasciò un testamento che era un
complesso voluminoso di restrizioni e istruzioni. Con ciò egli mostrò quanto fosse
grande la sua fiducia nel proprio discernimento e la sua sollecitudine per il bene
morale dei suoi discendenti.
Il tribunale mandò all’aria il testamento. Infatti la legge, nella sua
opposizione ai diritti perpetui, riconosce che esistono precisi limiti
all’utilità di consentire a una persona di imporre il suo marchio morale su
un futuro sconosciuto. Ma il desiderio di imporlo è un tratto molto umano,
tanto umano che la legge gli consente di avere effetto per un periodo di
tempo limitato dopo la morte.
L’articolo che in ogni costituzione regola la procedura per
l’approvazione di eventuali emendamenti è un buon indice della fiducia
nutrita dagli estensori nell’influenza delle proprie opinioni sulle
generazioni successive. Ci sono, mi pare, alcuni stati americani che hanno
costituzioni quasi non suscettibili di emendamenti. I loro autori debbono
aver avuto uno scarso senso del fluire del tempo: per loro l’hic et nunc era
così certo, e il futuro così vago o così spaventoso, che hanno avuto il
coraggio di dire in che modo la vita dovesse svolgersi dopo la loro
scomparsa. E dato che le costituzioni sono difficili da emendare gli zelanti
del gusto della pietrificazione hanno amato in ogni tempo scrivere su
115
questo bronzo imperituro ogni genere di regole e restrizioni; le quali, se
essi avessero avuto un briciolo d’umiltà verso l’avvenire, non avrebbero
dovuto essere più permanenti di una legge ordinaria.
Nelle nostre opinioni entra largamente il pregiudizio sul tempo. Per un
individuo un’istituzione esistita per tutta la durata della sua vita cosciente
fa parte dell’assetto permanente dell’universo: per un altro è effimera. Il
tempo geologico è molto diverso dal tempo biologico. Il tempo sociale è il
più complesso di tutti. Lo statista deve decidere se i suoi calcoli debbano
essere a immediata o a lunga scadenza. Alcune decisioni vanno prese sulla
base di quello che accadrà nelle due prossime ore; altre su quello che
accadrà entro una settimana, un mese, una stagione, un decennio, quando i
figli o i nipoti saranno adulti. Gran parte della saggezza sta nella capacità
di individuare il concetto di tempo connaturato al problema che si sta
affrontando. Tra il sognatore che ignora il presente, e il filisteo che non
vede altro, c’è tutta una gamma di persone che impiegano un concetto
erroneo del tempo. Un’autentica scala di valori implica un senso molto
acuto dei tempi corrispondenti.
In qualche modo si deve pur concepire il tempo lontano, il passato e il
futuro. Ma, come dice James, «della lunga durata non abbiamo un senso
diretto di “percezione”»2. Il periodo più lungo che immediatamente
percepiamo è quello che viene chiamato il «presente apparente». Esso,
secondo Titchener, dura circa sei secondi3.
Tutte le impressioni comprese in questo periodo di tempo ci sono compresenti.
Ciò rende possibile la percezione di mutamenti e di fatti nonché di oggetti
stazionari. Il presente percettivo è integrato dal presente ideativo. Grazie alla
combinazione di percezioni e immagini mnemoniche, giorni, mesi, e persino anni
interi del passato vengono a fondersi nel presente.
In questo presente ideativo, la vivezza, come diceva James, è
proporzionale al numero di distinzioni che percepiamo al suo interno. Così
una vacanza in cui ci annoiavamo, perché non avevamo nulla da fare,
passa lentamente mentre è in atto, ma sembra brevissima nella memoria.
L’attività intensa uccide rapidamente il tempo, ma la sua durata è lunga
nella memoria. James ha scritto un brano interessante sul rapporto tra la
nostra capacità di distinzione e il nostro senso del tempo4:
Abbiamo ogni ragione di credere che le creature possono differire enormemente
nelle quantità di durata di tempo che avvertono intuitivamente, e nella distinzione
dei fatti che possono riempirla. Von Baer si è dato ad alcuni interessanti calcoli
sull’effetto di tali differenze nel mutare l’aspetto della natura. Immaginiamo di
essere capaci, nel giro di un secondo, di notare distintamente diecimila fatti, invece
116
di solo dieci, come succede adesso5; se la nostra vita fosse destinata a ritenere un
ugual numero di impressioni, potrebbe anche essere mille volte più breve.
Vivremmo quindi meno di un mese, e personalmente non sapremmo del mutamento
delle stagioni. Se nascessimo in inverno, crederemmo all’estate come oggi crediamo
ai calori dell’era carbonifera. I movimenti degli esseri organici sarebbero così lenti
per i nostri sensi da essere arguiti, non visti. Il sole sarebbe immobile in cielo, la
luna sarebbe quasi senza mutamento, e così via. Ma ora facciamo l’ipotesi inversa, e
supponiamo che un essere avverta solo un millesimo delle sensazioni da noi
avvertite in un determinato tempo, e di conseguenza viva mille volte più a lungo di
noi. Inverni ed estati sarebbero per lui come quarti d’ora. I funghi e le piante a
rapida crescita matureranno così velocemente da apparire creazioni istantanee; gli
arbusti annuali sorgeranno e spariranno dalla terra come fonti inquiete di acqua
bollente; i movimenti degli animali saranno invisibili, come ci sono invisibili i
movimenti delle pallottole e delle palle di cannone; il sole solcherà il cielo come una
meteora, lasciando una traccia di fuoco dietro di sé.
5.
Nel suo Outline of History Wells ha fatto uno sforzo coraggioso per
rendere chiaro «il vero rapporto tra il tempo storico e quello geologico»1.
Su una scala che rappresenta il tempo intercorso tra Colombo e noi in tre
pollici di spazio, il lettore dovrebbe percorrere cinquantacinque piedi per
arrivare all’epoca di chi ha istoriato le caverne di Altamira,
cinquecentocinquanta piedi per vedere i primi uomini di Neanderthal, un
miglio all’incirca per incontrare l’ultimo dinosauro. Una cronologia più o
meno precisa non si ha fino a dopo il mille avanti Cristo, e a quell’epoca
«Sargon I dell’impero degli Accadi-Sumeri era un ricordo remoto, […] più
remoto di quanto non sia Costantino il Grande dal mondo d’oggi […]
Ammurabi era morto da mille anni […] Stonehenge, in Inghilterra,
esisteva già da mille anni».
Wells scriveva con un intento preciso. «Nel breve periodo di diecimila
anni queste unità (in cui gli uomini si sono associati) sono passate dalla
piccola tribù familiare della prima civiltà neolitica agli estesi regni
unificati – estesi ma ancor troppo piccoli e parziali – del tempo presente».
Mutando la prospettiva temporale verso gli attuali problemi, Wells sperava
di mutare la prospettiva morale. Purtuttavia la misura astronomica del
tempo, quella geologica, quella biologica, qualsiasi misura telescopica che
minimizzi il presente non è «più vera» di una misura microscopica.
Simeon Strunsky ha ragione quando insiste che
se Wells ha in mente il suo sottotitolo, il «Probabile Futuro dell’Umanità», allora ha
diritto a chiedere un indeterminato numero di secoli per addivenire alla sua
117
soluzione. Se invece pensa di salvare questa civiltà occidentale, vacillante per
effetto della grande guerra, deve ragionare in termini di decenni o ventenni2.
Dipende tutto dallo scopo pratico per cui si adotta la misura. Ci sono
situazioni in cui occorre allungare la prospettiva temporale, e altre in cui
occorre abbreviarla.
Colui che dice che non importa se quindici milioni di cinesi muoiono
per una carestia, dal momento che nello spazio di due generazioni la
natalità compenserà la perdita, ha usato una prospettiva temporale per
giustificare la propria inerzia. La persona che vede come misero un sano
giovanotto, perché emotivamente troppo impressionata da uno stato
contingente di disagio, ha perso il senso della durata della vita del
mendicante. Il popolo che per amore della pace immediata è disposto a
tacitare un impero aggressivo, indulgendo ai suoi appetiti, consente a un
presente ingannevole di interferire nella pace dei suoi figli. Il popolo che
non avrà pazienza con un vicino fastidioso, che vuol portare tutto a uno
showdown, non è meno vittima di un presente ingannevole.
Il calcolo corretto del tempo entra in quasi tutti i problemi sociali.
Supponiamo, ad esempio, che si ponga una questione di legname. Alcuni
alberi crescono più rapidamente di altri. In questo caso una sana politica
forestale è quella per cui la quantità di alberi di ogni specie e di ogni età,
tagliata ad ogni stagione, venga rimpiazzata. Nella misura in cui questo
calcolo è giusto, si ottiene la massima economia: tagliare meno è uno
spreco, e tagliare di più è sfruttamento. Ma può venire un momento
d’emergenza, mettiamo il bisogno di abete rosso per aeroplani, creato da
una guerra, per cui la misura annuale dev’essere superata. Un governo
attento se ne renderà conto, e considererà il ripristino dell’equilibrio come
un impegno per il futuro.
Il carbone implica una teoria del tempo diversa, perché il carbone, a
differenza dell’albero, è prodotto al ritmo del tempo geologico. La
provvista è limitata. Perciò una giusta politica sociale comporta complicati
calcoli delle risorse mondiali disponibili, delle possibili dichiarate,
dell’attuale tasso di impiego, dell’attuale economia di impiego, e dei
combustili alternativi. Ma quando questo calcolo è stato compiuto, deve
poi essere quadrato con un standard ideale in cui è incluso il tempo.
Supponiamo, ad esempio, che i tecnici arrivino alla conclusione che gli
attuali combustibili vanno esaurendosi a un certo ritmo; che se non
vengono scoperte nuove fonti, l’industria entrerà in una fase di contrazione
in un preciso momento dell’avvenire. Dovremo allora determinare quanta
parsimonia e quanti sacrifici saranno necessari, dopo aver realizzato tutte
le economie possibili, per non derubare i posteri. Ma chi considereremo
118
posteri? I nostri nipoti? I nostri pronipoti? Forse, se ci renderemo conto
subito della necessità, decideremo di calcolare sulla base di cent’anni,
giudicandoli un ampio periodo di tempo per la scoperta di altri
combustibili. Le cifre, naturalmente, sono ipotetiche, ma facendo questo
calcolo applicheremo le conoscenze che possediamo. Daremo così al
tempo sociale il suo posto nell’opinione pubblica.
Immaginiamo ora un caso in qualche modo diverso: un contratto tra un
municipio e un’azienda tranviaria. L’azienda dichiara che non investirà il
suo capitale se non le verrà garantito per novantanove anni il monopolio
delle strade principali. Nella mente di coloro che fanno questa richiesta
novantanove anni sono come dire «per l’eternità». Ma supponiamo che vi
sia ragione di credere che le tranvie in superficie, alimentate da una
centrale elettrica e correnti su binari, siano destinate a passare di moda nel
giro di vent’anni. Allora sarebbe un pessimo contratto, che virtualmente
condannerebbe una generazione futura a un trasporto pubblico di qualità
inferiore. Se sottoscrivono un tale contratto i rappresentanti del municipio
dimostrano di non avere un senso preciso di che cosa siano novantanove
anni. Molto meglio dare adesso una sovvenzione all’azienda, per
invogliare il capitale, piuttosto che stimolare l’investimento indulgendo a
un senso fallace di eternità. Nessun rappresentante municipale e nessun
rappresentante di azienda ha il senso del tempo reale quando parla di
novantanove anni.
La storia come viene vista dal popolo è il regno delle confusioni sul
tempo. Per l’inglese medio, ad esempio, la condanna di Cromwell, la
corruzione dell’Act of Union, la carestia del 1847, sono torti subiti da
persone morte da molto tempo, e commessi da protagonisti anch’essi morti
da parecchio tempo, con cui nessuna persona vivente, irlandese o inglese,
ha alcun reale rapporto. Ma nella mente di un patriota irlandese questi
stessi fatti sono quasi contemporanei, la sua memoria è come uno di quei
dipinti storici in cui Virgilio e Dante siedono fianco a fianco a conversare.
Queste prospettive e questi scorci costituiscono una grande barriera tra i
popoli. È molto difficile per una persona attaccata a una tradizione
ricordare che cosa sia contemporaneo nella tradizione di un’altra. Quasi
nulla di ciò che va sotto il nome di Diritti Storici o Torti Storici può
considerarsi una visione veramente obiettiva del passato. Prendiamo, ad
esempio, la disputa franco-tedesca sull’Alsazia-Lorena. Tutto dipende
dalla data che si sceglie. Se si parte dai Rauraci e dai Sequi, le terre
storicamente fanno parte dell’antica Gallia. Se si preferisce Enrico I, sono
storicamente territorio tedesco; se si prende il 1273, appartengono alla
Casa d’Austria; se si prendono il 1648 e la pace di Westfalia sono per la
119
maggior parte francesi; se si prende Luigi XIV e l’anno 1688 sono quasi
completamente francesi. Se si ricorre all’argomento storico, quasi
sicuramente si sceglieranno quelle date del passato che appoggiano
l’opinione che si ha a proposito di quello che si deve fare adesso.
Le discussioni sulle «razze» e sulle «nazionalità» tradiscono spesso la
stessa visione arbitraria del tempo. Durante la guerra, sotto l’influsso di
fortissime emozioni, la differenza tra «teutoni» da una parte e
«anglosassoni» e francesi dall’altra, veniva ritenuta comunemente una
differenza eterna; erano sempre state razze in conflitto. Eppure, una
generazione addietro, storici come Freeman mettevano in risalto la comune
origine teutonica dei popoli dell’Europa occidentale, e gli etnologi
certamente sosterrebbero che i tedeschi, gli inglesi, e la maggior parte dei
francesi sono ramificazioni di quello che un tempo fu un ceppo unico. La
regola generale è questa: se si prova simpatia oggi per un popolo, si
riportano le ramificazioni al tronco; se si ha antipatia, si sostiene che le
distinte ramificazioni sono in realtà distinti ceppi. Nel primo caso si
concentra l’attenzione sul periodo in cui non erano distinguibili; nel
secondo, sul periodo nel quale hanno cominciato a distinguersi. E il modo
di vedere corrispondente allo stato d’animo viene assunto come la
«verità».
Una divertente variante è l’albero genealogico. Di solito una coppia
viene designata come «i capostipiti»; possibilmente una coppia legata ad
un avvenimento che dà lustro, come la Conquista Normanna. Questa
coppia non ha antenati. Non sono discendenti di nessuno. Ma in realtà
erano discendenti di antenati, e l’espressione che il tal dei tali è stato il
fondatore di questo casato significa non che egli è l’Adamo della sua
famiglia, ma che egli è quel particolare antenato da cui è opportuno
cominciare, o magari l’antenato più remoto di cui si abbia notizia. Ma le
tavole genealogiche rivelano un pregiudizio più profondo: a meno che la
linea femminile non sia particolarmente rimarchevole, la discendenza
passa attraverso i soli maschi. L’albero è maschile; in certi momenti le
femmine si aggiungono ad esso come api vaganti si posano su un antico
melo.
7.
È il futuro però il tempo più ingannevole di tutti. Qui la nostra
tentazione è di saltare certi passi necessari alla successione; e, dal
momento che siamo governati dalla speranza o dal dubbio, di esagerare o
di minimizzare il tempo occorrente a completare le varie parti di un
120
percorso. La discussione del ruolo esercitabile dai dipendenti nella
direzione dell’industria è irta di difficoltà di questo tipo. Infatti la direzione
è una parola che abbraccia molte funzioni1. Alcune non richiedono alcuna
preparazione; altre richiedono un po’ di preparazione; altre ancora si
possono imparare solo nel corso di una vita. E il programma veramente
giudizioso di democratizzazione industriale sarebbe quello fondato sui
tempi adatti, cosicché l’assunzione di responsabilità procedesse
parallelamente a un programma complementare di preparazione tecnica.
La proposta di un’immediata dittatura del proletariato è un tentativo di
saltare il tempo intermedio della preparazione; l’opposizione a ogni forma
di partecipazione alla responsabilità è un tentativo di negare il mutamento
nel tempo delle capacità umane. I concetti primitivi della democrazia,
come quello dell’avvicendamento nelle cariche, e del disprezzo per
l’esperto, non sono altro che il vecchio mito che la Dea della Saggezza sia
balzata fuori matura e armata di tutto punto dalla fronte di Giove. Queste
idee presuppongono che non occorra affatto imparare quello che richiede
anni per essere imparato.
La concezione del tempo è un elemento decisivo ogniqualvolta la frase
«gente arretrata» viene usata a fondamento di una politica. Il patto sociale
della Società delle Nazioni dichiara2, ad esempio, che «il carattere del
mandato deve differire a seconda dello stadio di sviluppo della
popolazione», nonché per altre ragioni. Certe collettività, afferma, «hanno
raggiunto uno stadio di sviluppo» in cui si può riconoscere
provvisoriamente la loro indipendenza, fatta eccezione per quei consigli e
quell’assistenza che saranno necessari «fintantoché non saranno in grado
di reggersi da sole». Il modo in cui i paesi mandatari e quelli sotto
mandato concepiscono questo periodo di tempo influirà profondamente sui
loro rapporti. Così nel caso di Cuba il giudizio del governo americano ha
coinciso praticamente con quello dei patrioti cubani, e sebbene ci siano
stati dei disordini, non c’è forse pagina più bella nella storia
dell’atteggiamento tenuto dalle grandi potenze verso le piccole. In questa
storia spesso le valutazioni non hanno coinciso. Quando il popolo
imperiale, a prescindere dalla sua espressione ufficiale, si è profondamente
convinto che l’arretratezza del popolo arretrato è così ostinata da non valer
la pena d’un rimedio, o così vantaggiosa da rendere inopportuno un
rimedio, il rapporto tra i due è sempre degenerato, avvelenando la pace del
mondo. Si sono avuti pochi casi, pochissimi, in cui l’arretratezza abbia
significato per la potenza dominante la necessità di un programma di
avanzamento,un programma con regole definite e precise valutazioni
temporali. Molto più spesso, in realtà tanto spesso da sembrare la regola,
121
l’arretratezza è stata concepita come un marchio di inferiorità intrinseco ed
eterno. E allora ogni tentativo di essere meno arretrati è stato accolto come
quella sedizione che, in queste condizioni, esso indubbiamente è. Nei
nostri stessi conflitti razziali possiamo constatare alcuni dei risultati
dell’incapacità di capire che il tempo avrebbe gradualmente cancellato il
costume servile dei neri, e che l’adattamento sociale fondato su questo
costume avrebbe cominciato a sgretolarsi.
È difficile non immaginarsi il futuro come se obbedisse ai nostri fini
attuali, non annullare tutto ciò che rimanda l’attuazione di ciò che
desideriamo, o non rendere immortale tutto ciò che sta tra noi e i nostri
timori.
8.
Nel mettere insieme le nostre opinioni pubbliche, dobbiamo non solo
immaginare più spazio di quello che vediamo con i nostri occhi, e più
tempo di quello che possiamo percepire, ma dobbiamo descrivere e
giudicare più individui, più azioni, più cose di quante possiamo mai
contare o immaginare con chiarezza. Dobbiamo al tempo stesso
sintetizzare e generalizzare; dobbiamo trascegliere campioni, e trattarli
come tipici.
Scegliere bene un buon campione di un grande universo non è facile. È
un problema di scienza della statistica, ed è una faccenda estremamente
difficile per coloro la cui matematica è primitiva, e la mia resta azoica
nonostante la mezza dozzina di manuali che una volta piamente mi
illudevo di aver capito. Tutto quello che sono riusciti a darmi è una
maggiore consapevolezza di quanto sia difficile classificare e campionare,
della facilità con cui spalmiamo un po’ di burro sull’intero universo.
Qualche tempo fa un gruppo di assistenti sociali di Sheffield, in
Inghilterra, si mise in testa di sostituire un quadro preciso
dell’equipaggiamento mentale degli operai di quella città all’immagine
impressionistica che se ne erano formati. Intendevano dire, sulla base di
qualche fatto concreto, quale fosse questo equipaggiamento. Scoprirono,
come noi tutti scopriamo nel momento in cui non ci abbandoniamo alla
prima impressione, di essere assediati dalle complicazioni. Del test che
impiegarono non occorre dire qui se non che si trattava di un ampio
questionario. Per comodità immaginiamo che le domande costituissero un
buon test dell’equipaggiamento mentale utile alla vita urbana inglese. In
teoria, allora, si sarebbero dovute porre queste domande a ciascun membro
della classe operaia. Ma non è facile sapere chi sono i lavoratori. E tuttavia
122
immaginiamoci pure che l’ufficio del censimento sappia identificarli.
C’erano dunque all’incirca centoquattromila uomini e centosettemila
donne che avrebbero giustificato o confutato le frasi occasionali sugli
«operai ignoranti» o sugli «operai intelligenti», ma nessuno poteva
sognarsi di interrogarli tutti e duecentomila.
Perciò gli assistenti sociali consultarono un eminente statistico, il
professor Bowley. Il suo parere fu che un buon campione avrebbe dovuto
comprendere non meno di 408 uomini e 408 donne. Secondo i calcoli
matematici, questo numero non avrebbe presentato deviazioni dalla media
superiori a un ventiduesimo. Dovevano interrogare perciò almeno 816
persone prima di poter pretendere di parlare dell’operaio medio. Ma a
quali 816 persone avrebbero dovuto rivolgersi?
Avremmo potuto raccogliere informazioni sugli operai a cui uno o l’altro di noi
aveva accesso già prima dell’inchiesta; avremmo potuto operare attraverso signori e
signore dediti alla filantropia che fossero in contatto con certi gruppi di operai in un
circolo, in una missione, in un ambulatorio, in una chiesa, in un centro sociale. Ma
un tale metodo di selezione avrebbe dato risultati assolutamente senza valore. Gli
operai così prescelti non sarebbero stati in alcun modo rappresentativi di ciò che
comunemente si dice «il lavoratore normale»; avrebbero rappresentato solo i
gruppetti a cui appartenevano.
Il modo giusto di procurarsi «vittime», al quale ci siamo rigorosamente attenuti
con un immenso investimento di tempo e di fatica, è quello di trovare gli operai con
un qualche sistema «neutrale» o «casuale».
Così fecero. E dopo tutte queste precauzioni non approdarono a una
conclusione più precisa di questa: che sulla base della loro classificazione,
e secondo il loro questionario, tra i 200 000 operai di Sheffield «circa un
quarto» erano «ben equipaggiati», «quasi tre quarti» erano
«inadeguatamente equipaggiati», e che «un quindicesimo circa» erano
«mal equipaggiati».
Si paragoni questo metodo coscienzioso e quasi pedante di arrivare a
un’opinione con i nostri soliti giudizi a proposito di masse di persone:
sugli irlandesi volubili, e sui francesi logici, e sui tedeschi disciplinati, e
sugli slavi ignoranti, e sui cinesi onesti, e sui giapponesi infidi, e via
dicendo. Tutte queste sono generalizzazioni tratte da campioni, ma i
campioni vengono scelti con un metodo che statisticamente è del tutto
inaccettabile. Così il datore di lavoro giudicherà la manodopera dal
dipendente più importuno che conosce, oppure dal più docile, e molti
gruppetti estremisti si sono figurati di essere un buon campione della
classe operaia. Quante opinioni femminili sulla «questione delle
domestiche» sono poco più che il riflesso del trattamento fatto alle proprie
123
domestiche da chi le esprime? La tendenza della mente non scientifica è di
trascegliere o imbattersi in un campione che rafforza o sfida i suoi
pregiudizi, e poi di assumerlo a rappresentativo di tutta una categoria.
Un bel po’ di confusione sorge allorché gli individui rifiutano di
classificarsi come noi li abbiamo classificati. La profezia sarebbe molto
più facile, solo che essi restassero dove li abbiamo messi. Ma in realtà
un’espressione come la classe operaia abbraccerà solo una parte della
verità, e per una parte del tempo. Quando si prendono tutte le persone che
stanno al di sotto di un certo livello di reddito, e le si chiama la classe
operaia, non si può fare a meno di presumere che le persone così
classificate si comporteranno secondo le stereotipo che si ha. Chi siano
precisamente queste persone non si è affatto certi. Gli operai dell’industria
e i minatori ci rientrano più o meno, ma i salariati agricoli, i piccoli
coltivatori diretti, i venditori ambulanti, i piccoli esercenti, i commessi, i
domestici, i soldati, i poliziotti, i pompieri sfuggono alla rete. La tendenza,
quando ci si rivolge alla «classe operaia», è di concentrare l’attenzione sui
due o tre milioni più o meno accertati di iscritti ai sindacati, e di trattarli
come se fossero i Lavoratori; agli altri diciassette o diciotto milioni di
individui che statisticamente farebbero anch’essi parte di questa categoria,
viene tacitamente attribuito il punto di vista che si suppone abbia il nucleo
organizzato. Quanto è stato ingannevole, nel 1918-21, attribuire alla classe
operaia inglese il punto di vista espresso nelle risoluzioni del Trades Union
Congress, e negli opuscoli scritti da intellettuali!
Lo stereotipo della Classe Operaia come Emancipatrice sceglie i dati
che lo sostengono e rigetta gli altri. E così, parallelamente ai movimenti
reali dei lavoratori, esiste una finzione del Movimento Operaio, in cui una
massa idealizzata muove verso una meta ideale. La finzione si rivolge al
futuro poiché nel futuro le possibilità sono quasi indistinguibili dalle
probabilità e così le probabilità dalle certezze. Se il futuro è abbastanza
lungo, la volontà umana potrebbe trasformare quello che è appena
concepibile in ciò che è assai probabile in ciò che per forza si avvererà.
James chiamava tutto questo la scala della fede, e diceva che «è una
collina di buona volontà su cui, per quanto riguarda le grandi questioni
della vita, gli uomini abitualmente vivono»1.
1. Non vi è nulla di assurdo nel ritenere veritiera una certa visione del
mondo.
2. Avrebbe potuto essere vera sotto certe condizioni;
3. Può essere vera anche ora.
4. È degna d’essere vera.
5. Dovrebbe essere vera.
124
6. Deve essere vera.
7. Sarà vera, in ogni caso sarà vera per me.
E, come si espresse in altro luogo2, «l’agire in questo modo può essere,
in certi casi particolari, il mezzo per rendere il fatto sicuramente vero alla
fine». Tuttavia nessuno più di lui avrebbe insistito che, per quanto dipende
da noi, dobbiamo evitare di sostituire la meta al punto di partenza,
dobbiamo evitare di riportare al presente ciò che il coraggio, lo sforzo e la
capacità potrebbero creare nel futuro. Eppure questa verità lapalissiana è
smisuratamente difficile come regola di vita, perché ognuno di noi è assai
poco preparato alla scelta dei propri campioni.
Se crediamo che una certa cosa dovrebbe essere vera, possiamo sempre
trovare un caso in cui è vera, oppure qualcuno che crede che dovrebbe
essere vera. È arduo, quando un fatto reale illustra una speranza, dare a
quel fatto il suo giusto peso. Quando le prime sei persone che incontriamo
sono d’accordo con noi, non è facile ricordare che possono avere tutte
quante letto lo stesso giornale a colazione. E tuttavia non possiamo inviare
un questionario a 816 campioni scelti a caso ogni volta che desideriamo
valutare una probabilità. Nel maneggiare una gran massa di fatti dobbiamo
presumere di non aver scelto dei veri campioni, se agiamo
sull’impressione del momento.
9.
E quando tentiamo di fare un passo più in là, per cercare le cause e gli
effetti di questioni complicate e lontane, l’opinione casuale gioca degli
scherzi. Ci sono ben pochi grossi problemi, nella vita pubblica, in cui la
causa e l’effetto siano immediatamente evidenti. Non sono ovvi nemmeno
agli occhi di studiosi che hanno dedicato anni, poniamo, a studiare i cicli
economici, o le fluttuazioni dei prezzi e dei salari, o la migrazione e
l’assimilazione dei popoli, o le mire diplomatiche delle potenze straniere.
Eppure in qualche modo si presume che si abbia tutti delle opinioni su
questi problemi, e non è affatto sorprendente che la forma più comune di
ragionamento sia quella intuitiva: post hoc ergo propter hoc.
Quanto più una mente è interpretata, tanto più facilmente elabora la
teoria per cui due cose che attraggono la sua attuazione
contemporaneamente sono in rapporto causale. Ci siamo già soffermati a
lungo sul modo in cui le cose colpiscono la nostra attenzione. Abbiamo
visto che il nostro accesso all’informazione è ostruito e incerto, e che la
nostra percezione è profondamente controllata dai nostri stereotipi; che le
125
prove che si offrono alla nostra ragione sono soggette a illusioni di difesa,
prestigio, moralità, spazio, tempo e campionamento. Ora è il caso di notare
che le opinioni pubbliche, dopo questo vizio iniziale, incontrano ulteriori
limitazioni, perché in una serie di fatti visti per lo più attraverso degli
stereotipi siamo pronti a considerare una successione o un parallelismo
come un rapporto di causa ed effetto.
È tanto più probabile che questo accada quando due idee, che sorgono
contemporaneamente, suscitano lo stesso sentimento. Se sorgono insieme è
probabile che suscitino lo stesso sentimento; e anche quando non arrivano
insieme è probabile che il forte sentimento connesso a una di loro risucchi
dagli angoli della memoria tutte le idee che abbiano un tono sentimentale
più o meno eguale. Così tutto ciò che è doloroso tende a connettersi in un
sistema di causa ed effetto, e lo stesso accade a tutto ciò che è piacevole.
11 novembre 1675. Quest’oggi sento che Dio ha scoccato un dardo nel centro di
questo Paese. Il vaiolo è in un esercizio all’insegna del Cigno, il nome dell’oste
dell’esercizio è Windsor. La figlia di costui è colpita dal male. È da osservare che
questo male comincia in un’osteria, a testimoniare il dispiacere di Dio per il peccato
dell’ubriachezza e per il moltiplicarsi delle osterie!1
Così scriveva Increase Mather, e così nell’anno 1919 scriveva un noto
professore di Meccanica Celeste a proposito della teoria di Einstein: «Può
ben essere che […] le insurrezioni bolsceviche siano in realtà le
manifestazioni visibili di un qualche profondo disturbo mentale
sottostante, di carattere mondiale […] questo stesso spirito di inquietudine
ha invaso la scienza»2.
Quando odiamo violentemente una cosa, noi facilmente le associamo
come causa o effetto la maggior parte delle altre cose che odiamo o
temiamo violentemente. Possono esser non più legate tra loro di quanto lo
siano il vaiolo o le osterie, o la relatività e il bolscevismo, ma sono avvinte
nella stessa emozione. In una mente superstiziosa, come quella del
professore di Meccanica Celeste, il sentimento è un flusso di lava fusa che
travolge e incorpora tutto ciò che trova sulla sua strada. Quando vi si scava
dentro si trova, come in una città sepolta, ogni genere di cose buffamente
intrecciate. Ogni cosa può essere messa in rapporto a ogni altra cosa,
purché desti lo stesso sentimento. E una mente che si trovi in questo stato
non può rendersi conto di quanto ciò sia assurdo. Antiche paure, rafforzate
da paure più recenti, si coagulano in un viluppo di paure, dove ogni cosa
che si paventa è la causa di ogni altra cosa che si paventa.
Di solito tutto ciò culmina nell’edificazione di un sistema del male, e di
un altro, che è il sistema del bene; allora si rivela il nostro amore
126
dell’assoluto. Infatti non abbiamo simpatia per gli avverbi che qualificano
e limitano3, poiché ingombrano le frasi, e ostacolano il sentimento
irresistibile. Preferiamo massimo e maggiore, minimo e minore, non ci
garbano le parole come piuttosto, forse, se, oppure, ma, verso, non del
tutto, quasi, temporaneamente, parzialmente. E tuttavia quasi tutte le
opinioni sulle questioni pubbliche hanno bisogno di un ridimensionamento
di questo genere, ma quando non ci controlliamo, tutto tende a comportarsi
in modo assoluto: cento per cento, dappertutto, per sempre.
Non basta dire che la nostra parte ha più ragione di quella avversaria,
che la nostra vittoria gioverà alla democrazia più della sua. Si deve
pretendere che la nostra vittoria porrà fine per sempre alla guerra, e salverà
il mondo alla democrazia. E quando la guerra è finita, pur avendo
abbattuto un male maggiore di quelli che ancora ci affliggono, la relatività
del risultato svanisce, l’assolutezza del male presente sopraffà il nostro
spirito, e ci sembra di essere impotenti perché non siamo stati irresistibili.
Il pendolo oscilla tra l’onnipotenza e l’impotenza.
Lo spazio reale, il tempo reale, le quantità reali, le responsabilità reali
vanno perduti. La prospettiva e lo sfondo e le dimensioni dell’azione
vengono ritagliati e congelati nello stereotipo.
1 Cfr., ad esempio, E. Locard, L’enquête criminelle et les méthodes scientifiques,
Flammarion, Paris 1920. Negli ultimi anni è stato raccolto parecchio materiale
interessante sulla credibilità del testimone, ed esso dimostra, come dice un acuto
recensore del libro del dottor Locard nel supplemento letterario del «Times» di Londra
del 18 agosto 1921, che la credibilità varia a seconda delle categorie di testimoni e delle
categorie di avvenimenti e anche a seconda del tipo di percezione. Così le percezioni
tattili, olfattive e gustative servono poco ai fini della testimonianza. Il nostro udito è
difettoso e arbitrario quando giudica la fonte e la direzione del suono, e nell’ascoltare la
conversazione di altre persone «le parole che non vengono udite verranno fornite in
perfetta buona fede dal testimone. Avrà una sua opinione a proposito del senso della
conversazione, e organizzerà i suoni che ha udito in modo che vi si accordino». Anche
le percezioni visive vanno soggette a gravi errori di identificazione, di riconoscimento,
di valutazione della distanza, di valutazione quantitativa, come ad esempio l’entità di
una folla. Il senso del tempo dell’osservatore comune varia molto. Tutte queste
debolezze originarie vengono poi complicate dagli scherzi della memoria e
dall’incessante creatività dell’immaginazione. Cfr. anche C. S. Sherrington, The
Integrative Action of the Nervous System, Constable and Co., London 1906, pp. 318-27.
Il professor Hugo Münsterberg ha scritto su questo argomento un libro di successo,
intitolato On the Witness Stand.
2 James, Principles of Psychology cit., I, p. 488.
3 J. Dewey, Come pensiamo, a cura di A. Guccione Monroy, La Nuova Italia,
Firenze 1961, pp. 221-2; ed. or. How We Think, D. C. Heath & Co., Boston 1910, p.
121.
127
Ibid., pp. 247-8; ed. or. p. 133.
5 A. Van Gennep, La formation des légendes, Flammarion, Paris 1910, pp. 158-9
(trad. it. Le origini delle leggende. Una ricerca sulle leggi dell’immaginario, trad. di V.
Cucchi, Xenia, Milano 1992, pp. 108-9). Citato da F. van Langenhove in The Growth of
a Legend, G. P. Putnam’s sons, New York-London 1916, pp. 120-2 (ed. or. Comment
naît un cycle de légendes. Franc-tireurs et atrocités en Belgique, Paris 1916).
6 B. Berenson, The Central Italian Painters of the Renaissance, G. P. Putnam’s sons,
New York-London 1909, pp. 60 sgg.; trad. it. I pittori italiani del Rinascimento, Hoepli,
Milano 19422.
7 Si veda anche il suo commento su Le immagini visive di Dante, e i suoi primi
illustratori. «Noi non possiamo fare a meno di vestire Virgilio come un romano antico,
e di dargli un “profilo classico” e un “portamento statuario”, ma l’immagine visiva che
Dante aveva di Virgilio era probabilmente non meno medievale, non più basata su una
ricostruzione critica dell’antichità, di quanto lo fosse tutta la concezione del poeta
romano. Gli illustratori del Trecento danno a Virgilio l’aspetto di un dotto medievale, e
non c’è motivo per cui l’immagine visiva che ne aveva Dante dovesse essere diversa da
questa». B. Berenson, The Study and Criticism of Italian Art, G. Bell and sons, London
1920, prima serie, p. 13.
8 Id., The Central Italian Painters cit., pp. 66-7.
1 Citato da E. H. Bierstadt, in «New Republic», 1° giugno 1921, p. 21.
1 Nel testo: «He is from Back Bay»: area di Boston nella quale erano concentrati gli
wasp [n.d.t.].
1 Wallas, Our Social Heritage cit., p. 17.
1 A. E. Zimmern, Greek Commonwealth politics and economics in fifth century
Athens, The Clarendon Press, Oxford 1915, p. 383, nota; trad. it. Il commonwealth
greco. Politica ed economia nell’Atene del V secolo, Il Saggiatore, Milano 1967.
2 Aristotele, Politica, 1. I, cap. V, trad. it. di R. Laurenti, Laterza, Roma-Bari 1993,
pp. 11-2.
1 Van Langehove, The Growth of a Legend cit. L’autore è un sociologo belga.
2 Ibid., pp. 5-7.
3 Erzberger è stato assassinato dopo che queste pagine erano state scritte.
1 Purtroppo è molto più difficile conoscere questa cultura reale che riassumere e
commentare le opere del genio. La cultura reale vive in persone troppo occupate per
indulgere alla strana occupazione di formulare le proprie convinzioni. Solo
occasionalmente si danno la cura di registrarle, e lo studioso ben di rado può sapere
quanto siano tipici i suoi dati. Forse la miglior cosa da fare è quella di seguire il
suggerimento di Lord James Bryce (Modern Democracies, Macmillan, New York 191,
I, p. 158; trad it. Democrazia motraduzione dovutaderna, Mondadori, Milano 1949):
muoversi cioè liberamente «tra tutte le specie e le classi di uomini» per cercare in ogni
ambiente quelle persone prive di pregiudizi che abbiano la capacità di dare valutazioni.
«C’è un fiuto che solo la lunga pratica e un atteggiamento di simpatia riescono a donare.
L’osservatore esperto impara a trarre profitto da piccole indicazioni, proprio come il
vecchio marinaio distingue, prima dell’uomo di terraferma, le avvisaglie dell’imminente
tempesta». C’è, in breve, una forte componente intuitiva, e non sorprende che gli
studiosi amanti della precisione limitino tanto spesso il loro interessamento alle
formulazioni di altri studiosi, che appaiono più chiare della realtà.
4
128
Literary Supplement del «Times» di Londra, 2 giugno 1921, p. 352. Il professor
Einstein ha dichiarato nel 1921 in America che la gente tendeva a sopravvalutare
l’influenza della sua teoria, e a sottovalutarne la certezza.
3 J. B. Bury, The Idea of Progress, Macmillan and Co., London 1920, p. 324.
4 H. T. Tennyson, Alfred Lord Tennyson; A Memoir by His Son, Macmillan, New
York 1899, I, p. 195. Citato da Bury, The Idea of Progress cit., p. 326.
1 Penso al trasporto e all’approvvigionamento di due milioni di soldati al di là
dell’oceano. Il professor Wesley Mitchell fa notare che il volume della produzione
totale di beni dopo la nostra entrata in guerra non superò di molto quello dell’anno
1916; invece la produzione bellica fu molto superiore.
1 G. B. Shaw, Back to Methuselah. A metabiological pentateuch, Brentano’s, New
York 1921 (trad. it. Torniamo a Matusalemme, Mondadori, Milano 1960), prefazione.
2 Id., The Quintessence of Ibsenism, Brentano’s, New York 1913; trad. it. La
quintessenza dell’Ibsenismo, Monanni, Milano 1928.
1 The Letters of ‘William James Edited by His Son, Henry James, The Atlantic
Monthly Press, Boston 1920, I, p. 65.
1 Cfr. Two Years of Conflict on the Internal Front, in «New York Evening Post», 15
gennaio 1921: si tratta della traduzione dovuta a Malcom W. Davis, di un testo
pubblicato a Mosca nel 1920 dalla Repubblica federale socialista sovietica russa.
1 James, Principles of Psychology cit., II, p. 300.
2 Si veda in questo senso l’intervista di Charles Grasty con il Maresciallo Foch sul
«New York Times» del 26 febbraio 1918. «La Germania marcia attraverso la Russia.
L’America e il Giappone, che sono in grado di farlo, dovrebbero andarle incontro in
Siberia». Si vedano anche la risoluzione del senatore King dell’Utah, del 10 giugno
1918, la dichiarazione di Taft sul «New York Times» dell’11 giugno 1918, e l’appello
rivolto all’America il 5 maggio 1918 da A. J. Sack, direttore del Russian Information
Bureau: «Se la Germania si trovasse al posto degli alleati […] entro un anno farebbe
combattere un esercito di tre milioni sul fronte orientale».
1 The Letters of William James cit., I, p. 6.
2 James, Principles of Psychology cit., I, p. 638.
3 Citato da H. C. Warren, Human Psychology, Houghton Mifflin, Boston-New York
1922, p. 255.
4 James, Principles of Psychology cit., I, p. 639.
5 Nel cinema questo effetto è ottimamente raggiunto dalla macchina da ripresa
ultrarapida.
1 H. G. Wells, The Outline of History, Macmillan, New York 1920, II, p. 605. Cfr.
anche J. H. Robinson, The New History. Essays illustrating the Modern Historical
Outlook, Macmillan, New York 1912, p. 239.
2 In una recensione di The Salvaging of Civilization, in «The Literary Review of the
New York Evening Post», 18 giugno 1921, p. 5.
1 Cfr. C. L. Goodrich, The Frontier of Control, Harcourt, Brace and Howe, New
York 1920.
2 Articolo XIX.
1 W. James, Some Problems of Philosophy: a Beginning of an Introduction to
Philosophy, Longmans, Green, and Co., New York 1911, p. 224.
2 Id., A Pluralistic Universe. Hibbert Lectures at Manchester College on the Present
2
129
Situation in Philosophy, Longmans, Green, and Co., New York 1909, p. 329; trad. it.
Un universo pluralistico, Marietti, Genova 1973.
1 The Heart of the Puritan, a cura di E. D. Hanscom, Macmillan, New York 1917, p.
77.
2 Citato in «The New Republic», 24 dicembre 1919, p. 120.
3 Cfr. le considerazioni di Freud sull’assolutismo nei sogni, in L’interpretazione dei
sogni (in Opere, III, Boringhieri, Torino 1966), cap. VI.
130
IV.
Gli interessi
131
XI.
Suscitare l’interesse
1.
La mente umana non è una pellicola che registri una volta per sempre
ogni impressione che le giunga attraverso i suoi obiettivi e le sue lenti; la
mente umana è infinitamente e persistentemente creativa. Le immagini
sbiadiscono o si fondono, sono messe a fuoco qui, condensate là, a misura
che ce ne impadroniamo più completamente. Non giacciono inerti sulla
superficie della mente, ma invece vengono rielaborate dalla facoltà poetica
sino a deviare una nostra espressione personale. Decidiamo il risalto da
dare e partecipiamo all’azione.
Per fare questo tendiamo a personalizzare la quantità e a drammatizzare
le relazioni. Gli affari del mondo vengono rappresentati come una specie
di allegoria, tranne in poche menti raffinatissime. Movimenti Sociali,
Forze Economiche, Interessi Nazionali, Opinione Pubblica vengono trattati
come persone; oppure persone come il Papa, il Presidente, Lenin, Morgan
o il Re diventano idee e istituzioni. Lo stereotipo più radicato di tutti è lo
stereotipo umano che attribuisce natura umana a cose inanimate o
coltivate.
La straordinaria varietà delle nostre impressioni, anche dopo che siano
state censurate in tutti i modi, tende a costringerci ad adottare il sistema
più economico dell’allegoria. La moltitudine delle cose è talmente grande
che non siamo in grado di tenerle in mente con vivezza, perciò di solito le
nominiamo, e lasciamo che il nome rappresenti tutta l’impressione. Ma un
nome è poroso. Vecchi significati ne scorrono via, e altri nuovi vi si
infiltrano, e il tentativo di conservare il pieno significato del nome è
faticoso quasi quanto quello di richiamare le impressioni originarie.
Tuttavia i nomi sono una moneta debole per il pensiero, sono troppo vuoti,
troppo astratti, troppo disumani. E così cominciamo a vedere il nome
attraverso qualche stereotipo personale, a leggervi dentro e infine a vedervi
l’incarnazione di qualche qualità umana.
Ma anche le qualità umane sono vaghe e fluttuanti, il miglior modo di
ricordarle è un segno fisico e perciò anche le qualità umane che tendiamo
ad attribuire ai nomi delle nostre impressioni, tendono a restarci presenti
132
sotto forma di metafore fisiche. Il popolo di Inghilterra, la storia
d’Inghilterra, si condensano nell’Inghilterra; e l’Inghilterra diventa John
Bull, che è gioviale e grasso, non troppo intelligente, ma assai capace di
difendersi. La migrazione di un popolo può parere a qualcuno come il
vagare di un fiume, e ad altri come un’inondazione devastatrice. Il
coraggio che gli individui mostrano può essere oggettivato in una roccia; i
loro intenti possono essere visti come una strada, i loro dubbi come bivii di
una strada, le loro difficoltà come solchi e pietre, il loro progresso come
una fertile vallata. Se mobilitano le loro corazzate, sfoderano la spada. Se
il loro esercito si arrende, sono messi a terra. Se sono oppressi, sono in
croce e sotto il giogo.
Quando gli affari pubblici vengono popolarizzati in discorsi, titoli di
giornale, drammi, film, vignette, romanzi, statue o dipinti, la loro
trasformazione in un interesse umano richiede dapprima l’astrazione
dall’originale, e poi l’animazione di ciò che è stato reso astratto. Non
possiamo provare molto interesse, o essere molto colpiti, dalle cose che
non vediamo. Degli affari pubblici ognuno di noi vede pochissimo, e
perciò rimangono tediosi e poco appetibili finché qualcuno dotato di
qualità artistiche non li traduca in un film. Così l’astrazione, imposta alla
nostra conoscenza della realtà da tutte le limitazioni del nostro accesso e
dei nostri pregiudizi, viene compensata. Non essendo onnipresenti e
onniscienti, non possiamo vedere molto di ciò di cui dobbiamo pensare e
parlare. Essendo di carne e sangue, non ci nutriremo di parole e nomi e
grigia teoria. Poiché siamo in un qualche modo artisti, dipingiamo quadri,
allestiamo drammi, e disegniamo vignette, ricavandoli tutti dalle
astrazioni.
Oppure, quando è possibile, troviamo uomini dotati che sono in grado
di vedere per noi. Infatti le persone non sono dotate tutte nella stessa
misura di capacità figurative. Tuttavia si può, credo, affermare con
Bergson che l’intelligenza pratica è più strettamente legata a qualità
spaziali1. Un pensatore «lucido» è quasi sempre dotato di buone qualità
visive, ma per questa stessa ragione, per il fatto che è «cinematografico», è
spesso in egual misura esteriore e insensibile. Infatti le persone che hanno
intuizione – la quale probabilmente è un altro nome per la percezione
musicale o muscolare – spesso apprezzano la natura di un fatto, e l’essenza
di un atto, molto meglio di chi ha immaginazione visiva. Comprendono di
più quando l’elemento cruciale è un desiderio mai apertamente espresso, o
che appare alla superficie solo in un gesto velato o in una cadenza di
discorso. Con la chiarezza visiva si può cogliere lo stimolo e il risultato,
ma l’intermedio e l’interno spesso vengono malamente travisati dal visivo,
133
così come l’intenzione del compositore viene messa in caricatura
dall’enorme soprano che fa la parte della soave fanciulla.
Ciononostante le intuizioni, pur avendo spesso una peculiare aderenza,
restano in grande misura private e incomunicabili. I rapporti sociali
dipendono dalla comunicazione, e se una persona può spesso condurre la
sua vita con estrema eleganza, grazie alle sue intuizioni, purtuttavia di
solito incontra grandi difficoltà a renderle reali agli altri. Quando ne parla,
sembrano una fascia di nebbia. Infatti, mentre l’intuizione dà una più
giusta percezione del sentimento umano, la ragione, con il suo pregiudizio
spaziale e tattile, può ricavare ben poco da questa percezione. Perciò,
quando l’azione presuppone che un certo numero di persone siano
d’accordo, è probabilmente vero che in una prima istanza nessuna idea si
presterà a una decisione concreta finché non ha acquistato valore visivo o
tattile. Ma è anche vero che nessuna idea visiva ha un significato per noi,
se prima non ha assorbito un po’ della tensione della nostra personalità.
Finché essa non libera o contrasta, deprime o esalta qualche nostro
desiderio, resta una cosa priva d’importanza.
2.
Le immagini sono, da sempre, il modo più sicuro di trasmettere
un’idea; e subito dopo, nell’ordine, le parole che richiamano alla nostra
memoria delle immagini; ma l’idea trasmessa non è pienamente nostra
finché non ci siamo identificati con qualche aspetto dell’immagine.
L’identificazione, ovvero ciò che Vernon Lee ha chiamato empatia1, può
essere sottile e simbolica quasi all’infinito. La mimica può manifestarsi
senza che ne siamo consapevoli, e talvolta in un modo che farebbe
inorridire quelle parti della nostra personalità su cui si fonda la stima di noi
stessi. Nelle persone raffinate la partecipazione può essere rivolta non al
destino dell’eroe, ma al destino di tutto il concetto al quale sono essenziali
sia l’eroe che il malvagio.
Nella rappresentazione popolare gli appigli per l’identificazione sono
quasi sempre etichettati, si sa subito chi è l’eroe e nessuna opera può
sperare di ottenere un facile successo se l’etichetta non è precisa e la scelta
chiara2. Ma questo non basta. Il pubblico deve avere qualcosa da fare, e la
contemplazione del vero, del buono e del bello non è qualcosa da fare. Per
non restare inerte davanti all’immagine – e questo vale per l’articolo di
giornale quanto per la narrativa e il cinema – il pubblico dev’essere messo
in moto dall’immagine. Ora vi sono due forme di moto che superano di
gran lunga tutte le altre, sia per la facilità con cui vengono suscitate, che
134
per l’entusiasmo con cui si cerca di destarle. Esse sono la passione
sessuale e il conflitto, e hanno così tanti rapporti tra di loro, si mescolano
tra di loro così intimamente, che un conflitto basato sul sesso surclassa
qualsiasi altro tema quanto a forza di richiamo. Non c’è nessun altro tema
che superi così facilmente le differenze di cultura e le frontiere.
Il motivo sessuale non ha quasi posto nelle immagini della vita politica
americana. Se si eccettuano certe marginali estasi belliche, qualche
scandalo occasionale, o certe fasi del conflitto razziale con i neri e gli
asiatici, il solo parlarne sembrerebbe cervellotico. Solo nei film, nei
romanzi e in qualche novella di rivista i rapporti di lavoro, la concorrenza
economica, la politica e la diplomazia vengono intralciati dalla fanciulla e
dall’«altra». Ma il tema del conflitto compare a ogni passo. La politica è
interessante quando c’è un conflitto, o, come diciamo, una questione. E per
rendere popolare la politica si debbono trovare problemi, anche quando, a
onor del vero, non ce ne sono affatto: non ce ne sono, nel senso che le
differenze di giudizio, o di principio, o di fatto, non richiedono un ricorso
all’aggressività3.
Ma dove non è in gioco l’aggressività, quelli di noi che non sono
direttamente coinvolti trovano difficile mantener desto l’interesse. Per
quelli che sono coinvolti l’assorbimento può essere abbastanza reale per
impegnarli anche quando non è in gioco alcuna questione. Possono essere
spinti dalla pura gioia dell’attività o da una sottile rivalità o dalla fantasia.
Ma in quelli ai quali l’intero problema resta esterno e lontano, queste altre
facoltà non entrano facilmente in gioco. Perché la debole immagine della
questione significhi qualcosa per loro, debbono avere la possibilità di dar
sfogo all’amore per la lotta, la suspense e la vittoria.
Miss Patterson4 sostiene che «la suspense […] costituisce la differenza
tra i capolavori del Metropolitan Museum of Art e i film del Rivoli o del
Rialto». Se avesse chiarito che ai capolavori mancano sia l’elemento della
facile identificazione che un tema adatto a questa generazione, avrebbe
pienamente ragione di dire che ciò
spiega perché le persone entrano nel Metropolitan a gruppi di due o tre e si
precipitano al Rialto e al Rivoli a centinaia. Le coppie e i terzetti contemplano un
quadro dell’Art Museum per meno di dieci minuti, a meno che non siano studiosi
d’arte, critici e intenditori. Le centinaia del Rivoli e del Rialto guardano il film per
più di un’ora. Per quanto riguarda la bellezza, non può esserci paragone tra i meriti
delle due cose. Tuttavia il film attira più persone e mantiene la loro attenzione più a
lungo di quanto non facciano i capolavori, non per il merito intrinseco, ma perché
rappresenta degli avvenimenti che si svolgono, e di cui il pubblico attende a fiato
sospeso il risultato. Possiede l’elemento della lotta, che non manca mai di suscitar
suspense.
135
E allora perché la situazione lontana non resti un grigio sfarfallamento
ai bordi dell’attenzione, dovrebbe essere suscettibile di venire tradotta in
immagini in cui sia riconoscibile la possibilità dell’identificazione. Finché
questo non accade interesserà solo pochi individui, e per breve tempo. Farà
parte delle cose viste, ma non avvertite, delle sensazioni che assalgono i
nostri sensi, e non vengono riconosciute. Abbiamo bisogno di parteggiare.
Abbiamo bisogno di essere in grado di parteggiare. Nei recessi del nostro
essere dobbiamo uscire dal pubblico per entrare in scena, e lottare come il
protagonista per la vittoria del bene sul male. Dobbiamo infondere
nell’allegoria il respiro della nostra vita.
3.
E così, a dispetto dei critici, viene pronunciato un verdetto sulla vecchia
controversia a proposito di realismo e romanticismo. Il gusto corrente
vuole che la vicenda cominci in un ambiente abbastanza realistico da
rendere plausibile l’identificazione, e termini in un ambiente abbastanza
romantico da apparire desiderabile, ma non tanto romantico da essere
inconcepibile. Tra l’inizio e la fine i canoni sono liberali, ma l’inizio
verace e il lieto fine sono punti di riferimento obbligati. Il pubblico
cinematografico respinge la pura fantasia che si sviluppa in modo logico,
perché nell’era delle macchine la fantasia pura non offre alcun appiglio
che riesca familiare. Respinge il realismo rigorosamente perseguito perché
non gli piace la sconfitta in una lotta che è diventata la sua.
Non è stabilito una volta per sempre che cosa sarà accolto come vero,
come realistico, come il bene, come il male, come desiderabile. Queste
cose sono stabilite da stereotipi, acquisiti dalle prime esperienze e riportati
nel giudizio su quelle successive. E, perciò, se l’investimento finanziario
in ciascun film e nelle riviste popolari non fosse tanto esorbitante da
richiedere un successo instantaneo e larghissimo, gli uomini di spirito e
d’immaginazione potrebbero adoperare lo schermo e il periodico così
come ci si potrebbe sognare che venissero adoperati: per ampliare e
raffinare, per verificare e criticare il repertorio di immagini con le quali
lavora la nostra immaginazione. Ma, dati gli attuali costi, gli uomini che
fanno i film, così come i pittori di chiese e di corte di altre epoche,
debbono aderire agli stereotipi che trovano, o pagare il prezzo dell’avere
frustrato le attese del pubblico. Gli stereotipi possono venire modificati,
ma non con tanta rapidità da garantire il successo del film che verrà messo
in circolazione tra sei mesi.
Gli individui che modificano gli stereotipi, gli artisti e i critici di
136
avanguardia, si sentono per forza di cose depressi e adirati verso i
produttori e gli editori che proteggono i propri investimenti. Essi rischiano
tutto: perché gli altri non lo fanno? Ma ciò non è affatto equo, perché nella
loro furia virtuosa dimenticano le proprie ricompense, che oltrepassano di
gran lunga tutte quelle che i loro datori di lavoro possono sperare di
provare. Non potrebbero e se potessero non vorrebbero scambiare i posti.
E dimenticano anche un’altra cosa, nella loro guerra incessante contro il
filisteismo. Dimenticano che stanno misurando il loro successo secondo
criteri che gli artisti e i saggi del passato non si sarebbero mai sognati di
invocare. Chiedono tirature e pubblici che non sono mai stati concepiti
dagli artisti fino a poche generazioni fa e quando non li ottengono, si
sentono delusi.
Quelli che ci riescono, come Sinclair Lewis col suo Main Street, sono
persone che sono riuscite a esternare in modo preciso quello che
moltitudini di altre persone cercavano oscuramente di dire nella propria
mente. «L’ha detto lui per me». Stabiliscono una nuova forma, che poi
viene incessantemente ricopiata finché anch’essa non diventa uno
stereotipo di percezione. Al nuovo pioniere riesce difficile far vedere al
pubblico Main Street in un altro modo e egli, come i precursori di Sinclair
Lewis, si mette a litigare con il pubblico.
Questa disputa è dovuta non solo al conflitto di stereotipi, ma al rispetto
dell’artista di avanguardia per la propria materia. Qualunque piano scelga,
su quel piano rimane. Se si occupa dell’interiorità di un fatto, lo segue fino
alla sua conclusione, senza curarsi del dolore che provoca. Non tarperà la
sua fantasia per aiutare qualcuno, né nasconderà i conflitti laddove ci sono
conflitti. Questa è la sua America. Ma i grossi pubblici non digeriscono
una tale severità. Essi provano interesse per se stessi più che per qualsiasi
altra cosa al mondo. I se stessi per cui provano interesse sono quelli che
sono stati rivelati dalle scuole e dalla tradizione. Essi insistono che
un’opera d’arte dev’essere un veicolo con un predellino che consenta loro
di salire a bordo, e su cui possano andare non seguendo la conformazione
di un terreno, ma alla volta di un paese dove per un’ora non vi siano
cartellini da timbrare né piatti da lavare. Per soddisfare queste esigenze c’è
una classe intermedia di artisti capaci e disposti a confondere i piani, a
mettere insieme una misura realistico-romantica derivata dalle invenzioni
di uomini maggiori, e, come consiglia Miss Patterson, a dare «ciò che la
vita reale fa così raramente: la risoluzione trionfale di una serie di
difficoltà; l’angoscia delle virtù e il trionfo del peccato […] trasformati
nella glorificazione della virtù e nella punizione eterna del suo nemico»1.
137
4.
Le ideologie politiche obbediscono a queste regole. L’appiglio
realistico c’è sempre. Nell’argomentazione è riconoscibile l’immagine di
qualche male reale, come la minaccia tedesca o il conflitto di classe. C’è
una descrizione di qualche aspetto del mondo, che è convincente perché si
accorda con le idee abituali. Ma dato che l’ideologia si rivolge a un futuro
sconosciuto, oltre che a un presente tangibile, presto attraversa
impercettibilmente la frontiera della verifica. Nel descrivere il presente si è
legati più o meno all’esperienza comune. Nel descrivere quello che
nessuno ha sperimentato per forza si divaga. Si sta, più o meno, ad
Armageddon, ma forse ci si batte per il Signore… Un inizio verace, verace
secondo i canoni dominanti, e un lieto fine. Il marxista è durissimo
riguardo alle brutalità del presente, mentre quasi sempre diventa lirico
quando parla del giorno successivo all’instaurazione della dittatura. E così
erano i propagandisti bellici: non c’era una qualità bestiale della natura
umana che non trovassero dappertutto a oriente del Reno, oppure, se i
propagandisti erano tedeschi, a occidente del Reno. Non c’è dubbio che vi
fosse la bestialità. Ma dopo la vittoria, pace eterna. Molto di tutto ciò è
cinicamente voluto. Infatti l’abile propagandista sa che mentre si deve
partire da un’analisi plausibile, non si deve seguitare ad analizzare, perché
il tedio del reale lavorio politico distruggerà ben presto l’interesse. Così il
propagandista esaurisce l’interesse per la realtà con un inizio
tollerabilmente plausibile, e poi attizza l’energia necessaria per un lungo
viaggio brandendo un passaporto per il paradiso.
La formula funziona quando la finzione pubblica si aggancia a una
pressante necessità privata. Ma una volta agganciata, nel calore della
battaglia l’io originario e lo stereotipo originario che si sono incontrati
possono venire del tutto persi di vista.
138
XII.
L’interesse personale riconsiderato
1.
Dunque un’identica storia non è la stessa storia per tutti quelli che la
sentono. Ognuno ci entrerà in un punto un po’ diverso, dato che non
esistono due esperienze esattamente eguali; ognuno la ricreerà a suo modo,
e vi trasfonderà i suoi sentimenti. Talvolta un artista di levatura superiore
ci costringerà a entrare in esistenze totalmente diverse dalla nostra,
esistenze che a prima vista appaiono noiose, repellenti o eccentriche, ma
questo è raro. In quasi tutte le storie che colpiscono la nostra attenzione
diventiamo un personaggio e recitiamo la parte con una nostra pantomima.
La pantomima può essere sottile o grossolana, può essere intonata alla
storia o solo rozzamente analoga; ma conterrà quei sentimenti che sono
suscitati dalla nostra concezione della parte. E così il tema originario a
mano a mano che circola viene accentuato, alterato, ricamato da tutte le
menti attraverso cui passa. È come se un dramma di Shakespeare venisse
riscritto, ogni volta che viene rappresentato, con tutti i mutamenti di
accento e di significato che gli attori e il pubblico vi abbiano infuso.
Qualcosa di assai simile sembra essere avvenuto ai racconti delle saghe
prima che fossero definitivamente trascritti. Ai nostri tempi il documento
stampato, quale esso sia, frena l’esuberanza della fantasia individuale. Ma
contro la diceria non esistono o quasi freni, e il fatto originario, vero o
inventato, mette fuori ali e corna, zoccoli e becchi, a mano a mano che
quell’artista che sta in ogni pettegolo ci lavora su. Il racconto del primo
narratore non conserva la sua forma e le sue proporzioni, viene curato e
riveduto da tutti quelli che ci giocarono quando l’udirono, che lo usarono
per i loro sogni ad occhi aperti, e lo trasmisero1.
Di conseguenza, quanto più misto sarà il pubblico, tanto maggiore sarà
la varietà delle reazioni. Infatti con l’aumento del pubblico diminuisce il
numero delle parole comuni. Così i fattori comuni del racconto diventano
più astratti. Questo racconto, privo di un preciso carattere proprio, viene
udito da persone i cui caratteri differiscono molto. Ed esse gli danno il
proprio carattere.
139
2.
Il carattere che si dà a questo racconto cambia non solo a seconda del
sesso e dell’età, della razza e della religione e della posizione sociale, ma,
entro queste grossolane classificazioni, a seconda della costituzione
ereditaria e acquisita dell’individuo, delle sue capacità, della sua carriera,
dell’andamento della sua carriera, di un particolare aspetto della sua
carriera, dei suoi modi e tempi, o del posto che occupa in uno dei giochi
della vita in cui è impegnato.
Egli percepisce attraverso i suoi schemi fissi, e ricrea con le sue
emozioni, la parte di vita pubblica che arriva sino a lui: qualche riga di
stampa, alcune fotografie, aneddoti, e qualche sua occasionale esperienza.
Non considera i suoi problemi personale come campioni parziali del
mondo in genere. Considera invece i racconti del mondo in genere come
un ingrandimento mimato della sua vita personale.
Non necessariamente però della vita personale come la descriverebbe a
se stesso. Infatti nella sua vita privata le scelte sono ristrette, e molto di se
stesso è compresso e nascosto, dove non può direttamente governare il suo
comportamento esteriore. E così oltre agli individui normalissimi, che
proiettano la felicità delle loro vite in una buona volontà generale, o la loro
infelicità nel sospetto e nell’odio, vi sono le persone all’apparenza felici,
che sono brutali ovunque fuorché nella propria cerchia, nonché le persone
che quanto più detestano le loro famiglie, gli amici, le loco occupazioni,
tanto più traboccano d’amore per il genere umano.
Passando dalle generalità al dettaglio, diventa più evidente ancora che il
carattere con cui gli uomini trattano i loro affari non è fisso. Forse le
diverse personalità hanno una radice comune e qualità comuni, ma i rami e
i ramoscelli hanno molte forme. Nessuno affronta con lo stesso carattere
tutte le situazioni. Il carattere in qualche misura varia per la semplice
influenza del tempo e dell’accumularsi della memoria, dato che l’individuo
non è un automa. Il carattere varia non solo nel tempo, ma a seconda delle
circostanze. La leggenda dell’inglese solitario nei mari del Sud, che
invariabilmente si rade e indossa il cravattino nero per la cena, testimonia
il suo timore intuitivo e di uomo civilizzato, di perdere il carattere che ha
acquistato. E così i diari e gli album di fotografie, e i ricordi, le vecchie
lettere e i vecchi vestiti, e l’amore per la routine immutabile, testimoniano
tutti la nostra impressione della difficoltà di bagnarsi due volte nel fiume
eracliteo.
Non vi è un io unico sempre al lavoro. E perciò ha una grande
importanza per la formazione di un’opinione pubblica sapere quale io vi
140
sia impegnato. I giapponesi chiedono il diritto di insediarsi in California. È
evidente che corre molta differenza tra il vedere la richiesta come un
desiderio di praticare la frutticoltura e il vederla invece come desiderio di
sposare la figlia del bianco. Se due nazioni si contendono un pezzo di
territorio, la situazione è assai diversa a seconda che la gente consideri i
negoziati come un affare di proprietà immobiliari, ovvero come un
tentativo di umiliarla, o, nel linguaggio eccitato e provocatorio che di
solito ottenebra queste discussioni, come uno stupro. Infatti l’io che
domina gli istinti, quando pensiamo a limoni o a terre lontane, è molto
diverso dall’io che si manifesta quando pensiamo anche solo
potenzialmente come se fossimo il capo oltraggiato di una famiglia. Nel
primo caso il sentimento privato che entra nell’opinione è tiepido, nel
secondo è incandescente. E così, mentre è vero al punto d’essere una mera
tautologia il fatto che l’«interesse personale» determina l’opinione,
l’affermazione non è illuminante fintantoché non si sappia quale dei molti
io sceglie e dirige l’interesse così concepito. L’insegnamento religioso e la
saggezza popolare hanno distinto sempre varie personalità in ogni essere
umano. Sono state chiamate volta a volta la Superiore e l’Inferiore, la
Spirituale e la Materiale, la Divina e la Carnale; e anche se non accettiamo
del tutto questa classificazione, non possiamo fare a meno di osservare che
esistono delle distinzioni. Invece di due esseri antitetici, un uomo moderno
noterebbe probabilmente molti esseri non nettamente separati tra di loro.
Direbbe che la distinzione tracciata dai teologi era arbitraria ed esteriore,
perché molti diversi io venivano raggruppati sotto l’etichetta «superiore»
purché rientrassero nelle categorie del teologo, ma ciononostante
riconoscerebbe che anche questo forniva un utile indizio della varietà della
natura umana.
Abbiamo imparato a notare molti io, e ad essere un po’ meno pronti a
emettere giudizi su di essi. Ci rendiamo conto di vedere lo stesso corpo,
ma spesso un uomo diverso, a seconda che l’individuo che osserviamo
abbia a che fare con un inferiore sociale, con un superiore sociale o con un
uguale; a seconda che faccia all’amore con una donna che può sposare o
con una che non può sposare; a seconda che corteggi una donna, o che se
ne consideri il proprietario; a seconda che si trovi con i suoi figli, i suoi
soci, i dipendenti più fidati, il padrone che può farlo o disfarlo; a seconda
che si trovi con uno straniero ben visto o con uno disprezzato; a seconda
che si trovi in grave pericolo, o in uno stato di perfetta sicurezza; a
seconda che si trovi solo a Parigi, o tra la sua famiglia a Peoria.
Naturalmente gli individui differiscono largamente nella coerenza del
carattere: così largamente che possono coprire l’intera gamma di
141
differenze che passa tra un’anima spaccata in due come quella del dottor
Jekyll e un uomo tutto d’un pezzo come Brand, Parsifal o Don Chisciotte.
Quando i vari io sono troppo dissociati diffidiamo dell’individuo; se si
trovano tutti inflessibilmente collocati su un solo binario, lo consideriamo
arido, cocciuto o eccentrico. Nel repertorio dei caratteri, striminzito per gli
isolati e gli autosufficienti, molto vario per gli adattabili, c’è un’intera
gamma di io, da quello al vertice che vorremmo far vedere a Dio, a quelli
che stanno in fondo e che noi stessi non osiamo guardare. Ci sono le ottave
che servono alla famiglia (padre, Geova, tiranno; marito, proprietario,
maschio; amante, libertino), o all’occupazione (datore di lavoro, padrone,
sfruttatore; concorrente, intrigante, nemico; subordinato, cortigiano, snob).
Talune non emergono mai alla luce del sole. Altre vengono mobilitate solo
da circostanze eccezionali. Ma i caratteri prendono forma sulla base di
come l’individuo concepisce la situazione in cui si trova. Se l’ambiente a
cui è sensibile è per caso lo smart set, egli imiterà il carattere che
considera appropriato. Questo carattere tenderà ad agire come modulatore
del suo portamento, del suo linguaggio, dei suoi argomenti di
conversazione, delle sue preferenze. Gran parte della commedia della vita
sta proprio qui, nel modo in cui le persone immaginano i propri caratteri
per situazioni che sono a loro estranee: il professore tra i venditori, il
diacono ad una partita di poker, il cockney in campagna, la gemma falsa
tra i diamanti veri.
3.
Nel processo di formazione dei caratteri di un individuo entra una serie
di influssi non facilmente separabili1. L’analisi, per gli aspetti
fondamentali, è forse non più sicura di quanto lo fosse nel V secolo avanti
Cristo, quando Ippocrate formulava la dottrina degli umori, distingueva i
temperamenti sanguigno, melanconico, collerico e flemmatico, e li
attribuiva al sangue, alla bile nera, alla bile gialla e alla flemma. Le teorie
più recenti, come le hanno formulate Cannon2, Adler3, Kempf4, sembrano
seguire più o meno la stessa pista: dalla condotta esteriore e dalla
coscienza interiore alla fisiologia del corpo. Ma ad onta dell’immenso
miglioramento della tecnica, nessuno sosterrebbe che si sia arrivati a
conclusioni sicure, che ci consentano di distinguere la natura
dall’educazione, e di astrarre il carattere nativo da quello acquisito. Solo in
quelli che Joseph Jastrow ha chiamato i bassifondi della psicologia, la
spiegazione del carattere viene considerata un sistema fisso applicabile da
frenologi, chiromanti, indovini, lettori del pensiero e qualche professore di
142
scienze politiche. Da loro si sentirà ancora affermare che «i cinesi amano i
colori, e hanno le sopracciglia fortemente arcuate», mentre «i crani dei
calmucchi sono depressi in cima, ma molto sporgenti ai lati, intorno
all’organo che dà l’inclinazione all’acquisizione; e infatti la propensione di
questa nazione al furto ecc., è ammessa»5.
Gli psicologi moderni sono portati a considerare il comportamento
esteriore di un adulto come un’equazione tra un certo numero di variabili,
quali la resistenza dell’ambiente, i desideri repressi maturati in varie età e
la personalità manifesta6. Essi ci permettono di supporre, benché io non
abbia mai visto formulata questa nozione, che la repressione o il controllo
dei desideri vengono sempre determinati non in rapporto alla personalità
totale, ma più o meno in rapporto ai suoi vari io. Ci sono cose che
l’individuo non fa in veste di patriota, e che invece fa quando non sta
pensando a se stesso come a un patriota. Senza dubbio ci sono impulsi, più
o meno incipienti nell’infanzia, che non si manifestano più nell’intero
corso della vita di un individuo, salvo quando entrano oscuramente o
indirettamente in combinazione con altri impulsi. Ma anche questo non è
certo, dato che la repressione non è irrimediabile. Infatti le situazioni
sociali come la psicoanalisi possono portare alla superficie un impulso
sepolto7. È solo quando ciò che ci sta intorno resta normale e placido,
quando ciò che si aspettano da noi quelli che incontriamo resta stabile, che
noi viviamo senza renderci conto di molte nostre inclinazioni. Quando
accade l’imprevisto, apprendiamo su noi stessi molte cose che non
sapevamo.
Gli io che costruiamo con l’aiuto di tutti coloro che ci influenzano,
prescrivono quali impulsi, con quale accentuazione, con quale
orientamento, siano adatti a certe situazioni tipiche per le quali abbiamo
appreso atteggiamenti precostituiti. Per un tipo riconoscibile di esperienza
c’è un carattere che controlla le manifestazioni esterne del nostro intero
essere. Nella vita civile, ad esempio, l’odio omicida viene controllato.
Anche se la rabbia ci strangola, non dobbiamo mai mostrarla come
genitori, figli, datori di lavoro, politici. Nessuno vorrebbe esibire una
personalità che trasuda odio omicida. La si disapprova, e la gente che ci sta
intorno la disapprova anch’essa. Ma se scoppia una guerra è assai
probabile che tutte le persone che ammiriamo comincino a ritenere
giustificato l’odio e l’assassinio. Dapprima questi sentimenti trovano uno
spiraglio molto angusto. L’io che viene avanti è quello che si intona a un
vero amor patrio, il tipo di sentimento che si ritrova in Rupert Brooke, nel
discorso del 3 agosto 1914 di Sir Edward Grey, e nel messaggio
indirizzato il 2 aprile 1917 al Congresso dal presidente Wilson. La realtà
143
della guerra viene ancora esecrata, e si impara solo un po’ alla volta che
cosa significhi veramente la guerra. Infatti le guerre precedenti sono
soltanto ricordi trasfigurati. In questa fase da luna di miele i realisti della
guerra insistono giustamente che la nazione non è ancora desta, e si
rassicurano a vicenda dicendo: «Aspetta gli elenchi dei caduti».
Gradualmente l’impulso a uccidere diventa la cosa principale, e tutti quei
caratteri che potrebbero modificarlo si disintegrano. L’impulso diventa
centrale, viene santificato e un po’ alla volta diventa incontrollabile. Cerca
uno sfogo non solo nell’idea del nemico, che è tutto ciò che del nemico la
maggior parte della gente davvero vede durante la guerra, ma in tutte le
persone e oggetti e idee che sono sempre stati odiosi. L’odio per il nemico
è legittimo. Questi altri odi si legittimano con una grossolana analogia:
un’analogia che, quando torniamo in noi stessi, riconosciamo come
assolutamente assurda. Occorre molto tempo per domare un impulso tanto
potente dopo che si sia scatenato. E perciò, quando la guerra è di fatto
finita, occorrono tempo e sforzi per riconquistare l’autocontrollo e per
affrontare i problemi della pace da uomini civili.
La guerra moderna, come ha detto Herbert Croly, è implicita nella
struttura politica della società moderna, ma nel contempo, è bandita dai
suoi ideali. Per la popolazione civile non esiste in guerra un codice ideale
di condotta, come quello che il soldato ancora possiede e la cavalleria un
tempo prescriveva. I civili sono privi di regole, tranne quelle che i migliori
di loro riescono ad improvvisare; le regole che possiedono rendono la
guerra una cosa infame. Eppure, anche se la guerra può essere necessaria,
nessuna educazione morale li ha preparati ad essa. Solo i loro io superiori
hanno un codice e dei modelli, e quando debbono agire con quello che il
carattere superiore considera carattere inferiore, ne scaturiscono disturbi
profondi.
La preparazione dei caratteri per tutte le situazioni in cui gli uomini
possono trovarsi è una delle funzioni dell’educazione morale. È chiaro che
il suo successo dipende dalla sincerità e dalla consapevolezza con cui
l’ambiente è stato esplorato. Infatti in un mondo falsamente concepito i
nostri caratteri sono falsamente concepiti, e ci comportiamo male. Così il
moralista deve scegliere: deve offrire un modello di condotta per ogni fase
della vita, per quanto spiacevoli possano essere talune di queste fasi,
oppure deve garantire che i suoi allievi non dovranno mai affrontare le
situazioni che egli disapprova. Deve abolire la guerra, o insegnare alla
gente come condurla con la massima economia psichica possibile; deve
abolire la vita economica dell’uomo, e nutrirlo di polvere di stelle e
rugiada, o deve investigare tutte le complicazioni della vita economica, e
144
offrire modelli di condotta applicabili in un mondo dove nessuno è
autosufficiente. Ma questo è proprio ciò che la cultura morale dominante si
rifiuta generalmente di fare. Nei suoi aspetti migliori è diffidente di fronte
alla spaventosa complessità del mondo moderno. Nei suoi aspetti peggiori,
è semplicemente codarda. Non ha grande importanza che i moralisti
studino economia e scienza politica e psicologia, o che gli scienziati sociali
educhino i moralisti. Ogni generazione entrerà impreparata nel mondo
moderno, se non le è stato insegnato a concepire il tipo di personalità che
dovrà avere di fronte ai problemi in cui con ogni probabilità s’imbatterà.
4.
La visione ingenua dell’interesse personale non spiega gran parte di
tutto ciò. Dimentica che l’io e l’interesse sono entrambi concepiti in un
qualche modo, e che per la massima parte sono concepiti in modo
convenzionale. La dottrina comune dell’interesse personale di solito
omette completamente la funzione conoscitiva. Insiste talmente sul fatto
che gli esseri umani alla fin fine riportano tutte le cose a se stessi, che non
si sofferma a notare che le idee degli uomini sulle cose e su se stessi non
sono istintive. Sono acquisite.
Così può esser abbastanza vero, come ha scritto James Madison nel
decimo saggio del Federalist, che «gli interessi dei proprietari agrari,
quelli degli industriali, dei commercianti, dei possessori di capitali liquidi
insieme ad altri minori crescono, di necessità, nelle nazioni civili e si
ripartiscono in diverse classi sollecitate ad agire da vari sentimenti e
valutazioni». Ma se si esamina il contesto del saggio di Madison, si scopre
qualcosa che secondo me getta luce su quell’atteggiamento di fatalismo
istintivo che talvolta viene chiamato l’interpretazione economica della
storia. Madison propugnava la costituzione federale, e «tra i numerosi
vantaggi dell’unione», egli metteva avanti «la sua tendenza a spezzare e a
controllare la violenza della fazione». La faziosità era ciò che preoccupava
Madison. Ed egli individuava le cause della faziosità
nella natura stessa dell’uomo; e noi le vediamo, ovunque, più o meno operanti, a
seconda di quelle che sono le varie situazioni di una società civile.
Una appassionata partecipazione a varie opinioni politiche, o religiose, o d’altro
genere, su questioni di carattere pratico o su speculazioni teoriche; una devozione
per vari capi in lotta per la preminenza e per il potere, o per persone di diverso
genere, le cui fortune siano importanti per le umane passioni, hanno, di volta in
volta, diviso l’umanità in diversi partiti, infiammando gli uomini di reciproca
animosità e rendendoli assai più pronti alla reciproca oppressione e vessazione, che
145
non ad una mutua cooperazione per il raggiungimento di un fine comune. Tale e
tanto forte è questa tendenza dell’umanità ad abbandonarsi all’odio reciproco che,
laddove siano venute a mancare delle ragioni più solide, sono bastati spunti e
distinzioni dei più futili e fantastici per eccitare le malevole passioni e generare i più
violenti conflitti.
Le fonti più comuni e durature di faziosità sono, tuttavia, fornite dalla varia o
ineguale distribuzione delle ricchezze.
Perciò la teoria di Madison è che la propensione alla faziosità può
essere accesa dalle opinioni religiose o politiche, o dai capi, ma più
comunemente dalla distribuzione della proprietà. E tuttavia si noti che
Madison sostiene solo che gli uomini sono divisi dai loro rapporti con la
proprietà. Egli non dice che la loro proprietà e le loro opinioni siano in
rapporto di causa ed effetto, ma che le differenze di proprietà sono le cause
delle differenze di opinione. La parola-chiave nel ragionamento di
Madison è «diverso». Dall’esistenza di situazioni economiche diverse si
può in via di ipotesi inferire una probabile diversità di opinione, ma non si
può inferire quali siano necessariamente queste opinioni.
Questa riserva incide radicalmente nelle pretese di questa teoria, come
di solito essa viene sostenuta. Che la riserva sia necessaria è testimoniato
dall’enorme contraddizione tra dogma e pratica esistente tra i socialisti
ortodossi. Essi sostengono che il prossimo stadio dell’evoluzione sociale è
il risultato inevitabile dello stadio attuale, ma per produrre questo prossimo
stadio inevitabile si organizzano e operano per produrre la «coscienza di
classe». Perché, ci si chiede, la situazione economica non produce la
coscienza di classe di tutti? Non la produce, questo è sicuro. E perciò non
regge l’orgoglioso vanto che la filosofia socialista si fondi su un’intuizione
profetica della direzione del destino. Essa si fonda su un’ipotesi circa la
natura umana1.
La prassi socialista si fonda sulla convinzione che, se gli uomini sono
economicamente dislocati in vari modi, si può indurli ad avere di
conseguenza certi punti di vista. Indubbiamente spesso finiscono col
credere, o possono essere indotti a credere, cose diverse, a seconda che
siano, ad esempio, proprietari o affittuari, dipendenti o datori di lavoro,
operai specializzati o non, produttori o mediatori, esportatori o importatori,
creditori o debitori. Le differenze di reddito creano una diversità profonda
nei contatti e nelle possibilità. Coloro che lavorano alle macchine
tenderanno, come Thorstein Veblen ha così brillantemente dimostrato2, a
interpretare l’esperienza in modo diverso da coloro che fanno un lavoro
artigianale o commerciale. Se la visione materialista della politica non
affermasse altro che questo, sarebbe un’ipotesi di immenso valore, della
146
quale non potrebbe prescindere colui che interpreta l’opinione; ma spesso
si troverebbe costretto ad abbandonare la teoria, e in ogni caso dovrebbe
stare sempre molto attento. Questo perché, nello spiegare le fonti di una
qualsiasi opinione pubblica, solo di rado è ovvio quale dei molti rapporti
sociali dell’individuo stia influenzando l’opinione specifica. L’opinione di
Smith prende origine dai suoi problemi di proprietario, di importatore, di
azionista delle ferrovie, o di datore di lavoro? L’opinione di Jones, che
lavora al telaio in una fabbrica tessile, deriva dall’atteggiamento del
padrone, dalla conoscenza che egli subisce da parte di nuovi immigrati, dai
conti familiari, o dall’incubo della società che gli sta vendendo una
macchina e una casa e un pezzetto di terreno a rate? Senza un’apposita
indagine non lo si può sapere. Il determinista economico non ve lo può
dire.
I vari contatti economici dell’individo limitano o allargano la gamma
delle sue opinioni. Ma quali di questi contatti, in che forma, per quale
ragione, questo la concezione materialistica della politica non lo può
prevedere. Può prevedere, con forte probabilità di azzeccarci, che se un
uomo ha una fabbrica, questa funzione di proprietario entrerà nelle
opinioni che in qualche modo sembrano toccare quella fabbrica. Ma come
opererà questa funzione, nessun determinista economico, in quanto tale,
può dire. Non esiste un gruppo fisso di opinioni per ognuna delle questioni
implicite nel fatto di essere proprietario di uno stabilimento; non esistono
opinioni fisse sugli operai, sulla proprietà, sui dirigenti, e tanto meno
opinioni su questioni meno vicine. Il determinista può predire che in
novantanove casi su cento il proprietario si opporrà ai tentativi di privarlo
della sua proprietà, o che appoggerà le leggi che crede possano far
aumentare i suoi profitti. Ma dato che nella proprietà non c’è il segreto che
consenta a un uomo d’affari di sapere quali leggi lo renderanno ricco, il
materialismo economico non descrive alcuna catena di causa ed effetto che
consenta di profetare se il proprietario perseguirà il guadagno immediato o
quello a lunga scadenza, se seguirà il metodo della concorrenza o quello
della collaborazione.
Se questa teoria avesse la validità che così spesso si è preteso che
abbia, ci consentirebbe di profetare. Potremmo analizzare gli interessi
economici di un popolo, e dedurne ciò che quel popolo è obbligato a fare.
Marx lo tentò, e dopo averci azzeccato a proposito dei monopoli, si sbagliò
completamente. Il primo esperimento socialista è uscito non, come egli ha
predetto, dal culmine dello sviluppo capitalistico occidentale, ma dal
collasso di un sistema precapitalistico dell’Est. Perché si sbagliò? Perché si
sbagliò il maggiore dei suoi discepoli, Lenin? Perché i marxisti pensavano
147
che la situazione economica degli uomini avrebbe irresistibilmente
prodotto una chiara concezione dei loro interessi economici. Ritenevano di
possedere loro questa chiara concezione, e che il resto dell’umanità
avrebbe imparato ciò che essi sapevano. I fatti hanno dimostrato non solo
che una chiara concezione dell’interesse non sorge automaticamente in
nessuno, ma che non è sorta nemmeno in Marx e in Lenin. Dopo tutto ciò
che Marx e Lenin hanno scritto, il comportamento sociale degli uomini
resta ancora oscuro. Non dovrebbe esserlo, se la situazione economica da
sola determinasse l’opinione pubblica. Se la loro teoria fosse giusta, la
situazione economica non solo dovrebbe dividere gli uomini in classi, ma
fornire a ciascuna classe la visione del suo interesse e una coerente politica
per realizzarlo. E invece non c’è nulla di più certo del fatto che tutte le
classi di uomini sono costantemente incerte su quali siano i propri
interessi3.
Questo toglie al determinismo economico la sua capacità d’urto. Infatti
se i nostri interessi economici sono composti dei nostri mutevoli concetti
di questi interessi, allora la teoria, come chiave interpretativa dei processi
sociali, fallisce. Questa teoria presume che gli uomini siano in grado di
adottare soltanto un’interpretazione del proprio interesse, e che, avendola
adottata, procedano fatalmente a realizzarla. Presuppone l’esistenza di uno
specifico interesse di classe. E questa presunzione è falsa. Si può concepire
un interesse di classe in modo lato o in modo ristretto, egoisticamente o
disinteressatamente, alla luce di nessun fatto, di alcuni fatti, di molti fatti,
della verità e dell’errore. E così la panacea marxista per i conflitti di classe
si sgonfia. Questa panacea presuppone che se la proprietà potesse essere
messa tutta in comune, le differenze di classe scomparirebbero. Questa
presunzione è falsa. La proprietà potrebbe esser messa in comune, e
tuttavia non venir concepita come un tutto. Nel momento in cui una parte
della gente non riuscisse a vedere il comunismo da un punto di vista
comunista, si dividerebbero in classi sulla base di ciò che vedono.
Per quanto riguarda l’ordinamento sociale esistente, il socialismo
marxista addita nel conflitto intorno alla proprietà la fonte dell’opinione;
per quanto riguarda la vagamente definita classe lavoratrice, non indica nel
conflitto intorno alla proprietà la base delle agitazioni; per quanto riguarda
il futuro, immagina una società senza il conflitto intorno alla proprietà, e
perciò senza il conflitto di opinioni. Ora nell’ordinamento sociale esistente
possono esserci senz’altro più casi, in cui il guadagno di un individuo
significa la perdita per un altro, di quanti ve ne sarebbero sotto il
socialismo; ma per ogni caso in cui il guadagno di uno significa la perdita
di un altro, si hanno casi innumerevoli in cui gli individui semplicemente
148
immaginano il conflitto perché sono ignoranti. E sotto il socialismo, anche
se si rimuovesse ogni caso di conflitto assoluto, il fatto che il singolo abbia
un accesso solo parziale al complesso dei fatti, creerebbe ugualmente dei
conflitti. Uno stato socialista non potrà fare a meno dell’istruzione, della
moralità, della cultura umanistica, sebbene dal punto di vista di una
concezione rigorosamente materialistica la proprietà comune dovrebbe
renderle superflue. I comunisti russi non diffonderebbero la loro fede con
un zelo così indefesso se l’opinione del popolo russo fosse determinata
esclusivamente dal determinismo economico.
5.
La teoria socialista della natura umana è, come il calcolo edonistico, un
esempio di falso determinismo. Entrambi sostengono che le inclinazioni
innate producono fatalmente, ma intelligentemente, un certo tipo di
comportamento. Il socialista crede che le inclinazioni mirino a promuovere
l’interesse economico di una classe; l’edonista crede che mirino a
promuovere il piacere e a evitare il dolore. Entrambe le teorie poggiano su
una concezione ingenua dell’istinto, una concezione che James1, pur
dandole un significato molto limitato, definiva come «la facoltà di agire in
modo da produrre certi fini, senza conoscere in precedenza i fini e senza
una previa preparazione a questa azione».
È dubbio che un’azione istintiva di questo tipo figuri davvero nella vita
sociale degli uomini. Infatti, come faceva notare James2, «l’atto istintivo di
un animale dotato di memoria deve cessare di essere “cieco” dopo essere
stato ripetuto una volta». Quali che siano le doti native, le inclinazioni
innate sono immerse sin dalla prima infanzia nell’esperienza, la quale
determina quali stimoli le ecciteranno. «Diventano suscettibili – come dice
McDougall3 – di essere destate, non solo dalla percezione di oggetti del
tipo che direttamente eccita l’inclinazione innata, gli eccitanti naturali o
nativi dell’istinto, ma anche dalle idee di tali oggetti, e dalle percezioni e
dalle idee di oggetti di altro tipo»4.
È solo la «parte centrale dell’inclinazione»5 dice più avanti McDougall,
«che conserva il suo carattere specifico e resta comune a tutti gli individui
e a tutte le situazioni in cui l’istinto viene eccitato». I processi conoscitivi,
e i concreti movimenti fisici attraverso i quali l’istinto raggiunge il suo
fine, possono essere infinitamente complessi. In altri termini, l’uomo ha
l’istinto della paura, ma l’oggetto della sua paura, e il modo in cui cercherà
di evitarlo, è determinato non dalla nascita, bensì dall’esperienza.
Se non fosse per questa variabilità, sarebbe difficile concepire
149
l’immensa varietà della natura umana. Ma quando si considera che tutte le
tendenze importanti della creatura, i suoi appetiti, i suoi amori, i suoi odi,
la sua curiosità, i suoi desideri sessuali, le sue paure e la sua aggressività
possono appigliarsi ad ogni sorta di oggetto-stimolo, la complessità della
natura umana non è più tanto inconcepibile. E quando si pensa che ogni
nuova generazione è la vittima casuale del modo in cui la generazione
precedente era condizionata, nonché l’erede dell’ambiente risultante, le
combinazioni e le varianti possibili sono innumerevoli.
E quindi non esiste alcuna evidenza per ritenere che poiché le persone
desiderano una particolare cosa, o si comportano in un particolare modo, la
natura umana sia fatalmente costituita per desiderare questo e per agire in
quel modo. Il desiderio e l’azione sono entrambi appresi, e in un’altra
generazione potrebbero essere appresi diversamente. La psicologia
analitica e la storia sociale sono concordi nell’appoggiare questa
conclusione. La psicologia indica come sia sostanzialmente casuale il
nesso tra il particolare stimolo e la particolare reazione; l’antropologia
intesa nel senso più lato corrobora la tesi dimostrando che le cose che
hanno eccitato le passioni degli uomini, e i mezzi che essi hanno usato per
soddisfare, variano infinitamente da tempo a tempo e da luogo a luogo.
Gli uomini perseguono il loro interesse, ma non è fatalmente
determinato il modo in cui lo perseguiranno. E perciò, quali che siano i
limiti di tempo entro cui questo pianeta continuerà ad ospitare la vita
umana, l’uomo non può porre alcuna scadenza alle energie creative umane.
Non può pronunciare una condanna di automatismo. Può dire, se proprio
ne ha bisogno, che durante la sua vita non vi saranno mutamenti che egli
possa considerare buoni. Ma dicendo questo confinerà la sua vita nei limiti
di ciò che può vedere con gli occhi, respingendo ciò che potrebbe vedere
con la mente; assumerà come misura del bene una misura che è
semplicemente quella che per avventura possiede. Se l’uomo non sceglie
di considerare l’ignoto come inconoscibile, se non decide di credere che
ciò che nessuno conosce non sarà conosciuto da nessuno, e che nessuno
potrà mai insegnare ciò che qualcuno non ha ancora appreso, non avrà
alcun motivo di abbandonare le sue migliori speranze e di allentare i suoi
sforzi coscienti.
H. Bergson, L’evoluzione creatrice (Paris 1909-10), La scuola, Brescia 19795,
capp. III e IV.
1 Vernon Lee (pseud. di Violet Paget), Beauty and Ugliness, John Lane company,
London-New York 1912.
2 Un fatto che influisce moltissimo sul carattere nelle notizie; cfr. parte VII.
1
150
Cfr. F. T. Patterson, Cinema Craftsmanship, Harcourt, Brace and Co., New York
1920, pp. 31-2: «III. Se la trama manca di suspense: uno, si aggiunga un antagonista;
due, si aggiunga un ostacolo; tre, si aggiunga un problema; quattro, si dia risalto ad una
delle questioni che già stanno nella mente degli spettatori».
4 Ibid., pp. 6-7.
1 Ibid., p. 46. «L’eroe e l’eroina debbono in generale possedere giovinezza, bellezza,
bontà, straordinaria abnegazione e una costanza inalterabile».
1 Un interessante esempio è il caso descritto da C. G. Jung in «Zentralblatt für
psychoanalyse», 1911, I, p. 81; trad. inglese di Constance Long, in Collected Papers on
Analytical Psychology cit., cap. IV.
1 Per un interessante schizzo dei più notevoli tra i primi tentativi di spiegare il
carattere, si veda il capitolo intitolato «Gli antecedenti dello studio del carattere e del
temperamento», in J. Jastrow, The Psychology of Conviction. A Study of Beliefs and
Attitudes, Houghton Mifflin, Boston-New York 1918.
2 W. Cannon, Bodily Changes in Pleasure, Pain and Anger, Appleton and Co., New
York-London 1915.
3 A. Adler, Il temperamento nervoso (ed. or. Über den nervösen Charakter,
Wiesbaden 1912), Newton Compton, Roma 1971.
4 E. J. Kempf, The Autonomic Function and the Personality, Nervous and Mental
Disease Publishing Co., New York-Washington 1918; Id., Psychopatology cit. Cfr.
anche L. Berman, The Glands Regulating Personality, Macmillan, New York 1921.
5 Jastrow, The Psychology of Conviction cit., p. 156.
6 Formulata da Kempf, in Psychopathology cit., p. 74 come segue:
3
Cfr. l’interessantissimo libro di E. D. Martin, The Behaviour of Crowds, Harper &
Brothers, New York-London 1920. Si veda anche T. Hobbes, Leviatano, parte II, cap.
XXV. «Le passioni degli uomini, le quali, disgiunte, sono moderate come il calore di un
tizzone, in un’assemblea sono come parecchi tizzoni, che si infiammano l’un l’altro
(specialmente quando vi si soffia sopra reciprocamente con le orazioni)» (trad. it. di G.
Micheli, La Nuova Italia, Firenze 1976, p. 256). G. Le Bon elabora questa osservazione
di Hobbes in Psicologia delle folle (Longanesi, Milano 1980).
1 Cfr. T. Veblen, The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers, in The
Place of Science in Modern Civilization and Other Essays, Heubsch, New York 1919,
particolarmente le pp. 413-8.
2 Id., The Theory of Business Enterprise, Scribner’s, New York 1904; trad. it. La
teoria dell’impresa, Franco Angeli, Milano 1970.
3 Di fatto, quando è stato messo alla prova, Lenin ha completamente abbandonato
l’interpretazione materialistica della politica. Se si fosse attenuto davvero alla formula
di Marx, quando si impadronì del potere nel 1917, avrebbe detto a se stesso: secondo gli
insegnamenti di Marx, il socialismo scaturirà da un capitalismo maturo… eccomi qui, a
capo di una nazione che entra solo ora nello sviluppo capitalistico… è vero che sono un
socialista, ma sono un socialista scientifico… ne segue che per il momento qualunque
idea di una repubblica socialista è fuori luogo… dobbiamo promuovere il capitalismo
7
151
perché abbia luogo l’evoluzione che Marx ha predetto. Ma Lenin non ha fatto nulla di
tutto ciò. Invece di attendere che l’evoluzione si evolvesse, ha cercato di sfidare con la
volontà, la forza e l’istruzione il processo storico che la sua filosofia presupponeva.
(Dopo che queste pagine erano state scritte, Lenin ha abbandonato il comunismo
giustificando il passo col fatto che la Russia non possiede la base necessaria di un
capitalismo maturo. Egli ora dice che la Russia deve creare il capitalismo, il quale
creerà un proletariato, il quale un giorno o l’altro creerà il comunismo. Questo elenco è
coerente con il dogma marxista. Ma dimostra quanto poco determinismo ci sia nelle
opinioni di determinista).
1 James, Principles of Psychology cit., II, p. 383.
2 Ibid., II, p. 390.
3 W. McDougall, An Introduction to Social Psychology, J. W. Luce & Co., Boston
19114, pp. 31-2
4 «La maggior parte delle definizioni degli istinti e delle azioni istintive tengono
conto solo dei loro aspetti volitivi […] ed è un errore comune trascurare gli aspetti
conoscitivi e affettivi del processo mentale istintivo». Ibid., p. 29, nota a piè di pagina.
5 Ibid., p. 34.
152
V.
La formazione di una volontà comune
153
XIII.
Il trasferimento dell’interesse
1.
Ciò dimostra che vi sono molte variabili nelle impressioni che si hanno
del mondo che non si vede. I punti di contatto variano, le aspettative
stereotipate variano, l’interesse destato varia ancor più sottilmente. Le vive
impressioni di un gran numero di persone sono, in ciascuna, personali in
misura insondabile, e in massa sono incontrollabilmente complesse. Come
si stabilisce, allora, un rapporto pratico tra ciò che sta nella mente degli
individui e ciò che sta nell’ambiente che esula dal loro campo visuale? In
che modo, per dirla col linguaggio della teoria democratica, si sviluppa
una volontà comune tra tante persone, ognuna delle quali ha un sentimento
così privato intorno a un’immagine così astratta? Come emerge da questo
sviluppo di variabili un’idea semplice e costante? In che modo immagini
così fluttuanti e casuali riescono a cristallizzarsi in quelle cose che
chiamiamo la Volontà del Popolo, o la Missione Nazionale o l’Opinione
Pubblica?
Che si tratti di una difficoltà reale è dimostrato da una rabbiosa tenzone
scoppiata nella primavera del 1921 tra l’ambasciatore americano in
Inghilterra e un gran numero di altri americani. Parlando durante un
pranzo, in Inghilterra, Harvey aveva indicato senza la minima esitazione al
mondo quali fossero stati nel 1917 i moventi degli americani1. Questi
ultimi, secondo lui, non erano i moventi su cui aveva insistito il presidente
Wilson, quando a sua volta aveva annunciato quale fosse il pensiero
americano. Naturalmente né Harvey né Wilson, né gli avversari né gli
amici di entrambi, né chicchessia, possono sapere quantitativamente e
qualitativamente che cosa passasse nella mente di trenta o quaranta milioni
di adulti. Ma ciò che tutti sanno è che una guerra è stata combattuta e vinta
grazie a una moltitudine di sforzi, stimolati, nessuno sa in quale
proporzione, dalle ragioni di Wilson e dalle ragioni di Harvey, e da tutte le
possibili combinazioni tra le due. La gente si è arruolata e ha combattuto,
lavorato, pagato le tasse, si è sacrificata per un fine comune; e tuttavia
nessuno può cominciare a dire con precisione che cosa abbia spinto
ciascuna persona a fare le singole cose che ha fatto. Perciò è inutile che
154
Harvey dica al soldato, il quale riteneva che questa fosse una guerra per
porre fine alla guerra, che il soldato non pensava affatto questo. Il soldato
che lo pensava, lo pensava. E Harvey, che pensava diversamente, pensava
diversamente.
Nello stesso discorso Harvey ha formulato con eguale chiarezza quello
che avevano in mente gli elettori del 1920. È un atteggiamento spericolato,
e, se addirittura si dà per scontato che tutti quelli che hanno votato come
noi l’hanno fatto per le stesse ragioni, è un atteggiamento insincero. Le
cifre indicano che sedici milioni di persone hanno votato per i
repubblicani, e nove milioni per i democratici. Hanno votato, dice Harvey,
pro e contro la Società delle Nazioni, e a sostegno di questa tesi può
richiamare la richiesta di Wilson di indire un referendum, e il fatto
innegabile che il partito democratico e Cox sostenevano che il tema delle
elezioni era la Società. Ma dire che la Società era il tema non la rendeva il
tema, e contando i voti degli elettori non si conosce la reale divergenza di
opinioni a proposito della Società. C’erano, ad esempio, nove milioni di
democratici. Si ha il diritto di ritenere che siano tutti strenui fautori della
Società? Certamente non lo sono. Infatti la conoscenza della politica
americana ci dice che molti milioni hanno votato, come fanno sempre, per
conservare nel Sud il sistema sociale esistente, e, quali che siano le loro
opinioni sulla Società delle Nazioni, non hanno affatto votato per
esprimerlo. Senza dubbio quelli che volevano la Società erano contenti che
anche il partito democratico la volesse. Quelli a cui non andava a genio la
Società forse si turavano il naso mentre votavano. Ma entrambi questi
gruppi di sudisti hanno votato per lo stesso partito.
Erano più unanimi i repubblicani? Chiunque può estrarre dalla cerchia
dei suoi amici un numero di elettori repubblicani sufficiente a coprire
l’intera gamma di opinioni che va dall’irriducibile avversione dei senatori
Johnson e Knox alle chiare simpatie di Hoover e del capo della Corte
Suprema Taft. Nessuno può dire con sicurezza quante persone provassero
un determinato sentimento nei confronti della Società, né quante persone
abbiano lasciato che i loro sentimenti nei confronti di quel problema
determinassero il loro voto. Dato che ci sono due soli modi di esprimere
cento diversi sentimenti, non esiste un modo certo di sapere quale sia stata
la combinazione decisiva. Il senatore Borah ha trovato nel partito
repubblicano una ragione per votare repubblicano, ma anche il presidente
Lowell ce l’ha trovata. La maggioranza repubblicana era composta di
uomini e donne che ritenevano che la vittoria repubblicana avrebbe ucciso
la Società, più quelli che la ritenevano il modo più pratico di garantire la
Società, più quelli che la ritenevano il modo più sicuro per ottenere una
155
Società modificata. Tutti questi votanti erano inestricabilmente
condizionati dal loro desiderio, o dal desiderio di altri votanti di migliorare
la congiuntura economica, o di mettere a posto i lavoratori, o di punire i
democratici per essere entrati in guerra, o di punirli per non esserci entrati
prima, o di sbarazzarsi di Burleson, o di migliorare il prezzo del grano, o
di diminuire le tasse.
E tuttavia una decisione è emersa: Harding si è trasferito alla Casa
Bianca. Infatti il minimo denominatore comune di tutti i voti era che i
democratici dovevano andarsene, e i repubblicani dovevano prendere il
loro posto. Era questo il solo fattore che rimaneva dopo che tutte le
contraddizioni si erano annullate a vicenda, ma questo fattore è stato
sufficiente a mutare l’indirizzo politico per quattro anni. Le ragioni
precise, per cui in quel giorno di novembre del 1920 si desiderava un
mutamento, non sono registrate nemmeno nella memoria dei singoli
votanti. Le ragioni non sono fisse. Si sviluppano e mutano, e si fondono
con altre ragioni, sicché le opinioni pubbliche che Harding oggi deve
affrontare non sono le opinioni che lo hanno eletto. Si è visto nel 1916 che
non c’è un’inevitabile connessione tra un assortimento di opinioni e una
particolare linea di azione. Eletto apparentemente al grido di «ci ha tenuti
fuori dalla guerra», Wilson dopo cinque mesi portò il paese in guerra.
Il funzionamento della volontà popolare ha sempre richiesto, perciò,
una spiegazione. Quelli che sono stati colpiti soprattutto dalla stravaganza
del suo funzionamento, hanno trovato un profeta in Le Bon, e hanno
accolto con favore le generalizzazioni su ciò che Sir Robert Peel definiva
«quella grossa mistura di follia, debolezza, pregiudizi, sentimenti sbagliati,
sentimenti giusti, ostinazione e trafiletti di giornale che si chiamano
opinione pubblica». Altri hanno concluso che, siccome dal flusso e
dall’incoerenza emergono però delle mire determinate, deve esserci un
misterioso congegno che funziona da qualche parte al di sopra e al di là
degli abitanti di una nazione. E perciò parlano di un’anima collettiva, di
una mente nazionale, di uno spirito dell’epoca, che impone un ordine
all’opinione casuale. Pare che debba esserci una superanima, perché le
emozioni e le idee dei membri di un gruppo non rivelano alcunché di tanto
semplice e tanto cristallino come la formula che questi stessi individui
accetteranno quale veritiera formulazione della loro Opinione Pubblica.
2.
Ma io credo che i fatti si possano spiegare in modo più convincente
senza l’aiuto della superanima in una qualsiasi delle sue manifestazioni.
156
Dopo tutto l’arte di indurre persone, che la pensano diversamente, a votare
nello stesso modo viene praticata in ogni campagna politica. Nel 1916, ad
esempio, il candidato repubblicano doveva produrre voti repubblicani
traendoli da molte specie di repubblicani. Scorriamo il primo discorso
tenuto da Hughes dopo aver accettato la candidatura1. Il contesto è ancora
abbastanza chiaro nella nostra mente per non rendere necessarie troppe
spiegazioni; e tuttavia i temi non sono più controversi. Il candidato era un
uomo insolitamente franco, che da vari anni non faceva politica e non era
personalmente impegnato nei problemi del recente passato. Per di più gli
mancava quel tipo di doti che possiedono capi popolari come Roosevelt,
Wilson o Lloyd George, quel dono istrionico grazie al quale uomini come
questi impersonano i sentimenti dei loro seguaci. Per temperamento e
preparazione era estraneo a questo aspetto della politica, ma conosceva per
calcolo quale sia la tecnica del politico. Era una di quelle persone che
sanno bene come si deve fare una cosa, ma che con la migliore volontà del
mondo non riescono a farla loro. Spesso sono maestri migliori del
virtuoso, nel quale l’arte è talmente una seconda natura che lui stesso non
sa come riesce. L’affermazione che coloro che possono, fanno, e coloro
che non possono, insegnano, non è poi tanto sfavorevole all’insegnante
come sembrerebbe.
Hughes sapeva che l’occasione era importante, e aveva preparato il suo
manoscritto con cura. In un palco sedeva Theodore Roosevelt, appena
tornato dal Missouri. Il teatro era pieno di reduci da Armageddon, in varie
fasi di dubbio e di angoscia. Sul palcoscenico e negli altri palchi si
potevano vedere gli ex sepolcri imbiancati e gli ex scassinatori del 1912,
ovviamente in ottima salute e di buonissimo umore. Al di là delle mura del
teatro c’erano forze filotedesche e forze filoalleate; un partito favorevole
alla guerra nell’Est e nelle grandi città; un partito favorevole alla pace nel
Midwest e nel Far West. C’era molta emozione per i fatti del Messico.
Hughes doveva formare una maggioranza contro i democratici riunendo
persone divise in tutte le possibili combinazioni sulle questioni Taft o
Roosevelt, Germania o Alleati, guerra o neutralità, intervento nel Messico
o non-intervento.
Naturalmente qui non ci interessano la moralità o la saggezza
dell’operazione. Ci interessa solo il metodo con cui il leader di
un’opinione eterogenea affronta il problema di assicurare un voto
omogeneo.
Quest’assemblea rappresentativa è un felice auspicio. Attesta la forza della
riunificazione. Attesta che il partito di Lincoln è ricostituito…
157
Le parole in corsivo sono il trait-d’union: in un tale discorso Lincoln
non ha naturalmente alcun rapporto con Abraham Lincoln. È soltanto uno
stereotipo grazie al quale la reverenza, che circonda questo nome, può
venire trasferita sul candidato repubblicano che in questo momento sta al
suo posto. Lincoln ricorda ai repubblicani, ai Bull Moose e alla Vecchia
Guardia, che prima della scissione avevano una storia comune. Sulla
scissione nessuno può permettersi di parlare. Ma resta lì, non ancora
sanata.
L’oratore deve sanarla. Ora, la scissione del 1912 era stata originata da
questioni interne; la riunificazione del 1916 doveva fondarsi, come aveva
dichiarato Theodore Roosevelt, sul comune sdegno per il modo in cui
Wilson conduceva la politica estera. Ma la politica estera era anch’essa
una pericolosa fonte di contrasti. Occorreva un argomento d’apertura che
non solo ignorasse il 1912, ma evitasse anche i conflitti esplosivi del 1916.
L’oratore scelse abilmente il clientelismo nell’assegnazione degli incarichi
diplomatici. «Democratici meritevoli» era un’espressione che screditava, e
Hughes la usa subito. Poiché l’evidenza è tale da non ammettere difese,
l’attacco viene portato a fondo senza esitazioni. Dal punto di vista logico,
era un’introduzione ideale alla formazione di uno stato d’animo comune.
Hughes poi passa al Messico, cominciando con un esame storico.
Doveva tener conto della diffusa impressione che le cose messicane
stessero andando male; e inoltre di un sentimento non meno diffuso che si
dovesse evitare la guerra; e di due potenti correnti d’opinione, una delle
quali affermava che Wilson aveva ragione di non riconoscere Huerta, e
l’altra che preferiva Huerta a Carranza, e l’intervento a entrambi. Huerta
era il primo punto dolente della faccenda…
Egli era certamente di fatto il capo del governo del Messico.
Ma bisognava placare i moralisti che consideravano Huerta un
assassino ubriaco.
Se dovesse esser riconosciuto o meno era una questione da determinarsi
nell’esercizio di una saggia discrezionalità, ma secondo retti principi.
E così, invece di dire che si doveva riconoscere Huerta, il candidato
dice che si dovevano applicare retti principi. Tutti credono nei retti
principi, e tutti, naturalmente, credono di possederli. Per confondere
ulteriormente la questione, la politica del presidente Wilson viene definita
«intervento». Lo era dal punto di vista giuridico, forse, ma non nel senso
che la parola aveva comunemente a quel tempo. Il contrasto tra le due
158
funzioni doveva venire represso stirando la parola sì da farle abbracciare
tanto quello che Wilson aveva fatto come quello che volevano i veri
interventisti.
Avendo superato i due punti esplosivi, «Huerta» e «intervento», col
metodo di lasciare che le parole assumessero il significato che ognuno
voleva attribuirgli, il discorso si colloca per un po’ su un terreno più
sicuro. Il candidato racconta la vicenda di Tampico e Vera Cruz, Villa,
Santa Isabel, Columbo e Carrizal. Hughes è dettagliato, o perché i fatti,
come si può ricavarli dai giornali, sono irritanti, o perché la vera
spiegazione è, come ad esempio nel caso di Tampico, troppo complicata.
Un tale racconto non poteva suscitare passioni contrarie. Ma alla fine il
candidato doveva prender posizione. Il suo pubblico se l’aspettava.
L’accusa era quella di Roosevelt. Avrebbe Hughes adottato il suo rimedio,
l’intervento?
La nazione non ha una politica di aggressione verso il Messico. Non desideriamo
alcuna parte del suo territorio. Desideriamo che abbia pace, stabilità e prosperità.
Dovremmo esser pronti ad aiutarlo a fasciare le sue ferite, a sollevarlo dalla fame e
dai disagi, a dargli in ogni possibile modo i benefici della nostra disinteressata
amicizia. La condotta di questa amministrazione ha creato difficoltà che dovremo
superare […] dovremo adottare una nuova politica, una politica di fermezza e
coerenza che sole ci consentiranno di promuovere un‘amicizia duratura.
Il tema dell’amicizia è per i non interventisti, il tema della «nuova
politica» e della «fermezza» è per gli interventisti. Nella parte non
controversa la precisione è addirittura opprimente, dove c’è dissidio, tutto
viene lasciato al vago.
A proposito della guerra in Europa Hughes impiegò un’ingegnosa
formula:
Sono per il mantenimento inflessibile di tutti i diritti americani in terra e in mare.
Per comprendere la forza di questa dichiarazione nel momento in cui fu
pronunciata dobbiamo ricordare che ciascuna fazione, durante il periodo di
neutralità, era convinta che le nazioni europee da essa osteggiate fossero le
sole che violavano i diritti americani. Hughes sembrava dire ai filoalleati:
avrei usato la maniera forte con la Germania. Ma i filotedeschi avevano
sostenuto che la forza navale inglese stava violando la maggior parte dei
nostri diritti. Con la frase simbolica «diritti americani», la formula copre
due fini diametralmente opposti.
Ma c’era il Lusitania. Come la scissione del 1912, questo era un
ostacolo invincibile alla concordia.
159
sono convinto che non si sarebbero perdute vite americane per l’affondamento del
Lusitania.
E allora ciò che non può essere oggetto di compromesso dev’essere
dimenticato. Quando c’è una questione su cui non possiamo sperare di
essere tutti d’accordo, fingiamo che non esista. Sulle future relazioni
dell’America con l’Europa, Hughes non si pronunciava. Non poteva
escogitare nulla che potesse incontrare il favore delle due fazioni
inconciliabili di cui doveva cercare l’appoggio.
È appena necessario dire che Hughes non inventò questa tecnica, né la
impiegò col massimo successo. Ma diede un esempio di come si possa
rendere nebulosa un’opinione pubblica fatta di opinioni divergenti; come il
suo contenuto si avvicini alla tinta neutrale che si ricava dalla mescolanza
di molti colori. Dove l’obiettivo è una concordia superficiale, e la
divergenza è la realtà di fatto, il risultato consueto nel rivolgersi al
pubblico è l’oscurità. Quasi sempre la poca chiarezza in una giuntura
cruciale del dibattito pubblico è sintomo di intenti contraddittori.
3.
Ma com’è che un’idea vaga così spesso ha il potere di unificare
opinioni profondamente sentite? Per quanto profondamente possano essere
sentite queste opinioni, esse, ricordiamolo, non stanno in contatto continuo
e acuto con i fatti che sostengono di trattare. Il nostro dominio sul mondo
che non vediamo – il Messico, la guerra in Europa – è tenue, anche se il
nostro sentimento può esser intenso. Le immagini e le parole, che in
origine l’hanno suscitato, non hanno minimamente la forza del sentimento
stesso. Il racconto di ciò che è accaduto, al di là della nostra vista e del
nostro udito, in un luogo dove non siamo mai stati, non ha e non può mai
avere, salvo per brevi attimi, come nel sogno o in una fantasticheria, tutte
le dimensioni della realtà. Ma può suscitare tutta l’emozione della realtà, e
talora qualcosa di più. Infatti il grilletto può essere fatto scattare da più di
uno stimolo.
Lo stimolo che in origine ha fatto scattare il grilletto può essere stato
una serie di immagini suscitate nella mente da parole pronunciate o
stampate. Queste immagini svaniscono e difficilmente restano costanti; i
loro contorni e il loro ritmo fluttuano. Gradatamente comincia il processo
del capire che cosa si prova, senza essere del tutto certi del perché lo si
prova. Le immagini evanescenti sono soppiantate da altre immagini, e poi
da nomi o simboli. Ma l’emozione permane, suscettibile ora di venire
160
destata dalle immagini e dai nomi subentranti. Queste sostituzioni
avvengono anche nel pensiero rigoroso, perché se un individuo cerca di
confrontare due situazioni complicate, ben presto trova estenuante il
tentativo di tenerle entrambe in mente in tutti i dettagli. Adopera una
stenografia di nomi e segni e campioni. Se vuole fare qualche progresso
deve fare così, perché non può portare il bagaglio intero in ogni frase,
attraverso ogni operazione che compie. Ma se dimentica di aver sostituito
e semplificato, scivola ben presto nel verbalismo, e comincia a parlare di
nomi prescindendo dalle cose. E allora non ha più modo di capire quando
la parola, scissa dal suo primo oggetto, è entrata in una mésalliance con
un’altra cosa. È ancora più difficile guardarsi dalle sostituzioni nella
politica quotidiana.
Infatti, per ciò che è noto agli psicologi come «reazione condizionata»,
un’emozione non è legata ad una sola idea. Ci sono innumerevoli cose che
possono suscitare l’emozione, e innumerevoli cose che la possono
soddisfare. Questo è particolarmente vero quando lo stimolo viene
percepito in modo indistinto e indiretto, e quando l’oggetto è parimenti
indiretto. Infatti si può associare un’emozione, ad esempio la paura,
dapprima a qualcosa di immediatamente pericoloso, poi all’idea di questa
cosa, poi a qualcosa di simile a quest’idea, e così via. L’intera struttura
della civiltà umana è per un certo verso l’elaborazione degli stimoli e delle
reazioni di cui le capacità emotive originarie restano un centro
relativamente fisso. Senza dubbio nel corso della storia la qualità
dell’emozione è mutata, ma con una velocità e un’elaborazione non
paragonabili a quelle che hanno caratterizzato i suoi condizionamenti.
Gli individui differiscono notevolmente nella disposizione ad essere
influenzati dalle idee. In alcuni l’idea di un bambino affamato in Russia è
praticamente viva quanto la vista di un bambino affamato. Altri sono quasi
incapaci di venir commossi da un’idea lontana. Tra gli uni e gli altri ci
sono molte gradazioni. E ci sono persone che sono insensibili ai fatti, e
mosse solo da idee. Ma anche se l’emozione viene suscitata dall’idea, non
riusciamo a soddisfare l’emozione agendo noi stessi sul luogo della
vicenda. L’idea del bambino russo affamato suscita il desiderio di dar da
mangiare al bambino, ma la persona colpita dall’idea non è in grado di
farlo. Può solo dare del denaro a un’organizzazione impersonale, oppure a
una personificazione che egli chiama Hoover. Il suo denaro non raggiunge
quel bambino. Va a un fondo generale con cui viene nutrita una massa di
bambini. E così, proprio come l’idea è indiretta, così sono indiretti gli
effetti dell’azione. La conoscenza è indiretta, la volizione è indiretta, solo
l’effetto è immediato. Delle tre parti del processo, lo stimolo proviene da
161
un punto che è fuori della vista, la reazione arriva in un punto che è fuori
della vista, solo l’emozione sta tutta dentro la persona. Della fame del
bambino egli ha soltanto un’idea, ma del proprio desiderio di aiutarlo ha
un’esperienza reale. È il fatto centrale della vicenda, l’emozione che ha in
sé, che è diretto.
Entro limiti che possono variare, l’emozione è trasferibile sia per
quanto riguarda lo stimolo che per quanto riguarda la reazione. Perciò se
tra diverse persone, che possiedono varie tendenze a reagire, si può trovare
uno stimolo che susciti la stessa emozione in molte di loro, esso può essere
sostituito agli stimoli originali. Se, ad esempio, un individuo detesta la
Società delle Nazioni, un altro odia Wilson, e un terzo teme i lavoratori, si
può riuscire a unirli se si è in grado di trovare uno stimolo che sia l’antitesi
di ciò che essi tutti odiano. Supponiamo che questo simbolo sia
l’americanismo. Il primo individuo può intenderlo come la conservazione
dell’isolazionismo americano, o, come forse lo chiamerà,
dell’indipendenza; il secondo come il rifiuto di un uomo politico che
contrasta con la sua idea di come un presidente americano deve essere; il
terzo come un imperativo ad opporsi alla rivoluzione. Il simbolo in se
stesso non significa letteralmente nessuna cosa in particolare, ma può
essere associato a quasi tutto. E per questo può diventare il cemento
comune di comuni sentimenti, anche se questi sentimenti in origine erano
legati a idee disparate.
Quando i partiti politici o i giornali si dichiarano a favore
dell’americanismo, del progressismo, della legge e dell’ordine, della
giustizia, dell’umanità, sperano di amalgamare il sentimento di fazioni in
contrasto che sicuramente si dividerebbero se, invece di questi simboli,
venissero invitate a discutere uno specifico programma. Infatti, quando è
stata realizzata una coalizione intorno al simbolo, il sentimento confluisce
verso il conformismo sotto il simbolo piuttosto che verso il vaglio critico
dei provvedimenti. Credo che sia opportuno e tecnicamente corretto
chiamare simboliche le espressioni polivalenti come queste. Non
rappresentano idee specifiche, ma una specie di tregua o giuntura tra idee.
Sono come un nodo ferroviario strategico, dove convergono molte linee
indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione ultima. Ma
colui che cattura i simboli, che per il momento contengono il sentimento
pubblico, controlla in corrispondenza le vie alla direzione della cosa
pubblica. E fintantoché un particolare simbolo ha il potere di coalizzare, le
fazioni ambiziose lotteranno per impossessarsene. Si pensi, ad esempio, al
nome di Lincoln o a quello di Roosevelt. Un capo o un interesse che può
entrare in possesso dei simboli correnti è padrone della situazione del
162
momento. Naturalmente ci sono dei limiti. Un abuso troppo violento delle
realtà che vari gruppi di persone ritengono rappresentate dal simbolo, o
una resistenza troppo forte a nuovi fini fatta in nome di questo simbolo,
faranno, per così dire, scoppiare il simbolo. In questo modo, nel corso del
1917, l’imponente simbolo della Santa Russia e del Piccolo Padre scoppiò
sotto l’urto delle sofferenze e della sconfitta.
4.
Le tremende conseguenze del collasso della Russia furono sentite su
tutti i fronti e tra tutti i popoli. Condussero direttamente a un sensazionale
caso di cristallizzazione in un’opinione comune delle disparate opinioni
messe in movimento dalla guerra. I Quattordici Punti si rivolgono a tutti i
governi – alleati, nemici, neutrali – e a tutti i popoli. Erano un tentativo di
cucire insieme i principali imponderabili di una guerra mondiale. Si
trattava per forza di cose di un nuovo orientamento, perché questa è stata
la prima grande guerra in cui tutti i membri responsabili del genere umano
abbiano potuto venir persuasi a riflettere sulle stesse idee, o almeno sugli
stessi nomi per le stesse idee, simultaneamente. Senza cablogrammi, radio,
telegrafo e stampa quotidiana, l’esperimento dei Quattordici Punti sarebbe
stato impossibile. Era un tentativo di utilizzare i moderni mezzi di
comunicazione per promuovere il ritorno a una «coscienza comune» in
tutto il mondo.
Ma anzitutto dobbiamo esaminare alcune delle circostanze che si
presentavano alla fine del 1917. Infatti, nella forma che il documento
assunse alla fine, tutte queste considerazioni erano in qualche modo
rappresentate. Durante l’estate e l’autunno era accaduta una serie di
avvenimenti che influirono profondamente sul morale della gente e sul
corso della guerra. In luglio i russi avevano condotto un’ultima offensiva,
erano stati disastrosamente battuti ed era cominciato il processo di
demoralizzazione che portò alla rivoluzione bolscevica di novembre. Poco
prima i francesi avevano subito una sconfitta grave e quasi disastrosa, nella
Champagne, che provocò ammutinamenti nell’esercito e un’agitazione
disfattista tra i civili. L’Inghilterra soffriva degli effetti delle incursioni dei
sommergibili, delle terribili perdite subite nelle battaglie delle Fiandre, e in
novembre a Cambray le armate inglesi subirono un rovescio che atterrì le
truppe al fronte e i dirigenti in patria. Un’estrema stanchezza pervadeva
l’intera Europa occidentale.
In realtà il tormento e la delusione avevano scosso l’adesione degli
individui all’interpretazione ufficiale della guerra. Il loro interesse non
163
veniva più trattenuto dai comunicati ufficiali, e la loro attenzione cominciò
a divagare, fissandosi ora sulle proprie sofferenze, ora sulle mete del loro
partito o della loro classe, ora sui risentimenti generali contro i governi.
Quella più o meno perfetta organizzazione della percezione ad opera della
propaganda ufficiale, dell’interesse e dell’attenzione ad opera degli stimoli
della speranza, della paura e dell’odio, che viene detto il «morale», stava
sul punto di crollare. Dappertutto le menti degli uomini cominciavano a
cercare nuove ancore di salvezza.
Improvvisamente videro un dramma impressionante. Sul fronte
orientale c’era una tregua natalizia, una cessazione del massacro, una
cessazione del frastuono, una promessa di pace. A Brest-Litovsk il sogno
della gente semplice si era avverato: era possibile negoziare, per porre fine
alla prova c’era un modo diverso del gareggiare vita contro vita con il
nemico. Timidamente, ma con un’attenzione rapita, la gente cominciò a
rivolgere lo sguardo ad Est. Perché no, si chiedeva? A cosa serve tutto
questo? Sanno gli uomini politici che cosa stanno facendo? Stiamo
davvero combattendo per quello che dicono? Non si potrebbe ottenerlo
senza combattere? Ben poco di tutto questo riusciva ad arrivare sulla
stampa, con la censura, ma quando parlò Lord Lansdowne ci fu una
reazione che veniva dal cuore. I precedenti simboli della guerra si erano
logorati, e avevano perso il loro potere unificatore. In tutti i paesi alleati si
stava aprendo sotto la superficie una larga frattura.
Qualcosa di simile stava avvenendo nell’Europa centrale. Anche lì
l’impulso originario alla guerra si era indebolito; l’unione sacra si era
spezzata. Le spaccature verticali lungo il fronte di combattimento erano
intersecate da divisioni orizzontali che si allargavano in modi
imprevedibili. La crisi morale della guerra era arrivata prima che ne fosse
in vista la conclusione militare. Il presidente Wilson e i suoi consiglieri si
resero conto di ciò. Naturalmente non avevano una conoscenza perfetta
della situazione; ma sapevano quello che ho sommariamente descritto.
Sapevano anche che i governi alleati erano legati a una serie di impegni
che nella lettera e nello spirito andavano contro la concezione popolare
delle ragioni della guerra. Le risoluzioni della Conferenza economica di
Parigi erano, naturalmente, di dominio pubblico, e la rete dei trattati segreti
era stata pubblicata dai bolscevichi nel novembre del 19171. Le loro
clausole erano note solo genericamente ai popoli, ma sicuramente si
pensava che non si accordavano allo slogan idealistico
dell’autodeterminazione, niente annessioni e niente indennità di guerra. I
popoli si domandavano quante migliaia di vite inglesi valessero l’AlsaziaLorena e la Dalmazia, quante migliaia di vite francesi valessero la Polonia
164
e la Mesopotamia. E anche in America si cominciò ad aver sentore di
queste domande. La causa degli alleati era stata messa sulla difensiva dal
rifiuto di partecipare ai negoziati di Brest-Litovsk.
Era uno stato d’animo molto delicato, da cui nessun esperto leader
poteva prescindere. La risposta ideale sarebbe stata un’azione congiunta
degli alleati. Essa risultò impossibile quando fu presa in considerazione
alla Conferenza interalleata d’ottobre. Ma a dicembre la pressione era
diventata così forte che Lloyd George e Wilson si sentirono costretti, l’uno
indipendentemente dall’altro, a dare una qualche risposta. La forma scelta
dal presidente americano fu una dichiarazione che indicava le condizioni
di pace in quattordici capi. La numerazione era un artificio per assicurare
la precisione e per creare subito l’impressione che si trattasse di un
documento pratico. L’idea di formulare le «condizioni della pace» invece
che «gli obiettivi della guerra» derivò dalla necessità di creare un’autentica
alternativa ai negoziati di Brest-Litovsk. Miravano a richiamare
l’attenzione del pubblico, sostituendo allo spettacolo delle conversazioni
russo-tedesche lo spettacolo molto più grandioso di un dibattito pubblico
mondiale.
Avendo suscitato l’interesse del mondo, fu necessario tener unito ed
elastico quest’interesse per far fronte a tutte le diverse possibilità implicite
nella situazione. Le condizioni dovevano essere tali che la maggioranza
degli alleati le considerasse valide. Dovevano incontrare le aspirazioni
nazionali di ogni popolo, e tuttavia limitare queste aspirazioni, affinché
nessuna nazione si considerasse lo strumento di un’altra. Le condizioni
dovevano soddisfare gli interessi ufficiali per non provocare una disunione
ufficiale, e tuttavia dovevano venire incontro alle concezioni correnti in
modo da prevenire il dilagare della demoralizzazione. In breve, dovevano
conservare e confermare l’unità degli alleati nel caso che la guerra dovesse
continuare.
Ma dovevano anche essere le condizioni di una possibile pace; nel caso
in cui il centro e la sinistra tedeschi fossero stati maturi per un’agitazione,
essi avrebbero avuto un testo con cui colpire la classe governante. Le
condizioni, perciò, dovevano avvicinare i governanti alleati ai loro poli,
allontanare i governanti tedeschi dal loro popolo, e creare un terreno di
comprensione reciproca tra gli alleati, l’opposizione tedesca e i popoli
assoggettati dall’Austria-Ungheria. I Quattordici Punti erano un audace
tentativo di levare uno stendardo sotto cui quasi tutti potessero ripararsi. Se
un numero sufficiente di nemici erano pronti, ci sarebbe stata la pace;
altrimenti gli alleati sarebbero stati in grado di sostenere meglio lo shock
della guerra.
165
Tutte queste considerazioni entrarono nella formulazione dei
Quattordici Punti. Forse nessuno le aveva tutte in mente, ma tutti gli
uomini che vi collaborarono ne avevano in mente qualcuna. Esaminiamo
ora alcuni aspetti del documento proiettandoli su questo sfondo. I primi
cinque punti e il quattordicesimo riguardano la «diplomazia aperta», la
«libertà dei mari», la parità «commerciale», la «riduzione degli
armamenti», il divieto delle annessioni imperialistiche di colonie e la
Società delle Nazioni. Potrebbero essere definiti la formulazione delle
generalizzazioni popolari in cui tutti a quel tempo professavano di credere.
Ma il numero tre è più specifico. Puntava consapevolmente e direttamente
alle deliberazioni della Conferenza economica di Parigi, e intendeva
liberare il popolo tedesco dalla paura del soffocamento.
Il numero sei è il primo punto che riguardi una particolare nazione.
Intendeva essere una risposta ai sospetti russi verso gli alleati, e
l’eloquenza delle sue promesse era intonata al dramma di Brest-Litovsk. Il
numero sette si occupa del Belgio, ed è, sia nella forma che nell’intento,
tanto impreciso quanto lo era la convinzione di quasi tutto il mondo,
compresa una gran parte dell’Europa centrale. Sul numero otto dobbiamo
soffermarci. Comincia con una richiesta perentoria di evacuazione e
restituzione del territorio francese, e quindi passa alla questione
dell’Alsazia-Lorena. La struttura di questa clausola illustra in modo
perfetto il carattere di una dichiarazione pubblica che deve condensare in
poche parole un’enorme congerie di interessi. «E il torto fatto alla Francia
dalla Prussia nel 1871 sulla questione dell’Alsazia-Lorena, che ha turbato
la pace del mondo per quasi cinquant’anni, dev’essere riparato». Qui ogni
parola fu scelta con cura meticolosa. Il torto fatto doveva esser riparato;
perché non dire che l’Alsazia-Lorena doveva essere restituita? Non lo si
diceva perché non era certo che tutti i francesi in quel momento avrebbero
continuato a combattere indefinitamente per la riannessione, se gli fosse
stato offerto un plebiscito; e perché era ancor meno certo che gli inglesi e
gli italiani avrebbero combattuto. Perciò la formula doveva coprire tutte e
due le possibilità. La parole «riparato» garantiva soddisfazione alla
Francia, ma non suonava come un impegno alla semplice annessione. Ma
perché parlare del torto fatto dalla Prussia nel 1871? La parola Prussia,
naturalmente, intendeva ricordare ai tedeschi del Sud che l’Alsazia-Lorena
apparteneva non a loro, ma alla Prussia. Perché parlare di pace turbata per
«cinquant’anni», e perché l’uso di «1871»? In primo luogo quello che i
francesi e il resto del mondo ricordavano era il 1871. Era questo il punto
nodale della loro lagnanza. Ma i formulatori dei Quattordici Punti
sapevano che i governanti francesi avevano in progetto qualcosa di più
166
dell’Alsazia-Lorena del 1871. Gli appunti segreti che erano passati tra i
ministri dello zar e i governanti francesi del 1916 abbracciavano
l’annessione della valle del Saar e una qualche forma di smembramento
della Renania. Si progettava di includere la valle del Saar sotto
l’espressione «Alsazia-Lorena», perché aveva fatto parte dell’AlsaziaLorena nel 1814, anche se ne era stata distaccata nel 1815, e anche se non
faceva affatto parte di questo territorio alla fine della guerra francoprussiana. La formula ufficiale francese per l’annessione della Saar era
dunque quella di includerla sotto l’espressione «Alsazia-Lorena»,
intendendo l’Alsazia-Lorena del 1814-1815. Insistendo sul «1871», il
presidente Wilson indicava in realtà in confine definitivo tra Germania e
Francia, prescindeva dal trattato segreto e lo scartava.
Il numero nove, un po’ meno sottilmente, fa la stessa cosa rispetto
all’Italia. «Demarcazioni nazionali chiaramente riconoscibili» sono
esattamente ciò che le demarcazioni del Trattato di Londra non erano.
Queste demarcazioni erano in parte strategiche, in parte economiche, in
parte imperialistiche, in parte etniche. L’unica parte che poteva in qualche
modo procurare la simpatia degli alleati era quella che avrebbe recuperato
l’autentica Italia Irredenta. Tutto il resto, come sapevano bene tutti quelli
che erano informati, non faceva altro che rinviare l’imminente rivolta
jugoslava.
5.
Sarebbe un errore credere che l’entusiasmo apparentemente unanime
che salutò i Quattordici Punti significasse accordo su un programma.
Ognuno sembrava trovare qualcosa che gli piaceva, ma nessuno rischiava
una discussione. Le frasi, così pregne dei sotterranei conflitti del mondo
civile, venivano accettate. Rappresentavano idee opposte, ma suscitavano
un’emozione comune. E in questo senso ebbero la funzione di rianimare i
popoli occidentali per i disperati dieci mesi di guerra che dovevano ancora
sopportare.
Fintantoché i Quattordici Punti trattavano di quel nebuloso e felice
futuro che sarebbe subentrato alla fine dell’agonia, i reali conflitti
d’interpretazione non venivano resi espliciti. Erano piani per il riassetto di
un mondo completamente invisibile, e poiché questi piani ispiravano a
ciascun gruppo la sua speranza particolare, tutte le speranze confluivano
come speranza pubblica. Infatti l’armonizzazione, come abbiamo visto nel
discorso di Hughes, è una gerarchia di simboli. A misura che si sale nella
gerarchia per potervi includere un numero sempre maggiore di fazioni, si
167
può per qualche tempo mantenere il collegamento emotivo, pur perdendo
quello intellettuale. Ma anche l’emozione si assottiglia. Allontanandosi
dall’esperienza, si sale sempre più nella generalizzazione o nella
sottigliezza. A mano a mano che si sale col pallone, si getta giù un numero
sempre maggiore di oggetti concreti, e quando si è raggiunta la cima con
qualche frase come i Diritti dell’Umanità o il Mondo Salvato alla
Democrazia, si vede in lungo e in largo, ma si vede pochissimo. Tuttavia le
persone, le cui emozioni si siano incanalate, non restano passive. A misura
che l’appello pubblico diventa, sempre di più, tutto quanto per tutti quanti,
e che l’emozione viene destata mentre il significato si disperde, ai loro
personalissimi significati viene data un’applicazione universale. Quello
che si desidera molto diventa i Diritti dell’Uomo. Infatti la frase ancora più
vuota, capace di significare quasi tutto, finisce ben presto per significare
pressocché tutto. Le frasi di Wilson venivano intese in ogni angolo della
terra in modi infinitamente diversi. Non esisteva alcun documento
negoziato, e reso di pubblica ragione, che correggesse la confusione1. E
così quando venne il giorno del rendiconto, tutti s’aspettavano tutto. Gli
autori europei del trattato avevano davanti a sé un’ampia scelta, e scelsero
di realizzare le aspettative di quella parte dei loro compatrioti che deteneva
la maggior parte del potere in patria.
Scesero, lungo la gerarchia, dai Diritti dell’Umanità ai Diritti della
Francia, dell’Inghilterra e dell’Italia. Non abbandonarono l’uso di simboli.
Abbandonarono solo quelli che dopo la guerra non avevano radici
permanenti nell’immaginazione dei loro elettori. Con l’uso dei simboli
mantenevano l’unità della Francia, ma non erano disposti a rischiare nulla
per l’unità dell’Europa. Il simbolo Francia era profondamente radicato, il
simbolo Europa aveva solo una breve storia. Ciononostante la distinzione
tra uno zibaldone come l’Europa e un simbolo come la Francia non è netta.
La storia degli stati e degli imperi insegna che vi sono momenti in cui
l’ambito dell’idea unificatrice si allarga, e momenti in cui si restringe. Non
si può dire che gli uomini siano passati coerentemente da fedeltà più
ristrette a fedeltà più ampie, perché i fatti non confermano la tesi.
L’Impero romano e il Sacro romano impero si gonfiarono al di là di quelle
unificazioni nazionali del XIX secolo, sulla cui base certuni per analogia
parlano di uno stato mondiale. Ciononostante, è probabilmente vero che
l’integrazione reale è aumentata, a prescindere dal gonfiamento e
sgonfiamento degli imperi.
6.
168
Una reale integrazione è indubbiamente avvenuta nella storia
americana. Nel decennio precedente il 1779 moltissimi individui, a quanto
pare, pensavano che il loro stato e la loro comunità erano reali, ma che la
confederazione degli stati fosse irreale. L’idea del loro stato, la sua
bandiera, i suoi capi più in vista, o qualunque altra cosa rappresentasse il
Massachusetts o la Virginia, erano simboli genuini. Erano cioè nutriti di
reali esperienze, che risalivano all’infanzia, al mestiere, alla residenza, e
via dicendo. Il raggio dell’esperienza degli individui raramente aveva
attraversato i confini immaginari dei loro stati. La parola virginiano era
associata a quasi tutto quello che la maggior parte dei virginiani avesse
mai conosciuto o sentito. Era l’idea politica più ampia che avesse un
autentico contatto con la loro esperienza.
Con la loro esperienza, non con i loro bisogni. Infatti i loro bisogni
sorgevano dal loro ambiente reale, che in quei tempi erano vasti almeno
quanto le tredici colonie. Avevano bisogno di una difesa comune. Avevano
bisogno di un regime finanziario ed economico vasto quanto la
confederazione. Ma fintantoché lo pseudo-ambiente dello stato li
racchiudeva, i simboli del loro stato esaurivano il loro interesse politico.
Un’idea interstatale come la confederazione rappresentava un’astrazione
inefficace. Era un carrozzone, piuttosto che un simbolo, e l’armonia tra
gruppi discordi che il carrozzone crea è transeunte.
Ho detto che l’idea di confederazione era un’astrazione inefficace. E
tuttavia nel decennio precedente la deliberazione della Costituzione il
bisogno di unità esisteva: esisteva nel senso che gli affari, se non si teneva
conto di questo bisogno di unità, non andavano per il giusto verso. Un po’
alla volta in ogni colonia certe classi cominciarono a superare i limiti
dell’esperienza statale. I loro interessi personali portavano, al di là delle
frontiere dello stato, a esperienze interstatali, e gradatamente si formava
nelle loro menti un’immagine dell’ambiente americano di dimensioni
realmente nazionali. Ai loro occhi l’idea di federazione divenne un vero
simbolo, e cessò di essere un carrozzone. Il più inventivo di questi uomini
fu Alexander Hamilton. Si dava il caso che egli non provasse un
attaccamento primitivo per nessuno degli stati perché era nato nelle Indie
occidentali, e sin dai primissimi inizi della sua vita attiva si era trovato a
contatto con gli interessi comuni di tutti gli stati. Per la maggior parte degli
uomini dell’epoca, ad esempio, la questione se la capitale dovesse essere
nella Virginia o a Filadelfia era di enorme importanza, perché avevano una
visuale locale. Per Hamilton la questione non aveva aspetti emotivi; ciò
che egli voleva era l’assunzione dei debiti degli stati, perché questo
avrebbe ulteriormente nazionalizzato l’unione proposta. Così egli barattò a
169
cuor leggero la sede della capitale con due voti decisivi di rappresentanti
dei distretti del Potomac. Per Hamilton l’unione era un simbolo che
rappresentava tutti i suoi interessi e la sua intera esperienza; per White e
Lee, del Potomac, il simbolo della loro provincia era l’entità politica più
alta da servire, ed essi la servirono pur detestando il prezzo richiestogli.
Acconsentirono, dice Jefferson, a mutare i loro voti, «White con una
nausea quasi convulsa»1.
Nel processo di cristallizzazione di una volontà comune, c’è sempre un
Alexander Hamilton al lavoro.
170
XIV.
Sì o no
1.
Spesso i simboli sono così utili e così misteriosamente potenti che la
parola stessa emana un fascino magico. Nel pensare ai simboli viene la
tentazione di trattarli come se possedessero un’energia indipendente.
Eppure innumerevoli simboli che una volta mandavano in estasi hanno
completamente cessato di influire sulle persone. I musei e le opere di
folklore sono pieni di emblemi e di incantesimi morti, dato che nel
simbolo non c’è alcun potere se non quello che esso acquista, per
associazione, nella mente umana. I simboli che hanno perduto il loro
potere, e i simboli, incessantemente suggeriti, che riescono a radicarsi, ci
ricordano che se abbiamo sufficiente pazienza per studiare in dettaglio la
diffusione di un simbolo, cogliamo una storia priva di aspetti sacri.
Nel discorso elettorale di Hughes, nei Quattordici Punti, nel progetto di
Hamilton vengono impiegati dei simboli, ma vengono impiegati da
qualcuno in un momento particolare. Le parole stesse non sono la
cristallizzazione di sentimenti occasionali; le parole debbono essere
pronunciate da persone che occupano posizioni strategiche, e debbono
essere pronunciate al momento opportuno: altrimenti non sono altro che
aria. I simboli debbono essere contrassegnati. Infatti in se stessi non
significano nulla, e la scelta dei possibili simboli è sempre così vasta che
dovremmo, come l’asino che stava equidistante tra due balle di fieno,
morire d’indecisione tra i simboli che concorrono a richiamare la nostra
attenzione.
Ecco, ad esempio, le ragioni con cui alcuni privati cittadini
giustificavano il loro voto ad un giornale alla vigilia delle elezioni del
1920.
Per Harding:
I patrioti di oggi, uomini e donne, che votano per Harding e Coolidge, saranno
considerati dai posteri come i firmatari della nostra Seconda Dichiarazione di
Indipendenza.
Wilmot, inventore.
Egli farà sì che gli Stati Uniti non entrino in «alleanze intralcianti». Washington,
171
come città, trarrà vantaggio dal passaggio del controllo governativo dalle mani dei
democratici a quelle dei repubblicani.
Clarence, commesso.
Per Cox:
Il popolo degli Stati Uniti si rende conto che il nostro dovere, giurato sui campi
di battaglia di Francia, è di aderire alla Società delle Nazioni. Dobbiamo assumerci
la nostra parte dell’onere di assicurare la pace in tutto il mondo.
Mary, stenografa.
Perderemmo il rispetto di noi stessi e quello delle altre nazioni se ci rifiutassimo
di entrare nella Società delle Nazioni per ottenere la pace internazionale.
Spencer, statistico.
I due gruppi di dichiarazioni sono egualmente nobili, egualmente veri e
quasi reversibili. Avrebbero Clarence e Wilmot ammesso anche solo per
un attimo che essi intendevano mancare al nostro dovere, giurato sui campi
di battaglia di Francia, o che non desideravano la pace internazionale?
Certamente no. Avrebbero Mary e Spencer ammesso di essere favorevoli
ad alleanze intralcianti, o a rinunciare all’indipendenza americana?
Avrebbero sostenuto che la Società era, come la definì il presidente
Wilson, un’alleanza svincolante, nonché una dichiarazione di
indipendenza per tutto il mondo, e in più una dottrina di Monroe per
l’intero pianeta.
2.
Dal momento che l’offerta di simboli è così generosa, e il significato
che gli si può attribuire è così elastico, in che modo un particolare simbolo
si radica nella mente di una particolare persona? Ve lo pianta un altro
essere umano, che la persona riconosce autorevole. Se viene piantato
abbastanza profondamente, può darsi che in seguito diremo autorevole la
persona che sbandiera quel simbolo davanti ai nostri occhi. Ma in un
primo momento i simboli ci sono resi congeniali e importanti perché ci
vengono presentati da persone congeniali e importanti.
Infatti non usciamo da un uovo già diciottenni e dotati di
un’immaginazione realistica; siamo ancora, come ricorda Shaw, nell’era di
Burge e Lubin, nella quale durante l’infanzia dipendiamo per tutti i nostri
contatti da esseri più maturi. E così stabiliamo i nostri collegamenti col
mondo esterno attraverso certe persone amate e autorevoli; sono loro il
primo ponte verso il mondo invisibile. E anche se gradualmente riusciamo
a dominare con le nostre forze molte fasi di questo mondo più vasto, ne
172
resta sempre uno ancora più vasto che è sconosciuto. A questo
continuiamo a collegarci attraverso delle autorità. Quando tutti i fatti sono
là dove non li possiamo vedere, un resoconto veritiero e un errore
plausibile suonano uguali e hanno la stessa carica emotiva. Tolte poche
materie nelle quali siamo ben preparati, non siamo in grado di scegliere tra
racconti veri e racconti falsi. Perciò scegliamo tra i cronisti degni di
fiducia e cronisti non degni di fiducia1.
In teoria dovremmo scegliere il più esperto in ogni materia. Ma la
scelta dell’esperto, quantunque sia assai più facile della scelta della verità,
è pur sempre difficile, e spesso impossibile. Gli esperti stessi non sono
minimamente certi su chi, tra loro, sia il più esperto. E con tutto ciò
l’esperto, anche quando riusciamo a identificarlo, è probabilmente troppo
occupato perché lo si possa consultare, o è addirittura inaccessibile. Ma ci
sono persone che possiamo identificare abbastanza facilmente, perché
sono le persone che dirigono. I genitori, gli insegnanti e gli amici
autorevoli sono le prime persone di questo genere che incontriamo. Non è
necessario affrontare la difficile questione del perché i bambini si fidano di
un genitore piuttosto che dell’altro, dell’insegnante di storia piuttosto che
dell’insegnante di catechismo. Né del modo in cui la fiducia gradualmente
si allarga, per il tramite di un giornale o di un conoscente che si occupa di
affari pubblici, a personaggi pubblici. La letteratura psicoanalitica è ricca
di ipotesi suggestive.
Comunque ci troviamo ad avere fiducia in certe persone, che
costituiscono i nostri mezzi di collegamento con quasi tutto il regno delle
cose sconosciute. A volte, stranamente, questo fatto è ritenuto per sua
natura poco dignitoso, quasi fosse una prova della nostra natura gregaria o
scimmiesca. Ma una completa indipendenza nell’universo è
semplicemente impossibile. Se non potessimo dare quasi tutto per
acquisito, dovremmo passare la vita perdendo tempo dietro a mille
banalità. La cosa più prossima a un adulto completamente indipendente è
un eremita, e il raggio d’azione di un eremita è brevissimo. Agendo solo
per se stesso, può agire solo entro un ambito minuscolo e per fini semplici.
Se ha tempo per pensare grandi pensieri, possiamo star certi che ha già
accettato senza obiezioni, prima di diventare un eremita, un intero
repertorio di nozioni faticosamente acquisite sul come riscaldarsi e sul
come lenire la fame, e anche su quali siano i grandi problemi. In tutti i
campi – salvo pochissimi, e per brevi periodi della nostra vita – la massima
indipendenza che possiamo esercitare è quella di moltiplicare le autorità
alle quali prestiamo benevola attenzione.
Da dilettanti congeniti, la nostra ricerca della verità consiste nello
173
stimolare gli esperti e nel costringerli a rispondere a una qualsiasi eresia
che abbia però l’accento della convinzione. In questo dibattito siamo
spesso in grado di giudicare chi abbia conquistato la vittoria dialettica, ma
siamo praticamente impotenti di fronte ad una premessa falsa, che nessuno
dei partecipanti abbia messo in dubbio, o di fronte a un aspetto poco noto,
che nessuno di loro abbia portato in discussione. Vedremo in seguito come
la teoria della democrazia parta dal presupposto contrario, e presuma, ai
fini del governare, l’esistenza di un numero illimitato di individui
autosufficienti.
Le persone da cui dipendiamo per i nostri contatti con il mondo esterno
sono quelle che sembrano dirigerlo2. Può darsi che dirigano solo una
piccolissima parte del mondo. La balia nutre il bambino, gli fa il bagno e
lo mette a letto, ma questo non fa della balia un’autorità nel campo della
fisica, della zoologia e dell’alta critica. Il signor Smith dirige o almeno
ingaggia la persona che dirige lo stabilimento, ma questo non lo rende
un’autorità in fatto di Costituzione degli Stati Uniti, né in materia di effetti
della tariffa doganale Fordney. Il signor Smoot dirige il partito
repubblicano nello stato dello Utah. Ciò di per sé non dimostra che sia
l’uomo più indicato per dare pareri in materia d’imposizione fiscale. Ma la
balia può nondimeno determinare per qualche tempo la zoologia che il
bambino imparerà, il signor Smith avrà molto da dire su ciò che la
Costituzione significa per sua moglie, per la sua segretaria e forse anche
per il suo parroco; e chi definirà i limiti dell’autorità del senatore Smoot?
Il prete, il signore feudale, i capitani e i re, i capi dei partiti, il mercante,
il padrone, comunque vengono scelti, per nascita, per eredità, per
conquista o per elezione: sono loro e il loro seguito organizzato che
amministrano gli affari umani. Sono loro gli ufficiali, e benché lo stesso
uomo possa essere generale a casa, sottotenente in ufficio, e soldato
semplice in politica, benché in molte istituzioni la gerarchia di rango sia
vaga o occulta, tuttavia in ogni istituzione che richiede la collaborazione di
molte persone esiste una tale gerarchia3. Nella politica americana la
chiamiamo macchina, oppure «l’organizzazione».
3.
Ci sono varie importanti distinzioni tra i membri della macchina e la
base. I capi, il comitato direttivo e la cerchia degli intimi sono in contatto
diretto con il loro ambiente. Naturalmente possono avere una nozione
molto limitata di ciò che dovrebbero definire l’ambiente, ma non sono
persone che trattino quasi esclusivamente di astrazioni. Ci sono persone
174
precise che sperano di vedere elette, situazioni precise che desiderano
vedere migliorate, obiettivi concreti che debbono venire raggiunti. Non
voglio dire che sfuggono alla propensione umana alla visione stereotipica.
Gli stereotipi spesso li rendono assurdamente abitudinari. Ma i capi,
nonostante i loro limiti, sono in reale contatto con qualche parte
fondamentale di questo mondo più vero. Sono loro che decidono. Sono
loro che danno ordini. Sono loro che contrattano. E qualcosa di preciso –
forse nulla di quello che immaginavano – accade davvero.
I loro subordinati non sono vincolati a loro da una convinzione
comune. Vale a dire, i membri minori di una macchina non dimostrano la
loro fedeltà secondo un autonomo giudizio circa la saggezza dei capi.
Nella gerarchia ciascuno dipende da un superiore ed è a sua volta superiore
a una qualche categoria di dipendenti. Ciò che tiene insieme la macchina è
un sistema di privilegi. Essi possono variare a seconda delle occasioni e
dei gusti di coloro che li cercano, in relazione al nepotismo e al
favoritismo in tutti i loro aspetti, allo spirito di corpo, al culto della
personalità o all’idea fissa. Variano in base al grado militare negli eserciti,
alla terra e ai servizi in un sistema feudale, agli incarichi e alla notorietà
nella moderna democrazia. Ecco perché si può spezzare una determinata
macchina abolendone i privilegi, ma la macchina, credo, deve per forza
riformarsi in ogni gruppo unito. Infatti il privilegio è assolutamente
relativo, e l’uniformità è impossibile. Si immagini il più assoluto
comunismo di cui la mente sia capace, in cui nessuno possieda un oggetto
che non possiedano anche tutti gli altri; e tuttavia, se il gruppo comunista
dovesse prendere una qualsiasi iniziativa, il semplice piacere di essere
l’unico di colui che sta per fare il discorso che assicurerà il maggior
numero di voti, sarebbe sufficiente, a mio avviso, a cristallizzargli intorno
un’organizzazione di iniziati.
Non è necessario, perciò, inventare un’intelligenza collettiva per
spiegare come mai i giudizi di un gruppo siano di solito più coerenti e
logici dei commenti dell’uomo della strada. Una sola mente, o poche
menti, possono svolgere una linea di pensiero, ma un gruppo che cerchi di
pensare insieme può, come gruppo, fare poco più che assentire o
dissentire. I membri di una gerarchia possono avere una tradizione
corporativa. Quando sono apprendisti imparano il mestiere dai maestri, che
a loro volta lo hanno imparato quando apprendisti. E in ogni società stabile
il ricambio del personale entro le gerarchie che governano è abbastanza
lento da permettere la trasmissione di certi grandi stereotipi e modelli di
comportamento. Certi modi di vedere e di fare vengono insegnati dal padre
al figlio, dal prelato al novizio, dal veterano al cadetto. Questi modi
175
diventano familiari e sono riconosciuti come tali dalla massa degli
estranei.
4.
Solo la distanza conferisce un fascino all’opinione che in una questione
complessa possano collaborare masse di persone senza una macchina
centrale manovrata da pochissimi individui. «Nessuno – dice Bryce1 – che
abbia fatto un’esperienza durata qualche anno del modo in cui opera
un’assemblea legiferante, o un’amministrazione, può avere mancato di
osservare come sia estremamente piccolo il numero di persone da cui è
governato il mondo». Si riferisce, naturalmente, agli affari di stato.
Ovviamente, se si considerano tutti gli affari umani, il numero delle
persone che governano è notevole, ma se si prende un’istituzione qualsiasi,
sia essa un corpo legislativo, o un partito, o un sindacato, o un movimento
nazionalista, o una fabbrica o un club, il numero di quelli che governano è
una percentuale piccolissima di coloro che in teoria dovrebbero governare.
Un trionfo elettorale può espellere una macchina e sostituirla con
un’altra; le rivoluzioni talvolta aboliscono del tutto una specifica
macchina. La rivoluzione democratica ha instaurato due macchine alterne,
ciascuna delle quali nel corso di alcuni anni raccoglie il vantaggio
derivante dagli errori dell’altra. Mai però la macchina scompare. In
nessuno caso la teoria idillica della democrazia si realizza. Certamente non
nei sindacati, non nei partiti socialisti, non nei governi comunisti. C’è una
cerchia di iniziati, circondata da circoli concentrici che sfumano
gradatamente nella base, la quale non si interessa o non viene
cointeressata.
I democratici non hanno mai voluto fare i conti con questo luogo
comune della vita di gruppo. L’hanno invariabilmente considerato un’idea
perversa. Infatti vi sono due visioni della democrazia: la prima presuppone
l’individuo autosufficiente; l’altra una Superanima che regola tutto. Delle
due la Superanima ha qualche vantaggio, perché almeno riconosce che la
massa prende delle decisioni che non nascono spontaneamente nel seno di
ciascun membro. Ma se concentriamo la nostra attenzione sulla macchina,
la Superanima, come genio che presiede a un comportamento collettivo, è
un mistero superfluo. La macchina è una realtà assolutamente prosaica. Si
compone di esseri umani che vestono panni e abitano in case, che possono
essere nominati e descritti. Sono loro che svolgono tutti i compiti di solito
attribuiti alla Superanima.
176
5.
La ragione d’essere della macchina non è la perversità della natura
umana. È che nessuna idea emerge di per sé dagli orientamenti personali di
un gruppo. Infatti il numero dei modi in cui una moltitudine di persone può
agire direttamente su una situazione, che sta al di là del loro controllo, è
limitato. Alcuni di loro possono trasmigrare, in una forma o nell’altra,
possono scioperare o fare il boicottaggio, possono applaudire o fischiare.
Con questi mezzi possono occasionalmente opporsi a quello che non gli
piace, o fare pressioni su quelli che ostacolano i loro desideri. Ma in realtà
nulla può essere costruito, escogitato, negoziato o amministrato mediante
l’azione di massa. Un pubblico in quanto tale, senza una gerarchia
organizzata intorno alla quale raggrupparsi, può rifiutarsi di comperare se i
prezzi sono troppo alti, o rifiutarsi di lavorare se i salari sono troppo bassi.
In uno sciopero un sindacato può, con l’azione di massa, spezzare
l’opposizione, sicché i funzionari sindacali possono negoziare un accordo.
Può conquistare, ad esempio, il diritto al controllo misto. Ma non può
esercitare questo diritto se non attraverso un’organizzazione. Una nazione
può invocare la guerra, ma quando va in guerra deve mettersi agli ordini di
un comando generale.
Il limite dell’azione diretta è, a tutti i fini pratici, il potere di dire Sì o
No di fronte a una questione presentata alla massa1. Infatti solo nei casi più
elementari una questione si presenta nella medesima forma
spontaneamente e approssimativamente, e nello stesso momento, a tutti i
componenti un pubblico. Ci sono scioperi e boicottaggi non organizzati, e
non soltanto industriali, in cui la rivendicazione è così semplice che
praticamente anche senza una guida la medesima reazione si manifesta in
molte persone. Ma anche in questi casi elementari ci sono persone che
capiscono quello che vogliono fare più rapidamente delle altre, e che
diventano capi improvvisati. Dove non compaiono, la folla si assieperà
senza scopo, sospinta da tutte le varie mire personali, o sosterà
fatalisticamente, come ha fatto l’altro giorno una folla di cinquanta
persone, a guardare uno che si sta suicidando.
Infatti ciò che noi ricaviamo dalla maggior parte delle impressioni che
ci arrivano dal mondo invisibile è una specie di pantomima rappresentata
come in sogno. Sono pochissime le volte che prendiamo consapevolmente
una decisione riguardante avvenimenti che stanno al di là della nostra
visuale, e ognuno di noi ha scarso senso di ciò che potrebbe realizzare se
tentasse. Raramente si presenta una questione pratica, e perciò si è poco
abituati alla decisione. Ciò sarebbe più evidente se la maggior parte delle
177
notizie non arrivasse a noi già con un’aura di suggestione sul modo in cui
dovremmo accoglierle. Abbiamo bisogno di questa suggestione, e se non
la troviamo nelle notizie, ci rivolgiamo agli editoriali o a un consigliere
fidato. La fantasticheria, se ci sentiamo implicati, è scomoda fintantoché
non sappiamo in che posizione stiamo, ossia fintantoché i fatti non siano
stati formulati in modo da consentirci di pensare un Sì o un No nei loro
confronti.
Quando varie persone dicono tutte Sì, possono avere le ragioni più
diverse per dirlo. E generalmente le hanno. Infatti le immagini che sono
nelle loro menti variano, come abbiamo già notato, nei modi più sottili e
intimi. Ma questa sottigliezza resta all’interno delle loro menti;
pubblicamente viene a essere rappresentata da varie frasi simboliche, che
esprimono il sentimento individuale dopo aver eliminato la maggior parte
dell’intenzione. La gerarchia, o, se c’è concorrenza, le due gerarchie,
associano i simboli a un’azione precisa, a un voto che si esprime in un Sì o
in un No, a un atteggiamento pro o contro. Quindi Smith, che era contrario
alla Società delle Nazioni, e Jones, che era contrario all’articolo dieci, e
Brown, che era contrario a Wilson e a tutta la sua opera, ciascuno per un
suo motivo, tutti in nome di una frase simbolica che è più o meno la stessa,
danno un voto contro i democratici votando per i repubblicani. È stata
espressa una volontà comune.
Si doveva presentare una scelta concreta e la scelta doveva venire
collegata, trasferendo l’interesse attraverso i simboli, all’opinione
individuale. I politici professionisti lo hanno appreso molto tempo prima
dei filosofi democratici e così hanno organizzato quel comitato ristretto
che viene chiamato caucus – l’assemblea per la designazione del candidato
– e quell’organo che si chiama comitato direttivo, come mezzi per la
formulazione di una scelta precisa. Tutti quelli che vogliono realizzare
qualcosa che richieda la collaborazione di un gran numero di persone
seguono il loro esempio. Talvolta la cosa avviene piuttosto brutalmente,
come quando la Conferenza della pace si ridusse al Consiglio dei Dieci, e
il Consiglio dei Dieci ai Tre o a Quattro Grandi; e redassero un trattato che
gli alleati minori, i loro elettori e il nemico potevano soltanto prendere o
lasciare. Di solito è possibile e opportuna una consultazione maggiore di
quella che si è avuta in questo caso. Resta il fatto essenziale che un piccolo
numero di cervelli presenta una scelta a un vasto gruppo.
6.
Gli abusi del comitato direttivo hanno portato a proposte come quelle
178
per l’iniziativa popolare, il referendum e l’elezione primaria diretta. Ma
queste proposte hanno semplicemente rimandato o oscurato la necessità
della macchina, complicando le elezioni ovvero, come disse una volta H.
G. Wells con scrupolosa precisione, le selezioni. Infatti non è con il
numero delle votazioni che si può ovviare alla necessità di creare una
questione – si tratti di un provvedimento o di un candidato – sulla quale i
votanti possano dire Sì o No. Non esiste, in realtà, il «legiferare» diretto. E
infatti, che cosa accade quando si suppone che esista? Il cittadino va alle
urne, riceve una scheda su cui sono stampati vari provvedimenti, quasi
sempre in forma abbreviata, e se esprime il suo voto, lo esprime dicendo Sì
o No. Può venirgli in mente il più brillante emendamento del mondo, ma
egli vota Sì o No su quel progetto di legge, e nient’altro. Si deve far
violenza alla lingua inglese per chiamare ciò «legiferare». Non sostengo,
naturalmente, che non presenti dei vantaggi, comunque si voglia chiamare
il processo. Ritengo che per certi problemi presenti anzi dei precisi
vantaggi, ma la necessaria semplicità di una decisione di massa è un fatto
importantissimo, data l’inevitabile complessità del mondo in cui operano
queste decisioni. La forma più complicata di votazione che sia stata
proposta è, ritengo, la scheda con le preferenze. Tra vari candidati
presentati al votante, questo sistema richiede, non di dire Sì a un candidato
e No a tutti gli altri, bensì di dichiarare l’ordine di priorità della propria
scelta. Ma anche in questo caso l’azione della massa, pur essendo
enormemente più elastica, dipende dalla qualità delle scelte offerte1. E
queste scelte vengono offerte dalle vigorose cricche che corrono in giro
con ordini del giorno, e che raggruppano i delegati. I Molti possono
eleggere dopo che i Pochi hanno designato.
179
XV.
I capi e i seguaci
1.
Data la loro importanza pratica decisiva, i capi affermati hanno sempre
trovato il tempo per coltivare i simboli che organizzano il loro seguito. I
simboli costituiscono per la base quello che i privilegi sono per la
gerarchia: mantengono l’unità. Dal palo totemico alla bandiera nazionale,
dall’idolo ligneo a Iddio il Re Invisibile, dalla parola magica a qualche
versione annacquata di Adam Smith o di Bentham, i simboli sono stati
tenuti cari dai capi – che spesso non ci credevano affatto – perché erano
punti focali in cui scomparivano le differenze. L’osservatore distaccato
può disprezzare il rituale «stellato» che circonda il simbolo, forse proprio
come il re che diceva a se stesso che Parigi valeva bene una messa. Ma il
capo sa per esperienza che solo quando i simboli hanno fatto la loro opera
egli ha uno strumento con cui muovere la folla. Nel simbolo l’emozione
viene scaricata sul bersaglio comune, e le peculiarità delle idee concrete
vengono cancellate. Non sorprende che egli detesti ciò che chiama critica
distruttiva, chiamata talvolta dagli spiriti liberi l’eliminazione delle parole
vuote. «Soprattutto – dice Bagehot – i nostri reali devono essere riveriti, e
se si comincia a curiosarci intorno non si riesce a considerarli con
riverenza»1. Infatti il curiosarci intorno, cercando definizioni precise e
dichiarazioni franche, è utile a tutti i fini più alti noti all’uomo, tranne
all’agevole conservazione di una volontà comune. Il curiosare, come tutti i
capi responsabili subodorano, tende a impedire il trasferimento
dell’emozione dalla mente del singolo al simbolo istituzionale. E il primo
risultato di ciò è, come essi dicono giustamente, il caos dell’individualismo
e delle fazioni in lotta. La disintegrazione di un simbolo come la Santa
Russia o il Ferreo Diaz, è sempre l’inizio di un lungo sconvolgimento.
Questi grandi simboli possiedono per trasferimento tutte le minute e
dettagliate fedeltà di una società antica e stereotipata. Suscitano il
sentimento che ciascun individuo prova per il paesaggio, per il mobilio, i
volti, le memorie che sono la sua prima e, in una società statica, la sua sola
realtà. Questo nucleo di immagini e di devozione, senza le quali egli non
riesce a immaginare se stesso, è la nazionalità. I grandi simboli raccolgono
180
queste devozioni, e possono suscitarle senza richiamare le immagini
originarie. I simboli minori della vita pubblica, la più occasionale
conversazione sulla politica, si riallacciano sempre a questi protosimboli, e
quand’è possibile vi alludono esplicitamente. La questione della giusta
tariffa di una metropolitana municipale viene rappresentata come un
conflitto tra il Popolo e gli Interessi, e quindi il Popolo viene inserito nel
simbolo Americano, sicché alla fine, nel calore della campagna elettorale,
una tariffa di otto cents diventa anti-Americana. I padri della Rivoluzione
morirono per impedirla, Lincoln soffrì perché non venisse approvata,
l’opposizione ad essa era implicita nella morte di coloro che riposano nei
cimiteri francesi.
Il simbolo, col suo potere di risucchiare l’emozione dalle idee precise, è
tanto un meccanismo di solidarietà quanto un meccanismo di sfruttamento.
Consente alle persone di operare per un fine comune, ma proprio perché i
pochi che stanno in posizione strategica debbono scegliere gli obiettivi
concreti, il simbolo è anche uno strumento mediante il quale i pochi
possono ingrassarsi a spese dei molti, deviare le critiche e persuadere gli
individui ad affrontare sofferenze per scopi che non comprendono.
Molti aspetti della nostra sottomissione ai simboli non sono affatto
lusinghieri, se vogliamo immaginarci come personalità realiste,
autosufficienti ed autonome. Eppure è impossibile arrivare alla
conclusione che i simboli siano totalmente strumenti del demonio. Nel
regno della scienza e della contemplazione essi sono indubbiamente il
Maligno in persona, ma nel mondo dell’azione possono essere benefici, e
talvolta sono una necessità. La necessità spesso è immaginata, il pericolo è
fabbricato; ma quando servono a risultati immediati, la manipolazione
delle masse attraverso i simboli può essere il solo mezzo rapido per
realizzare una cosa d’importanza cruciale. Spesso è più importante agire
che capire. Talvolta è vero che l’azione fallirebbe se tutti la capissero. Ci
sono molte faccende che non possono aspettare un referendum, o reggere
alla pubblicità, e ci sono tempi, durante la guerra ad esempio in cui una
nazione, un esercito, ed anche i suoi comandanti debbono affidare la
strategia a pochissimi cervelli; in cui due opinioni in conflitto, quantunque
una delle due sia giusta, sono più pericolose di un’opinione sola sbagliata.
L’opinione sbagliata può avere cattivi risultati, ma le due opinioni possono
portare al disastro distruggendo l’unità2.
E così Foch e Sir Henry Wilson, che previdero il disastro incombente
sull’armata di Gough come conseguenza della divisione e dispersione delle
riserve, tennero nondimeno le loro opinioni entro un circolo molto
ristretto, sapendo che persino il rischio di una grossa sconfitta era
181
certamente meno distruttivo di un’agitata discussione sui giornali. Infatti
ciò che conta nei momenti di tensione, come quello che si ebbe nel marzo
1918, è meno la giustezza di una particolare mossa che la sicurezza circa la
continuità del comando. Se Foch fosse «andato al popolo», avrebbe potuto
vincere la disputa; ma assai prima di poterla vincere, le armate che doveva
comandare si sarebbero dissolte. Infatti lo spettacolo di una lite
sull’Olimpo è distraente e distruttivo.
Ma lo è anche una congiura del silenzio. Dice il capitano Wright:
È nell’alto comando, e non in linea, che l’arte della mimetizzazione è praticata di
più, e raggiunge le massime altezze. Ovunque i capi vengono ora dipinti dallo
zelante lavoro di innumerevoli pubblicisti, sì da poter essere scambiati per
Napoleoni: alla lunga […] diventa quasi impossibile spostare questi Napoleoni, per
grande che sia la loro incompetenza, a causa dell’enorme seguito pubblico creato
nascondendo o attenuando gli insuccessi, ed esagerando o inventando i successi […]
ma il peggiore e più insidioso effetto di questa falsità così bene organizzata lo
subiscono gli stessi generali: modesti e patrioti come perlopiù sono, e come
generalmente si deve essere per scegliere e seguire la nobile professione delle armi,
essi stessi vengono alla fine suggestionati da queste illusioni universali, e
leggendole ogni mattina sui giornali, si persuadono di essere fulmini di guerra e
infallibili, anche se falliscono, e che la loro permanenza al comando è un fine così
sacro da giustificare l’uso di qualsiasi mezzo […] queste varie condizioni, che
raggiungono il massimo in questo grande inganno, alla fine liberano tutti i comandi
generali da qualsiasi controllo. Non vivono più per la nazione: la nazione vive, o
piuttosto muore, per loro. La vittoria o la sconfitta cessano di essere l’interesse
primario. Ciò che importa a queste corporazioni semisovrane è se alla loro testa ci
sarà il caro vecchio Willy o il povero vecchio Harry, o se il partito di Chantilly
prevarrà sul partito del Boulevard des Invalides3.
Tuttavia il capitano Wright, che riesce a essere così eloquente e così
acuto a proposito dei pericoli del silenzio, è costretto nondimeno ad
approvare il silenzio tenuto da Foch per non distruggere pubblicamente le
illusioni. C’è qui un complicato paradosso, derivante, come vedremo
meglio in seguito, dal fatto che la visione democratica tradizionale della
vita è concepita non per i momenti di emergenza e di pericolo, ma per
quelli di tranquillità e di armonia. E così quando masse di persone
debbono collaborare in un ambiente incerto e sconvolto, di solito è
necessario assicurare unità ed elasticità senza un vero consenso. E questo
lo fa il simbolo. Esso oscura l’intento personale, neutralizza la capacità di
distinguere e offusca le mete individuali. Immobilizza la personalità, ma
nello stesso tempo rafforza enormemente l’intenzione del gruppo e
impegna il gruppo stesso, come in una crisi nessun’altra cosa riesce a
impegnarlo, all’azione risoluta. Pur immobilizzando la personalità, rende
182
mobile la massa. Il simbolo è lo strumento mediante il quale per un breve
periodo di tempo la massa sfugge alla propria inerzia, l’inerzia
dell’indecisione o l’inerzia del movimento precipitoso, e viene resa capace
di essere guidata lungo i tornanti di una situazione complicata.
2.
A lungo andare però tra i capi e i seguaci s’impone la necessità di
reciproche concessioni. Il termine più spesso adoperato per definire lo
stato d’animo della truppa verso i suoi capi è «il morale». Si dice che è
buono quando gli individui svolgono la parte loro assegnata con tutta la
loro energia; quando tutte le forze di ciascun individuo vengono suscitate
dagli ordini impartiti dall’alto. Ne segue che ogni capo deve tener conto di
ciò quando pianifica la sua politica. Deve considerare la sua decisione non
solo «nel merito», ma anche nei suoi effetti sulla parte del seguito del cui
appoggio continuativo ha bisogno. Se è un generale che fa il piano di un
attacco, egli sa che i suoi reparti militari organizzati, qualora la percentuale
delle perdite diventasse troppo alta, si disgregherebbero in folle
disordinate.
Nella grande guerra i calcoli preventivi vennero sconvolti in misura
straordinaria, poiché «ogni nove uomini che andarono in Francia, cinque
caddero sul campo»1. Il limite della resistenza fu molto maggiore di quello
che si fosse immaginato, ma ci doveva pur essere un limite. E così, in parte
per l’effetto sul nemico, ma in gran misura per l’effetto sulle truppe e sulle
famiglie, in questa guerra nessun comando ha osato pubblicare un franco
resoconto delle sue perdite. In Francia gli elenchi dei caduti non sono mai
stati pubblicati, in Inghilterra, in America e in Germania la pubblicazione
delle perdite subite nelle grandi battaglie è stata diluita in lunghi periodi di
tempo per impedire un’impressione globale del totale. Per molto tempo
solo gli iniziati seppero quant’era costata la Somme, o la battaglia delle
Fiandre2, e indubbiamente Ludendorff aveva di queste perdite un’idea
molto più precisa di quanto potesse avere un qualsiasi cittadino di Londra,
Parigi o Chicago. Tutti i capi dell’uno e dell’altro campo fecero del loro
meglio per limitare la quantità di guerra che il singolo soldato o il singolo
civile riuscissero a concepire con chiarezza. Ma naturalmente i vecchi
veterani, come le truppe francesi del 1917, sanno della guerra assai di più
di quanto arrivi mai a saperne il pubblico. Un tale esercito comincia a
giudicare i suoi comandanti dalle proprie sofferenze. E quindi, quando
un’altra stravagante promessa di vittoria si dimostra la solita sconfitta
sanguinosa, si può scoprire che un ammutinamento è scoppiato in seguito a
183
un errore relativamente minore3, come l’offensiva di Nivelle del 1917,
perché è un errore che viene ad accumularsi ad altri. In genere le
rivoluzioni e gli ammutinamenti scoppiano in seguito a un piccolo
campione di una grossa serie di mali4.
Il raggio di azione di una politica determina il rapporto tra capo e
seguaci. Se coloro di cui ha bisogno per il suo piano sono lontani dal luogo
in cui avviene l’azione, se i risultati vengono celati o rimandati, se
l’impegno dei singoli è indiretto o non immediatamente richiesto, e
soprattutto se il consenso implica un’emozione piacevole, il capo
probabilmente avrà mano libera. I programmi che hanno immediatamente
successo sono quelli, come il proibizionismo tra gli astemi, che non
incidono subito nelle abitudini personali dei seguaci. E qui sta una delle
grandi ragioni per cui i governi hanno mano libera in politica estera. La
maggior parte degli attriti fra due stati s’imperniano su una serie di contese
oscure e prolisse, di quando in quando sulle frontiere, ma assai più spesso
su regioni delle quali le geografie scolastiche non hanno fornito alcuna
idea precisa. In Cecoslovacchia l’America è considerata il Liberatore; nei
giornali e nelle commedie musicali americane, e nella conversazione
americana in generale, non è mai stato deciso del tutto se il paese che
abbiamo liberato è la Cecoslavia o la Jugoslovacchia.
Negli affari internazionali l’incidenza della politica si limita per
lunghissimi periodi di tempo a un mondo che non si vede. Nulla di quello
che vi accade è avvertito come del tutto reale. E così, dato che nel periodo
prebellico nessuno deve combattere e nessuno deve pagare, i governi
tirano avanti secondo i loro umori, senza tener molto conto del loro
popolo. Negli affari locali il costo di una politica è più chiaramente
visibile. E perciò tutti i capi, fuorché quelli davvero eccezionali,
preferiscono politiche in cui i costi siano per quanto possibile indiretti.
Non amano la tassazione diretta. Non amano il pagamento alla consegna.
Prediligono i debiti a lungo termine. Amano far credere all’elettore che
pagherà lo straniero. Sono sempre stati costretti a calcolare la prosperità
dal punto di vista del produttore, piuttosto che da quello del consumatore,
perché il peso che ricade sul consumatore è distribuito su moltissime
piccole voci. I capi sindacali hanno sempre preferito un aumento dei salari
monetari a una diminuzione dei prezzi. La gente si è sempre molto più
interessata dei profitti dei milionari, che sono visibili ma relativamente
privi di importanza, che degli sprechi del sistema industriale, che sono
enormi ma sfuggenti. Un’assemblea legislativa che affronti una situazione
di penuria degli alloggi, come quella esistente nel momento in cui queste
pagine vengono scritte, conferma questa regola, in primo luogo non
184
facendo nulla per aumentare il numero degli alloggi, in secondo luogo
tagliando le gambe al rapace proprietario, in terzo luogo investigando sui
costruttori che hanno realizzato guadagni illeciti e sui lavoratori. Infatti
una politica costruttiva affronta questioni remote e non interessanti, mentre
un proprietario rapace o un idraulico profittatore sono visibili e immediati.
Ma mentre la gente facilmente crederà che in un futuro imprecisato e in
luoghi invisibili una certa politica le recherà dei vantaggi, il concreto
svolgersi di una politica segue una logica diversa da quella che
s’immagina. Una nazione può essere indotta a credere che l’aumento delle
tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci farà prospere le ferrovie. Ma
questa convinzione non farà prospere le ferrovie, se il peso di queste tariffe
sugli agricoltori e sugli spedizionieri è tale da provocare un prezzo del
prodotto superiore alla capacità d’acquisto del consumatore. La decisione
del consumatore di pagare o meno questo prezzo dipende non dal fatto di
aver annuito nove mesi prima alla proposta di elevare le tariffe per salvare
l’economia, ma dal fatto se ora desidera un cappello nuovo o
un’automobile nuova a tal punto da essere disposto a pagarli di più.
3.
I capi spesso fingono di avere semplicemente scoperto un programma
che esisteva già nelle teste del loro pubblico. Quando lo credono, di solito
s’ingannano. I programmi non nascono contemporaneamente in una
moltitudine di cervelli. E questo non perché una moltitudine di cervelli
siano necessariamente inferiori a quelli dei capi, ma perché il pensiero è la
funzione di un organismo, e una massa non è un organismo.
Questa realtà non appare chiaramente perché la massa è costantemente
esposta a suggestioni. Non legge le notizie, bensì le notizie avvolte in
un’aura di suggestione, indicante la linea d’azione da prendere. Ascolta
resoconti non oggettivi come sono i fatti, ma già stereotipati secondo un
certo modello di comportamento. Così il capo apparente scopre spesso che
il capo reale è un potente proprietario di giornali. Ma se, come in un
laboratorio, si potessero eliminare tutte le suggestioni e le influenze
dall’esperienza di una moltitudine, si scoprirebbe, credo, qualcosa di
questo genere: una massa esposta agli stessi stimoli manifesterebbe
reazioni che in teoria potrebbero essere rappresentate in un poligono di
errori. Vi sarebbe un certo gruppo che manifesterebbe una reazione
abbastanza omogenea per poter essere classificato insieme. Vi sarebbero
varianti di reazione alle due estremità. Queste classificazioni tenderebbero
a cristallizzarsi a mano mano che gli individui entro ciascuna categoria
185
dessero voce alle loro reazioni. Vale a dire, quando le vaghe emozioni di
coloro che abbiamo sentito in modo vago fossero state messe in parole,
essi comprenderebbero in modo più preciso ciò che hanno sentito e allora
lo sentirebbero più precisamente.
I capi che si mantengono a contatto con l’umore popolare si rendono
rapidamente conto di queste reazioni. Sanno che i prezzi elevati fanno
pressione sulla massa, o che certe categorie di individui stanno diventando
impopolari, o che il sentimento verso un’altra nazione è amichevole o
ostile. Ma, sempre prescindendo dagli effetti della suggestione la quale è
nient’altro che l’assunzione di una funzione di guida da parte del cronista,
nel sentimento della massa non ci sarebbero elementi atti a determinare
fatalmente la scelta di una politica piuttosto che di un’altra. Tutto ciò che il
sentimento della massa pretende è che la politica elaborata ed esposta si
riallacci, se non logicamente, per analogia e associazione, al sentimento
originario.
Così, quando si deve lanciare una nuova politica, si comincia con un
appello preliminare alla comunione dei sentimenti, come nel discorso di
Marc’Antonio ai seguaci di Bruto1. Nella prima fase, il capo dà voce alle
opinioni prevalenti nella massa. Si identifica con gli atteggiamenti comuni
del suo pubblico, talvolta raccontando una barzelletta efficace, talvolta
sbandierando il suo patriottismo, spesso toccando una rivendicazione.
Stabilito che ci si può fidare di lui, la moltitudine che stava vagando qua e
là può incanalarsi verso di lui. Ci si aspetterà allora che esponga un piano
d’azione, ma egli non troverà questo piano negli slogan che esprimono i
sentimenti della massa. Questi slogan spesso non lo indicheranno
nemmeno. Dove la politica incide molto alla lontana, quello che è
essenziale è che il programma all’inizio si riallacci verbalmente ed
emotivamente a quello a cui la moltitudine ha già dato voce. Gli uomini
che riscuotono fiducia svolgendo il loro ruolo riconosciuto possono,
sottoscrivendo i simboli accettati, fare molta strade per conto loro senza
spiegare la sostanza del loro programma.
Ma i capi avveduti non si accontentano di questo. Se capiscono che la
pubblicità non rafforzerà eccessivamente l’opposizione, e che la polemica
non rimanderà troppo a lungo l’azione, cercano di ottenere una certa
misura di consenso. Mettono a parte dei loro progetti, se non l’intera
massa, i subordinati della gerarchia, nella misura sufficiente a prepararli a
ciò che potrebbe succedere, e per dargli l’impressione di aver liberamente
voluto il risultato. Ma per quanto sincero possa essere il capo, quando i
fatti sono molto complicati c’è sempre in queste consultazioni una certa
dose di illusione. Infatti è impossibile che tutte le circostanze siano chiare
186
all’intero pubblico quanto lo sono ai più esperti e ai più dotati di intuito.
Una percentuale piuttosto grande di individui è destinata ad acconsentire
senza aver avuto il tempo, o senza avere la preparazione, per apprezzare le
scelte che il capo presenta loro. Nessuno, tuttavia, può pretendere di più. E
infatti solo i teorici lo pretendono. Se siamo stati per un momento alla
ribalta, se quello che avevamo da dire ha trovato udienza, e se poi ciò che
viene fatto in seguito riesce bene, la maggior parte di noi non si sofferma a
domandarsi in quale misura la nostra opinione abbia influito sulla
decisione in questione.
E perciò se i poteri costituiti sono sensibili e bene informati, se
manifestamente si sforzano di andare incontro al sentimento popolare, e
rimuovono effettivamente alcune delle cause di insoddisfazione, non
importa se procedono lentamente: purché sembri che procedono, hanno
ben poco da temere. Occorrono colossali e persistenti errori, e una
mancanza di tatto quasi infinita, per provocare una rivoluzione dal basso.
Le rivolte di palazzo, le congiure di gabinetto, sono una cosa diversa. E lo
è pure la demagogia. Questa si limita ad allentare la tensione esprimendo il
sentimento. Ma l’uomo di stato sa che questo sollievo è temporaneo e, se
ci si ricorre troppo spesso, poco sano. Perciò sta attento a non suscitare
sentimenti che non abbia modo di dirottare in un programma attinente ai
fatti a cui i sentimenti si riferiscono. Ma non tutti i capi sono uomini di
stato, nessun capo vuole dimettersi, e la maggior parte dei capi è riluttante
ad ammettere che le cose non andrebbero peggio di come vanno se ad
occuparsene fosse il loro oppositore. Non stanno passivamente ad aspettare
che il pubblico senta il peso della politica, perché a sua volta il peso di
questa scoperta pende in genere sulle loro teste. Perciò ogni tanto si
preoccupano di mettere a posto le loro difese e di consolidare la loro
posizione.
Il rafforzamento delle difese consiste nell’offrire un qualche capro
espiatorio, nel soddisfare qualche piccola rivendicazione di un individuo o
di una fazione potente, nel redistribuire certi incarichi, nel placare un
gruppo di persone che vogliono un arsenale nel loro paese, o una legge per
eliminare i vizi di qualcheduno. Si studi l’attività quotidiana di un qualsiasi
personaggio pubblico elettivo, e sarà facile allargare l’elenco. Ci sono
parlamentari, rieletti un anno dopo l’altro, che non si sognano mai di
sprecare le loro energie negli affari pubblici. Preferiscono fare un piccolo
favore a molta gente per molte piccole cose, piuttosto che impegnarsi a
cercare di fare un qualche grande servizio laggiù nel vuoto. Ma il numero
di persone alle quali un’organizzazione può fare vantaggiosamente dei
servizi è limitato, e i politici astuti stanno molto attenti a favorire sia la
187
persona influente, sia qualcuno che appaia così manifestamente privo di
influenza che l’occuparsi di lui diventi segno di sensazionale magnanimità.
La grande maggioranza che non può essere agganciata con favori, la
moltitudine anonima, riceve la propaganda.
In ogni organizzazione i capi indiscussi hanno grandi vantaggi naturali.
Si crede che abbiano migliori fonti di informazione. I libri e le carte stanno
nei loro uffici. Hanno preso parte alle riunioni importanti. Hanno
conosciuto le persone importanti. Hanno responsabilità. Perciò a loro è più
facile assicurarsi l’attenzione e parlare in tono convincente. Ma hanno
anche un forte controllo sull’accesso ai fatti. Ogni pubblico ufficiale è in
qualche misura un censore. E siccome nessuno può sopprimere le notizie,
nascondendole o dimenticando di citarle, senza un’idea di quello che
desidera far sapere al pubblico, ogni capo è in qualche misura un
propagandista. Trovandosi in una posizione strategica, costretto spesso a
scegliere nel migliore dei casi tra gli ideali egualmente potenti, sebbene in
conflitto, della sicurezza dell’istituzione e della franchezza verso il suo
uditorio, il pubblico ufficiale si troverà a decidere sempre più
consapevolmente quali fatti, con quale contorno, in quale guisa, permetterà
al pubblico di conoscere.
4.
Nessuno negherà, credo, che la fabbricazione del consenso è
suscettibile di grandi raffinatezze. Il processo attraverso il quale si
formano le opinioni pubbliche è certamente non meno intricato di quanto
sia apparso in queste pagine, e le possibilità di manipolazione, che si
offrono a tutti coloro che comprendono questo processo, sono abbastanza
evidenti.
La creazione del consenso non è un’arte nuova. È un’arte vecchissima,
che era stata data per morta quando apparve la democrazia, ma non è
morta. In realtà ne è stata migliorata enormemente la tecnica, perché ora si
fonda sull’analisi piuttosto che sulla pratica. E così, per effetto della
ricerca psicologica abbinata ai moderni mezzi di comunicazione, la prassi
democratica ha fatto una svolta. Sta avvenendo una rivoluzione,
infinitamente più significativa di qualsiasi spostamento di potere
economico.
Nel corso della vita della generazione che ora controlla il mondo, la
persuasione è diventata un’arte deliberata e un organo regolare del governo
popolare. Nessuno di noi è in grado di vederne tutte le conseguenze, ma
non è azzardato pensare che la conoscenza dei modi per creare il consenso
188
altererà tutti i calcoli politici e modificherà tutte le premesse politiche.
Sotto la pressione della propaganda, non necessariamente nella sola
accezione sinistra della parola, le vecchie costanti del nostro pensiero sono
diventate variabili. Non è più possibile, ad esempio, credere nel dogma
originario della democrazia: cioè che le conoscenze necessarie alla
condotta degli affari umani sorgano spontaneamente dal cuore umano.
Quando operiamo sulla base di questa teoria, ci esponiamo
all’autoinganno, e a forme di persuasione che non siamo in grado di
verificare. È stato dimostrato che se vogliamo affrontare il mondo che sta
al di là della nostra immediata sfera personale, non possiamo affidarci
all’intuizione, alla coscienza o agli accidenti dell’opinione casuale.
«New York Times», 20 maggio 1921.
1 Pronunciato alla Carnegie Hall di New York il 31 luglio 1916.
1 Nel suo colloquio con i senatori il presidente Wilson dichiarò di non avere mai
sentito parlare di questi trattati prima di arrivare a Parigi. Questa dichiarazione è
sconcertante. I Quattordici Punti, come il testo dimostra, non avrebbero potuto essere
formulati senza la conoscenza dei trattati segreti. La sostanza di questi trattati era nota al
presidente quando questi e il colonnello House prepararono il testo definitivo dei
Quattordici Punti.
1 L’interpretazione americana dei Quattordici Punti venne spiegata agli statisti alleati
appena prima dell’armistizio.
1 T. Jefferson, Works, IX, p. 87. Citato in C. A. Beard, Economic Origins of
Jeffersonian Democracy, Macmillan, New York 1915, p. 173.
1 Si veda un vecchio libro interessante e piuttosto curioso: G. C. Lewis, An Essay on
the Influence of Authority in Matters of Opinion, J. W. Parker, London 1849.
2 Cfr. Bryce, Modern Democracies cit., II, pp. 544-5.
3 Cfr. M. Ostrogorsky, Democracy and the Organization of Politicai Parties,
Macmillan, New York 1908, passim; R. Michels, La sociologia del partito politico
(1911), il Mulino, Bologna 1966; e Bryce, Modern Democracies cit., soprattutto il cap.
LXXV; e anche E. A. Ross, The Principles of Sociology, The Century Co., New York
1920, capp. XXII-XXIV.
1 Bryce, Modern Democracies cit., II, p. 542.
1 Cfr. James, Some Problems of Philosophy cit., p. 227. «Ma per la maggior parte
delle nostre situazioni di crisi le soluzioni frammentarie sono impossibili. Solo di rado
possiamo agire frammentariamente». Cfr. A. L. Lowell, Public Opinion and Popular
Government, Longmans, Green and Co., New York 1913, pp. 91-2.
1 Cfr. H. J. Laski, Foundations of Sovereignty, and Other Essays, Harcourt, Brace
and Co., New York 1920, p. 224: «La rappresentanza proporzionale […] portando,
come sembra portare, al sistema di gruppo […] può privare gli elettori della possibilità
di scegliere i capi che preferiscono». Il sistema di gruppo tende indubbiamente, come
dice Laski, a rendere più indiretta la selezione dei dirigenti, ma non c’è dubbio che
tende anche a produrre delle assemblee legislative in cui le correnti di opinione sono
rappresentate in modo più aderente. Non si può stabilire a priori se ciò sia un bene o un
1
189
male. Ma si può dire che per conseguire la collaborazione e la responsabilità in
un’assemblea, che sia più fedelmente rappresentativa, occorre un’organizzazione di
intelligenza politica e di costume politico migliore di quella necessaria in una Camera
rigidamente bipartitica. È una forma politica più complicata e perciò può funzionare
molto bene.
1 W. Bagehot, The English Constitution, D. Appleton & Co., 1914, p. 127; trad. it.
La costituzione inglese, il Mulino, Bologna 1995.
2 Vale la pena di leggere attentamente il libro del capitano Peter S.Wright,
vicesegretario del Consiglio supremo di guerra, At the Supreme War Council, G. P.
Putnam’s sons, New York-London 1921. Le pagine più interessanti sono quelle sulla
segretezza e l’unità di comando, anche se nei confronti dei capi alleati l’autore conduce
un’appassionata polemica.
3 Ibid., pp. 98, 101-5.
1 Ibid., p. 37. Il capitano Wright ha tratto queste cifre dal compendio statistico della
guerra esistente negli archivi del War Office. Le cifre si riferiscono apparentemente alle
sole perdite inglesi, forse alle perdite inglesi e francesi.
2 Ibid., p. 34. Nella battaglia della Somme le perdite ammontarono a 500 000 unità;
nelle offensive di Arras e delle Fiandre, del 1917, le perdite inglesi ammontarono a 650
000 unità.
3 Gli alleati hanno subito sconfitte molto più sanguinose di quella di Chemin des
Dames.
4 Cfr. il racconto di Pierrefeu, G.Q.G. Secteur 1 cit., I, parte III sgg., circa le cause
degli ammutinamenti di Soissons, e il metodo adottato da Pétain per affrontarli.
1 Analizzato eccellentemente da Martin, The Behaviour of Crowds cit., pp. 130-2.
190
VI.
L’immagine della democrazia
Confesso che in America ho visto più
dell’America; cercavo l’immagine stessa
della democrazia.
Alexis de Tocqueville
191
XVI.
L’uomo egocentrico
1.
Poiché si ritiene che nelle democrazie l’Opinione Pubblica sia il primo
motore, sarebbe ragionevole attendersi di trovare una vastissima letteratura
sull’argomento. Ma in realtà non esiste. Ci sono opere eccellenti sul
governo e sui partiti, ossia sui congegni che in teoria registrano le opinioni
pubbliche dopo che si sono formate. Ma sulle fonti da cui queste opinioni
pubbliche scaturiscono, o sui processi dai quali vengono derivate, c’è
relativamente poco. L’esistenza di una forza chiamata Opinione Pubblica è
di solito data per acquisita, e gli scrittori politici americani si sono
interessati soprattutto di scoprire il modo per far esprimere al governo la
volontà comune, o quello per impedire alla volontà comune di sovvertire i
fini per cui pensano che esista il governo. A seconda delle loro tradizioni,
hanno desiderato addomesticare l’opinione oppure obbedirla. Così il
curatore di una notevole serie di libri di testo scrive che «la questione più
difficile e più importante del governare [è] come trasferire la forza
dell’opinione individuale nell’azione pubblica»1.
Ma certamente c’è una questione ancora più importante: la questione di
come convalidare le nostre personali interpretazioni della vita politica.
C’è, come tenterò di dimostrare in seguito, la prospettiva di un radicale
miglioramento mediante uno sviluppo di principi già in atto. Ma questo
sviluppo dipenderà dalla nostra capacità di apprendere ad adoperare la
conoscenza del modo in cui le opinioni vengono costruite per sorvegliare
le nostre opinioni quando sono in costruzione. Infatti l’opinione comune,
essendo il prodotto di contatti parziali, di tradizioni e di interessi personali,
non può davvero accogliere volentieri un metodo di pensiero politico che
si fonda su documenti precisi, misurazioni, analisi e confronti. Proprio
quelle qualità della mente, che determinano che cosa apparirà interessante,
importante, familiare, personale e drammatico, sono le qualità che
l’opinione realistica frustra sin dall’inizio. Perciò, se nella collettività,
presa nel suo complesso, manca una crescente consapevolezza del fatto
che il pregiudizio e l’intuizione non sono sufficienti, l’elaborazione
dell’opinione realistica, che richiede tempo, denaro, fatica, sforzo
192
cosciente, pazienza ed equanimità, non troverà appoggi sufficienti. Questa
consapevolezza cresce a mano a mano che aumenta l’autocritica, e ci rende
coscienti delle parole vuote, ci fa disprezzare noi stessi quando le
impieghiamo, e ci fa stare all’erta per scoprirle. Senza un’inveterata
abitudine ad analizzare le opinioni quando leggiamo, parliamo e
decidiamo, la maggior parte di noi non sospetterebbe la necessità di idee
migliori, non se ne interesserebbe quando apparissero, e non riuscirebbe a
impedire che si manipolasse la nuova tecnica dell’informazione politica.
Tuttavia le democrazie, se dobbiamo giudicarle dagli esempi più vecchi
e più efficaci, hanno reso misteriosa l’opinione pubblica. Ci sono stati
organizzatori di opinione, capaci di intendere il mistero abbastanza bene
per riuscire a creare delle maggioranze al giorno dell’elezione. Ma questi
organizzatori sono stati considerati dalla scienza politica delle basse
creature, o dei «problemi», e non i possessori delle conoscenze più efficaci
sul modo di creare e adoperare l’opinione pubblica. La tendenza delle
persone che hanno espresso le idee della democrazia, anche quando non ne
hanno diretto l’azione, la tendenza degli studiosi, degli oratori, dei
giornalisti, è stata quella di vedere l’Opinione Pubblica come gli uomini di
altre società vedevano le forze arcane a cui attribuivano l’ultima parola
nella determinazione degli avvenimenti.
Infatti in quasi tutte le teorie politiche c’è un elemento inscrutabile, che
nel momento in cui le teorie stesse furoreggiano non viene esaminato. Al
di là delle apparenze c’è un Fato, ci sono degli Angeli Custodi, o dei
Comandi ad un Popolo Eletto, una Monarchia Divina, un Vicario del Cielo
o una Classe dei Bennati. Gli angeli, i demoni e i re più ovvi sono
scomparsi dal pensiero democratico, e tuttavia perdura la necessità di
credere che ci siano dei poteri di riserva. Perdurava in quei pensatori del
Settecento che tracciarono la matrice della democrazia. Avevano una
divinità pallida, ma cuori ardenti, e trovarono nella dottrina della sovranità
popolare la risposta al loro bisogno di attribuire un’origine infallibile al
nuovo ordine sociale. Il mistero era lì, e solo i nemici del popolo potevano
toccarlo con mani profane e curiose.
2.
Non sollevarono il velo, perché erano politici pratici impegnati in una
lotta aspra e incerta. Essi stessi avevano sentito l’aspirazione alla
democrazia, che è sempre tanto più profonda, intima e importante di
qualsiasi teoria del governo. Erano impegnati, contro il pregiudizio di
secoli, nell’affermazione della dignità umana. La loro molla non era l’idea
193
che John Smith avesse opinioni sensate sulle questioni pubbliche, bensì
quella che John Smith, discendente da un ceppo che era stato sempre
considerato inferiore, d’ora in avanti non avrebbe piegato il ginocchio
davanti a nessun altro uomo. Era questo spettacolo che rendeva una
beatitudine «l’esser vivi in quell’alba». Ma tutti i critici sembrano sminuire
questa dignità, negando che tutti gli uomini siano sempre ragionevoli, o
istruiti o informati, notando che le persone vengono ingannate, che non
sempre conoscono i propri interessi, e che non tutti gli uomini sono
egualmente adatti a governare.
Questi critici riuscivano graditi quanto può esserlo un bambino munito
di un tamburo. Ognuna di queste osservazioni sulla fallibilità dell’uomo
veniva sfruttata fino alla nausea. Ammettendo che c’era della verità in uno
qualsiasi degli argomenti aristocratici, i democratici avrebbero aperto una
breccia nelle proprie difese. E così, proprio come Aristotele doveva
insistere che lo schiavo era schiavo per natura, i democratici dovevano
insistere che l’uomo libero era legislatore e amministratore per natura. Non
potevano indugiare a spiegare che un’anima umana poteva non avere
ancora, o anzi avrebbe potuto non avere mai, questo corredo tecnico; e che
nondimeno aveva il diritto inalienabile di non essere adoperata come
pedina non consenziente da altri uomini. Le persone superiori erano ancora
troppo forti e troppo prive di scrupoli per astenersi dal far tesoro di una
dichiarazione così candida.
E allora i primi democratici sostenevano che una rettitudine ragionata
scaturiva spontaneamente dalla massa degli uomini. Tutti speravano che
fosse così, molti di loro credevano che lo fosse, sebbene i più avveduti,
come Thomas Jefferson, nutrissero privatamente molte riserve al riguardo.
Ma una cosa era certa: in quell’epoca tutti ritenevano che la pubblica
opinione sarebbe sorta spontaneamente o non sarebbe sorta affatto. Infatti,
sotto un aspetto fondamentale la scienza politica su cui si basava la
democrazia era la stessa scienza che Aristotele aveva formulato. Era la
stessa scienza per il democratico e l’aristocratico, il monarchico e il
repubblicano, poiché la sua premessa maggiore postulava che l’arte di
governo fosse una dote naturale. Gli uomini rivelavano opinioni
radicalmente diverse allorché cercavano di indicare gli uomini forniti di
questa dote; ma era d’accordo nel pensare che la questione più grossa era
quella di trovare coloro nei quali la saggezza era nata. I monarchici erano
certi che i re fossero nati per governare. Alexander Hamilton riteneva che
pur «essendoci forti intelletti in tutti i campi […] il corpo rappresentativo,
con eccezioni troppo poco numerose per avere un’influenza sullo spirito
del governo, sarà composto di proprietari terrieri, di commercianti e liberi
194
professionisti»1. Jefferson riteneva che le doti politiche venissero
depositate da Dio negli agricoltori e nei proprietari di piantagioni, e talora
parlava come se si potesse trovarle in tutti gli individui2. La premessa
principale era la stessa: governare era un istinto che appariva, a seconda
delle proprie preferenze sociali, in un solo uomo o in pochi eletti, in tutti i
maschi, o in tutti i maschi bianchi di età superiore ai ventun anni, o magari
in tutti gli uomini e in tutte le donne. Nel decidere chi fosse più adatto a
governare, la conoscenza del mondo era data per scontata. L’aristocratico
riteneva che quelli che maneggiavano affari importanti possedevano
l’istinto; i democratici affermavano che tutti gli uomini possedevano
l’istinto, e perciò erano in grado di trattare gli affari importanti. In nessun
caso faceva parte della scienza politica il problema di spiegare come far
arrivare la conoscenza del mondo al governante. Se si era per il popolo,
non c’era alcun bisogno di risolvere la questione del modo in cui tenere
informato l’elettore. All’età di ventun anni questi aveva le sue facoltà
politiche. Ciò che contava era un buon cuore, una mente raziocinante, un
punto di vista equilibrato. Sarebbero maturati con l’età, ma non era
necessario preoccuparsi di come informare il cuore e nutrire la ragione. Gli
uomini assorbivano i fatti così come assorbivano l’aria.
3.
Ma i fatti che gli uomini potevano giungere a possedere in questa
maniera, che non richiedeva sforzo, erano limitati. Potevano conoscere i
costumi e le caratteristiche più evidenti del luogo in cui vivevano e
lavoravano. Ma il mondo esterno dovevano immaginarselo, e non se lo
immaginavano istintivamente, né potevano assorbirne una conoscenza
attendibile per il solo fatto di vivere. Perciò il solo ambiente in cui era
possibile la politica spontanea era quello compreso nell’ambito della
conoscenza diretta e certa del governante. Non si può sfuggire a questa
conclusione ogniqualvolta si fondi il governo sull’ambito naturale delle
facoltà dell’uomo. «Per decidere questioni di giustizia e per distribuire le
cariche secondo il merito – come diceva Aristotele1 –, è necessario che i
cittadini si conoscano a vicenda nelle loro qualità, poiché, ove ciò non si
avvera, di necessità le faccende riguardanti le cariche e le sentenze
giudiziarie vanno male».
Ovviamente, questa massima era valida per tutte le scuole di pensiero
politico. Ma presentava difficoltà particolari per i democratici. Quelli che
credevano nel governo di classe potevano ragionevolmente sostenere che
alla corte del re, o nelle ville dei signori, gli uomini conoscevano i
195
rispettivi caratteri, e finché il resto dell’umanità restava passivo, i soli
caratteri che occorreva conoscere erano i caratteri degli uomini della classe
governante. Ma i democratici, che aspiravano a elevare la dignità di tutti
gli uomini, si trovavano alle prese con le enormi dimensioni e con la
confusione della loro classe governante: l’elettorato maschile. La loro
scienza gli diceva che la politica era un istinto, e che l’istinto operava in un
ambiente limitato. Le loro speranze li spingevano a sostenere che tutti gli
uomini compresi in un vastissimo ambiente potevano governare. In questo
micidiale conflitto tra i loro ideali e la loro scienza, l’unica via d’uscita era
quella di postulare senza troppe discussioni che la voce del popolo era la
voce di Dio.
Il paradosso era troppo grande, la posta troppo grossa, il loro ideale
troppo prezioso per un esame critico. Non potevano dimostrare in che
modo un cittadino di Boston potesse, restando a Boston, capire le opinioni
di un virginiano, in che modo un virginiano, stando nella Virginia, potesse
avere delle reali opinioni sul governo di Washington, in che modo i
parlamentari, stando a Washington, potessero avere opinioni sulla Cina o
sul Messico. Infatti a quel tempo solo pochi individui erano in grado di
estendere il raggio del giudizio al mondo che non vedevano. S’erano fatti
dei progressi, naturalmente, dai tempi di Aristotele. C’erano alcuni
giornali, e c’erano libri, e strade probabilmente migliori, e navi migliori.
Ma non c’era un grande progresso, e i postulati politici del Settecento
dovevano in fondo essere quelli che avevano dominato la scienza politica
per duemila anni. I primi democratici non possedevano gli strumenti per
risolvere il conflitto tra ciò che si sapeva essere il campo d’attenzione
dell’individuo e la fede illimitabile nella sua dignità.
I loro postulati erano antecedenti non solo al giornale moderno, alle
agenzie mondiali, alla fotografia e ai film, ma, ciò che importa di più,
erano antecedenti alle misurazioni e ai documenti, all’analisi quantitativa e
comparativa, ai canoni dell’evidenza, e alla capacità dell’analisi
psicologica di correggere e far la tara sui pregiudizi del testimone. Non
voglio dire che i nostri documenti siano soddisfacenti, che la nostra analisi
sia priva di pregiudizi, che le nostre misurazioni siano sicure. Quel che
voglio dire è che le invenzioni-chiave sono state fatte per portare il mondo
lontano entro il raggio del giudizio. Non erano state escogitate al tempo di
Aristotele, e non erano ancora abbastanza importanti per venir notate dalla
teoria politica al tempo di Rousseau, Montesquieu e Thomas Jefferson. Più
avanti credo che si vedrà come anche nell’ultima teoria della ricostruzione
umana, quella dei socialisti corporativi inglesi, tutte le premesse più
importanti siano state tratte da questo antico sistema di pensiero politico.
196
Questo sistema, quando era competente e onesto, doveva sostenere che
nessun individuo poteva avere altro che una parzialissima esperienza della
vita pubblica. Nel senso che può dedicarle solo poco tempo, questo
postulato è ancora vero, ed è pregno di conseguenze. Ma la teoria antica
era costretta a sostenere non solo che gli uomini potevano dedicare scarsa
attenzione alle questioni pubbliche, ma che l’attenzione disponibile
avrebbe dovuto limitarsi alle questioni immediatamente a portata di mano.
Sarebbe stato utopistico, allora, pensare che sarebbe venuto un tempo in
cui si sarebbero potuti riferire, analizzare e presentare fatti lontani e
complicati in modo tale che un dilettante potesse fare una scelta realmente
valida. Questo tempo è ora in vista. Non c’è più alcun dubbio che
l’informazione continua sul mondo che non si vede è una possibilità
pratica. Spesso questo viene fatto malamente, ma la circostanza stessa che
lo si faccia dimostra che può esser fatto, e la circostanza che cominciamo a
capire che spesso è fatto male, dimostra che può esser fatto meglio. Con
gradi diversi di capacità e onestà, ogni giorno situazioni lontane complesse
vengono esposte da tecnici e contabili a industriali o uomini d’affari, da
segretari e funzionari ad autorità pubbliche, da ufficiali dei servizi segreti
allo Stato maggiore generale, da alcuni giornalisti ad alcuni lettori. Sono
inizi grossolani, ma radicali. Assai più radicali, nel senso letterale di questa
parola, della ripetizione di guerre, rivoluzioni, abdicazioni e restaurazioni;
radicali quanto il mutamento spaziale avvenuto nella vita umana, e che ha
reso possibile a Lloyd George di discutere delle miniere del Galles a
Londra dopo la prima colazione e del destino degli arabi prima di cena a
Parigi.
Infatti la possibilità di portare entro il raggio del giudizio un qualsiasi
aspetto delle cose umane, spezza l’incantesimo che pendeva sulle linee
politiche. Ci sono stati naturalmente moltissimi individui che non si sono
resi conto che il raggio dell’attenzione era la premessa principale della
scienza politica. Hanno costruito sulla sabbia. Hanno dimostrato nelle
proprie persone gli effetti di una conoscenza limitatissima ed egocentrica
del mondo. Ma nei pensatori politici che hanno contato qualcosa – da
Platone e Aristotele, attraverso Machiavelli e Hobbes, fino ai teorici della
democrazia – la riflessione si è imperniata sull’uomo egocentrico, che
doveva vedere il mondo intero mediante qualche immagine che aveva in
testa.
197
XVII.
La comunità autosufficiente
1.
È sempre stato evidente che i gruppi di individui egocentrici, venendo a
contatto tra loro, avrebbero ingaggiato una lotta per l’esistenza. C’è
almeno questo di vero in quel famoso brano del Leviatano, in cui Hobbes
afferma che
anche se non ci fosse mai stato un tempo in cui i particolari fossero in condizione di
guerra l’un contro l’altro, tuttavia in tutti i tempi i re e le persone dotate di autorità
sovrana, a causa della loro indipendenza, si trovano ad avere continue gelosie, ad
essere nello stato e nella posizione di gladiatori che stanno con le armi puntate e gli
occhi fissi l’uno sull’altro1.
2.
Per aggirare questa conclusione una grande corrente di pensiero, che ha
avuto ed ha molte scuole, procedeva in questo modo: concepiva un
modello idealmente giusto di rapporti umani, in cui ciascuna persona
aveva funzioni e diritti ben precisi. Se svolgeva coscienziosamente il ruolo
assegnatole, non importava se le sue opinioni erano giuste o sbagliate.
Faceva il suo dovere, il suo vicino lo faceva pure, e tutte le persone ligie al
dovere formavano insieme un mondo armonioso.
Tutti i sistemi di casta sono un’illustrazione di questo principio; lo si
trova nella Repubblica di Platone e in Aristotele, nell’ideale feudale, nelle
sfere del Paradiso di Dante, nel socialismo di tipo burocratico, e nel
laissez-faire, e in misura sorprendente nel sindacalismo, nel socialismo
corporativo, nell’anarchismo e nel sistema di diritto internazionale
idealizzato da Robert Lansing. Tutti, senza eccezione, presuppongono
un’armonia prestabilita, ispirata, imposta, o innata, per opera della quale la
persona, la classe o la collettività egocentrica viene orchestrata insieme al
resto dell’umanità. I più autoritari immaginano un direttore di questa
sinfonia, che bada a far suonare a ognuno la sua parte; gli anarchici son
propensi a pensare che se ciascun suonatore improvvisasse a piacimento, si
sentirebbe un’armonia più divina.
198
Ma ci sono stati anche filosofi che si infastidivano di questi schemi di
diritti e doveri, che davano per scontato il conflitto e cercavano di capire in
che modo si poteva far uscire vincente la loro parte. Sono sempre apparsi
più realisti, anche quando parevano allarmanti, perché non avevano da fare
altro che generalizzare l’esperienza a cui nessuno sfuggiva. Machiavelli è
il classico di questa scuola, un uomo spietatamente calunniato, perché gli
capitò di essere il primo naturalista che usasse un linguaggio semplice in
un campo sino allora occupato dai soprannaturalisti1. Ha una nomea
peggiore di ogni altro pensatore politico di ogni tempo, e più discepoli di
ogni altro. Descrisse in modo veritiero la tecnica di esistenza dello stato
autosufficiente. Ecco perché ha dei discepoli. Ha una cattiva nomea
soprattutto perché ammiccò alla famiglia Medici, sognando di notte nel
suo studio, quando indossava i suoi «panni curiali», di esser lui,
Machiavelli, il Principe; e trasformò una pungente descrizione del modo in
cui le cose vengon fatte in un elogio di questo modo di fare.
Nel suo capitolo più famigerato2 scrisse che
debbe adunque avere uno principe gran cura che non li esca mai di bocca una cosa
che non sia piena delle soprascritte cinque qualità, e paia, a vederlo et udirlo, tutto
pietà, tutto fede, tutto integrità, tutto relligione. E non è cosa più necessaria a parere
di avere, che questa ultima qualità. E li uomini in universali iudicano più alli occhi
che alle mani; perché tocca a vedere a ognuno, a sentire a pochi. Ognuno vede
quello che tu pari, pochi sentono quello che tu se’; e quelli pochi non ardiscano
opporsi alla opinione di molti, che abbino la maestà dello stato che li difenda; e nelle
azioni di tutti li uomini, e massime de’ principi, dove non è iudizio da reclamare, si
guarda al fine. […] Alcuno principe de’ presenti tempi, quale non è bene nominare,
non predica mai altro che pace e fede, e dell’una e dell’altra è inimicissimo; e l’una
e l’altra, quando e’ l’avessi osservata, li arebbe più volte tolto o la reputazione o lo
stato.
Questo è cinico. Ma è il cinismo di un uomo che vedeva chiaro, senza
sapere del tutto perché vedeva quello che vedeva. Machiavelli pensa alla
generalità degli uomini e dei principi «che iudicano più alli occhi che alle
mani», che è il suo modo di dire che i loro giudizi sono soggettivi. Era
troppo pratico per pretendere che gli italiani del suo tempo vedessero il
mondo con fermezza, e che lo vedessero intero. Non voleva indulgere a
fantasie, e non aveva le basi per immaginarsi una razza di uomini che
avessero imparato il modo di correggere la loro visione.
Il mondo, come gli si presentava, si componeva di persone la cui
visione difficilmente poteva esser corretta; e Machiavelli sapeva che tali
persone, vedendo tutti i rapporti pubblici da un punto di vista privato, sono
perpetuamente in conflitto. Ciò che vedono è la loro interpretazione
199
personale, di classe, dinastica o municipale, di cose che in realtà arrivano
molto al di là dei limiti della loro visione. Vedono il loro aspetto. Lo
vedono come quello giusto. Ma incrociano altre persone che sono
parimenti egocentriche. E allora la loro stessa esistenza è in pericolo, o
almeno ciò che essi, per insospettate ragioni private, considerano la propria
esistenza, e ciò che giudicano un pericolo. Il fine, che si fonda
ineluttabilmente su un’esperienza reale, quantunque privata, giustifica i
mezzi. Sono disposti a sacrificare uno qualsiasi di questi ideali per salvarli
tutti… «si guarda al fine».
3.
I filosofi della democrazia si sono trovati di fronte a queste verità
elementari. Consapevolmente o no, avvertivano che il raggio della
conoscenza politica era limitato, che l’area dell’alto governo avrebbe
dovuto essere limitata, e che gli stati autosufficienti, venendo a contatto tra
di loro, assumevano pose gladiatorie. Ma avvertivano con altrettanta
certezza che negli uomini c’era la volontà di determinare il proprio
destino, e di trovare una pace che non fosse imposta con la forza. Come
potevano conciliare il desiderio e la realtà?
Si guardarono attorno. Nelle città-stato della Grecia e dell’Italia
trovarono una storia di corruzione, intrighi e guerra1. Nelle proprie città
videro faziosità, artificiosità, febbrilità. Non era questo l’ambiente in cui
l’ideale democratico poteva prosperare, non era questo il posto in cui un
gruppo di individui indipendenti e di pari competenza poteva condurre i
propri affari comuni spontaneamente. Guardarono più in là, forse guidati
in qualche modo da Jean-Jacques Rousseau; guardarono ai remoti e
incorrotti villaggi rurali. Quel che videro fu sufficiente a convincerli che là
era la patria del loro ideale. Jefferson in particolare lo sentì, e Jefferson più
di ogni altro formulò l’immagine americana della democrazia. Il potere
che aveva portato la rivoluzione americana alla vittoria era venuto dai
borghi. Dai borghi dovevano venire i voti che portarono il partito di
Jefferson al potere. Là nelle comunità rurali del Massachusetts e della
Virginia, se si riusciva a distogliere lo sguardo dagli schiavi, si poteva
vedere con l’occhio della mente l’immagine di ciò che la democrazia
doveva essere.
«Scoppiata la rivoluzione – dice de Tocqueville2 – il dogma della
sovranità del popolo uscì dal comune e si impadronì del governo».
Certamente prese possesso delle menti di quegli uomini, che formularono
e resero popolari gli stereotipi della democrazia. «Il nostro principio era la
200
cura del popolo» scrisse Jefferson3. Ma il popolo che egli curava era
composto quasi esclusivamente di piccoli proprietari coltivatori:
Quelli che lavorano la terra sono il popolo eletto di Dio, se mai Egli ha avuto un
popolo eletto, il cui petto Egli ha fatto scrigno di ogni forte e genuina virtù. È il
focolare in cui Egli tien vivo quel sacro fuoco che altrimenti potrebbe fuggire dalla
faccia della terra. La corruzione morale della massa dei coltivatori è un fenomeno di
cui non si sono avuti esempi in alcun tempo e in alcuna nazione.
Una parte di questa esclamazione certamente si spiega con la voglia del
ritorno romantico alla natura, ma non manca anche una dose di solido
buon senso. Jefferson aveva ragione di pensare che un gruppo di
agricoltori indipendenti si avvicina più di qualsiasi altra società umana a
soddisfare i requisiti della democrazia spontanea. Ma se si vuole
mantenere l’ideale, è necessario isolare queste comunità ideali dalla
ignominie del mondo. Se debbono amministrare i loro affari, gli agricoltori
debbono limitarsi a questi affari che sono abituati ad amministrare.
Jefferson tirò tutte queste conclusioni logiche. Disapprovava l’industria, il
commercio estero, la marina, le forme intangibili di proprietà e in teoria
ogni forma di governo che non si incentrasse nel piccolo gruppo
autogovernante. Ai suoi tempi ebbe degli oppositori: uno di loro notò che
«avvolti nella pienezza della nostra importanza e sufficientemente forti, in
realtà, per difenderci da qualunque invasore, potremmo godere di
un’eterna rusticità e vivere per sempre apaticamente e volgarmente sotto il
riparo di un’egoistica e soddisfatta indifferenza»4.
4.
L’ideale democratico jeffersoniano, consistendo in un ambiente ideale e
in una classe scelta, non era in conflitto con la scienza politica del suo
tempo. Era però in conflitto con la realtà. E quando l’ideale venne
formulato in termini assoluti, in parte per entusiasmo e in parte per fini
elettorali, si dimenticò ben presto che la teoria era stata concepita in
origine per situazioni particolarissime. Diventò il vangelo politico, e fornì
gli stereotipi attraverso i quali gli americani di tutte le tendenze hanno
visto la politica.
Questo vangelo fu imposto dal fatto che al tempo di Jefferson nessuno
avrebbe potuto immaginare opinioni pubbliche che non fossero spontanee
e soggettive. Perciò la tradizione democratica cerca sempre di figurarsi un
mondo in cui gli individui si occupino esclusivamente di cose, le cui cause
e i cui effetti operino tutti nell’ambito della regione in cui abitano. La
201
teoria democratica non ha mai potuto immaginarsi nel contesto di un
ambiente vasto e imprevedibile. Lo specchio è concavo. E i democratici,
pur ammettendo di essere in contatto con affari esterni, vedono con
sicurezza che tutti i contatti oltrepassanti il gruppo autosufficiente sono
una minaccia alla democrazia, come è stata originariamente concepita.
Questo è un timore saggio. Se la democrazia deve essere spontanea, gli
interessi della democrazia debbono restare semplici, comprensibili e facili
ad amministrarsi. Se si deve lasciare l’informazione all’esperienza casuale,
le condizioni debbono avvicinarsi a quelle delle comunità rurali isolate.
L’ambiente deve restringersi a quello di cui ogni individuo ha una
conoscenza diretta e certa.
Il democratico ha compreso ciò che l’analisi dell’opinione pubblica
sembra dimostrare: che nei rapporti con un ambiente lontano, che non si
vede, le decisioni sono chiaramente prese a caso, il che ovviamente non
dovrebbe accadere1. Perciò ha sempre cercato in un modo o nell’altro di
minimizzare l’importanza di questo mondo lontano. Temeva il commercio
estero perché il commercio comporta rapporti con l’estero; diffidava delle
fabbriche perché creavano grandi città e ammassavano folle; se comunque
ci dovevano essere fabbriche, allora pretendeva il protezionismo
nell’interesse dell’autosufficienza. Quando non riusciva a trovare queste
condizioni nel mondo reale, andava con passione verso le terre nuove a
fondare comunità utopiche, lontane da contatti con lo straniero. I suoi
slogan rivelano i suoi pregiudizi. È per l’Autogoverno,
l’Autodeterminazione, l’Indipendenza. Nessuna di queste idee comporta
un’idea di consenso o di comunità oltrepassanti le frontiere dei gruppi che
si autogovernano. Il campo dell’azione democratica è un’area circoscritta.
Entro confini protetti, l’obiettivo è stato quello di conseguire
l’autosufficienza e di evitare i legami. Questa regola non si limita alla
politica estera, ma è particolarmente evidente nel suo caso, perché la vita
al di fuori dei confini nazionali è più chiaramente estranea di qualsiasi vita
che si svolga entro di essi. E come dimostra la storia, generalmente le
democrazie in politica estera hanno dovuto scegliere tra lo splendido
isolamento e una diplomazia che violava i loro ideali. In realtà le
democrazie più riuscite, la Svizzera, la Danimarca, l’Australia, la Nuova
Zelanda, e fino a poco tempo fa l’America, non hanno mai avuto una
politica estera nel senso europeo di questa espressione. Persino un precetto
come la Dottrina di Monroe è sorto dal desiderio di aggiungere ai due
oceani uno spalto di stati che fossero sufficientemente repubblicani per
non avere alcuna politica estera.
Mentre il pericolo è una grande, forse indispensabile, condizione
202
dell’autocrazia2, la sicurezza è stata vista come una necessità per il
funzionamento della democrazia. Si deve turbare il meno possibile la
premessa di una comunità autosufficiente. L’insicurezza comporta delle
sorprese. Essa significa che ci sono persone che agiscono sulla nostra vita,
sulle quali non abbiamo alcun controllo, con le quali non possiamo
consultarci. Significa che si è in presenza di forze che turbano la consueta
routine, e presentano problemi insoliti per i quali occorre prendere
decisioni rapide e insolite. Ogni democratico sente nelle ossa che le crisi
pericolose sono incompatibili con la democrazia, perché sa che l’inerzia
delle masse è tale che per poter agire rapidamente solo pochissimi
debbono decidere, e il resto deve venir dietro piuttosto ciecamente. Non è
che questo abbia reso i democratici rinunciatari, ma ha fatto sì che tutte le
guerre democratiche siano state combattute per fini pacifisti. Anche
quando le guerre sono, in realtà, guerre di conquista, si crede sinceramente
che siano fatte in difesa della civiltà.
Questi vari tentativi di recingere una parte della superficie della terra
non sono stati ispirati da viltà, da apatia, o da quella che un oppositore di
Jefferson chiamava la propensione a vivere sotto una disciplina monacale.
I democratici avevano intravisto un’abbagliante possibilità, quella che ogni
essere umano raggiungesse la sua piena statura, liberato dai limiti creati
dall’uomo stesso. Con quello che conoscevano dell’arte di governo,
potevano, come Aristotele prima di loro, concepire una società di individui
autonomi solo a patto che fosse conchiusa e semplice. Non potevano
scegliere un’altra premessa, se dovevano arrivare alla conclusione che tutti
gli individui erano in grado di amministrare spontaneamente i loro affari
pubblici.
5.
Avendo adottato questa premessa, perché era necessaria alla loro più
cara speranza, trassero anche altre conclusioni. Dal momento che per avere
l’autogoverno spontaneo ci si doveva tenere nei limiti di una comunità
autosufficiente, davano per acquisito che un individuo era competente
quanto il suo vicino ad amministrare questi affari semplici e
autosufficienti. Questa logica, quando il desiderio è padre del pensiero, è
convincente. Inoltre la dottrina del cittadino onnicompetente è vera, a
quasi tutti gli effetti pratici, nella comunità rurale. Nel villaggio tutti,
presto o tardi, mettono mano a tutto quello che il villaggio fa. Nelle
cariche si avvicendano uomini che sanno fare un po’ di tutto. La dottrina
dei cittadini onnicompetenti andava benissimo finché lo stereotipo
203
democratico non veniva applicato universalmente, e gli uomini, di fronte
ad una civiltà complicata, continuavano a vedere un villaggio conchiuso. Il
singolo cittadino non solo era adatto ad occuparsi di tutti gli affari
pubblici, ma era costantemente pervaso di spirito civico e dotato di un
interesse che non cedeva mai. Nella comunità rurale, dove conosceva tutti
e si interessava delle faccende di tutti, aveva abbastanza senso civico.
L’idea di sufficiente per la comunità rurale si trasformò facilmente
nell’idea di sufficiente ad ogni effetto, poiché, come abbiamo notato, il
pensare quantitativamente non si addice agli stereotipi. Ma si fece un altro
passo in là. Poiché si dava per acquisito che tutti si interessassero a
sufficienza degli affari importanti, finirono per sembrare importanti solo
quegli affari di cui tutti si interessavano.
Ciò volle dire che gli individui si formavano la loro immagine del
mondo esterno sulla base delle immagini incontestate che avevano nelle
loro menti. Queste immagini arrivavano a loro convenientemente
stereotipate dai genitori e dagli insegnanti, e la loro esperienza le
modificava poco. Solo poche persone avevano affari che le portassero oltre
i confini del loro stato. Ancor meno avevano ragioni per andare all’estero.
La maggior parte degli elettori vivevano tutta la vita in un solo ambiente, e
dovevano concepire il mondo più vasto del commercio e della finanza,
della guerra e della pace, col solo ausilio di pochi deboli giornali, di
qualche opuscolo, di qualche discorso politico, della loro preparazione
religiosa, e di voci. Il numero delle opinioni pubbliche fondato su una
documentazione obiettiva era piccolissimo rispetto a quelle fondate sulla
fantasia.
E così nel periodo formativo l’autosufficienza è stata per molte svariate
ragioni un ideale spirituale. L’isolamento fisico della comunità locale, la
solitudine del pioniere, la tradizione protestante e i limiti della scienza
politica, hanno tutti contribuito a far credere agli individui che dovevano
estrarre la saggezza politica dalle loro coscienze. Non è strano che la
deduzione di leggi da principi assoluti abbia assorbito tanta parte delle loro
energie libere. La mente politica americana doveva vivere sul proprio
capitale. Nella stretta aderenza alla legge trovò un corpo di regole
collaudato, dal quale potevano essere derivate nuove regole senza la fatica
di apprendere nuove verità dall’esperienza. Le formule divennero tanto
stranamente sacre che tutti i migliori osservatori stranieri si sono stupiti del
contrasto tra l’energia pratica dinamica del popolo americano e lo statico
dottrinarismo della loro vita pubblica. Questo costante amore per i principi
stabiliti era semplicemente il solo modo conosciuto di conseguire
l’autosufficienza. Ma questo significava che le opinioni pubbliche delle
204
singole comunità sul mondo esterno consistevano soprattutto in poche
immagini stereotipate ordinate in un modello dedotto dai loro codici legali
e morali, e animato dal sentimento destato dalle esperienze locali.
Perciò la teoria democratica, partendo dalla sua bella visione della
fondamentale dignità umana, fu costretta, dalla mancanza di strumenti di
informazione sul proprio ambiente, a ripiegare sulla saggezza e
sull’esperienza che si erano casualmente accumulate nell’elettore. Dio,
secondo Jefferson, aveva fatto del petto degli uomini «lo scrigno di ogni
forte e genuina virtù». Queste persone elette nel loro ambiente
autosufficiente avevano davanti a sé tutti i fatti. L’ambiente era così
familiare che si poteva dare per scontato che gli individui parlassero
sostanzialmente delle stesse cose. Perciò i soli veri disaccordi potevano
consistere nei giudizi sugli stessi fatti. Non c’era alcun bisogno di garantire
le fonti dell’informazione. Erano ovvie ed egualmente accessibili a tutti gli
individui. E non c’era nemmeno bisogno di preoccuparsi dei criteri di
fondo. Nella comunità autosufficiente si poteva presupporre, o perlomeno
di fatto si presupponeva, un codice morale omogeneo. Perciò le differenze
d’opinione avevano luogo soltanto nell’applicazione logica di norme
accettate a fatti accettabili. E dato che la facoltà raziocinante era anch’essa
fortemente standardizzata, un errore di ragionamento veniva messo a nudo
rapidamente nel libero dibattito. Ne derivava che la verità poteva essere
raggiunta liberamente entro questi limiti. La comunità poteva dare per
scontata la sua provvista di informazioni; i suoi codici li trasmetteva
attraverso la scuola, la chiesa e la famiglia, e il potere di trarre deduzioni
da una premessa piuttosto che la capacità di trovare la premessa, veniva
considerato il fine principale dell’educazione intellettuale.
205
XVIII.
Il ruolo della forza,
del favoritismo e del privilegio
1.
È avvenuto – scrisse Hamilton1 – proprio quel che si sarebbe dovuto prevedere. I
deliberati dell’Unione non sono stati eseguiti, la disubbidienza degli Stati, poco per
volta, è giunta a tali estremi da finir per inceppare completamente le ruote del
governo centrale, riducendole in condizioni miserevoli.
Infatti «nel nostro caso occorre che ben tredici volontà sovrane e
separate si trovino d’accordo, in seno alla Confederazione, perché si possa
dar corso ad un provvedimento di qualche importanza che venga deciso
dall’Unione». E come poteva essere altrimenti?, si chiedeva:
I governanti dei singoli Stati-membri, cominceranno ad entrare nel merito delle
misure stesse e a giudicarle, sia che ne abbiano diritto da un punto di vista
costituzionale, sia che non lo abbiano. Essi vorranno considerare la questione che
viene loro proposta o imposta alla luce dei propri immediati interessi e dei propri
scopi particolari, ed alla luce dei vantaggi o degli svantaggi contingenti che
sarebbero determinati dall’adozione del provvedimento. Tutto ciò avverrebbe in uno
spirito di egoistica e sospettosa inquisizione, senza quella conoscenza delle
circostanze d’indole nazionale o delle ragioni di Stato che sarebbero essenziali ad un
equo giudizio e con quella particolare attenzione, invece, alle questioni di carattere
locale che non può fare a meno di sviare la decisione. Lo stesso modo di vedere si
ripeterà per ogni membro componente la Confederazione suddetta, onde
l’esecuzione dei provvedimenti, elaborati dalle assemblee generali, sarà sempre alla
mercé delle opinioni prevenute o male informate di ciascuna parte.
Coloro che ben conoscono i procedimenti delle assemblee popolari, che hanno
visto come sia spesso difficile, allorché non sussista una qualche situazione
oggettivamente impellente, che esse giungano ad accordarsi su deliberazioni relative
ad argomenti di capitale importanza – comprenderanno assai facilmente come debba
essere del tutto impossibile il riuscire a far sì che un certo numero di assemblee del
genere, che operano e deliberano in luoghi ben distanti l’uno dall’altro ed in
momenti diversi e sotto la spinta di diverse impressioni, non possano cooperare a
lungo in una unanimità di intenti e di principi.
Più di dieci anni di agitazione e tensione con un Congresso che era,
diceva John Adams2, «solo un’assemblea diplomatica», avevano fornito ai
206
capi della rivoluzione «una lezione istruttiva ma penosa»3 su ciò che
accade quando varie comunità autosufficienti si trovano a operare entro
uno stesso ambiente.
E così, quando nel maggio del 1787 andarono a Filadelfia,
apparentemente per rivedere gli articoli della Confederazione, essi si
trovavano in realtà in piena ribellione contro la premessa fondamentale
della democrazia del Settecento. I capi non solo erano consapevolmente
contrari allo spirito democratico del tempo, convinti, come diceva
Madison, che «le democrazie sono sempre state spettacoli di turbolenza e
contesa», ma entro le frontiere nazionali erano decisi a controbilanciare
per quanto possibile l’idea della comunità che si autogoverna in ambienti
autosufficienti. Gli scontri e gli insuccessi della democrazia concava, in
cui gli individui spontaneamente amministravano tutti i loro affari, erano
davanti ai loro occhi. Il problema, a loro avviso, era di restaurare il
governo in contrapposizione alla democrazia. Intendevano per governo il
potere di prendere decisioni nazionali e di farle applicare in tutta la
nazione; ritenevano che la democrazia fosse l’attaccamento delle comunità
locali, e delle classi, all’autodeterminazione secondo i loro interessi e fini
immediati.
Non potevano tener conto, nei loro calcoli, della possibilità di
un’organizzazione dell’informazione tale da permettere alle singole
comunità di agire simultaneamente sulla base della stessa interpretazione
dei fatti. Cominciamo appena adesso a concepire questa possibilità per
certe parti del mondo, in cui ci sono la libera circolazione delle notizie e
un linguaggio comune, e anche qui solo per certi aspetti della vita.
Tutta l’idea di un federalismo volontario nell’industria e nella politica
mondiale è ancora così rudimentale che, come vediamo nella nostra
esperienza, incide solo raramente e assai modestamente nella politica
pratica. Gli autori della Costituzione non avevano alcuna ragione di
concepire anche solo vagamente quello che noi, a più di un secolo di
distanza, riusciamo a concepire solo come un incentivo a uno sforzo
intellettuale di generazioni intere. Per poter costituire il governo nazionale,
Hamilton e i suoi colleghi dovevano fare dei piani poggiando non sulla
teoria che gli individui avrebbero collaborato perché avevano il senso
dell’interesse comune, ma su quella che gli individui avrebbero potuto
essere governati se gli interessi particolari fossero stati mantenuti in
equilibrio con un sistema di freni e contrappesi. «L’ambizione – diceva
Madison4 – deve essere usata come antidoto all’ambizione».
Non intendevano, come hanno creduto certi scrittori, dare a ogni
interesse un contrappeso sicché il governo si trovasse in un perpetuo
207
impasse. Intendevano neutralizzare l’interesse locale, e di categoria, per
impedirgli di ostacolare il governo. «Nell’organizzare un governo di
uomini che dovranno reggere altri uomini – scrisse Madison5 – qui sorge la
grande difficoltà: prima si dovrà mettere il governo in grado di controllare
i propri governanti, e quindi obbligarlo ad autocontrollarsi». Sotto un
aspetto molto importante, quindi, la dottrina dei freni e contrappesi era il
rimedio dei capi federalisti per il problema dell’opinione pubblica. Non
vedevano altro modo di sostituire «la mite influenza della magistratura»
all’«opera cruenta della spada»6 che quello di escogitare un ingegnoso
meccanismo per neutralizzare l’opinione locale. Non capivano come si
potesse manipolare un vasto elettorato, come non vedevano la possibilità
di fondare il consenso comune sull’informazione comune. È vero che
Aaron Burr diede a Hamilton una lezione che lo colpì moltissimo, quando
nel 1800 conquistò il controllo di New York City con l’aiuto di Tammany
Hall. Ma Hamilton fu ucciso prima di poter tenere conto di questa nuova
scoperta, e, come dice Ford7, la pistola di Burr fece saltare le cervella del
partito federalista.
2.
Al tempo in cui la Costituzione veniva scritta, «la politica poteva
ancora svolgersi mediante riunioni e accordi tra gentiluomini»1, e fu ai
gentiluomini che Hamilton si rivolse per formare un governo. Si pensava
che avrebbero amministrato gli affari nazionali quando i pregiudizi locali
fossero stati neutralizzati dai freni e dai contrappesi costituzionali. Non c’è
dubbio che Hamilton, che apparteneva per adozione a questa classe, aveva
un pregiudizio sentimentale a loro favore. Ma questo di per sé è una magra
spiegazione della sua arte di governo. Certamente non si può mettere in
dubbio la sua struggente passione per l’Unione, e credo che sia un
capovolgimento della verità sostenere che abbia fatto l’Unione per
proteggere i privilegi di classe anziché dire che usò i privilegi di classe per
fare l’Unione. «Dobbiamo prendere l’uomo così com’è – diceva Hamilton
– e se vogliamo che si dedichi alla cosa pubblica dobbiamo interessare le
sue passioni a questo scopo»2. Aveva bisogno che governassero uomini, le
cui passioni potessero essere avvinte con la massima rapidità a un interesse
nazionale. Questi erano i proprietari terrieri, i creditori pubblici, gli
imprenditori, gli spedizionieri e i commercianti3, e probabilmente nella
storia dell’adattamento di mezzi astuti a fini chiari non esiste un esempio
migliore della serie di misure fiscali con cui Hamilton legò i notabili di
provincia al nuovo governo.
208
Sebbene l’assemblea costituente lavorasse a porte chiuse, e sebbene la
ratifica fosse manovrata dal «voto di probabilmente non più di un sesto dei
maschi adulti»4, non ci si nascondeva dietro false apparenze. I federalisti si
battevano per l’Unione, non per la democrazia, e la parola repubblica
aveva un suono sgradevole per George Washington, anche quando era già
da due anni un presidente repubblicano. La Costituzione era un chiaro
tentativo di limitare la sfera del governo popolare; l’unico organo
democratico che si pensava che il governo dovesse avere era la Camera,
fondata su un suffragio molto limitato da requisiti di censo. E anche così si
riteneva che la Camera sarebbe stata una parte così licenziosa del governo
che si pensò bene di neutralizzarla con i freni e i contrappesi del Senato,
del collegio elettorale, del veto presidenziale e dell’interpretazione del
potere giudiziario.
E quindi, nel momento in cui la rivoluzione francese accendeva il
sentimento popolare in tutto il mondo, i rivoluzionari americani del 1776 si
davano una Costituzione che risaliva, per quanto le condizioni lo
consentissero, al modello della monarchia inglese. Questa reazione
conservatrice non poteva durare. Gli uomini che ne erano stati i
protagonisti erano una minoranza, i loro moventi erano sospettati e quando
Washington si ritirò, la posizione dei gentiluomini non era abbastanza
forte per resistere all’inevitabile lotta per la successione. Il divario tra il
piano originario dei Padri e il sentimento morale dell’epoca era troppo
grande per non essere capitalizzato da un abile uomo politico.
3.
Jefferson definiva la sua elezione «la grande rivoluzione del 1800», ma
più che altro era una rivoluzione del modo di vedere. Nessuno dei grandi
indirizzi fu modificato, ma si stabilì una nuova tradizione. Infatti fu
Jefferson che per primo insegnò al popolo americano a considerare la
Costituzione uno strumento di democrazia, e fu lui a stereotipare le
immagini, le idee e anche molte delle frasi con cui da quel momento in poi
gli americani hanno definito tra di loro la politica. La vittoria mentale fu
così completa che venticinque anni dopo de Tocqueville, che veniva
ricevuto nei salotti federalisti, osservava che anche quelli che erano irritati
per il suo perdurare, non di rado si mettevano a «vantare pubblicamente la
mitezza del governo repubblicano e i vantaggi delle istituzioni
democratiche»1.
Nonostante tutta la loro sagacia, i padri della Costituzione non erano
riusciti a capire che una costituzione francamente antidemocratica non
209
sarebbe stata tollerata a lungo. Lo sfacciato rifiuto del governo popolare
doveva per forza offrire il fianco all’attacco di un uomo come Jefferson,
che sul piano delle opinioni costituzionali non era affatto più disposto di
Hamilton ad affidare il governo alla volontà «grezza» del popolo2. I capi
federalisti erano stati uomini di convinzioni decise e di linguaggio franco.
C’era poca discordanza effettiva tra le loro opinioni pubbliche e quelle
private. Ma la mente di Jefferson era una massa di ambiguità, non soltanto
a causa dei suoi difetti, come hanno creduto Hamilton e i suoi biografi, ma
perché credeva nell’Unione e credeva nelle democrazie spontanee, e nella
dottrina politica del suo tempo non esisteva un modo soddisfacente di
conciliare le due cose. Jefferson era confuso nel pensiero e nell’azione,
perché intravedeva una nuova e grandiosa idea sulla quale nessuno aveva
ragionato fino in fondo. Ma la sovranità popolare, pur non essendo capita
chiaramente da nessuno, pareva implicare un miglioramento così grande
della vita umana che nessuna costituzione, che la negasse apertamente,
poteva resistere. I netti rifiuti furono perciò espunti dalla coscienza, e si
parlò e pensò del documento, che all’apparenza è un onesto esempio di
democrazia costituzionale ristretta, come di uno strumento di governo
popolare diretto. Jefferson arrivò davvero al punto di credere che i
federalisti avessero pervertito la Costituzione, della quale nella sua fantasia
essi non erano più gli autori. E così la Costituzione fu, nello spirito,
riscritta. In parte con veri e propri emendamenti, in parte con la prassi –
come nel caso del collegio elettorale – ma soprattutto vedendola attraverso
un altro sistema di stereotipi, alla facciata non fu più consentito di apparire
oligarchica.
Il popolo americano arrivò a credere che la sua Costituzione fosse uno
strumento democratico, e come tale la trattò. Esso deve questa finzione
alla vittoria di Thomas Jefferson, ed è stata una grande finzione
conservatrice. È facile ipotizzare che se tutti avessero sempre visto la
Costituzione come la vedevano i suoi autori, essa sarebbe stata
violentemente rovesciata, perché la fedeltà alla Costituzione e la fedeltà
alla democrazia sarebbero apparse incompatibili. Jefferson risolse questo
paradosso insegnando al popolo americano a leggere la Costituzione come
un’espressione di democrazia. Personalmente egli non andò oltre. Ma nel
corso di venticinque anni, o giù di lì, le condizioni sociali erano mutate
così radicalmente che Andrew Jackson portò a compimento la rivoluzione
politica per la quale Jefferson aveva preparato la tradizione3.
4.
210
Il nucleo politico di questa rivoluzione fu la questione del favoritismo.
Dagli uomini che fondarono il governo la carica pubblica era considerata
una specie di proprietà, da non importunare con leggerezza, e
indubbiamente essi speravano che le cariche sarebbero rimaste nelle mani
della loro classe sociale. Ma la teoria democratica aveva tra i suoi principi
fondamentali la dottrina del cittadino onnicompetente. Perciò quando il
popolo cominciò a vedere nella Costituzione uno strumento democratico,
era certo che la permanenza in carica sarebbe apparsa antidemocratica. Le
ambizioni naturali degli uomini coincidevano qui con il grande impulso
morale del loro tempo. Jefferson aveva reso popolare l’idea senza metterla
in pratica rigorosamente, e le rimozioni per ragioni di partito furono
relativamente poche sotto i presidenti virginiani. Fu Jackson che fondò la
prassi di trasformare la carica pubblica in favoritismo.
Per quanto possa sembrare strano, il principio dell’avvicendamento
nelle cariche a breve distanza di tempo fu considerato una grande riforma.
Non solo riconobbe la nuova dignità dell’uomo medio, trattandolo come se
fosse idoneo a qualsiasi carica, non solo distrusse il monopolio di una
piccola classe sociale e sembrò aprire le carriere all’ingegno, ma «erano
secoli che veniva invocato come il rimedio sovrano per la corruzione
politica», e come il solo modo di impedire la creazione di una burocrazia1.
La prassi del rapido avvicendamento nelle cariche pubbliche fu
l’applicazione a un grande territorio dell’immagine della democrazia
derivata dal villaggio autosufficiente.
Naturalmente non ebbe nella nazione gli stessi risultati che aveva nella
comunità ideale su cui si fondava la teoria democratica. Produsse risultati
del tutto inaspettati, perché creò una nuova classe politica in sostituzione
degli ormai sommersi federalisti. Senza volerlo il favoritismo fece per un
vasto elettorato quello che le misure fiscali di Hamilton avevano fatto per
le classi superiori. Spesso si stenta a rendersi conto di quanta parte della
stabilità del nostro governo sia dovuta al favoritismo. Infatti fu il
favoritismo che svezzò i capi naturali da un eccessivo attaccamento alla
comunità egocentrica, fu il favoritismo che indebolì lo spirito
campanilistico e unì in una sorta di collaborazione pacifica gli stessi
uomini che, come notabili provinciali, in assenza di un senso dell’interesse
comune avrebbero disfatto l’unione.
Ma naturalmente non era inteso che la teoria democratica producesse
una nuova classe di governo, e infatti essa non si è mai adattata al fatto.
Quando il democratico aspirava ad abolire il monopolio delle cariche, ad
avere l’avvicendamento e mandati brevi, aveva in mente la comunità dove
chiunque poteva ricoprire un incarico pubblico e poi ritornare umilmente
211
alla sua fattoria. L’idea di una classe particolare di politici era proprio
quello che al democratico non piaceva. Ma non era in grado di avere
quello che gli piaceva, perché la sua teoria era tratta da un ambiente ideale,
ed egli viveva in un ambiente reale. Quanto più profondamente sentiva
l’impulso morale della democrazia, tanto meno era pronto a capire la
profonda verità dell’affermazione di Hamilton, che le comunità deliberanti
lontane l’una dall’altra e sotto impressioni diverse non potevano
collaborare a lungo in comunanza di vedute e di fini. Infatti questa verità
rimanda la piena realizzazione della democrazia nella vita pubblica al
momento in cui l’arte di ottenere il consenso comune sia stata
radicalmente migliorata. E così, sebbene la rivoluzione sotto Jefferson e
Jackson abbia prodotto il favoritismo, che ha creato il sistema bipartitico,
che ha creato a sua volta un sostituto al governo dei gentiluomini e una
disciplina per regolare l’impasse dei freni e contrappesi, tutto ciò è
accaduto, per così dire, in modo invisibile.
Così l’avvicendamento nelle cariche poteva essere la teoria apparente,
ma in pratica le cariche oscillavano tra gli accoliti. La carica poteva non
essere un monopolio permanente, ma il politico di professione era
permanente. Il governo poteva essere, come disse una volta il presidente
Harding, una cosa semplice, ma vincere le elezioni era un’impresa
complicata. Le prebende potevano essere ostentatamente modeste, come le
stoffe di Jefferson fatte in casa, ma le spese dell’organizzazione del partito
e i frutti della vittoria erano grandiosi.
Lo stereotipo della democrazia controllava il governo visibile; le
correzioni, le eccezioni e gli adattamenti del popolo americano ai fatti reali
del suo ambiente dovevano essere per forza invisibili, anche quando tutti
sapevano tutto al riguardo. Sono state solo le parole della legge, sono stati
i discorsi degli uomini politici, i programmi e l’apparato formale
dell’amministrazione, che hanno dovuto uniformarsi all’immagine pristina
della democrazia.
5.
Se si fosse chiesto a un democratico portato alla meditazione in che
modo dovessero collaborare queste comunità autosufficienti, dal momento
che le loro opinioni pubbliche erano così egocentriche, egli avrebbe
additato il governo rappresentativo incarnato nel Congresso. E nulla
l’avrebbe sorpreso più della scoperta del costante declino del prestigio del
governo rappresentativo, di pari passo con l’aumento del potere della
Presidenza.
212
Alcuni critici hanno fatto risalire la cosa alla consuetudine di mandare a
Washington solo dei notabili locali. Secondo loro, se il Congresso potesse
essere composto degli uomini di prestigio nazionale, la vita della capitale
sarebbe più brillante. Lo sarebbe, naturalmente, e sarebbe un’ottima cosa
se i presidenti uscenti, insieme ai membri del loro gabinetto, seguissero
l’esempio di John Quincy Adams. Ma l’assenza di questi uomini non
spiega il dilemma del Congresso perché il suo declino è cominciato
quando era relativamente la branca più eminente del governo. È anzi più
probabile che sia vero il contrario, e che il Congresso abbia cessato di
attirare le persone eminenti a mano a mano che ha perduto l’influenza
diretta sulla formazione della politica nazionale.
La ragione principale del suo discredito, che è mondiale, va ricercata,
mi pare, nel fatto che un Congresso di rappresentanti è essenzialmente un
gruppo di ciechi in un mondo immenso e sconosciuto. Salvo poche
eccezioni, il solo modo riconosciuto dalla Costituzione, o dalla teoria del
governo rappresentativo, in cui il Congresso può informarsi, è quello di
scambiarsi le opinioni formatesi nei collegi elettorali. Non esiste per il
Congresso un modo sistematico, adeguato e autorizzato di apprendere quel
che succede nel mondo. La teoria è che l’uomo migliore di ogni collegio
porti il meglio della saggezza dei suoi elettori a un luogo che sta al centro,
e che tutte queste saggezze messe insieme costituiscano tutta la saggezza
di cui ha bisogno il Congresso. Ora non è necessario mettere in dubbio la
validità del fatto di esprimere opinioni locali e di confrontarle. Il
Congresso ha un grande valore come foro di una nazione che copre tutto
un continente. Nei guardaroba, negli atri degli alberghi, nelle pensioni di
Capitol Hill, ai tè delle mogli dei congressmen, e grazie a visite periodiche
ai salotti internazionali di Washington, si aprono nuove prospettive e più
vasti orizzonti. Ma anche se la teoria venisse applicata, e i collegi elettorali
mandassero sempre i loro uomini più saggi, la somma o la combinazione
delle impressioni locali non sarebbe una base sufficientemente ampia per
la politica nazionale, e non sarebbe affatto una base per il controllo della
politica estera. Dato che gli effetti reali della maggior parte delle leggi
sono sottili e occulti, non possono essere compresi filtrando esperienze
locali attraverso stati d’animo locali. Si può capirli solo mediante la
documentazione controllata e l’analisi obiettiva. E proprio come il capo di
una grande fabbrica non può conoscere l’efficienza di quest’ultima
parlando col capo reparto, ma deve esaminare le singole voci dei costi e gli
altri dati che solo un contabile può procurarsi, così il legislatore non arriva
a un quadro veritiero dello stato dell’Unione mettendo insieme un mosaico
di immagini locali. Ha bisogno di conoscere le immagini locali, ma se non
213
possiede strumenti per calibrarle, un’immagine vale l’altra e forse è anche
migliore.
Il presidente viene in aiuto del Congresso pronunciando messaggi sullo
stato dell’Unione. È in grado di farlo perché presiede a un vastissimo
insieme di uffici e di funzionari, i quali non solo agiscono, ma forniscono
notizie. Ma egli dice al Congresso quello che ha deciso di dirgli. Non può
esser sottoposto a domande imbarazzanti, e il potere di scegliere che cosa
sia o non sia compatibile con l’interesse pubblico spetta a lui. È un
rapporto assolutamente unilaterale e delicato, che raggiunge talora tali
vette di assurdità che il parlamento per avere un documento importante
deve ringraziare l’intraprendenza di un giornale di Chicago o
l’indiscrezione calcolata di un funzionario subordinato. Il contatto dei
legislatori con i fatti indispensabili è così lacunoso da costringerli ad
affidarsi o a confidenze private o a quell’atrocità legalizzata,
l’investigazione parlamentare, con la quale i congressmen, privati del
legittimo cibo della loro mente, procedono ad una caccia all’uomo
selvaggia e febbrile, e non si fermano nemmeno di fronte al cannibalismo.
Se togliamo il poco che rendono queste investigazioni, le
comunicazioni occasionali dei ministeri, i dati interessati e disinteressati
raccolti dai privati, i giornali, i periodici e i libri che possono leggere i
parlamentari, e la nuova e eccellente pratica di chiamare in aiuto gruppi di
esperti come la Interstate Commerce Commission, la Federal Trade
Commission e la Tariff Commission, la creazione dell’opinione
parlamentare è incestuosa. E allora succede che la legislazione a carattere
nazionale viene preparata da pochi iniziati informati, ed è approvata grazie
al potere di una parte, o che la legislazione viene spezzettata in una serie di
provvedimenti locali, ognuno dei quali viene votato per ragioni locali.
Livelli dei dazi doganali, basi navali, caserme, fiumi e porti, uffici postali
ed edifici federali, pensioni e favori, sono queste le cose che vengono
ammannite alle comunità concave quale prova tangibile dei benefici della
vita nazionale. Essendo concave, riescono a vedere l’edificio di marmo
bianco che sorge dai fondi federali per elevare i valori immobiliari locali, e
dare lavoro agli appaltatori locali, con maggiore facilità di quanto possano
giudicare il costo cumulativo di questo grasso che cola. Si può dire che in
una grande assemblea, in cui ogni membro ha una conoscenza pratica
soltanto del suo distretto, le leggi concernenti le questioni extralocali
vengono respinte o accettate dalla massa dei parlamentari senza alcuna
partecipazione creativa. La loro partecipazione si limita a quelle leggi che
si prestano ad essere trattate come un fascio di problemi locali. Infatti un
corpo legislativo privo di mezzi efficaci di informazione e di analisi deve
214
necessariamente oscillare tra una cieca regolarità, temperata ogni tanto da
qualche impennata, e l’intrallazzo. Ed è l’intrallazzo che rende la regolarità
sopportabile, perché è con l’intrallazzo che un parlamentare dimostra ai
suoi elettori più attivi che sta curando i loro interessi come essi li
concepiscono.
Di ciò il singolo parlamentare non ha colpa, a meno che non vi indulga
deliberatamente. Il parlamentare più capace e più industrioso non può
sperare di capire anche solo una frazione dei progetti di legge che è
chiamato a votare. La miglior cosa che può fare è specializzarsi su
qualcuno di essi, e per il resto ascoltare qualcun altro. Ho visto
parlamentari studiare, mentre si preparavano su un argomento, come non
avevano mai più studiato dopo aver superato gli ultimi esami scolastici,
con molte tazze di caffè nero, asciugamani bagnati e via dicendo.
Dovevano scovare i fatti, sudare per verificarli ed organizzarli, cosa che, in
un governo consapevolmente organizzato, avrebbe dovuto essere
facilmente accessibile in una forma atta a consentire di prendere decisioni.
E anche quando conoscevano davvero un argomento, le loro ansietà erano
appena all’inizio. Infatti nel collegio i direttori di giornale, la camera di
commercio, la centrale sindacale e i circoli femminili si erano risparmiati
queste fatiche, e si limitavano a guardare l’azione del parlamentare
attraverso una lente locale.
6.
Ciò che il favoritismo ha fatto per legare i maggiorenti politici al
governo nazionale, l’infinita varietà delle sovvenzioni e dei privilegi locali
lo fa per le comunità egocentriche. Il favoritismo e il denaro amalgamano
e stabilizzano migliaia di opinioni particolari, malcontenti locali,
ambizioni personali. Esistono due sole altre alternative. Una è il governo
del terrore e dell’obbedienza, l’altra è il governo fondato su un sistema
così sviluppato di informazioni ed analisi che «la conoscenza delle
condizioni nazionali e delle ragioni di stato» è evidente a tutti gli individui.
Il sistema autocratico è in decadenza, il sistema volontario è ancora nella
sua primissima fase di sviluppo; e così, nel calcolare le prospettive di
associazione tra grandi aggregati umani – una Società delle Nazioni, un
governo industriale o un’Unione federale di stati – la misura in cui esiste la
base di una coscienza comune determina fino a che punto la
collaborazione dipenderà dalla forza, o da quella più mite alternativa alla
forza che è il favoritismo e il privilegio. Il segreto dei grandi edificatori di
stati, come Alexander Hamilton, è che essi conoscono il modo di tener
215
conto di questi principi.
216
XIX.
La vecchia immagine in una forma nuova:
il socialismo corporativo
1.
Ogni volta che le dispute dei gruppi egocentrici stavano diventando
insopportabili, i riformatori del passato si sono trovati nella necessità di
scegliere tra due grandi alternative. Potevano prendere la strada di Roma, e
imporre una pace romana alle tribù in guerra. Potevano prendere la strada
dell’isolamento, dell’autonomia e dell’autosufficienza. Quasi sempre
sceglievano la strada che conoscevano meno bene. Se avevano provato la
micidiale monotonia dell’impero, erano portati a preferire sopra ogni altra
cosa la semplice libertà della loro comunità. Ma se avevano visto questa
semplice libertà dissipata in gelosie campanilistiche, desideravano
ardentemente lo spazioso ordine di un grande e potente stato.
In ogni caso la difficoltà fondamentale era la stessa. Se le decisioni
venivano decentrate, ben presto annegavano in un caos di opinioni locali.
Se venivano centralizzate, la politica dello stato veniva a basarsi sulle
opinioni di un piccolo ambiente sociale situato nella capitale. La forza era
comunque necessaria per difendere un diritto locale contro un altro, o per
imporre la legge e l’ordine alle comunità locali, o per opporsi al governo di
classe al centro, o per difendere l’intera società, centralizzata o
decentralizzata, contro la barbarie esterna.
La democrazia moderna e il sistema industriale nacquero entrambi in
un’epoca di reazione contro il re, il governo della corona e un regime di
stretti controlli economici. Nella sfera industriale questa reazione assunse
una forma di estremo decentramento, nota come l’individualismo del
laissez-faire. Ogni decisione economica doveva esser lasciata all’individuo
titolare della proprietà in questione. Dato che quasi tutto era posseduto da
qualcuno, c’era per ogni cosa qualcuno che l’amministrava. Era la
sovranità pluralistica portata all’estremo.
Era il governo dell’economia dal punto di vista di qualsiasi filosofia
economica, anche se lo si riteneva controllato da leggi immutabili di
economia politica che alla fine dovevano produrre l’armonia. Produsse
molte splendide cose, ma anche altre cose abbastanza sordide e terribili per
217
provocare controcorrenti. Una di queste fu il trust, che instaurò una specie
di pace romana nell’industria, e fuori di essa un imperialismo romano
predatorio. Il popolo si rivolse al parlamento per essere difeso. Invocò il
governo rappresentativo, fondato sull’immagine dell’agricoltore di paese,
per controllare le aziende semisovrane. La classe lavoratrice si affidò
all’organizzazione sindacale. Seguì un periodo di crescente
centralizzazione, e una specie di corsa agli armamenti. I trust si
associarono, i sindacati di mestiere si federarono e confluirono in un
movimento operaio, il sistema politico diventò più forte a Washington e
più debole negli stati, mentre i riformatori cercavano di fargli fare prove di
forza contro il padronato.
In questo periodo praticamente tutte le correnti socialiste, dalla sinistra
marxista al Nuovi Nazionalisti raccoltisi intorno a Theodore Roosevelt,
consideravano la centralizzazione come il primo stadio di un’evoluzione
che sarebbe sfociata nell’assorbimento di tutti i poteri economici
semisovrani da parte dello stato politico. L’evoluzione non ebbe mai
luogo, tranne per pochi mesi durante la guerra. L’esperienza però è basata,
e si è avuta una reazione contro lo stato onnivoro a favore di varie forme
nuove di pluralismo. Ma questa volta la società non doveva ritornare
all’individualismo atomistico dell’uomo economico di Adam Smith, e
dell’agricoltore di Thomas Jefferson, ma a una sorta di individualismo
molecolare di gruppi volontari.
Un aspetto interessante di queste oscillazioni teoriche è che ciascuna di
esse promette a turno un mondo in cui nessuno dovrà seguire Machiavelli
per sopravvivere. Si fondano tutte su una qualche forma di coercizione,
tutte esercitano la coercizione per conservarsi, e tutte alla fine vengono
scartate proprio a causa della coercizione. Tuttavia non accettano la
coercizione – sia questa la forza fisica o una posizione particolare, il
favoritismo o il privilegio – come parte del loro ideale. L’individualista
diceva che l’interesse personale illuminato avrebbe portato alla pace
interna ed esterna. Il socialista è certo che i moventi che portano
all’aggressività scompariranno. Il nuovo pluralista spera che
scompariranno1. La coercizione è l’irrazionale per quasi tutte le teorie
sociali, tranne quella di Machiavelli. La tentazione di ignorarla, in quanto
assurda, inesprimibile e incontrollabile, diventa soverchiante in ogni
individuo che cerca di razionalizzare la vita umana.
2.
Fino a che punto un uomo intelligente arrivi a volte a spingersi per
218
sfuggire al pieno riconoscimento del ruolo della forza si può ricavare dal
libro di Cole sul socialismo corporativo. Lo stato attuale, egli dice, «è
principalmente uno strumento di coercizione»1; in una società socialista
corporativa non ci sarà alcun potere sovrano, ma ci sarà un organo
coordinatore. Egli chiama quest’organo il Comune.
Elenca poi i criteri di quest’organo, che, ricordiamo, anzitutto non deve
essere uno strumento di coercizione2. Compone le vertenze sui prezzi. A
volte fissa i prezzi, dispone delle eccedenze o distribuisce le perdite.
Dispone delle risorse naturali, e controlla l’emissione del credito. Inoltre
«dispone delle forze di lavoro comunali». Ratifica i bilanci delle
corporazioni e dei servizi pubblici. Impone tasse. «Tutte le questioni
attinenti al reddito» ricadono sotto la sua giurisdizione. «Assegna» il
reddito ai membri non produttivi della collettività. È il giudice supremo di
tutti i conflitti di indirizzo e di giurisdizione che sorgano tra le
corporazioni. Approva leggi costituzionali che stabiliscono le funzioni
degli organi operativi. Nomina i giudici. Conferisce alle corporazioni
poteri coercitivi, e ratifica i loro regolamenti per le parti in cui comportano
la coercizione. Dichiara la guerra e stipula la pace. Controlla le forze
armate. È il rappresentante supremo della nazione all’estero. Decide sulle
questioni di delimitazione territoriale all’interno dello stato nazionale.
Istituisce nuovi organi operativi, o distribuisce nuove funzioni ai vecchi. È
a capo della polizia, stabilisce le leggi necessarie a disciplinare la condotta
personale e la proprietà personale.
Questi poteri vengono esercitati non da un solo comune, ma da una
struttura federativa di comuni provinciali e locali, con un Comune
nazionale al vertice. Naturalmente Cole può sostenere che questo non è
uno stato sovrano, ma se esiste un potere coercitivo dello stato moderno,
che egli abbia escluso dal suo elenco, vorrei sapere qual è.
Egli ci dice, tuttavia, che la società corporativa sarà non-coercitiva:
«Noi vogliamo edificare una nuova società che sarà concepita nello spirito
non della coercizione, ma del libero servizio»3. Tutti quelli che
condividono questa speranza, cioè la maggior parte degli uomini e delle
donne, esamineranno perciò con cura il piano socialista corporativo per
capire che cosa vi sia che prometta di ridurre la coercizione ai minimi
termini, anche se i corporativisti d’oggi hanno già riservato ai loro comuni
i più ampi poteri coercitivi. Ammettiamo subito che la nuova società non
può essere instaurata con il consenso universale. Cole è troppo onesto per
eludere la questione della forza necessaria per effettuare la transizione4. E
pur non potendo ovviamente predire quanta guerra civile potrebbe esserci,
dice chiaramente che dovrebbe esserci un periodo di azione diretta da parte
219
dei sindacati.
3.
Ma lasciando da parte i problemi della transizione, e la questione del
suo possibile effetto sulla loro azione futura, una volta che gli uomini si
siano aperti il varco verso la terra promessa, cerchiamo di immaginarci la
società corporativa in atto. Cos’è che la fa funzionare come una società
non-coercitiva?
Cole ha due risposte per questa domanda. Una è la risposta marxista
ortodossa, secondo cui l’abolizione della proprietà capitalistica eliminerà
l’impulso all’aggressività. Tuttavia non ci crede davvero neanche lui,
perché se lo credesse non si preoccuperebbe, più di quanto si preoccupi il
marxista medio, del modo in cui la classe lavoratrice debba governare, una
volta arrivata al potere. Se la sua diagnosi fosse giusta, il marxista avrebbe
assolutamente ragione: se il male fosse la classe capitalista e solo la classe
capitalista, la salvezza seguirebbe automaticamente alla sua estinzione. Ma
Cole si preoccupa enormemente del problema se la società successiva alla
rivoluzione debba essere governata dal collettivismo di stato, dalle
corporazioni o dalle cooperative, da un parlamento democratico o dalla
rappresentanza delle categorie. In realtà, è proprio come una nuova teoria
del governo rappresentativo che il socialismo corporativo attira
l’attenzione.
I corporativisti non s’aspettano che la scomparsa dei diritti proprietari
capitalisti produca come risultato un miracolo. Essi pensano, e
naturalmente a ragione, che i rapporti sociali, se la regola fosse
l’eguaglianza dei redditi, risulterebbero profondamente modificati. Ma, per
quanto posso capire, essi differiscono dal comunista russo ortodosso in
questo: il comunista propone di instaurare l’eguaglianza con la forza della
dittatura del proletariato, nella convinzione che una volta che gli individui
venissero parificati nel reddito e nei servizi, verrebbero meno gli incentivi
all’aggressività. I corporativisti propongono anche loro di instaurare
l’eguaglianza con la forza, ma sono abbastanza avveduti per capire che
allo scopo di consentire un equilibrio è necessario approntare istituzioni
adatte. Perciò i corporativisti si affidano a quella che ritengono una nuova
teoria della democrazia.
Il loro obiettivo, dice Cole, «è di indovinare il meccanismo giusto, e di
adattarlo per quanto possibile all’espressione delle volontà sociali
dell’individuo»1. A queste volontà è necessario dare la possibilità
dell’autoaffermazione nell’autogoverno «in tutte le forme possibili di
220
azione sociale». Dietro queste parole c’è il vero impulso democratico, il
desiderio di esaltare la dignità umana, nonché il tradizionale postulato
secondo cui questa dignità umana viene contraddetta se la volontà del
singolo individuo non entra nell’amministrazione di tutto ciò che lo
riguarda. Perciò il corporativismo, come il democratico delle origini, cerca
un ambiente in cui questo ideale dell’autogoverno possa realizzarsi. Sono
passati più di cento anni dai tempi di Rousseau e Jefferson, e il centro
dell’interesse si è spostato dalla campagna alla città. Il nuovo democratico
non può più cercare l’immagine della democrazia nella comunità rurale
idealizzata. Si rivolge ora all’officina.
Si deve dare libero gioco allo spirito di associazione nella sfera in cui riesce
meglio ad esprimersi. Questa sfera è evidentemente la fabbrica, nella quale gli
individui hanno l’abitudine e la tradizione di lavorare insieme. La fabbrica è l’unità
naturale e fondamentale della democrazia industriale. Ciò implica non solo che la
fabbrica deve essere libera, per quanto è possibile, di amministrare i propri affari,
ma anche che l’unità democratica della fabbrica deve diventare la base della più
vasta democrazia della corporazione, e che gli organi dell’amministrazione del
governo corporativo debbono fondarsi largamente sul principio della rappresentanza
di fabbrica2.
Fabbrica è, naturalmente, una parola molto generica. E Cole ci invita a
comprendervi anche le miniere, i cantieri navali, le attrezzature portuali, le
stazioni e tutti i luoghi che sono «centri naturali di produzione»3. Ma una
fabbrica intesa in questo senso è una cosa del tutto diversa da un’industria.
La fabbrica, come la concepisce Cole, è un luogo di lavoro in cui gli
uomini hanno realmente contatti personali, un ambiente abbastanza
piccolo per poter essere direttamente conosciuto da tutti i lavoratori. «Se
dev’essere reale, questa democrazia deve toccare ogni singolo membro
della corporazione, ed essere direttamente esercitabile da lui»4. Questo è
importante, perché Cole, come Jefferson, cerca un’unità naturale di
governo. La sola unità naturale è un ambiente perfettamente familiare. Ma
un grande stabilimento, un sistema ferroviario, un grande giacimento di
carbone non sono in questo senso unità naturali. Se non è davvero una
piccolissima fabbrica, quello a cui Cole in realtà pensava è l’officina. È qui
che si può immaginare che gli individui abbiano «l’abitudine e la
tradizione di lavorare insieme». Il resto dello stabilimento, il resto
dell’industria è un ambiente inferito.
4.
221
Chiunque è in grado di rendersi conto, e quasi tutti ammettono, che
l’autogoverno negli affari puramente interni dell’officina è governo di
affari che possono essere afferrati d’un sol colpo1. Meno facile è
accordarsi su quali siano gli affari interni di un’officina. Ovviamente gli
interessi più grossi, come i salari, le norme di produzione, l’acquisto di
materiale, la vendita del prodotto, la pianificazione generale del lavoro,
non sono affatto puramente interni. La democrazia di officina ha una
libertà che soggiace a enormi condizioni limitative esterne. Può
organizzare in una certa misura il lavoro assegnato all’officina, può tener
presente l’umore e il temperamento degli individui, può amministrare una
giustizia industriale spicciola, e servire da tribunale di prima istanza nelle
dispute individuali un po’ più importanti. Soprattutto può operare come
un’unità nei suoi rapporti con altre officine, e forse con lo stabilimento nel
suo insieme. Ma l’isolamento è impossibile. L’unità della democrazia
industriale è del tutto coinvolta negli affari esterni. Ed è la condotta di
queste relazioni esterne che costituisce il test della teoria socialista
corporativa.
Debbono essere amministrate attraverso un governo rappresentativo
ordinato in una federazione che va dall’officina allo stabilimento, dallo
stabilimento al settore industriale, dal settore industriale alla nazione, con
raggruppamenti regionali intermedi di rappresentanti. Ma tutta questa
struttura deriva dell’officina, e tutte le sue peculiari virtù vengono ascritte
a questa origine. I rappresentanti che scelgono i rappresentanti che
finalmente «coordinano e controllano» le officine vengono eletti, afferma
Cole, da una vera democrazia. Dal momento che provengono in origine da
un’unità che si autogoverna, l’intero organismo federale sarà pervaso dallo
spirito e dalla realtà dell’autogoverno. I rappresentanti mireranno ad
attuare la «vera volontà (dei lavoratori) come la intendono loro»2, cioè
come la intendono gli individui nelle officine.
Un governo condotto letteralmente secondo questo principio sarebbe,
se la storia può insegnarci qualcosa, o un intrallazzo perpetuo, o un caos di
officine in guerra tra loro. Infatti, mentre il lavoratore dell’officina può
avere una vera opinione su cose che si svolgono totalmente entro di essa,
la sua «volontà» circa il rapporto tra l’officina e lo stabilimento, il settore
industriale e la nazione è soggetta a tutte le limitazioni di accesso,
stereotipo ed egoismo che racchiudono qualsiasi altra opinione
egocentrica. Nella migliore delle ipotesi, la sua esperienza dell’officina è
in grado di portare alla sua attenzione solo qualche aspetto dell’insieme.
Può raggiungere una sua opinione su ciò che è giusto all’interno
dell’officina grazie ad una conoscenza diretta dei fatti essenziali. La sua
222
opinione su ciò che è giusto nel grande, complicato ambiente che esce dal
suo campo visuale è più facilmente sbagliata che giusta, se è una
generalizzazione tratta dall’esperienza della singola officina. Sul piano
dell’esperienza, i rappresentanti di una società corporativa scoprirebbero,
proprio come scoprono oggi i massimi dirigenti sindacali, che per un gran
numero di questioni su cui essi debbono decidere non esiste alcuna «vera
volontà come la intendono» le officine.
5.
Tuttavia i corporativisti sostengono che questa critica è cieca perché
trascura una grande scoperta politica. Si può aver ragione, direbbero, si
pensare che i rappresentanti delle officine dovrebbero decidere da soli su
molte questioni su cui le officine non hanno alcuna opinione. Ma in questo
modo non si fa che impigliarsi in un antico errore: si sta cercando uno che
rappresenti un gruppo. Non è possibile trovarlo. Il solo rappresentante
possibile è colui che agisce per «una particolare funzione»1, e perciò ogni
persona deve concorrere a scegliere tanti rappresentanti «quanti sono i
gruppi essenziali di funzioni da svolgere».
Immaginiamo allora che i rappresentanti parlino, non per gli individui
delle officine, ma in nome di certe funzioni a cui questi individui sono
interessati. Essi, è bene tenerlo presente, sono sleali se non attuano la
volontà del gruppo a proposito della funzione, così come l’intende il
gruppo2. Questi rappresentanti funzionali si riuniscono. Il loro compito è di
coordinare e disciplinare. Con quale criterio ciascuno giudicherà le
proposte dell’altro, se presumiamo, come dobbiamo presumere, che esista
un conflitto di opinioni tra le officine, dato che se non ci fosse non ci
sarebbe alcuna necessità di coordinare e disciplinare?
Senonché si sostiene che la virtù peculiare della democrazia funzionale
sia il fatto che gli uomini votino francamente secondo i propri interessi,
che si suppone conoscano per quotidiana esperienza. Essi possono farlo
all’interno del gruppo autosufficiente. Ma nelle sue relazioni esterne il
gruppo nel suo complesso, o il suo rappresentante, affronta questioni che
trascendono l’esperienza immediata. L’officina non arriva spontaneamente
a una visione della situazione complessiva. Perciò le opinioni pubbliche di
un’officina sui propri doveri e diritti nell’industria e nella società sono una
questione di educazione e di propaganda, non il prodotto automatico della
coscienza di officina. Eleggano un delegato, ovvero un rappresentante, i
corporativisti non sfuggono al problema del democratico ortodosso. O il
gruppo nel suo insieme o il portavoce eletto, devono allargare la mente al
223
di là dei limiti dell’esperienza diretta. Devono votare su questioni
provenienti da altre officine, e su problemi che hanno origine al di là delle
frontiere dell’industria nel suo insieme. L’interesse primario dell’officina
non si estende nemmeno alla funzione di una specializzazione industriale.
La funzione di una specializzazione, una grande industria, un distretto, una
nazione, sono concetti, non esperienze, e non debbono essere immaginati,
inventati, insegnati e creduti. E anche quando si sia definita la funzione
con la maggior cura possibile, una volta che si ammette che l’opinone di
un’officina su questa funzione non coinciderà necessariamente con
l’opinione di altre officine, si sta dicendo in sostanza che il rappresentante
di un interesse è coinvolto nelle proposte fatte da altri interessi. Si sta
dicendo che egli deve concepire un interesse comune. E nel votare per lui
si sceglie un individuo che non rappresenterà le opinioni che si hanno delle
opinioni di altri a proposito di questa funzione. Si vota in modo indefinito,
proprio come il democratico ortodosso.
6.
Nella loro mente i corporativisti hanno risolto la questione del modo di
concepire un interesse comune giocando sulla parola funzione.
Immaginano una società in cui il lavoro più importante sia stato analizzato
e ridotto a funzioni, e queste funzioni a loro volta siano state sintetizzate
armoniosamente1. Presuppongono un accordo fondamentale circa i fini
della società nel suo complesso, e un accordo essenziale circa il ruolo di
ciascun gruppo organizzato nel perseguimento di questi fini. È stato quindi
un nobile sentimento quello che li ha indotti a trarre il nome della loro
teoria da un’istituzione sorta nella società feudale cattolica. Ma dovrebbero
ricordare che l’ordine di funzioni che i saggi di quell’epoca postulavano
non era costruito da mortali. Non è chiaro come i corporativisti pensino
che quest’ordine possa esser costruito e reso accettabile nel mondo
moderno. A volte sembrano sostenere che l’ordine si svilupperà dalle
organizzazioni sindacali, altre volte che i comuni definiranno la funzione
costituzionale dei gruppi. Ma sul piano pratico fa una grande differenza
che essi credano o meno che i gruppi definiscano le proprie funzioni.
Nell’uno e nell’altro caso Cole presume che la società possa essere
portata avanti da un contratto sociale fondato sull’idea comune di «gruppi
fondamentali di funzioni». Come si fa a riconoscere questi gruppi
fondamentali? Per quanto posso capire, Cole ritiene che la funzione sia ciò
a cui si interessa un gruppo di persone. «L’essenza della democrazia
funzionale è che un individuo deve contare tante volte quante sono le
224
funzioni a cui è interessato»2. Però ci sono almeno due significati nella
parola «interessato». Si può usarla per intendere che un individuo è
coinvolto, o che la sua mente è occupata. John Smith, ad esempio, può
aver provato un enorme interesse per il caso di divorzio Stillman. Forse ha
letto ogni parola che sia stata scritta al riguardo dai giornali. Invece il
giovane Guy Stillman, della cui legittimità si discuteva, non si
preoccupava affatto. John Smith si interessava di un processo che non
toccava i suoi «interessi»; e Guy non si interessava di un processo che
avrebbe determinato l’intero corso della sua vita. Cole, temo, tende verso
John Smith. Così risponde alla «sciocchissima obiezione» che per votare
per funzioni si deve votare molto spesso: «Se un individuo non prova
abbastanza interesse per votare, e se non c’è modo di destare in lui un
interesse sufficiente a spingerlo a votare su, poniamo, una dozzina di
materie diverse, egli rinuncia al suo diritto di voto e il risultato non è meno
democratico che se votasse ciecamente e senza interesse».
Cole pensa che l’elettore impreparato «rinuncia al suo diritto al voto».
Da ciò deriva che i voti dei preparati rivelano il loro interesse, e il loro
interesse definisce la funzione3. «Brown, Jones e Robinson debbono avere
perciò non un voto ciascuno, ma tanti distinti voti funzionali quante sono
le distinte questioni, richiedenti un’azione associata, alle quali sono
interessati»4. Resto in gran dubbio se Cole ritenga che Brown, Jones e
Robinson debbono aver diritto di votare ad ogni elezione in cui affermano
di essere interessati, oppure che qualcun altro, non specificato, sceglie le
funzioni a cui essi hanno il diritto di essere interessati. Se mi si chiedesse
di dire che cosa, secondo me, pensa Cole, sosterrei che ha scavalcato la
difficoltà grazie al sottinteso stranissimo che sia l’elettore impreparato a
rinunciare al suo diritto al voto; e arrivando alla conclusione che se la
votazione funzionale è organizzata da un potere superiore, o «dal basso» in
base al principio che un individuo può votare quando gli interessa votare,
solo il preparato voterà in ogni caso, e quindi l’istituzione funzionerà.
Ma ci sono due specie di elettore impreparato. C’è colui che non sa e sa
di non sapere. In genere è una persona illuminata. È lui l’individuo che
rinuncia al suo diritto al voto. Ma c’è anche colui che è impreparato e non
sa di esserlo, né gli importa. Può sempre essere portato alle urne, se
l’organizzazione di partito funziona bene. Il suo voto è la base della
macchina. E dato che i comuni della società corporativa hanno ampi poteri
in materia di tassazione, salari, prezzi, credito e risorse naturali, sarebbe
assurdo pensare che le elezioni non verrebbero combattute perlomeno con
la stessa passione delle nostre.
Il modo in cui gli individui manifestano il loro interesse non delimiterà
225
quindi le funzioni di una società funzionale. La funzione potrebbe essere
definita in almeno due altri modi. O dai sindacati che abbiano combattuto
la battaglia per creare il socialismo corporativo. Una tale lotta
coagulerebbe dei gruppi di persone in una qualche specie di rapporto
funzionale, e questi gruppi diventerebbero allora gli interessi costituiti
della società socialista corporativa. Alcuni di loro, come i minatori e i
ferrovieri, sarebbero fortissimi e con ogni probabilità sarebbero
profondamente attaccati alla visione della loro funzione appresa durante la
battaglia con il capitalismo. Non è affatto improbabile che certi sindacati
situati in posizioni strategiche diventerebbero in uno stato socialista il
centro dell’unità e del governo. Ma una società corporativa faticherebbe
inevitabilmente a tenerli al loro posto, perché l’azione diretta gli avrebbe
fatto capire qual è il loro potere strategico, e perlomeno alcuni dei loro
capi non sarebbero tanto disposti a immolare questo potere sull’altare della
libertà. Per «coordinarli», la società corporativa dovrebbe radunare le sue
forze, e ben presto si scoprirebbe, secondo me, che la sinistra, nel regime
corporativo, chiederebbe comuni abbastanza forti per delimitare le
funzioni delle corporazioni.
Ma se si arriva al punto in cui dev’essere il governo (comune) a
delimitare la funzione, le basi della teoria scompaiono. Perché le officine
autosufficienti si mettessero volontariamente in rapporto con la società, la
teoria aveva dovuto immaginare che l’ordine delle funzioni fosse ovvio. Se
non c’è un ordine fisso di funzioni nella mente di ciascun elettore, questi in
un regime di socialismo corporativo non è in grado di trasformare
un’opinione egocentrica in un giudizio sociale meglio di quanto possa fare
nella democrazia ortodossa. E naturalmente non può esserci un tale ordine
fisso, perché, anche se Cole e i suoi amici ne escogitassero uno buono, le
democrazie di officina, da cui deriva tutto il potere, giudicherebbero
l’ordine in atto secondo quel che ne vengono a sapere e secondo quel che
possono immaginare. Le corporazioni lo vedrebbero in modo diverso. E
così invece di avere una situazione in cui l’ordine sarebbe lo scheletro che
tiene insieme la società corporativa, anche in questo regime, come negli
altri, la principale questione politica sarebbe quella di definire ciò che
l’ordine debba essere. Se potessimo concedere a Cole il suo ordine di
funzioni, potremmo concedergli quasi tutto. Purtroppo ha inserito nei suoi
presupposti proprio ciò a cui la società corporativa dovrebbe portare5.
226
XX.
Una nuova immagine
1.
Mi sembra che la lezione sia piuttosto chiara. In mancanza di istituzioni
e di un’istruzione, grazie alle quali l’ambiente venga rappresentato tanto
bene che le realtà della vita pubblica si staglino nettamente contro
l’opinione egocentrica, gran parte degli interessi comuni sfuggono
completamente all’opinione pubblica e possono essere amministrati
soltanto da una classe specializzata i cui interessi personali oltrepassino
l’ambito della comunità locale. Questa classe è irresponsabile, perché
agisce sulla base di informazioni che non sono di dominio pubblico, in
situazioni che il pubblico in genere non si immagina, e può essere
chiamata al rendiconto solo a fatto compiuto.
Poiché non ammette che le opinioni egocentriche non bastano a
procurare il buon governo, la posizione democratica si trova in perpetuo
conflitto tra la teoria e la pratica. Secondo la teoria, la piena dignità
dell’individuo richiede che la sua volontà, come dice Cole, debba
esprimersi «in tutte le forme possibili dell’azione sociale». Si suppone che
l’espressione della propria volontà costituisca l’ardente passione degli
individui, perché si presume che essi possiedano per istinto l’arte di
governare. Ma la comune esperienza insegna che l’autodeterminazione è
solo uno dei molti interessi della personalità umana. Il desiderio di essere
padroni del proprio destino è un forte desiderio, ma deve adattarsi ad altri
desideri egualmente forti, quale il desiderio di una vita comoda, della pace,
di liberarsi dai problemi. Nelle teorie originarie della democrazia si
sosteneva che l’espressione della volontà di ciascun individuo avrebbe
spontaneamente
soddisfatto
non
solo
la
sua
aspirazione
all’autoaffermazione, ma anche il desiderio di una vita comoda, perché
l’istinto di esprimersi in una vita comoda era innato.
Perciò si è sempre insistito sul meccanismo per esprimere la volontà.
L’Eldorado democratico è sempre stato un ambiente perfetto, e un perfetto
sistema di votazione e di rappresentanza, in cui l’innata buona volontà e
l’istintiva arte di governo di ciascun individuo avrebbero potuto tradursi in
azione. In zone circoscritte e per brevi periodi l’ambiente è stato così
227
favorevole – ossia così isolato – e così ricco di possibilità che la teoria ha
potuto funzionare abbastanza bene per confermare gli individui nel
pensiero che fosse buona per tutti i tempi e per tutti i luoghi. Poi, quando
l’isolamento è cessato, e la società è diventata complessa, e gli uomini
hanno dovuto adattarsi reciprocamente gli uni agli altri con la massima
cura, il democratico ha cominciato a dedicarsi all’impresa di escogitare
sistemi elettorali più perfetti, nella speranza, come dice Cole, di poter in
qualche modo «azzeccare il meccanismo giusto, e adattarlo per quanto
possibile alle volontà sociali degli individui». Ma occupandosi di questo, il
teorico della democrazia era assai lontano dagli effettivi interessi della
natura umana. Un solo interesse lo assorbiva: l’autogoverno. Gli uomini
invece si interessavano di tutt’altre cose, dell’ordine, dei loro diritti, della
prosperità, della vita intorno a loro, e non volevano annoiarsi. Nella misura
in cui non soddisfa gli altri loro interessi, la democrazia spontanea appare
quasi sempre alla maggior parte degli uomini una cosa vuota. Poiché l’arte
del buon autogoverno non è istintiva, gli uomini non ambiscono alla lunga
all’autogoverno per se stesso. Lo desiderano per i risultati. Ecco perché
l’impulso all’autogoverno raggiunge sempre il suo culmine nella protesta
contro insoddisfacenti condizioni di vita. L’errore dei democratici è stato
quello di preoccuparsi dell’origine del governo piuttosto che delle
procedure e dei risultati. Il democratico ha sempre dato per scontato che il
potere politico, se si fosse riusciti a derivarlo nel modo giusto, sarebbe
stato benefico. Ha rivolto tutta la sua attenzione alla fonte del potere, dato
che è ipnotizzato dalla convinzione che la cosa importante è esprimere la
volontà del popolo, anzitutto perché l’espressione è l’interesse più alto
dell’uomo, e in secondo luogo perché la volontà è istintivamente buona.
Ma nessun controllo di un fiume alla sorgente potrà regolare
completamente il suo corso, e i democratici, lasciandosi assorbire dal
tentativo di trovare un buon meccanismo generatore del potere sociale,
cioè un buon meccanismo di elezione e rappresentanza, hanno trascurato
quasi tutti gli altri interessi dell’uomo. Infatti non importa che sorga il
potere, perché l’interesse cruciale sta nel modo in cui il potere viene
esercitato. Ciò che determina il tono della civiltà è l’uso che si fa del
potere. E quest’uso non può essere controllato alla fonte.
Se si cerca di controllare completamente il governo alla fonte,
inevitabilmente si rendono invisibili tutte le decisioni fondamentali. Infatti,
dato che non esiste alcun istinto il quale generi automaticamente decisioni
politiche che producano una vita comoda, gli individui che effettivamente
esercitano il potere non solo non esprimono la volontà del popolo, giacché
su moltissime questioni non esiste alcuna volontà, ma esercitano il potere
228
secondo opinioni che restano celate all’elettorato.
Se allora si estirpa dalla filosofia democratica tutta la premessa, in tutte
le sue ramificazioni, secondo cui il governo è istintivo, e perciò può essere
amministrato secondo opinioni egocentriche, che cosa succede della fede
democratica nella dignità dell’uomo? Riprende vitalità solo se la si
ricollega alla personalità intera, invece che a un misero aspetto di essa. In
realtà il democratico tradizionale fondava, con qualche azzardo, la dignità
dell’uomo su un solo assunto assai precario, e cioè sul concetto che
quest’ultimo avrebbe manifestato istintivamente questa dignità sotto forma
di leggi savie e di buon governo. Ma gli elettori non l’hanno manifestata, e
così fatalmente il democratico è stato fatto apparire un po’ sciocco dai duri
realisti. Ma se invece di far dipendere la dignità umana da quel solo
postulato dell’autogoverno, si sostiene che la dignità dell’individuo
richiede un tenore di vita in cui le sue capacità abbiano adeguate
possibilità di venir esercitate, il problema cambia completamente. I criteri
di giudizio che in questo caso si applicano al governo diventano altri: si
cerca di verificare cioè se esso assicura un minimo livello sanitario, un
minimo di alloggi decorosi, un minimo di cibo e vestiario, di istruzione, di
libertà, di divertimenti, di bellezza, oppure se, sacrificando tutte queste
cose, si limita a vibrare alle opinioni egocentriche che si trovano a vagare
nelle menti degli individui. Nella misura in cui questi criteri possono esser
resi esatti e oggettivi, la decisione politica, che inevitabilmente spetta a
relativamente poche persone, viene davvero messa in rapporto agli
interessi degli individui.
Non esiste alcuna prospettiva che in un futuro prevedibile l’ambiente
invisibile diventi tutto così chiaro agli individui da consentirgli di arrivare
spontaneamente a opinioni pubbliche sensate su tutto ciò che riguarda il
governo. E anche se ci fosse una tale prospettiva, è estremamente dubbio
che molti di noi vorrebbero dedicare del tempo o prendersi la briga di
formarsi un’opinione su «tutte le forme di azione sociale» che ci
riguardano. La sola prospettiva non visionaria è che ognuno di noi, nella
sua sfera, agirà sempre più in base a un quadro realistico del mondo
invisibile, e che avremo un numero sempre maggiore di individui esperti
nel mantenere realistiche queste immagini. Fuori del raggio piuttosto
ristretto della nostra possibile attenzione, il controllo sociale dipende
dall’invenzione di condizioni di vita e di metodi di verifica con cui
misurare le azioni delle autorità pubbliche e dei dirigenti industriali. Non
possiamo noi stessi ispirare o guidare tutte queste azioni, come il
democratico mistico si è sempre figurato. Ma possiamo regolarmente
accrescere il nostro controllo effettivo su queste azioni, pretendendo che
229
debbano essere tutte chiaramente documentate, e che i loro risultati
vengano tutti obiettivamente misurati. Dovrei dire forse che possiamo
progressivamente sperare di pretendere. Infatti lo sviluppo di queste
condizioni di vita e di queste verifiche è appena cominciato.
A. B. Hart, nella nota introduttiva a Lowell, Public Opinion and Popular
Government cit.
1 Il federalista, a cura di M. D’Addio e G. Negri, trad. di B. M. Tedeschini Lalli, il
Mulino, Bologna 1980, nn. 35 e 36, p. 267. Cfr. il commento di Henry Jones Ford nel
suo Rise and Growth of American Politics. A Sketch of Constitutional Development,
Macmillan, New York 1898, cap. V.
2 Si veda più avanti, p. 241.
1 Politica, l. VII, cap. IV, trad. it. cit., pp. 231-2.
1 Hobbes, Leviatano cit., cap. XIII. «Della condizione naturale dell’umanità per
quanto concerne la sua felicità e la sua miseria», trad. it. cit., p. 122.
1 F. S. Oliver, nel suo Alexander Hamilton, G. P. Putnam’s sons, New York 1920,
così dice di Machiavelli (p. 174): «Presumendo che le condizioni esistenti – la natura
dell’uomo e delle cose – siano immutabili, procede in modo calmo e amorale, come un
conferenziere che parli di rane, a dimostrare come un governante valoroso e sagace
possa volgere nel migliore dei modi gli avvenimenti a proprio vantaggio e a vantaggio
della sicurezza della sua dinastia».
7
2 Il principe, Einaudi, Torino 1972 , pp. 87-8, cap. XVIII: «Quomodo fides a principus
sit servanda».
1 «Le democrazie hanno sempre offerto spettacolo di turbolenza e di dissidi […] e
hanno vissuto una vita che è stata tanto breve, quanto violenta ne è stata la morte».
Madison, in Il federalista, n. 10 (trad. it. cit., p. 93).
2 La democrazia in America, a cura di G. Candeloro, Rizzoli, Milano 1982, I, p. 66.
3 Citato da Beard nel suo Economic Origins of Jeffersonian Democracy cit., cap. XIV.
4 Ibid., p. 426.
1 Cfr. Aristotele, Politica, l. VII, cap. IV.
2 Fisher Ames, terrorizzato dalla rivoluzione democratica del 1800, scrisse nel 1802
a Rufus King: «Noi abbiamo bisogno, come tutte le nazioni, di avere sul perimetro del
nostro territorio la pressione di un vicino formidabile, la cui presenza possa in ogni
momento suscitare timori più forti di quelli che i demagoghi possono ispirare al popolo
nei confronti del loro governo». Citato da Ford, Rise and Growth of American Politics
cit., p. 69.
1 Il federalista, n. 15 (trad. it. cit., p. 134).
2 Ford, Rise and Growth cit., p. 36.
3 Il federalista, n. 15.
4 Il federalista, n. 51, citato da Ford, Rise and Growth cit., p. 60.
5 Ibid.
6 Il federalista, n. 15.
7 Ford, Rise and Growth cit., p. 119.
1 Ibid., p. 144.
2 Ibid., p. 47.
1
230
Beard, Economic Interpretation of the Constitution, passim.
4 Ibid., p. 325.
1 Tocqueville, La democrazia in America cit., p. 266.
2 Cfr. il suo piano per la Costituzione della Virginia, le sue idee di un Senato di
proprietari, e le sue opinioni sul veto della magistratura. Beard, Economic Origins of
Jeffersonian Democracy cit., pp. 450 sgg.
3 Il lettore che abbia qualche dubbio sulla portata della rivoluzione che separava le
opinioni di Hamilton dalla prassi di Jackson dovrebbe vedere il citato Rise and Growth
of American Politics di Henry Jones Ford.
1 Ibid., p. 169.
1 Cfr. G. D. H. Cole, Social Theory, F. A. Stokes, New York 1920, p. 142.
1 Id., Guild Socialism, F. A. Stokes, New York 1921, p. 107.
2 Ibid., cap. VIII.
3 Ibid., p. 141.
4 Ibid., cap. X.
1 Ibid., p. 16.
2 Ibid., p. 40.
3 Ibid., p. 41.
4 Ibid., p. 40.
1 Aristotele, Politica, l. VII, cap. IV.
2 Cole, Guild Socialism cit., p. 42.
1 Ibid., pp. 23-4.
2 Cfr. parte V, «La formazione di una volontà comune».
1 Cole, Guild Socialism cit., cap. XIX.
2 Id., Social Theory cit., pp. 102 sgg.
3 Cfr. il cap. XVIII di questo libro. «Siccome si riteneva che tutti fossero abbastanza
interessati agli affari importanti, finirono per sembrare importanti solo quegli affari per
cui tutti provavano interesse».
4 Cole, Guild Socialism cit., p. 24.
5 Mi sono occupato della teoria di Cole piuttosto che dell’esperienza della Russia
sovietica perché, pur esistendo solo testimonianze frammentarie, tutti gli osservatori
competenti sembrano convenire che la Russia del 1921 non è un esempio di stato
comunista in pieno funzionamento. La Russia è ancora in rivoluzione, ed essa può
insegnare soltanto com’è fatta una rivoluzione. Si può apprendere ben poco su come
sarebbe una società comunista. Tuttavia è straordinariamente significativo che i
comunisti russi, prima come rivoluzionari e poi come esponenti pubblici, si siano
affidati non alla democrazia spontanea del popolo russo, ma alla disciplina, all’interesse
particolare e al senso di responsabilità di una classe specializzata: i fedeli e indottrinati
membri del partito comunista. Nel periodo di «transizione», al quale, mi pare, non è
stato posto alcun limite, la cura applicata al governo di classe e allo stato coercitivo è
rigorosamente omeopatica. Ci si può anche chiedere perché ho scelto i libri di Cole
piuttosto che l’assai più rigoroso Constitution for the Socialist Commonwealth of Great
Britain di Sidney e Beatrice Webb, Longmans, Green, and Co., London-New York
1920. Ammiro moltissimo questo libro; ma non sono riuscito a convincermi che sia
qualcosa di diverso da un tour de force intellettuale. Cole mi sembra assai più
autenticamente nello spirito del movimento socialista, e perciò un miglior testimone.
3
231
VII.
I giornali
232
XXI.
Il pubblico come consumatore
1.
L’idea che gli uomini debbano andare a studiare il mondo per poterlo
governare ha giocato una parte assai marginale nel pensiero politico. Non
ha avuto molto spazio, perché i sistemi per informare sul mondo in modo
utile al governare hanno fatto relativamente pochi progressi dal tempo di
Aristotele all’epoca in cui sono state gettate le basi della democrazia.
Perciò se si fosse chiesto a un democratico degli inizi da dove dovesse
venire l’informazione su cui avrebbe dovuto basarsi la volontà del popolo,
la domanda lo avrebbe messo in imbarazzo. Sarebbe stato un po’ come
chiedergli da dove venissero la sua vita o la sua anima. La volontà del
popolo – egli avrebbe per lo più sostenuto – esiste sempre; il compito della
scienza politica era di elaborare le invenzioni della consultazione elettorale
e del governo rappresentativo. Se venivano elaborate bene e applicate nelle
condizioni giuste, come quelle che esistono nel villaggio autosufficiente o
nell’officina autosufficiente, il meccanismo avrebbe in qualche modo
superato l’ostacolo, osservato da Aristotele, della brevità dell’attenzione, e
anche quello della ristrettezza del suo raggio, che la teoria della comunità
autosufficiente tacitamente riconosceva. Abbiamo visto come persino
adesso i socialisti corporativi siano stati trafitti dall’idea che una
confederazione cooperativa complicata è possibile purché la si costruisca
sulla base della giusta unità elettorale e di rappresentanza.
I democratici, convinti che la saggezza attendeva solo di essere
scoperta, hanno trattato il problema della formazione delle opinioni
pubbliche come un problema di diritti civili1. «Chi mai ha visto la Verità
soccombere in uno scontro libero e aperto?»2. Ammettendo che nessuno
l’abbia mai vista soccombere, dobbiamo credere allora che la verità sia
generata dallo scontro, come il fuoco dall’attrito di due bacchette? Dietro
questa dottrina classica della libertà, che i democratici americani
realizzarono nel loro Bill of Rights, ci sono, in realtà, diverse teorie
sull’origine della verità. Una è la fede che, nella competizione delle
opinioni, la più vera vincerà perché c’è una forza peculiare nella verità. È
una tesi probabilmente ben fondata se si permette che la competizione si
233
protragga per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Chi sostiene
questa posizione di solito ha in mente il verdetto della storia, e in
particolare pensa agli eretici perseguitati in vita e canonizzati dopo morti.
La domanda di Milton poggia anche sulla convinzione che la capacità di
riconoscere la verità sia innata in tutti gli individui, e che la verità messa
liberamente in circolazione conquisterà il consenso generale. Essa deriva
anche dall’esperienza, la quale ha dimostrato che gli individui hanno
poche probabilità di scoprire la verità se non possono dirla che sotto gli
occhi di un poliziotto poco comprensivo.
Non è possibile sopravvalutare il valore pratico di questi diritti civili,
né l’importanza di difenderli. Quando sono in pericolo, è in pericolo lo
spirito umano, e nel caso che venga il momento in cui debbono venir
limitati, come durante la guerra, la soppressione del pensiero è per la
civiltà un rischio che potrebbe impedirle di riaversi dalle conseguenze
della guerra, se gli isterici, che sfruttano lo stato di necessità, fossero
abbastanza numerosi per riuscire a far perdurare in tempo di pace i tabù
della guerra. Fortunatamente la massa degli uomini è troppo tollerante per
compiacersi a lungo degli inquisitori professionali, i quali, un po’ alla
volta, sotto il fuoco delle critiche di uomini non disposti a farsi
terrorizzare, si rivelano meschine creature che per nove decimi di tempo
non sanno di che cosa stanno parlando3.
Ma ad onta della sua fondamentale importanza, il diritto civile in
questo senso non garantisce l’opinione pubblica nel mondo moderno.
Infatti esso presume sempre o che la verità è spontanea, o che i mezzi per
ottenerla esistono allorché non c’è alcuna interferenza esterna. Ma quando
si ha a che fare con un ambiente invisibile, l’assunto è falso. La verità
riguardante questioni lontane o complesse non è di per sé evidente, e gli
strumenti per raccogliere le notizie sono tecnici e costosi. E tuttavia la
scienza politica, e soprattutto la scienza politica democratica, non si è mai
liberata abbastanza dall’assunto originario della politica di Aristotele per
riformulare le premesse, affinché il pensiero politico potesse confrontarsi
col problema di come rendere visibile ai cittadini di uno stato moderno
l’ambiente invisibile.
La tradizione è così radicata che fino a pochissimo tempo fa, ad
esempio, la scienza politica veniva insegnata nelle nostre università come
se i giornali non esistessero. Non mi riferisco alle scuole di giornalismo,
poiché queste sono scuole professionali, intese a preparare uomini e donne
a una carriera. Mi riferisco invece alla scienza politica come viene esposta
ai futuri dirigenti industriali, avvocati, funzionari pubblici e cittadini in
genere. In questa scienza uno studio della stampa e delle fonti
234
dell’informazione popolare non ha trovato posto. È un fatto curioso. A
chiunque non sia immerso nel trantran della scienza politica riesce quasi
inesplicabile che nessuno studioso americano della vita pubblica, nessun
sociologo americano, abbia mai scritto un libro sul processo di raccolta
delle notizie. Si fanno ogni tanto riferimenti alla stampa, e dichiarazioni
che essa non è o dovrebbe essere «libera» e «veritiera». Ma praticamente
non riesco a trovare altro. E questo disdegno degli esperti ha il suo
equivalente nelle opinioni pubbliche. Si ammette universalmente che la
stampa è il mezzo principale di contatto con l’ambiente che sta al di fuori
del nostro campo visuale. E praticamente dappertutto si ritiene che la
stampa dovrebbe fare spontaneamente per noi quello che la democrazia
delle origini si figurava che ciascuno di noi potesse fare spontaneamente
per se stesso, che ogni giorno e due volte al giorno ci fornirà un quadro
veritiero di tutto il mondo esterno di cui ci interessiamo.
2.
Questa persistente e antica fede che la verità non viene conquistata, ma
ispirata, rivelata, fornita gratuitamente, si manifesta molto chiaramente nei
nostri pregiudizi economici di lettori di giornali. Ci aspettiamo che il
giornale ci serva, anche quando non è redditizia, la verità. Per questo
servizio difficile e spesso pericoloso, che riconosciamo fondamentale,
pretendevamo fino a poco tempo fa di pagare la moneta più piccola fra
quante ne vengono coniate dalla zecca. Ora ci siamo abituati a pagare due
e persino tre cents nei giorni feriali, e di domenica, per un’enciclopedia
illustrata e un supplemento di varietà, ci siamo spremuti fino a pagare
cinque e persino dieci cents. Non si pensa neanche per un momento di
dover pagare per il proprio giornale. Si attende che le fonti della verità
zampillino, ma non ci si impegna in alcun contratto, legale o morale, che
comporti il rischio, un costo o qualche fastidio per se stessi. Si pagherà un
prezzo nominale quando se ne avrà voglia, e si smetterà di pagarlo quando
non se ne avrà voglia, si prenderà un altro giornale quando farà comodo.
Qualcuno ha detto molto appropriatamente che il direttore di giornale
dev’essere riconfermato ogni giorno.
Questo occasionale e unilaterale rapporto tra lettori e stampa è
un’anomalia della nostra civiltà; non c’è nient’altro di simile, e perciò è
difficile paragonare la stampa a una qualsiasi altra istituzione o impresa.
Non è un’impresa pura e semplice, in parte perché il prodotto viene
regolarmente venduto sotto costo, ma soprattutto perché la collettività
applica una misura etica alla stampa e un’altra misura al commercio o
235
all’industria. Eticamente il giornale viene giudicato come se fosse una
chiesa o una scuola. Ma se si cerca di paragonarlo a queste ultime, non si
riesce: il contribuente paga per la scuola pubblica, la scuola privata riceve
sovvenzioni oppure si mantiene con le rette, per la chiesa ci sono sussidi e
collette. Non si può confrontare il giornalismo all’avvocatura, alla
medicina o all’ingegneria, perché in tutte queste professioni il consumatore
paga per il servizio. Una stampa libera, a giudicare dall’atteggiamento dei
lettori, significa giornali praticamente regalati.
Eppure i critici della stampa, quando pretendono che questa istituzione
viva sullo stesso piano sul quale si ritiene che vivano la scuola, la chiesa e
le professioni disinteressate, non fanno altro che esprimere i criteri morali
di giudizio della collettività. Ciò è un altro esempio del carattere concavo
della democrazia. Non si sente l’esigenza di un’informazione
artificialmente acquisita. L’informazione deve venire naturalmente, vale a
dire gratis, se non dal cuore del cittadino, dal giornale. Il cittadino pagherà
per il suo telefono, il suo biglietto ferroviario, la sua automobile, i suoi
divertimenti. Ma non paga visibilmente per le sue notizie.
Tuttavia pagherà a caro prezzo il privilegio di far parlare di sé il
giornale. Pagherà direttamente per fare la pubblicità. E pagherà indiretta
mente per gli annunci pubblicitari di altre persone, perché questo
pagamento, nascosto com’è nel prezzo di vendita del prodotto, fa parte di
un ambiente invisibile che egli non domina efficacemente. Sarebbe
considerato un oltraggio il fatto di dover pagare visibilmente il prezzo di
un buon gelato per tutte le notizie del mondo; quantunque il pubblico
paghi questo ed altro quando acquista i prodotti propagandati. Il pubblico
paga per la stampa, ma solo quando questa spesa è nascosta.
3.
La diffusione, quindi, è il mezzo per raggiungere un fine. Diventa un
patrimonio solo quando può esser venduta all’inserzionista, il quale la
compra con entrate assicurate da un’indiretta tassazione del lettore1. Il tipo
di diffusione che l’inserzionista comprerà dipende da quello che ha da
vendere. Può essere la «qualità» o la «massa». In genere non c’è una linea
netta di demarcazione, perché di fronte alla maggior parte dei prodotti
venduti attraverso la pubblicità gli acquirenti non sono né la piccola classe
dei ricchissimi né i poverissimi. Sono le persone che dispongono di
sufficienti eccedenze rispetto alle necessità primarie, per poter esercitare
negli acquisti una certa discrezionalità. Perciò il giornale che entra nelle
case delle persone piuttosto agiate è generalmente quello che offre di più
236
all’inserzionista. Può anche entrare nelle case dei poveri, ma, se si
eccettuano certi tipi di beni, un agente pubblicitario esperto non dà grande
valore a questa diffusione, a meno che, come sembra sia il caso di certi
giornali di Hearst, la diffusione non sia enorme.
Un giornale che scontenta quelli che fanno guadagnare di più
all’inserzionista non conviene a quest’ultimo. E dal momento che nessuno
ha mai preteso che la pubblicità sia una forma di filantropia, gli
inserzionisti acquistano spazio in quelle pubblicazioni che hanno le
migliori probabilità di raggiungere i loro futuri clienti. Non è necessario
perdere molto tempo a preoccuparsi degli scandali soffocati dei
commercianti di tessuti. Non rappresentano nulla di veramente importante,
e gli incidenti di questo genere sono meno comuni di quello che credono
molti critici della stampa. Il vero problema è che i lettori di un giornale,
non abituati a pagare il costo della raccolta delle notizie, possono essere
capitalizzati solo venendo trasformati in diffusione vendibile agli
industriali e ai commercianti. E quelli che è più importante capitalizzare
sono quelli che hanno più denaro da spendere. Una siffatta stampa deve
per forza rispettare il punto di vista del pubblico che può comprare. È per
questo pubblico di acquirenti che i giornali vengono redatti e pubblicati,
perché senza questo appoggio il giornale non può vivere. Un giornale può
maltrattare un inserzionista, può attaccare un potente interesse bancario o
commerciale, ma se si aliena le simpatie del pubblico che ha potere di
acquisto, perde il solo patrimonio indispensabile alla sua esistenza.
John L. Given2, già del «New York Evening Sun», dichiarò nel 1914
che su oltre 2300 quotidiani pubblicati negli Stati Uniti ce n’erano circa
175 stampati in città con più di centomila abitanti. Questi costituiscono la
stampa che fornisce le «notizie generali». Sono i giornali-chiave che si
procurano le notizie relative ai grandi avvenimenti, e anche quelli che non
leggono nessuno dei 175 giornali dipendono in ultima analisi da loro per
quanto riguarda le notizie provenienti dal mondo esterno. Infatti essi
formano le grandi associazioni della stampa che collaborano nello scambio
delle notizie. Ognuno di loro, perciò, non soltanto è l’informatore dei
propri lettori, ma è anche il corrispondente locale dei giornali di altre città.
La stampa rurale e la stampa specializzata in genere traggono le loro
notizie generali da questi giornali-chiave. E tra questi ce ne sono alcuni
molto più ricchi degli altri, sicché di solito per le notizie internazionali
tutta la stampa della nazione può dipendere dalle corrispondenze delle
agenzie giornalistiche e dai servizi speciali di pochi quotidiani di grandi
città.
Approssimativamente, il sostegno economico della raccolta delle
237
notizie generali sta nel prezzo che pagano per i prodotti reclamizzati i
settori discretamente agiati delle città che superano i centomila abitanti.
Questi pubblici di compratori comprendono i membri delle famiglie che
traggono il loro reddito principalmente dal commercio, dall’industria e
dalla finanza. Sono la clientela che rende di più a che fa la réclame attra
verso il giornale. Essi detengono un potere d’acquisto concentrato, che può
essere minore, come volume, del totale complessivo del potere d’acquisto
degli agricoltori e degli operai; ma entro il raggio coperto da un quotidiano
sono il capitale più rapidamente realizzabile.
4.
Inoltre presentano un duplice richiamo. Non sono soltanto i migliori
clienti dell’inserzionista, ma includono anche gli inserzionisti. E perciò
l’impressione che i giornali fanno su questo pubblico importa moltissimo.
Fortunatamente questo pubblico non è unanime. Può essere «capitalista»,
ma abbraccia opinioni discordi su cosa sia il capitalismo e su come debba
essere condotto. Salvo nei momenti di pericolo, questa rispettabile
opinione è abbastanza divisa da permettere considerevoli differenze di
indirizzo politico. Queste sarebbero ancora maggiori se non fosse che gli
editori sono anch’essi di solito membri di queste comunità urbane, e
vedono in buona fede il mondo attraverso le lenti dei loro colleghi e amici.
Sono impegnati in un’impresa speculativa1, che dipende dalla
situazione generale dell’economia, e più precisamente da una diffusione
basata non su un contratto di matrimonio con i lettori, ma sul libero amore.
L’obiettivo di ogni editore è perciò quello di trasformare la sua diffusione
da un’accozzaglia di casuali compratori di edicola in una devota
compagnia di lettori fedeli. Un giornale che possa davvero contare sulla
fedeltà dei suoi lettori ha tutta l’indipendenza che un giornale può avere,
data l’economia del giornalismo moderno2. Un corpo di lettori che resti
fedele, nei tempi buoni come nei cattivi, è una forza maggiore di quella di
cui può disporre il singolo inserzionista, e una forza abbastanza grande per
spezzare una combinazione di inserzionisti. Perciò ogni volta che ci si
imbatte in un giornale che tradisce i suoi lettori per amore di un
inserzionista, si può stare discretamente certi o che l’editore sinceramente
condivide le opinioni dell’inserzionista, o che ritiene, forse erroneamente,
di non poter contare sull’appoggio dei lettori se resiste apertamente
all’imposizione. È questione di sapere se i lettori, che non pagano in
contanti per le loro notizie, le pagheranno con la fedeltà.
238
XXII.
Il fedele lettore
1.
La fedeltà del pubblico dei compratori a un giornale non viene sancita
da alcun contratto. In quasi ogni altra impresa la persona che pretende di
essere servita prende un impegno che pone dei limiti ai suoi umori
passeggeri. Perlomeno paga per quello che riceve. Nel campo dei periodici
la cosa più vicina ad un impegno a scadenza precisa è l’abbonamento; ma
quest’ultimo, credo, non è un fattore importante nell’economia di un
grande quotidiano. Il lettore è l’unico e quotidiano giudice della propria
fedeltà, e non gli si può far causa per rottura di promessa di matrimonio o
per mancata corresponsione di alimenti.
Sebbene tutto si imperni sulla costanza del lettore, non esiste nemmeno
lontanamente la tradizione di richiamare questo fatto alla mente del lettore.
La sua costanza dipende dall’umore in cui si trova, o dalle sue abitudini. E
queste ultime dipendono non semplicemente dalla qualità delle notizie, ma
più spesso da molti elementi oscuri che solitamente, nel nostro occasionale
rapporto con la stampa, non ci diamo la pena di rendere coscienti. Il più
importante di essi è che ciascuno di noi tende a giudicare un giornale,
quando lo giudica, da come tratta quella parte delle notizie in cui si sente
personalmente coinvolto. Il giornale si occupa di una gran quantità di
avvenimenti che trascendono la nostra esperienza. Ma si occupa anche di
alcuni avvenimenti che vi rientrano. E noi lo approviamo o no, ci fidiamo
o rifiutiamo di tenere quel determinato foglio in casa, a seconda di come
affronta questi avvenimenti. Se il giornale dà un resoconto soddisfacente
di ciò che crediamo di conoscere, la nostra attività economica, la nostra
chiesa, il nostro partito, è quasi certo che non lo criticheremo con violenza
in nessun caso. Per la persona che legge mentre fa colazione, c’è forse un
criterio migliore di preferenza del constatare che l’interpretazione del
giornale collima con la sua opinione? Perciò la maggior parte degli
individui tende a considerare responsabile il giornale, assai più che come
lettori generali, come parti in causa in campi particolari, di cui hanno
diretta esperienza.
È raro che qualcuno, che non sia parte interessata, sia in grado di
239
verificare l’esattezza di un resoconto. Se la notizia è locale, e se c’è
polemica, il direttore sa che colui che giudica il proprio ritratto non equo e
inesatto, probabilmente si farà vivo. Ma se la notizia non è locale, le
probabilità di una rettifica diminuiscono in proporzione alla lontananza
della materia trattata. Le sole persone che possono rettificare quella che
ritengono una falsa immagine di sé pubblicata in un’altra città,
appartengono a gruppi che dispongono di uffici stampa o di agenti
pubblicitari.
È interessante notare che il lettore comune di un giornale non può adire
le vie legali quando ritiene di essere stato ingannato dalle notizie. È solo la
parte offesa che può querelare per calunnia o diffamazione e deve provare
di aver subito un danno materiale. La legge riflette la tradizione secondo
cui le notizie generali non sono materia di interesse comune1, salvo quando
si tratti di argomenti vagamente definiti come immorali o sediziosi.
Ma l’insieme delle notizie, anche se non viene controllato come tale dal
lettore disinteressato, è composto di singoli elementi su cui i singoli lettori
hanno preconcetti molto precisi. Questi elementi formano i dati su cui
fondano il loro giudizio, e le notizie che gli individui non leggono con
questo criterio personale vengono giudicate con un metro che non è il loro
metro di valutazione dell’esattezza. In questi casi la materia che si trovano
di fronte è indistinguibile ai loro occhi dal racconto inventato. Il canone
della verità non può essere applicato. Se le notizie corrispondono ai loro
stereotipi, non provano alcuna perplessità e continuano a leggere purché
presentino qualche interesse2.
2.
Ci sono giornali, anche nelle grandi città, redatti secondo il concetto
che i lettori desiderano leggere di se stessi. Secondo questa teoria, se molte
persone vedono il loro nome nel giornale abbastanza spesso, e possono
leggere resoconti dei loro matrimoni, funerali, festini, viaggi all’estero,
riunioni, premi scolastici, onomastici, compleanni, nozze d’argento, gite e
picnic, si potrà contare su una diffusione sicura.
La classica formula di un siffatto giornale è contenuta in una lettera
scritta il 3 aprile 1860 da Horace Greeley all’«amico Fletcher», che stava
per pubblicare un giornale di provincia1:
Parta dalla chiara convinzione che l’argomento di più profondo interesse per il
comune mortale è se stesso; subito dopo va collocato il suo interesse per i vicini.
Nella sua considerazione l’Asia e le isole Tonga stanno a grande distanza da questi
interessi […]. Faccia in modo che non si apra una nuova chiesa, o non si associno
240
altri membri a una già esistente, o non si venda una tenuta, o non si edifichi una
nuova casa, o non entri in funzione un nuovo mulino, o non si apra un negozio, o
non accada qualcosa che interessi una dozzina di famiglie, senza che il fatto sia
debitamente, anche se brevemente, riferito nelle colonne del suo giornale. Se un
agricoltore abbatte un grosso albero, o produce un’enorme barbabietola, o raccoglie
una messe abbondante di grano o granoturco, esponga il fatto nel modo più conciso
e sobrio possibile.
Ogni giornale, ovunque sia pubblicato, deve in qualche misura
adempiere alla funzione, come dice Lee, di «diario stampato del paese
natio». E dove, come a New York, i giornali d’informazione generale a
grande diffusione non sono in grado di adempierla, esistono piccoli
giornali fatti sul modello di Greeley per singoli quartieri cittadini. Nei
quartieri di Manhattan e del Bronx, i quotidiani locali sono forse il doppio
dei giornali d’informazione generale2. E vengono integrati da tutti i tipi di
pubblicazioni particolari a carattere professionale, religioso, etnico.
Questi diari si rivolgono a persone che trovano interessanti le proprie
vite. Ma ci sono anche moltissime persone che trovano noiose le proprie
vite, e vogliono vivere, come Hedda Gabler, una vita più emozionante. Per
loro vengono pubblicati giornali interi, e sezioni di altri, dedicati alle vite
personali di una serie di persone immaginarie, con i cui vizi sfarzosi il
lettore può tranquillamente identificarsi nella sua mente. L’instancabile
interesse di Hearst per l’alta società serve a persone che non hanno alcuna
speranza di frequentare l’alta società, e tuttavia riescono a trarre qualche
godimento dal vago sentimento di far parte della vita di cui leggono. Nelle
grandi città il «diario stampato del paese natio» tende a essere il diario
stampato dello smart set. E, come abbiamo già notato, ai quotidiani delle
grandi città che spetta l’onere di portare le notizie di cose lontane al
privato cittadino. Ma non sono le loro notizie politiche e sociali che
mantengono in primo luogo la diffusione. L’interesse per queste notizie è
intermittente, e pochi editori possono farvi affidamento in modo esclusivo.
Perciò il giornale assume tutta una serie di altre funzioni, tutte aventi lo
scopo di mantenere unito un corpo di lettori che non sono in grado di
essere critici di fronte alle grandi notizie. Inoltre, per quanto riguarda le
grosse notizie, la concorrenza in ogni singola comunità non è molto seria.
Le agenzie giornalistiche standardizzano i principali avvenimenti; solo
ogni tanto si fa il grande colpo; apparentemente non c’è un grosso
pubblico di lettori per un servizio di corrispondenza così completo come
quello che negli ultimi anni ha reso il «New York Times» indispensabile a
persone di tutte le sfumature d’opinione. Per differenziarsi tra loro e
assicurarsi un pubblico costante, la maggior parte dei giornali deve uscire
241
dal campo delle notizie generali. Trattano i fatti della società brillante, gli
scandali, i delitti, gli sport, i film, le attrici, forniscono consigli ai cuori
afflitti, notizie sulle scuole secondarie, pagine per le donne e per i
compratori, ricette di cucina, consigli ai giocatori di scacchi e di whist,
parlano di giardinaggio, inseriscono fumetti, parteggiano clamorosamente,
e non perché gli editori e i direttori si interessino di tutto fuorché delle
notizie, ma perché debbono trovare il modo di mantenere la presa su quella
presunta schiera di lettori appassionatamente interessati, che certi critici
della stampa si immaginano perpetuamente intenti a esigere la verità e
nient’altro che la verità.
Il direttore di giornale occupa una strana posizione. Le sue iniziative
dipendono da una tassazione indiretta imposta dai suoi inserzionisti ai suoi
lettori; il favore degli inserzionisti dipende dalla capacità del direttore di
trattenere un efficace gruppo di clienti. Questi clienti giudicano secondo le
loro esperienze personali e le loro aspettative stereotipate, perché per forza
di cose non hanno una conoscenza autonoma della maggior parte delle
notizie che leggono. Se il giudizio non è sfavorevole, il direttore si trova
per lo meno nel raggio di una circolazione che rende. Ma per assicurarsi
questa diffusione, non può affidarsi totalmente alle notizie riguardanti il
vasto mondo. Le tratta nel modo più interessante possibile, naturalmente,
ma la qualità delle notizie generali, soprattutto di quelle sulla vita
pubblica, non è di per sé sufficiente a persuadere grandi masse di lettori a
compiere delle scelte tra i quotidiani.
Questo rapporto un po’ ambiguo tra giornali e informazione pubblica si
riflette negli stipendi dei giornalisti. La cronaca, che in teoria costituisce la
base dell’intera istituzione, è il settore giornalistico peggio retribuito, ed è
il meno considerato. In genere i capaci vi entrano solo per necessità o per
far pratica, e con la precisa intenzione di farsi promuovere il più presto
possibile. Infatti la semplice cronaca non è una carriera che offra grandi
soddisfazioni. Nel giornalismo le soddisfazioni sono prerogativa
dell’attività specializzata, delle corrispondenze firmate che contengono dei
giudizi, dei dirigenti e di coloro che abbiano uno stile proprio. Ciò è
dovuto, senza dubbio, a quello che gli economisti chiamano la rendita
delle capacità. Ma questo principio economico opera nel giornalismo con
una violenza così singolare che la compilazione delle notizie non attira
minimamente il numero di individui preparati e capaci che la sua
importanza pubblica parrebbe esigere. Il fatto che gli individui capaci
facciano la «semplice cronaca» con l’intenzione di abbandonarla il più
presto possibile è, secondo me, la ragione principale per cui non si sono
mai sviluppate in misura sufficiente quelle tradizioni di corpo che danno a
242
una professione prestigio e un senso geloso della propria dignità. Infatti
sono queste tradizioni di corpo che danno luogo all’orgoglio professionale,
che tendono a elevare i livelli di ammissione, a punire le violazioni del
codice e a dare agli individui la forza di difendere la loro posizione nella
società.
3.
Tuttavia con questo non si arriva ancora alla radice della questione.
Infatti, mentre l’economia del giornalismo è tale da deprimere il valore
della cronaca, sono convinto che arrestando l’analisi a questo punto si
cadrebbe in un falso determinismo. Il potere intrinseco del cronista appare
così grande, e il numero di persone molto capaci che possano per la
cronaca è così ingente, che dev’esserci una ragione più profonda perché,
parlando in senso relativo, sono stati fatti così pochi sforzi per elevare la
professione al livello, poniamo, della medicina, dell’ingegneria o
dell’avvocatura.
Upton Sinclair parla a nome di una vasta corrente di opinione
americana1 quando pretende di avere trovato questa ragione più profonda
in quello che egli chiama «Il Gettone della Prostituta», o marchetta:
Che cos’è la marchetta?
Essa sta nella busta collo stipendio, ogni settimana, nella busta di voi che
scrivete, stampate e distribuite i nostri giornali e le nostre riviste. La marchetta è il
prezzo della vostra vergogna; di voi, che prendete il bellissimo corpo della Verità e
lo vendete sul mercato, che date in mano le vergini speranze dell’umanità ai tenitori
dello schifoso bordello dei «Pescecani»2.
Sembrerebbe, da queste parole, che esista una verità accertata e un
complesso di speranze ben fondate che vengono prostituite da una
congiuntura più o meno cosciente dei ricchi proprietari di giornali. Se
questa teoria è giusta, ne deriva allora una certa conclusione: e cioè che il
bellissimo corpo della Verità sarebbe inviolato in una stampa che non
fosse in alcun modo legata ai «Pescecani», al Big Business. Infatti, se
dovesse accadere che una stampa non controllata dal Big Business, e
nemmeno benevola nei suoi confronti, non contenesse il bel corpo della
verità, la teoria di Sinclair sarebbe sbagliata.
Una siffatta stampa esiste. Strano a dirsi, nel proporre un rimedio
Sinclair non consiglia ai suoi lettori di abbonarsi al più vicino giornale di
sinistra. Perché no? Se i mali del giornalismo americano risalgono alla
marchetta del Big Business, perché il rimedio non consisterebbe nella
243
lettura dei giornali che non accettano neppure lontanamente la marchetta?
Perché sovvenzionare un «Notiziario Nazionale», con un ampio comitato
direttivo in cui siano rappresentate «tutte le fedi e cause», per stampare un
giornale pieno di fatti «senza curarsi di ciò che vien leso, lo Steel Trust,
l’International Workers of the World, la Standard Oil Company, o il
partito socialista?». Se il male è il Big Business, cioè lo Steel Trust, la
Standard Oil o via dicendo, perché non invitare tutti a leggere i giornali
socialisti dell’IWW? Sinclair non dice il perché. Ma la ragione è semplice.
Non è in grado di convincere gli altri, e nemmeno se stesso, che la stampa
anticapitalistica sia il rimedio alla stampa capitalistica. Trascura la stampa
anticapitalistica sia nella sua teoria della marchetta che nella sua proposta
costruttiva. Ma se si fa la diagnosi del giornalismo americano, non si può
trascurarla. Se l’oggetto delle proprie preoccupazioni è «il bellissimo
corpo della Verità», non si commette il grossolano errore logico di mettere
insieme tutti i casi di malafede e di menzogne che si possono rintracciare
in un complesso di giornali, ignorare tutti i casi facilmente reperibili in un
altro complesso, e poi additare come causa unica della menzogna la sola
caratteristica che si suppone abbia in comune la stampa a cui si è limitata
la propria indagine. Se si intende biasimare il «capitalismo» per le colpe
della stampa, si ha l’obbligo di provare che queste colpe non esistono se
non quando c’è il controllo del capitalismo. Che Sinclair non lo faccia è
dimostrato dal fatto che mentre la diagnosi fa risalire tutto al capitalismo,
nella cura ignora sia il capitalismo che l’anticapitalismo.
Si sarebbe creduto che l’impossibilità di prendere un giornale non
capitalista a modello di veridicità e competenza avrebbe indotto Sinclair, e
quelli che condividono le sue opinioni, a considerare un po’ più
criticamente i loro assunti. Avrebbero dovuto chiedersi, ad esempio, dove
sia il bellissimo corpo della Verità, che il Big Business prostituisce, ma che
l’avversario del Big Business non sembra raggiungere. Infatti questa
domanda conduce, io credo, al nocciolo della questione, al problema di che
cosa sia l’informazione.
244
XXIII.
La natura delle notizie
1.
Tutti i cronisti del mondo, lavorando ventiquattr’ore al giorno, non
potrebbero assistere a tutti gli avvenimenti del mondo. Non ci sono
moltissimi cronisti. E nessuno di loro ha il potere di essere in più di un
luogo contemporaneamente. I cronisti non sono dei chiaroveggenti, non
possono vedere il mondo a loro talento guardando in una sfera di cristallo,
né sono aiutati dalla telepatia. Eppure la gamma di argomenti che questo
numero relativamente piccolo di individui riesce a coprire sarebbe
miracoloso se il tutto non fosse un processo standardizzato.
I giornali non cercano di tener d’occhio tutta l’umanità1. Hanno
osservatori dislocati in determinati posti, come i commissariati di polizia,
l’ufficio del coroner, la segreteria della contea, il municipio, la Casa
Bianca, il Senato, la Camera dei rappresentanti, e così via. Osservano, o
piuttosto, nella maggioranza dei casi, fanno parte di associazioni che
assumono persone che tengono d’occhio
un numero relativamente piccolo di posti dove si viene a sapere quando la vita di
qualcuno […] esce dai consueti binari, o quando accadono fatti degni di esser
raccontati. Supponiamo ad esempio che John Smith diventi un agente di borsa. Per
dieci anni va avanti in modo normale e nessuno, tranne i suoi clienti e i suoi amici,
si interessa di lui. Per i giornali è come se non esistesse. Ma nell’undicesimo anno
subisce gravi perdite e alla fine, esaurite tutte le risorse, chiama il suo avvocato e si
mette d’accordo per dichiarare fallimento. L’avvocato si precipita alla segreteria
della contea, e qui un impiegato riempie le voci del registro richieste. A questo
punto entrano in campo i giornali. Mentre l’impiegato scrive il necrologio
economico di Smith, un cronista alle sue spalle sbircia il registro e qualche minuto
dopo i cronisti apprendono le disavventure di Smith e sono informati sulla sua
situazione economica come se avessero tenuto un cronista alla porta del suo ufficio
ogni giorno per più di dieci anni2.
Quando Given dice che i giornali conoscono «le disavventure di
Smith» e «la situazione economica» non intende dire che le conoscono
come le conosce Smith, o come le conoscerebbe Arnold Bennett se avesse
fatto di Smith il protagonista di un romanzo in tre volumi. I giornali
apprendono solo «in pochi minuti» i nudi fatti che vengono registrati
245
nell’ufficio della segreteria della contea. Questo atto pubblico «scopre» la
notizia riguardante Smith. Se la notizia avrà o non avrà un seguito è
un’altra questione. Sta di fatto che prima che una serie di avvenimenti si
trasformi in notizia, di solito deve rendersi osservabile in un atto più o
meno manifesto. E di solito in un atto crudamente manifesto. Può darsi che
gli amici di Smith sapessero da anni che egli stava correndo dei rischi, può
darsi persino che ne sia giunta voce al redattore finanziario, se gli amici di
Smith non erano discreti. Ma a prescindere dal fatto che nulla di tutto ciò
poteva essere pubblicato perché si sarebbe trattato di diffamazione, in
queste voci non c’è nulla di preciso su cui imbastire un pezzo. Deve
succedere qualcosa di preciso e inequivocabile. Può trattarsi di una
dichiarazione di fallimento, di un incendio, di uno scontro, di
un’aggressione, di un tumulto, di un arresto, di una denuncia, della
presentazione di un progetto di legge, di un discorso, di una votazione, di
una riunione, dell’opinione espressa da un notabile del luogo, dell’articolo
di fondo di un giornale, di una vendita, di una tabella salariale, di un
ritocco di prezzi, della proposta di costruire un ponte… dev’esserci
qualcosa di evidente. Il corso degli avvenimenti deve assumere una certa
forma definibile, e finché non arriva alla fase in cui un qualche aspetto sia
diventato ormai un fatto compiuto, la notizia non si distingue dall’oceano
della verità possibile.
2.
Naturalmente le opinioni circa il momento in cui i fatti prendono una
forma che può essere riferita differiscono notevolmente. Un buon
giornalista scoverà le notizie più spesso di uno scribacchino. Se vede un
edificio che ha un’inclinazione pericolosa, non ha bisogno di aspettare che
crolli per riconoscere la notizia. Era un grande giornalista quello che
indovinò il nome del nuovo viceré dell’India sentendo che Lord Tal-deiTali si stava informando sui climi. Ci sono intuizioni fortunate, ma il
numero degli individui in grado di averle è piccolo. Di solito è la forma
stereotipata assunta da un fatto in una sede ovvia a far scoprire la notizia
comune. La sede più ovvia è quella in cui le faccende dei singoli entrano
in contatto con l’autorità pubblica. De minimis non curat lex. È in queste
sedi che i matrimoni, le nascite, le morti, i contratti, i fallimenti, gli arrivi,
le partenze, i processi, i disordini, le epidemie e le calamità vengono resi
noti.
Perciò in prima istanza la notizia non è uno specchio delle condizioni
sociali, ma la cronaca di un aspetto che si è imposto all’attenzione. La
246
notizia non ci dice in che modo il seme stia germinando nel terreno, ma
può dirci quando appare alla superficie il primo germoglio. Può anche farci
sapere che cosa una data persona crede che stia accadendo al seme
sottoterra. Può anche dirci che il germoglio non è spuntato quando si
prevedeva. Più sono i momenti in cui un avvenimento può venire fissato,
oggettivato, misurato, nominato, e più sono i momenti in cui può avverarsi
una notizia.
Sicché se un giorno un’assemblea, avendo esaurito tutti gli altri mezzi
per migliorare gli uomini, vietasse di segnare il punteggio delle partite di
baseball, forse si potrebbe ancora giocare in qualche specie di partita in cui
l’arbitro decidesse secondo il suo concetto di fair play quanto debba durare
la partita, quando le squadre debbano avere il loro turno alla mazza, e chi
debba essere considerato il vincitore. Se i giornali pubblicassero un
resoconto di questa partita, esso consisterebbe nell’elenco delle decisioni
dell’arbitro, più l’impressione del cronista sui fischi e gli applausi della
folla, più, nella migliore delle ipotesi, una vaga esposizione di come
certuni, privi di compiti specifici sul campo, si siano mossi per qualche ora
su un terreno non delimitato. Quanto più si cerca di immaginare la logica
di una situazione così assurda, tanto più diventa chiaro che al fine di
redigere la notizia (per non parlare del fine di giocare la partita) è
impossibile fare granché senza un apparato e delle regole per nominare,
segnare il punteggio, riferire. E poiché questo meccanismo è tutt’altro che
perfetto, la vita dell’arbitro è spesso agitata. Deve giudicare a occhio molte
azioni critiche. Si potrebbe eliminare dalla partita anche l’ultimo residuo di
controversia, com’è stato eliminato dagli scacchi là dove i giocatori si
attengono alle regole, qualora qualcuno giudicasse utile fotografare ogni
azione. Sono stati i film che hanno risolto definitivamente certi dubbi –
sorti nella mente dei cronisti e dovuti alla lentezza dell’occhio umano – su
quale dei pugni di Dempsey abbia messo ko Carpentier.
Ogni volta che c’è un buon strumento di registrazione, il moderno
servizio d’informazione opera con grande precisione. Ce n’è uno in Borsa,
e le notizie sulle fluttuazioni dei prezzi vengono trasmesse per
telescrivente con precisione sicura. C’è un apparato per la comunicazione
dei risultati elettorali, e quando lo spoglio e il conteggio sono ben fatti, di
solito il risultato di un’elezione nazionale è noto la sera dopo l’elezione.
Nei paesi civili i decessi, le nascite, i matrimoni, i divorzi vengono
registrati e si può conoscerli con precisione se non c’è occultamento o
negligenza. L’apparato esiste per alcuni – e solo alcuni – aspetti
dell’industria e del governo, e con vari gradi di certezza per i titoli, il
denaro e i generi di prima necessità, le operazioni bancarie, la compra247
vendita di immobili, le tabelle salariali. Esiste per le importazioni e le
esportazioni, perché queste passano attraverso una dogana, e possono
essere direttamente registrate. Esiste in misura molto minore nel
commercio interno, e soprattutto in quello al minuto. Si vedrà, credo, che
c’è una relazione assai diretta tra la certezza della notizia e il sistema di
registrazione. Se si pone mente agli argomenti che formano la principale
accusa dei riformatori contro la stampa, si vede che ci sono materie in cui
il giornale occupa la posizione dell’arbitro della partita di baseball in cui
sia stato abolito il punteggio. Tutte le notizie riguardanti gli stati d’animo
hanno questo carattere: così pure tutte le descrizioni del carattere, della
sincerità, delle aspirazioni, dei moventi, delle intenzioni, dei sentimenti
della massa, dei sentimenti nazionali, dell’opinione pubblica, della politica
dei governi stranieri. Così sono quasi tutte le notizie riguardanti
avvenimenti che debbono ancora accadere. Così pure le notizie di cose che
hanno a che vedere con il profitto personale, il reddito personale, i salari,
le condizioni di lavoro, l’efficienza della manodopera, le possibilità
d’istruzione, la disoccupazione1, la monotonia, la sanità, le
discriminazioni, le ingiustizie, la concorrenza sleale, gli sprechi, i «popoli
arretrati», il conservatorismo, l’imperialismo, il sinistrismo, la libertà,
l’onore, la rettitudine. Tutte queste cose comportano dati che nella
migliore delle ipotesi vengono registrati irregolarmente. I dati possono
essere nascosti a causa della censura o di una tradizione di riserbo,
possono non esistere in quanto nessuno considera importante registrarli,
perché viene ritenuto burocratico, o perché nessuno ha ancora inventato un
sistema obiettivo di valutazione. Perciò le notizie riguardanti questi
argomenti sono destinate a essere discusse, quando non vengono del tutto
ignorate. I fatti che non vengono registrati non vengono considerati
notizie, oppure vengono riferiti come opinioni personali e tradizionali.
Non prendono corpo finché qualcuno non protesti, o investighi, oppure ne
faccia pubblicamente una questione nel senso etimologico della parola.
È questa la ragione fondamentale dell’esistenza dell’agente
pubblicitario. L’enorme discrezionalità con cui vengono scelti dai cronisti i
fatti e le impressioni ha finito per persuadere ogni gruppo organizzato di
persone che, se si vuole pubblicità, o si vuole evitarla, non si può lasciare
al cronista l’esercizio della discrezionalità. È più sicuro ingaggiare un
agente pubblicitario che si collochi tra il gruppo e i giornali. Una volta
ingaggiatolo, la tentazione di sfruttare la sua posizione strategica è
grandissima.
Poco prima della guerra – dice Frank Cobb – i giornali di New York fecero un
censimento degli agenti pubblicitari che avevano un regolare incarico e scoprirono
248
che ce n’erano circa milleduecento. Quanti ce ne siano oggi (1919) non ho la pretesa
di saperlo, ma quello che so per certo è che molti dei canali diretti alle notizie sono
stati chiusi, e l’informazione per il pubblico viene filtrata attraverso agenti
pubblicitari. Ne hanno le grandi aziende, le banche, le ferrovie, ne hanno tutte le
organizzazioni economiche e sociali e politiche, e sono gli strumenti attraverso cui
giungono le notizie. Anche gli uomini di governo ne hanno2.
Se la cronaca fosse il semplice recupero di fatti ovvi, l’agente
pubblicitario sarebbe poco più di un impiegato. Ma dato che i fatti, in
rapporto alla maggior parte dei grandi temi d’informazione, non sono
semplici, e non sono affatto ovvi, ma soggetti alla scelta e all’opinione, è
naturale che tutti vorrebbero fare una propria scelta dei fatti da pubblicare
nei giornali. L’agente pubblicitario fa questo. E nel farlo certamente
risparmia molti fastidi al cronista, presentandogli un quadro chiaro di una
situazione che altrimenti gli apparirebbe senza capo né coda. Ma ne deriva
che il quadro che l’agente pubblicitario prepara per il cronista è quello che
vuol far vedere al pubblico. È censore e propagandista insieme,
responsabile solo verso i suoi datori di lavoro, e verso la verità intera
responsabile solo nella misura in cui è in armonia con la concezione che il
datore di lavoro ha del proprio interesse.
Lo sviluppo dell’agente di pubblicità è un chiaro segno che i fatti della
vita moderna non assumono spontaneamente una forma che consenta di
conoscerli. Qualcuno gli deve dare una forma, e siccome nella routine
quotidiana i cronisti non possono dare una forma ai fatti, e poiché è ben
scarsa l’organizzazione disinteressata dell’informazione, l’esigenza di una
qualche elaborazione viene soddisfatta dalle parti interessate.
3.
Il buon agente pubblicitario comprende che le virtù della sua causa non
fanno notizia, a meno che non siano virtù così strane da uscir fuori dalla
routine della vita. Questo non perché i giornali non amino la virtù, ma
perché non vale la pena di dire che non è successo nulla quando nessuno si
aspettava che succedesse qualcosa. Perciò se l’agente pubblicitario vuole
pubblicità gratuita, deve, a rigor di termini, dare inizio a qualcosa. Mette in
moto una trovata: blocca il traffico, prende in giro la polizia, riesce in
qualche modo a legare il suo cliente o la sua causa a un fatto che faccia già
notizia. Le suffragette lo sapevano, e mentre non gli faceva particolare
piacere saperlo, agivano in conseguenza, e tenevano la loro causa in
cronaca anche dopo che gli argomenti pro e contro avevano perso ogni
freschezza e la gente stava per abituarsi a vedere il movimento delle
249
suffragette come una delle istituzioni della vita americana1.
Fortunatamente le suffragette, a differenza delle femministe, avevano
un obiettivo perfettamente concreto, e semplicissimo. Non è semplice
quello che il voto simboleggia, come sapevano i più capaci dei sostenitori
e degli oppositori. Ma il diritto al voto è un diritto semplice e ben noto.
Nelle vertenze sindacali, che sono probabilmente il capo principale
d’accusa contro i giornali, il diritto di sciopero, come il diritto al voto, è
abbastanza semplice. Ma le cause e gli obiettivi di un particolare sciopero
sono come le cause e gli obiettivi del movimento femminista:
estremamente sottili.
Supponiamo che le condizioni di vita che portano a uno sciopero siano
cattive. Qual è la misura del male? Una certa concezione di un tenore di
vita adeguato, dell’igiene, della sicurezza economica e della dignità
umana. Può darsi che l’industria sia molto al di sotto del livel lo di vita
teorico della collettività, e che gli operai siano troppo miseri per protestare.
Può darsi che le condizioni siano superiori a questo livello e che gli operai
protestino violentemente. Nella migliore delle ipotesi il tenore di vita è una
vaga misura. Tuttavia immagineremo che le condizioni di vita siano
inferiori al livello medio, così come questo viene inteso dal direttore del
giornale. Talvolta, senza attendere che i lavoratori minaccino, ma
sollecitato, poniamo, da un assistente sociale, manderà dei cronisti a
investigare, e richiamerà l’attenzione del pubblico sulle cattive condizioni
di vita. Ma per forza di cose non può farlo spesso. Infatti queste
investigazioni richiedono tempo, denaro, particolari capacità e parecchio
spazio. Per rendere plausibile un resoconto che sostenga che le condizioni
di vita sono cattive, si deve poter disporre di molte colonne di stampa. Per
poter dire la verità sull’operaio delle acciaierie della zona di Pittsburgh,
sono stati necessari un’équipe di investigatori, una gran quantità di tempo
e vari grossi volumi stampati. È impossibile supporre che un giornale
quotidiano possa normalmente considerare come uno dei suoi compiti lo
svolgimento dei «Pittsburgh Surveys», o magari degli «Interchurch Steel
Reports». Le notizie la cui raccolta richiede una fatica così grande sono al
di là delle possibilità di un quotidiano2.
Le cattive condizioni di vita come tali non sono notizie, perché il
giornalismo, fuorché in casi eccezionali, non è un’esposizione di prima
mano del materiale grezzo. È un’esposizione di questo materiale già resa
stilizzata. Perciò le cattive condizioni di vita potrebbero diventare notizia
se il Board of Health denunciasse un tasso di mortalità insolitamente alto
in una zona industriale. Mancando un intervento di questo tipo, i fatti non
diventano notizia finché i lavoratori non si organizzano per presentare una
250
rivendicazione ai datori di lavoro. Anche in questo caso, se si sa che la
vertenza sarà composta facilmente, il valore della notizia è basso, a
prescindere dal fatto se l’accordo risolva o meno il problema delle
condizioni di vita. Ma se i rapporti di lavoro precipitano nello sciopero o
nella serrata, il valore della notizia aumenta. Se la sospensione del lavoro
riguarda un servizio che tocca direttamente i lettori dei giornali, o se
comporta un turbamento dell’ordine, il valore della notizia è ancora
maggiore.
Il problema sottostante appare nella notizia attraverso certi sintomi
facilmente riconoscibili, una rivendicazione, uno sciopero, dei disordini.
Dal punto di vista dell’operaio, o colui che è alla ricerca disinteressata
della giustizia, la rivendicazione, lo sciopero e i disordini non sono altro
che episodi di un processo che ai loro occhi è estremamente complicato.
Ma poiché tutte le realtà immediate esulano dalla diretta esperienza sia del
cronista che del particolare pubblico che appoggia la maggior parte dei
giornali, di solito debbono attendere un segnale sotto forma di un atto
manifesto. Quando il segnale arriva – attraverso, poniamo, uno sciopero
degli operai o una chiamata della polizia – mette in moto gli stereotipi che
la gente ha nella mente a proposito di scioperi e disordini. La lotta, che
loro non vedono, perde il proprio carattere. Viene registrata astrattamente,
e questa astrazione viene poi animata dall’esperienza personale del lettore
e del cronista. Ovviamente questa è un’esperienza diversissima da quella
degli scioperanti. Questi sentono, diciamo, il cattivo umore del
caporeparto, la sfibrante monotonia della macchina, il tanfo deprimente, la
fatica delle mogli, il rachitismo dei figli, lo squallore dei loro alloggi. Gli
slogan dello sciopero si caricano di questi sentimenti. Ma il cronista e il
lettore vedono dapprima solo uno sciopero e alcune parole d’ordine. Li
caricano dei propri sentimenti. Magari pensano che il loro lavoro è
minacciato perché gli scioperanti bloccano una produzione che serve al
loro lavoro, che ci saranno penuria e aumenti di prezzo, che è tutto
maledettamente scomodo. Anche queste sono realtà. E quando colorano
l’astratta notizia che è stato indetto uno sciopero, è nella natura delle cose
che gli operai si trovino in situazione di svantaggio. È nella natura, per
meglio dire, dell’attuale sistema dei rapporti di lavoro che le notizie che
traggono origine da rivendicazioni o da speranze dei lavoratori debbano
essere quasi invariabilmente rivelate da un attacco aperto alla produzione.
Ecco dunque la situazione di fatto in tutta la sua dilagante complessità,
l’atto manifesto che la segnala, il comunicato stereotipato che rende noto il
segnale, e il senso che il lettore gli attribuisce, dopo averlo tratto
dall’esperienza che direttamente lo tocca. Beninteso, l’esperienza che il
251
lettore ha dello sciopero può essere in realtà molto importante, ma dal
punto di vista del problema centrale, che ha provocato lo sciopero, resta
eccentrica. Tuttavia questo significato eccentrico è automaticamente il più
interessante3. Penetrare con l’immaginazione nel nocciolo della questione
è per il lettore come uscire da se stesso ed entrare in vite molto diverse.
Ne segue che nel fare la cronaca degli scioperi, il modo più facile è
quello di lasciare che le notizie si manifestino attraverso l’atto palese, e di
descrivere il fatto come il racconto di un’intromissione nella vita del
lettore. È in questo modo che si desta la sua attenzione e si richiama più
facilmente il suo interesse. Buona parte di ciò – la parte cruciale, secondo
me – che agli occhi del lavoratore e del riformatore appare come un
deliberato fraintendimento da parte dei giornali, è il risultato diretto della
difficoltà pratica di scoprire la notizia e della difficoltà emotiva di rendere
interessanti dei fatti lontani, a meno che non riusciamo, come dice
Emerson, a «percepirli solo come una nuova versione della nostra consueta
esperienza» e a «metterci a tradurli immediatamente nella nostra realtà
parallela»4.
Se si esamina il modo in cui molti scioperi vengono riferiti dalla
stampa, si scoprirà molto spesso che i problemi che li hanno provocati
figurino di rado nei titoli, a malapena nei paragrafi d’apertura, e talvolta
non vengono menzionati mai. Una vertenza sindacale scoppiata in un’altra
città dev’essere molto importante perché il resoconto contenga
informazioni precise sul suo soggetto. La routine si svolge così, e con
qualche modifica si svolge così anche per quanto riguarda le notizie sui
problemi politici e sulle questioni internazionali. La notizia è
un’esposizione delle fasi manifeste che interessano, e la pressione affinché
il giornale si attenga a questa routine viene da molte parti. Viene dal
risparmio rappresentato dal fatto di notare solo la fase stereotipata di una
situazione. Viene dalla difficoltà di trovare giornalisti che riescano a
vedere quello che non hanno imparato a vedere. Viene dalla quasi
inevitabile difficoltà di trovare lo spazio minimo in cui il giornalista
migliore possa rendere plausibile un’opinione non convenzionale. Viene
dalla necessità economica di interessare rapidamente il lettore, e dal
rischio economico che si corre quando non si riesce affatto ad interessarlo,
o quando lo si offende con notizie inattese insufficientemente o
goffamente esposte. Tutte queste difficoltà insieme rendono incerto il
direttore quando sono sul tappeto questioni pericolose, e lo portano
naturalmente a preferire il fatto incontrovertibile e un atteggiamento che
aderisca di più all’interesse del lettore. Il fatto incontrovertibile e il sicuro
interesse sono lo sciopero stesso e il disagio del lettore.
252
Nell’attuale organizzazione dell’industria tutte le verità più sottili e più
profonde sono verità molto poco sicure. Esse comportano giudizi sul
tenore di vita, sulla produttività, sui diritti umani che sono infinitamente
opinabili in mancanza di una precisa documentazione e di un’analisi
quantitativa. E finché queste ultime non esistono nell’industria, la
generalità delle notizie che vi si riferiscono tenderà, come diceva Emerson
citando Isocrate, a «fare delle collinette montagne e delle montagne
collinette»5. Là dove nell’industria non esiste una procedura stabilita dalla
legge, né si ha una valutazione delle testimonianze e delle rivendicazioni
da parte di un esperto, il fatto che riesce sensazionale al lettore è il fatto
che cercheranno quasi tutti i giornalisti. Data la situazione generale dei
rapporti di lavoro, anche quando ci sono trattative o c’è un arbitrato, ma
non si ha un vaglio dei fatti disinteressato ai fini della decisione, quello che
al pubblico del giornale apparirà come il problema sul tappeto tenderà a
essere diverso da quello che è un problema per l’industria. E così
pretendere di ottenere un giudizio sulla vertenza attraverso i giornali
significa accollare a questi e ai lettori un onere che non possono e non
debbono portare. Finché non ci saranno una legge positiva e un
ordinamento, il grosso delle notizie, a meno di non venire
consapevolmente e coraggiosamente corrette, opererà contro quelli che
non hanno un metodo legale e ordinato di affermarsi. I comunicati dal
luogo dell’azione faranno notare gli inconvenienti provocati dalla
rivendicazione piuttosto che le ragioni che li hanno provocati. Le ragioni
sono intangibili.
4.
Il direttore si serve di questi comunicati. Sta seduto nel suo ufficio, li
legge, di rado vede lui stesso una parte degli avvenimenti. Come abbiamo
visto, egli deve attirare ogni giorno almeno un settore dei suoi lettori,
perché questi ultimi lo lasceranno senza pietà se un giornale concorrente
riesce a colpire la loro fantasia. Lavora sotto un’enorme pressione, perché
la concorrenza dei giornali è spesso una questione di minuti. Ciascun
comunicato richiede un rapido ma complicato giudizio. Deve esser capito,
messo in rapporto ad altri comunicati, anch’essi da capire, e messo in
risalto o in ombra a seconda del suo probabile interesse per il pubblico,
come lo intende il direttore. Senza una standardizzazione, senza degli
stereotipi, senza dei giudizi precostituiti, senza una noncuranza spietata per
le sottigliezze, il direttore morirebbe ben presto di agitazione. La pagina
definitiva deve avere una dimensione determinata e dev’esser pronta a un
253
momento determinato; può esserci solo un certo numero di sottotitoli nei
pezzi, in ciascun sottotitolo dev’esserci un numero determinato di lettere.
Ci sono sempre l’urgenza precaria del pubblico dei compratori, la legge
sulla diffamazione e la possibilità di infiniti guai. La cosa non riuscirebbe
affatto senza una sistemazione, perché nel prodotto standardizzato c’è
economia di tempo e di fatica, nonché una garanzia parziale contro
l’insuccesso.
È qui che i giornali si influenzano a vicenda più profondamente. Così,
quando scoppiò la guerra, i giornali americani si trovarono davanti a un
argomento per il quale non avevano un’esperienza precedente. Certi
quotidiani, abbastanza ricchi per poter pagare le tariffe dei cablogrammi,
cominciarono per primi a procurarsi le notizie e il modo in cui le
presentavano divenne un modello per l’intera stampa. Ma da dove veniva
quel modello? Veniva dalla stampa inglese, non perché Northcliffe
possedeva dei giornali americani, ma perché in un primo momento, fu più
facile acquistare corrispondenze inglesi, e perché, in seguito, fu più facile
per i giornalisti americani leggere i giornali inglesi che gli altri. Londra era
il centro dei cablogrammi e delle notizie, e fu lì che si sviluppò una certa
tecnica per informare sulla guerra. Qualcosa di simile avvenne per i
reportage sulla rivoluzione russa. In questo caso l’accesso alla Russia era
impedito dalla censura militare, tanto russa che alleata, ed era impedito
ancor più efficacemente dalle difficoltà della lingua russa. Ma soprattutto
era precluso a un’informazione efficace dal fatto che la cosa più difficile
da esporre è il caos, anche quando è un caos in evoluzione. Di
conseguenza la formulazione delle notizie dalla Russia a Helsinki,
Stoccolma, Ginevra, Parigi e Londra stava nelle mani di censori e
propagandisti. Per molto tempo non subirono limitazioni di sorta. Finché
non si resero ridicoli, riuscirono a ricavare, ammettiamolo, da alcuni
autentici aspetti dell’immenso maelström russo una serie di stereotipi così
carichi di odio e di paura da soffocare per molto tempo anche il miglior
istinto del giornalista, il desiderio di andare a vedere per riferire1.
5.
Nel momento in cui raggiunge il lettore, il giornale è il risultato di
un’intera serie di scelte circa gli argomenti da trattare, la posizione in cui
devono essere collocati, la quantità di spazio che ciascuno deve occupare,
il tono che si deve dare a ciascuno. Qui non esistono criteri oggettivi. Ci
sono convenzioni. Si prendano due giornali pubblicati nella stessa città la
stessa mattina. Sul primo campeggia il titolo: «L’Inghilterra promette aiuto
254
a Berlino contro l’aggressione francese; la Francia appoggia apertamente i
polacchi». Il titolo del secondo è: «L’altro amore della signora Stillman».
Preferire uno o l’altro è questione di gusto, ma non del tutto una questione
di gusto del direttore. Si tratta di un suo giudizio su quello che assorbirà la
mezz’ora d’attenzione che una certa categoria di lettori darà al suo
giornale. Ora il problema di assicurare l’attenzione non equivale affatto a
esporre le notizie nella prospettiva prescritta dall’insegnamento religioso,
o da qualche forma di cultura etica. È il problema di provocare emozioni
nel lettore, di indurlo a provare un senso di identificazione personale con
le vicende di cui sta leggendo. La notizia che non dà questa possibilità di
inserirsi nella lotta che presenta non può attirare un vasto pubblico. Il
pubblico deve partecipare alla notizia, pressappoco come partecipa al
teatro, mediante l’identificazione personale. Proprio come tutti trattengono
il respiro quando l’eroina è in pericolo, e come aiutano Babe Ruth a
ruotare la sua mazza, così in forme più sottili il lettore entra nella notizia.
Per potervi entrare deve trovare un appiglio familiare nella vicenda, e
questo gli vien fornito con l’uso di stereotipi. Questi ultimi gli dicono che
se un’associazione di idraulici viene definita un «monopolio», ha ragione
di provare ostilità; se viene definita un «gruppo di autorevoli esponenti
economici», l’invito è a una reazione favorevole.
Il potere di creare l’opinione risiede nella combinazione di questi
elementi. Gli editoriali fanno da rincalzo. Talvolta in una situazione che
nelle pagine dedicate alle notizie appare troppo confusa per consentire
l’identificazione, essi danno al lettore un indizio che lo aiuti a impegnarsi.
E un indizio deve per forza averlo se, come accade alla maggior parte di
noi, egli deve afferrare la notizia in fretta. Egli esige un suggerimento di
qualche tipo, che gli dica, per così dire, in che punto un uomo come lui,
che ha una determinata opinione di se stesso, deve integrare i suoi
sentimenti con le notizie di legge.
È stato detto – scrive Walter Bagehot1 – che se si riesce a far pensare un inglese
di ceto medio alla questione se esistono «lumache su Sirio», egli avrà subito in
proposito un’opinione. Sarà difficile indurlo a riflettere, ma se riflette non può
restare inerte, deciderà qualcosa. Ed è così, naturalmente, per tutti i problemi
comuni. Un droghiere ha tutta una filosofia della politica estera, una giovane ha una
teoria completa dei sacramenti, e nessuno dei due ha alcun dubbio in proposito.
Tuttavia questo stesso droghiere avrà molti dubbi sulle sue mercanzie, e
questa signorina, meravigliosamente sicura sui sacramenti, può aver dubbi
di ogni sorta se le convenga sposare il droghiere, e, in caso negativo, se sia
corretto accettarne le attenzioni. La capacità di restare inerti implica o una
255
mancanza di interesse per il risultato, o un forte senso delle alternative
concorrenti. Nel caso della politica estera o dei sacramenti, l’interesse per i
risultati è intenso, mentre i mezzi per controllare l’opinione sono scarsi.
Questo è il dilemma del lettore di notizie generali. Se la deve leggere,
bisogna che provi interesse, ossia bisogna che entri nella situazione e si
preoccupi del risultato. Ma se lo fa non può restare inerte, e finché non
esistono mezzi indipendenti per controllare le indicazioni dategli dal suo
giornale, il fatto che sia interessato può rendergli difficile l’impresa di
raggiungere quell’equilibrio di opinione che forse si avvicina di più alla
verità. Quanto più diventa emotivamente coinvolto, tanto più tenderà a
infastidirsi non solo di un’opinione diversa, ma di una notiziola importuna.
Ecco perché molti giornali scoprono che, avendo onestamente suscitato la
partigianeria dei loro lettori, non possono facilmente, ammesso che il
direttore ritenga che i fatti lo impongono, mutare posizione. Se un
cambiamento è necessario, la transizione deve avvenire con la massima
abilità e delicatezza. Di solito un giornale non tenterà un’impresa così
pericolosa. È più facile e più sicuro far diminuire e poi scomparire le
notizie su quell’argomento, spegnendo il fuoco per mancanza di alimento.
256
XXIV.
Le notizie, la verità e una conclusione
A mano a mano che progrediamo nello studio della stampa, acquisterà
una grande importanza l’ipotesi alla quale ci affidiamo. Se sosteniamo con
Sinclair, e con la maggior parte dei suoi avversari, che notizia e verità
siano due parole per indicare la stessa cosa, credo che non approderemo a
nulla. Dimostreremo che su questo punto il giornale ha mentito.
Dimostreremo che su quell’altro punto è il resoconto di Sinclair che non è
veritiero. Dimostreremo che Sinclair ha mentito quando ha detto che
qualcuno ha mentito, e che qualcuno ha mentito quando ha detto che
Sinclair ha mentito. Daremo sfogo ai nostri sentimenti, ma sarà uno sfogo
a vuoto.
L’ipotesi che a me sembra più feconda è che la notizia e la verità non
siano la stessa cosa, e debbano essere chiaramente distinte1. La funzione
della notizia è di segnalare un fatto, la funzione della verità è di portare
alla luce i fatti nascosti, di metterli in relazione tra di loro e di dare un
quadro della realtà che consenta agli uomini di agire. Solo là dove le
condizioni sociali assumono una forma riconoscibile e misurabile, il corpo
della verità e il corpo della notizia coincidono. Questa è una parte
relativamente piccola dell’intero campo dell’interesse umano. In questo
settore, e solo in questo settore, i criteri per giudicare le notizie sono
sufficientemente esatti per rendere le accuse di distorsione o soppressione
qualcosa di più di un giudizio partigiano. Non c’è attenuante né scusa
alcuna per dichiarare sei volte che Lenin è morto, quando la sola
informazione che il giornale possieda è una segnalazione della sua morte
proveniente da una fonte che si è dimostrata ripetutamente inattendibile.
La notizia, in questo caso, non è «Morto Lenin», ma «Helsinki afferma che
Lenin è morto» E si può pretendere che un giornale si assuma la
responsabilità di non fare Lenin più morto di quanto non consenta la fonte
della notizia; se c’è un momento nel quale i direttori sono da tenersi più
responsabili, questo è il momento in cui giudicano dell’attendibilità della
fonte. Ma quando si tratta, ad esempio, di pronunciarsi su articoli che
trattano di quello che vorrebbe il popolo russo, un tale metro non esiste.
L’assenza di precisi criteri di verifica spiega, mi pare, meglio di
qualunque altra cosa il carattere della professione. C’è un piccolissimo
257
corpo di conoscenze esatte, che non richiede alcuna capacità o
preparazione eccezionali. Il resto rientra nella discrezionalità del
giornalista. Appena egli esce dalla zona, in cui è chiaramente registrato
all’ufficio della segreteria di contea che John Smith è andato in bancarotta,
scompaiono tutte le regole fisse. Il racconto del motivo per cui John Smith
è fallito, delle sue debolezze umane, l’analisi della situazione economica
che lo ha fatto naufragare, tutto ciò può essere riferito in cento modi
diversi. Non esiste una disciplina di psicologia applicata, come esiste una
disciplina nei campi della medicina, dell’ingegneria o della legge, che
abbia l’autorità di orientare la mente del giornalista quando questi passa
dalla notizia al vago regno della verità. Non esistono canoni per orientare
la sua mente, né canoni che indirizzino il giudizio del lettore o dell’editore.
La sua versione della verità è solo la sua versione. Come può dimostrare la
verità che ha visto? Non può dimostrarla, non più di quanto Sinclair Lewis
possa dimostrare di aver detto tutta la verità su Main Street. E quanto più
capisce le proprie debolezze, tanto più è pronto ad ammettere che dove
non esiste un criterio obiettivo di verifica la sua opinione è
fondamentalmente fatta dai suoi stereotipi, secondo il suo particolare
codice e secondo l’urgenza del suo interesse. Inoltre sa di vedere il mondo
attraverso delle lenti soggettive. Non può negare d’essere anche lui, come
osservava Shelley, una cupola di vetro multicolore che macchia il bianco
fulgore dell’eternità.
E la sua sicurezza viene temperata da questa consapevolezza. Potrebbe
avere tutto il coraggio morale del mondo, e talvolta lo ha, ma gli manca la
sottostante certezza di una tecnica come quella che ha finalmente liberato
le scienze fisiche dal controllo teologico. È stato il graduale sviluppo di un
metodo irrefragabile a dare al fisico la libertà intellettuale di fronte a tutte
le potenze del mondo. Le sue prove erano così chiare, l’evidenza dei suoi
esperimenti così nettamente superiore alla tradizione, che alla fine è
riuscito a spezzare ogni controllo. Ma il giornalista non ha un sostegno
come questo nella propria coscienza o nella realtà. Il controllo esercitato su
di lui dalle opinioni dei suoi datori di lavoro e dei suoi lettori, non è il
controllo della verità da parte del pregiudizio, ma di un’opinione da parte
di un’altra opinione che non si può dimostrare meno vera. Tra
l’affermazione del giudice Gary, che i sindacati distruggeranno le
istituzioni americane, e l’affermazione di Gomper, che essi sono strumenti
dei diritti dell’uomo, la scelta, in larga misura, dev’essere governata dalla
volontà di credere.
Il compito di sgonfiare queste controversie, e di ridurle al punto in cui
possono esser riferite come notizie, non è un compito cui possa adempiere
258
un cronista. Ai giornalisti è possibile e necessario far capire alla gente il
carattere incerto della verità su cui si fondano le sue opinioni, e con la
critica e l’attività stimolare la scienza sociale a elaborare formulazioni più
utili della realtà sociale e stimolare gli uomini di governo a creare
istituzioni più visibili. In altri termini, la stampa può battersi per
l’estensione della verità riferibile. Ma con l’attuale organizzazione della
verità sociale, la stampa non è in grado di fornire con continuità la dose di
conoscenza che la teoria democratica dell’opinione pubblica esige. Questo
non dipende dall’Assegno d’Ottone, come la qualità delle notizie
pubblicate dai giornali di sinistra dimostra, ma dal fatto che la stampa ha a
che fare con una società in cui le forze dominanti sono assai
imperfettamente documentate. La teoria secondo cui la stampa stessa può
documentare queste forze è falsa. Normalmente può documentare solo
quello che è stato documentato per lei dalle istituzioni nel corso del loro
funzionamento. Tutto il resto è polemica e opinione, e oscilla con le
vicissitudini, l’autocoscienza e il coraggio dell’animo umano.
Anche se la stampa non è così universalmente malvagia, né così
oscuramente cospiratoria come Sinclair vorrebbe farci credere, è tuttavia
molto più fragile di quello che la teoria democratica finora abbia ammesso.
È troppo fragile per portare il peso intero della sovranità popolare, per
fornire spontaneamente la verità che i democratici speravano fosse innata.
E quando pretendiamo che fornisca questo corpo di verità, adoperiamo un
criterio di giudizio fuorviante. Fraintendiamo la natura limitata della
notizia, la complessità illimitabile della società; sopravvalutiamo la nostra
esistenza, il nostro spirito pubblico e la nostra competenza generale.
Immaginiamo in noi un appetito di verità non interessanti che nessuna
onesta analisi dei nostri gusti rivela.
Se i giornali, quindi, debbono essere investiti del compito di tradurre
l’intera vita pubblica degli uomini, affinché ogni adulto possa farsi
un’opinione su ogni questione controversa, essi falliscono, sono destinati a
fallire, in un futuro prevedibile continueranno a fallire. Non è possibile
sostenere che un mondo, che si regge sulla divisione del lavoro e sulla
distribuzione dell’autorità, possa esser governato da opinioni
universalmente condivise da tutta la popolazione. Inconsciamente questa
teoria postula il singolo lettore come teoricamente onnicompetente. E
accolla alla stampa l’onere di fare tutto quello che il governo
rappresentativo, l’organizzazione industriale e la diplomazia non sono
riusciti a fare. Si pretende che la stampa, nei trenta minuti in cui agisce
ogni ventiquattr’ore sulla gente, crei una forza mistica chiamata Opinione
Pubblica, che compensi le manchevolezze delle istituzioni pubbliche.
259
Spesso la stampa ha erroneamente dato a credere di poter fare proprio
questo. Pagando un altro prezzo morale, essa ha incoraggiato una
democrazia ancora legata alle sue premesse originarie ad attendersi che i
giornali forniscano spontaneamente per tutti gli organi di governo, per tutti
i problemi sociali, gli strumenti di informazione che essi stessi
normalmente non forniscono. Le istituzioni, non essendo riuscite a darsi
gli strumenti di conoscenza, sono diventate un fascio di «problemi», che la
popolazione nel suo insieme dovrebbe risolvere leggendo la stampa nel
suo insieme.
La stampa, in altre parole, ha finito per esser considerata un organo di
democrazia diretta, investito ogni giorno e su scala assai più ampia, della
funzione spesso attribuita all’iniziativa popolare, al referendum e alla
revoca. Il tribunale dell’Opinione Pubblica, aperto giorno e notte, deve
dettar legge su tutto, continuamente. Ma in realtà non funziona. E se si
considera la natura delle notizie, è persino inconcepibile. Infatti la notizia,
come abbiamo visto, è precisa in proporzione alla precisione con cui il
fatto viene registrato. Se non è possibile nominare, misurare, dar forma,
rendere specifico il fatto, o esso non assume carattere di notizia, o è
soggetto agli infortuni e ai pregiudizi dell’osservazione.
Perciò in generale la qualità dell’informazione sulla società moderna è
un indice della sua organizzazione sociale. Quanto migliori sono le
istituzioni, tanto più facilmente tutti gli interessi relativi sono formalmente
rappresentati, tante più questioni vengono dipanate, tanto più obiettivi
sono i criteri adottati, tanto più perfettamente si può presentare come
notizia una vicenda. Nella sua espressione migliore la stampa è serva e
custode delle istituzioni; nella sua espressione peggiore è un mezzo
mediante il quale alcuni sfruttano la disorganizzazione sociale ai propri
fini particolari. Nella misura in cui le istituzioni non riescono a funzionare,
il giornalista privo di scrupoli può pescare in acque torbide, e quello
coscienzioso corre il rischio delle incertezze.
La stampa non è un sostituto delle istituzioni. È come il fascio di luce
di un lato che si sposta incessantemente, portando un episodio dopo l’altro
dal buio alla luce. Gli uomini non possono compiere le loro opere con
questa sola luce. Non possono governare la società a forza di episodi,
incidenti ed esplosioni. È solo quando operano illuminati da una ferma
luce propria che la stampa, quando si rivolge verso di loro, rivela una
situazione abbastanza chiara per consentire una decisione popolare. Il male
sta a un livello più profondo della stampa, e così anche il suo rimedio.
Questo sta in un’organizzazione sociale basata su un sistema di analisi e
documentazione, e in tutti i corollari di questo principio; nell’abbandono
260
della teoria del cittadino onnicompetente, nel decentramento delle
decisioni, nel coordinamento delle decisioni sulla base di documentazioni
e analisi confrontabili. Se nei centri direttivi c’è un controllo continuo, che
renda il lavoro intelligibile a quelli che lo fanno, e a quelli che vi
sovrintendono, le questioni che sorgono non sono semplicemente scontri di
ciechi. E inoltre le notizie si manifestano alla stampa grazie a un sistema di
informazione che serve anche da freno alla stampa.
Questa è la maniera estrema. Infatti i guai della stampa, come i guai del
governo rappresentativo, territoriale o funzionale che esso sia, come i guai
dell’industria, capitalista, cooperativa o comunista che sia, risalgono a una
fonte comune: al fatto che gli individui che si autogovernano non sono
riusciti a trascendere la propria casuale esperienza e i propri pregiudizi,
inventando, creando e organizzando degli strumenti di conoscenza. È
proprio perché sono costretti ad agire senza un’immagine attendibile del
mondo che i governi, le scuole, i giornali e le chiese fanno così pochi
progressi nel rimediare alle più ovvie manchevolezze della democrazia, ai
pregiudizi violenti, all’apatia, alla preferenza per le quisquilie curiose
anziché per le cose noiose ma importanti, e alla fame di baracconi da fiera
e di vitelli a tre zampe. Questo è il difetto principale del governo popolare,
un difetto implicito nelle sue tradizioni; e tutti gli altri suoi difetti, mi
sembra, possono essere ricollegati a questo.
Il miglior studio è quello del professor Z. Chafee, Freedom of Speech, Harcourt,
Brace and Howe, New York 1920.
2 J. Milton, Aeropagitica, citato all’inizio del libro di Chafee. Per un commento su
questa classica dottrina della libertà, come l’hanno formulata Milton, John Stuart Mill e
Bertrand Russell, si veda il mio Liberty and the News, Harcourt, Brace and Howe, New
York 1920, cap. II.
3 Cfr., ad esempio, le pubblicazioni del Lusk Committee di New York, e le
dichiarazioni e le profezie pubbliche di Mitchell Palmer, che fu Procuratore Generale
degli Stati Uniti durante la malattia del presidente Wilson.
1 «Un giornale affermato ha il diritto di fissare le sue tariffe per la pubblicità in modo
che i suoi introiti netti derivanti dalla diffusione possano essere iscritti tra i crediti nel
bilancio dei profitti e delle perdite. Per arrivare agli introiti netti, detrarrei dal totale
lordo il costo della promozione, della distribuzione, nonché le altre spese relative alla
diffusione». Da un discorso tenuto il 26 luglio 1916 da Adolf Ochs, editore del «New
York Times», al congresso di Filadelfia dell’Associated Advertising Clubs of the
World. Citato da Elmer Davis in History of the New York Times, 1851-1921, The New
York Times, New York 1921, pp. 397-8.
2 J. Given, Making a Newspaper, H. Holt and Co., New York 1907, p. 13; questo è il
miglior libro tecnico che io conosca, e tutti quelli che si accingono a discutere intorno
alla stampa dovrebbero leggerlo. G. B. Diblee, che ha scritto il volume della Home
1
261
University Library su The Newspaper (H. Holt and Co., New York 1913) dice che «c’è
un solo libro eccellente sulla stampa, per chi ci lavora dentro, ed è quello di Given» (p.
253).
1 A volte così speculativa che per assicurarsi il credito l’editore deve mettersi
completamente nelle mani dei suoi creditori. È molto difficile procurarsi notizie su
questo aspetto, e per questo motivo la sua importanza generale viene spesso assai
esagerata.
2 «È un assioma dell’editoria di giornali: “Più lettori, maggiore indipendenza dagli
inserzionisti; meno lettori, maggiore dipendenza dall’inserzionista”. Può sembrare una
contraddizione (eppure è la verità) affermare: maggiore il numero degli inserzionisti,
minore l’influenza che individualmente possono esercitare sull’editore». Adolf S. Ochs,
citato in Davis, History of the New York Times cit.
1 Il lettore non deve prendere questa considerazione come una richiesta di censura.
Tuttavia potrebbe essere una buona cosa l’istituzione di tribunali competenti,
preferibilmente non ufficiali, che potessero esaminare le accuse di falsità e malafede
nella presentazione delle notizie generali. Si veda Lippmann, Liberty and the News cit.,
pp. 73-6.
2 Si noti, ad esempio, quanto sia poco indignato Upton Sinclair con i giornali
socialisti, persino con quelli che si mostrano così ingiusti e malevoli verso i datori di
lavoro quando certi dei giornali da lui citati si mostrano ingiusti verso la sinistra.
1 Citato da J. M. Lee, in The History of American Journalism, Houghton Mifflin,
Boston-New York 1917, p. 405.
2 Cfr. Given, Making a Newspaper cit., p. 13.
1 Hilaire Belloc fa praticamente la stessa analisi per i giornali inglesi. Si veda The
Free Press.
2 U. Sinclair, Il gettone della prostituta, trad. di A. Dobelli Zampetti, Casa Editrice
Rassegna Internazionale, Roma 1922, p. 479; ed. or. The Brass Check. A study of
American journalism, The author, Pasadena (CA) 1919, p. 436.
1 Si veda l’illuminante capitolo su «La scoperta delle notizie» (cap. V) in Given,
Making a Newspaper cit.
2 Ibid., p. 57.
1 Si pensi a quante congetture si è fatto posto nelle relazioni del 1921 sulla
disoccupazione.
2 Discorso tenuto allo Women’s City Club di New York, l’11 dicembre 1919.
Ristampato in «New Republic», 31 dicembre 1919, p. 44.
1 Cfr. I. H. Irwin, The Story of the Women’s Party, Harcourt, Brace and Co., New
York 1921. Si tratta non solo di un buon resoconto di una parte fondamentale della
grande agitazione, ma di una riserva di materiale su un’agitazione vittoriosa, non
rivoluzionaria, non cospiratoria, condotta in una situazione moderna di attenzione ed
interesse pubblici e di costume politico.
2 Non molto tempo fa Babe Ruth venne arrestato per eccesso di velocità. Scarcerato
poco prima dell’inizio della partita, si precipitò nella sua automobile e recuperò il tempo
perduto in carcere violando le leggi sulla velocità lungo il tragitto che portava allo
stadio. Nessun poliziotto lo fermò, ma un cronista cronometrò la velocità e la pubblicò
l’indomani. Babe Ruth è un uomo eccezionale. I giornali non possono cronometrare la
velocità di tutti gli automobilisti. Debbono procurarsi le notizie sugli eccessi di velocità
262
dalla polizia.
3 Cfr. cap. XI, «Suscitare l’interesse».
4 R. W. Emerson, Art and Criticism (trad. it. in Id., Saggi, Bollati Boringhieri, Torino
1962). La citazione è tratta da pagina 87 del libro del professor R. W. Brown, The
Writer’s Art by those have praticed, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)
1921.
5 Ibid.
1 Cfr. W. Lippmann - C. Merz (con l’aiuto di Fay Lippmann), A Test of the News, in
«New Republic», 4 agosto 1920.
1 W. Bagehot, Literary Studies. On the Emotion of Conviction, London 1879, III, p.
172.
1 Quando scrissi Liberty and the News, non capivo questa distinzione abbastanza
chiaramente per formularla, ma si vedano pp. 89 sgg.
263
VIII.
L’informazione organizzata
264
XXV. Il
cuneo iniziale
1.
Se il rimedio fosse interessante, i pionieri americani come Charles
McCarthy, Robert Valentine e Frederick W. Taylor non avrebbero dovuto
combattere così duramente per farsi ascoltare. Ma è chiaro perché abbiano
dovuto combattere, e perché gli uffici di ricerca del governo, i controlli
dell’industria, la compilazione dei bilanci e simili siano i brutti anatroccoli
della riforma. Essi capovolgono il processo mediante il quale si
costruiscono le opinioni pubbliche interessanti. Invece di presentare un
fatto occasionale, un grande schermo di stereotipi e una drammatica
identificazione, essi smontano il dramma, spezzano gli stereotipi e offrono
agli individui un’immagine dei fatti a loro sconosciuta e impersonale.
Quando non è doloroso, tutto ciò è noioso, e quelli a cui riesce doloroso, il
politicante intrigante e il fazioso che ha molto da nascondere, spesso
sfruttano la noia provata dal pubblico per eliminare il dolore che provano
loro.
2.
Eppure tutte le collettività complesse hanno cercato l’aiuto di individui
speciali, di àuguri, preti, anziani. La nostra stessa democrazia, benché
basata su una teoria della competenza universale, ha cercato avvocati che
amministrassero il suo governo e aiutassero ad amministrare la sua
industria.
Si ammetteva che l’individuo fornito di una preparazione speciale era
vagamente orientato verso un sistema di verità più ampio di quello che
sorge spontaneamente nella mente del dilettante. Ma l’esperienza ha
dimostrato che la preparazione tradizionale dell’avvocato non era un aiuto
sufficiente. La Grande Società è cresciuta furiosamente, raggiungendo
dimensioni colossali grazie all’applicazione delle conoscenze tecniche. È
stata costruita da ingegneri che hanno imparato a usare misure precise e
l’analisi quantitativa. Gli uomini hanno cominciato a scoprire che non
poteva essere governata da individui che ragionassero per deduzione sui
265
diritti e i doveri. Poteva essere posta sotto il controllo umano solo dal
tecnico che l’aveva creata e quindi un po’ alla volta le menti direttive più
illuminate si sono rivolte a esperti che erano stati preparati, o che si erano
preparati, a rendere alcuni settori di questa Grande Società comprensibili a
quelli che la dirigono. Queste persone vengono chiamate con vari nomi,
statistici, contabili, controllori dei conti, consulenti industriali, ingegneri di
varie specie, amministratori aziendali scientifici, dirigenti del personale,
ricercatori, «scienziati» e talvolta semplicemente segretari particolari.
Ognuno ha portato con sé un suo gergo, nonché schedari, archivi, grafici,
agende e quaderni, e soprattutto l’ideale sensatissimo del dirigente seduto
davanti a una scrivania piana, con un solo foglio dattiloscritto di fronte a
sé, che decide su questioni d’indirizzo presentategli in forma adatta a
un’immediata approvazione o a un immediato rifiuto.
Tutto questo sviluppo è stato il frutto non tanto di un’evoluzione
creativa spontanea, quanto della cieca selezione naturale. Lo statista, il
dirigente industriale, il capo partito, il capo di un’associazione volontaria,
scoprirono che per poter discutere un paio di dozzine di argomenti diversi
nel corso di una giornata, doveva esserci qualcuno che desse loro
l’imbeccata. Cominciarono a pretendere dei promemoria. Scoprirono di
non poter leggere la loro posta. Pretesero che qualcuno sottolineasse i
brani interessanti delle lettere importanti. Scoprirono di non poter digerire
le grandi pile di relazioni dattiloscritte che ingiallivano sulle loro scrivanie.
Ne pretesero dei riassunti. Scoprirono di non poter leggere colonne
interminabili di cifre. Abbracciarono l’individuo che le trasformò in
immagini colorate. Scoprirono di non poter davvero distinguere una
macchina dall’altra. Assunsero ingegneri per sceglierle e per dir loro
quanto costavano e che cosa erano in grado di fare. Si liberarono di un
peso dopo l’altro, come colui il quale, quando si sforza di spostare un peso
poco maneggevole, comincia a togliersi il cappello, poi la giacca, poi il
colletto.
3.
Stranamente, però, pur sapendo di aver bisogno di aiuto tardarono a
chiamare lo scienziato sociale. Il chimico, il fisico, il geologo ebbero
accoglienze più tempestive e più amichevoli. Si istituirono per loro dei
laboratori, gli si offrirono allettamenti, perché si erano apprezzate subito le
vittorie sulla natura. Ma lo scienziato che ha per problema la natura umana
è un caso diverso. Le ragioni sono molte: la principale è che ha ben poche
vittorie da mostrare. Ne ha così poche perché, se non si rivolge al passato
266
storico, non è in grado di dimostrare le sue teorie prima di offrirle al
pubblico. Lo scienziato fisico può fare un’ipotesi, sottoporla a prove,
modificare l’ipotesi centinaia di volte, e, se dopo tutto questo scopre di
aver sbagliato, nessun altro deve pagarne il prezzo. Ma lo scienziato
sociale non può in alcun modo offrire la sicurezza di una prova di
laboratorio, e se il suo consiglio viene seguito, ed è sbagliato, le
conseguenze possono essere incalcolabili. Per forza di cose egli è molto
più responsabile, e molto meno certo.
C’è di più. Nelle scienze sperimentali lo studioso ha superato il
dilemma tra pensiero e azione. Infatti può portare un campione dell’azione
in un posto tranquillo, dove può essere ripetuto a volontà, ed esaminato
comodamente. Mentre lo scienziato sociale si trova continuamente stretto
da un dilemma. Se rimane nella sua biblioteca, dove ha tutto l’agio di
pensare, deve affidarsi alla scarsa e occasionale documentazione stampata
che gli arriva attraverso le relazioni ufficiali, i giornali e le interviste. Se
esce nel «mondo» dove accadono i fatti, deve sottoporsi a un lungo, spesso
dispersivo tirocinio prima di essere ammesso ai luoghi riservati dove
vengono prese le decisioni. Quello che non può fare è tuffarsi nell’azione e
poi uscirne a suo talento. Non ci sono osservatori privilegiati. L’uomo
d’affari, osservando che lo scienziato sociale conosce solo dall’esterno ciò
che egli conosce, almeno in parte, dall’interno e riconoscendo che l’ipotesi
dello scienziato sociale non è per sua natura suscettibile di prove di
laboratorio, e che la verifica è possibile solo nel mondo «reale», si è fatto
un’opinione piuttosto bassa degli scienziati sociali che non condividono le
sue vedute sugli indirizzi politici.
In cuor suo lo scienziato sociale condivide questo giudizio su di sé. Ha
poca fiducia nel proprio lavoro; ci crede solo a metà, e non essendo sicuro
di nulla, non trova una ragione impellente per difendere la sua libertà di
pensiero. In coscienza, che pretese può avanzare al riguardo?1 I suoi dati
sono incerti, i suoi strumenti di verifica lasciano a desiderare, le stesse sue
qualità migliori sono fonti di frustrazione. Infatti se ha davvero tempra di
critico, ed è imbevuto di spirito scientifico, non può essere dottrinario e
scendere sul campo di Armageddon contro gli amministratori delle
università, gli studenti, le leghe civiche e la stampa conservatrice in nome
di una teoria di cui non è sicuro. Se si va ad Armageddon, è per battersi in
nome del Signore, ma lo scienziato politico dubita sempre un po’ che il
Signore l’abbia chiamato.
Di conseguenza, se tanta parte della scienza sociale è apologetica
invece che costruttiva, la spiegazione sta nelle possibilità concrete della
scienza sociale, e non nel «capitalismo». Gli studiosi di scienze naturali si
267
sono affrancati dal clericalismo elaborando un metodo che portava a
conclusioni che non potevano essere soppresse o ignorate. Convinsero se
stessi e acquistarono dignità, sapendo bene per cosa si battevano. Lo
scienziato sociale acquisterà dignità e forza solo quando avrà elaborato il
suo metodo. Ci riuscirà se sarà capace di tramutare in concrete possibilità
il bisogno dei dirigenti della Grande Società di possedere strumenti di
analisi che rendano intelligibile un ambiente invisibile e formidabilmente
difficile.
Ma oggi come oggi lo scienziato sociale trae i suoi dati da una massa di
materiale privo di nessi. I processi sociali vengono registrati
spasmodicamente, spesso come incidenti amministrativi. Un rapporto al
Congresso, un dibattito, un’investigazione, delle comparse legali, un
censimento, una tariffa doganale, un elenco di contribuenti; il materiale,
come il cranio dell’uomo di Piltdown, va messo insieme per mezzo di
ingegnose deduzioni prima che lo studioso riesca ad avere un quadro del
fatto che sta studiando. Quest’ultimo, pur riguardando la vita cosciente dei
suoi concittadini, è fin troppo spesso di una scoraggiante opacità, e ciò
perché colui che sta cercando di generalizzare non ha in pratica alcun
modo di controllare i sistemi di raccolta dei dati di cui si serve. Si
immagini una ricerca medica svolta da studenti che potessero entrare solo
di rado in un ospedale, ai quali venisse negata la possibilità di compiere
esperimenti sugli animali, e che perciò fossero costretti a trarre le loro
conclusioni dai racconti di ex ammalati, dalle testimonianze di infermiere,
ciascuna delle quali avesse un proprio sistema di diagnosi, e dalle
statistiche compilate dall’ufficio erariale sui sovrapprofitti dei farmacisti.
Di solito lo scienziato sociale deve ricavare quello che può da
classificazioni uscite acriticamente dalla mente di un funzionario
incaricato di applicare una parte di una legge, o che si proponeva di
giustificare, di persuadere, di pretendere o di provare. Lo studioso sa tutto
questo, e per proteggersi ha sviluppato delle tecniche per accertare dove i
suoi dati siano revocabili in dubbio.
Questa è certamente una virtù, ma diventa una virtù di poco conto
quando non è altro che un correttivo della posizione malsana in cui si trova
la scienza sociale. Infatti lo studioso è condannato a indovinare come
meglio può perché mai, in una situazione che non si comprende fino in
fondo, possa essere avvenuta una certa cosa. Ma l’esperto che viene
impiegato come mediatore tra rappresentanti di parti, e come specchio e
misura di funzionalità, ha un ben diverso controllo dei fatti. Invece di
essere colui che trae generalizzazioni dai fatti lasciati trapelare dagli
uomini d’azione, diventa colui che prepara i fatti per gli uomini d’azione.
268
Si tratta di un profondo mutamento della sua posizione strategica. Non sta
più al di fuori a ruminare quello che gli forniscono dei frettolosi uomini
d’affari, ma prende posto davanti e non dietro la decisione. Oggi la
successione è questa: l’uomo d’affari trova i fatti e decide sulla base di
questi; e poi, dopo qualche tempo, lo scienziato sociale deduce eccellenti
ragioni sul perché abbia o non abbia deciso saggiamente. Questo rapporto
retrospettivo è accademico nel senso peggiore di questa bella parola. La
successione logica dovrebbe essere quest’altra: prima l’esperto
disinteressato trova e formula i dati per l’uomo d’azione, e
successivamente trae tutta la saggezza possibile dal raffronto tra la
decisione, che è in grado di capire, e i dati, che egli stesso ha organizzato.
4.
Nelle scienze fisiche questo mutamento di posizione strategica ha avuto
un inizio lento, ma poi ha assunto un ritmo sempre più rapido. C’è stata
un’epoca in cui l’inventore e l’ingegnere erano romantici e mezzo
affamati, degli esclusi trattati come maniaci. L’uomo d’affari e l’artigiano
conoscevano tutti i segreti del loro mestiere. Poi i mestieri divennero più
misteriosi, e infine l’industria cominciò a dipendere da leggi fisiche e da
combinazioni chimiche che nessun occhio poteva vedere, e che solo una
mente addestrata poteva immaginare. Lo scienziato si trasferì dalla sua
nobile soffitta del Quartiere Latino agli uffici e ai laboratori. Solo lui,
infatti, era in grado di costruire un’immagine funzionale della realtà su cui
l’industria poggiava. Dal nuovo rapporto ha avuto quanto ha dato, forse di
più: la scienza pura si è sviluppata più rapidamente di quella applicata,
traendo gran parte del suo appoggio economico, della sua ispirazione e
della sua utilità da un contatto costante con le decisioni pratiche. Ma la
scienza fisica era ancora appesantita dall’enorme limitazione costituita dal
fatto che coloro che decidevano avevano per guida solo il loro buon senso.
Amministravano senza un’assistenza scientifica un mondo reso complesso
dagli scienziati. Ancora una volta dovevano affrontare fatti che non
riuscivano ad afferrare, e come una volta avevano dovuto appellarsi agli
ingegneri, così ora dovevano appellarsi agli statistici, ai contabili e ad
esperti di tutti i tipi.
Questi studiosi della vita pratica sono i veri pionieri di una nuova
scienza sociale. Sono «ingranati nelle ruote motrici»1 e sia la scienza che
l’azione si avvantaggeranno in modo radicale da questo loro connubio
operativo: l’azione trarrà benefici dalla chiarificazione dei suoi
presupposti; i presupposti la trarranno dalla continua verifica dei fatti.
269
Siamo ancora agli albori. Ma se si ammette che le maggiori forme di
associazione umana debbano, per far fronte alle loro difficoltà pratiche,
trovare uomini che vedono la necessità di affidare a esperti l’analisi del
loro particolare ambiente, allora l’immaginazione ha una base su cui
operare. Nello scambio di tecniche e di risultati tra équipes di esperti, si
può vedere, mi pare, l’inizio del metodo sperimentale nella scienza sociale.
Quando ogni circondario e bilancio scolastico, ogni ripartizione della
sanità, ogni fabbrica e ogni elenco di tariffe doganali costituiranno materia
di studio e di conoscenza per tutti gli altri, il numero delle esperienze
raffrontabili comincerà ad avvicinarsi alle dimensioni del vero
esperimento: 48 stati, 2400 città, 277 000 scuole, 270 000 fabbriche, 27
000 miniere e cave offrono un patrimonio di esperienze che attende solo di
essere registrato e reso disponibile. E c’è anche la possibilità di fare
tentativi ed errori con un rischio veramente minimo: in sostanza si
potrebbe dar corso a qualsiasi ipotesi ragionevole senza mettere in pericolo
le basi della società.
Lo spiraglio è stato aperto, non solo da certi dirigenti industriali e da
certi uomini di governo, che avevano bisogno di aiuto, ma anche dagli
uffici studi municipali2, dalle biblioteche specializzate in materia
legislativa, dai gruppi di pressione specializzati delle grandi aziende, dei
sindacati e dei movimenti di riforma, nonché da organizzazioni volontarie
come la Lega delle Donne Elettrici, la Lega dei Consumatori, le
Associazioni degli industriali: da centinaia di associazioni di categoria e di
comitati cittadini; da pubblicazioni come «Searchlight on Congress» e
«Survey»; e da fondazioni come il General Education Board. Certamente
non sono tutti disinteressati. Ma non è questo il punto. È il fatto che tutti
insieme cominciano a dimostrare la necessità di interporre una forma di
competenza specializzata tra il cittadino privato e il vastissimo ambiente in
cui si trova immerso.
270
XXVI.
Il lavoro d’informazione
1.
Finora la prassi della democrazia ha sopravanzato la teoria. Infatti la
teoria sostiene che l’insieme degli elettori adulti trae decisioni da una
volontà che è in ciascuno di loro. Ma proprio come si sono sviluppate
gerarchie di governo che la teoria non contemplava, così si sono avuti
anche molti adattamenti costruttivi di cui non s’era tenuto conto nel
costruire l’immagine della democrazia. Si è trovato il modo di
rappresentare molti interessi e funzioni che normalmente restano occulti.
Ci rendiamo conto di ciò soprattutto nella teoria dei tribunali, quando
spieghiamo i loro poteri e veti legislativi con la teoria che ci sono interessi
da tutelare che i governanti eletti potrebbero dimenticare. Ma l’ufficio dei
censimenti, quando conta, classifica e raggruppa persone, cose e
mutamenti, documenta anche fattori operanti nell’ambiente, tuttavia
invisibili. Il catasto geologico rende evidenti le risorse minerarie, il
Dipartimento dell’agricoltura rappresenta negli organi nazionali fattori di
cui il singolo agricoltore vede solo una parte infinitesima. Le autorità
scolastiche, la Commissione per le tariffe doganali, il servizio consolare,
l’ufficio erariale, rappresentano persone, idee e obiettivi che non si
troverebbero mai automaticamente rappresentati in questa prospettiva per
effetto di un’elezione. L’Ufficio per i Minori è il portavoce di tutto un
complesso di interessi e funzioni che non sono normalmente visibili
all’elettore, e che perciò non possono spontaneamente entrare a far parte
delle sue opinioni pubbliche. Così la pubblicazione di statistiche
comparate sulla mortalità infantile viene spesso seguita dalla riduzione del
tasso di mortalità. I funzionari municipali e gli elettori non avevano, prima
della pubblicazione, un posto per questi bambini nella loro immagine
dell’ambiente. Le statistiche li hanno resi visibili, come se i bambini
avessero eletto un consigliere per dar voce alle loro lamentele.
Il governo mantiene al Dipartimento di stato una Divisione per gli
affari dell’Estremo Oriente. A che cosa serve? I governi giapponese e
cinese hanno entrambi degli ambasciatori a Washington. Non sono
qualificati a parlare in nome dell’Estremo Oriente? Sono loro i suoi
271
rappresentanti. Tuttavia nessuno sosterrebbe che il governo americano
possa apprendere tutto quello che gli serve sull’Estremo Oriente da questi
ambasciatori. Essi, anche ammesso che siano del tutto franchi, restano
sempre fonti di informazioni limitate. Ed è proprio per questo che
manteniamo delle ambasciate a Tokyo e Pechino, e dei consoli in molte
località. Ed anche, immagino, degli agenti segreti. Costoro dovrebbero
mandare rapporti al Segretario di stato, passando attraverso la divisione
per gli affari dell’Estremo Oriente. Che cosa si attende il Segretario da
questa Divisione? So di uno che si attendeva che la Divisione
semplicemente spendesse i fondi assegnatile. Ma ci sono anche segretari
cui è negata l’ispirazione divina, e che si rivolgono alle divisioni per aiuto.
Naturalmente l’ultima cosa di cui hanno bisogno è un’elegante
argomentazione che giustifichi l’atteggiamento americano.
Hanno bisogno invece che gli esperti portino l’Estremo Oriente sulla
scrivania del segretario, con tutti gli elementi organizzati in maniera che
egli possa sentirsi in contatto diretto con l’Estremo Oriente. L’esperto deve
tradurre, semplificare, generalizzare, ma le decisioni che ne risultano
debbono essere pertinenti all’Oriente, e non solo alle premesse del
rapporto. Se il Segretario vale qualcosa, non sopporterà nemmeno il
sospetto che i suoi esperti abbiano una «politica». Non vuol sapere da loro
se giudicano positiva la politica giapponese verso la Cina. Vuole sapere
che cosa ne pensano vari ambienti cinesi e giapponesi, inglesi, francesi,
tedeschi e russi; e che cosa, di conseguenza, si accingono probabilmente a
fare. Pretende che gli si rappresenti tutto ciò come base per la sua
decisione. Sarà un Segretario di stato tanto migliore, quanto più
fedelmente la Divisione gli illustrerà quello che altrimenti non verrebbe
illustrato, né dagli ambasciatori giapponesi o americani, né dai senatori e
deputati degli stati che si affacciano sul Pacifico. Può decidere di trarre la
sua politica dalla costa del Pacifico, ma la sua opinione sul Giappone la
trarrà dal Giappone.
2.
Non a caso il miglior servizio diplomatico del mondo è quello in cui è
più perfetto il divorzio tra la raccolta dei dati e la formulazione della
politica. Durante la guerra in molte ambasciate inglesi e nello stesso
Foreign Office inglese ci si imbatteva quasi sempre in uomini, funzionari
permanenti o incaricati straordinari, che riuscivano assai bene ad astrarsi
dalla mentalità bellica esistente. Evitavano la perdita di tempo di essere
pro o contro, di avere delle nazionalità predilette, delle avversioni
272
personali e delle perorazioni non pronunciate in petto. Lasciavano queste
cose ai capi politici. Ma una volta a un’ambasciata americana ho sentito un
ambasciatore dire che egli non riferiva mai nulla a Washington che non
potesse rallegrare i compatrioti. Riusciva simpatico a tutti quelli che
incontrava, aiutava i connazionali rimasti al verde, ed era superbo quando
si trattava di scoprire monumenti.
Non capiva che la forza dell’esperto sta nella capacità di staccarsi da
quelli che prendono la decisione, di non curarsi nel suo animo d’esperto
della decisione presa. Colui il quale, come questo ambasciatore, prende
posizione, e si immischia nella decisione, viene ben presto tenuto in poco
conto. Eccolo lì ridotto ad essere l’ennesimo sostenitore di una certa
impostazione. Infatti, quando comincia a preoccuparsi troppo, comincia a
vedere ciò che vuol vedere e perciò non vede più quello che è da vedere. È
lì per illustrare il non visto; rappresenta persone che non sono elettori,
funzioni degli elettori che non sono evidenti, avvenimenti fuori del campo
visuale, persone mute, persone non nate, rapporti tra le persone e le cose.
Ha un collegio elettorale di inafferrabili. E gli inafferrabili non possono
essere utilizzati per formare una maggioranza politica, perché l’elezione è
in ultima analisi una prova di forza, una battaglia sublimata, e l’esperto
non rappresenta alcuna forza immediatamente disponibile. Ma può
esercitare la forza interferendo nello schieramento delle forze. Rendendo
visibile l’invisibile mette un nuovo ambiente dinanzi a quelli che
esercitano la forza materiale, promuove in loro idee e sentimenti, li fa
spostare dalle posizioni precostituite, influendo perciò sulla decisione nel
modo più profondo.
Gli uomini non possono agire per molto tempo in un modo che
chiaramente contraddica la loro concezione dell’ambiente. Se si
intestardiscono ad agire in un certo modo, debbono ripensare l’ambiente,
debbono censurare, debbono razionalizzare. Ma se si trovano di fronte a un
fatto così insistente e lampante da non poter essere rimosso con una
spiegazione, possono scegliere una di queste tre vie. Possono
pervicacemente ignorarlo, anche se così facendo si ritroveranno menomati,
finiranno per strafare, e tutto gli andrà male. Possono tenerne conto, ma
rifiutarsi di agire; e in questo caso si sentono a disagio e frustrati. Oppure,
e io credo che sia il caso più frequente, adattano completamente il loro
comportamento all’ambiente allargato.
L’idea che l’esperto sia una persona incapace, perché lascia agli altri la
decisione, è assolutamente smentita dall’esperienza. Più sottili sono gli
elementi che entrano nella decisione, più irresponsabile diventa il potere
che egli detiene. Inoltre egli è certo che in futuro eserciterà più potere di
273
quanto abbia potuto esercitare in passato, perché i dati necessari alla
decisione sfuggiranno sempre più all’elettore e ai dirigenti. Tutti gli organi
amministrativi tenderanno a istituire centri di ricerca e di informazione,
che allungheranno dei tentacoli e si espanderanno come è avvenuto per
tutti i servizi di informazione di tutti gli eserciti del mondo. Ma gli esperti
resteranno esseri umani. Gusteranno il potere, e proveranno la tentazione
di autonominarsi censori e di assorbire la funzione decisoria vera e propria.
Finché la loro funzione non sarà correttamente definita tenderanno a
trasmettere i dati che giudicano convenienti e a dar corso alle decisioni che
approvano. Tenderanno, in breve, a diventare una burocrazia.
La sola salvaguardia istituzionale sta nel separare il più nettamente
possibile il personale che esegue dal personale che indaga. Dovrebbero
essere due gruppi paralleli, ma completamente distinti, assunti con metodi
diversi, pagati, se possibile, con fondi diversi, responsabili di fronte a capi
diversi, gli uni indifferenti al successo personale degli altri e viceversa.
Nell’industria, i revisori dei conti, i contabili e gli ispettori dovrebbero
essere indipendenti dal direttore, dai sovraintendenti, dai capireparto, e alla
lunga, credo, scopriremo che per esercitare un controllo sociale
sull’industria il meccanismo di documentazione dei dati dovrà essere
indipendente dai consigli d’amministrazione e dagli azionisti.
3.
Ma nell’accingerci a costruire i centri di informazione dell’economia e
della politica, noi non partiamo da un terreno sgombro. E del resto, dopo
avere insistito su questa fondamentale separazione di funzioni, sarebbe
inopportuno insistere con troppa precisione sulla forma che il principio
dovrebbe assumere nei casi particolari. Ci sono persone che credono nel
lavoro d’informazione, e lo adotteranno; ci sono persone che non lo
capiscono, ma non possono farne a meno per la loro attività; e ci sono
persone che si opporranno. Ma perché il principio faccia strada basterà che
si apra uno spiraglio in ogni organizzazione sociale, e il modo di
cominciare è cominciare. Nel governo federale, ad esempio, non è
necessario dipanare la matassa amministrativa e gli illogici doppioni di
un’espansione secolare, per trovare il posto adatto agli uffici
d’informazione di cui Washington ha tanto bisogno. Prima delle elezioni si
può promettere di gettarsi coraggiosamente nella breccia. Ma quando
finalmente si arriva trafelati alla breccia, si scopre che ogni assurdità si
fonda su consuetudini, forti interessi e deputati suadenti. Se si attacca su
tutta la linea reagiscono tutte le forze della reazione. Si va alla battaglia,
274
come diceva il poeta, e regolarmente si cade. Si può mozzare un ufficio
antiquato qui, infilzare un drappello di impiegati là, si possono unire due
uffici. E a questo punto ci si trova occupati con le tariffe doganali e le
ferrovie, e l’era delle riforme è passata. Inoltre, per attuare una
riorganizzazione veramente logica dell’amministrazione, come tutti i
candidati promettono di fare, si sarebbe costretti a suscitare più passioni di
quante si avrebbe tempo di sedare. E ogni nuovo sistema, supponendo di
averne uno pronto, richiederebbe funzionari che lo rendessero operante. Si
dica quello che si vuole dei funzionari, ma persino la Russia sovietica è
stata contenta di recuperare molti di quelli del vecchio regime; e questi
vecchi funzionari, se verranno trattati con troppa durezza, saboteranno
persino un’Utopia.
Nessun sistema amministrativo può funzionare senza la buona volontà,
e la buona volontà nei confronti dei nuovi metodi è impossibile senza una
educazione adatta. Il modo migliore è di inserire nel congegno esistente,
ovunque si riesca a trovare un appiglio, organi che servano
quotidianamente da specchio agli altri. Si può sperare così di rendere il
meccanismo visibile a quelli che lo manovrano, nonché ai capi che ne
portano la responsabilità e al pubblico esterno. Quando i funzionari
cominciano a vedersi – o piuttosto, quando gli estranei, i capi, e i
subordinati cominciano a vedere tutti gli stessi fatti, o se si preferisce, le
stesse prove schiaccianti – l’opposizione diminuirà. L’opinione del
riformatore, che un certo ufficio è inefficiente, è solo la sua opinione;
un’opinione che agli occhi dell’ufficio è meno attendibile della propria.
Ma basterà che il lavoro di quest’ufficio venga analizzato e illustrato, e poi
confrontato con quello di altri uffici e di aziende private, perché il discorso
si sposti su un altro piano.
A Washington dieci Dipartimenti sono rappresentati nel Gabinetto.
Supponiamo che in ciascuno di essi ci fosse un ufficio permanente di
ricerca. Quali potrebbero essere le condizioni per renderli efficaci?
Soprattutto che i funzionari addetti alla ricerca siano indipendenti sia dai
comitati parlamentari competenti per le materie dei rispettivi Dipartimenti,
sia dal Segretario titolare del Dipartimento; e che non debbano essere
coinvolti nella decisione o nell’azione. L’indipendenza quindi poggerebbe
su tre punti: sui fondi, sulle condizioni del rapporto di impiego e
sull’accesso ai fatti. Infatti è chiaro che se un’autorità parlamentare o
ministeriale può privarli dei fondi, licenziarli, o escluderli dagli archivi,
quei funzionari cadono in sua balía.
275
4.
La questione dei fondi è importante e difficile. Nessun ente di ricerca
può essere davvero libero se dipende dalla carità annuale di quello che può
essere un Congresso geloso o parsimonioso. Tuttavia non si può sottrarre
al potere legislativo il controllo ultimo dei fondi. Il congegno finanziario
deve garantire il personale di ricerca dagli attacchi obliqui, dai trabocchetti
e dai codicilli che possono danneggiarlo, da occulte manovre di
distruzione; e al tempo stesso deve consentire lo sviluppo dell’attività. Il
personale dev’essere così ben trincerato da obbligare chiunque voglia
attentare alla sua esistenza a operare alla luce del sole. Forse potrebbe
lavorare protetto da uno statuto federale che costituisca un fondo di
garanzia, e dall’assegnazione di una percentuale prestabilita dei fondi via
via assegnati al Dipartimento di cui fa parte. Ad ogni modo non si tratta di
ingenti somme di denaro: il fondo di garanzia potrebbe coprire i costi di
impianto e d’esercizio relativi all’organico iniziale, la percentuale potrebbe
coprire gli sviluppi. Comunque lo stanziamento dev’essere garantito da
ogni rischio, come si fa con qualsiasi obbligazione a lunga scadenza.
Questo è un modo molto meno grave di «legare le mani al Congresso» che
non sia l’approvazione di un emendamento costituzionale o l’emissione di
buoni del Tesoro. Il Congresso potrebbe revocare lo Statuto: ma dovrebbe
revocarlo, e non limitarsi a gettare bastoni tra le ruote.
Debbono essere inamovibili, debbono godere di una pensione generosa,
e di congedi ogni sette anni per studi e ricerche di aggiornamento e di
perfezionamento; e il loro eventuale licenziamento deve avvenire solo
dopo un giudizio formale pronunciato da un tribunale di colleghi. Debbono
valere qui le condizioni che si applicano a tutte le carriere intellettuali che
non hanno fini di lucro. Perché il lavoro possa essere rilevante, le persone
che lo svolgono debbono godere di una posizione di dignità, di sicurezza,
e, almeno ai gradi superiori, di quella libertà intellettuale che si trova solo
là dove gli individui non si debbono occupare direttamente delle decisioni
pratiche.
Il diritto di accesso ai dati e ai documenti deve essere stabilito
chiaramente nel provvedimento istitutivo. L’ufficio deve poter esaminare
tutti gli incartamenti e interrogare qualsiasi funzionario o estraneo.
Indagini continuative di questo genere non avrebbero nulla a che vedere
con le sensazionali inchieste parlamentari e le spasmodiche cacce che
ancora oggi sono un tratto normale del nostro sistema. L’ufficio deve avere
per legge il diritto di proporre al Dipartimento nuovi metodi contabili, e
qualora la proposta venga respinta, o violata dopo essere stata accettata, di
276
fare ricorso al Congresso.
Anzitutto l’ufficio di ricerca sarebbe l’anello di congiunzione tra il
Congresso e il Dipartimento di cui fa parte, un anello, a mio avviso,
migliore di quello rappresentato dalla richiesta di chiarimenti ai ministri in
sede di Camera di rappresentanti o di Senato; ma questa proposta non
esclude poi l’altro sistema.
L’ufficio sarebbe un po’ come l’occhio con cui il Congresso
sorveglierebbe l’applicazione della sua politica. Sarebbe anche lo scudo
del Dipartimento contro le critiche del Congresso. E poi, dato che le
attività del Dipartimento sarebbero permanentemente visibili, forse il
Congresso non sentirebbe più il bisogno di insistere in quella minuziosa
legiferazione, frutto della sfiducia e di una falsa interpretazione della
separazione dei poteri, che rende così difficile un efficiente funzionamento
dell’amministrazione.
5.
Ma naturalmente questi dieci uffici non dovrebbero lavorare a
compartimenti stagni. Nei loro reciproci rapporti sta la prospettiva più
sicura di quel «coordinamento» del quale si sente tanto parlare e si vede
così poco. Evidentemente sarebbe necessario che i vari uffici adottassero,
ove fosse possibile, omogenei criteri di valutazione. Si scambierebbero le
documentazioni. Così, se il Dipartimento della Difesa e quello delle Poste
comprano entrambi legname, ingaggiano carpentieri o costruiscono muri
in mattone, non debbono necessariamente farlo per mezzo dello stesso
ente,
perché
questo
potrebbe
portare
a
un’ingombrante
sovracentralizzazione; ma potrebbero usare la stessa misura per le stesse
cose, essere consapevoli dei confronti ed essere trattati come concorrenti.
E quanta più concorrenza di questo tipo ci fosse, tanto meglio sarebbe.
Infatti il valore della concorrenza è determinato dal valore dei criteri
usati per misurarla. E allora, invece di chiederci se crediamo nella
concorrenza, dobbiamo chiederci se crediamo nelle cose per cui i
concorrenti concorrono. Nessuna persona sensata pretende di «abolire la
concorrenza», perché quando l’ultimo vestigio dell’emulazione fosse
scomparso, lo sforzo sociale consisterebbe nell’osservanza meccanica di
una routine, mitigata nella minoranza dall’aspirazione naturale.
D’altronde, nessuno aspira a portare la concorrenza alle sue logiche
conclusioni, cioè a una lotta micidiale di ognuno contro tutti. Il problema è
di scegliere gli obiettivi della concorrenza e le regole del gioco. Quasi
sempre queste ultime saranno determinate dal metro più visibile e ovvio: il
277
denaro, il potere, la popolarità, l’approvazione o lo «spreco ostentato» di
Veblen. Quali altri criteri di misurazione offre normalmente la nostra
civiltà? In che modo misura l’efficienza, la produttività, il servizio, le cose
cioè che continuamente reclamiamo?
In genere non ci sono misure, e quindi non c’è molta concorrenza alla
realizzazione di questi ideali. Infatti la differenza tra i moventi alti e quelli
bassi non è, come gli uomini spesso affermano, una differenza tra
altruismo e egoismo1, ma la differenza tra l’operare per fini facilmente
comprensibili e l’operare invece per fini oscuri e vaghi. Incoraggiate un
uomo a conseguire un profitto maggiore del suo vicino: egli saprà a che
cosa mirare. Esortatelo ad essere più utile alla società: e come fa a sapere
che cosa sia socialmente più utile? Qual è il punto di riferimento? Qual è la
misura? Un sentimento soggettivo, è opinione di qualcuno. Dite a un uomo
in tempo di pace che deve servire il suo paese, e avrete pronunciato
nient’altro che una pia banalità. Ditegli la stessa cosa in tempo di guerra, e
la parola servire acquisterà un significato; significherà degli atti concreti,
l’arruolarsi, l’acquistare buoni del Tesoro, il non sprecare il cibo, il
lavorare per un dollaro all’anno, e ciascuno di questi servizi sarà ai suoi
occhi parte integrante dell’obiettivo concreto di mandare al fronte un
esercito più numeroso e meglio armato di quello nemico.
E così, quanto meglio si riesce ad analizzare l’amministrazione e a
escogitare elementi suscettibili di raffronto, e quanto meglio si riesce a
inventare misure quantitative per le qualità che si desidera promuovere,
tanto più facilmente si può indirizzare la concorrenza verso fini ideali. Se
si riesce a escogitare i numeri indici che vanno bene2, si può creare una
situazione di concorrenza tra i singoli operai di un’officina; tra le officine;
tra le fabbriche; tra le scuole3; tra i Dipartimenti statali; tra i reggimenti; tra
le divisioni; tra le navi; tra gli stati, le contee, le città; e tanto più utile sarà
la concorrenza quanto migliori saranno i numeri indici.
6.
Le possibilità insite nello scambio di materiale sono evidenti. I
Dipartimenti dell’amministrazione pubblica chiedono continuamente
informazioni che forse sono già state ottenute da un altro Dipartimento,
magari in una forma un po’ diversa. Il Dipartimento di stato ha bisogno di
sapere, poniamo, l’entità delle risorse messicane di petrolio, quale
percentuale rappresentino delle risorse mondiali, chi possieda attualmente i
giacimenti petroliferi messicani, l’importanza del petrolio per le corazzate
in costruzione o in programma, i costi comparati di vari giacimenti. Come
278
si procura oggi queste informazioni? I dati probabilmente sono dispersi tra
i dipartimenti dell’Interno, della Giustizia, del Commercio, del Lavoro e
della Marina. Delle due l’una: o un impiegato del Dipartimento di stato fa
una ricerca sul petrolio messicano su un testo specializzato, che può essere
preciso come può anche non esserlo, oppure il segretario particolare di
qualcuno telefona al segretario particolare di qualcun altro per chiedere un
promemoria, e dopo qualche tempo arriva un commesso negro con una
bracciata di documenti incomprensibili. Invece il Dipartimento dovrebbe
poter invitare il suo ufficio di ricerca e documentazione a raccogliere i dati
in forma utile al problema diplomatico che sta sul tappeto. E questi dati
l’ufficio di ricerca del Servizio diplomatico li otterrebbe dalla stanza di
compensazione centrale1.
Questa organizzazione diventerebbe ben presto un centro di
informazioni straordinario. E lavorando per essa si acquisterebbe una
precisa consapevolezza di ciò che realmente sono i problemi del
governare. Si affronterebbero i problemi di definizione, di terminologia, di
tecnica statistica, di logica; si attraverserebbe concretamente l’intera
gamma delle scienze sociali. Non si vede perché tutto questo materiale,
fatta eccezione per alcuni segreti diplomatici e militari, non dovrebbe
essere accessibile agli studiosi del paese. È qui che lo scienziato politico
troverebbe le vere noci da schiacciare e le vere ricerche da affidare ai suoi
studenti. Non è necessario che tutto il lavoro venga fatto a Washington, ma
potrebbe essere compiuto tenendo presente Washington. L’organizzazione
neutrale avrebbe allora in sé i germi di un’università nazionale. Il
personale dei singoli uffici potrebbe essere reclutato da quest’organo
centrale tra i laureati. Questi ultimi svolgerebbero tesi scelte previa
consultazione tra i dirigenti dell’università nazionale e professori di tutto il
paese. Se l’associazione fosse elastica, come dovrebbe essere, si avrebbe,
oltre al personale fisso, un regolare avvicendamento di incaricati speciali e
temporanei provenienti dalle università, e inoltre le università potrebbero
sistematicamente invitare i funzionari degli uffici di ricerca di Washington
a tenere dei corsi. In questo modo la preparazione e il reclutamento del
personale procederebbero di pari passo. Una parte della ricerca stessa
verrebbe svolta da studenti, e la scienza politica delle università verrebbe a
collegarsi alla politica del paese.
7.
Nei suoi tratti fondamentali il principio è altrettanto applicabile ai
governi dei singoli stati regionali e alle amministrazioni urbane e rurali.
279
L’attività di raffronto e interscambio potrebbe essere svolta da federazioni
degli uffici di ricerca degli stati; delle amministrazioni urbane e di quelle
di contea. E all’interno di queste federazioni si potrebbero organizzare
tutte le combinazioni regionali opportune. Molti doppioni potrebbero
essere evitati, se i sistemi amministrativi fossero omogenei.
Particolarmente opportuno è il coordinamento regionale; infatti le frontiere
legali spesso non coincidono con gli ambienti reali. Tuttavia hanno una
certa base tradizionale, che costerebbe troppo turbare. Coordinando le loro
informazioni, varie circoscrizioni amministrative potrebbero conciliare
l’autonomia della decisione con la collaborazione. La città di New York,
ad esempio, è già ora un’unità amministrativa troppo grossa perché il
municipio possa amministrarla bene. Tuttavia, a molti effetti, come ad
esempio quello della sanità e dei trasporti, il distretto metropolitano è
l’unità amministrativa ottimale. Questo distretto, però, comprende grandi
città come Yonkers, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Hoboken, Bayonne.
Non potrebbero essere amministrate da un unico centro, e tuttavia
dovrebbero svolgere insieme molte funzioni. Forse alla lunga la soluzione
più adatta potrebbe essere un sistema elastico di amministrazione locale,
come quella che hanno suggerito Sydney e Beatrice Webb1. Ma il primo
passo dovrebbe essere il coordinamento, non delle decisioni e delle
attività, ma dell’attività di ricerca e documentazione. Occorre che i
funzionari delle varie municipalità vedano i problemi comuni alla luce
degli stessi fatti.
8.
Sarebbe poco realistico negare che una rete siffatta di uffici di ricerca
operante nella politica e nell’economia potrebbe diventare un peso morto e
una continua fonte di attriti. È facile immaginare il suo potere di attrazione
su persone in cerca di sinecure, sui pedanti, sui ficcanaso. Si possono
immaginare lungaggini burocratiche, montagne di scartafacci, moduli a
non finire, sette copie di ogni documento, controfirme, rinvii, documenti
smarriti, l’uso del modulo 136 invece del modulo 29B, la restituzione del
documento perché si è usata la matita invece dell’inchiostro, o l’inchiostro
nero invece di quello rosso. Il lavoro potrebbe essere fatto anche molto
male: nessuna istituzione è mai del tutto protetta dalla stupidità.
Ma se ci fosse circolazione in tutto il sistema tra Dipartimenti federali,
fabbriche, uffici e università – circolazione di uomini, circolazione di dati
e di critica – i rischi della putrefazione non sarebbero poi così gravi. E non
sarebbe giusto dire che questi uffici di ricerca complicherebbero la vita. Al
280
contrario, tenderanno a semplificarla, rendendo chiara una complessità che
oggi è talmente grande da essere umanamente incontrollabile. L’attuale,
fondamentale invisibile sistema di governo è così intricato che la maggior
parte delle persone hanno rinunciato al tentativo di tenergli dietro. E
siccome non ci provano nemmeno, sono tentate di immaginarselo come
relativamente semplice. Invece è elusivo, occulto, opaco. L’impiego di un
sistema di ricerca e documentazione significherebbe una riduzione di
personale per unità di risultato, perché, rendendo accessibile a tutti
l’esperienza di ciascuno, ridurrebbe l’entità degli esperimenti e degli
errori; e perché, rendendo visibile il processo sociale, condurrebbe il
personale all’autocritica. Non comporta un grande incremento del numero
dei funzionari, se si tiene conto del tempo oggi sprecato da comitati
speciali di investigazione, giurie inquirenti, procuratori distrettuali,
organizzazioni di riforma e autorità disorientate, a cercare una via d’uscita
attraverso una nera confusione.
Se l’analisi dell’opinione pubblica e delle teorie democratiche, in
rapporto all’ambiente moderno, è in linea di principio giusta, non vedo
come si possa sfuggire alla conclusione che un’attività di ricerca siffatta è
la chiave del progresso. Non mi riferisco ai pochi suggerimenti esposti in
questo capitolo: sono soltanto degli esempi. Il compito di elaborare una
tecnica spetta a coloro che sono preparati a questo, e nemmeno loro
possono oggi prevedere del tutto quali forme assumerà, e tanto meno i
dettagli. Ancora oggi sono ben pochi i fenomeni sociali di cui si possieda
una documentazione, gli strumenti dell’analisi sono molto rozzi, i concetti
spesso sono vaghi e acritici. Ma si è già fatto abbastanza, mi sembra, per
dimostrare che gli ambienti non visti possono essere riferiti efficacemente,
che possono essere riferiti a gruppi in discordia tra loro in un modo
neutrale rispetto ai loro pregiudizi, e capace di indurli a superare il loro
soggettivismo.
Se questo è vero, allora gli uomini, nel rendere operante il principio
della ricerca e della documentazione, troveranno il modo di superare
quella che è la difficoltà centrale dell’autogoverno: la difficoltà di
affrontare la realtà che non si vede. Proprio a causa di queste difficoltà,
nessuna comunità autogovernantesi è riuscita finora a conciliare la sua
necessità di isolamento con la necessità di ampi contatti, a conciliare la
dignità e l’individualità della decisione locale con la sicurezza e un largo
coordinamento, ad assicurarsi capi reali senza sacrificare la responsabilità,
ad avere opinioni pubbliche utili senza tentare di avere opinioni pubbliche
universali su tutti i problemi. Mancando la possibilità di stabilire
interpretazioni comuni delle realtà non viste, misure comuni per atti
281
diversi, la sola immagine della democrazia che potesse funzionare, anche
in teoria, è stata quella fondata sulla comunità isolata, le cui facoltà
politiche erano limitate, secondo la famosa massima di Aristotele, dal
raggio della loro visione.
Ma ora c’è una via d’uscita – a lungo termine, beninteso – ma pur
sempre una via d’uscita. È fondamentalmente la stessa via che ha
consentito al cittadino di Chicago, fornito di vista e di udito non migliori di
quelli dell’Ateniese, di vedere e di udire da grandi distanze. Oggi è
possibile – e sarà sempre più possibile a misura che crescerà l’impegno –
ridurre le discrepanze tra l’ambiente immaginato e l’ambiente reale. A
mano a mano che questo si avvererà, il federalismo funzionerà sempre più
per consenso, e sempre meno per coercizione. Infatti il federalismo, pur
essendo il solo metodo possibile di unione tra gruppi autogovernanti1,
oscilla tra la centralizzazione imperiale e l’anarchia campanilistica,
qualora l’unione non sia fondata su concetti giusti e comunemente accettati
dell’ambito federale. Questi concetti non sorgono spontaneamente: devono
esser messi insieme pezzo a pezzo mediante una generalizzazione fondata
sull’analisi, e gli strumenti di quest’analisi debbono essere inventati e
verificati per mezzo della ricerca.
Le riforme elettorali, i rimaneggiamenti territoriali, i mutamenti del
sistema di proprietà, non toccano la radice della questione. Non si può
ricavare dagli uomini più saggezza politica di quella che hanno. E, per
sensazionale che possa essere, nessuna riforma, la quale non fornisca
consapevolmente il modo di superare il soggettivismo dell’opinione umana
basato sulla limitazione dell’esperienza umana, è veramente radicale.
Esistono sistemi di governo, elettorali, e di rappresentanza che rendono di
più degli altri. Ma in ultima analisi la conoscenza non deve venire dalla
coscienza, ma dall’ambiente con cui la coscienza ha a che fare. Quando gli
uomini agiscono in base al principio della ricerca e della documentazione,
vanno a cercare i fatti e a formarsi una loro saggezza. Quando lo
trascurano, rientrano in se stessi e trovano soltanto ciò che hanno dentro. E
così elaborano i loro pregiudizi invece di accrescere le loro conoscenze.
282
XXVII.
L’appello al pubblico
1.
Nella vita reale nessuno agisce pensando di poter avere un’opinione
pubblica su ogni questione pubblica, benché la cosa spesso non appaia, in
quanto l’individuo pensa che non ci siano questioni pubbliche dal
momento che egli non ha opinioni pubbliche. Ma nella teoria politica
continuiamo a pensare più letteralmente di quanto intendesse Lord Bryce
che «l’azione dell’Opinione è continua»1, benché «la sua azione […] si
riferisca solo ai principi generali»2. E poi, dato che siamo portati a
immaginare di avere continuamente delle opinioni, senza però essere del
tutto certi di cosa sia un principio generale, accogliamo spontaneamente
con uno sbadiglio angosciato una tesi che sembra comportare la lettura di
altri rapporti governativi; altre statistiche, altre curve e altri grafici. Infatti
tutto ciò a prima vista può confondere quanto la retorica di partito, ed è
molto meno divertente.
Indubbiamente è piuttosto scarsa l’attenzione disponibile per un
sistema in cui si presuma che tutti i cittadini della nazione, dopo essersi
dedicati alle pubblicazioni di tutti gli uffici di ricerca, diverrebbero vigili,
informati e attenti alla moltitudine di questioni reali che non si inquadrano
mai troppo bene in un principio generale. Infatti non si pretende tanto.
Innanzitutto l’ufficio di ricerca è uno strumento dell’uomo d’azione, del
rappresentante investito di potere decisorio, del lavoratore in sede di
lavoro, e se non è utile a loro, alla fin fine non sarà mai utile a nessuno. Ma
nella misura in cui li aiuta a comprendere l’ambiente in cui lavorano, rende
visibile ciò che fanno. E in quella misura diventano più responsabili verso
il pubblico in generale.
L’intento, quindi, non è di seppellire ogni cittadino sotto un cumulo di
opinioni esperte su tutte le questioni, ma di allontanare da lui questo
fardello per metterlo sulle spalle dell’amministratore responsabile. Un
sistema di ricerca vale, naturalmente, come fonte di notizie generali, e
come controllo sulla stampa quotidiana. Ma ciò è secondario. La sua vera
utilità è come aiuto al governo rappresentativo e all’amministrazione sia
politica che economica. La richiesta dell’aiuto di cronisti esperti, sotto
283
forma di contabili, statistici, segretarie, e simili, non viene dal pubblico,
ma da persone che svolgono attività pubbliche, e che non possono più
svolgerle in maniera approssimativa. Per natura, e anche in teoria, è uno
strumento per svolgere meglio le attività pubbliche piuttosto che per sapere
meglio quali sono le pecche di queste attività pubbliche.
2.
Come privato cittadino, come elettore sovrano, nessuno riuscirebbe a
digerire questi documenti. Ma chi è parte in causa in una vertenza, o
membro di una commissione legislativa, o funzionario governativo,
industriale, sindacale, o membro di un’associazione industriale, accoglierà
sempre più favorevolmente le documentazioni riguardanti la specifica
materia in discussione. Il privato cittadino che si interessa a qualche causa
aderirebbe, come fa oggi, ad associazioni volontarie, il cui personale
studierebbe i documenti e presenterebbe relazioni utili per controllare le
autorità responsabili. Questo materiale verrebbe studiato da qualche
giornalista, ma soprattutto da esperti e da scienziati della politica. Ma il
profano, e tutti noi siamo dei profani riguardo a quasi tutti gli aspetti della
vita moderna, non ha il tempo né l’attenzione né l’interesse né la
preparazione per dare giudizi specifici. È sulle persone che stanno
addentro alle cose, sempre che le condizioni in cui lavorano siano normali,
che le amministrazioni ordinarie delle società debbono poggiare.
Il pubblico dei profani può giudicare se queste condizioni siano normali
solo sulla base dei risultati delle attività, e della procedura seguita prima
dell’atto concreto. I principi generali sui quali l’azione dell’opinione
pubblica può svolgersi con continuità sono essenzialmente principi di
procedura. Il profano può chiedere agli esperti di dirgli se i dati pertinenti
siano stati debitamente considerati; nella maggior parte dei casi non può
decidere lui che cosa sia pertinente, o che cosa significhi prendere in
debita considerazione. Il profano può forse giudicare se i gruppi interessati
alla decisione siano stati opportunamente sentiti, se la votazione, qualora
fosse richiesta, si sia svolta correttamente, e forse anche se il risultato sia
stato lealmente accettato. Può seguire la procedura quando le notizie
indicano che c’è qualcosa da seguire. Può mettere in dubbio che la
procedura sia giusta, se i suoi risultati ordinari contraddicono al suo ideale
della vita1. Ma se cerca sistematicamente di sostituirsi alla procedura, di
fare intervenire l’Opinione Pubblica nel modo in cui lo zio provvidenziale
appare nelle crisi delle commedie, complicherà la propria confusione. Non
riuscirà a svolgere logicamente una serie di pensieri.
284
Infatti la consuetudine di appellarsi al pubblico per questioni
complicatissime tradisce quasi sempre il desiderio di evitare le critiche dei
competenti, reclutando una larga maggioranza che non ha avuto alcuna
possibilità di informarsi. Si fa dipendere il verdetto da chi ha la voce più
forte o più suadente, l’agente pubblicitario più abile o più sfrontato, i
contatti migliori per far parlare di sé i giornali. Infatti anche quando il
direttore è scrupolosamente equo verso «l’altra parte», l’equità non è
sufficiente. Possono esserci varie altre parti, sottaciute dai parteggianti
organizzati, finanziati e attivi.
Il cittadino privato, assediato da appelli di parte che gli chiedono in
pegno la sua Opinione Pubblica, forse si accorgerà ben presto che questi
appelli non sono un complimento alla sua intelligenza, ma un abuso della
sua buona fede e un insulto al suo senso critico. A misura che la sua
coscienza civile gli consentirà di rendersi conto della complessità del suo
ambiente, egli si preoccuperà dell’equità e della sensatezza della
procedura, ma anche su questo pretenderà nella maggior parte dei casi che
la vigilanza sia esercitata in suo nome dal rappresentante che egli ha eletto.
Si rifiuterà di accettare l’onere di queste decisioni, e quasi sempre
avverserà quelli che, nella fretta di vincere, lasciano il tavolo delle
trattative per precipitarsi a dare le prime notizie ai giornali.
Solo insistendo perché i problemi non gli vengano sottoposti se non
dopo essere passati attraverso una procedura, il cittadino indaffarato di uno
stato moderno può sperare di affrontarli in forma comprensibile. Infatti i
problemi, come li formula la parte in causa, quasi sempre consistono in
una serie di fatti complicata, come la parte stessa li ha visti, circondata da
un’abbondante massa di frasi stereotipate pervase dalle sue emozioni.
Secondo la moda del giorno, uscirà dalla sala delle trattative sostenendo
che ciò che vuole è una nobile idea come la Giustizia, il Bene Comune,
l’americanismo, il Socialismo. Con questi stimoli talvolta il cittadino
comune può essere indotto alla paura o all’ammirazione, ma al giudizio
mai. Prima che egli riesca ad affrontare in qualche modo la questione, si
deve depurare quest’ultima di tutti gli elementi superflui.
3.
Questo risultato può essere raggiunto qualora i rappresentanti discutano
alla presenza di qualcuno, presidente o mediatore, che costringa la
discussione ad affrontare le analisi fornite dagli esperti. Dev’essere questa
l’organizzazione fondamentale di un organo rappresentativo che affronti
questioni lontane. I portavoce delle parti interessate debbono esser
285
presenti, ma debbono trovarsi a confronto con persone, non personalmente
coinvolte, che abbiano un sufficiente controllo dei dati di fatto, e
possiedano l’abilità dialettica per distinguere ciò che è percezione reale da
ciò che è stereotipo, schema e complicazione. È in fondo il dialogo
socratico, compresa l’energia che Socrate impiegava per penetrare,
attraverso le parole, sino ai significati; e anche qualcosa di più di questo,
perché la dialettica nella vita moderna dev’essere esercitata da uomini che
abbiano esplorato, oltre alla mente umana anche l’ambiente.
Supponiamo, ad esempio, che ci sia una seria vertenza nell’industria
dell’acciaio. Ciascuna delle parti pubblica un manifesto traboccante di
altissimi ideali. In questa fase la sola opinione pubblica che meriti rispetto
è l’opinione che sostiene la necessità che si aprano trattative. Non ci può
essere molta simpatia per la parte la quale sostiene che la sua causa è
troppo giusta per poterla contaminare con delle trattative, perché tra gli
esseri umani non ci può essere una causa come questa. Forse quelli che si
oppongono alle trattative non si esprimono proprio in questo modo. Forse
dicono che la parte avversaria è troppo malvagia; non possono stringere la
mano a dei traditori. Allora tutto quello che l’opinione pubblica può fare in
questo caso è di organizzare un’udienza presieduta da pubbliche autorità
per ascoltare le prove della malvagità. Non può prendere per buona la
parola dei diretti interessati. Ma supponiamo che ci si accordi
sull’opportunità di trattative, e supponiamo che ci sia un presidente
neutrale, che abbia ai suoi ordini gli esperti consulenti dell’azienda, del
sindacato, e, poniamo del Dipartimento del Lavoro.
Il giudice Gary dichiara in tutta sincerità che i suoi operai sono ben
pagati e non sfruttati, e poi passa a tracciare la storia della Russia dal
tempo di Pietro il Grande all’assassinio dello zar. Il signor Foster s’alza,
dichiara con altrettanta sincerità che gli operai sono sfruttati, e poi passa a
tracciare la storia dell’emancipazione umana da Gesù Nazareno ad
Abramo Lincoln. A questo punto il presidente chiede agli esperti le tabelle
salariali, per poter sostituire alle parole «ben pagati» e «sfruttati» una
tabella indicante le paghe delle diverse categorie. Pensa il giudice Gary
che siano ben pagati? Lo pensa. Pensa il signor Foster che siano tutti
sfruttati? No, pensa che i gruppi C, M e X siano sfruttati. Che cosa intende
per sfruttati? Intende che non viene loro corrisposto un salario sufficiente
per vivere. E invece il salario è sufficiente, dice il giudice Gary. Che cosa
può comprare una persona con quel salario?, chiede il presidente. Nulla,
dice il signor Foster. Tutto quello che gli serve, dice il giudice Gary. Il
presidente consulta le statistiche dei bilanci familiari e dei prezzi redatte
dal governo1. Decide che il gruppo X può far fronte a un bilancio medio,
286
ma che i gruppi C e M non possono. Il giudice Gary comunica che non
considera esatte le statistiche ufficiali: i bilanci familiari sono troppo alti e
in ogni caso i prezzi sono scesi. Anche il signor Foster comunica
un’obiezione: il bilancio è troppo basso e i prezzi sono saliti. Il presidente
decide che questo punto non rientra nella competenza della riunione in
corso, che le cifre ufficiali restano valide, e che gli esperti del giudice Gary
e del signor Foster dovranno far ricorso al comitato permanente degli
uffici di ricerca confederati.
E a parte tutto, dice il giudice Gary, se si modificano queste tabelle
salariali noi saremo rovinati. Che cosa intende per rovinati?, chiede il
presidente: esibisca i suoi libri mastri. Non posso, sono privati, dice il
giudice Gary. Quello che è privato non ci interessa, replica il presidente; e
perciò redige un comunicato per il pubblico in cui si afferma che i salari
dei lavoratori dei gruppi C e M stanno di tanto e tanto al di sotto del
minimo vitale ufficiale, e che il giudice Gary si rifiuta di aumentarli per
ragioni che preferisce non comunicare. Dopo una procedura di questo tipo,
si può avere un’opinione pubblica nel senso elogiativo del termine2.
Il valore della mediazione dell’esperto non sta nel fatto che crea
un’opinione per forzare le parti in causa, ma nel fatto che disintegra la
partigianeria. Il giudice Gary e il signor Foster sono forse tanto poco
persuasi quanto lo erano in partenza, sebbene anch’essi dovrebbero ormai
esprimersi in un altro tono. Ma quasi tutti gli altri, che non erano
personalmente coinvolti, si risparmierebbero di venire coinvolti loro
malgrado. Infatti questo tipo di dialettica districa gli stereotipi e gli slogan
intralciati e fuorvianti, a cui i loro riflessi sono così pronti a reagire.
4.
In molte materie di grande importanza pubblica, e in gradi diversi tra
persone diverse anche in materie più personali, i fili della memoria e del
sentimento sono aggrovigliati. la stessa parola designa le idee più diverse:
le emozioni vengono spostate dalle immagini a cui appartengono a nomi
che somigliano ai nomi di quelle immagini. Nelle parti della mente in cui
non opera il senso critico avvengono facilmente associazioni per semplice
assonanza, contatto e successione. Ci sono attaccamenti emotivi liberi, ci
sono parole che erano nomi e sono maschere. Nei sogni, nelle
fantasticherie e nei momenti di panico scopriamo una dose di disordine
sufficiente per comprendere come sia fatta la mente ingenua, e come si
comporti quando non è disciplinata da uno sforzo cosciente e dalle
resistenze esterne. Ci rendiamo conto che non c’è più ordine naturale di
287
quanto se ne possa trovare in una vecchia soffitta polverosa. C’è spesso la
stessa incongruenza tra il fatto, l’idea e l’emozione, che ci potrebbe essere
in un teatro lirico in cui tutti i costumi fossero stati gettati in un mucchio e
tutti gli spartiti mischiati assieme, cosicché Madama Butterfly vestita da
Valchiria stesse ad aspettare liricamente il ritorno di Faust.
Nella stagione natalizia – dice un editoriale – vecchi ricordi inteneriscono il
cuore, ci si sovviene di santi insegnamenti e la mente si volge all’infanzia. Il mondo
non sembra così malvagio quando lo si vede attraverso il velo del ricordo felice e
triste dei cari che hanno raggiunto Dio. Nessun cuore è restato insensibile a quella
misteriosa influenza […]. Il paese è crivellato dalla propaganda rossa: ma abbiamo
abbondanza di corda, muscoli e lampioni […] finché il mondo lo gira, lo spirito
della libertà arderà nel petto dell’uomo.
La persona che ha trovato nella sua mente queste frasi ha bisogno di
assistenza. Ha bisogno di un Socrate che isoli le parole, lo interroghi
finché egli non le abbia definite e rese nomi di idee; e non le abbia legate a
un particolare oggetto e a nient’altro. Infatti queste sillabe piene di
tensione si sono connesse nella sua mente per effetto di un’associazione
primitiva, e sono tenute assieme dai ricordi del Natale, della sua
indignazione di conservatore e dai suoi brividi di erede di una tradizione
rivoluzionaria. A volte il groviglio è troppo grosso e antico per poter
essere rapidamente districato. Altre volte, come nella moderna
psicoterapia, ci sono vari strati di memoria che risalgono sino all’infanzia,
e che debbono essere separati e identificati.
L’effetto di indicare con nomi, l’effetto cioè di dire che i gruppi di
operai C e M, ma non X, sono sottoretribuiti, invece di dire che i
Lavoratori sono Sfruttati, è incisivo. Le percezioni recuperano la loro
identità, e l’emozione che suscitano è specifica, non essendo più rinforzata
da connessioni grossolane e casuali con tutto quanto, dal Natale a Mosca.
L’idea isolata con un nome proprio è un’emozione che sia stata vagliata
criticamente, è sempre molto più aperta alla possibilità di essere corretta da
nuovi dati. Era affondata in tutta la personalità, aveva in qualche modo
affiliazioni che coinvolgevano tutto l’io: una sfida suscitava reazioni in
tutta l’anima. Ma dopo essere stata compiutamente criticata, l’idea non è
più me, ma quella. È stata resa oggettiva, ed allora è tenuta a distanza. Il
suo destino non è legato al mio, ma al destino del mondo esterno su cui io
agisco.
5.
288
Una rieducazione di questo genere contribuirà a portare le nostre
opinioni pubbliche a contatto con l’ambiente. È questo il modo per poter
liquidare l’immane apparato di censura, di creazione di stereotipi e di
drammatizzazione dei fatti oggi esistente. Quando non c’è difficoltà a
conoscere qual è l’ambiente pertinente, il critico, l’insegnante, il medico
possono sciogliere i nodi della mente. Ma quando l’ambiente riesce oscuro
all’analista come lo è l’allievo, la tecnica analitica non è sufficiente. Si
rende necessario il lavoro di ricerca e di documentazione. Per quanto
riguarda i problemi politici e industriali, il critico come tale può fare
qualche cosa, ma la sua dialettica non può andare molto lontano, se non è
sicuro di poter ricevere dagli esperti un valido quadro dell’ambiente.
Perciò, benché anche qui, come in quasi tutti i campi, l’«educazione»
sia il rimedio supremo, il valore di questa educazione dipenderà
dall’evoluzione della conoscenza. E la nostra conoscenza delle istituzioni
umane è ancora straordinariamente scarsa e impressionistica. La raccolta
dei dati sociali è nel complesso ancora occasionale; non è, come dovrà
diventare, il normale accompagnamento dell’azione. E tuttavia la raccolta
delle notizie non verrà fatta, si può star sicuri, in vista del suo impiego
ultimo. Verrà fatta perché la decisione moderna richiede che sia fatta. Ma
nel corso di questa raccolta si accumulerà un complesso di dati che la
scienza politica può tradurre in generalizzazioni e ordinare a beneficio
delle scuole in un quadro concettuale del mondo. Quando questo quadro
prende forma, l’educazione civica può diventare una preparazione ad
affrontare l’ambiente che non si vede.
Quando l’insegnamento comincia ad avere a disposizione un modello
operante del sistema sociale, può usarlo per rendere l’allievo
adeguatamente consapevole del modo in cui la sua mente agisce di fronte
ai fatti ignoti. In mancanza di questo modello l’insegnante non può sperare
di preparare pienamente gli uomini al mondo in cui debbono vivere. Ciò
che può fare è prepararli ad affrontare questo mondo con un atteggiamento
molto più disincantato di fronte ai propri processi mentali. Con l’ausilio
del metodo dei casi specifici, può insegnare all’allievo l’abitudine di
esaminare le fonti della sua informazione. Può insegnargli, ad esempio, a
fare attenzione al luogo di provenienza della notizia stampata nel suo
giornale, al nome del corrispondente, al nome dell’agenzia di stampa,
all’autorità a cui si appoggia la dichiarazione, alle circostanze in cui la
dichiarazione è stata ottenuta. Può insegnare all’allievo a chiedersi se il
cronista abbia descritto in passato altri avvenimenti. Può chiarirgli il
carattere della censura, dell’idea di segretezza, e fornirgli notizie sulla
propaganda precedente. Utilizzando opportunamente la storia, può
289
renderlo cosciente dello stereotipo, e può coltivare in lui l’abitudine
all’introspezione riguardo alle immagini suscitate dalle parole stampate.
Per mezzo di corsi di storia comparata e di antropologia, può dargli una
consapevolezza permanente del modo in cui i codici impongono
all’immaginazione uno stampo particolare. Può insegnare agli individui a
cogliersi nell’atto di costruire allegorie, di drammatizzare rapporti e di
personificare astrazioni. Può mostrare all’allievo in che modo egli si
identifichi con queste allegorie, come arrivi a immedesimarvisi, e come
scelga l’atteggiamento, eroico, romantico, economico, che adotterà nel
sostenere una particolare opinione.
Lo studio dell’errore non solo è straordinariamente profilattico, ma
serve anche da stimolante introduzione allo studio della verità. A mano a
mano che le nostre menti diventano sempre più consapevoli della loro
soggettività, troviamo in esse un gusto del metodo obiettivo che altrimenti
non ci sarebbe. Vediamo, con una chiarezza che normalmente non
avremmo, l’enorme danno e l’irriflessiva crudeltà dei nostri pregiudizi. E
la distruzione di un pregiudizio, anche se in un primo momento è dolorosa
perché è legato al nostro orgoglio, dà un immenso sollievo e una sottile
fierezza quando è compiuta. Si estende in modo radicale il campo
dell’attenzione monolitica del mondo. La scienza diventa vivace e piena.
Ne segue un forte incentivo a un sincero apprezzamento del metodo
scientifico, che diversamente è difficile suscitare ed è impossibile
mantenere. I pregiudizi sono molto più comodi e interessanti. Infatti se si
insegnano i principi della scienza come se fossero stati sempre accettati, la
loro principale virtù morale, che è l’obiettività, li renderà noiosi. Ma se li
si insegna in un primo momento come vittorie sulle superstizioni della
mente, la gioia della caccia e della conquista può servire a far superare
all’allievo quella dura transizione dall’esperienza limitata di se stesso alla
fase in cui la sua curiosità è diventata matura, e la sua ragione ha
acquistato passione.
290
XXVIII.
L’appello alla ragione
1.
Ho scritto e scartato vari finali di questo libro. Ma su tutti incombeva
quella fatalità dei capitoli conclusivi, in cui ciascuna idea sembra trovare il
suo posto e tutti i misteri che lo scrittore non abbia dimenticato vengano
svelati. Nella politica il protagonista non vive per sempre felice e contento,
né conclude la sua esistenza in modo perfetto. Non c’è capitolo
conclusivo, perché in politica il protagonista ha davanti a sé più futuro che
non storia documentata dietro a sé. L’ultimo capitolo è semplicemente il
punto in cui lo scrittore si immagina che il lettore educato abbia
cominciato a dare sguardi furtivi all’orologio.
2.
Quando Platone arrivò al punto in cui era il caso di tirare le somme, la
sua sicurezza si tramutò in panico al pensiero di quanto sarebbe suonato
assurdo ciò che egli sentiva riguardo al posto spettante alla ragione nella
politica. Anche per Platone era difficile pronunciare quelle frasi del libro V
della Repubblica: sono così assolute e austere che gli uomini non riescono
né a dimenticarle né a vivere secondo il loro insegnamento. Così fa dire a
Socrate, rivolto a Glaucone, che verrebbe accolto dalle più matte risate se
dicesse qual è il minimo cambiamento perché uno stato passi alla forma
più vera, perché il pensiero che avrebbe voluto pronunciare, se non fosse
sembrato troppo stravagante era che «a meno che o i filosofi non regnino
nelle città, o quelli che oggi han nome di re e di sovrani non prendano a
nobilmente e acconciamente filosofare, e non vengano a coincidere la
forza politica e la filosofia, e i vari tipi che ora tendono separatamente a un
dei due campi non ne siano per forza esclusi […] non avran tregua alcuna
dai mali le città, anzi credo neppure il genere umano»1.
Aveva appena pronunciato queste terribili parole che si rese conto di
aver pronunciato un invito alla perfezione, e si sentì imbarazzato per
l’irraggiungibile grandezza della sua idea. Così si affretta ad aggiungere
che, naturalmente, «il vero esperto pilotaggio» sarà chiamato «uno con la
291
testa per aria, un chiacchierone»2. Ma quest’amara ammissione, pur
proteggendolo dall’equivalente greco dell’accusa di mancare di sense of
humour, costituiva una coda umiliante a un pensiero solenne. Prende allora
un tono di sfida e avverte Adeimanto che bisogna attribuire l’inutilità dei
filosofi al difetto di «quelli che non sanno servirsi da loro, non già ai
buoni. Non è infatti naturale che un pilota debba pregar lui i marinai di
lasciarsi da lui comandare». E con questo gesto altezzoso raccolse in fretta
gli strumenti della ragione e scomparve nell’Accademia, lasciando il
mondo a Machiavelli.
Così, nel primo grande scontro tra la ragione e la politica, la strategia
della ragione fu di ritirarsi adirata. Ma intanto, come ci dice Platone, la
nave è in mare. Ci sono state molte navi sul mare, dal tempo in cui Platone
scriveva, e oggi, sciocco o saggio che sia questo atteggiamento, non
potremmo più chiamare qualcuno vero pilota solo perché conosce il modo
di occuparsi «dell’anno e delle stagioni, del cielo e degli astri, e dei venti e
di ogni altra cosa che spetta alla sua arte»3. Non può trascurar nulla che
serva a far salpare favorevolmente quella nave. Dal momento che ci sono a
bordo degli ammutinati, non può dire: tanto peggio per noi tutti… non è
nella natura delle cose che io debba sedare un ammutinamento… non è
nella natura della filosofia che io debba contemplare l’ammutinamento…
so navigare…non so far navigare una nave piena di marinai… e se non si
rendono conto che sono io che devo guidare, non posso farci niente.
Finiremo tutti contro gli scogli, loro in punizione dei loro peccati; io con la
sicurezza che avevo ragione…
3.
La difficoltà delineata in questa parabola ricorre ogni qualvolta in
politica facciamo appello alla ragione. Infatti c’è una difficoltà intrinseca
al fatto di usare il metodo della ragione per affrontare un mondo
irrazionale. Anche se si assume con Platone che il vero pilota sa ciò che è
meglio per la nave, bisogna tener presente che non è tanto facile
riconoscerlo, e se questa incertezza fa sì che una gran parte della ciurma
non si persuada. Per definizione la ciurma non sa quello che lui sa. E il
pilota, affascinato dalle stelle e dai venti, non sa come persuadere la
ciurma dell’importanza di quello che sa lui. Non c’è tempo durante
l’ammutinamento in mare per far sì che ciascun marinaio diventi un
esperto giudice di esperti. Al pilota manca il tempo per consultare la
ciurma e scoprire se è davvero tanto saggio come crede di essere. Infatti
l’educazione è questione di anni, l’emergenza di ore. Sarebbe quindi del
292
tutto accademico dire al pilota che il vero rimedio è, ad esempio,
un’educazione che dia ai marinai criteri migliori per giudicare. Questo, si
può dirlo solo ai capitani quando sono a terra. Nei momenti di crisi l’unico
consiglio possibile è quello di usare un fucile o di fare un discorso, o di
proclamare uno slogan emozionante, o di offrire un compromesso, cioè di
impiegare tutti i mezzi disponibili per sedare l’ammutinamento, dal
momento che i criteri di giudizio sono quelli che sono. Solo a terra, dove
progettano molti viaggi, gli uomini possono – e debbono per la propria
sicurezza – permettersi di occuparsi di quelle cause che richiedono molto
tempo per essere eliminate. Si occuperanno di anni e di generazioni, e non
soltanto di emergenze. E nulla metterà alla prova la loro saggezza quanto
la necessità di distinguere le false crisi da quelle vere. Infatti, quando c’è
un’atmosfera di panico, e le crisi si susseguono l’una all’altra, e i pericoli
reali si mescolano ai timori immaginari, non c’è possibilità alcuna di usare
in modo costruttivo la ragione e ben presto un qualsiasi ordine apparirà
preferibile al disordine.
È solo sulla base di una certa stabilità prolungata nel tempo che gli
uomini possono sperare di seguire il metodo della ragione. Questo non
perché gli uomini siano inetti, o perché l’appello alla ragione sia
utopistico, ma perché l’evoluzione della ragione nel campo politico è
ancora nella sua fase iniziale. Nella politica le nostre idee razionali sono
ancora grosse e tenui generalità, di gran lunga troppo astratte e rozze per
fornire una guida pratica, tranne quando gli aggregati siano abbastanza
vasti da cancellare le peculiarità individuali e mostrare vaste uniformità. In
politica la ragione è immatura soprattutto nel prevedere il comportamento
dei singoli, perché nella condotta umana la più piccola variazione iniziale
spesso si traduce nelle più complicate differenze. Forse è per questo che
quando cerchiamo di insistere esclusivamente sull’appello alla ragione
nell’affrontare situazioni improvvise, ci troviamo subissati dalle più matte
risate.
4.
Infatti il ritmo col quale la ragione che possediamo può avanzare è più
lento del ritmo col quale si deve agire. Allo stato attuale della scienza
politica accade che le situazioni si trasformino prima di essere chiaramente
intese, per cui la maggior parte della critica politica è semplicemente
retrospettiva. Sia nella scoperta dell’ignoto che nella comunicazione di ciò
che è stato provato, c’è uno scarto di tempo che dovrebbe interessare il
filosofo politico assai più di quanto l’abbia interessato finora. Abbiamo
293
cominciato, soprattutto grazie all’ispirazione di Graham Wallas, a
esaminare l’effetto dell’ambiente invisibile sulle nostre opinioni. Non
riusciamo ancora a capire, se non un po’ a occhio, l’elemento tempo nella
politica, quantunque influisca in modo piuttosto decisivo sull’attuabilità di
qualsiasi proposta costruttiva1. Ci rendiamo conto, ad esempio, che in
qualche modo la pertinenza di un piano dipende dal tempo che
l’operazione richiede. E questo perché dipenderà dal tempo se i dati che il
piano accetta resteranno davvero gli stessi2. C’è qui un fattore che gli
uomini realisti e ricchi di esperienza già tengono presente; un fattore che li
distingue in qualche modo dagli opportunisti, dai visionari, dai filistei e dai
pedanti3. Ma al presente non abbiamo cognizioni sistematiche sul modo
preciso in cui il calcolo del tempo entra nella politica.
In attesa di comprendere più chiaramente queste cose, possiamo
almeno ricordarci che c’è un problema teoricamente arduo e pregno di
conseguenze pratiche. Ci aiuterà a coltivare l’ideale di Platone, senza
condividere la sua affrettata conclusione sulla perversità di coloro che non
ascoltano ragione. In politica è difficile obbedire alla ragione, perché si
cerca di far marciare assieme due processi che hanno ancora un’andatura e
un ritmo diversi. Finché la ragione sarà sottile e volta al particolare,
l’immediata lotta politica continuerà a esigere una dose di astuzia naturale,
di forza e di fede indimostrabile quale la ragione non può né fornire né
controllare, perché i fatti della vita sono troppo indifferenziati per i suoi
poteri di comprensione. I metodi della scienza sociale sono così poco
perfezionati che in molte delle decisioni gravi, e in moltissime di quelle
minori, non esiste ancora altra scelta che quella di giocare con il destino
secondo intuizione.
Ma possiamo fare della fede nella ragione proprio una di queste
intuizioni. Possiamo usare la nostra astuzia e la nostra forza per creare
appigli alla ragione. Al di là delle nostre immagini del mondo, possiamo
tentare di vedere il panorama meno contingente degli avvenimenti, e
qualora sia possibile evadere dal presente che urge, possiamo tentare di
inquadrare le nostre decisioni in questo tempo più lungo. E tuttavia, anche
quando c’è questa volontà di tener conto del futuro, scopriamo
regolarmente di non sapere con certezza come agire secondo i dettami
della ragione. Il numero di problemi sui quali la ragione è preparata a
imporsi è piccolo.
5.
C’è tuttavia una nobile falsificazione in quell’amorevolezza che deriva
294
dalla conoscenza di sé, e una fede indiscutibile che nessun membro della
nostra socievole specie è isolato nel suo anelito verso un mondo che gli sia
più amico. Una parte così grande degli atteggiamenti che gli uomini
prendono gli uni verso gli altri è legata al battito del loro polso, per cui non
a tutti bisogna dare importanza. E con tanta incertezza, con tante azioni
che vengono condotte sulla base di mere congetture, è già moltissimo
quello che si richiede alla semplice correttezza degli individui, e si deve
vivere come se bastasse la buona volontà. Non possiamo dimostrare
sempre che di fatto basterà, né possiamo spiegare perché l’odio,
l’intolleranza, il sospetto, il bigottismo, la segretezza, la paura e la
menzogna siano i sette peccati mortali contro l’opinione pubblica.
Possiamo solo affermare che non hanno posto nell’appello alla ragione,
che alla lunga sono un veleno; e prendendo posizione secondo una visione
del mondo che trascende la nostra situazione, e le nostre vite, possiamo
coltivare un vigoroso pregiudizio contro di loro.
Possiamo riuscirci tanto meglio se non ci lasceremo impressionare dal
terrorismo e dal fanatismo al punto di scrollare le spalle infastiditi e di
perdere interesse per gli avvenimenti a lunga scadenza, avendo perduto la
fede nel futuro dell’uomo. Questa disperazione non è giustificata, perché
tutti i se a cui, come diceva James, è appeso il nostro destino, sono ricchi
di possibilità, come sempre. Abbiamo visto quel che abbiamo visto di
brutalità, e poiché era eccezionale non è stata conclusiva. Si trattava solo
di Berlino, Mosca, Versailles dal 1914 al 1919, e non, come abbiamo detto
retoricamente di Armageddon. Quanto più realisticamente gli uomini
hanno affrontato la brutalità e l’isterismo, tanto più hanno guadagnato il
diritto di dire che non è sciocco per gli uomini, per il fatto che un’altra
grande guerra ha avuto luogo, credere che l’intelligenza, il coraggio e
l’impegno non potranno mai assicurare una vita decente a tutti gli uomini.
L’orrore, per quanto grande, non è stato universale. Ci sono stati i
corrotti e ci sono stati gli incorruttibili. Ci sono state allucinazioni e ci
sono stati miracoli. Si sono dette enormi menzogne; ma ci sono stati
uomini decisi a smascherarle. È uno stato d’animo, e non un giudizio,
l’affermare che ciò che è vero di alcuni non possa esser vero di un numero
maggiore o sufficiente di uomini. Si può disperare di quello che non è mai
stato; si può disperare di poter avere tre teste, benché Shaw si sia rifiutato
di disperare anche di questo. Ma non si può disperare delle possibilità che
potrebbero esistere grazie ad una qualsiasi delle qualità umane già
manifestate da esseri umani. E se in mezzo a tutti i mali di questo decennio
non abbiamo visto uomini e donne, né conosciuto momenti che vorremmo
veder moltiplicati, nemmeno il Signore ci può aiutare.
295
Wading River, Long Island, 1921.
Cfr. C. E. Merriam, The Present State of the Study of Politics, in «American
Political Science Review», 15, 2, maggio 1921.
1 Cfr. il discorso tenuto il 28 dicembre 1920 dal presidente dell’American
Philosophical Association, Ralph Barton Perry. È stato pubblicato negli atti del
ventesimo Congresso annuale.
2 Negli Stati Uniti il numero di questi organi è grandissimo. Alcuni sono vitali, altri
sono mezzi morti. La loro situazione muta rapidamente. Gli elenchi di cui sono in
possesso, fornitimi da varie fonti, ne comprendono varie centinaia.
1 Cfr. cap. XII.
2 Adopero l’espressione non solo nel suo significato tecnico, ma per indicare
qualsiasi sistema per la misurazione comparata dei fenomeni sociali.
3 Si veda, ad esempio, L. P. Ayres, An Index Number for State School Systems,
Russell Sage Foundation, New York 1920. Il principio della quota è stato applicato con
molto successo nelle campagne per le vendite dei buoni del Tesoro durante la guerra, e
in circostanze molto più difficili dal Consiglio alleato per i trasporti marittimi.
1 C’è stato un grandissimo sviluppo di questi servizi tra associazioni imprenditoriali.
Le possibilità di un impiego scorretto di questi servizi sono state rivelate nel 1921
dall’inchiesta sull’industria edilizia di New York.
1 «The Reorganization of Local Government», in A Constitution for the Socialist
Commonwealth of Great Britain cit., cap. IV.
1 Cfr. Laski, The Foundation of Sovereignty cit. Si veda soprattutto il saggio che dà il
titolo al libro, nonché quelli sui problemi delle circoscrizioni amministrative, sulla
teoria della sovranità popolare e sullo stato pluralista.
1 Bryce, Modern Democracies cit., I, p. 159.
2 Ibid., p. 158, nota a piè di pagina.
1 Cfr. cap. XX.
1 Cfr. l’articolo di Leo Wolman, The Cost of Living and Wage Cuts, in «New
Republic» del 27 luglio 1921, in cui è svolta una brillante critica dell’uso ingenuo di tali
cifre e «pseudo-princìpi». L’ammonimento è di particolare importanza, perché viene da
un economista e statistico che ha fatto molto per conto suo al fine di migliorare la
tecnica delle controversie industriali.
2 Nell’accezione usata da Lowell nel suo Public Opinion and Popular Government
cit.
7
1 Platone, La Repubblica, l. V, trad. it. di F. Gabrieli, Rizzoli, Milano 1993 , p. 194.
2 Ibid., l. VI, trad. it. cit., p. 211.
3 Ibid.
1 Cfr. H. G. Wells nei primi capitoli di Mankind in the Making, C. Scribner’s son,
New York 1904.
2 Quanto meglio si condurrà l’analisi del presente nell’attività di ricerca delle varie
istituzioni, tanto meno probabile sarà la prospettiva che gli uomini affrontino i problemi
del presente alla luce dei fatti del passato.
3 Non tutte, ma alcune delle differenze tra reazionari, conservatori, liberali ed
estremisti si debbono, io credo, a una diversa valutazione intuitiva del ritmo della
1
296
trasformazione sociale.
297
Indice
Trama
Biografia
3
4
Frontespizio
Copyright
Indice
Prefazione di Nicola Tranfaglia
Dedica
I. Introduzione
I. Il mondo esterno e le immagini che ce ne facciamo
II. Accessi al mondo esterno
6
7
8
10
24
26
27
46
II. La censura e la segretezza
III. Il contatto e la possibilità
IV. Il tempo e l’attenzione
V. La velocità, le parole e la chiarezza
III. Gli stereotipi
47
54
62
67
77
VI. Gli stereotipi
VII. Gli stereotipi come difesa
VIII. I punti ciechi e il loro valore
IX. I codici e i loro nemici
X. La scoperta degli stereotipi
IV. Gli interessi
78
88
94
101
111
131
XI. Suscitare l’interesse
XII. L’interesse personale riconsiderato
V. La formazione di una volontà comune
132
139
153
XIII. Il trasferimento dell’interesse
XIV. Sì o no
XV. I capi e i seguaci
154
171
180
VI. L’immagine della democrazia
191
XVI. L’uomo egocentrico
XVII. La comunità autosufficiente
192
198
298
XVIII. Il ruolo della forza, del favoritismo e del privilegio
XIX. La vecchia immagine in una forma nuova: il socialismo
corporativo
XX. Una nuova immagine
VII. I giornali
206
217
227
232
XXI. Il pubblico come consumatore
XXII. Il fedele lettore
XXIII. La natura delle notizie
XXIV. Le notizie, la verità e una conclusione
VIII. L’informazione organizzata
XXV. Il cuneo iniziale
XXVI. Il lavoro d’informazione
XXVII. L’appello al pubblico
XXVIII. L’appello alla ragione
233
239
245
257
264
265
271
283
291
299