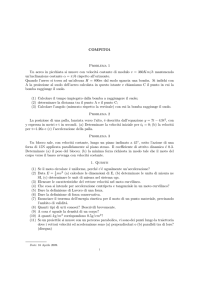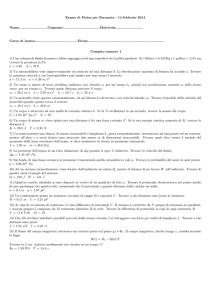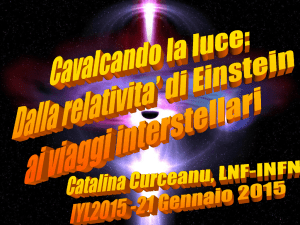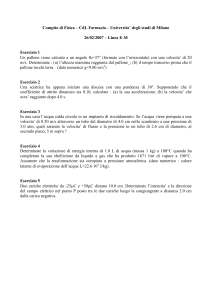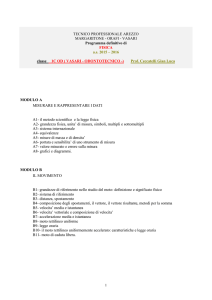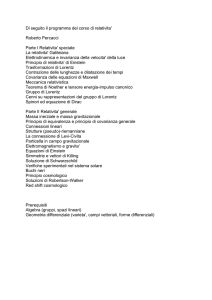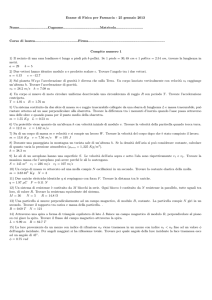caricato da
common.user2143
Introduzione ai postulati della Relatività Ristretta

Introduzione ai postulati della Relatività Ristretta e alle loro conseguenze cinematiche G IOVANNI B ORGHI Laboratorio didattico-pedagogico di fisica Didattica della fisica Sommario Questa unità didattica (UD) consiste in una introduzione alla relatività speciale a partire dai risultati di Maxwell sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Al suo interno, si discute la generalizzazione del concetto di relatività Galileiana all’elettrodinamica, seguendo la linea dell’articolo originale di Einstein. Nel fare questo, si riprendono in modo ragionato i concetti di sistemi di riferimento e di trasformazioni di sistema di riferimento, e si procede col mostrare gli aspetti innovativi della relatività Einsteiniana rispetto alla Galileiana, puntualizzando i concetti di spaziotempo, sistema inerziale, causalità, simultaneità e tempo proprio, in un modo che può essere propedeutico all’introduzione della relatività generale. Si introducono a scopo didattico alcuni strumenti di “orientamento” nello spazio-tempo, attraverso i quali si costruiscono esercizi al fine di consolidare i contenuti della materia. Le tempistiche necessarie allo sviluppo degli argomenti presentati sono fuori dalla portata di un corso tradizionale (pre-riforma) di fisica per la classe V dei licei. Tuttavia, nell’ottica della riforma dei programmi, si propone un percorso un po’ più lungo, che esclude la dinamica relativistica, ma che è comunque diluito nel corso una dozzina di ore. Motivazioni Ritengo utile utilizzare come motivazioni per questa UD tre argomenti, tra tanti. Il primo argomento è relativo ai fondamenti stessi della fisica moderna: si intende formulare una elettrodinamica che, al pari della meccanica dei punti materiali e dei corpi rigidi (regolata dalle tre leggi di Newton), sia valida in qualsiasi riferimento inerziale1 . Il termine “relatività” suona quasi come un ossimoro di fronte allo scopo raggiunto da Einstein: rendere le equazioni di Maxwell “assolute”, piuttosto che relative ad un particolare sistema di riferimento. La relatività Einsteiniana è una conferma delle intuizioni di Galileo sul fatto che le leggi della fisica siano universali, emancipate dalle angustie di uno specifico sistema di riferimento, sia esso il laboratorio terrestre (in cui potevano avere luogo gli esperimenti ai tempi di Galileo), sia esso il riferimento del sistema solare o delle stelle fisse (laboratorio più arioso dove i fenomeni ottici continuano però a dispiegarsi su scale di tempo umanamente accessibili). Il fatto che la relatività di Einstein renda obsolete 1 En passant, la teoria della relatività speciale non è ancora una unificazione di meccanica ed elettrodinamica; per queste manca ancora oggi una trattazione organica dell’interazione tra i campi elettromagnetici e la materia in cui entrambi siano considerati variabili dinamiche 1 le trasformazioni di Galileo, sostituendole con le trasformazioni di Lorentz, non deve essere visto come una correzione, ma piuttosto come una generalizzazione del lavoro dello scienziato pisano. Il secondo argomento è meno storico-epistemologico e più cinematografico, e si collega sia alla prospettiva dei viaggi nel tempo, che alla prospettiva dei viaggi inter-galattici. Tutto sommato non fa che cavalcare alcuni cliché fantascientifici, proponendo ad esempio queste due domande: • le leggi della fisica rendono possibili i viaggi nel tempo? • le leggi della fisica rendono idealmente possibile per un uomo, nel corso della sua vita naturale, di raggiungere luoghi arbitrariamente lontani dell’universo? Si verificherà come sia necessario, per dare una risposta positiva a entrambe, affrontare almeno due punti cruciali della relatività speciale, come il concetto di e la preservazione del principio di causalità. Al primo argomento, epistemologico, ed al secondo, cinematografico, ne aggiungerei un terzo, valido soprattutto per l’insegnante, ma che vale la pena presentare agli studenti come motivazione alla riflessione personale, anche in vista dell’orientamento universitario e della tesina di maturità. La relatività speciale è un’ottima occasione per ripassare gli argomenti di cinematica proprio nella fase conclusiva del triennio della scuola superiore, e in particolare del liceo, in vista dell’esame di maturità. Più in generale, il modulo didattico di Fisica del ’900, che comprende oltre alla relatività la Meccanica Quantistica, si presta ad un “ripasso” critico della fisica dei secoli precedenti (studiata dall’alunno negli anni precedenti), dalla cinematica alla dinamica, dalla fisica delle onde alla termodinamica, fornendo innumerevoli spunti per collegamenti all’interno della disciplina. Inoltre, gli argomenti di Fisica Moderna consentono una discussione sulla “forma mentis” dello scienziato, sul metodo e sull’attitudine della ricerca (che tende all’unificazione delle leggi ed alla generalizzazione dal particolare all’universale) sulla falsificabilità delle teorie scientifiche e sull’importanza dei cambi di paradigma. Questo tipo di riflessioni sono strettamente correlate con gli aspetti umanistici e storici del nostro passato prossimo, e possono essere ampiamente utilizzate per spunti interdisciplinari. Contesto Tipologia di scuola La scuola dove ritengo opportuno sviluppare questa UD è un liceo scientifico. Non tanto per i pre-requisiti di conoscenze, che sono verosimilmente ben sviluppati anche nei programmi degli istituti tecnici, ma perchè si presta a riflessioni piuttosto profonde sui fondamenti della fisica classica e della fisica moderna, e sul significato dei sistemi di coordinate, che credo siano più efficaci e meglio contestualizzabili in ambito liceale. In particolare, se dovessi svilupparla per un istituto tecnico, strutturerei questa UD in modo da concentrarmi più su applicazioni pratiche (con l’uso degli strumenti per gli “esperimenti mentali”), dilungandomi meno sugli aspetti di fondamento e sulla motivazione dei postulati della relatività speciale. In tal caso, tra le motivazioni addotte per l’UD, mi soffermerei più sulla seconda che sulla prima o la terza, queste ultime molto più valide per gli studenti di un liceo, per i quali si prospetta, tra le scelte di orientamento, anche l’iscrizione alla facoltà di fisica. Modulo didattico Questa UD si inserisce al termine del modulo didattico di elettromagnetismo, e in particolare al termine dell’UD finale di questo modulo, sulle onde elettromagnetiche come 2 fenomeno predetto a partire dalle equazioni di Maxwell . Oltre ad essere un coronamento importante per il modulo didattico di elettromagnetismo, la relatività speciale apre il modulo didattico di Fisica Moderna (si veda lo schema concettuale Fig. 1), funzionando allo stesso tempo da argomento propedeutico alla Relatività Generale. Ciascun argomento di Fisica Moderna può essere introdotto partendo dall’aspetto della Fisica Classica rimasto incompreso fino al secolo scoroso, quindi il blocco “Crisi della Fisica Classica” nello schema Fig. 1, mostra una serie di temi che si possono trattare come motivazioni esplicite delle unità didattiche e dei sottoargomenti delle unità didattiche di Fisica Moderna. 3 4 Figura 1: Contestualizzazione dell’UD sulla relatività speciale: il modulo didattico (di tipo sperimentale allo stato attuale della normativa sui programmi di scuola superiore e in particolare di liceo scientifico) è quello di Fisica Moderna, le singole unità didattiche sono segnate con un numero progressivo. Le suddivisioni del diagramma ad albero sono più fini ed evidenziano la possibilità di una parcellizzazione ulteriore delle unità didattiche nel caso si voglia e si possa dedicare più tempo alla fisica moderna. Le bandierine indicano il tema svolto prima della presente UD, che apre il modulo, mentre le stelle contrassegnano l’UD a cui questa può essere propedeutica. Il rettangolo titolato “Crisi della fisica classica” contiene una serie di punti che devono essere sviluppati prima di svolgere o all’inizio dello svolgimento delle unità didattiche del modulo che ne sono interessate. Pre-requisiti Conoscenze • conoscenza dalle lingua Italiana, della grammatica italiana, dei connettivi logici, della logica matematica e dialettica; • conoscenza del concetto di vettore; • conoscenza del concetto di circuitazione di un campo vettoriale; • conoscenza dei concetti di posizione, velocità, accelerazione; • conoscenza della cinematica del punto materiale, della legge oraria, del moto rettilineo uniforme, del moto uniformemente accelerato; • conoscenza del principio di inerzia galileiano, e delle tre leggi della dinamica Newtoniana; • conoscenza della relatività galileiana e delle trasformazioni di Galileo; • conoscenza della forma finale delle equazioni di Maxwell (non si richiede una conoscenza approfondita dell’elettromagnetismo ai fini di questa UD); • conoscenza della fisica delle onde non-elettromagnetiche, in particolare dell’effetto doppler; • conoscenza del concetto di derivata, del concetto di integrale, del concetto di limite; • conoscenza di una scaletta per lo studio di funzioni; • conoscenza delle tecniche di scomposizione in fattori, di razionalizzazione, di soluzione di equazioni e disequazioni algebriche di diverso grado, irrazionali, fratte; • conoscenza generale del contesto storico sullo sfondo delle principali scoperte della fisica dal ’600 e dell”800 nel campo della meccanica e dell’elettromagnetismo. Abilità • risoluzione di semplici problemi cinematici tramite legge oraria, calcolo dei tempi di percorrenza, o dello spazio percorso in un determinato tempo; • risoluzione semplici problemi di dinamica, applicazione della seconda legge di Newton dopo l’analisi vettoriale delle forze; • distinzione dei sistemi di riferimento inerziali da quelli non inerziali e applicazione delle trasformazioni di Galileo alla legge oraria di un corpo; • saper ricavare l’effetto doppler per un’onda classica che si muove in un mezzo materiale; • saper affrontare un problema di algebra, risolvendo equazioni, comprendendo la significatività delle soluzioni; • saper studiare una funzione, calcolandone derivata, facendone il limite, comprendendo le ricadute dello studio della funzione sul contesto fisico in cui è stata formulata (ad esempio se è una legge oraria, o una velocità in funzione del tempo); • abilità di affrontare un problema generico di fisica, sistematizzando la risoluzione in modo da mettere in evidenza le grandezze in gioco e le relazioni tra di loro e i loro eventuali cambiamenti, riconoscendo le “grandezze incognite” e operando per 5 trovare un sistema di equazioni che le possa determinare (abilità di problem solving in fisica); • abilità nell’esposizione scritta ed orale, correttezza formale del linguaggio, e scioltezza nell’eloquio. Competenze • saper trovare, tra i concetti spiegati a lezione, e gli esempi svolti di problemi di matematica o di fisica, gli ingredienti che possono essere utilizzati per la risoluzione di un problema mai visto (competenza generale di problem solving scientifico) [saper essere un buon risolutore di problemi]; • saper tradurre un problema della vita reale in espressioni e termini fisico-matematici, adatti alla formulazione di un problema fisico tramite ipotesi e congetture, ed alla sua risoluzione tramite esperimento pratico o mentale, saper applicare il risultato di un esercizio di fisica ad un fenomeno della vita reale [saper essere uno “scienziato”]; • saper individuare gli elementi chiave di un nuovo argomento, distillandone i nodi concettuali e le relazioni reciproche [saper essere un buon “ascoltatore”, saper essere “ricettivo”]; • saper comunicare un concetto, per iscritto o oralmente, in modo chiaro e sintetico, mostrando consapevolezza della diversa rilevanza delle idee che si espongono all’interno di una materia o di un argomento più specifico [saper essere un comunicatore sintetico ed efficace]; • saper mettere in relazione il contesto storico con le scoperte della fisica, e vice versa [saper essere detentore di una cultura “interdisciplinare”]; • saper essere perseverante nelle difficoltà incontrate durante le lezioni e le prove di valutazione, imparando dagli errori e adottando un atteggiamento positivo anche in caso di fallimento temporaneo o di flessione nella propria performance scolastica; • saper essere umile e collaborativo nelle routines di classe, intervenendo per dare il proprio contributo e non disturbando nei momenti in cui non viene richiesto un intervento individuale agli studenti. Obiettivi Obiettivi Trasversali Gli obiettivi trasversali consistono nel consolidamento dei pre-requisiti di competenze sopra elencati. Obiettivi Specifici Conoscenze • conoscere le ragioni della necessità della teoria della relatività speciale come risposta ad una controversia sull’esistenza dell’etere, nata con la forma finale delle equazioni di Maxwell, e proseguita con l’esperimento di Michelson e Morley; • conoscere le applicazioni della relatività speciale, dalla descrizione della vita del muone, al GPS, a quella, ideale, del viaggio inter-galattico; • conoscere il concetto di sistema di riferimento, sistema di riferimento inerziale (SRI), evento, di misura della posizione di un evento nello spazio-tempo; 6 • conoscere il concetto di trasformazione da un sistema di riferimento ad un altro, pensato come trasformazione di coordinate in 4 dimensioni, in cui lo spazio si combina con il tempo; • sapere che l’universalità delle leggi della fisica nei sistemi di riferimento inerziali, formulata da Galileo viene sposata perfettamente da Einstein, mentre quello che viene aggiornato è la trasformazione di coordinate da un sistema di riferimento ad un altro; • conoscere il concetto di tempo proprio, conoscere il concetto di linea di universo; • conoscere la relatività della simultaneità temporale, in analogia con la relatività dell’identificazione delle posizioni di due eventi già introdotta da Galileo. Abilità • saper calcolare la distanza invariante tra due eventi di tipo tempo, come tempo proprio di un viaggiatore che parte dal primo evento ed arriva puntuale al secondo evento muovendosi di moto rettilineo uniforme, saper applicare il concetto di tempo proprio a semplici problemi; • capire quando un sistema di riferimento è inerziale o no, capire il “paradosso dei gemelli” non solo nel senso di dilatazione dei tempi, ma nel senso di una diminuzione del tempo proprio in tutte le “linee di universo” tra due eventi che non sono di moto rettilineo uniforme; • capire e saper applicare il “radar”, come mezzo per calcolare la velocità di un altro sistema di riferimento rispetto al mio, capire le differenze tra un radar a onde sonore (“non relativistico”) e un radar relativistico, a onde elettromagnetiche; • saper ottenere il fenomeno della dilatazione dei tempi applicando il concetto di universalità della velocità della luce in tutti i sistemi di riferimento; • saper applicare il concetto di tempo proprio come distanza nello spazio-tempo; Competenze • saper comprendere e contestualizzare la relatività Galileiana e Einsteiniana nell’ambito delle scoperte scientifiche degli ultimi quattro secoli; • essere consapevoli del significato della parola “relatività”, e del fatto che esso non sminuisce la validità delle osservazioni scientifiche. Capire la differenza “relativismo” in ambito filosofico e “relatività” in ambito scientifico; • auto-valutare criticamente il proprio approccio ad un problema di relatività, capire dove i “luoghi comuni” di intervalli di tempo assoluti possono subentrare a viziare il ragionamento; • saper combinare le proprie conoscenze di fisica classica con i nuovi concetti di questa UD, in modo da ottenere una visione organica dei problemi di fisica di cinematica classica e relativistica; • consolidare le proprie competenze di Problem Solving, in particolare acquisendo flessibilità nel “cambiare punto di vista”, e “utilizzare le simmetrie del problema”. Strategie didattiche • Lezione frontale di tipo euristico-socratica per illustrare, ogni volta, i nodi concettuali dell’UD. 7 • Esercizi guidati (tecnica del “problem solving” o “scoperta guidata”, “apprendistato”) proposti a casa e/o svolti dall’insegnante alla lavagna, facendo domande agli studenti su come di volta in volta proseguire la risoluzione, per stimolare alla riflessione ed allo sviluppo delle abilità specifiche della materia. • Discussione-dibattito, sia nel momento della lezione, sia durante gli esercizi, per fare emergere in modo circolare i nodi concettuali dell’argomento. Strumenti • Libro di testo, non tanto per gli aspetti teorici, ma per estrarre eventualmente esercizi ulteriori rispetto a quelli proposti. In ogni caso si sceglieranno esercizi della stessa tipologia di quelli elencati in questa UD. • Eventualmente slides, in particolare per sottolineare con immagini i momenti chiave della lezione o la schematizzazione di un problema, in particolare laddove la mancanza di tempo potesse farle preferire ad un disegno alla lavagna. Suddivisione delle lezioni In questa sezione dell’unità didattica si descrivono in modo schematico le lezioni di cui l’UD è composta, facendo continuamente riferimento alla parte di contenuti (Sezione 8) e strumenti (Sezione 9) in cui presento più dettagliatamente la linea di pensiero che vorrei sviluppare. La linea temporale delle lezioni è sintetizzata anche in Fig. 2. Il materiale da cui ho preso spunto sono i testi e gli appunti su cui a suo tempo ho studiato la relatività, ovvero gli appunti del prof. Paolo Rossi dell’università degli studi di Pisa [1], gli appunti del prof. Elio Fabri [2], e il libro di relatività speciale “Fisica dello Spazio-Tempo” [3]. Le suddette persone non hanno comunque responsabilità per le eventuali inesattezze presenti nella mia esposizione dei contenuti. Tempo previsto per lo svolgimento compessivo della unità didattica Si prevede di svolgere questa untià didattica sull’arco di tempo compessivo di circa un mese. Si prevedono un massimo di 15h30 dedicate all’argomento, di cui 10h di lezione, ed il tempo restante dedicato a verifiche formative e sommative. Si prevede che circa metà del tempo dedicato alle lezioni sarà nella forma di teoria esposta tramite l’ausilio esercizi guidati e discussione degli esercizi. Prima lezione: 1h • ricapitolazione delle equazioni di Maxwell (sezione 8.1) • per motivare allo studio della materia, si utilizza il primo argomento illustrato nella sezione 1 • esposizione delle tre ipotesi su relatività e validità delle equazioni di Maxwell • esperimento di Michelson e Morley (sezione 8.2) Seconda lezione: 1h • ricapitolazione dell’esperimento di Michelson e Morley (sezione 8.2) • l’interpretazione di Einstein: i postulati della Relatività Speciale (sezione 8.3) • esposizione del paradosso nel paragrafo 8.3. Si può lasciare aperta la discussione e la riflessione fino alla lezione successiva. 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Raccordo UD, motivazione Mappa Orologio a luce e Autovelox Bomba Radar Valutazione Figura 2: Schema della suddivisione dei tempi didattici (in ore), suddivisi, anzichè per argomenti, secondo gli “strumenti” elencati nella mappa in Fig. 3, e sviluppati nella sezione 9. Terza lezione: 1h • ricapitolazione, spiegazione del paragrafo 8.3, breve anticipazione di quello che accadrà con l’orologio a luce. • lezione sulla sezione 8.4.1 e 8.4.2, esempi di trasformazioni di galileo, si può richiamare l’effetto doppler classico • come “compito a casa”, si possono dare una serie di oggetti dei quali si deve dire se siano eventi o meno; si può utilizzare a tale scopo la tabella 2; inoltre si può chiedere agli studenti di disegnare su un grafico x, t un elenco di eventi dati (ad esempio durante il viaggio di una corriera lungo l’autostrada) e discutere che aspetto avrà invece la propagazione di un raggio di luce. In sostanza si introduce lo strumento “mappa” (sezione 9.1). Quarta lezione: 1h • ricapitolazione, “sincronizzatore” di orologi (sezione 9.3), spiegazione dei paragrafi 8.4.3 e 8.4.4 • anticipazione qualitativa dell’orologio a luce • come compito a casa, si può chiedere di disegnare sulla “mappa” la linea di universo di un corpo che si muove, in fisica classica, di moto uniformemente accelerato, e di confrontarlo con la linea di universo di un raggio di luce (ne uscirà una discussione su se e come sia possibile andare a velocità maggiore della luce, questo anticipa la discussione sullo strumento “radar”, ma anche l’orologio a luce, e l’introduzione del fattore γ, già comparso quasi per magia nell’esperienza di Michelson e Morley). Quinta lezione: 1h • illustrazione dell’orologio a luce (sezione 8.5), paradosso dei gemelli (sezione 8.5.1) • introduzione dello strumento “autovelox” e contrazione delle lunghezze (sezione 9.4), anticipazione dello strumento radar. • discussione dei viaggi ai confini dell’universo, ovvero presentazione della seconda motivazione illustrata nella sezione 1. Anche viaggiando a velocità minore di c, grazie alla contrazione delle lunghezze si può arrivare ovunque (anche se non 9 “in tempo per ogni cosa”), ma al rientro dal viaggio si troveranno i nostri amici enormemente invecchiati. Sesta lezione: 1h • lezione sul tempo proprio (sezione 8.6), e la distanza invariante nello spazio-tempo (sezioni 8.7, e 8.8) • come compito si possono lasciare quattro o cinque eventi, chiedendo di classificarne le distanze come “di tipo tempo”, “spazio” o “luce”; si può chiedere di calcolare quanto tempo proprio trascorre per un abitante della luna durante una rivoluzione lunare attorno alla terra, da confrontare con il tempo di rivoluzione lunare nel riferimento terrestre (supponendo il riferimento terrestre come inerziale e ignorando la relatività generale). • introduzione dello strumento “bomba” (sezione 9.5), eventualmente si può lasciare un esercizio a tale scopo. Settima lezione: 1h • ricapitolazione sullo strumento bomba, e relatività della simultaneità (sezione 9.5.3) • introduzione dello strumento “radar” (sezione 9.6), discussione sull’effetto doppler, e confronto con quello classico • per casa, un esercizio ancora sulla “bomba” Scritto-interrogazione formativa: 1h • si danno esecizi da fare al posto, anche a piccoli gruppi, e si chiamano alla lavagna alcuni studenti per esporre le soluzioni. Ottava lezione: 1h • Ricapitolazione sullo strumento radar, legge di composizione delle velocità, concetto di rapidità; • discussione, dubbi, ricapitolazione degli argomenti visti; lo strumento “radar” potrebbe essere abbastanza ostico, e richiede di ribadire più volte in particolare la sua importanza nel calcolo delle velocità; • si può lasciare un esercizio sul “radar”, ad esempio si può chiedere di calcolare il fattore di il ritardo doppler per riflessione contro uno specchio che si allontana con velocità c/2, e un’altro che si allontana rispetto al primo ancora con velocità c/2. Nona lezione: 1h • Ricapitolazione degli argomenti dell’unità didattica, seguendo ad esempio la mappa in figura 3; • schema per ricapitolare il funzionamento del “radar”; • esercizi di ricapitolazione, sui diversi strumenti introdotti. Decima lezione: 1h • Conferme sperimentali ed applicazioni della relatività speciale (sezione 8.9); • spunti per introdurre alle prossime unità didattiche (come indicato nel paragrafo 8.10); 10 • esercizi svolti alla lavagna, facendo domande al posto Compito: 1h 30 min • compito con domande aperte ed esercizi da svolgere Correzione: 1h • correzione del compito Recupero: 1h+1h • interrogazione degli insufficienti e di altri studenti, domande alla lavagna di teoria ed esercizi 11 12 Figura 3: Mappa concettuale sintetica dei contenuti dell’unità didattica, suddivisi in nodi concettuali e strumenti per “esperimenti mentali”. Si intende usare gli elementi di questa mappa concettuale come dei cardini intorno a cui far ruotare il linguaggio delle lezioni, come vere e proprie routines concettuali e lessicali da reiterare durante l’interazione didattica con gli studenti. Trasformazioni di Galileo valide Eq. di Maxwell corrette Eq. di Maxwell indip. da SRI 3 3 7 3 7 3 7 3 3 I ipotesi II ipotesi III ipotesi Tabella 1: Tabella riassuntiva delle tre congetture formulate dopo la scoperta delle Equazioni di Maxwell, per capire la relazione tra elettrodinamica e relatività. Se le trasformazioni di Galileo sono corrette e le equazioni di Maxwell valide nel SR dell’etere, allora queste equazioni saranno diverse in altri sistemi di riferimento. Se accettiamo che le Equazioni di Maxwell siano giuste, e anche indipendenti dal sistema di riferimento, dobbiamo rinunciare alla validità delle trasformazioni di Galileo. Contenuti Equazioni di Maxwell e trasformazioni di Galileo Le equazioni di Maxwell (scritte nel Sistema di misura Internazionale (SI)) ~E · d~S = ∑ Qi e0 IS ~B · d~S = 0 I S I ~ ~E · d~l = − dΦ( B) dt γ (1) (2) (3) ~ ~B · d~l = µ0 i + e0 µ0 dΦ( E) (4) dt γ √ presentano al loro interno una costante 1/ e0 µ0 che risulta essere uguale alla velocità della luce “nel vuoto”. Nel sistema internazionale (SI) questa compare esplicitamente soltanto nell’equazione di Ampère-Maxwell , tuttavia sia e0 , la costante dielettrica del vuoto, sia µ0 , la permeabilità magnetica del vuoto, sembrano presupporre che il vuoto sia “pieno” di una materiale che consenta la propagazione dell’onda attraverso le sue proprietà intrinseche di polarizzazione e magnetizzazione, un materiale che chiameremo, seguendo la terminologia della fisica del diciannovesimo secolo, “etere”. Se crediamo quindi alla struttura delle equazioni di Maxwell , si pone allora un dilemma inevitabile: dobbiamo rinunciare al principio di eguaglianza delle leggi fisiche in tutte i riferimenti inerziali, che sembrava essere assodato dopo la formulazione delle leggi della dinamica, a causa di questa non invarianza dell’elettrodinamica? Il sistema di riferimento dell’etere sebrerebbe infatti essere un sistema di riferimento “speciale”, in cui la fisica avviene in modo esclusivo, rendendo valide le equazioni di Maxwell . Se non si ammette invece che esista un sistema di riferimento speciale in cui l’elettrodinamica è regolata dalla forma conosciuta delle equazioni di Maxwell, resta comunque un grosso problema da risolvere. Infatti le trasformazioni di Galileo, il modo fino ad ora accettato per passare da un SRI ad un altro, se applicate alle equazioni di Maxwell, ne alterano profondamente la struttura (in particolare ne alterano un parametro, la velocità della luce); se vogliamo che le equazioni di Maxwell conservino la stessa forma in tutti i riferimenti inerziali, siamo allora costretti a considerare ammissibili due importantissime affermazioni: I • affinchè le equazioni di Maxwell restino le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, anche la velocità della luce deve essere la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali. 13 • le trasformazioni di Galileo non sono adeguate a descrivere un cambiamento di sistema di riferimento.2 L’interferometro di Michelson e Morley Di fronte alle tre possibilità prospettate nella Tabella 1, si rese necessario un esperimento dirimente. Un esperimento che verificasse, ad esempio, la possibilità che le equazioni di Maxwell fossero valide soltanto per un particolare SR, quello dell’etere, il mezzo, se esistente, in cui si era convinti che la luce si propagasse. Per verificare l’esistenza o meno dell’etere si costruı̀ un interferometro in cui lo stesso raggio di luce veniva diviso in due da uno specchio semitrasparente, percorrendo due cammini ortogonali. I due raggi vennero poi fatti interferire su una lastra, e venne osservata la figura di interferenza. Se esiste un riferimento dell’etere, allora la Terra, almeno in un periodo dell’anno, siccome effettua un moto circolare, si troverà in moto rispetto all’etere; esisterà quindi un “vento di etere” che attraversa l’interferometro. Nell’ipotesi in cui i bracci A e B sono puntati rispettivamente lungo la direzione del vento di etere, e perpendicolarmente a questa direzione, e componendo vettorialmente la velocità della luce con la velocità dell’etere, si ottengono per la lunghezza temporale dei due cammini i valori3 : L L 2L/c + = 2 c+v c−v 1 − vc2 q 2 L2 + v2 TB2 2L/c TB = =⇒ TB = q 2 c 1 − vc2 TA = TA /TB = q 1 1− (5) (6) (7) v2 c2 Quindi il primo ed il secondo raggio di luce, viaggiando per un tempo diverso, arrivano sulla lastra con una fase diversa, cosa che dovrebbe far spostare le frange di interferenza rispetto al caso in cui, ad esempio entrambi i bracci A e B vengono disposti perpendicolarmente al vento di etere, facendo registrare ai raggi luminosi lo stesso percorso. L’esperimento venne eseguito numerose volte, senza vedere alcuno spostamento delle frange. Venne eseguito in diversi periodi dell’anno, quando in teoria la terra avrebbe dovuto viaggiare in direzione diversa rispetto all’etere, senza tuttavia ottenere nessuna variazione delle frange di interferenza. Se si considera il moto circolare della terra, che porta circa all’inversione della sua velocità ogni sei mesi, si comprende come la terra costituisse, a seconda del periodo dell’anno, un riferimento in moto approssimativamente rettilineo, ma con velocità diversa rispetto al riferimento del sistema solare. Eppure, indipendentemente dalla velocità della Terra rispetto al Sole (ipoteticamente fermo rispetto all’etere), nel riferimento della Terra, la luce viaggiava sempre con la stessa velocità. Nessun esperimento è stato in grado di trovare un sistema di riferimento in cui la luce si propagasse con una velocità diversa da c. I postulati della relatività speciale Einstein interpretò l’esperimento di Michelson e Morley non solo come la confutazione dell’esistenza di un “vento di etere”, ma come una conferma della esistenza di una teoria 2 per lo meno non sono adeguate a descrivere i cambiamenti di sistemi di riferimento nell’ambito di una trattazione unificata della Fisica, in cui dinamica dei corpi materiali ed elettrodinamica abbiano lo stesso status. 3 È possibile far notare più avanti, una volta ricavato il fattore γ , come questo fosse già comparso v nell’esperimento di Michelson e Morley 14 che contenesse c come una costante universale, e le equazioni di Maxwell come leggi, indipendenti dal SRI, per la descrizione dell’elettrodinamica. Adottando la terza ipotesi in Tabella 1, nel suo articolo del 1905 “Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento”, stabilı̀ che: • non solo la meccanica, ma anche l’elettrodinamica segue il principio di relatività, già formulato da Galileo per la meccanica, ovvero: le leggi della Fisica sono uguali in qualsiasi SRI • siccome le Equazioni di Maxwell sono una legge fisica, di cui c (che compare nelle √ equazioni come 1/ e0 µ0 ) è una costante, allora la luce deve viaggiare a velocità c in tutti i SRI (proprio per rispettare questa legge). Raggio di luce alla stazione Per far meglio capire la portata di questa affermazione, si può far accendere una lampadina ad un uomo fermo in stazione, e ad un uomo su un treno in moto (istantaneamente nello stesso punto dell’uomo fermo) Il raggio colpisce un cartello sui binari, verso cui il treno si sta muovendo. Siccome la velocità del raggio è la stessa, e l’uomo fermo vede un cartello fermo, mentre l’uomo sul treno vede un cartello che si avvicina, è inevitabile che i due uomini prevedano un tempo di percorrenza diverso. Questo, si può far vedere, non avverrebbe in relatività classica, con la composizione delle velocità per somma. Conclusione, per far sı̀ che c sia la velocità della luce sia per l’uomo sul treno che per quello a terra, la misura del tempo sui due sistemi di riferimento deve essere diversa. L’ABC della relatività di Galileo Eventi e trasformazioni di Galileo Siamo quindi giunti a stabilire che la velocità della luce sia “assoluta”, nel senso di indipendente dal SRI. Cosa significa questo? Prima di vederlo, dobbiamo ripassare le trasformazioni di Galileo. Ricordiamo le trasformazioni di Galileo per due sistemi di riferimento S e S, dove S si muove rispetto ad S con velocità v nella direzione x (ad esempio S) è una corriera in viaggio, mentre S è il sistema di riferimento della strada: x = x − vt (8) y=y (9) z=z (10) t=t (11) Vediamo di capire meglio cosa significa operare una trasformazione di Galileo, soprattutto, a cosa si riferiscono le coordinate x, y, z, t e x, y, z, t. Ad esempio le trasformazioni Eq. (8) possono contenere le coordinate x, y, z di un semaforo lungo la strada. Però c’è anche la coordinata t. Questa ad esempio si riferisce al momento in cui il semaforo diventa rosso. Qual’è l’oggetto quindi di questo spazio descritto con quattro coordinate, in cui c’è anche il tempo? L’oggetto fisico a cui si riferiscono è un evento, dove per evento intendiamo qualunque avvenimento oggettivo, verificabile dagli osservatori di tutti i sistemi di riferimento, che avvenga in un preciso punto dello spazio, e in un preciso istante. Un semaforo che diventa rosso diventa rosso in un preciso istante e in un preciso punto dello spazio. Non solo nel riferimento fermo della strada avviene in un preciso punto dello spazio, ma anche nel riferimento della corriera. Un viaggiatore sulla corriera può infatti dire: “il semaforo è diventato rosso dopo due secondi che l’avevamo superato, e quando l’avevamo già sorpassato di dieci metri”. Quindi anche il viaggiatore sulla corriera 15 riesce ad assegnare una precisa quaterna di coordinate spaziali e temporali all’evento “il semaforo diventa rosso”. La quaterna assegnata da un uomo sulla strada sarà diversa da quella assegnata dal viaggiatore, e le trasformazioni di Galileo mettono in relazione, per la fisica classica, le due quaterne tra di loro. È importante ricordare che l’Eq. (8) va bene scritta cosı̀ se nei due sistemi di riferimento si concorda su quale sia l’origine degli assi spaziali, e l’origine dei tempi. Ad esempio il viaggiatore e l’uomo sulla strada e quello sulla corriera potrebbero avere sincronizzato gli orologi nel momento in cui si sono incontrati all’incrocio, e aver preso le coordinate dell’incrocio come origine degli assi. La sincronizzazione degli orologi significa proprio fare sı̀ che t = t. Nel caso più generale in cui viaggiatore e uomo sulla strada non concordassero sull’origine degli assi spaziali e dei tempi, quello che le trasformazioni di Galileo ci permettono di scrivere è: x − x 0 = x − x0 − v ( t − t0 ) (12) y − y = y − y0 (13) z − z0 = z − z0 (14) t − t0 = t − t0 (15) 0 dove adesso le quantità che vengono messe in relazione sono esplicitamente differenze tra coordinate di un evento x, y, z, t, e un evento di riferimento x0 , y0 , z0 , t0 . Ribadiamolo, in generale le trasformazioni di Galileo ci aiutano a mettere in relazione le differenze di coordinate tra un evento dato e un evento di riferimento, che, nel caso particolare della corriera, poteva essere il passaggio del semaforo. Quando entrambi i sistemi di riferimento concordano sulla coordinata spaziale e temporale da dare all’evento di riferimento, allora si ha la forma semplificata (di solito quella che si trova sui libri) Eq. (8). Se guardiamo l’Eq. (12) osserviamo che la trasformazione di Galileo assomiglia ad un cambio di coordinate in cui le ascisse vengono combinate linearmente con il tempo, usando come “coefficiente” la velocità. Le trasformazioni di coordinate a cui gli studenti possono già essere abituati sono, per esempio, se pensiamo al piano cartesiano, quelle che “combinano” ordinate con ascisse, del tipo: x − x 0 = x − x0 (16) y − y = y − y0 − α ( x − x0 ) (17) 0 (18) in cui l’asse y non cambia, mentre l’asse x viene inclinato lungo una retta con coefficiente angolare −α. Supponiamo che io e un mio amico giochiamo a battaglia navale avendo lui come riferimento un piano cartesiano con assi ortogonali, e una intelaiatura a scacchiera fatta tracciando le parallele all’asse x e y, e lui un piano cartesiano con l’asse x inclinato. Anche lui traccia le parallele. Un evento può essere come un punto sul foglio, se facciamo due copie del foglio e su ciascuna tracciamo i due riferimenti cartesiani, le coordinate date all’evento saranno diverse, ma l’evento è uno solo. Le trasformazioni del piano consentono di prendere l’etichetta x, y data ad un punto rispetto ad un riferimento, ed esprimerla “nel linguaggio” dell’altro riferimento. I punti sul foglio sono assoluti. Se io disegno quattro punti a forma di quadrato, quando sia io che il mio amico lo guardiamo, continueremo a vedere un quadrato, ma saranno diverse le etichette che daremo ai vertici. Come si danno le etichette? Confrontando la posizione di ciascun vertice con una intelaiatura fatta tracciando parallele agli assi x e y, ovvero linee lungo cui cambia una sola coordinata alla volta, e guardando vicino a quale “incrocio” di parallele si trova 16 Alcuni esempi di eventi: fatti che avvengono in un istante ed in un punto determinabile in qualsiasi sistema di riferimento 1. scoppio di una bomba 2. il viaggiatore A incontra il viaggiatore B 3. il viaggiatore A passa all’incrocio ( x, y) della griglia del SR S, il cui orologio segna il tempo t 4. il viaggiatore A in moto rettilineo uniforme, cambia improvvisamente la sua velocità aumentandola, diminuendola, o cambiandone la direzione (il cambio di velocità è indipendente dal SR, mentre di quanto cambi, incluso l’angolo tra le due direzioni, dipende dal SR) 5. una palla rimbalza contro al muro 6. due palline rimbalzano simultaneamente nello stesso punto 7. un pendolo finisce di effettuare la sua terza oscillazione Alcuni esempi di cose che non si possono considerare eventi (i punti segnati in blu non sarebbero eventi neanche per Galileo): 8. due palline rimbalzano simultaneamente in due punti diversi dello spazio (il rimbalzo può essere simultaneo in un sistema di riferimento, e non simultaneo in tutti gli altri, quindi in questi SR il rimbalzo simultano potrebbe non avvenire mai) 9. il viaggiatore A incrementa la sua velocità di 30 m/s (in un riferimento inerziale rispetto a cui A si sta muovendo con velocità pari a c-3m/s questo incremento non avverrà mai, perchè gli farebbe superare la velocità della luce) 10. il viaggiatore A passa all’incrocio ( x, y) al tempo t (occorre specificare il SR) 11. il viaggiatore A svolta a destra, cambiando la direzione della sua velocità di 90 gradi (questa “svolta” a destra potrebbe essere a sinistra per un osservatore in moto relativo, rispetto a cui A si allontana invece di avvicinarsi) Tabella 2: IMPORTANTE: si ricordi che l’“accadere” di un evento è sempre assoluto (un evento “accade in qualsiasi sistema di riferimento”) ciò che è relativa è la sua etichetta x, y, z, t. Qualsiasi “accadimento” espresso in modo che non si possa verificare in tutti i sistemi di riferimento non si può considerare un evento. 17 ciascun punto. Quindi si misura l’etichetta del punto “per confronto” con una intelaiatura di incroci (anche questi punti) di riferimento. Cosa è un sistema di riferimento in relatività Nello scrivere le trasformazioni di Galileo Eq. (12), si è parlato di coordinate spaziali e temporali per il viaggiatore sulla corriera, e per l’uomo sulla strada. Più correttamente, si dovrebbe parlare di “sistema di riferimento” del viaggiatore, e dell’uomo sulla strada. Cosa intendiamo per sistema di riferimento? Nel paragrafo precedente, con l’esempio su un piano cartesiano di assi ortogonali o non ortogonali, con una trasformazione di coordinate dall’uno all’altro, il sistema di riferimento era l’insieme di punti tracciati come incroci “alla battaglia navale” tra parallele all’asse x e parallele all’asse y, assieme alle loro etichette x, y. I punti vengono usati come confronto. Una persona che gioca alla battaglia navale intenderà come sistema di riferimento la scacchiera in cui ogni quadretto è contrassegnato da una lettera e da un numero. Una persona che vive a New York prenderà come sistema di riferimento l’intelaiatura in Streets e Avenues, e i loro incroci. In generale un sistema di riferimento spaziale è una intelaiatura di punti di riferimento, contrassegnati con una etichetta di posizione. La posizione di qualsiasi altro oggetto può essere dedotta per confronto con la posizione dei punti di riferimento. In questo senso, un sistema di riferimento ci permette di tracciare una “mappa”. Per uno stesso terreno, è possibile prendere intelaiature di punti di riferimento diversi (ad esempio a New York usando le intersezioni tra paralleli e meridiani invece che streets e avenues come punti di confronto), e le trasformazioni di coordinate aiutano ad esprimere i punti di una “mappa” in funzione dei punti dell’altra “mappa”. Le trasformazioni sono quindi uno strumento “sociale” di “coordinamento” tra diversi sistemi di riferimento, e tra le loro mappe. Un po’ come le traduzioni sono strumenti sociali di comunicazione tra persone che parlano lingue diverse. La trasformazione (traduzione) presuppone quindi l’esistenza sia di qualcosa di relativo (la parola, che cambia con la lingua), sia di qualcosa di assoluto (il concetto che si vuole esprimere con quella parola). Analogamente, l’Hotel Metropolitan è un oggetto assoluto, sulla cui esistenza tutti concorderanno (indipendentemente dalla loro mappa, e concorderanno anche sul fatto che sia più vicino a Central Park che a Times Square, quindi concorderanno anche sulle relazioni reciproche di posizione di diversi oggetti). Sono le coordinate dell’Hotel Metropolitan a non essere uguali per tutti (l’indirizzo via e numero, piuttosto che la posizione GPS). Cosa c’è di speciale nelle trasformazioni di Galileo? C’è che ora tra le coordinate compare anche il tempo. Anzi, le trasformazioni di Galileo mescolano il tempo con lo spazio (ma non lo spazio con il tempo). Il nostro sistema di riferimento deve quindi comprendere una intelaiatura non soltanto rispetto allo spazio, ma anche rispetto al tempo. Se prima gli elementi dello spazio erano oggetti a posizione fissata, adesso il “terreno”, la “città” in cui ci muoviamo è lo spazio-tempo, ovvero gli elementi che lo caratterizzano sono gli eventi (oggetti a posizione fissata, a cui si attribuisce anche un tempo fissato). Quindi l’intelaiatura di punti di riferimento deve diventare non più una intersezione di (ad esempio per la città) una street (a x fissato e y variabile) con una avenue (a y fissato e x variabile), ma ora per ogni x e y fissati occorre aggiungere un asse a t variabile), quindi una intelaiatura di rette lungo cui cambia il tempo, ma non la posizione. Se il nostro asse x era una street, e l’asse y una avenue, l’asse t è un orologio posto all’origine x = 0 e y = 0. Mandare delle parallele a questo asse t in ogni punto x, y significa mettere un orologio, sincronizzato (ovvero con lo stesso t0 = 0) con quello in (0, 0), in ogni punto ( x, y). Dunque un prototipo di sistema di riferimento dello spazio-tempo è un reticolo di “strade”, con ad ogni incrocio un orologio. Questa intelaiatura costituisce una griglia di eventi di riferimento, dove ogni evento è ad esempio descrivibile come 18 Galileo Einstein sim. temporale 3 7 sim. spaziale 7 7 sim spazio-temporale 3 3 Tabella 3: Indipendenza dal SR del concetto di simultaneità spaziale, temporale, e spaziotemporale in Galileo ed Einstein “l’orologio in ( x, y) batte il minuto t”. Qualunque cosa (evento) succeda in questa città disseminata di orologi tutti sincronizzati, questa cosa accadrà nelle vicinanze di un qualche orologio, e precisamente quando questo batte una determinato minuto. L’evento accade indipendentemente dal sistema di riferimento (se mi dimenticassi di tracciare l’intelaiatura di strade, o di mettere gli orologi), ma il sistema di riferimento è necessario per “etichettarlo”, per “orientarmi” rispetto ad esso . Se ci restringessimo ad uno spazio bidimensionale, come quello della superficie di una città, potremmo rappresentare l’asse del tempo come un asse verticale (come un asse z). Una persona che siede su una panchina e sfoglia il giornale, genera eventi (ad esempio lo sfogliare una pagina) che si dispongono lungo un asse verticale. Una persona che va in bicicletta a velocità costante genera eventi (ad esempio la prima, la seconda . . . la ventesima pedalata) che si dispongono su una retta con una pendenza pari alla velocità (attenzione perchè in questo caso l’asse dei tempi è quello verticale, mentre in cinematica di solito l’asse x era quello verticale). Ora, uno può scegliere un altro sistema di riferimento, ad esempio una corriera che si muove lungo la dodicesima strada. Supponiamo che la corriera sia molto grande, e che anchèssa sia divisa in righe e colonne di sedili, con ad ogni incrocio un orologio. Se l’uomo in bicicletta viaggia esattamente alla stessa velocità della corriera, di fianco ad essa, le sue pedalate “avvengono” nel sistema di riferimento della corriera esattamente nello stesso punto. Un aspetto delle trasformazioni di sistema di riferimento che si vede già nella relatività di Galileo è che eventi che accadono nello stesso punto in un sistema di riferimento, possono non accadere nello stesso punto in altri sistemi di riferimento. In altre parole “accadere” nello stesso punto non è una proprietà indipendente dal sistema di riferimento, detto in altre parole ancora, se io dico “Quel signore che legge il giornale starnutisce nello stesso punto in cui il ciclista fa la sua prima pedalata”, il valore di verità della mia affermazione non è indipendente dal sistema di riferimento. Infatti il ciclista potrebbe fare la sua prima pedalata di fianco alla panchina, e di fianco alla corriera nel momento in cui questa passa di fianco alla panchina, e due minuti dopo il lettore del giornale starnutisce. I due eventi accadono nello stesso punto nel riferimento della città, ma in quei due minuti la corriera si è allontanata dalla panchina, quindi in particolare il signore starnutisce, nel riferimento della corriera (che ha la sua origine nel posto del guidatore, ad esemio), più lontano di quanto il ciclista faccia la sua prima pedalata. Sistema di riferimento inerziale Da quanto visto prima, un sistema di riferimento è una inpalcatura di incroci ed orologi. Due sistemi di riferimento possono essere in quiete relativa quando le due impalcature non si muovono l’una rispetto all’altra, oppure possono essere in movimento relativo. Posso calcolare la velocità relativa ad esempio usando un autovelox, usando come “automobile” un incrocio dell’impalcatura dell’altro sistema di riferimento. La velocità che calcolo io avrà la stessa direzione e verso opposto a quella che calcolerà un viaggiatore solidale all’altro sistema di riferimento che cerca di misurare la mia velocità. Secondo Galileo e Newton, un sistema di riferimento è inerziale quando è in quiete, o si muove di moto rettilineo uniforme rispetto ad un sistema di riferimento in cui valga la prima legge di 19 Newton, ovvero rispetto ad un sistema di riferimento in cui i corpi non soggetti a forze si muovono di moto rettilineo uniforme. Secondo la relatività Galileiana, in ogni SRI, la fisica avviene nello stesso identico modo. L’essere “in quiete o in moto rettilineo uniforme rispetto a (IMR)” è un concetto relativo. Possiamo vedere che questa frase stabilisce una relazione di equivalenza. Un SR è sempre IMR rispetto a se stesso, anzi, sempre in quiete rispetto a se stesso (proprietà riflessiva); se mi muovo a velocità v rispetto ad un altro sistema, lui si muove a velocità −v rispetto a me (proprietà antisimmetrica); se A si muove a velocità costante v rispetto a B e B con velocità costente u rispetto a C, allora C si muove con velocità costante rispetto ad A (transitiva).4 Questa ultima cosa è facile da vedere con le trasformazioni di Galileo, applicandole per due volte, troviamo che C si muove rispetto ad A con velocità u + v. Con la relatività speciale sarà un pò diverso, ma resterà il fatto che la velocità di C rispetto ad A sarà costante. Fissato il mio sistema di riferimento, posso classificare tramite una velocità v relativa al mio sistema di riferimento, tutti i SR che si muovono rispetto al mio di moto rettilineo uniforme, etichettandoli con questa v. Allora la IMR è una relazione di equivalenza, e posso stabilire delle classi di equivalenza. Per ogni classe posso scegliere un rappresentante che descrive la classe. Tra queste classi una sola è quella dei sistemi di riferimento inerziali, e la relatività Galileiana dice che tra questi non esiste un rappresentante privilegiato. Come controllare allora se il nostro sistema di riferimento è inerziale o no? Possiamo attaccare ad ogni incrocio dell’impalcatura del nostro sistema di riferimento un accelerometro, ovvero una molla con attaccata una massa, vicino ad una molla uguale senza massa. Supponiamo di essere in assenza di gravità. Se il nostro sistema di riferimento è accelerato, la molla con la massa si allungherà rispetto alla quella senza massa. La lunghezza della molla, e la sua inclinazione, ci dirà in quale classe di sistemi di riferimento siamo. La classe dei sistemi inerziali è quella in cui le molle non si allungano; per ogni allungamento e direzione della molla, esiste una classe di sistemi di riferimento accelerati. Dentro quella classe, esistono tanti rappresentanti quante sono le velocità relative. Le trasformazioni di Galileo permettono di connettere le coordinate spazio-temporali di due sistemi di riferimento che si muovono a velocità relativa v, quindi di connettere due rappresentanti in una classe. Riprendiamo una trasformazione di Galileo in una dimensione spaziale: x − x 0 = ( x − x0 ) − v ( t − t0 ) t − t0 = t − t0 (19) (20) Se supponiamo che il sistema di riferimento S, con coordinate degli “incroci” x, t sia in quiete (riferimento della strada), mentre S è la corriera; troviamo: dx = −v dt (21) ovvero x è la coordinata del semaforo nel riferimento della corriera, che si sposta con velocità −v rispetto ad un punto in quiete nella corriera. Se x fosse la coordinata di un punto in moto con velocità u rispetto alla strada, la derivata della sua coordinata x sarebbe (controllare per credere) dx/dt = u − v (ad esempio il ciclista che si muove a fianco della corriera). Questa è la legge Galileiana di trasformazione della velocità u di un viaggiatore da un sistema di riferimento ad un altro con velocità relativa v: la nuova velocità è la somma della vecchia velocità, e della velocità relativa del vecchio sistema di riferimento rispetto al nuovo (la strada si muove con velocità −v rispetto alla corriera). Se x fosse sempre la coordinata del ciclista, ed il ciclista stesse accelerando 4 Da notare, Einstein cambia la regola di composizione delle velocità, ma mantiene questa proprietà transitiva, mantenendo anche le prime due cosı̀ come sono. 20 con accelerazione a nel riferimento della strada, allora si avrebbe d2 x/dt2 = a, quindi l’accelerazione dei corpi, in relatività galileiana, è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali; l’accelerazione e la durata degli intervalli di tempo (t − t0 ) tra due eventi, sono invarianti per trasformazioni di Galileo. Questo ci ribadisce anche che l’aggettivo di “rettilineo uniforme” (a = 0) è invariante per trasformazioni di Galileo. Se un moto è rettilineo uniforme in un SR lo è in tutti i SR nella stessa “classe di equivalenza”. Sistema di riferimento “proprio” e linea di universo Ogni viaggiatore nello spazio-tempo è dotato anche lui di un suo orologio, supponiamo che disponga anche di un metro (bastano le sue braccia) per misurare le distanze. In effetti ogni viaggiatore, per lo stesso fatto di esistere e di possedere il suo “metro” individua sempre un sistema di riferimento ad esso “solidale”. Infatti ogni viaggiatore può considerare se stesso come origine degli spazi, e la mezzanotte del suo orologio come origine dei tempi. Può quindi immaginare di usare il suo metro per creare attorno a lui una intelaiatura di “incroci” per misurare lo spazio che lo circonda, e idealmente può pensare di porre una copia del suo orologio ad ogni incrocio. Se il viaggiatore ha attaccato a se stesso un lampeggiante, l’evento “n-esimo lampo di luce” descrive sempre, nel riferimento “solidale” con il viaggiatore, una serie di punti su una retta parallela all’asse t. Ovvero tutti questi eventi accadono nello stesso punto. Chiamiamo questo sistema di riferimento “solidale” in cui la posizione del viaggiatore è ad ogni tempo fissata, “sistema di riferimento proprio”. In un altro sistema di riferimento generico S rispetto a cui il viaggiatore è in moto, il lampeggiare della lampadina del viaggiatore descriverà una curva nello spazio-tempo. Se il viaggiatore è in moto rettilineo uniforme rispetto a questo sistema di riferimento S la curva sarà una linea retta in generale inclinata rispetto all’asse t e x (se supponiamo che ci si muova in una sola dimensione), la cui pendenza in ogni istante sarà la velocità del viaggiatore “relativa” al sistema di riferimento in cui lo osserviamo. L’insieme degli eventi “lampeggiare” della lampadina può essere messo in “ordine” rispetto a quale lampeggio avviene prima e quale dopo rispetto all’orologio del viaggiatore. L’ordine che diamo ai punti non dipende dal sistema di riferimento S, mentre come saranno disposti nello spazio dell’“intelaiatura” di incroci ed orologi di S dipenderà ovviamente dal sistema di riferimento. In generale l’insieme dei lampeggii, ordinati in questo modo, descrive una curva chiamata “linea di universo” (forse voi studenti la conoscete meglio come “legge oraria”), che ha forme diverse in sistemi di riferimento diversi... ma che nel sistema di riferimento “proprio” è sempre una retta parallela a t. L’orologio a luce Secondo il secondo postulato della relatività ristretta, la velocità della luce è la stessa in tutti i SRI. Questo postulato ha una ripercussione nel modo in cui il tempo trascorre in un sistema di riferimento piuttosto che in un altro. Prendiamo ad esempio un sistema di riferimento in cui un orologio sia in quiete, ad esempio uno degli orologi posti all’incrocio di una impalcatura di un SRI. Utilizziamo come orologio5 una coppia di specchi paralleli tra cui rimbalzi, in modo perpendicolare agli specchi, un raggio luminoso. Ogni volta che il raggio di luce ritorna al primo specchio dopo essere rimbalzato sul secondo, l’orologio registra il trascorrere di una “unità di tempo proprio (UTP)”, dove intendiamo “tempo proprio” il tempo che trascorre nel SR dove l’orologio è fermo. Supponiamo che la distanza degli specchi sia standardizzata, per cui l’UTP sia la stessa in tutti gli orologi. Se gli specchi sono a distanza l, 1 UTP= ∆τ = 2l/c. Se mi metto in un SR S che si muove con velocità v 5 Qui si può inserire una immagine dell’orologio a luce 21 rispetto all’orologio, in questo SR il raggio di luce che rimbalza da uno specchio all’altro viene “visto” viaggiare non lungo la stessa direzione avanti e indietro, per una lunghezza l, ma gli si vede percorrere un cammino inclinato L da uno specchio all’altro. L sarà l’ipotenusa di un triangolo che ha come cateti l e v∆t /2, dove ∆t è il tempo che la luce impiega a ritornare sul primo specchio, visto nel riferimento S. Siccome il raggio, per il secondo postulato della relatività speciale, deve sempre viaggiare con modulo della velocità uguale a c, ∆t = 2L/c. Questa ultima relazione si puó scrivere tutta in funzione di ∆t q 2 l 2 + v2 ∆2t /4 = ∆t (22) c e si trova: ∆2t = 4l 2 ∆τ 4l 2 = = 2 2 2 2 1 − v /c 1 − v /c 1 − v2 /c2 (23) Quindi il tempo che trascorre in S mentre l’orologio che è fermo in S ticchetta di un ∆τ = 1 UTP, risulta uguale a: ∆ t = γv ∆ τ (24) Questo fenomeno è detto “dilatazione dei tempi”, ed è un effetto che non è presente nella relatività Galileiana, per cui gli intervalli di tempo sono invarianti. L’assolutezza della velocità della luce costringe a considerare il trascorrere del tempo come “relativo”. In un mondo Galileiano, il raggio di luce visto da S muoversi attraversando lo specchio, avrebbe una velocità maggiore di c, e precisamente la sua componente nella direzione del moto sarebbe uguale a v, mentre quella ortogonale sarebbe uguale a c. Il tempo totale di attraversamento dell’orologio non cambierebbe. 6 Usando la (24) scritta in un altro modo: r v2 ∆τ = ∆t 1 − 2 (25) c si mostra chiaramente come gli intervalli di tempo misurati da un orologio a luce nel riferimento in cui l’orologio non si muove (ovvero nel riferimento “proprio” dell’orologio), sono sempre minori dei rispettivi intervalli di tempo misurati in qualsiasi sistema di riferimento in cui l’orologio è in moto. L’affermazione equivale a dire che “il quarto d’ora dell’orologio a luce” (il tempo che trascorre tra i due eventi quando la lancetta dei minuti è sul 12, a quando è sul 3), dura un quarto d’ora solo nel riferimento proprio dell’orologio a luce, mentre dura di più in qualsiasi altro sistema di riferimento in moto rispetto all’orologio. Il tempo scandito dell’orologio a luce nel suo sistema di riferimento proprio si chiama “tempo proprio”. Esercizio: viaggio verso una stella e ritorno Studiamo questo problema. In un certo SR, la Terra e la stella X distano 100 anni luce. Un astronave passa vicino alla Terra viaggiando con v/c = 0.99, quindi impiegherà t = 100/0.99 ≈ 101 anni a raggiungere X. Tuttavia il suo orologio segnerà che è passato √ un tempo uguale a ∆τ ≈ 101 1 − 0.98 ≈ 14 anni. Insomma, mentre sulla Terra i genitori, e forse i figli, del viaggiatore sono morti, lui è invecchiato di appena 14 anni! Se rimonta sull’astronave e torna indietro, passeranno nuovamente per lui altri 14 anni mentre sulla Terra ne passano 101. Risultato finale, viaggiando per 28 anni si ritroverà sulla Terra a 6 Qui si può proporre di studiare la funzione γv , facendo vedere che è maggiore di 1, e che tende a ∞ per v→c 22 vivere con persone di due secoli più avanti. È come se Napoleone, facendo un viaggio spaziale, rientrasse sulla Terra oggi. 7 Prima di proseguire nella discussione sul tempo proprio, introduciamo due strumenti, utilizzabili per la relatività Galileiana ma anche nella relatività speciale, che servono per calcolare la velocità relativa di due SRI in moto uno rispetto all’altro, l’“Autovelox” e il “Radar” (vedi sezioni 9.6 e 9.4)8 . Un sistema di riferimento speciale per due eventi Supponiamo che per t = t0 il primo maggio (in un riferimento S, ad esempio quello del Sistema Solare) vi sia una grigliata per x = x0 Terra, mentre per t = t1 primo maggio dell’anno dopo, vi sia una grigliata su x = x1 Giove. Un viaggiatore è interessato a presenziare a entrambi gli eventi, e subito dopo la grigliata sulla Terra azzera il suo orologio a luce e si mette in viaggio in moto rettilineo uniforme per raggiungere Giove in tempo per la grigliata successiva, quindi con velocità (spazio percorso fratto tempo impiegato) v = ( x1 − x0 )/(t1 − t0 ) = ∆ x /∆t . Arrivato su Giove, misura quante UTP sono passate sul suo orologio. Usando l’Eq. (23), troviamo una relazione tra ∆t anno e ∆τ , che è il tempo proprio misurato sull’orologio a luce del viaggiatore. ∆2τ = ∆2t − v2 2 ∆ c2 t (26) ma siccome il viaggiatore si è mosso di moto rettilineo uniforme, allora v∆t = ∆ x , quindi si ottiene: ∆2τ = ∆2t − ∆2x c2 (27) A secondo membro in pratica si sta sottraendo all’intervallo di tempo al quadrato che intercorre tra i due eventi, il tempo al quadrato che ci metterebbe la luce ad attraversare lo spazio tra uno e l’altro. Il viaggiatore che si muove in moto rettilineo uniforme dalla Terra a Giove in pratica si mette su un SR speciale, in cui le due grigliate avvengono nello stesso punto. Anche il primo membro in realtà contiene il tempo al quadrato che passa tra i due eventi, meno il tempo al quadrato che ci metterebbe la luce ad attraversare lo spazio che li separa, soltanto nel SR del viaggiatore entrambe le grigliate avvengono con la stessa coordinata spaziale. 9 In effetti, nel sistema di riferimento solidale al viaggiatore (che è il sistema di riferimento proprio del viaggiatore), i due eventi distano soltanto nel tempo, e non nello spazio, e la loro distanza nel tempo coincide con il tempo proprio che il viaggiatore vede trascorrere tra i due eventi. La cosa importante è che se in qualsiasi sistema di riferimento, ad esempio quello S di una cometa che si muove attraverso il sistema solare a velocità costante facciamo la differenza tra il tempo al quadrato che intercorre tra i due eventi ed il tempo al quadrato che la luce impiega a percorrere lo spazio tra i due eventi, otteniamo sempre la stessa quantità, che è questo ∆2τ , ovvero il tempo misurato su un SRI in cui i due eventi avvengono nello stesso punto, ovvero il tempo proprio di un viaggiatore che presenzia ad entrambi gli eventi, partendo subito dopo il primo evento e arrivando puntuale al secondo, muovendosi di moto rettilineo 7A questo punto in teoria per trasparenza sembrerebbe necessario evidenziare il paradosso: anche Napoleone vedrebbe ticchettare gli orologi del SR della Terra in modo più lento, dal suo punto di vista. Ritengo non opportuno sollevare la questione adesso, lasciando spazio all’effetto stupore causato da questo fenomeno di “viaggio nel tempo”. Ci si può tornare sopra al momento di discutere il paradosso dei gemelli dopo avere definito il tempo proprio. 8 Si procede a discutere l’autovelox, introducendo soltanto il Radar, rimandando la discussione di come funzioni a dopo 9 Sarebbe come dire che su un pullman che viaggia da Roma a Milano, tutti i rifornimenti di benzina avvengono alla stessa coordinata del SR del pullman, ovvero quella del serbatoio del pullman. 23 uniforme. Questo SR speciale è come la corriera che parte sullo stesso luogo ed allo stesso tempo dell’evento 1, e si muove in moto rettilineo uniforme in modo da arrivare esattamente puntuale sul luogo dell’evento 2. Una quantità per misurare la distanza tra eventi Si può considerare la quantità ∆2t − ∆c2x , espressa nell’equazione (27) come il quadrato di una vera e propria “distanza” tra due eventi nello spazio-tempo. 10 Se è positiva (si dice “di tipo tempo”), questa distanza si può scrivere come (prendendo la radice quadrata): r ∆2 ∆τ = ∆2t − 2x (28) c 2 come detto, corrisponde al tempo dell’orologio a luce di un viaggiatore che parte da un evento e si muove di moto rettilineo uniforme verso il luogo dell’altro evento, in modo da arrivarci “puntuale”. Di solito quando si risolve un’equazione con una incognita al quadrato, si estrae la radice e si prende col più o con il meno. La radice quadrata in Eq. (28) in questo caso si prende con il segno più, con la convenzione quindi che ∆τ sia positivo, ovvero l’intervallo di tempo scandito dall’orologio del viaggiatore si calcola tra l’evento che avviene dopo (nel riferimento del viaggiatore) e quello che avviene prima. Cosa vuole dire se la distanza tra due eventi è zero ( si dice “di tipo luce”)? Vuole dire che ∆2t = ∆c2x , ovvero che il viaggiatore dovrebbe muoversi alla velocità della luce per arrivare “puntuale”. In questo senso, quando ∆τ è positivo significa che la luce che partisse dal primo evento arriverebbe “in anticipo” al punto del secondo evento. Se ∆τ è zero, il viaggiatore deve viaggiare alla velocità della luce (solo un fotone può farlo), e il tempo proprio che trascorre per questo viaggiatore risulta essere zero (l’orologio a luce del fotone non ticchetta mai). Vi è anche la possibilità che la quantità sotto radice in Eq. (28) sia negativa (distanza “di tipo spazio”). In tal caso ∆τ è immaginario, e ciò significa che nessun viaggiatore riuscirebbe ad arrivare “puntuale” partendo dalla posizione di un evento e viaggiando verso la posizione dell’altro. Si può dire anche che il primo evento non ha alcun modo di “influenzare” il secondo, perchè nessun viaggiatore che è stato presente al primo evento potrebbe riuscire ad essere presente al secondo (arriverebbe sempre “in ritardo”, quando l’evento è già avvenuto)11 . Il fatto che ∆τ sia immaginario è un risultato del fatto che la relatività di Einstein rispetta il principio di causalità. È possibile dimostrare che per due eventi con un ∆τ immaginario (e quindi un ∆2τ negativo) si può trovare un sistema di riferimento in cui i due eventi avvengono contemporaneamente (il ∆τ di due eventi che avvengono contemporaneamente è sempre negativo o nullo). Anzi, se in un SRI i due eventi avvengono uno prima dell’altro, si può trova un altro SRI in cui il secondo avviene prima del primo. Due eventi per cui esista un sistema di riferimento che scambia l’ordine in cui accadono, non possono essere in relazione di causalità l’uno con l’altro12 . 2 10 Si osserva che la quantità Eq. (27) non resta la stessa se si applica una trasformazione di Galileo. Questo è un’ulteriore conferma del fatto che le trasformazioni di Galileo non sono adeguate alla fisica della relatività di Einstein, in cui Eq. (28) deve restare la stessa in tutti i SRI. Le trasformazioni di SR giuste, che descrivono il passaggio da un SRI ad un altro in relatività speciale, riproducendo correttamente la dilatazione dei tempi e mantenendo invariato ∆τ , sono diverse, e sono chiamate Trasformazioni di Lorentz. 11 Si possono fare molti altri esempi, ad esempio con l’alibi di un omicidio. L’assassino deve dimostrare di avere presenziato ad un evento “di tipo spazio” rispetto all’omicidio, altrimenti l’alibi cade. 12 Una sciocca battuta a tale proposito: sembra quindi che la nascita dell’uovo e della gallina siano due eventi di tipo spazio 24 Tempo proprio come lunghezza di una linea di universo Gli eventi della storia di una persona, o le tappe dalla legge oraria di un qualsiasi corpo, sono tutti eventi “di tipo tempo”, questo perchè nel sistema di riferimento della persona avvengono tutti nello stesso punto, e quindi il radicando nella Eq. (28) non ha la parte negativa, che dipende da ∆ x . Quando abbiamo una distanza13 , possiamo usarla per calcolare lunghezze non solo di tratti rettilinei, ma anche di curve. E in effetti, l’intervallo di tipo tempo ∆τ può essere usato per misurare il tempo trascorso sull’orologio a luce di un viaggiatore che si sposta nello spazio-tempo durante la sua vita, anche in modo curvo (non di moto rettilineo uniforme). Questo tempo proprio non è altro che la “lunghezza” invariante (misurata con la distanza invariante) della sua linea di universo (anche curva). Per effettuare la misura, basta considerare tanti eventi, sempre più vicini nel tempo, della storia del viaggiatore (Giovanni mangia la Pizza a Napoli, si lava i denti a Firenze, sale su un aereo a Londra, mangia il terzo grissino ad un aperitivo, mangia il quarto grissino, mastica la prima volta, la seconda . . . l’orologio a luce di Giovanni ticchetta una volta, due volte, tre volte . . . )14 , eventi della sua “linea di universo”, e sommare il ∆τ . La somma si può fare usando Eq. (28) in qualsiasi sistema di riferimento, basta calcolare i due intervallini a secondo membro. Tutti gli eventi avvengono nello stesso punto del SR del viaggiatore, quindi ∆τ = dτ è proprio uguale all’elementino di tempo proprio tra i due eventi. Inoltre, tra ciascuna coppia di eventi vicini, se sono abbastanza vicini, il viaggiatore si muove di moto approssimativamente rettilineo uniforme, ed arriva esattamente “in punto” per l’evento successivo, quindi ∆τ = dτ è anche la distanza nello spazio-tempo tra i due eventi. Si ottiene: Z Z r (dx )2 (dt)2 − 2 (29) Tproprio = dτ = c γ γ dove γ è la linea di universo del viaggiatore (la linea aperta composta ordinatamente dagli eventi x0 , t0 , x1 , t1 ... xn , tn della vita del viaggiatore). Il secondo membro si può calcolare in qualsiasi SR: se tra un evento con coordinate x, t e uno x + dx, t + dt, il viaggiatore si muove con velocità circa costante v(t) = dx/dt, si può scrivere Z Z r Z r v2 v ( t )2 2 2 dt − dt 2 = 1 − 2 dt Tproprio = dτ = (30) c c γ che equivale a sommare i “ticchettii” dell’orologio del viaggiatore durante tutto il suo percorso nello spazio tempo (uguali a secondo membro ai “ticchettii” dell’orologio del SR contratti del fattore di contrazione dei tempi 1/γv ) Si può dimostrare che se tra due eventi della sua vita t = t0 , x = x0 (ad esempio l’appuntamento per l’aperitivo al caffé concerto alle cinque) e t = t1 , x = x1 (ad esempio la proiezione del film al cinema estivo) per un sistema di riferimento S, un viaggiatore si muove di moto rettilineo uniforme con velocità uguale a ∆ x /∆t (percorre una linea di universo rettilinea nel piano x, t), la sua variazione di tempo proprio (ovvero il numero di UTP trascorse sul suo orologio a luce), che in caso di moto rettilineo uniforme è anche uguale, come detto prima, alla “distanza” nello spazio-tempo tra la colazione e la projezione al cinema, risulta essere la massima possibile. Supponiamo infatti che il bar ed il cinema si trovino a 10000 secondi/luce (1000 secondi ×c) di distanza di distanza, e l’intervallo di tempo tra la colazione e la projezione sia di 20000 secondi, circa cinque ore 13 Conviene ribadire che questa è una distanza molto strana, perchè può essere immaginaria si arriva a scandire gli eventi della linea di universo con i ticchettii dell’orologio proprio, si sta effettivamente parametrizzando la linea di universo come x (τ ), t(τ ), quindi si sta dando la definizione, senza dirlo, di linea di universo contenuta nei libri universitari di relatività 14 Quando 25 e mezzo. Se un viaggiatore si muove di moto rettilineo uniforme deve viaggiare a v = c/2, usando l’Eq. (30), si ricava15 : r 1 Tproprio = 20000 1 − ≈ 17320 (31) 4 quindi al viaggiatore sembrerà che tra l’aperitivo ed il cinema siano trascorsi solo 17320 (cinque ore meno un quarto), e non 10000 secondi. Se però, prima di andare al cinema, il viaggiatore vuole andare a comprare le sigarette a metà strada, a 5000 secondi-luce di distanza, arrivando prima della chiusura del negozio (che chiude circa alle sette, ovvero dopo 7000 secondi/luce) il percorso si spezza in due moti rettilinei uniformi tra il bar e il tabaccaio, e tra il tabaccaio ed il cinema, divisi da un momento di accelerazione: il tempo proprio del viaggiatore risulta più piccolo r r 25 25 Tproprio = 7000 1 − + 13000 1 − ≈ 4898 + 12000 = 16898 (32) 49 169 Ma la questione è ancora più paradossale di quanto sembra: se il viaggiatore decide di arrivare “in anticipo” sul luogo del secondo evento, in modo da potersi leggere un libro, ad esempio percorrendo i 10000 secondi-luce in 15000 secondi, invece che 20000, e poi stando fermo, si ottiene ancora: r √ 4 (33) Tproprio = 15000 1 − + 5000 1 − 0 ≈ 11180 + 5000 = 16180 9 ovvero, paradossalmente quando cerca di arrivare in anticipo, il tempo totale che ha a disposizione per leggersi il giornale tra un evento e l’altro diminuisce16 ! Questo perchè, anche in questo caso, il viaggiatore ha accelerato (ha cambiato il suo moto arrestandosi e mettendosi in quiete) in un punto dello spazio-tempo intermedio tra i due eventi.17 Abbiamo quindi questa proprietà: dati due eventi ed un viaggiatore che percorre una linea di universo che li ha come estremi, in altre parole un viaggiatore che nel corso della sua vita presenzia ad entrambi, la linea di universo tra i due eventi che comporta il massimo tempo proprio, ovvero il massimo invecchiamento, o più ottimisticamente il massimo tempo per leggersi il giornale, per il viaggiatore, è la linea rettilinea nello spazio-tempo, ovvero che comporta un moto rettilineo uniforme del viaggiatore. Vedendo le cose in modo equivalente, ma un po’ diverso, il sistema di riferimento “proprio” del viaggiatore, ad esempio l’automobile su cui si muove, sarà inerziale (si muoverà di moto rettilineo uniforme) se e solo se il tempo proprio del viaggiatore tra i due eventi sarà il massimo possibile. Se il viaggiatore, nel passare dal primo al secondo evento, dovesse accelerare (come è costretto a fare per comprare le sigarette), allora automaticamente tra l’aperitivo ed il cinema sul suo orologio trascorrerà meno tempo. Detto in altre parole, se la linea di universo è dritta, il suo tempo proprio è massimo. Se il viaggiatore accelera, la sua linea di universo è curva (o spigolosa), il tempo proprio è minore. In particolare, se due eventi avvengono nello stesso punto dello spazio rispetto ad un certo SR, il viaggiatore che presenzia ad entrambi gli eventi che registrerà il massimo intervallo di tempo proprio sarà il viaggiatore che non si muove in quel SR. 15 Nel mostrare questo caso ed i seguenti, si può disegnare alla lavagna la linea di universo nei diversi casi; questo può essere utile anche per rimarcare come il tempo proprio non sia uguale alla lunghezza “Euclidea” sul piano x, t, visto che la linea di universo misurata in modo Euclideo risulterebbe più lunga proprio quando invece comporta un tempo proprio minore 16 G.K. Chesterton direbbe “la fretta fa perdere tanto tempo” 17 Qui può essere utile rimarcare di nuovo come “punto dello spazio-tempo” ed “evento” siano due sinonimi. 26 Ecco perchè se di due gemelli uno resta sulla Terra, e uno fa un viaggio sul pianeta X (Sezione 8.5.1), quello che ha viaggiato ritorna sulla terra più giovane del primo. Tra l’evento partenza e l’evento arrivo sulla Terra, il secondo gemello ha effettuato un moto accelerato. Vedete allora che in relatività speciale esiste un altro modo di definire un SRI, ovvero un sistema di riferimento solidale ad un viaggiatore che percorre lo spazio-tempo in modo che tra i suoi “impegni” (gli eventi a cui presenzia) intercorra sempre il tempo proprio massimo (è ad esempio la corriera guidata da un viaggiatore che viaggia “con calma”, un viaggiatore “inerziale”). Einstein si accorgerà che in presenza di gravità, questa definizione di SRI fa allargare la classe dei SRI fino a comprendere anche i SRI accelerati “in volo libero” in campo gravitazionale, come un ascensore in caduta libera, e a causa di questa osservazione sarà portato a formulare la relatività generale, che estende ancora di più la validità della meccanica e dell’elettrodinamica, facendole valere anche in questa ulteriore classe di sistemi di riferimento. Conferme sperimentali della relatività speciale Tra le conferme sperimentali della relativits̀peciale possiamo annoverare: • l’esperimento di Michelson e Morley, che più che altro è una confutazione della teoria alternativa della propagazione della luce nell’etere (che impediva di estendere la relatività Galileiana all’elettromagnetismo) • la vita media del muone. Il muone è una particella che si forma negli strati alti dell’atmosfera, e come una bomba ad orologeria decade (“esplode”) dopo due milionesimi di secondo. Se non si verificasse il fenomeno della dilatazione dei tempi (il muone nel riferimento della terra decade dopo un tempo maggiore rispetto ai due milionesimi di secondo), il muone non avrebbe tempo di raggiungere la superficie della terra, cosa che invece avviene, in media, per la maggior parte di loro. • il sistema GPS; in effetti questo sistema ha bisogno non solo della relatività speciale, ma anche della relatività generale per funzionare. I satelliti che sono in orbita attorno alla terra inviano ai dispositivi terrestri un segnale elettromagnetico con la loro posizione ed il loro tempo. Dal momento in cui arriva il segnale e dall’informazione del tempo in cui è partito, io posso stabilire la mia distanza dal satellite. Ma il satellite è in moto rispetto alla terra, ed il suo orologio “ticchetta” più lentamente per una persona sulla Terra. L’informazione di tempo che lui mi invia è quindi “il suo” tempo, non “il mio”. Se non ne tengo conto sbaglio a calcolare la mia posizione. Se ne tengo conto, il GPS invece funziona. Spunti per motivare alle prossime unità didattiche Le unità didattiche successive, secondo la mappa in Fig. 1, sono la dinamica relativistica e la relatività generale. Per introdurre la relatività generale già da questa UD, ci si può agganciare alla nuova definizione di moto rettilineo uniforme data nella Sezione 8.8 in termini di percorso di massimo tempo proprio. Ai fini dell’introduzione della dinamica relativistica, può essere interessante partire dal concetto di dilatazione dei tempi e di orologio a luce, e provare a mettere di fianco a questo orologio a luce una molla. Per l’effetto di dilatazione dei tempi il periodo della molla sarà più lungo in un SR in cui la molla è in movimento. Questo, presupponendo che la seconda equazione di Newton sia valida in qualsiasi SRI, porta alla definizione di massa relativistica, ed introduce quindi i concetti chiave di energia ed impulso relativistici. 27 Strumenti per esperimenti mentali Mappa dello spazio-tempo Si tratta di una mappa t vs x di un particolare SRI, che usiamo per “etichettare” gli eventi, come punti sulla mappa. Sulla mappa si possono disegnare anche le linee di universo, ovvero le successioni ordinate (rispetto al ticchettio dell’orologio a luce proprio) di eventi a cui “presenzia” un viaggiatore nello spazio tempo. La “storia” di un individuo, in cui per ogni ticchettio del suo orologio si registra il punto in cui il ticchettio avviene, ed il momento t del SRI in cui avviene. Gli esercizi che si possono dare o svolgere alla lavagna concernenti questo strumento sono ad esempio: • una serie di eventi da rappresentare su una mappa (x, t), calcolandone le distanze invarianti, classificandoli come di tipo tempo, luce, o spazio. • dati degli eventi rappresentati su una mappa, rappresentarli su un’altra mappa, quella di un viaggiatore che si muove di moto rettilineo uniforme rispetto al primo sistema di riferimento, tenendo conto che per entrambi i sistemi di riferimento un particolare evento dato si trova nell’origine (basta quindi riscalare le variazioni di tempo). Questo esercizio in realtà è troppo avanzato rispetto a quanto visto in questa UD, in cui non si danno esplicitamente le trasformazioni di Lorentz. Nel caso però i due eventi siano di tipo tempo, è possibile ricavare la loro posizione sulla mappa del viaggiatore in moto anche senza sapere le trasformazioni di Lorentz. Sevirebbe però una lezione apposita che in questa unità didattica non si è prevista. Orologio a luce Questo strumento è già stato illustrato nella sezione 8.5. Sincronizzatore di orologi Abbiamo visto che un SR , già in relatività galileiana, consiste in una intelaiatura, in una impalcatura di assi paralleli agli assi x, y, z, con a ciascun incrocio un orologio. L’orologio a ciascun incrocio, in relatività speciale, è un orologio a luce. Risulta importante poter sincronizzare gli orologi a ciascun incrocio l’uno con l’altro, in modo che ad ogni punto del SR gli orologi battano la stessa ora. Per farlo basta mandare un messaggio in forma di onda elettromagnetica dall’orologio “ufficiale” del SR verso unp qualunque punto dello spazio. Il messaggio arriverà dopo un tempo ∆t = L/c, dove L = x2 + y2 + z2 , sottraendo ∆t al tempo indicato nel messaggio, si troverà l’orario su cui fissare le lancette dell’orologio a luce. Mentre gli orologi dello stesso SRI, una volta sincronizzati, resteranno in punto, gli orologi di due diversi SRI, a causa della dilatazione dei tempi, si sfaseranno. È possibile però fissare per entrambi una origine dei tempi, ovvero sincronizzarli almeno per un istante in modo che battano la stessa ora. Basta per esempio che (ricordando i due sistemi di riferimento strada-corriera) il guidatore della corriera, passando davanti alla stazione, legga il valore delle lancette (quindi la sincronizzazione degli orologi deve avvenire come un singolo evento, stesso istante, stessa posizione), e poi utilizzando il messaggio elettromagnetico sincronizzi tutti gli orologi del suo sistema di riferimento rispetto al suo orologio personale. Autovelox Una corriera S viaggia in autostrada a velocità v prossima a quella della luce. Un autovelox nel SR S della strada verifica questa velocità come segue: due sensori sono posti a distanza L sopra due pietre miliari consecutive (i cartelli che indicano il kilometraggio lungo le 28 strade), ciascun sensore scatta quando gli passa davanti il muso della corriera. Lo scatto di un sensore è un evento. Il tempo ∆t tra ciascuno scatto del sensore permette di calcolare v = L/∆t . È importante che i due orologi dei due sensori siano sincronizzati. Sulla corriera invece il tachimetro del guidatore viene regolato usando un altro criterio, ogni volta che un sensore sulla ruota anteriore della corriera passa davanti ad una pietra miliare, registra l’intervallo di tempo tra una pietra miliare e la precedente. Sulla corriera l’orologio proprio del guidatore ticchetta più lentamente rispetto all’orologio che è installato su ciascun sensore dell’autovelox, dunque tra un passaggio davanti al primo sensore ed il passaggio davanti al secondo sensore, passa un tempo ∆t = ∆t /γv , quindi se L è la distanza tra i due sensori misurata sulla corriera, il modulo della velocità rispetto alla strada viene calcolata come v = γv L/∆t . Ma se per il SR S la corriera viaggia a velocità in modulo v, per il SR S, la strada le viene incontro con velocità −v, quindi uguale in modulo e opposta, per un principio di simmetria nel moto relativo tra i corpi. Allora questo significa che si deve avere γv L/∆t = L/∆t , ovvero che L = L/γv . Da notare che se il guidatore prendesse per buone le distanze scritte sulle pietre miliari, e calcolasse la sua velocità come L/∆t troverebbe un valore di γv L/∆t = γv v, che è maggiore di v, e che tende addirittura ad infinito quando v → c. Bomba a orologeria Si tratta di una bomba che ha come timer un orologio a luce, e che esplode dopo un intervallo di tempo proprio ∆τ fissato dal momento dell’innesco. Un terrorista la lancia ad una certa velocità rispetto al proprio SR di quiete, cercando di farla esplodere in corrispondenza di un certo evento di coordinate (∆ x , ∆t ) nel SR dell’osservatore. Questo evento può essere considerato anche l’incontro della bomba con un viaggiatore in moto rispetto al terrorista. Si possono creare svariati esercizi a partire da questo strumento, faccio alcuni esempi: Esercizio: lancio di una bomba Il viaggiatore ed il terrorista sono fermi, condividendo lo stesso SR . Il terrorista ha un lancia-bombe che spara bombe a velocità fissata u, e deve stabilire di conseguenza la lunghezza della miccia per riuscire a fare esplodere la bomba al momento giusto. Il tempo che passa tra il lancio della bomba e l’incontro della bomba con il viaggiatore é chiaramente uguale a (supponiamo che il viaggiatore sia a distanza L): ∆t = L u (34) tuttavia il tempo proprio dell’orologio della bomba che trascorre tra il lancio e l’incontro della bomba e del viaggiatore è: ∆τ = L γu u (35) Se il terrorista non tiene conto della “lentezza” dell’orologio della bomba quando questa viene messa in moto, e per esempio fissa la miccia in modo che la bomba esploda dopo ∆τ = L/u, il viaggiatore può prendere in mano la bomba e lanciarla indietro verso il terrorista; se fa bene i conti, l’ignoranza della teoria della relatività può costare molto cara al terrorista. Infatti al viaggiatore resta ancora un tempo: L 1 0 ∆τ = 1− (36) u γu 29 per lanciare la bomba all’indietro con velocità v e farla esplodere in corrispondenza del terrorista.18 Per ottenere la velocità di lancio deve risolvere l’equazione implicita (dove si conosce ∆0 τ): ∆0τ = L γv v (37) e si trova L ∆0τ v= r 1+ L c∆0τ 2 (38) Questo problema può essere utilizzato per illustrare il fenomeno dei muoni, che in effetti non sono altro che “bombe” lanciate dall’atmosfera verso la terra. Il fatto che facciano più strada di quanto non ci si aspetterebbe prima di decadere (“esplodere”) avviene per la stessa ragione per cui la bomba di questo esercizio esplode in ritardo rispetto a quanto il terrorista “Galileiano” non si aspetterebbe. Esercizio: attentato suicida Equivalentemente, si può considerare un viaggiatore che si muove ad una certa velocità u rispetto al SR del terrorista, questa volta un kamikaze, il quale fissa il timer della bomba e si lascia esplodere sul posto, senza lanciarla. In questo caso il timer deve essere fissato a L/u secondi invece che L/(uγu ). Si può far notare che la differenza di tempo di innesco tra questo caso ed il caso precedente, in cui la bomba viene lanciata, è dovuta ad una asimmetria tra i due problemi. Nel caso precedente la bomba subisce una accelerazione dopo che il timer è stato fissato, nel secondo caso non subisce nessuna accelerazione. L’accelerazione che la bomba subisce tra l’evento innesco e l’evento incontro con il viaggiatore è responsabile del fatto che il tempo proprio che trascorre tra i due eventi sia minore di quello che trascorrerebbe se la bomba non subisse accelerazione (ad esempio se la bomba fosse già in movimento al momento dell’innesco assieme al terrorista, il quale però calcolerebbe, a causa della contrazione delle lunghezza, che la distanza del viaggiatore sia L/γu ) Esercizio: doppio attentato Si può utilizzare lo strumento della bomba (anzi due bombe) per mostrare il concetto di relatività della simultaneità. Il terrorista lancia due bombe con velocità in modulo uguale a v, una verso destra e una verso sinistra, per fare esplodere due obiettivi governativi simultaneamente, dislocati a distanza ± L. Le bombe hanno lo stesso tempo di innesco ∆τ , quindi nel riferimento del terrorista esplodono simultaneamente, a distanza spaziale identica dal terrorista, e pari a L/(γu ∆τ ). Dal punto di vista di un viaggiatore su una corriera con verlocità u, tuttavia, la bomba che gli viene incontro avrà rapidità r (v0 ) = r (v) + r (u), mentre quella che si allontana avrà rapidità minore: r (v00 ) = r (v) − r (u) 19 . Quindi il viaggiatore vedrà ticchettare l’orologio della bomba che si avvicina più lentamente dell’orologio della bomba che si allontana. Quindi la bomba che si allontana, nel riferimento del viaggiatore, esploderà prima di quella che si avvicina. A che distanza dal terrorista esploderanno nel riferimento del viaggiatore? Nel riferimento del terrorista, esplodono a distanza L dal terrorista. Qui conviene usare la distanza invariante tra l’evento “lancio” e l’evento “esplosione”. Essa è uguale al tempo proprio 18 NB una conseguenza del principio del massimo tempo proprio nei moti rettilinei è anche il fatto che più ci si “rimpalla” un orologio, meno rapidamente l’orologio ticchetta. 19 Se non si è ancora fatto il Radar (vedi Sezione 9.6) e manca il concetto di rapidità, basta parlare di velocità. 30 di ciascuna bomba tra il lancio e l’esplosione: ∆τ . Nel riferimento della corriera, si ha (∆0t )2 − (∆0x )2 /c2 = ∆2τ = (∆00t )2 − (∆00x )2 /c2 . Siccome ∆0t > ∆00t , allora si deve avere anche ∆0x > ∆00x . Quindi la bomba che viene verso la corriera esplode più lontana dal terrorista di quella che si allontana. Radar Usando un emettitore di onde elettromagnetiche, un viaggiatore V in un SR S nello spaziotempo può controllare la velocità relativa di un altro SR S, su cui sia stato installato uno specchio. Il metodo funziona in questo modo: il viaggiatore invia due segnali luminosi ravvicinati, il primo ritardato di un intervallo di tempo ∆ rispetto al proprio orologio a luce. Dopo un certo lasso di tempo T, riceve il primo due segnali, dopo T 0 = T + ∆00 riceve il secondo segnale. Anche questi tempi sono ovviamente misurati rispetto all’orologio a luce del viaggiatore. Il valore del ritarto ∆00 tra l’arrivo del primo e del secondo segnale è uguale a ∆ soltanto se lo specchio è fermo rispetto al viaggiatore. Altrimenti si modifica. Dal tempo di arrivo del primo segnale inviato, e dal confronto tra ∆ e ∆00 si possono estrarre due informazioni utilissime: la prima è la velocità dello specchio rispetto al viaggiatore, la seconda è la distanza dello specchio L al momento dell’invio del primo segnale. Vediamo come ottenerle. Ricordiamo che il SR S dove facciamo i conti è quello dove il viaggiatore è fermo e lo specchio si sta muovendo, supponiamo avvicinandosi, con velocità v. Il primo segnale (1) s1 verrà emesso al tempo τ0 = 0, quando lo specchio si trova a distanza L. Impiegherà quindi un tempo δτ = ( L − vδτ )/c 20 a raggiungere lo specchio, e lo stesso tempo a rientrare, quindi otteniamo: T = 2δτ = 2L v+c (39) (2) Il secondo segnale verrà emesso al tempo τ0 = ∆, quando lo specchio si trova a distanza L − v∆, quindi per tornare al viaggiatore impiegherà un tempo (abbiamo imparato come si fa, usiamo la stessa formula) 2( L − v∆)/(v + c), che sommato al tempo a cui è stato emesso ci fornisce il tempo finale di arrivo: T0 = ∆ + 2( L − v∆) v+c Se calcoliamo la differenza tra i due tempi di arrivo, troviamo: −2v∆ 1 − v/c 00 0 ∆ = T −T = ∆+ = ∆ v+c 1 + v/c (40) (41) Una osservazione: il ritardo ∆0 con cui, in S, i due raggi colpiscono lo specchio, è uguale a (basta sommare metà del secondo termine nella (41), cosı̀ che si considera metà del percorso dei raggi soltanto, cioè l’andata): −v∆ 1 0 ∆ = ∆+ = ∆ (42) v+c 1 + v/c Quindi se calcoliamo la quantità D (−v) (la chiamiamo D (−v) come “doppler”, mettiamo il meno perchè lo specchio viene “incontro” all’onda) che descrive la contrazione dell’intervallo tra i due impulsi, troviamo ∆00 1 − v/c D (−v) = = (43) ∆ 1 + v/c 20 quando colpisce lo specchio, lo specchio si è avvicinato di una distanza proporzionale al tempo che il raggio ci ha messo a raggiungerlo 31 possiamo ottenere la velocità con cui lo specchio ci viene incontro come: D (v) − 1 v=c D (v) + 1 (44) e quindi anche la L misurata al tempo τ = 0 L= 1 T (v + c) 2 (45) cosı̀ che la distanza L0 al momento T 0 della ricezione del secondo segnale (che è il momento in cui si ha tutta l’informazione per calcolare v e L), sarà L0 = L − v( T 0 ) = 1 T (v + c) − vT 0 2 (46) Dal punto di vista dello specchio Supponiamo adesso di metterci nel SR dello specchio, S, in cui lo specchio è fermo. Lo specchio vede arrivare i due raggi di luce inviati dal viaggiatore, questa volta in moto. Supponiamo che assieme a ciascun segnale venga inviata anche l’informazione rispetto all’orario dell’orologio a luce del viaggiatore a cui il segnale è stato emesso, in modo che si possa conoscere, in particolare, il valore di ∆. Ricordiamo√che il secondo-luce dell’orologio del viaggiatore in moto viene percepito come γv = 1/ 1 − v2 /c2 volte più lungo dall’osservatore vicino allo specchio. Se fissiamo per convenzione come tempo t = 0 quello a cui viene emesso il primo raggio (nel riferimento S), il secondo raggio viene emesso con un ritardo ∆ = γv ∆ nel riferimento S. Nel frattempo il viaggiatore sarà avanzato di una distanza l = v∆, che dà al secondo raggio un vantaggio di v∆/c secondi. Quindi l’intervallo ∆0 tra l’arrivo sullo specchio del primo e del secondo segnale sarà, nel riferimento S uguale a: v ∆0 = 1 − ∆ (47) c e ricordandosi della dilatazione dei tempi, si ottiene v γv ∆ = ∆0 = 1 − c r 1 − v/c 1 + v/c ! ∆ (48) Quindi abbiamo ottenuto come coefficiente di proporzionalità tra il ritardo di emissione (misurato nel SR dell’emettitore) e quello di riflessione sullo specchio (misurato nel SR dello specchio), esattamente la radice quadrata del termine trovato nell’Eq. (43). Da notare come a questo punto, scambiando i ruoli di S e S, si può guardare l’intervallo di ricezione ∆00 con cui i due segnali riflessi dallo specchio arrivano sul viaggiatore in S, calcolandolo in funzione dell’intervallo di riflessione ∆0 . In questo caso è come se i raggi partissero dallo specchio in moto ed arrivassero al viaggiatore nel riferimento in cui egli è fermo. Si ottiene quindi che il ritardo tra i due segnali ricevutip in S rispetto al ritardo con cui partono dallo specchio in S è più breve di un altro fattore (1 − v/c)/(1 + v/c), cosı̀ che: ! r 1 − v/c 00 ∆ = ∆0 (49) 1 + v/c e usando l’espressione (48) di ∆0 in funzione di ∆, si torna ad ottenere l’Eq. (41). 32 Confronto con l’effetto Doppler per onde che si propagano in un mezzo Se andiamo a rivedere l’espressione per l’effetto doppler in fisica classica per un’onda che si propaga in un mezzo con velocità u, ad esempio un’onda sonora, troveremo che le due espressioni per il ritardo tra due impulsi inviati in un SR dove il mezzo è fermo, riflessi da uno specchio in moto (che, riflettendo, si comporta come una sorgente in movimento), e nuovamente ricevuti dall’emettitore, è ancora: 1 − v/u ∆00 = ∆ (50) 1 + v/u tuttavia nell’ambito della fisica classica, gli intervalli di tempo non cambiano da un SR all’altro per cui gli intervalli sottolineati sono uguali agli intervalli non sottolineati; inoltre, essendo il mezzo di propagazione fermo nel riferimento di S, la velocità u è tale soltanto in S, mentre in S risulta essere uguale a u + v, per la composizione galileiana delle velocità. Se andiamo a calcolare il ritardo con cui i due raggi colpiscono lo specchio (Doppler da sorgente ferma ed osservatore, lo specchio, in moto), troviamo esattamente l’Eq. (42). −v∆ 1 ∆0 = ∆ + ∆ (51) = v+u 1 + v/u dove u è la velocità del suono. Se consideriamo ora lo specchio come emettitore (sorgente in moto), troviamo, in modo analogo a Eq. (47), v 0 ∆00 = 1 − ∆ (52) u É interessante notare come ora vi sia una asimmetria tra il percorso di andata e quello di ritorno. Questo avviene proprio perchè i due sistemi di riferimento non sono più equivalenti rispetto alla legge di propagazione delle onde. Questa asimmetria tra i due percorsi dell’onda scompare in relatività speciale. 21 Composizione delle velocità Analizziamo ora tre sistemi di riferimento S, S e S. I primi due sono gli stessi del problema precedente sull’effetto Doppler, ovvero il riferimento del viaggiatore e quello dello specchio. Se ci mettiamo in S, di fianco al viaggiatore, vediamo lo specchio muoversi con velocità v verso di noi. Supponiamo di metterci in S quindi di fianco allo specchio, e supponiamo anche che lo specchio sia semitrasparente, cosı̀ che parte del segnale luminoso invato dal viaggiatore oltrepassi lo specchio. Stando nel riferimento dello specchio vediamo un altro specchio in movimento verso di noi con velocità u. I due impulsi inviati dal viaggiatore con ritardo ∆, raggiungeranno il primo specchio fermo in S con un ritardo pari a ∆0 , che abbiamo già calcolato in Eq. (48) in funzione del ritardo in S, e verranno in parte riflessi, arrivando al viaggiatore, nel suo riferimento S, con un ritardo ∆00 già visto in Eq. (41). In parte i due impulsi verranno trasmessi, e si rifletteranno sul secondo specchio. Se pensiamo soltanto ai SR S e a S, vediamo che possiamo vedere lo specchio fermo in S come un emettitore (ha il ruolo che prima aveva il viaggiatore), mentre lo specchio fermo nel riferimento S ∗ assume il ruolo che prima aveva lo specchio in S. Se scriviamo come ∆ il ritardo con cui i due impulsi arrivano al secondo specchio, troviamo la relazione: ! ! r ! r r 1 − u/c 1 − u/c 1 − v/c ∗ ∆ = ∆0 = ∆ (53) 1 + u/c 1 + u/c 1 + v/c 21 Un’altra cosa da notare è che, nel caso lo specchio si muovesse a velocità maggiore di u, l’intervallo di ritorno alla sorgente dei due segnali emessi potrebbe essere negativo: i due segnali potrebbero invertirsi, e quello emesso per secondo arrivare per primo: una cosa che invece non può succedere nel caso di segnali luminosi emessi dalla stessa sorgente. 33 Che lega il ritardo sullo specchio in S al ritardo di emissione in S. Se togliamo lo specchio intermedio, e facciamo i conti considerando soltanto i due SR S, e S, quello che troviamo dovrebbe essere una espressione di questo tipo: ! r 1 − u0 /c ∗ ∆ (54) ∆ = 1 + u0 /c dove u0 è la velocità che il viaggiatore rileverebbe usando il radar direttamente contro lo specchio in S, ovvero è la velocità di S rispetto ad S. Secondo Galileo, questa dovrebbe essere uguale a u + v, e a noi cosa viene? Abbiamo calcolato in due modi diversi quanto cambia il ritardo tra i due impulsi tra il riferimento S e S. Allora dobbiamo per forza avere, per essere consistenti: ! ! r ! r r 1 − u0 /c 1 − u/c 1 − v/c = (55) 1 + u0 /c 1 + u/c 1 + v/c Risolvendo questa equazione, troviamo: u+v 1 + uv c2 u0 = (56) Osserviamo una serie di cose interessanti: • se u, v sono piccole rispetto a c, il denominatore è circa uguale a 1, e si ritrova la legge di composizione che si ottiene dalle trasformazioni di Galileo. • il fatto che in generale le velocità non si sommino, significa che le trasformazioni di Galileo in generale non sono valide • la velocità di uno specchio in moto non potrebbe mai essere maggiore di c, questo è un risultato importante che si poteva intuire già dalla divergenza del fattore γ: delle velocità maggiori di c non hanno senso, non sono fisiche22 . • guardando l’Eq. (55), se si prendono i logaritmi di entrambi i membri, si trova: 1 ln 2 1 − u0 /c 1 + u0 /c 1 = ln 2 1 − v/c 1 + v/c 1 + ln 2 1 − u/c 1 + u/c (57) v/c Einstein ha chiamato la quantità r (v) = 21 ln 11+ −v/c “rapidità”. Per ricordarsi la legge di composizione delle velocità basta ricordarsi che mentre in relatività Galileiana le velocità si sommano, in relatività speciale le rapidità si sommano. Si può notare che per v piccole, r (v)/v → 1, mentre r (v) → ∞ per v → c. Quindi mentre la velocità relativa di due SR non può essere mai maggiore di c, la rapidità può avere valori arbitrari (proprio come prima la velocità in ambito Galileiano). • in funzione della rapidità, il fattore di contrazione (o dilatazione) doppler dell’intervallo tra i due impulsi D (v) si scrive come exp 2r (v) (un fattore exp r (v) all’andata e exp[r (v)]+exp[r (−v)] uno al ritorno). Il fattore di dilatazione temporale γv si scrive come 2 che è una funzione crescente di r (v). 22 si può provare a comporre due velocità, ad esempio 3/4c e c/2, il risultato sarà minore di c 34 Alcuni suggerimenti per affrontare un problema di relatività 1. individuare gli eventi in gioco, ricordandosi la definizione di evento 2. individuare di volta in volta i sistemi di riferimento in gioco, e le velocità di ognuno rispetto agli altri 3. ricordarsi che gli intervalli di tempo e le distanze hanno un valore diverso in un sistema di riferimento rispetto ad un altro; per non sbagliarsi è meglio usare dei simboli diversi per sistemi di riferimento diversi, e quando si fa il disegnino del problema, fare un disegno diverso ogni volta che si considera un sistema di riferimento diverso 4. invece la luce viaggia sempre alla stessa velocità c; si può usare questa cosa per calcolare calcolare distanze o tempi in un qualsiasi sistema di riferimento 5. chiedersi sempre se per qualsiasi ragione si sta usando un concetto fisico come se ci si trovasse in relatività galileiana: non siamo abituati a lavorare in relatività di Einstein, e quindi il cervello, se non stiamo attenti, tende a farci fare ragionamenti sbagliati. 6. ricordarsi che oltre a c, anche la “distanza spazio-temporale” tra due eventi è sempre uguale in tutti i sistemi di riferimento. Può essere utile calcolarla prima in un sistema di riferimento, poi in un altro, per trovare una relazione tra intervalli di tempo e di spazio nei due sistemi di riferimento. 7. cercare di individuare delle “simmetrie” nel problema, ovvero cercare di capire se due quantità che in un problema generico non sono uguali, devono essere uguali per il problema in esame a causa di “situazioni identiche” (si veda il problema dell’effetto doppler nella sezione 9.6, dove in relatività si possono scambiare i ruoli di viaggiatore e specchio, ottenendo le stesse formule per il ritardo tra i due impulsi luminosi emessi e ricevuti) Valutazione Valutazione formativa Per la valutazione formativa si intende assegnare a casa degli esercizi, da risolvere di volta in volta. Si possono chiamare brevemente alla lavagna alcuni studenti a correggerli e discuterli, ed annotarsi alcune considerazioni che possano essere usate per compilare la rubric Tabella 4. È prevista un’ora in cui si propongono degli esercizi da fare a piccoli gruppi, con discussione di classe alla fine. Verifica sommativa Si propone un compito in due sezioni: domande aperte e problemi. Si indica come un’ora e mezza il tempo per svolgerlo, eventualmente dando una mezz’ora in più nel caso ci si renda conto che i ragazzi hanno difficoltà a svolgerne una parte soddisfacente in novanta minuti. Per ciascuna sezione, si richiede di svolgere metà del compito. Si assegnano 6 punti ad ogni domanda aperta, 24 punti ad ogni problema. Idealmente, per i soli problemi si vorrebbe porre la sufficienza a 27 punti, ovvero poco più del punteggio di un problema completo. Un alunno che si trovasse in difficoltà a risolvere un problema intero potrebbe arrivare alla sufficienza anche svolgendo le parti più facili di ciascun problema. Mettendo insieme problemi e domande, si richiede, per avere la sufficienza, un punteggio di 40. Il punteggio di un compito svolto perfettamente (4 domande, 2 problemi), è di 72. Il 35 punteggio massimo ottenibile è il doppio, ma ci sono limiti oggettivi di tempo che rendono la possibilità che uno studente faccia l’en plein estremamente remota. Domande aperte Si chiede di rispondere a metà delle domande (6 pt a ciascuna domanda). La valutazione di completezza di ciascuna domanda viene fatta utilizzando le prime due righe della rubric in Tabella 4. 1. Enunciare il primo postulato della relatività speciale; enunciare una osservazione teorica e una sperimentale che hanno portato alla sua formulazione. 2. A cosa si riferisce il termine “relatività”? Che cosa è “relativo” nella teoria? Che cosa non lo è? 3. Se Einstein avesse potuto discutere con Galileo, che cosa avrebbe approvato della sua relatività Galileiana? Che cosa avrebbe invece contestato? Percè 4. Perchè secondo te si è dovuto aspettare fino a fine ’800 per poter formulare la teoria della relatività speciale? Non poteva scoprirla anche Galileo? 5. A cosa “serve” la relatività speciale? Enunciare una applicazione di cui ciascuno di noi beneficia nella vita di tutti i giorni, e spiegare perchè senza la relatività di Einstein non funzionerebbe. 6. Descrivere il concetto si SR in relatività. 7. Descrivere il concetto di evento in relatività. Fare due esempi di cose che sono eventi, e se possibile un esempio di una cosa che non è un evento. 8. Qualè il nuovo concetto di SRI che emerge alla fine della formulazione della teoria della relatività speciale e che prelude alla relatività generale? Chiarire la connessione con il concetto più tradizionale di SRI. Problemi Si risolvano due dei seguenti quattro problemi. La valutazione di completezza dei singoli punti viene fatta secondo la seguente griglia: i) 100%, risultato corretto, risposta completa di passaggi corredati di una breve spiegazione; ii) 80% qualche errore di calcolo, oppure spiegazione troppo stringata e mancante malgrado risultato corretto, oppure passaggio finale lasciato in sospeso; iii) 60% mostra di avere capito in che direzione procedere nello svolgimento, ma lo svolgimento è lacunoso, salta passaggi, o non giustifica nessun passaggio, i risultati sbagliati non derivano da errori concettuali ma da difficoltà nel problem solving; iv) 40% commette un errore concettuale (o interpr) che compromette lo svolgimento dell’esercizio; v) 20% commette un errore concettuale grave; vi) 0% non risolve. 1. John Wayne e Clint Easwood si affrontano in un duello con la pistola. Il tempo di reazione di Clint è il doppio di quello di John, che vale ∆t . La pistola di Clint però, spara proiettili al triplo della velocità rispetto a quelli di John, che viaggiano con velocità u rispetto alla pistola che li ha sparati. Dopo che l’arbitro dello scontro ha dato il via, John e Clint estraggono la pistola e sparano dopo che è trascorso il loro tempo di reazione. John e Clint distano L nel loro sistema di riferimento. • determinare, se esiste, qual’è il valore minimo di L (in funzione di ∆t e di u) affinchè John riesca ad uccidere Clint prima che Clint riesca a sparare. (2 pt) • determinare, se esiste, qualè il valore minimo di u (in funzione di ∆t e di L), affinché Clint riesca ad uccidere John prima che John riesca a sparare. (2 pt) 36 • nel caso entrambi i contendenti riescano a sparare, determinare in quali casi muore prima Clint, ed in quali casi muore prima John (calcolare la posizione e il tempo dell’evento “morte di Clint” e “morte di John” in funzione dei parametri del problema). (2 pt) • calcolare la distanza invariante nello spazio-tempo tra i due eventi “morte di Clint” e “morte di John”, è reale o complessa (o dipende, e se dipende, in quali casi è reale ed in quali casi è complessa)? (6 pt) • esiste un sistema di riferimento (in moto rispetto a John e Clint) in cui John e Clint muoiono contemporaneamente? (6 pt) (suggerimento, considerare la distanza tra i due eventi di morte dei due contendenti) Trovare questo sistema di riferimento. (6 pt) 2. un razzo a più stadi parte dal pianeta X (supposto in un sistema di riferimento inerziale) con velocità v, di cui si fissa la direzione. Dopo un tempo ∆τ (nel riferimento del razzo), dal razzo si sgancia un secondo stadio, un razzetto che viaggia a velocità v rispetto al razzo iniziale. Dopo un altro tempo ∆τ , si sgancia un altro razzo, sempre con velocità v rispetto al precedente. • descrivere come varia nel riferimento del pianeta l’intervallo di tempo tra un distacco e l’altro di uno stadio del razzo. (6 pt) • descrivere come varia nel riferimento dell’ultimo stadio del razzo, e nel riferimento del pianeta, lo spazio percorso dal razzo tra il distacco di uno stadio e l’altro. (6 pt) • supponiamo che ∆τ tenda a zero (diventando un dτ ), e che la velocità di distacco di ciascuno stadio sia uguale a adτ ; calcolare, al momento in cui l’orologio a luce dello stadio più avanzato del razzo batte il tempo τ, qual’è il tempo T segnato dall’orologio a terra (12 pt)? (suggerimento: si usi il concetto di rapidità) 3. Carlo e la sua ragazza Chiara abitano a L anni luce di distanza e condividono lo stesso sistema di riferimento S. Carlo e Chiara decidono di andare a cena insieme, incontrandosi al tempo t = T a cui apre un ristorante nel loro sistema di riferimento, e che si trova a L/2 da Carlo e da Chiara. Al tempo t = 0, partono da casa dirigendosi verso il ristorante. Quando in ristorante apre, Carlo e Chiara, che sono entrambi arrivati, confrontano i propri orologi, e l’orologio di Carlo è più avanti dell’orologio di Chiara. • che cosa si può dire sul moto di Carlo e Chiara tra le loro rispettive case e il ristorante? (5pt) • è possibile che il tempo segnato dall’orologio di Carlo segni un tempo trascorso durante il viaggio pari a T? (2pt) • qual’è il tempo massimo ed il tempo minimo che potrebbe segnare l’orologio di Carlo? (Non si fanno ipotesi sul tipo di mezzo di trasporto usato da Carlo e sulle eventuali tappe del suo viaggio) (5pt) • supponiamo che Chiara sia arrivata in anticipo al ristorante (muovendosi di moto rettilineo uniforme in modo da arrivare al ristorante prima di Carlo), per fare una sorpresa a Carlo, e che Carlo sia arrivato puntuale all’apertura del ristorante viaggiando di moto rettilineo uniforme. Se la differenza di tempo segnato dagli gli orologi di Carlo e Chiara è ∆, quanto tempo prima di Carlo è arrivata al ristorante? (6pt) Descrivere, in funzione dell’anticipo di Chiara, di T e di L, il valore del tempo segnato dal suo orologio. (6pt) 37 4. Un lanciatore di una squadra di baseball lancia orizzontalmente una palla contro un battitore che si muove di moto rettilineo uniforme con velocità v = c/2 verso il lanciatore. Nel sistema di riferimento del lanciatore, la palla ha velocità u = c/4. Nel sistema di riferimento in cui il battitore è fermo, il battitore colpisce la palla in modo da invertire il verso della sua velocità, lasciando inalterato il modulo. • Con quale velocità la palla torna indietro verso il lanciatore (nel sistema di riferimento in cui il lanciatore è fermo)? (4pt) • Sarebbe possibile che il lanciatore, invertendo il verso del moto della palla, raddoppiasse il modulo della sua velocità? Potrebbe triplicarlo? Percè? (5pt) • Supponendo che il battitore si trovi inizialmente a distanza L nel riferimento del lanciatore, nell’istante in cui il lanciatore lancia la palla, calcolare l’intervallo di tempo che passa tra il lancio della palla e l’arrivo della palla sul battitore, e tra la ribattuta della palla e l’arrivo della palla sul lanciatore i) nel sistema di riferimento del lanciatore (5pt) ii) nel sistema di riferimento del battitore (5pt) iii) nel sistema di riferimento della palla. (5pt) Recupero e valorizzazione delle eccellenze Recupero Per quanto riguarda il recupero, si prevede una prova orale, da valutare con l’aiuto della rubric 4. Le domande possono vertere sia sulle domande aperte già svolte, ma in modo lacunoso, durante il compito, sia sulle domande aperte presenti nel compito ma non svolte. Riguardo alla parte di problem-solving, si faranno domande sui problemi svolti durante le lezioni, apportandovi poche modifiche. Valorizzazione delle eccellenze I problemi per la valutazione sommativa sono quattro, divisi in vari punti, con diversi gradi di difficoltà. La valorizzazione delle eccellenze avviene durante il compito, in cui studenti che abbiano competenze di problem-solving, un interesse per l’argomento, e capacità di calcolo sopra la media possono ampiamente dimostrarle, anche risolvendo più problemi di quanti richiesti. 38 39 10 Esegue le consegne per a casa, si auto-valuta e pone domande se non riesce a capire, interviene in classe, segue i consigli dell’insegnante per migliorarsi Mette in atto strategie corrette di problem solving, dimostra intuizione e capacità di auto-valutare i propri passaggi. Esegue gli esercizi assegnati e segue i consigli dell’insegnante per migliorarsi, capisce gli errori ma non restituisce un particolare feedback 8 Mette in atto strategie corrette di problem solving, è in grado di verificare i propri passaggi. 7 Dimostra originalità nella presentazione dei contenuti, ma si è limitato allo studio concetti presentati a lezione. 7 Sviluppa in modo puntuale tutti i contenuti richiesti, ma in modo non organico e non particolarmente sintetico 8 Esegue gli esercizi assegnati, non è molto in grado di capire i propri errori, non è propositivo 6 La risposta non è organica e vi è una omissione di alcuni contenuti rilevanti, ma viene affrontato almeno un nodo concettuale richiesto 6 Presenta i concetti discussi a lezione in modo corretto, ma scolastico, senza originalità di ragionamento o di contenuti 6 Mette in atto strategie corrette di problem solving, non riesce a valutare bene i propri passaggi. Si auto-corregge se brevemente guidato dall’insegnante. 6 Non è in possesso di una strategia di problem solving. Non riesce ad auto-correggersi neanche se guidato dall’insegnante. Applica una strategia di problem solving in modo talvolta scorretto. È in grado di autocorreggersi se guidato in modo sostanziale. Si disinteressa degli esercizi e delle sollecitazioni dell’insegnante 4 4 Possiede una conoscenza scarsa dei concetti della materia, ha difficoltà a metterli in relazione. 4 5 Possiede una conoscenza schematica dei concetti della materia, ha difficoltà nel collegarli tra di loro. 5 La risposta è fortemente lacunosa, dimostra una mancata comprensione dei concetti, o discute concetti non rilevanti 4 Tabella 4: Rubric per la valutazione dei contributi scritti discorsivi, dei contributi orali discorsivi e di problem solving e dell’impegno in classe. I punteggi assegnati sono riportati sopra a ciascuna voca. Quando utilizzata per il recupero, una strategia di valutazione che si può utilizzare è quella di dare il peso di 1/10 a ciascuno dei quattro voti della rubric, sommandoli al voto del compito pesato con un peso di 6/10. (4) Impegno (3) Soluzione di problemi (2) Rielaborazione dei contenuti (1) Ricchezza e pertinenza dei contenuti 10 Sviluppa in modo organico e puntuale tutti i contenuti della UD richiesti dalla domanda, senza chiamare in causa temi non pertinenti 10 Ha rielaborato i contenuti presentati a lezione ed è in grado di presentarli in modo originale, dimostra di avere approfondito i concetti presentati. 9 Indice 1 Motivazioni 1 2 Contesto 2 3 Pre-requisiti 5 4 Obiettivi 6 5 Strategie didattiche 7 6 Strumenti 8 7 Suddivisione delle lezioni 8 8 Contenuti 8.1 Equazioni di Maxwell e trasformazioni di Galileo . . . . . 8.2 L’interferometro di Michelson e Morley . . . . . . . . . . . 8.3 I postulati della relatività speciale . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 L’ABC della relatività di Galileo . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4.1 Eventi e trasformazioni di Galileo . . . . . . . . . . 8.4.2 Cosa è un sistema di riferimento in relatività . . . . 8.4.3 Sistema di riferimento inerziale . . . . . . . . . . . . 8.4.4 Sistema di riferimento “proprio” e linea di universo 8.5 L’orologio a luce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5.1 Esercizio: viaggio verso una stella e ritorno . . . . . 8.6 Un sistema di riferimento speciale per due eventi . . . . . 8.7 Una quantità per misurare la distanza tra eventi . . . . . . 8.8 Tempo proprio come lunghezza di una linea di universo . 8.9 Conferme sperimentali della relatività speciale . . . . . . . 8.10 Spunti per motivare alle prossime unità didattiche . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 14 14 15 15 18 19 21 21 22 23 24 25 27 27 Strumenti per esperimenti mentali 9.1 Mappa dello spazio-tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Orologio a luce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Sincronizzatore di orologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4 Autovelox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 Bomba a orologeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.1 Esercizio: lancio di una bomba . . . . . . . . . . . . . 9.5.2 Esercizio: attentato suicida . . . . . . . . . . . . . . . 9.5.3 Esercizio: doppio attentato . . . . . . . . . . . . . . . 9.6 Radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6.1 Composizione delle velocità . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 Alcuni suggerimenti per affrontare un problema di relatività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28 28 28 28 29 29 30 30 31 33 35 . . . . . 35 35 35 36 36 38 10 Valutazione 10.1 Valutazione formativa . . . . . . . . . . . . 10.2 Verifica sommativa . . . . . . . . . . . . . . 10.2.1 Domande aperte . . . . . . . . . . . 10.2.2 Problemi . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 Recupero e valorizzazione delle eccellenze 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice analitico causalità, 1, 2, 23 distanza invariante, 7, 9, 22–24, 29, 33, 35 equazioni di Maxwell, 1, 3, 5, 6, 8, 12–14 esperienza di Michelson, 6, 8, 9, 13, 26 evento, 6, 7, 14–18, 20, 22–25, 27–29, 34, 35 linea di universo, 7, 9, 20, 23–25 problemi svolti, 20, 21, 24, 27–30, 32 sistema di riferimento, 1, 6, 7, 12–14, 16–22, 24, 25, 33, 35, 36 sistema di riferimento proprio, 18, 20, 25 tempo proprio, 1, 2, 7, 9, 23–29 41 Riferimenti bibliografici 1. P. Rossi. Fisica relativistica e analitica. 2006. 2. E. Fabri. Insegnare relatività nel xxi secolo. 3. J. A. Wheeler E. F. Taylor. Fisica dello Spazio-Tempo. Zanichelli, 1996. 4. G. Borghi. Appunti presi durante le lezioni di Laboratorio Didattico-Pedagogico di Fisica e Didattica della Fisica. Acronimi UD unità didattica UTP unità di tempo proprio SR sistema di riferimento SRI sistema di riferimento inerziale 42