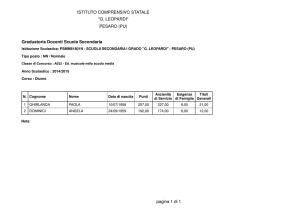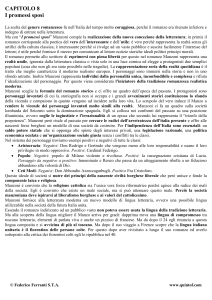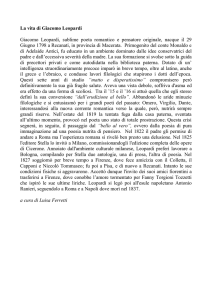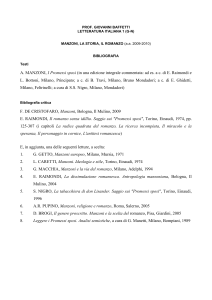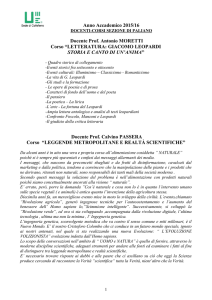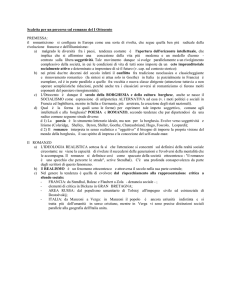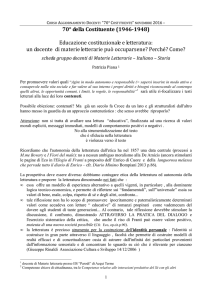caricato da
common.user1366
Letteratura italiana: Romanticismo ad oggi - Milano e Torino
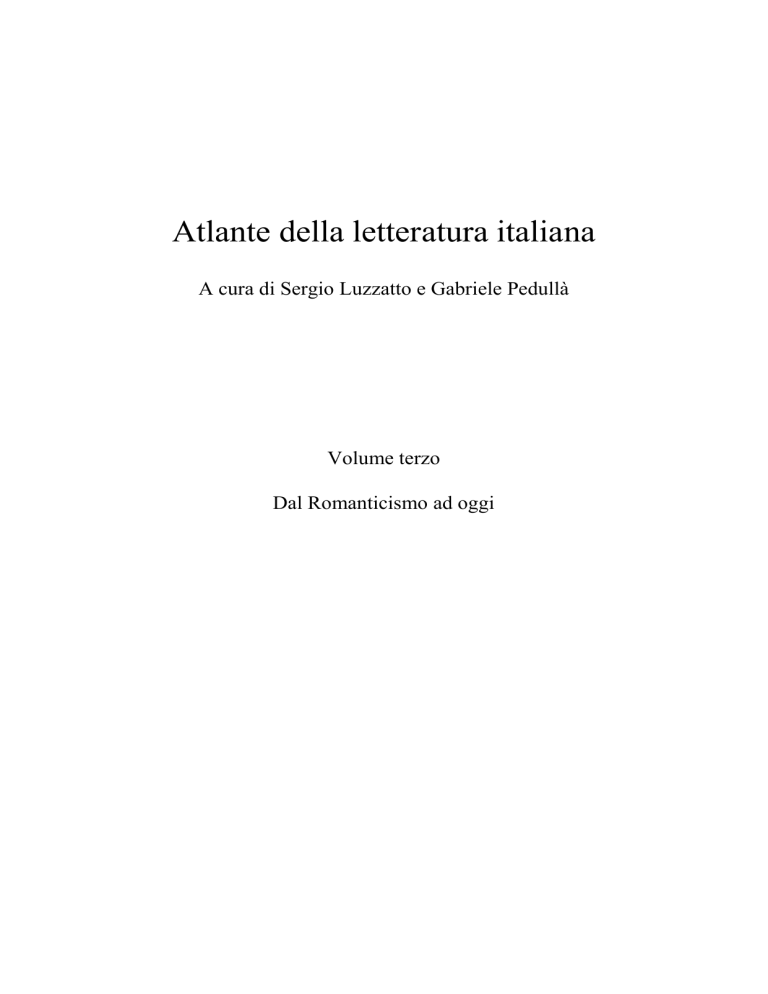
Atlante della letteratura italiana A cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà Volume terzo Dal Romanticismo ad oggi L’età di Torino 1813-1861 Durante l’età della Restaurazione, tutto quanto avviene di culturalmente significativo nella penisola italiana sembra succedere a Milano, o sembra comunque partire da lì. Dalla Milano in cui una donna straniera, Madame de Stael, innesca la miccia di un confronto esplosivo tra classici e romantici. Dalla Milano dove un patriota piemontese, Silvio Pellico, inaugura un’esperienza di prigioniero che finirà per costare all’Austria più di una battaglia perduta, ma anche per consegnare all’Italia un genere letterario poco invidiabile, le scritture dal carcere. Dalla Milano dove una contessina disinvolta, Clara Maffei, fa salotto con una libertà di movimento delle persone e delle idee che diventa volontà di cambiamento delle cose. È a Milano che il genere del romanzo storico partorisce, fra un’imitazione e l’altra di Walter Scott, I promessi sposi di Manzoni. È a Milano che il Teatro alla scala sperimenta forme inedite di consumo borghese di una vecchia passione della sociabilità nobiliare, il melodramma; nella geopolitica della cultura italiana, l’ex capitale del regno napoleonico sembra dunque rimanere tale anche dopo il congresso di Vienna, nonostante la Restaurazione assuma nel Lombardo-Veneto i tratti di un’occupazione militare. La Milano degli anni venti, e poi trenta e quaranta sembra un passaggio obbligato per scrittori, poeti, gazzettieri, librettisti, poligrafi. Nel Quarantotto invece, in seguito ai moti mazziniani, cominciò un’altra storia e Torino divenne capitale in pectore sia in termini politico-diplomatici, sia in termini culturali. Il mantenimento dello Statuto albertino fece del regno di Sardegna l’unico stato della penisola organizzato secondo principi liberali, seppure entro i limiti di un sistema elettorale censitario. Di lì a poco la comunità ebraica di Torino si sentirà a tal punto integrata al suo territorio da far progettare niente meno che la Mole antonelliana. La dinamica storica che rese gli anni cinquanta dell’Ottocento un decennio di preparazione all’Unità, e rese la Torino di Vittorio Emanuele II capitale virtuale di quell’Italia imminente, era stata inaugurata in anticipo sull’estemporaneo fiorire di una primavera dei popoli. SERGIO LUZZATTO Milano, gennaio 1816 Povera Italia Nel gennaio 1816 sulla “Biblioteca italiana”, giornale di letteratura, scienze e arte compilato da una società di letterati, esce l’articolo di Madame de Stael, celebrità conosciuta in tutta Europa, che innesca il dibattito tra classici e romantici. La portata dell’articolo, che s’intitolava Sulla maniera e la utilità delle traduzioni, è deducibile da alcune parole chiave delle sue argomentazioni: ripetizione si legga come sinonimo di imitazione, in evidente polemica con i cascami del classicismo; all’opposto la virtù originale della fantasia, mito fondante del romanticismo; il prezzo che si paga deprimendo la seconda a favore della prima è presto detto: povertà, sterilità, ovvero decadenza mentre le parole magiche per salvarsi sono poesia e nazione, divulgate attraverso la traduzione. Nello stesso anno Pietro Giordani replica in forma anonima con l’articolo Un italiano risponde al discorso della Stael. Prima dell’articolo dell’ articolo della “pitonessa”, così veniva definita Madame de Stael sulla rivista “Lo Spettatore”, si poteva leggere un Proemio non firmato, ma scritto da Giordani, che iniziava col classico luogo comune della funesta bulimia di periodici, nel 1816 gli associati alla “Biblioteca italiana” erano 1596, tra questi figurava il conte Monaldo Leopardi di Recanati e il libraio Antonio Fortunato Stella e il diciottenne figlio di Monaldo , Giacomo, destinato a diventare in seguito collaboratore di Stella, nonché a pubblicare presso di lui nel 1827 le Operette Morali. L’Iliade di Fiocchi, edita da Sonzogno, era uno dei 240 libri stampati nel corso del 1816 a Milano, indiscussa capitale editoriale d’Italia. In quell’anno la fiorente industria tipografica milanese proponeva le poesie dialettali di del giovane Tommaso Grossi e quelle seicentesche di Carlo Maria Maggi, oltre alle ristampe del Giorno e delle Odi di Parini. Questo il clima politico e culturale che vide il ritorno di Madame de Stael in Italia, a dieci anni di distanza dal suo primo viaggio nella penisola, avvenuto tra il 1804 e il 1805. Allora si era trattato di un vero e proprio Grand Tour, che le era valso la conoscenza dei maggiori intellettuali italiani, in particolare di Vincenzo Monti, nonché la nomina in pompa magna a pastorella dell’Arcadia, con il patrocinio di Alessandro Verri. Il secondo soggiorno della baronessa, avvenuto a cavallo tra il 1815 e il 1816, fu invece speso in prevalenza a Pisa, non prima però di aver fatto tappa a Milano, dove l’accolsero il generale H.J.J.Bellegarde, conosciuto a Vienna, e il governatore della città, il conte Franz Joseph Graf von Sarau, vale a dire i due principali promotori della Biblioteca Italiana. FRANCESCA SERRA La polemica classico-romantica in Italia Nel gennaio del 1816, il primo fascicolo della “Biblioteca italiana” accoglie in traduzione lo scritto De l’esprit des traductiond Madame de Stael. La scrittrice francese constata la chiusura che caratterizza il mondo letterario italiano, afflitto da un progressivo inaridirsi dell’ispirazione poetica e da un conseguente decadimento delle forme. Quelli che poco più tardi un Pietro Borsieri perplesso rimarcherà essere semplici suggerimenti vengono immediatamente percepiti – spesso equivocando, e a volte distorcendo a bella posta le parole di Madame de Stael- come un intollerabile attentato alla gloriosa tradizione letteraria italiana. La risposta dell’ambiente classicista è quindi immediata e piccatissima, condotta spesso sui temi del risentimento e dell’attacco personale nei confronti della “vecchia pitonessa”, rea di leso orgoglio nazionale. Giova ben poco a raffreddare gli animi la controreplica di M. de Stael in cui si specifica che l’esortazione era a conoscere le moderne letterature straniere, non a imitarle, e a svincolarsi dagli stereotipi della mitologia antica, non a rinnegare i classici. La polemica ormai si è accesa e divampa nella Milano della Restaurazione. Il primo a scendere in campo in difesa del fronte romantico è Ludovico di Breme, il cui entusiasmo per le idee di Madame de Stael viene rinsaldato da una conoscenza de visu avvenuta a Milano in occasione del secondo tour italico della baronessa. Con lo scritto Intorno all’ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani, da considerarsi il primo manifesto della nuova scuola romantica in Italia, Breme indirizza la denuncia dello stagnante panorama culturale italiano contemporaneo, chiuso in una cappa asfittica di minuzie erudite e priva di un qualunque “sincero fervore del bello”, verso un fecondo tentativo di convergenza fra il patrimonio ideologico-culturale settecentesco e sub alpino che gli è proprio, di sostanziale ispirazione illuministica e le sollecitazioni di marca idealistica provenienti dalla moderna cultura europea. Il nucleo sintetico che se ne ricava è un’esaltazione della coscienza individuale come presupposto di ogni libera e spontanea attività ricreativa. Una pubblica presa di posizione altrettanto radicale è quella di Borsieri. Nelle Avventure, concettualmente uno dei più significativi e originali manifesti del romanticismo italiano, oltre che una narrazione briosa e godibilissima, si rintracciano molti dei leitmotiv che saranno più spesso riutilizzati nel corso del confronto polemico. A chiudere la serie di interventi direttamente rivolti all’articolo staeliano, la celebre Lettera semiseria di Giovanni Berchet. Alla sua uscita, sul finire del 1816, il pamphlet non suscita molto scalpore, ma a lungo termine avrà una straordinaria risonanza. Punti focali del codice romantico di Berchet sono: l’individuazione del quid espressivo della vera poesia in una permanente esigenza di contemporaneità, che comporta la scelta di temi attuali, attinenti alla storia in fieri, e per converso l’abbandono del repertorio mitologico grecoromano. L’articolo di Madame de Stael non resta un casus belli isolato. Infatti se il 1816 segna anagraficamente la nascita della polemica romantica, il 1818 rappresenta la punta emergente della contestazione. La reviscenza della polemica parte dalla stroncatura di Giuseppe Acerbi sulla “Biblioteca italiana”, alla quale Breme risponde dalle colonne dello “Spettatore” con le Osservazioni. Le Osservazioni di Breme colpiscono anche l’attenzione di un giovanissimo Leopardi, il quale, nello Zibaldone, vi ravvisa una serie di ragionamenti che “può imbrogliare o inquietare”. Tipico del complesso gioco di azione e reazione innescato dai vari interventi è il concrescere di nuovi episodi polemici su nuclei tematici precedenti. Dimostrare l’inconsistente alterità dei canoni della nuova poetica rispetto alle linee di sviluppo della tradizione italiana, con dilatazione del romanticismo sino a farne una categoria extrastorica, diventa quindi la via più battuta dai mediatori, classicisti e romantici. Come si è visto il veicolo privilegiato della discussione è costituito dalle riviste e dai giornali, soprattutto perché la loro cadenza serrata e regolare, assecondando il rapido contrappuntarsi degli interventi polemici, impedisce che le questioni poste sul tavolo del dibattito si raffreddino. Riviste, dunque, e per l’esattezza riviste milanesi. Se è vero che il romanticismo italiano si presenta come “fenomeno tipicamente piemontese e lombardo”, la querelle coinvolge soprattutto piemontesi trapiantati a Milano, milanesi e lombardi che ruotano attorno al capoluogo. MARCELLO RAVESI Milano, 13 ottobre 1820 Scritture dal carcere Se Le mie prigioni è un testo famoso per il suo rifiuto della politica in favore della storia un po’monotona di un’anima incarcerata, il retroterra è una tipica biografia romantica in cui gli interessi politici si fondono con quelli artistici e con quelli amorosi. E in quell’anno 1820, in realtà, la politica non era stato l’unico interesse dell’autore. Prima del suo arresto Silvio Pellico era vissuto in una Milano sthendaliana. Il 1820 era stato un anno cruciale e movimentato nella sua vita. Resta il fatto che pur deludendo molte aspettative, Le mie prigioni riscossero un successo immediato. Il testo fu messo all’Indice solo quando stampato insieme alle Addizioni (1833) di Maroncelli: uno scritto che aveva principalmente il torto di denunciare il ruolo di Stefano Paulovich, prete istriano che allo Spielberg si incaricava non soltanto della cura spirituale, quanto gli interrogatori mascherati da confessioni. Di fatto agli occhi dei posteri, ma anche dei contemporanei, è come se la fase rilevante della vita di Pellico si fosse chiusa con l’uscita dallo Spielberg e con la poco successiva pubblicazione delle Mie prigioni. Entrato in carcere a trentun anni e uscitone a quarantuno, Pellico avrebbe passato i successivi ventiquattro anni di vita in una posizione di osservatore partecipe ma serenamente distaccato. Fra le altre numerose testimonianze della carcerazione in quella fortezza asburgica possiamo ricordare le già citate Addizioni di Maroncelli, le Memorie di Confalonieri (scritte in realtà prima de Le mie prigioni), Spielberg e Gradisca del nobile milanese Giorgio Pallavicini, l’Autobiografia di Gabriele Rosa, un membro della Giovine Italia. Anche le memorie dal carcere di altri prigionieri politici italiani dell’Ottocento risentono spesso del modello Pellico, assurto a pietra di paragone. Per esempio due testimonianze di detenzioni papali lo riecheggiano fin dal titolo: La mia pazzia di Angelo Frignani e La mia prigionia di Giuseppe Galletti. Ben più famosi sono altri tesi dalla fisionomia più indipendente: il Manoscritto di un prigioniero di Carlo Bini, imprigionato a Forte della Stella sull’isola d’Elba e le Ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini. Se si passa a considerare la ricezione delle Mie prigioni da una prospettiva europea, e quindi meno legata alle vicende interne del nostro Risorgimento, ci si accorge che l’accoglienza del libro fu ancora più trionfale: le Mie prigioni fu il libro italiano di maggior successo dell’Ottocento, e tuttora il più tradotto dopo l’irraggiungibile Pinocchio. Nel folto di questa fioritura un po’disordinata di scritture diaristiche e testi di memoria, Le mie prigioni inaugurano un sottogruppo di ricordi e diari di prigionia che si presentavano in primo luogo come testimonianze personali, non come dialoghi filosofici o come testi che cercavano un effetto di realtà soltanto per preparare al meglio un’unica azione significativa che solitamente è la fuga. Il culto romantico per l’autobiografia e per i grandi scrittori fa nascere un’insoddisfazione verso i grandi del passato che non avevano saputo cogliere l’occasione di lasciare ai posteri i loro diari di reclusioni. PAOLO ZANOTTI I luoghi della cultura nella Milano della Restaurazione La vita culturale nella Milano della Restaurazione si gioca in uno spazio ristretto , racchiuso entro le cinta delle mura ma soprattutto concentrato nelle piazze e nelle strade attorno al duomo, nel reticolo disteso tra il Teatro la Scala e il Palazzo di Brera. È qui che dimorano, a distanza di poche decine di metri l’uno dall’altro, le figure più significative della stagione romantica, da Luigi Porro Lambertenghi a Federico Confalonieri, i cui palazzi sono uno di fianco all’altro, da Silvio Pellico a Giovanni Berchet, da Carlo Porta a Vincenzo Monti. Proprio nel cuore di questo spicchio di centro cittadino si colloca inoltre, in via del Morone, a due passi dal teatro La Scala e da quello dei Filodrammatici, la casa di Alessandro Manzoni: verso la quale quasi quotidianamente giunge Tommaso Grossi, autore del Marco Visconti e notaio di fiducia del bel mondo milanese. Lungo l’intero quindicennio che prelude al Quarantotto , quando non si spinge fino a casa Manzoni Grossi è solito fermarsi qualche portone prima, in piazza Belgioioso presso casa Maffei, dove la contessa Clara apre il suo salotto quasi ogni sera. Esiste quindi una rete di contatti e iniziative facente capo ad un’industria editoriale la cui vivacità rende Milano la capitale culturale europea dell’Italia della Restaurazione, meta di un pellegrinaggio che attira da ogni angolo della penisola schiere di giovani letterati in cerca di fortuna. Dopo il Quarantotto e fino all’Unità d’Italia, Milano- schiacciata dalla repressione del federrmaresciallo Radrtzky e a lungo sottoposta allo stato d’assedio dovrà cedere a Torino quel ruolo di capitale culturale della penisola che aveva tenuto ben saldo durante l’età della Restaurazione. Milano, agosto 1821 Vera la storia, vera l’invenzione Mentre Scott si affaccia ufficialmente in Italia, e Manzoni e i suoi amici riflettono sullo scrivere romanzi, i romanzi da leggere sono merce rara. L’interesse romantico per la storia e l’imitazione di Scott, cominciano anche a generare, assieme alle novelle in versi (fortunatissima, per esempio, l’Ildegonda di Tommaso Grossi, del 1820), narrazioni in prosa dove le vicende sono ambientate in un passato non più classico bensì medievale o moderno. Discorrendo qualche decennio più tardi, del romanzo storico, Cesare Cantù ne rintraccerà gli archetipi italiani, trascurando ogni forma di narrazione cronologicamente prossima, nel poema cavalleresco in ottave e in Boccaccio. Sempre nel 1821 viene varato a Milano, presso l’editore Giovanni Pirotta, un’altra collana, “la biblioteca amena e istruttiva per le donne gentili” il cui nucleo portante è costituito da romanzi stranieri che si vogliono capaci di soddisfare bisogni di intrattenimento e istruzione. Primo libro pubblicato, Le confessioni al sepolcro del prolifico scrittore August Lafontaine. Un titolo che con le sue suggestioni tenebrose, testimonia della fortuna in Germania di un gusto ben diffuso anche in Italia, attraverso il duplice canale delle traduzioni francesi e italiane: quello dei romanzi gotici, la cui principale autrice Ann Radcliff, fu ammirata da Scott, ebbe su Francesco Domenico Guerrazzi un’influenza riconosciuta dallo stesso autore e, agì forse sulla concezione del romanzo manzoniano. Manzoni sarà il primo scrittore italiano ad individuare due linee di riflessione: moralità di contenuti e modernità della lingua. Al Fermo e Lucia spetta una primogenitura, se non strettamente cronologica quanto ideale, poiché la scrittura del romanzo rientra per lui in un progetto culturale più vasto, ed è sempre sostenuta da una vigile consapevolezza dei doveri, degli strumenti, degli ostacoli che sono parte della creazione letteraria. Per Manzoni è chiaro, il romanzo si presenta come un problema da risolvere. C’è un modello, del quale appaiono evidenti l’interesse e i limiti; c’è un pubblico potenziale, c’è per contro una corrente di resistenza tenace, armata di morale; e c’è infine un problema linguistico. Nicolò Tommaseo disse che Manzoni si era abbassato a scrivere un romanzo, in realtà Manzoni aveva raccolto una sfida. La tendenza a leggere la produzione narrativa storica come fenomeno collettivo si giustifica prima di tutto per la diffusa omogeneità tematica, a partire dalla preferenza per i tempi di mezzo ai quali Giuseppe Mazzini esortava i romanzieri, in quanto “fecondi, sovratutti di gravi insegnamenti, di memorie sublimi, e di esempi”. Gli stessi titoli, con la loro frequenza del modulo nomecognome (Margherita Pusterla) costituiscono, nella loro uniformità, un marchio inusuale nella storia letteraria. MARIAROSA BRICCHI Walter Scott in Italia e il romanzo storico Tra i principali campi di battaglia su cui i romantici e classicisti si affrontarono negli anni venti dell’Ottocento vi fu una delle nuove forme letterarie perpetrate nell’Europa meridionale: il romanzo storico, un genere inventato nel 1814 con il Waverly dello scrittore Walter Scott (1771-1832), all’epoca già famoso come poeta. Il successo fu rapido e dirompente in tutta Europa. In Italia i romanzi storici erano arrivati anzitutto grazie alle versioni francesi e gran parte dei volumi furono tradotti da Gaetano Barbieri, professore di matematica, massone e liberale, che si prese il compito di accompagnarlo con delle note. Per esattezza ad introdurre Scott in Italia era stato Gioacchino Rossini: la sua Donna del lago venne infatti rappresentato al Teatro San Carlo di Napoli nel 1819. Si trattava di una scelta destinata a fare tendenza in tutta Europa: soprattutto ci consente di vedere subito uno dei punti di forza dell’opera di Scott; nella sua prosa dimessa rispetto alla solennità dell’endecasillabo e dell’alessandrino, Scott offriva degli intrecci perfetti per essere portati in scena. A parte i non rari adattamenti per il teatro di prosa, da quel momento – e per almeno un quarto di secolo- i melodrammi ispirati ai testi di Scott avrebbero rappresentato un fiorente filone dell’opera italiana. Il romanzo settecentesco aveva appreso molto dalle arti della scena, ma prima di allora nessun narratore si era spinto tanto avanti su questa strada. Anche in Italia i critici più avvertiti si accorsero subito di tali particolarità dell’opera di Scott. Così, in uno dei saggi più intelligenti sul tema, Carlo Varese, al tempo apprezzato autore di romanzi storici, arrivò a proporre proprio su questa base su una precisa parentela tra la narrativa di Scott e musica di Rossini. Anche l’altra grande qualità della prosa di Scott venne subito notata dai primi lettori. L’autore di Ivanohe era un vero maestro di quella che i francesi avrebbero chiamato la presentatiòn soprattutto a proposito del suo maggior discepolo, vale a dire Balzac. Oltre alle opere stampate e vendute conta soprattutto la penetrazione del modello e la corsa degli autori italiani a imitare lo scozzese, da subito gli spiriti più sensibili alla propaganda risorgimentale come Francesco Domenico Guerrazzi non si fecero sfuggire che il romanzo storico poteva servire a diffondere gli ideali patriottici attraverso la rievocazione delle sventure nazionali. Nel fiacco scetticismo italiano l’eccezione è rappresentata chiaramente da Manzoni. Un successo tanto travolgente non era però destinato a durare; l’andamento delle nuove edizioni e delle ristampe illustra bene il declino di Scott già nella seconda metà del XIX secolo, dopo un ventennio folgorante, tra il 1821 e il 1840, e un altro ventennio di alte tirature, in coincidenza con l’unificazione della penisola, assistiamo ad un crollo verticale. Nel XX secolo le cose sarebbero andate ancora peggio. I giudizi di sufficienza di Benedetto croce e di Mario Praz (quando non decisamente ostili, come nel caso di Emilio Cecchi) dimostrano quanto il clima fosse mutato. I nuovi esperimenti modernisti relegavano il romanzo storico tra i generi sorpassati, ma anche i pochi autori di prestigio che nella prima metà del Novecento vi si dedicarono, Riccardo Bacchelli e Anna Banti, non sembrava aver avuto molto presente la figura di Scott. Così, anche quando il romanzo storico si trovò ad avere un imprevisto sussulto di vita, tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Sessanta del XX secolo, il narratore inglese appare completamente fuori dall’orizzonte degli autori della nuova ondata. Né Il barone rampante di Italo Calvino, né Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, né il Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia gli devono nulla; per trovare un vero estimatore di Scott nel Novecento bisognerà rivolgersi al paradossale Giorgio Manganelli. ERMINIA IRACE e GABRIELE PEDULLÀ Milano, 13 agosto 1825 Sul buon uso del mito Fin dai primi mesi del 1825 Antonietta Costa, marchesa genovese e «tenera amica» di Vincenzo Monti, ha deciso che le nozze di suo figlio Bartolomeo vadano immortalate con un epitalamio del grande poeta. Poco importa che, a conti fatti, il celebre e famigerato Sermone sulla mitologia, abbia ben poco dell’epitalamio, se si esclude una coda che sa di posticcio, ma Antonietta Costa aveva ottenuto molto più di quanto fosse lecito aspettarsi, legando la memoria delle nozze di suo figlio a una poesia destinata a far divampare una delle più note questioni della storia letteraria italiana. Nella carriera di Vincenzo Monti il 1825 è un anno tutt’altro che infruttuoso e trascurabile. Prima del Sermone il poeta ormai settantunenne compone un idillio mitologico in versi sciolti che gli si apparenta strettamente: le nozze di Cadmo ed Ermione. Allo stesso anno risale anche la quarta stampa della sua traduzione dell’Iliade, l’ultima rivista dall’autore. Ma nel 1825 i giochi sembrano davvero fatti. Quando già si era arrivati all’insolenza di cui aveva dato prova appena due anni prima il giovane poeta e drammaturgo Alessandro Manzoni, nella sua famosa lettere Sul Romanticismo indirizzata al marchese Cesare Taparelli D’Azeglio, riuscirà difficile anche solo concepire una difesa delle vecchie storie mitologiche in poesia. Questa lettera sul Romanticismo rimase inedita ma circolò per tutta Milano per cui appare impossibile che Monti non conoscesse il fondo del ragionamento manzoniano. Almeno fin dal 1819 la meditazione di Leopardi ha individuato un nesso fondamentale, quello dell’infanzia e dell’immaginazione mitologica, entrambe capaci di offrire prospettive veramente inaudite. Firenze, 9 febbraio 1830 L’anomalia Leopardi Il 9 febbraio 1830, nella sede fiorentina dell’Accademia della Crusca, si diede lettura della relazione che attribuiva il premio quinquennale di mille scudi banditi dall’Accademia. Giacomo Leopardi che di quegli scudi avrebbe avuto un gran bisogno, partecipò con le Operette morali, che erano state pubblicate a Milano in coincidenza e per lo stesso editore, Anton Fortunato Stella, con I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Quasi all’unanimità gi accademici della Crusca assegnarono il premio a Carlo Botta, autore di una Storia d’Italia dal 1789 al 1814 che era stata pubblicata sei anni prima. Leopardi ricevette un solo voto, probabilmente quello dell’accademico Lorenzo Collini. Non molto diverse erano state le reazione al di fuori del contesto accademico soprattutto nell’ambiente romano. Improntato al quieto e sonnolento classicismo diffuso nell’intero Stato della Chiesa, tra le Marche, l’Emilia, la Romagna e appunto Roma. Fuori da quei confini ecclesiastici costituiva una vistosa eccezione l’amico piacentino del poeta, Pietro Giordani, che per primo seppe intuire la forza e l’eccezionalità della posizione di Leopardi nel panorama contemporaneo. Quanto all’ambiente milanese, verso il quale si era indirizzato ancora diciottenne il giovane Leopardi, la ricerca di contatti diretti si era presto interrotta. Gioberti pose la questione Leopardi in termini originali: anziché acuire il conflitto ideologico con condanne e censure, elaborò una strategia di assimilazione, individuando nel pensiero leopardiano una continuità, rispetto al pessimismo cristiano e giungendo alla conclusione che l’ateismo non poteva considerarsi una libera scelta del poeta, sottovalutando quindi la base filosofica del suo pensiero, ma piuttosto il frutto degli influssi esercitati dall’istigatore Pietro Giordani. In Europa, e specialmente in area francese, dove la circolazione dell’opera di Gioberti sarebbe stata assai significativa, questa interpretazione del poeta conobbe una diffusione cospicua, decisamente prevalente rispetto all’altra, ispirata da Pietro Giordani, rispettosa del materialismo leopardiano e con esso solidale. Dopo la morte del poeta, quando cominciarono a porsi le basi per l’edificazione del mito, a Parigi si concentrò una serie di tensioni filo e antileopardiane, quasi a riassumere i contrasti che si erano verificati in patria durante la vita. In Italia, invece, sull’operazione vigilava il devotissimo amico degli ultimi anni, Antonio Ranieri, il quale imponeva la propria supervisione per salvaguardare le ultime volontà dell’autore, di cui si dichiarava di diritto l’unico depositario. La censura non omise di intervenire persino dopo la morte sulla filosofia di Leopardi, colpendone il libro che meglio la dichiarava: nel 1850 al primo posto dell’Indice dei libri proibiti figuravano infatti le Operette Morali, accompagnati dalla formula rituale “donec corrigantur”. NOVELLA BELLUCCI I luoghi di Leopardi Nei suoi Ricordi poco più che ventenne Giacomo Leopardi annotava “mio desiderio di vedere il mondo”. Per oltre ventiquattro anni egli sarebbe in realtà rimasto relegato laddove era nato, nel 1789, a Recanati, piccola città delle Marche appartenente allo Stato della Chiesa. Successivamente nella seconda metà della vita, Leopardi si sarebbe spostato (ma con continui ritorni alla città natale): a Roma, e poi Bologna, Milano, Firenze, Pisa, Napoli, l’ultima delle sue città. La mappa delle pubblicazioni filologiche del giovanissimo studioso pone Milano in posizione centrale: tra il 1816 e il 1817 compaiono nel capoluogo lombardo ben undici saggi quasi tutti di traduzioni. Così, all’inizio della carriera leopardiana, le lettere da Recanati giungevano perlopiù a Milano e a Roma, alla volta degli editori e letterati da Giacomo ritenuti più importanti: Giuseppe Acerbi, direttore della Biblioteca Italiana, Vincenzo Monti, Angelo Mai, Pietro Giordani. A Roma, per anni luogo di un ideale ma mai realizzato trasferimento del giovinetto recanatese, anche in vista di una sua collocazione lavorativa nel mondo ecclesiastico, erano uscite alla fine del 1818 le prime due canzoni, le cosiddette patriottiche, ma nessun’altra opera leopardiana vi avrebbe in seguito visto la luce. A occupare una significativa centralità nell’atlante dei luoghi leopardiani è Bologna, la più dinamica e aperta città dello Stato della Chiesa, letterariamente legata alla temperie classicistico-erudita: dove si concentrano per Giacomo interessi editoriali, incontri letterari e amicali. Firenze entra più tardi nella geografia leopardiana ma con un impatto assai significativo, anche se le cifre evidenziano un numero minore di rimandi rispetto ad altre città. Firenze è la città della prima edizione dei Canti e già questo dato sarebbe sufficiente, ma Firenze a partire dal 1824 è anche la città della relazione con Giampietro Visseaux, animatore del celebre Gabinetto e direttore dell’”Antologia”, la più importante rivista letteraria dell’Italia restaurata. Eppure Giacomo non amò particolarmente nessuna di queste città, né Roma né Bologna né Firenze. Soltanto Pisa, fra quelle che abitò, gli fu particolarmente cara occupando un posto speciale nella sua geografia mentale. Gli indicatori dei luoghi leopardiani si diramano fra molte altre città italiane, piccole e grandi: si potranno citare almeno Torino, dove conduce l’amicizia con Vincenzo Gioberti, Piacenza, la città di Pietro Giordani, Macerata. Le lettere di Leopardi superano anche i confini nazionali e raggiungono, per esempio, Parigi, in lettere indirizzate all’amico Louis de Sinner a cui Leopardi aveva affidato tutti i propri manoscritti filologici. E a completare la mappa leopardiana, i due luoghi in essa fondamentali, quello della nascita e quello della morte: Recanati e Napoli. NOVELLA BELLUCCI I salotti del Risorgimento Erede della tradizione settecentesca di origine soprattutto francese, di corte o aristocratica, il salotto ottocentesco presenta- nella sua versione italiana- una natura più spiccatamente politica, una caratterizzazione borghese, ed è quasi sempre dominato o promosso da figure femminili. L’esperienza francese, che alla fine del Settecento si era imposta con un’accezione prevalentemente politica più che letteraria, valse da modello decisivo anche per l’Italia del nuovo secolo sia grazie ai suoi echi letterari (Madame de Stael e Stendhal) sia per contatti diretti (come quelli della principessa Beljoioso con Madame Recamier). E come è centrale nel salotto francese il ruolo della donna, così il salotto italiano riesce fondamentale per l’affermazione di un protagonismo femminile che altrove fatica a trovare spazio. Nelle principali città della penisola è la padrona di casadoviziosa, colta e con sensibilità patriottiche- ad aprire la sua dimora all’aristocrazia illuminata, ai ceti professionali inclini alle novità, agli intellettuali, agli scrittori. Il salotto del Risorgimento ha una frequente e spiccata funzione artistico-letteraria, che si alimenta dell’incontro dell’artista con la committenza o con i suoi più accesi sostenitori. Il salotto è infine luogo di approdo di scrittori e artisti stranieri in visita, come al principio del secolo Madame de Stael, Stendhal, Byron, più tardi Balzac, il pianista Liszt, la scrittrice Loiuse Colet. Entro un simile contesto, la padrona di casa poteva assolvere un ruolo da vera e propria agente letteraria: è il caso di Emilia Peruzzi nella Firenze del secondo Ottocento. SIMON LEVIS SULLAM Napoli, 1836 Alla ricerca della lingua moderna A Napoli Giacomo Leopardi arriva nel 1833 dove viveva il marchese Basilio Puoti e – per quanto Leopardi non abbia mai descritto alcun incontro col dotto grammatico purista- è rimasta memoria di di una visita alla scuola di Puoti grazie ad un allievo, l’allora diciannovenne Francesco de Sanctis. L’incontro Puoti- Leopardi ha un valore simbolico, non solo perché la pagina di De Sanctis traccia un filo, tra grammatica e poesia, lungo tre generazioni, ma perché quel filo attraversa questioni cruciali per la storia della lingua e della letteratura italiana. Imitazione, tradizione, lingua della prosa e della lingua poesia, parole antiche e parole nuove: su questi temi si concentrano, con la ripetitività martellante di un’ossessione, le riflessioni dei letterati italiani lungo tutto l’Ottocento. La lingua poetica che Leopardi legge ed eredità è una lingua grammaticalizzata, ad alto tasso di codificazione. Da un punto di vista storico, risalgono infatti al Cinquecento il differenziarsi tra lingua della prosa e lingua della poesia, e la percezione della frattura. Il tema si riversa nelle prescrizioni dei grammatici che, da Pietro Bembo in avanti, distinguono modi e forme per la prosa e per la poesia; la separatezza teorizzata da secoli si riversa nell’educazione dei giovani, da un capo all’altro della penisola: Francesco Domenico Guerrazzi, formatosi ad una rigida scuola purista, rievoca in una lettera l’insegnamento del suo maestro per insistere sul divario tra parlato e scrittura. Insomma è riconosciuta a tutti i livelli della società colta che la poesia possiede un proprio repertorio lessicale, morfologico e grammaticale. Ben diversa la lirica leopardiana, che si caratterizza per una consapevolezza critica che può essere ben individuata come il filo per orientarsi nella lingua del poeta. Sul rapporto tra lingua della poesia e lingua e antichità della lingua Leopardi conduce infatti una riflessione serrata, secondo un percorso che assume la condivisa constatazione del divario tra poesia e prosa. I passaggi di questo percorso sono testimoniati dallo Zibaldone, in riflessioni che si infittiscono negli anni tra il 1821 e il 1823, quando il poeta ha già composto gran parte degli idilli. Dal punto di vista lessicale, Leopardi attua una distinzione tra arcaismi e parole antiche; la distinzione riecheggia la tradizionale coppia di etichette attive nei vocabolari ottocenteschi che definiscono “voce arcaica” o “arcaismo” una parola fuori dall’uso, e classificano variamente “voce letteraria” o “non comune” ogni parola che, pur non ritenuta morta, si considera portatrice di una genealogia letteraria e appartenente ad un registro alto. Leopardi utilizza un criterio di selezione di natura squisitamente estetica: seleziona solo termini ed espressioni dotate della qualità che egli stesso identifica con la poesia: vaghezza ed eleganza. Ben altrimenti orientata era, negli stessi anni, la riflessione sul medesimo tema del Manzoni prosatore. L’autore manifestava a chiare lettere la sua avversione per le varietà diacroniche della lingua, quando la loro presenza non fosse giustificata da una precisa necessità comunicativa. Il lume deve guidare nell’assunzione o nel rigetto delle parole antiche non è dunque per Manzoni, la loro freschezza e bellezza, ma soltanto la possibilità che queste colmino nella lingua un vuoto, che rispondono ad un’esigenza di comunicazione altrimenti risolta. MARIAROSA BRICCHI La questione della lingua tra Settecento e Ottocento La concezione alla base della Crusca introduce una prospettiva destinata ad incidere su ogni approccio futuro: la lingua è al tempo stesso un patrimonio e una meta; attorno al 1840, l’autore degli ormai Promessi Sposi avvia la quinta redazione del saggio Della lingua italiana. Il testo, progettato e mai concluso come la summa di riflessioni inesauste sulla questione della lingua, si apre negando l’esistenza dell’oggetto, “se ogni lingua è un mezzo d’intendersi, non ogni mezzo d’intendersi è una lingua”. Pubblicata e vivacemente discussa sarà però, trenyt’anni più tardi, la relazione Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla (1868). In quest’ultimo scritto sul tema linguistico Manzoni risponde a un quesito sociale e politico: quale debba essere la lingua degli italiani, nello scritto e nel parlato, per le necessità pratiche e culturali della vita associata. L’incombere di questa questione sulle vicende italiane coinvolgerà la storia culturale e sociale del paese non meno di quella letteraria. Nella prima metà del Settecento, nuovi eruditi, nutriti di sapienza filologica (Fontanini, Mafferi, Muratori) s’impegnarono allora in ricerche intese a sostituire un’ottica diacronica alla concezione metastorica della lingua ereditata dal classicismo cinquecentesco. Un altro aspetto di novità che si manifesta sin dal primo Settecento è l’intensificarsi del rapporto dell’italiano con le culture e le parlate straniere, soprattutto quella francese. Tra le sedi deputate alla riflessione linguistica restano comunque decisivi, di secolo in secolo, i vocabolari. La pubblicazione della nuova Crusca genera nuove reazioni, in primis sul versante vocabolaristico, con raccolte che, pur esprimendo formale ossequio, puntano di fatto l’attenzione su settori del lessico meno frequentati dagli accademici. Sull’incapacità che il lessico selezionato dalla Crusca manifesta per rispondere alle esigenze del presente discutono due testi che – per ragioni diverse- contano tra i più significativi del secolo: la ben nota Rinunzia al Vocabolario della Crusca (1764) goliardico pamphlet di Alessandro verri maturato nel clima del giovane illuminismo lombardo; e il Saggio sopra la lingua italiana (1785) del padovano Cesarotti, fondato su una concezione generale del linguaggio di matrice sensista. Rappresenta finalmente una novità nel panorama lessicografico (e, per mole e autorevolezza, una concreta alternativa alla Crusca) il Dizionario universale critico-enciclopedico di Francesco d’Alberti (1797-1805). Con d’Alberti si apre una stagione di inaudità fertilità lessicografica: lungo il corso dell’intero Ottocento non solo si moltiplicano i vocabolari, ma crescono gli interventi che ne individuano ruoli, finalità e impostazione. Nel Saggio sopra la lingua italiana Cesarotti aveva stabilito che il compito di un vocabolario è informare su e quando una voce fosse stata impiegata, senza giudizi sulla sua bellezza o opportunità. Naturalmente normativo appare l’atteggiamento dei puristi, realizzato nel dizionario dell’abate Antonio Cesari (1806-1811) che propone all’uso moderno il patrimonio trecentesco. Impiegando una metafora molto diffusa, nella sua Proposta di alcune aggiunte e correzioni al Vocabolario della Crusca, Vincenzo Monti aveva accusato Cesari di “voler sostituire il Vocabolario de’morti a quello de’vivi”. Mezzo secolo più tardi toccherà a Manzoni, nella Relazione sull’unità della lingua e sui mezzi per diffonderla, stabilendo che lo scopo di un vocabolario si biforca in due distinte direzioni: da una parte “somministrare il mezzo d’intendere gli scrittori di tutti i tempi2, dall’altra rappresentare “per quanto è possibile l’uso attuale di una lingua”. Il vocabolario che scaturirà dalle teorie manzoniane, il Giorgini- Broglio (18701897). È indirizzato alla gente , non agli studiosi, e raccoglie parole ed espressioni dell’uso fiorentino, accompagnate da esempi tratti non dal patrimonio letterario ma dalla parlata quotidiana. Nella concezione di Manzoni il vocabolario è infatti un mezzo per la diffusione della lingua. La distinzione introdotta da Manzoni tra dizionari storici e dizionari dell’uso si rivela produttiva e genera nel secondo Ottocento una frattura: sulla linea della raccolta del patrimonio storico stanno la Quinta impressione della Crusca , pubblicata tra il 1863 e il 1923, e il Tommaseo- Bellini, del 1861-79. Sul fronte dell’uso si contano fra gli altri il Novo dizionario di Policarpo Petrocchi, del 1887-91, e il Vocabolario della lingua parlata di Fanfani e Rigutini del 1875. MARIAROSA BRICCHI Milano, 1º marzo 1837 I diritti dell’autore: Manzoni e Balzac Il 1º marzo 1837 nel “salotto rosso” del primo piano dove Manzoni riceveva ogni sera, tra le otto e le undici, i suoi pochi amici, era atteso un visitatore di eccezione, quell’Honorè de Balzac che i giornalisti amavano definire “il più fecondo dei nostri romanzieri”. La fama che lo precedeva non era certo la più adatta a conciliargli le simpatie della piccola cerchia raccolta intorno all’autore dei Promessi sposi. L’autore francese era giunto a Milano perché era stato incaricato da un amico milanese residente a Parigi, Guidoboni Visconti, di risolvere per lui una complicata questione ereditaria. Balzac era allora in Italia l’autore francese più conosciuto, questo spiega i termini più che lusinghieri con cui i giornali italiani salutarono il suo arrivo. Quella famosa sera del primo marzo in cui Balzac fu ricevuto nel salotto manzoniano, vi fu condotto dall’amico Felice Carron de Saint-Thomas, più giovane di Balzac di undici anni e profondo ammiratore di questi. Conosciuta di seconda mano, da una versione francese inadeguata o dai riassunti dei recensori, la storia di Renzo e Lucia pareva a Balzac povera d’intreccio. Il pregiudizio di Balzac sui Promessi Sposi pesò certamente sul suo incontro con Manzoni , non meno delle riserve morali che Manzoni non poteva non nutrire nei confronti del collega parigino. Non furono le differenze di carattere o di educazione a frapporre tra i due romanzieri una barriera insormontabile, ma l’impossibilità in cui ognuno dei due venne a trovarsi di apprezzare il valore dell’opera dell’altro, per ragioni ideologiche e culturali. È stato giustamente notato che la battaglia combattuta da Balzac, per tutta la vita, a favore dei misconosciuti “diritti del genio” rappresenta il suo vero impegno politico, di gran lunga più incisivo delle sue professioni di fede legittimiste. Difficile pensare che le sue riflessioni su questo problema potessero apparire “insulse” a Manzoni, che contro le contraffazioni dei Promessi Sposi dovette lungamente difendersi. MARIOLINA BONGIOVANNI BERTINI La fortuna editoriale dei Promessi sposi “Di un libro eccellente non sono mai troppe le edizioni”, dichiarava nel 1827 il tipografo luganese Veladini, il primo a pubblicare i Promessi Sposi fuori d’Italia. Accanto a quella nazionale, il romanzo è infatti titolare di una diffusione europea non solo numericamente significativa, ma articolata su due fronti linguistici: da un lato le traduzioni, dall’altro le edizioni stampate in italiano all’estero. Troppe edizioni dunque, se non dal punto di vista degli editori, certamente da quello dell’autore, vittime per decenni di ristampe sfuggite al suo controllo, che lo danneggiarono sia sul versante economico, in termini di mancato guadagno, sia su quello intellettuale. La vicenda delle stampe non autorizzate dei Promessi Sposi è legata all’inadeguatezza normativa in tema di diritto d’autore e al sistema della circolazione commerciale delle merci. Il primo problema coinvolge in realtà tutta l’Europa. L’Inghilterra per esempio, dove esisteva una legge sul copyright fin dal 1709, fu inondata nel corso di tutto l’ottocento da ristampe illegali realizzate in Irlanda. Il governo austriaco , che pure introduce nel LombardoVeneto nuove norme circa la concessione della patente agli stampatori e regola la censura preventiva, non vara alcuna iniziativa in materia di protezione del diritto d’autore, ignorando i ripetuti appelli del mondo intellettuale. Proporzionali al gradimento, le edizioni dei Promessi Sposi raggiungono numeri ben più importanti, che ne fanno il libro italiano più stampato all’epoca. Il romanzo, edito a Milano presso Vincenzo Ferrario tra il 1825 e il 1827 e distribuito nel giugno 1827 (la famosa edizione definita “ventisettana”), esaurisce rapidamente la tiratura . le ristampe si concentrano nelle capitali culturali (Torino, Firenze, Napoli), con emergenze più limitate in provincia (Piacenza, Parma, Livorno, Pesaro, Macerata). Di scarso peso le edizioni romane, due sole tra il 1835 e il 1836, a conferma del carattere asfittico del commercio librario nella futura capitale, caratterizzato da un inasprimento della censura. Nel panorama europeo le sorti del romanzo sfuggono a ogni controllo d’autore. Il Belpaese Prima di giungere all’epoca di nascita del turismo e, dopo ancora, all’epoca del turismo di massa, bisogna precisare che l’età del Grand Tour era già finita nella prima metà dell’Ottocento, sotto i colpi delle guerre napoleoniche. È possibile individuare tre mutazioni del Grand Tour coincidenti con tre tradizioni nazionali. La prima mutazione è il viaggio dei romantici tedeschi, in cui l’Italia non è vista solo come completamento di un’educazione, ma anche come esperienza iniziatica del Sud e della classicità. La seconda mutazione è quella che ha portato sulla penisola i viaggiatori inglesi. In questo caso si passa dall’ineludibilità del Grand Tour a ciò che è stato chiamato “the lure of Italy”: il fascino esercitato dall’Italia, che portò molti scrittori inglesi a trasferirsi in Toscana, al punto che alcuni artisti anglosassoni dell’Ottocento proprio in Toscana sono nati come il pittore John Singer Sargent. Il lure of Italy non dipendeva tanto dall’Italia contemporanea quanto dall’Italia immutabile ( paesaggi) e dalle rovine delle città del passato. La terza mutazione del viaggio in Italia dopo i secoli del Grand Tour è quella di matrice americana. Si tratta della nuova tradizione meno distante dal Grand Tour classico. Considerata la lunghezza del viaggio necessaria per arrivare in Europa, gli americani erano costretti a visitarla tutta insieme, in una sequenza che quasi per forza di cose cominciava dall’Inghilterra, luogo dello sbarco, proseguiva in Francia e terminava in Italia. Il viaggio in Italia era spesso affrontato, proprio come il Grand Tour, da giovani a completamento dei loro studi. Giunsero ventenni in Italia Washington Irving, Emerson, Longfellow, Henry Adams. Per secoli, accanto al Grand Tour, l’altra motivazione tipica di trasferimento in Italia era stata quella lavorativa, che riguardava però soprattutto gli artisti plastici, ma l’immagine prevalente del nostro Paese rimane comunque quella di un paese attraente non tanto per le opportunità sociali e professionali quanto per il suo fascino spirituale e paesaggistico e, non da ultimo, climatico. Al di fuori delle aree canoniche- Roma, Venezia, Napoli e il suo golfo, la Toscana, la Liguria, la Sicilia- il resto dell’Italia continua ad essere visitato quasi per caso, o a seguito di passioni individuali. Aumenta, come prevedibile, il peso dei soggiorni di vacanza, soprattutto da parte degli intellettuali tedeschi: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Ernest Bloch, Siegfried Kracauer. Quanto ai ritrovi “ufficiali” risulta in calo nel Novecento il peso dei circoli diplomatici, e in ascesa, a Roma, il ruolo delle accademie nazionali. Sul piano generale, dobbiamo osservare come l’Italia, a differenza della Francia e degli Stati Uniti, non sia stata toccata in modo significativo dalle diaspore intellettuali del Novecento. PAOLO ZANOTTI Nel paese del melodramma La grande stagione del melodramma in musica ottocentesco, a partire da Rossini fino al verismo di fine secolo, si sviluppa col favore di una straordinaria crescita delle strutture teatrali lungo l’intera penisola italiana: una smania di costruir teatri che si diffonde a partire alla fine del Settecento (il San Carlo a Napoli, il Teatro Regio a Torino, la Scala a Milano, la Fenice a Venezia). Il ruolo culturale e civile giocato dall’opera nella società italiana del xix secolo difficilmente si può comprendere senza considerare questa minuziosa diffusione dei teatri. Il risultato di tale processo costruttivo fittamente diffuso sul territorio italiano fu censito sette anni dopo l’Unità, nel 1868, da una rilevazione che entro i confini del regno d’Italia contò 942 sale teatrali attive, distribuite in 650 comuni, due terzi dei quali sorte dopo il 1815. Le pubbliche autorità non pongono limitazioni al numero dei teatri, né esistono prescrizioni relative al genere delle rappresentazioni. Le vie dell’esilio Inaugurata dagli esuli delle repubbliche giacobine alla fine del Settecento, l’esperienza dell’esilio politico italiano nell’Ottocento trova le sue figure idealmente fondatrici in Filippo Buonarroti e Ugo Foscolo, e si moltiplica poi nei molti percorsi e destini – noti e meno noti, marginali o decisividell’emigrazione italiana nel Risorgimento. Foscolo aveva percorso il proprio destino di esule già al principio del secolo, nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis. Infine, nel 1815-16, da Milano attraverso la Svizzera raggiunse l’Inghilterra, sua nuova ed ultima patria durante gli undici anni successivi. Quanto a Buonarroti, rifugiatosi a Ginevra dal 1814 dopo la stagione rivoluzionaria e imperiale, vi entrò in diverse logge massoniche capeggiando l’antibonapartista Adelfia. Negli anni venti fu spesso la penisola iberica ad attrarre gli esuli: in principio, motore di questa attrazione fu il mito della costituzione liberale di Cadice del 1812, quindi divenne lo scontro tra forze liberali e i cosiddetti miguelisti, più tardi ancora la guerra civile del 1832-34. Ma a metà degli anni venti anche un altro campo di battaglia richiamò gli esuli italiani – specialmente dal loro esilio inglese – in difesa e per l’affermazione delle nazionalità oppresse: fu la Grecia, dove si recarono tra gli altri, da Londra, nel 1824 Luigi Porro. In una terza fase, cioè dopo l’inebriante quanto sfortunata “primavera dei popoli” del biennio 1848-49, dalla Sicilia costituzionale, dalla Repubblica democratica di Venezia, dalla Repubblica romana provennero – assumendo ruoli diversi nel cosiddetto decennio di preparazione dell’Unità italiana – figure di esuli quali Pasquale Calvi, già ministro degli Interni a Palermo e poi storici della rivoluzione del 1848 rifugiatosi a Malta; Daniele Manin, in fuga da Venezia via Corfù e Marsiglia verso Parigi, dove nel 1857, poco prima della morte, fondò la Società nazionale italiana; Felice Orsini, che visse nella cospirazione tra l’Italia, la Svizzera, la Francia e l’Inghilterra, recandosi infine a Parigi per compiere l’attentato contro Napoleone III che nel 1858 gli sarebbe costato il patibolo. In generale, gli italiani in esilio poterono avvantaggiarsi delle condizioni di maggiore libertà rispetto al clima oppressivo degli antichi stati peninsulari: ad esempio in un crocevia come quello elvetico, tappa frequentatissima e porto sicuro dell’emigrazione politica. Londra e Parigi rappresentarono le capitali dell’esilio italiano, benché non si possono trascurare né Bruxelles, né centrali periferiche come Lugano e Marsiglia. A Londra i comitati filoitaliani fiorirono soprattutto negli anni cinquanta, con la Society of the Friends of Italy e l’Italian Emancipation Fund Committee. A Bruxelles, tra la fine degli anni venti e gli anni trenta si trovavano Buonarroti, Gioacchino Prati, Luigi Angeloni, Camillo e Filippo Ugoni, Giovanni Arrivabene, i mazziniani Carlo Bianco e Giuseppe Vitalevi. Milano, agosto 1840 Fede, bellezza e stroncatura Nell’agosto 1840 la rivista milanese “Il Politecnico” inserì anonimo- com’era uso abbastanza comune per l’epoca- un saggio critico attorno a Fede e Bellezza, il romanzo di Niccoò Tommaseo pubblicato a Venezia nel precedente mese di maggio: romanzo che aveva ampiamente incuriosito il pubblico e di cui si conversava in vari salotti alla moda, soprattutto nel Lombardo- Veneto e in Toscana. Ma anche l’intervento di recensione passò tutt’altro che inosservato: un “vero libello famoso”, lo avrebbe definito Cesare Cantù, autore di romanzi popolari e opere di largo respiro nella compilazione storica. In quella tarda testimonianza Cantù non faceva mistero sul nome dell’impietoso recensore, che era il milanese Carlo Cattaneo. Uscito nell’anno in cui Manzoni andava approntando l’edizione definitiva dei Promessi Sposi, il nuovo romanzo di Tommaseo si discostava dal modulo largamente in auge del racconto storico, cui lo stesso scrittore dalmata si era pure dedicato con le sue prime prove narrative. Fede e bellezza presenta chiare affinità di interessi con l’opera del critico e scrittore francese, che consistono nella comune propensione allo scavo in una condizione umana ondeggiante sulle opposte rive della sensualità e del misticismo, alla quale ammicca il titolo stesso del libro. È la storia di una reciproca confessione di due peccatori: Giovanni, scrittore italiano riparato in Francia, e Maria, orfana di madre senese e di padre corso, anch’essa passata in terra francese , che attraverso il sacramento del matrimonio- e la tragica morte di lei che subito vi fa seguito- arrivano ad espiare una vita debordante di equivoci trascorsi amorosi. Al suo primo apparire, Fede e bellezza fece rumore e furore. Dai carteggi tommaseiani emerge la straordinaria popolarità di quel piccolo libro elegantemente stampato di 170 pagine di formato ridotto in 8º, posto in vendita al prezzo di 3 lire e mezza: ricercatissimo in molte città d’Italia , e anche in Francia, soprattutto in Corsica, dove l’autore aveva lasciato nei mesi precedenti tanti amici al corrente di quel nuovo lavoro. Scrittrici dell’Ottocento Questo studio è condotto su un corpus di 201 autrici, nate tra la seconda metà del settecento e il 1870 circa. Esse furono diversamente note tra i loro contemporanei e operarono a vario titolo nel mondo culturale italiano del XIX secolo, tra la rivoluzione napoletana del 1799 e l’inizio della prima guerra mondiale. Oggi si trovano nella quasi totalità escluse dal canone della letteratura nazionale, in parte per il loro valore non certo eccelso, in parte per la collocazione marginale rispetto ai circuiti della cultura ufficiale, e finalmente per una selezione critica in qualche caso ingenerosa. L’origine delle letterate e la distribuzione geografica delle pubblicazioni conferma il fruttuoso policentrismo del panorama culturale italiano. In molti casi le donne intraprendono l’attività letteraria per stabilire relazioni con la comunità intellettuale, gravitando attorno a riviste specialistiche e collaborando a progetti collettivi. Tra le città spiccano, per il numero di letterate attive, Milano (10% soprattutto a partire dalla seconda metà dell’Ottocento: la metropoli lombarda è nel XIX secolo il più importante centro editoriale in Italia), la Firenze granducale prima e italiana poi (7%), Bologna, importante sede universitaria (3%), Torino, in particolare quando è capitale del regno (6%). Al sud si distingue Napoli, capitale del regno borbonico (6%), seguita da Roma (5%) e Palermo (3%), dove opera un gruppo di letterate molto attive negli anni preunitari, animate da sentimenti patriottici e pioniere del genere romanzesco. Le scrittrici italiane provengono ancora, in maggioranza, dalla nobiltà o dall’alta borghesia, ma non mancano isolati casi di popolane autodidatte, come ad esempio la poetessa “pastorella” scoperta da Tommaseo, Beatrice Bugelli (180285), più nota come Beatrice del Pian degli Ontani. Il livello di istruzione è generalmente medio. La maggior parte delle scrittrici ha studiato a casa e con un precettore, che ha impartito loro un’educazione elementare e tradizionale incentrata sullo studio dei classici latini e italiani. All’istruzione si lega strettamente l’abilità traduttoria di molte autrici, normalmente privilegiata come esercizio di scrittura ( prescritto anche agli uomini: basti considerare i consigli di Pietro Giordani al suo Eugenio nella Istruzione ad un giovane italiano sull’arte dello scrivere, 1821) e , nel caso delle donne, raccomandata come argine alla propensione per “l’immaginazione”. Dalla traduzione dei classici, propedeutica all’apprendimento della scrittura in porosa, si passa alla traduzione dalle lingue europee contemporanee, il francese in particolare. L’acquisizione di una seconda lingua moderna è parte fondamentale del curriculum di una ragazza bennata, abilità indispensabile alla conversazione salottiera, ma anche raffinato strumento di mediazione culturale. A partire dalla fine dell’Ottocento si diffonde l’uso – mai attestato prima degli anni ottanta – di firmare le traduzioni con pseudonimi maschili: un fenomeno che si potrebbe attribuire alla minore familiarità delle donne colte con le lingue straniere, o alla maggiore considerazione riscossa dall’attività del traduttore, in ogni caso, uno stratagemma sessista. La rete di frequentazioni intellettuali di queste letterate è generalmente determinata dalla famiglia di origine e quindi dal matrimonio, che tali signorine (con molte eccezioni) iniziano a gestire con maggiore indipendenza rispetto alle loro madri e al quale (in rari casi) porranno fine con una separazione. La vita di queste donne si presenta molto diversa dalle loro colleghe settecentesche, più mondane e meno legate agli obblighi familiari. Molte delle letterate operanti negli anni tra il 1820 e il 1870 circa, per la maggior parte poetesse, vengono dipinte come perfette massaie e madri eroiche disposte al sacrificio della prole per la patria, fedeli al marito come alla causa nazionale. Il modello celebratissimo è quello di Adelaide Cairoli. Le letterate sono per la maggior parte ben inserite all’interno della comunità intellettuale contemporanea: ma il loro forte desiderio di partecipazione diventa a volte zelo, eccessivo presenzialismo. Il percorso generale della letteratura femminile italiana nel corso dell’Ottocento può essere descritto come il progressivo consolidarsi di una ispirazione unitaria e di uno specialismo romanzesco. Nel Settecento italiano non vi erano romanzi scritti da donne. È segnalato un unico caso, l’eccezione che conferma la regola, trattandosi della principessa Giuseppina di Lorena-Carignano educata secondo un modello francese. A partire dalla fine degli anni Settanta, e di più tra gli anno ottanta e novanta del XIX secolo, il romanzo femminile diventa invece un genere di larghissimo consumo. I volumi di Carolina Invernizio (1851-1916), di Tommasina Guidi (Cristina Guidicini Tabellini 1833/351903), della Marchesa Colombi vengono ristampati più volte con grande successo, raggiungendo un pubblico di affezionati lettori e soprattutto lettrici. Si crea in Italia una fascia di mercato editoriale espressamente indirizzato alle donne e di cui le donne sono anche produttrici. Nascono collane apposite, che fanno la fortuna degli editori abbastanza intraprendenti per lanciarle. Firenze (dove spicca l’editore Salani) e Milano (con Treves in particolare, ma anche con la Società Editrice La Milano, l’editore Galli e gli altri) sono le città che dimostrano di saper sfruttare al meglio il fenomeno: si stampa qui circa il 60% delle edizioni complessive. Napoli, 1844 La poesia delle lapidi È noto come la descrizione delle ultime tribolazioni e del decesso di Giacomo Leopardi a Napoli sia contenuta in Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, che Antonio Ranieri, un uomo da lui cos’ diverso nel carattere espansivo e nelle idee (di romantico idealista, di patriota liberale e framassone) da esserne l’antipode, pubblicò ben quarantatre anni dopo la morte del poeta, nel 188°. Libro infarcito di aneddoti e di una minutaglia biografica utile a suffragare l’immagine di Ranieri nei termini del disinteresse e della magnanimità, i Sette anni allegano tuttavia un documento, datato 1851, che riferisce alcuni fatti inoppugnabili tra quelli successivi alla morte del poeta; il referto, con l’autorevole firma di Michele Ruggiero, indugia sul trasferimento della cassa coi resti di Leopardi dagli ipogei al vestibolo della chiesa Di San Vitale a Fuorigrotta avvenuto nel 1844. È da credere che Ranieri fosse il committente della lapide, come del resto lascia intendere lo clausola. La lapide a firma di Pietro Giordani rimane comunque il sigillo di una lunga amicizia intellettuale che un tempo era stata fervida. Solo chi conoscesse nel profondo leopardi avrebbe potuto infatti cogliere e connettere in appena nove linee i tratti distintivi della sua costellazione vasta e ancora clandestina per quasi chiunque. Più anziano di lui di quasi venticinque anni, ex novizio benedettino, già ammiratore dei giacobini e di Napoleone, nemico dell’ancien regime, scrittore e poligrafo di fede classicistica, il piacentino Giordani aveva subito intravisto nell’ignoto giovinetto prima un genio mortificato della Restaurazione nella clausura feudale di Recanati. Osservandone la lingua e lo stile, si nota nell’epigrafia di Giordani una ricerca di trasparenza, dal lessico alla sintassi. Del resto, solo una grande limpidezza intellettuale, di cui è spia la grammatica delle epigrafe, avrebbe potuto permettere di fissare nel marmo il fatto che Giacomo Leopardi era stato, contemporaneamente, non solo un ammirato filologo e poeta, ma appunto un “altissimo” scrittore di filosofia: in pratica è ciò che attualmente si riassume, grazie alla formulazione icastica di Antonio Prete , nella categoria di pensiero poetante. Delle epigrafi in lingua italiana e del fatto che fossero venute di moda nel pieno Ottocento, diffidava per primo colui che avrebbe messo in mano i libri di Giordani e Giuseppe Chiarini, nientemeno Giosuè Carducci, il quale pubblicò sulla “Cronaca bizantina” del 18 ottobre 1881 una feroce stroncatura. Illustre ma nel complesso sparuta la pattuglia dei precursori (tra cui comunque Bembo, Varchi, Giovio, Vasari, Speroni, Bartoli, Tesauro). L’editoria ottocentesca Nel corso dell’Ottocento l’universo del libro fu segnato da una grande rivoluzione, che ebbe per protagonista una figura nuova: l’editore moderno, una professione distinta, per le sue caratteristiche d’iniziativa imprenditoriale e di progettualità culturale, dai tradizionali mestieri del tipografo e del libraio. In precedenza, cioè durante l’epoca del cosiddetto antico regime tipografico- che in Italia così come in Francia, in Germania e in Inghilterra, durò fino agli anni trenta-quaranta del XIX secolo-, la produzione editoriale era uscita soprattutto da botteghe artigiane, che lavoravano con torchi manuali pubblicando prevalentemente testi su committenza. D’altro canto se molti erano i centri editoriali diffusi nella penisola, fino al termine del XVIII secolo esisteva una capitale indiscussa: Venezia, che con la sua capacità produttiva dominava l’intero mercato italiano. La svolta maturò negli anni della dominazione napoleonica, allorchè si fecero strada le prime istanze di liberalizzazione del settore librario e della cultura in generale. La città lombarda diventò il principale punto di riferimento degli intellettuali e dei collaboratori editoriali, la fucina delle maggiori novità culturali, le sede dei più intraprendenti operatori del libro. A partire dagli anni quaranta l’editoria italiana conobbe una lunga stagione espansiva, che proseguì nei decenni successivi, estendendosi fino al Novecento. Tutto si accrebbe, soprattutto dopo il 1861: il numero delle stamperie, quello degli addetti del settore, delle opere pubblicate- libri ma anche testate periodiche; crebbero infine le tirature. Produrre per il mercato voleva dire perseguire tre finalità principali. In primo luogo bisognava ampliare il numero dei lettori, ampliamento da intendersi in senso geografico e in senso sociale, raggiungendo il pubblico formato dai ceti popolari in via di alfabetizzazione, dai fanciulli in età scolare, dalle donne: quest’ultime, fino ad allora lettrici prevalentemente di testi devoti, divennero le grandi acquirenti dei romanzi, il genere più diffuso della produzione narrativa ottocentesca. Secondariamente al fine di acquisire nuovi lettori era necessario abbattere i costi, ossia produrre libri di qualità a prezzi contenuti, in maniera concorrenziale rispetto agli altri editori, locali e nazionali: questo implicava modernizzare il processo produttivo adottando i nuovi torchi meccanici, inizialmente importati dall’estero. Tuttavia il limite maggiore di tale espansione commerciale e pedagogica fu rappresentato dai canali distributivi, che per l’intero Ottocento non funzionarono come si era sperato. Si tentarono svariate soluzioni per mettere nelle mani dei lettori- anche residenti in periferie remote- i libri e i periodici via via pubblicati,: una per tutte il coinvolgimento degli uffici postali, preso i quali ritirare i volumi da pagare in contrassegno, un sistema ideato da Pomba. I generi letterari più rappresentati nelle varie collane furono sicuramente il romanzo nei suoi vari generi, d’appendice, storico, d’avventura, fantastico, e le forme breve del racconto e della novella. ERMINIA IRACE Quarto, 5 maggio 1860 Nievo e gli amori garibaldini L’impresa dei Mille è diventata una favola. Troppo perfetta narrativamente, troppo necessaria politicamente perché potesse sfuggire a questo destino. Passata attraverso innumerevoli racconti, assurto a capitolo centrale dell’epopea risorgimentale, mondata di tutti i suoi non secondari risvolti di guerra civile, essa si è insieme rarefatta e appesantita. Giuseppe Cesare Abba visse allora, a ventun anni, l’estate più importante della sua vita. Così importante da restarne schiacciato: nel viaggio da Quarto al Volturno il suo rito di iniziazione all’età adulta coincise con la nascita della nazione. Avrebbe passato i cinquant’anni successivi a rielaborare la storia che in quei mesi aveva vissuto e subito fermato in poche, laconiche pagine di diario, via via integrandole, abbellendole, stilizzandole, consegnandole a una progressione di edizioni e variazioni successive, destinate a proseguire anche dopo la sua morte. Eppure c’era tra gli stessi volontari partiti da Quarto chi avrebbe potuto raccontare la storia dei Mille in un’altra maniera. E in parte lo fece, attraverso le lettere che sono documenti di intatta freschezza sia per le scelte linguistiche sia per ricchezza di sfumature, di sentimenti, di situazioni, di penetrazione politica e psicologica. Ippolito nievo era atteso alla prova della scrittura dai suoi stessi compagni di viaggio. Abba nelle sue Noterelle lo presenta già l’8 maggio a Talamone, come “il poeta gentile che canterà le nostre battaglie”. <nessuno invece aveva ancora potuto leggere il suo capolavoro , Le Confessioni di un italiano”, che sarebbe rimasto allo stato di manoscritto, fino al 1867, nove anni dopo che fu concluso e sei anni dopo la morte del suo autore, e poi a lungo negletto dai lettori e dalla critica. Il libro dispiacque a molti anche se fu il più bel romanzo del Risorgimento, ironico e autoironico nello sguardo, politicamente avanzato, laico nell’approccio alla vita, persino trasgressivo nella rappresentazione di genere, raccontava il farsi della coscienza nazionale attraverso la vita di Carlino Altoviti narrata dallo stesso protagonista immaginato alle soglie degli ottant’anni, Se a Ippolito Nievo è stato accostato Luigi Meneghello, per prossimità regionale, oltre che stilistica ed esistenziale, non è forse opportuno suggerire che il Risorgimento italiano, avrebbe potuto trovare in lui anche il proprio Fenoglio, il narratore di razza, capace di esplorare l’universo sentimentale che sta dentro e dietro le scelte politiche. Il filtro della scrittura epistolare, ma forse anche l’autoironia e lo stile, preservano Nievo dalla boria maschilista che pur connota l’autorappresentazione del volontario in terra di conquista, e che sarà destinato a scorrere e crescere, per vie interne, dal garibaldinismo al fascismo. Le lettere sono anche cronaca del governo provvisorio di Garibaldi in Sicilia, raccontato da chi vi ricopriva una posizione privilegiata: Nievo era stato incaricato di amministrare la cassa della spedizione, e a palermo aveva ricevuto il grado di capitano e la nomina a vice intendente generali delle forze armate in Sicilia. Nei confronti dei meridionali Nievo ha una penna più lieve di tanti suoi compagni di viaggio, i quali non esiteranno invece a manifestare il proprio disprezzo per quei semiselvaggi che avevano appena battezzato italiani e fratelli, ma su cui si specchiavano con evidente ribrezzo. Artista per vocazione, soldato per scelta e funzionario per spirito di servizio, durante il suo soggiorno a Palermo Nievo non dimentica di essere anche un intellettuale militante, interessato ai risvolti e agli esiti politici della spedizione. Il rapporto con i contadini è centrale per Nievo, sia come artista che come politico. Come letterato egli risente della cultura del suo tempo, ritiene che nella cultura popolare siano le radici, cioè il genio particolare della nazione e che il mondo rurale sia un serbatoio di valori autentici e di un’umanità non corrotta. Sul piano politico, invece, vede meglio e molto più lontano dei suoi coetanei. ALESSANDRO CASELLATO Marx in Italia Destini singolari quelli dei nomi e dell’opera di Marx ed Engels nell’Italia di Depretis e Nicotera, di Crispi e di Turati. Legati allo sviluppo della classe operaria e dell’industria, all’organizzazione e alla modernità, pareva che della loro diffusione dovevano incaricarsi proprio quelle figure che Marx ed Engels avevano in odio e combattevano politicamente: gli anarchici e la boheme di provincia. Le strade percorse dai nomi di Marx ed Engels per divenire marxismo, infatti, non passarono solo dalle grandi città operaie del Nord. L’Italia è un paese nel quale la cultura marxista si è sviluppata rigogliosamente e in profondità. Nel XX secolo, una personalità come quella di Antonio Gramsci non ha uguali nel panorama europeo, e lo stesso può dirsi di Antonio Labriola. Il socialismo marxista si era affermato, nell’ultimo quarto dell’Ottocento, come dottrina dominante nel movimento operaio, come “socialismo scientifico”. Il quando, dove e il come della penetrazione del marxismo in Italia sono largamente noti: si tratta degli anni intorno alla formazione del PSI, dell’età giolittiana e del primo dopoguerra. Ne sono soggetti attivi l’editoria socialista e la forza propagandistica dei partiti politici socialista prima e comunista poi; la loro vocazione è nazionale. Altrettanto nota è la fortuna di marx ed Engels e delle loro opere: discussi come importanti autori di economia e politica, ne sono sostenitori o avversari Antonio Labriola, Ettore Ciccotti e Achille Loria. I luoghi della diffusione del nome di Marx e del marxismo sono in parte coerenti con le dinamiche della politica: sono i centri dell’organizzazione operaia, Milano, Torino, Genova; sono le grandi città e le capitali, Firenze, Napoli, Roma. Ma la geografia della conoscenza di Marx negli anni settanta e ottanta ci conduce invece in un universo insospettabile di piccole città di provincia, nella quale formicola la democrazia sociale e sovversiva. FRANCO ANDREUCCI I luoghi della cultura nella Toscana di Cavour Lo spettacolo del futurismo È il 15 gennaio 1909, durante l’intervallo che segue il secondo atto di La donna è mobile, versione italiana di Poupees èlectriques: un testo che aveva indotto il critico teatrale de Il Lavoro al commento “non tutti i matti sono in manicomio”. L’autore, Filippo Tommaso Marinetti, sale sul palco, affronta imperterrito il pubblico rumoreggiante e lo ringrazia per questa fischiata che mi onora profondamente “, provocando così un subisso di urla. Ma la scandalosa serata di cui stiamo parlando non ebbe luogo a Parigi e neppure a Milano, le due città dove, secondo la leggenda, il Futurismo è stato fondato, bensì al teatro Alfieri di Torino. In verità il Futurismo fu sin dall’inizio un espressione di una rete nazionale, i suoi personaggi erano insediati e lavoravano in ogni parte del paese. I futuristi facevano grande affidamento sulle esibizioni dal vivo. Oltre alla pubblicazione di manifesti e alle mostre d’arte, organizzavano concerti, conferenze, simposi, manifestazioni di protesta, spettacoli teatrali, ma soprattutto quel genere di evento che riuniva tutte queste forme di performance, la leggendaria serata. In Italia tra il 1909 e il 1915 i futuristi organizzò almeno 115 eventi ma meno di 20 mostre d’arte. Anche nel suo primo anno di vita dunque, quando l’esistenza del futurismo era legata quasi esclusivamente alle sue espressioni cartacee, la detonazione del movimento non interessò soltanto Parigi o Milano ma coinvolse svariate città italiane. È da notare come Napoli mostri subito un grande interesse per le nuove imprese di Marinetti, con ampie cronache sullo spettacolo scandalo La donna è mobile, riproducendo il Manifesto su tre diversi quotidiani, quasi l’annuncio che la capitale partenopea sarebbe diventata presto, con Roma, un centro focale del futurismo. Oltre a Torino e Parigi, La Spezia e Trieste furono i luoghi deputati ad ospitare gli eventi futuristi della prima annata. Il 1913 portò con sé un’esplosione di eventi, dopo il vuoto totale dell’anno precedente , dovuto ai numerosi viaggi all’estero dei protagonisti del movimento. Le manifestazioni non ufficiali si moltiplicarono; a contribuire alla diffusione si aggiunse l’apertura di due gallerie permanenti da parte di Giuseppe Sprovieri: la prima a Roma nel dicembre 1913, la seconda a Napoli nel maggio 1914; una terza, progettata a Palermo, non fu mai inaugurata per via della guerra. Le performance dal vivo abbinate alle mostre, a Berlino, a Londra e a Parigi, sottolineano lo sforzo compiuto dal movimento per farsi conoscere nei luoghi dove poteva ottenere il massimo della pubblicità. Le esibizioni e mostre futuriste raggiunsero dunque quaranta città italiane e venti città straniere fin dai primi anni del movimento, mentre l’ampia diffusione delle pubblicazioni e l’attenzione della stampa fecero sì che il movimento lasciasse il segno anche in quei luoghi in cui i futuristi non erano nemmeno passati. PATRICIA GABORIK Ginevra, Marzo/Aprile 1909 Pascoli, Saussure e gli anagrammi Il 19 marzo 1909 Ferdinand de Saussure da Ginevra a Giovanni Pascoli per chiedergli un parere intorno ad alcune questioni di composizione poetica che lo assillava da tempo. Saussure era uno dei più grandi studiosi di linguistica della sua epoca. Dopo un brillantissimo periodo d’insegnamento a Parigi, da quasi un ventennio era attivo presso l’Università di Ginevra, nella Svizzera natale. Tra le incertezze più pressanti che in quegli anni angustiavano lo studioso svizzero figurano senz’altro quelle relative ai problemi di una sua vasta ricerca- lasciata inedita- sugli anagrammi. L’ipotesi sottesa all’intera ricerca di Saussure sugli anagrammi si può riassumere, schematizzando, nel modo seguente: che alla composizione poetica nelle antiche lingue indoeuropee presiedesse un principio di costruzione anagrammatica indipendente dalle altre ragioni di ordine metrico, ritmico e retorico. Il primo motore del testo poetico sarebbe dunque la ripetizione cifrata di un nome proprio o di una parola-tema non nominati direttamente nel testo medesimo , ma restituiti ora attraverso una permutazione perfettamente equivalente delle loro lettere consecutive (l’anagramma puro), ora attraverso la loro disseminazione nell’ambito di uno o più versi successivi (ipogramma). I quaderni lasciati da Saussure contengono prove di decifrazione anagrammatica e ancor più ipogrammatica applicate ad Omero e all’antica poesia latina. Saussure non tardò nell’individuare in Giovanni Pascoli, successore di Giosuè Carducci e poeta pluripremiato, un interlocutore eccezionalmente autorevole. Nelle sue raccolte di poesie più significative l’eccellenza della poesia pascoliana non può essere distinta dalla particolare ipersensibilità linguistica del poeta. Anche se soltanto attraverso la specola della poesia in latino, Saussure aveva dunque visto giusto. Pascoli è un grande poeta della lingua , che nei suoi versi viene mobilitata pressoché ad ogni livello. È dunque ad un poeta di tale natura che il 19 marzo 1909 Saussure invia la prima delle sue lettere, alla ricerca di una conferma in merito all’esistenza di un molto preciso principio di composizione anagrammatica sotteso alla versificazione poetica. Quelle lettere sono state ritrovate e pubblicate nel 1968, almeno fino ad oggi la risposta di Pascoli non è stata ritrovata, ma dalla successiva lettera di Saussure si evince con certezza che non doveva contenere indicazioni incoraggianti per lo studioso ginevrino. Da Pascoli era arrivata dunque una sconfessione dell’ipotesi saussuriana relativa alla non intenzionalità soggettiva e (di conseguenza) agli automatismi imposti dalla rigida osservanza del metodo di composizione moderna. ROBERTO GALAVERNI Napoli, 20 maggio 1909 L’inafferrabile sentimento dell’umorismo Da quando il 20 maggio 1909 Benedetto Croce stroncò il saggio sull’umorismo di Pirandello, iniziò una disputa destinata a trascinarsi per ben trent’anni, con un episodio a decennio; le premesse furono poste proprio all’inizio del secolo. Nel 1902 proprio Benedetto Croce aveva pubblicato la sua Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, in cui l’uomo veniva ridotto ad un fatto empirico e psicologico, in sé privo di valore estetico, meritevole di una trattazione essenzialmente individuale: “Non c’è umorismo, ma c’è Sterne, Richer, Heine” avrebbe poi ribadito nel 1903, dedicando all’argomento una nuova, breve trattazione. Pirandello invece, sin dal titolo della sua prima raccolta di poesie, Mal giocondo (1889), aveva manifestato una consapevole propensione ai rovesciamenti, agli scontri tra parole di significato opposto, ai paradossi semantici e soprattutto logici, propensione di cui troviamo traccia anche in altri titoli. Del 1904 è anche il romanzo che gli diede la fama, Il fu Mattia Pascal e qui all’ossimoro celato dall’accostamento tra l’irrazionale del nome e il razionale del cognome si aggiunge un’altra chiave: il linguaggio burocratico e ufficiale dell’aggettivo “fu”, etichetta sociale che non aderisce alla verità dell’individuo. È proprio dalla preoccupazioni patrimoniali seguite alla perdita della miniera di famiglia che dobbiamo il saggio sull’Umorismo. Entrambi i libri nascevano in polemica con l’estetica crociana, soprattutto con la crociana espulsione della dimensione riflessiva dalla sfera estetica. È questa la dimensione in cui cercare i rapporti tra arte e scienza; è questa soprattutto la dimensione dell’umorismo: la realtà non è unitaria, quel che è si rispecchia, con le inevitabili deformazioni, , in quel che vi pare; l’io è scisso. Nell’Umorismo si dice che l’uomo “è fuori di chiave”, “è a un tempo violino e contrabbasso”, non può abbandonarsi a un sentimento senza avvertir subito qualcosa dentro che fa una smorfia e lo turba e lo sconcerta e lo indispettisce”. Condizione comica per chi l’avverte e, invece, umoristica per chi cerca di penetrarla: “avvertimento del contrario” e “sentimento del contrario” sono le due formule che Pirandello escogita per definire rispettivamente il comico e l’umoristico. La stroncatura crociana del 1908 era stata innanzitutto una dissuasione a Pirandello dell’inoltrarsi nei territori filosofici, Croce non contesta davvero, nel merito, la tesi di Pirandello, ma addita la sua irriducibilità nei termini di un sistema che è poi, ovviamente quello di Croce stesso. Oggi il saggio di Pirandello per Eco si può leggere in tre modi: come definizione, imprecisa e fallimentare, dell’umorismo; come enunciazione della poetica di Pirandello; come dramma grottesco di una definizione impossibile. In termini più sociologici che semiotici quella tra Eco e Pirandello è forse una tipica dialettica tra movimento e istituzione, in cui il concetto rinuncia allo statuto di stella polare., per diventare bussola, sistema di riferimento mobile. STEFANO BARTEZZAGHI Firenze, dicembre 1910 Croce e la morte del passato Il progetto editoriale di “Scrittori d’Italia”, la collezione di autori della letteratura italiana pubblicata da Laterza a partire dal 1910, ha una gestazione estiva. Nel 1909 Benedetto Croce è a Raino, ospite della cugina Teresa Petroni Rossi, in un palazzo al centro di un antico tratturo che dall’Abruzzo porta in Puglia. È agosto. Croce scrive a Giovanni Laterza e gli chiede di raggiungerlo in villeggiatura. Gli vuole parlare di un nuovo progetto. Una raccolta di scrittori, non solo i maggiori, 200 volumi, 350 pagine circa ognuno. Il 28 settembre sul “Giornale d’Italia”, pochi giorni il ritorno di Laterza a Bari, Croce annuncia il progetto dell’opera. La questione di un’edizione moderna dei classici italiani era molto dibattuta in quell’estate del 1909. La concorrenza editoriale su questo fronte era molto forte. Il 29 settembre Bellonci annuncia la collana “Scrittori nostri” per Carabba, l’editore abruzzese di Lanciano, un’analoga iniziativa Milano, giugno 1985 I blog di Pier Vittorio Tondelli Quando ancora non esistevano i blog, attraverso quali modalità di scrittura si esprimevano e dialogavano i giovani? Un tentativo di risposta potrebbe consentirci di ricostruire la trafila dei passaggi essenziali attraverso cui i modelli di scrittura giovanile sono andati via via acquistando un assetto preciso e inconfondibile, fino al punto di esprimere attraverso i blog la proprio forma di espressione privilegiata. Esistono tuttavia delle date che possiedono un rilievo particolare e non si può trascurare, per esempio, il giugno 1985 quando Pier Vittorio Tondelli dalle pagine di “linus” trasforma in un invito all’autonarrazione la proposta, formulatogli dalla rivista, di tracciare un presunto identikit delle giovani generazioni. L’intervento esce con il titolo emblematico Gli scarti e costituisce il primo abbozzo di quello che diverrà di lì a poco il progetto Under 25. Solo qualche mese dopo l’iniziativa riceverà la sua consacrazione ufficiale, in seguito alle numerose lettere di consenso arrivate alla rivista. Il progetto, definito da Tondelli, uno “strumento di lavoeo” si presenta all’insegna di un cantiere della scrittura giovanile. Perché Under 25? Per non creare la solita confusione tra giovani, esordienti, inediti e opere prime, solo un ferreo limite di età. Il progetto di Tondelli nasconde non poche insidie nei confronti dell’istituzione letteraria , i modelli dominanti della letteratura vanno sovvertiti radicalmente, quanto il diffuso conformismo rivoluzionario che, mentre aspirerebbe a scardinare l’ortodossia ufficiale, ne segna invece un preciso rovesciamento speculare. La nuova figura di scrittore auspicata da Tondelli è colui che legge, scruta i segni impressi nella propria comunità di appartenenza. Ogni scrittore deve, in prima istanza, essere sempre un lettore, un attento interprete del proprio influsso esistenziale, come, d’altro canto, ogni lettore è sempre, a tutti gli effetti, un potenziale scrittore. Tondelli propone inoltre una nozione decisamente singolare di testualità, che non coincide con il perimetro tradizionale del libro. I numerosi scrittori che rispondono all’appello lanciato sulle pagine di “linus2 costringono Tondelli ad una rigida quasi brutale selezione. Solo un ristretto ventaglio di racconti- precisamente trentanovetroverà posto nei tre volumi di cui si comporrà l’iniziativa, pubblicata con i seguenti titoli Giovani Blues, Belli & Perversi, Papergang. Gli Under 25 presenti nelle tre raccolte formano una compagine articolata. Si va da scrittori occasionali ad alcuni giovani narratori che riusciranno negli anni successivi ad imporsi con evidenza, Andrea Canobbio, Gabriele Romagnoli, Silvia Ballestra, Giuseppe Culicchia e, probabilmente, Elena Ferrante. ARTURO MAZZARELLA Milano, autunno 1995 Bene, è finito un secolo Nell’autunno del 1995, l’editore Bompiani pubblica le Opere del celebre attore Carmelo Bene. Compaiono nella serie pregiata dei «Classici», un volume in 8º, quasi 1600 pagine in carta india, rilegatura in pelle con due nastrini segnalibro, elegante sopracopertina bianca con un piccolo ritratto in bianco e nero dell’autore. La veste editoriale riproduce a puntino quella della famosissima Pleiade francese: la grande collana stampata da Gallimard, il non plus ultra del genere. Da trentasei anni Carmelo Bene era considerato un enfant terrible della cultura, così come Dario Fo ne era lo scatenato giullare. Nell’ottobre del 1997, sarebbe giunta da Stoccolma la notizia del premio Nobel a Dario Fo e un’ira sorda avrebbe corso gli establishment letterario italiano. A partire dalla fine degli anni Sessante, Carmelo Bene aveva pubblicato e ripubblicato i suoi libri presso Lerici, Longanesi, Sugar, Einaudi, Feltrinelli. Era molto noto come attore di indiscutibile talento, solitario e geniale, ma non veniva considerato un vero scrittore. Gli spettacoli teatrali e cinematografici di Carmelo Bene erano stati tutti o quasi, successi di scandalo, una tra le varianti dei teatrali trionfi. I suoi punti di riferimento erano shopenauer e Max Stirner, si annoiava con Brecht, amava Celìne. Si divertiva con Gozzano, Carlo Dossi, Gadda e Antonio Pizzuto, ma soprattutto con D’Annunzio. Vent’anni dopo i ribelli del teatro, artisti e intellettuali, lo veneravano. Goffredo Fofi e Piergiorgio Giacchè si adoperavano con le riviste “Linea d’ombra” e “Lo straniero” a liberare il fenomeno Bene dalla banalizzazione, dall’aneddotica bizzarra dalle premeditate esagerazioni. C’erano critici patentati che continuavano a sbeffeggiarlo trattandolo alla stregua di un Pinocchio o Lucignolo dell’arte, genialoide e cialtrone. In Francia si era invece da tempo conquistato il ruolo d’una “scoperta” per numerosi esponenti dell’elite intellettuale, da Gilles Deleuze a Michel Foucault, da Jaques Derrida a Pierre Klossowsky. Veniva spesso paragonato ad Artuad. Un abbaglio non privo di giustificazioni, perché Carmelo Bene era giusto il rovescio di Antonin Artuad. FERDINANDO TAVIANI