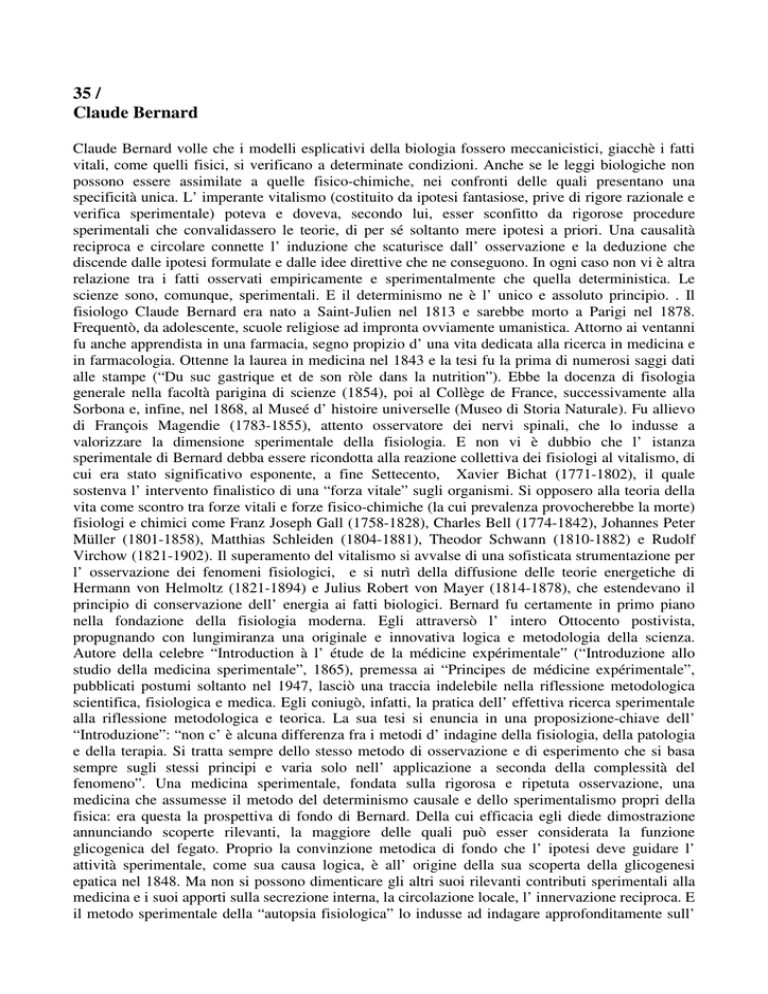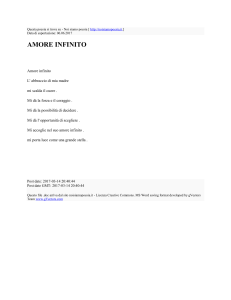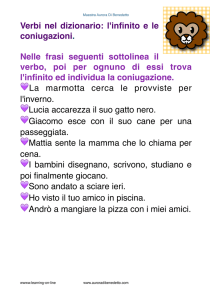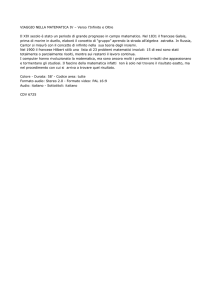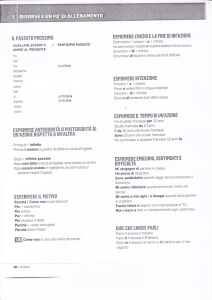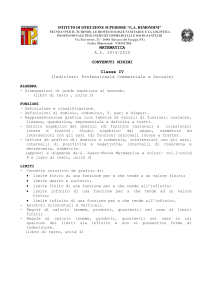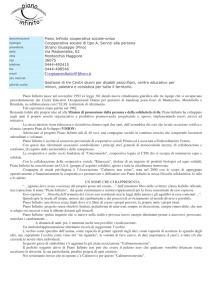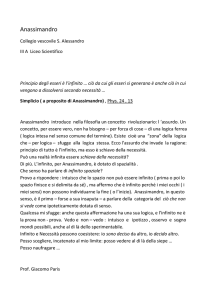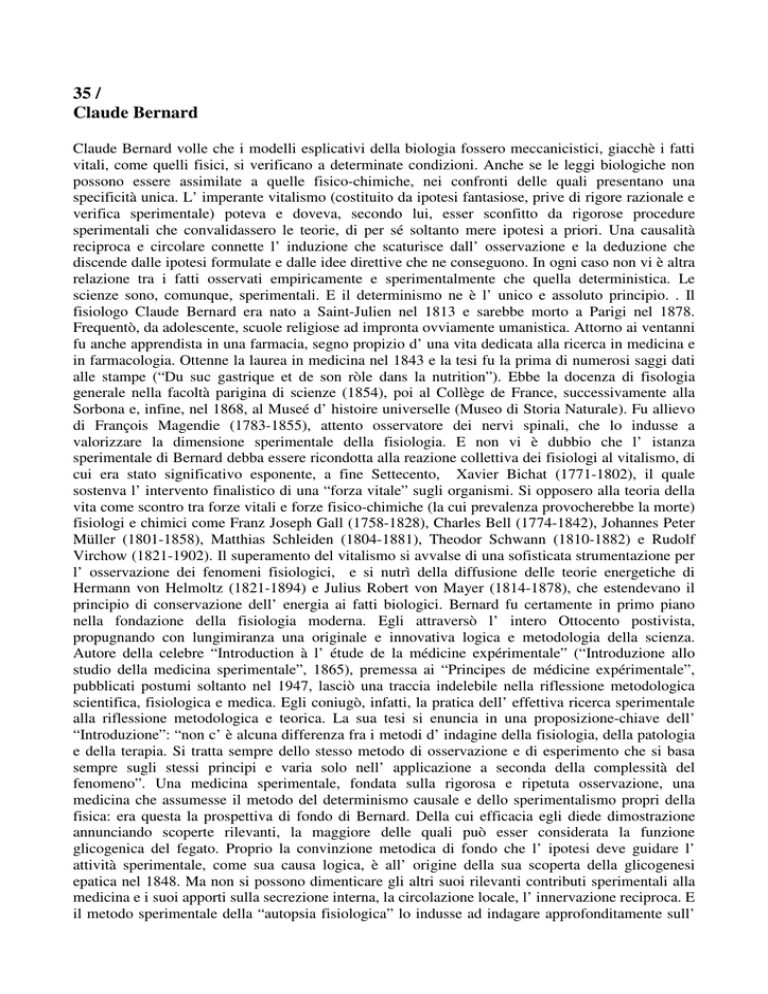
35 /
Claude Bernard
Claude Bernard volle che i modelli esplicativi della biologia fossero meccanicistici, giacchè i fatti
vitali, come quelli fisici, si verificano a determinate condizioni. Anche se le leggi biologiche non
possono essere assimilate a quelle fisico-chimiche, nei confronti delle quali presentano una
specificità unica. L’ imperante vitalismo (costituito da ipotesi fantasiose, prive di rigore razionale e
verifica sperimentale) poteva e doveva, secondo lui, esser sconfitto da rigorose procedure
sperimentali che convalidassero le teorie, di per sé soltanto mere ipotesi a priori. Una causalità
reciproca e circolare connette l’ induzione che scaturisce dall’ osservazione e la deduzione che
discende dalle ipotesi formulate e dalle idee direttive che ne conseguono. In ogni caso non vi è altra
relazione tra i fatti osservati empiricamente e sperimentalmente che quella deterministica. Le
scienze sono, comunque, sperimentali. E il determinismo ne è l’ unico e assoluto principio. . Il
fisiologo Claude Bernard era nato a Saint-Julien nel 1813 e sarebbe morto a Parigi nel 1878.
Frequentò, da adolescente, scuole religiose ad impronta ovviamente umanistica. Attorno ai ventanni
fu anche apprendista in una farmacia, segno propizio d’ una vita dedicata alla ricerca in medicina e
in farmacologia. Ottenne la laurea in medicina nel 1843 e la tesi fu la prima di numerosi saggi dati
alle stampe (“Du suc gastrique et de son ròle dans la nutrition”). Ebbe la docenza di fisologia
generale nella facoltà parigina di scienze (1854), poi al Collège de France, successivamente alla
Sorbona e, infine, nel 1868, al Museé d’ histoire universelle (Museo di Storia Naturale). Fu allievo
di François Magendie (1783-1855), attento osservatore dei nervi spinali, che lo indusse a
valorizzare la dimensione sperimentale della fisiologia. E non vi è dubbio che l’ istanza
sperimentale di Bernard debba essere ricondotta alla reazione collettiva dei fisiologi al vitalismo, di
cui era stato significativo esponente, a fine Settecento, Xavier Bichat (1771-1802), il quale
sostenva l’ intervento finalistico di una “forza vitale” sugli organismi. Si opposero alla teoria della
vita come scontro tra forze vitali e forze fisico-chimiche (la cui prevalenza provocherebbe la morte)
fisiologi e chimici come Franz Joseph Gall (1758-1828), Charles Bell (1774-1842), Johannes Peter
Müller (1801-1858), Matthias Schleiden (1804-1881), Theodor Schwann (1810-1882) e Rudolf
Virchow (1821-1902). Il superamento del vitalismo si avvalse di una sofisticata strumentazione per
l’ osservazione dei fenomeni fisiologici, e si nutrì della diffusione delle teorie energetiche di
Hermann von Helmoltz (1821-1894) e Julius Robert von Mayer (1814-1878), che estendevano il
principio di conservazione dell’ energia ai fatti biologici. Bernard fu certamente in primo piano
nella fondazione della fisiologia moderna. Egli attraversò l’ intero Ottocento postivista,
propugnando con lungimiranza una originale e innovativa logica e metodologia della scienza.
Autore della celebre “Introduction à l’ étude de la médicine expérimentale” (“Introduzione allo
studio della medicina sperimentale”, 1865), premessa ai “Principes de médicine expérimentale”,
pubblicati postumi soltanto nel 1947, lasciò una traccia indelebile nella riflessione metodologica
scientifica, fisiologica e medica. Egli coniugò, infatti, la pratica dell’ effettiva ricerca sperimentale
alla riflessione metodologica e teorica. La sua tesi si enuncia in una proposizione-chiave dell’
“Introduzione”: “non c’ è alcuna differenza fra i metodi d’ indagine della fisiologia, della patologia
e della terapia. Si tratta sempre dello stesso metodo di osservazione e di esperimento che si basa
sempre sugli stessi principi e varia solo nell’ applicazione a seconda della complessità del
fenomeno”. Una medicina sperimentale, fondata sulla rigorosa e ripetuta osservazione, una
medicina che assumesse il metodo del determinismo causale e dello sperimentalismo propri della
fisica: era questa la prospettiva di fondo di Bernard. Della cui efficacia egli diede dimostrazione
annunciando scoperte rilevanti, la maggiore delle quali può esser considerata la funzione
glicogenica del fegato. Proprio la convinzione metodica di fondo che l’ ipotesi deve guidare l’
attività sperimentale, come sua causa logica, è all’ origine della sua scoperta della glicogenesi
epatica nel 1848. Ma non si possono dimenticare gli altri suoi rilevanti contributi sperimentali alla
medicina e i suoi apporti sulla secrezione interna, la circolazione locale, l’ innervazione reciproca. E
il metodo sperimentale della “autopsia fisiologica” lo indusse ad indagare approfonditamente sull’
azione del curaro, sulla funzione del pancreas, sui nervi vasomotori, sul timpano, sull’ azione degli
anestetici. Precursore della biochimica contemporanea, richiamò comunque, autorevolmente, l’
attenzione sulle secrezioni interne e tracciò la via dell’ endocrinologia novecentesca. “La science
expérimentale” (1878) e le “Lecons sur le phénomènes de la vie communs aux animaux et aux
végétaux” (1878) sono certamente, al riguardo, delle pietre miliari. Quel che rende interessante ed
originale l’ epistemologia di Bernard è il fatto che egli volle evitare tanto l’ aprioristico e astratto
razionalismo cartesiano quanto il radicale empirismo che trovava molti fautori nella medicina del
suo secolo. Il metodo dell’ indagine in fisiologia deve procedere secondo inseparabili orientamenti.
Il primo è quello dell’ osservazione di nuovi fatti; il secondo è quello della formulazione di una
ipostesi (“idea a priori”) sulle loro cause; il terzo è costituito dall’ effettivo esperimento. “Ogni
uomo – enunciava – immagina sempre qualcosa quando osserva e cerca di interpretare i fenomeni
naturali prima ancora di conoscerli per mezzo dell’ esperimento. Questa tendenza è innata nell’
uomo; l’ idea preconcetta è stata e sarà sempre il primo impulso della mente che indaga. Il metodo
sperimentale invece tende a trasformare questa idea “a priori”, basata su una semplice intuizione o
su un concetto vago delle cose, in una interpretazione “a posteriori” fondata sulla conoscenza
sperimentale dei fenomeni”. La presunzione della veridicità delle “concezioni ideali” della propria
mente, spinge da sempre gli esseri umani a credere che esse corrispondano pienamente alla realtà e
siano fondate. L’ attitudine a sperimentare ed a verificare le proprie idee non è, dunque, spontanea
in loro. Essi l’ hanno appresa attraverso errori, tentativi, fallimenti, delusioni: “Il metodo
sperimentale è l’ imposizione di una disciplina alla fantasia: disciplina finalizzata all’ eliminazione
di quelle ipotesi (o mondi possibili) incapaci di descrivere, spiegare e prevedere qualche pezzo o
aspetto di mondo reale. Si è visto che la fantasia non bastava per capire il mondo e allora si è
cercato di disciplinarla. E la scienza e il suo progresso sono il frutto di questo disciplinamento”.
Anche gli scienziati, come i metafisici, partono da “idee a priori”. Ma, mentre i metafisici le
assumono come assolute aprioristicamente, e ne deducono logicamente numerose verità, gli
scienziati intendono le proprie ipotesi iniziali come “una interpretazione anticipata della natura …
più o meno probabile” le cui conseguenze logiche debbono essere poste continuamente a confronto
della realtà attraverso la sperimentazione. Osservazioni ed esperimenti di controllo, critica dei fatti e
dubbio perenne: tali erano gli indirizzi metodologici che Bernard voleva per la fisiologia e per la
patologia, poiché era certo che, tanto nell’ una quanto nell’ altra, “le idee assurde possono condurre
talvolta a fare scoperte utili”, ma anche che “le teorie più accreditate devono essere considerate
provvisorie e non verità assolute”. E lo stesso valga per la terapia: “Diagnosi, prognosi e terapia
sono ipotesi e vanno provate nelle loro conseguenze per accertarsi se corrispondano o no ai fatti”.
Bernard saldava, comunque, le due istanze dell’ osservazione e della sperimentazione, nella
consapevolezza che l’ una non implica l’ altra. “Una scienza di osservazione – scriveva – mira a
scoprire le leggi dei fenomeni naturali per poterli prevedere; essa però non può modificarli e
padroneggiarli a suo piacimento”. E, al riguardo, faceva l’ esempio dell’ astronomia, i cui fatti sono
prevedibili ma non modificabili. Al contrario, “Le scienze sperimentali mirano a scoprire le leggi
dei fenomeni naturali non soltanto per prevederli, ma per regolarli e padroneggiarli”. Così accade
per la fisica e la chimica. Bernard postulava, quindi, alla base della clinica, una medicina
sperimentale: “una medicina capace di penetrare nell’ interno dell’ organismo e trovare i mezzi per
modificare e regolare fino ad un certo punto i fenomeni nascosti della macchina vivente”. Desta
qualche perplessità Ernst Cassirer in “Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft
der neueren Zeit” (“Storia della filosofia moderna: Il problema della conoscenza nella filosofia e
nella scienza”, 1940) quando sostiene che “In Francia, nell’ ambito della fisiologia, colui che
rappresentò < l’ ideale cartesiano dello studio della natura > nel modo più rigoroso fu Claude
Bernard”. La fisica di Cartesio era senza dubbio apriostica e ben poco attenta alla convalida ed alla
corroborazione sperimentale, ma Cassirer ha, comunque, ragione nel ricordare quanto Bernard
asseriva nelle “Leçons sur les phénomènes de la vie” (1878): “la seule voie por arriver à la vérité
dans la science physiologique est la voie expérimentale” (“la sola via per conseguire la verità nella
fisiologia è quella sperimentale”). E Cassirer conferma che, anche per Wilhelm Roux, il fautore di
una “meccanica dell’ evoluzione” (“Die Entwicklungsmechanik, ein neuer Zweig der biologischen
Wissenchaft”, ovvero “La meccanica dell’ evoluzione, un nuovo ramo della scienza biologica”,
1905), “Il pensiero causale-analitico e l’ esperimento sono … in un certo qual modo solidali e non
possono essere separati l’ uno dall’ altro: il primo deve preparare la strada al secondo, e quest’
ultimo solo decide se questa è la strada giusta e se essa ha condotto alla mèta” precisa al riguardo
Cassirer e prosegue sottolinenando che Roux “asserisce che, con questa divisione delle parti tra il
pensiero e l’ esperienza, l’ importanza della descrizione per la conoscenza biologica non è messa in
dubbio in nessun caso e che i suoi diritti non devono essere menomati. Giacchè esiste, secondo lui,
anche un esperimento puramente descrittivo. Questo, che si potrebbe anche chiamare l’
“esperimento analitico formale”, agisce senza voler provocare una reazione sull’ oggetto e, se una
tale reazione ha egualmente luogo, senza volerla utilizzare”. In tal caso l’ esigenza era quella “di
presentare all’ osservazione con maggior esattezza il “fatto formale” e Cassirer riconduce a questa
categoria, ad esempio, le prime esperienze condotte da Pflüger e Roux sulle uova di rana: “lo scopo
di queste esperienze era di assodare se già la direzione della segmentazione dell’ uovo nei due primi
blastomeri avesse una determinata relazione con la direzione del piano di simmetria del futuro
animale. Risultò che in tre quarti dei casi le due direzioni coincidevano completamente o quasi.
Quest’ esperienza, puramente descrittiva in se stessa, divenne solo più tardi, per l’ eliminazione d’
un fattore causale, la forza di gravità. Pflüger era arrivato al risultato che la forza di gravità
determinasse, nell’ uovo, la regione destinata a diventare il midollo spinale, e addirittura che questa
determinazione fosse indipendente dalla specie di materiale, componente l’ uovo, che si trovava in
quella regione. Con un dispositivo sperimentale adatto, Roux poté eliminare l’ influenza della forza
di gravità, senza che fosse turbato lo sviluppo normale dell’ uovo; con ciò risultava che un effetto
ordinatore, direttivo della forza di gravità non era necessario alla determinazione del piano di
simmetria. Risultò l’ importante conseguenza che tutti i fattori che determinano la specie tipica
della formazione, sono contenuti nello stesso uovo fecondato, e che perciò lo sviluppo è da
considerarsi un’ autodifferenziazione. Gli organismi che si sviluppano sono sostanzialmente
“complessi chiusi di attività, che determinano e producono una data forma”; per la loro
realizzazione è necessario procurare dall’ esterno soltanto le energie ed il materiale nutritivo
necessari allo sviluppo”. E Cassirer sottolinea che l’ inferenza dell’ autodifferenziazione non portò
Roux al vitalismo: costui si attenne al suo meccanicismo. Il vitalismo era molto diffuso all’ inizio
dell’ Ottocento e contava su molti seguaci. Per quanto un Du Bois-Reymond deridesse il concetto di
“forza vitale” come un “factotum” che presumeva di risolvere tutti i problemi senza chiarirne
alcuno, il vitalismo cedette soltanto lentamente ai colpi della sperimentazione. In ogni caso, le
avvedute asserzioni di Bernard furono decisive per l’ avvento di una “medicina sperimentale” le
cui finalità siano quelle, come scriveva nell’ “Introduzione”, di “conoscere le leggi dell’ organismo
sano ed ammalato, non solo per prevedere i fenomeni, ma per potere, entro certi limiti, regolarli e
modificarli” e sosteneva che “la medicina tende fatalmente a diventare sperimentale ed ogni
medico, somministrando farmaci efficaci ai suoi ammalati, collabora all’ edificazione di questa
medicina sperimentale”. Ma sia ben chiaro che la condizione necessaria che permette all’ “attività
del medico sperimentale” di uscire dall’ empirismo e di fregiarsi del “nome di scienza”, consiste
nella “conoscenza delle leggi che governano i fenomeni biologici nell’ ambiente interno dell’
organismo sano ed ammalato”. Bernard intendeva dire che “La base scientifica della medicina
sperimentale è la fisiologia … perché senza fisiologia non esiste scienza medica … se si vuole
comprendere e spiegare il meccanismo delle malattie e l’ azione degli agenti terapeutici e tossici,
bisogna ricorrere sempre alla fisiologia”.
36 /
Salvatore Tommasi
Salvatore Tommasi, clinico e fisiologo, fu uno dei numerosi uomini di scienza che, nell’ Ottocento,
conferirono al Positivismo italiano un taglio fortemente “tecnico”, calandolo in una pratica
epistemologica che si muoveva nella concretezza della ricerca scientifica e delle scienze applicate.
Il positivismo costituì, per la Penisola, un forte richiamo all’ innovazione nell’ indagine scientifica
antropologica e sociale, un netto incitamento ad assumere un’ atteggiamento ed una prospettiva
nuovi nell’ esaminare problemi e questioni ben determinate e particolari. Se si esclude la
dimensione squisitamente sistematica, teoretica e speculativa del “realismo positivo” di Roberto
Ardigò, i positivisti italiani – come i loro predecessori, i “novatori” illuministi del Settecento –
operarono con forte spirito innovativo nelle varie branche della concreta indagine scientifica.
Trasposero, dunque, nell’ applicazione e nell’ innovazione metodologiche ed epistemologiche le
coordinate antimetafisiche e scientiste doltralpe, che Ardigò andava risistemando con originalità.
Eugenio Garin, nella sua “Storia della filosofia italiana” (1966) ha rifiutato recisamente il giudizio
tagliente che, della “fioritura positivistica che l’ Italia ebbe soprattutto per impulso dell’ Ardigò”,
diede Benedetto Croce, il quale la valutò come una “negazione della filosofia, o più veramente lo
sforzo di sostituire alla filosofia idealistica una filosofia naturalistica e agnostica, e al metodo
speculativo quello estraneo della fisica e delle scienze naturali”. Garin ha evitato di considerare il
positivismo italiano come una semplice reazione all’ idealismo, e vi ha intravvisto, tuttalpiù, il
rifiuto del più tardivo e debole spiritualismo di un Terenzio Mariani. “Il metodo positivo – scrive
Garin – fu erudizione nel campo delle scienze storiche, e soverchia erudizione talora, ma utile e
salutare esempio di ricerca severa, e preziosa disciplina d’ indagine; fu nel campo della filosofia
richiamo alla concretezza dell’ esperienza, al limite fisico che accompagna ogni atto spirituale; fu
esigenza di studi e di problemi umani, appello alla corposità del mondo degli uomini, ove l’ idea è
vuota parola se non s’ incarna nel veicolo terreno”. Il positivismo si innestò con l’ autorevolezza
della sua aderenza ai fatti e all’ osservazione, nella “tradizione culturale”. E Garin nota che proprio
nei “più seri fra i neokantiani ed hegeliani”, Bertrando Spaventa, ad esempio, si impose il “motivo
positivistico”. E, analogamente, è caratteristica “l’ evoluzione spirituale di Salvatore Tommasi …
che nelle “Istituzioni di fisiologia” … aveva cominciato col professare apertamente un finalismo
teistico, in cui l’ attività dello spirito, del tutto sganciata dal substrato corporeo, si presenta come
“causalità determinante e libera delle proprie azioni””. L’ abbandono della prospettiva spiritualistica
è decisamente e definitivamente palese ne “Le dottrine mediche e la clinica” (1865), laddove
rivendica “per le scienze “obbiettive e naturali” una piena indipendenza da qualunque speculazione
metafisica, da qualunque presupposto che non sia integralmente spiegabile con l’ esperienza”.
Salvatore Tommasi nacque a Roccaraso nel 1813 e morì a Napoli nel 1888. Fu docente di Medicina
pratica nell’ Università di Napoli ma la partecipazione ai moti liberali del 1848 lo privò dell’
insegnamento. Conobbe il carcere e poi l’ esilio dal Regno. Dopo che gli austriaci furono cacciati
dalla Lombardia, Tommasi ottenne la docenza di Patologia speciale e di Clinica medica a Pavia.
Avrebbe poi riavuto la cattedra napoletana di clinica medica. Nonostante le traversie personali
legate alle vicende della travagliata riunificazione italiana, egli fondò una autorevole scuola,
lasciando il suo insegnamento in una copiosa e qualificata letteratura, tra cui si possono ricordare le
“Istituzioni di fisiologia” del 1847-1848, “Il rinnovamento della medicina in Italia” del 1878 e le
“Lezioni di terapia generale e di clinica medica” del 1888. Avviando il suo primo anno accademico,
Tommasi – come evidenziava, appunto, Garin – intese preliminarmente liberare le “scienze
oggettive e naturali” da qualsiasi ipoteca metafisica e da preconcetti che discendano dalla fantasia o
dal sentimento. Rifiutò insomma postulati e principi aprioristici e volle esplicitamente riconoscersi
nella metodica di Galileo Galilei. “Il filosofo – sostenne – deve improntare dalla sola esperienza il
materiale e il contenuto dei suoi concetti universali”. Era l’ approdo ad un radicale positivismo.
Tommasi si muoveva sulla stessa traiettoria degli altri positivisti italiani che, nelle scienze dell’
educazione come nell’ antropologia, nella psicologia come nella storiografia, intendevano
comprendere l’ essere umano, nella sua vita sociale, morale, intellettuale, attraverso una eziologia
fisica, biologica, economico-sociale. In sostanza, i positivisti italiani concepivano
deterministicamente le scienze umane, al pari delle scienze della natura. Garen sottolinea l’
inequivocabile asserto metodico della concreta attività di ricerca di Tommasi: “la legge nelle
scienze della natura … è il generale che si è svolto nei particolari”. Ma se la medicina costringeva
Tommasi a concepire tutto come “materia attiva”, Garen mette in guardia dall’ intendere il suo
come un “materialismo” metafisico. Si tratta, piuttosto, di una “premessa metodica”, anche se è
vero comunque che, in generale, i positivisti italiani non rimasero insensibili al materialismo di
medici, fisiologi e biologi come Ludwig Büchner, Jacob Moleschott o Karl Vogt, che non è del
tutto alieno ad una concezione onnicomprensiva dell’ uomo e della natura. Al riguardo, comunque,
fa bene Garin a chiarire la questione, quando evoca le parole di Tommasi: “Noi non possiamo
sorpassare i confini dell’ esperienza. La metafisica, se crede, passerà oltre, e noi la rispetteremo, ma
a noi ci lasci fare … Si chiamino pure materiali i progressi promossi dalla scienza naturale; ma nella
loro materialità hanno tal potere che lo spirito del mondo ne è stato rinnovato in pochi lustri”. La
quale affermazione pare esser molto galileiana. Giacchè Galilei non era indifferente ai limiti della
scienza naturale che lui, in modo determinante, aveva contribuito a fondare. Era certo che essa
fornisse certezze ben fondate ma non presumeva fosse portatrice di verità assolute. La scienza
naturale muove da ipotesi matematiche e razionali e le condizioni della sua validità risiedono nella
conferma sperimentale di tali ipotesi, e perciò non ambisce ad enunciare verità assolute e
metafisiche. Per Tommasi, comunque, “materialismo” non era altro che “fedeltà all’ esperienza” e
alla sperimentazione, e riscoprì la prospettiva della tradizione rinascimentale del “naturalismo
moderno”. Era proprio questo il titolo del suo discorso accademico del 1865: “Il naturalismo
moderno”. Che, secondo Garin, costituisce “l’ inizio di una riscossa speculativa in quell’ università
napoletana che aveva già visto l’ hegelismo spaventiano imporsi e signoreggiare sulle spoglie del
giobertismo. Il quale naturalismo, se aveva larghe risonanze in quel campo metafisico che pur
dichiarava di voler rispettare, si annunziava innanzitutto come metodo scientifico …”. Alla
rivalutazione ed alla riscoperta del naturalismo rinascimentale avrebbe provveduto Roberto Ardigò.
Egli collocava la matrice del suo “realismo positivo” proprio nel naturalismo rinascimentale, nel
richiamo sensistico di Bernardino Telesio (che aveva inteso studiare la realtà fisica secondo i suoi
propri principi), nel metodo ipotetico-deduttivo-sperimentale di Galileo Galilei, nell’ attenzione all’
induzione di Giordano Bruno, nel primato – assegnato da Leonardo da Vinci – all’ armonia ed alla
misura delle sensate esperienze, nella psicologia e nell’ etica naturalistiche di Pietro Pomponazzi.
Lo ricordava Rodolfo Mondolfo nella “Conferenza letta per l’ 80° anniversario di Roberto Ardigò a
Mantova e a Padova” (1908), sottolineando che “Il positivismo dell’ Ardigò continua la tradizione
eminentemente naturalistica e positiva che è caratteristica del pensiero filosofico italiano; il quale
sempre, nei periodi del maggior fiore, e nei rappresentanti più illustri, è stato, si può dire, un
continuo richiamo all’ esperienza”. E Mondolfo prosegue con un esplicito richiamo al
Rinascimento, età in cui “l’ Italia diventa centro di irradiazione del rinnovamento della filosofia”. In
quest’ età “Pietro Pomponazzi (il cui nome ha speciale importanza qui, in quanto il discorso
intorno alla sua filosofia segnò la prima, per quanto non ancora completa, affermazione del
positivismo Ardighiano) col suo detto che il senso e l’ esperimento sono la bilancia della verità; e
Leonardo da Vinci, col dichiarare la esperienza madre comune di tutte le scienze e col rifiutare ogni
speculazione che non abbia l’ esperienza a sua conferma, segnano la via che viene poi, per quanto
con insufficiente rigore di procedimento, battuta anche da Bernardino Telesio, da Giordano Bruno e
da Tomaso Campanella”. Mondolfo non esita, però, a rimarcare che “Galileo Galilei, con la teorica
del metodo e con l’ applicazione datane nelle ricerche scientifiche, segna il più completo
svolgimento di questa tendenza al metodo positivo; e nell’ età moderna il Vico la riafferma e la
costituisce a principio fondamentale della sua filosofia: verum ipsum factum”. E infine “col
Romagnoli, col Gioia, col Cattaneo, col Ferrari, la tradizione continua e si rinnova”. Non vi è alcun
dubbio che Ardigò ritrovasse nel naturalismo rinascimentale il primato della ragione scientifica e la
sollecitazione ad esaltare l’ aderenza ai fatti naturali, un’ istanza precipua nel sensismo e nel
meccanicismo moderni. Ma sia ben chiaro che del sapere magico-ermetico e del panpsichismo
animistico e ilozoistico che permeano la filosofia cinquecentesca della natura, da Giordano Bruno a
Bernardino Telesio, non vi è alcun residuo nel realismo positivo di Ardigò. E il Bruno al quale lui
rinvia non è certo il protagonista, con Baruch Spinoza, della “renaissance” romantica e idealistica di
fine Settecento e primi dell’ Ottocento in Germania. Ma, ancor di più, si tenga conto del fatto che,
tra il naturalismo cinquecentesco e il positivismo di Ardigò, vi sono la scienza moderna, l’
empirismo anglosassone, la filosofia illuministica, l’ epistemologia ottocentesca. Del resto, come ha
ben sottolineato Giovanni Landucci (“Roberto Ardigò e la “seconda rivoluzione scientifica””),
“Ardigò quando parlava di scienza moderna non si riferiva genericamente alla rivoluzione
scientifica di Galileo e Descartes, ma si riferiva alla scienza del suo tempo < facendo > i nomi di
Laplace, Herschel, Lyell, Darwin … Mayerjoule, Hirn, Kirchof, Grove, Thomson, Daguin,
Berthelot, Clausins, Dumas, Tyndall, Würtz …”. Ardigò ha fortemente e ripetutamente insistito
sulla propria conoscenza degli scienziati e degli epistemologi contemporanei (da Ernst Mach ad
Herbert Spencer, soltanto per citare alcuni dei più autorevoli) con i quali ebbe un continuo e serrato
confronto, proficuo ed originale. Wilhelm Büttemeyer (“Roberto Ardigò – Pasquale Villari,
Carteggio 1868-1916”), ha rimarcato con forza che il positivismo di Ardigò non è una filosofia
della natura nell’ accezione tradizionale, e che la sua gnoseologia, strutturalmente e
costitutivamente psicologica, non scaturisce da una semplice evoluzione della cosmologia delle
prime opere, a partire da “La formazione naturale nel fatto del Sistema solare” (1877). Essa si
presenta, piuttosto, come un originale ripensamento dello psicologismo di Vincenzo Gioberti.
Ardigò legittimò, comunque, in sede teoretica, quell’ esigenza di un solido riferimento all’
esperienza ed al metodo sperimentale, che solo il naturalismo rinascimentale poteva fornire ad un
positivismo, come quello italiano, impegnato nella concreta ricerca sui vari versanti delle scienze
umane. La filosofia della natura del Cinquecento era un irrinunciabile rinvio per Salvatore Tommasi
e per tutti coloro che operavano, con una forte ansia di rinnovamento, nella ricerca e nella
sperimentazione, ed erano animati dalle consapevolezze che giungevano da quel sapere che
proveniva doltralpe e con il quale si andavano riconciliando. Il naturalismo rinascimentale aveva
preso parte in modo autorevole – soprattutto con Galileo Galilei – a quella Rivoluzione scientifica
moderna cui, nell’ Ottocento, era subentrata una seconda e ancor più dirompente Rivoluzione
scientifica. Il “naturalismo” che guidava le proficue indagini mediche di Tommasi e di numerosi
altri scienziati italiani in varii contesti, costituiva il segno di una riconciliazione con la cultura
continentale e di una vivacità intellettuale mai sopita.
37 /
Cesare Lombroso
Cesare Lombroso, nel prender le misure del cranio del brigante Villella (era il 1871) ritenne di poter
consolidare sperimentalmente, in via definitiva, le ipotesi che, negli anni precedenti, aveva
elaborato attorno alla genesi della “delinquenza”. Fu quello un anno cruciale per la sociologia o
psicologia o antropologia criminale da lui fondata. Essa si proponeva di indagare la relazione tra
anomalie psichiche e inclinazioni morali. Egli volle ricondurre ad una costituzione fisica anomala,
l’ origine comune della genialità, della delinquenza e della follia. Il Museo torinese di Lombroso
propone tuttora scheletri e crani di briganti che fecero la storia dello Stato italiano nei primi decenni
della sua esistenza, esposti accanto a calchi di volti di delinquenti, manufatti di folli e reclusi … La
pista seguita da Lombroso partiva da lontano. Egli era stato preceduto dalle indagini anatomopatologiche di Franz Joseph Gall (1758-1828), che lo stesso Auguste Comte avrebbe ripreso e
discusso. In sostanza, Lombroso era convinto che le deformazioni craniche dei briganti potessero
essere ricondotte ad una condizione evolutiva regressiva. Il rigido determinismo fisiologico che
dettava le sue dottrine escludeva, per l’ essere umano, una qualsiasi astratta libertà d’ arbitrio e d’
azione: la devianza andava collocata e motivata in un contesto materiale, fisiologico e somatico. Gli
stessi uomini di genio presentano frequentemente delle “tare” perché, come i folli, divergono dalla
norma. La genialità comporta la compromissione di alcune funzioni psichiche e produce anomalie
organiche. Lo sviluppo ipertrofico di alcune funzioni esige il sacrificio di altre. Lombroso
sosteneva che, se si considerano le dimensioni della scatola cranica dell’ “uomo normale”, in quella
del delinquente dev’ esservi un difetto (come, ad esempio, nel ladro) od un eccesso (come, ad
esempio, nel capo-banda). La media generale sarebbe garanzia di onestà e di probità morale. L’
eccesso o il difetto costituirebbero, al contrario, l’ indice di animalità-criminalità. La criminalità
era, in sostanza, secondo Lombroso, una stigmata naturale. Si nasce criminali e il delitto è un fatto
naturale che trascende la società umana e coinvolge l’ animalità. Il criminale è tale per natura e la
morfologia organica, interna od esterna, lo rivela: i codici interpretativi sono costituiti dai segni
somatici ma anche dalla produzione grafica-grafologica e dal linguaggio non verbale, dai gerghi e
dai tatuaggi. Nel delitto la responsabilità individuale non avrebbe alcun ruolo e non si dovrebbe
parlare di una volontà volta al male. E’ dalla degenerazione dell’ organizzazione psico-fisica che
scaturiscono le tendenze criminali. “I legislatori, i filosofi, uomini d’ animo integerrimo e nutriti
alle speculazioni più sublimi della mente umana, - scriveva Lombroso in “L’ uomo delinquente”
(1876) – partono a giudicare l’ animo altrui dal proprio; riluttanti al male quasi fin dalla nascita, tali
credono tutti gli altri, né vogliono, né potrebbero calare dalle regioni superbe della metafisica nell’
umile terreno delle case penali”. E ancora, sosteneva che “Il delitto … appare, così dalla statistica
come dall’ esame antropologico, un fenomeno naturale, un fenomeno, direbbero alcuni filosofi,
necessario, come la nascita, la morte, i concepimenti”. Inoltre “L’ atavismo ci aiuta, ancora, a
comprendere l’ inefficacia della pena; ed il fatto singolare del ritorno costante e periodico d’ un dato
numero di delitti”. L’ atavismo rivela nell’ essere umano, la persistenza di tendenze animali: l’
uomo selvaggio, l’ uomo primitivo … ricomparirebbero nel criminale. I criminali hanno volto più
largo del consueti, i loro zigomi sono accentuati, il prognatismo è notevole: si tratta della
ricomparsa dei tratti dell’ animale, nel cui muso vi è la riprova di un maggior sviluppo degli organi
sensoriali rispetto ai centri nervosi. L’ ipertrofismo del cranio del brigante Villella evocava quella
delle scimmie antropomorfe. La sopravvivenza di caratteri atavici e il comportamento deviante sono
correlati. Negli “Studi clinici ed antropometrici sulle microcefalie” Lombroso concluse,
impietosamente, che “i cretini formano un vero anello tra l’ animalità e l’ umanità”. Del resto, gli
scritti ove egli espose le sue teorie psichiatriche e crimonologiche ebbero vasta risonanza, da
“Genio e follia” (1864) ad “Azione degli astri e delle meteore sulla mente umana” (1867), da “L’
uomo delinquente studiato in rapporto all’ antropologia, alla medicina e alle discipline carcerarie”
(1876) alle “Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici” (1909). Erano il frutto di prolungate e
accurate indagini fisiognomiche, nutrite di attente misurazioni, di schizzi anatomici, di disegni degli
stessi alienati osservati, di scritti dei delinquenti. Si pensi, ad esempio, all’ “Antropologia sul
tatuaggio in Italia in specie fra i delinquenti” (1875). La convinzione di fondo che guida la sua
riflessione e la sua ricerca è proprio la stretta correlazione che vi sarebbe fra i tratti somaticopsicologici e l’ azione criminale. E la personalità criminale è riconducibile a caratteristiche
ereditarie che compaiono nel volto e nei comportamenti. Ma è da ribadire che non soltanto la
psicologia del delinquente, ma anche quella del genio, debbono essere ricondotte a degenerazioni
psichiche organiche. Due sono le categorie antropologiche che danno conto dell’ “animalità” che
ritorna nell’ “homo sapiens”: l’ atavismo e la degenerazione. Apparentemente prossimi, i due
processi sono contrapposti. L’ atavismo conferma la legge biogenetica di Ernst Haeckel: lo sviluppo
individuale ripercorre le stesse fasi della filogenesi, dell’ evoluzione della specie. La degenerazione
è, invece, il “blocco dello sviluppo fetale. L’ atavismo è il segno dell’ evoluzione, la degenerazione
è un’ involuzione, un arresto dell’ ontogenesi. E’ questa la cifra del positivismo psicologico e
criminologico di Cesare Lombroso, che nacque a Verona nel 1835 da famiglia ebraica di idee
socialiste, e sarebbe morto a Torino, agli albori del nuovo secolo, nel 1909. Prese la laurea in
Medicina a Pavia nel 1858, discutendo una tesi sul cretinismo. Fece parte di quel numeroso corpo di
spedizione dell’ appena costituito Esercito italiano che, dal 1862, anche in Calabria avrebbe
represso, con la legge marziale, il brigantaggio. Da giovane medico militare aveva intrapreso una
rilevazione sistematica di misure antropometriche su numerosi soldati. Avrebbe continuato, poi,
tali misurazioni sui malati mentali. Docente presso l’ Università di Pavia, diresse, infatti, l’
Ospedale psichiatrico di Pesaro. L’ obiettivo di fondo era la convergenza dell’ ordine della misura
con l’ ordine clinico, nella convinzione che essi avrebbero trovato una conferma teorica con un
metodo del tutto simile a quello matematico-statistico ed a quello comparativo-linguistico. Tornò a
Pavia nel 1872 ma le incomprensioni con Paolo Mantegazza, lo indussero ad allontanarsene
nuovamente e, nel 1876, ottenne la cattedra torinese di Medicina legale. Nel 1905 ottenne nell’
Università di Torino la cattedra di quella disciplina, l’ antropologia criminale, che proprio lui aveva
fondato, e che ebbe non pochi influssi sulla scuola positiva di diritto penale. Il richiamo ai fattori
ambientali oltre che alla dimensione psicofisica del criminale indusse ad un ripensamento della
pena, che cominciò ad esser concepita come strumento e veicolo di riabilitazione e non più come
semplice punizione. Il giuspositivismo avrebbe liberato la norma giuridica da ogni condizionamento
metafisico, da ogni corrispondenza a trascendenti valori di giustizia: non vi è altro riferimento che
la norma positiva e il diritto non è altro che il complesso delle norme che lo costituiscono. La
prospettiva di Lombroso nei confronti del criminale era, senza alcun dubbio, unilateralmente e
aprioristicamente organicistica e patologistica, ma non si può ignorare che essa contribuì a deviare
gli studi giuridici da una dominante attenzione astratta nei confronti del delitto ad una più concreta
valutazione del criminale. Rilevante contributo all’ innovazione della psicologia criminale da parte
di Lombroso fu la pubblicazione dell’ “Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze
penali per servire allo studio dell’ uomo alienato e delinquente”, rivista il cui primo numero uscì nel
1880. La psicologia criminale sarebbe poi stata coltivata con impegno in Italia: basterebbe ricordare
il solo nome di Padre Agostino Gemelli o di Sante De Sanctis. Eugenio Garin, nella sua “Storia
della filosofia italiana” (1966) definisce Lombroso un “materialista schietto” e ne ricorda il
contributo alla diffusione e alla conoscenza, in Italia, di Jacob Moleschott, del quale introdusse
nella Penisola (1869), “La circolazione della vita” (1852), che Roberto Ardigò conosceva molto
bene. Del resto “Il Moleschott stesso insegnò a Torino” ricorda Garin, e la presenza del
materialismo nel positivismo italiano fu ampia e solida. Aldo Agazzi, nel suo “Panorama della
pedagogia d’ oggi” (1954), individuava nel positivismo, e non solo italiano, due correnti: “quella
del “positivismo degli scienziati” e quella del “positivismo dei filosofi””. E precisava che “Il primo,
darwiniano, spenceriano ed haeckeliano, … si era caratterizzato nei tratti dell’ evoluzionismo, del
determinismo e del materialismo, nella ingenua convinzione della derivazione progressiva del
superiore dall’ inferiore (dal meccanico al chimico, dal chimismo alla vita, dal biologico allo
psichico, dallo psichico alla coscienza), e … aveva elaborato le sue concezioni “scientifiche”
meccanicistiche ed antiteologiche, dell’ uomo privo di libertà”. Tra i positivisti di questa corrente
“scientifica”, Agazzi colloca, oltre a Lombroso, Giuseppe Sergi, Enrico Morselli, Enrico Ferri, e la
stessa Maria Montessori. L’ altra corrente “pur accogliendo il concetto spenceriano dell’ evoluzione
dall’ omogeneo all’ eterogeneo e quello dell’ adattamento all’ ambiente, aveva interpretato
criticamente, in alcuni casi, il determinismp, concependolo, non come “fatto oggettivo”, ma soltanto
come “esigenza della ricerca scientifica” in quanto senza fissità e regolarità delle leggi di natura
nessuna scienza sarebbe possibile; e aveva riconosciuto comunque una virtualità indefinita e una
possibilità di iniziativa al pensiero ed al valore dell’ uomo di fronte ai dati stessi dell’ esperienza e
della realtà”. Non vi è alcun dubbio che, con Lombroso, lo scientismo giunse ad una delle sue
massime espressioni nelle scienze umane. Patrizia Magli (“Il volto e l’ anima. Fisiognomica e
passioni”, 1995) ha scritto che, in lui, “L’ ossessione con cui la misurazione diventa parametro
indicativo è data, per esempio, dall’ uso del goniometro, strumento che misura l’ angolo auricolotemporale allo scopo di costruire una scala che va dall’ uomo normale alla scimmia passando
attraverso vari tipi di criminali”. “Nel sesto capitolo del primo volume di “Antropometria e
fisionomia”, dove Lombroso rende conto <delle sue> indagini sulla quantificazione e misurazione
delle anomalie, - scrive ancora la Magli – egli sottolinea il fatto che si tratta di un campione di ben
6.608 devianti. E’ un campione elevato, egli dice, ma indispensabile affinché il concetto di tipo
possa avere il sostegno di una legge biologica, che, secondo quanto dirà anche Enrico Ferri, si
combina solo con i grandi numeri”. Patrizia Magli è docente di Semiotica all’ Università di Bologna
e, tra i suoi saggi, ci sono “Corpo e linguaggio” e “Le donne e i segni”. Ne “Il volto e l’ anima” ha
voluto ricondurre l’ antropologia criminale di Lombroso a quella plurisecolare “vasta impresa di
decifrazione” del viso che ha il suo primo atto nella “Historia animalium” e nel “De
Physiognomica”, trattati che fanno parte del “Corpus Aristotelicum”. Nonostante “la pluralità
eterogenea delle pratiche divinatorie, fisiologiche, mediche e artistiche … il viso – scrive la Magli –
continua a far parte di quegli oggetti mai interamente oggettivabili, di quelle rappresentazioni mai
interamente rappresentabili, di quelle visibilità a un tempo manifeste e invisibili … La
fisiognomica, come ogni altra attività scientifica, si è posta come obiettivo quello di poter
attraversare la complessità del reale servendosi di un pacchetto limitato di principi esplicativi e
poter così riportare la diversità a un numero ristretto di categorie comuni”. Le critiche che Wilhelm
Hegel rivolse nella “Fenomenologia dello spirito” (1807) alla fisiognomica, alla frenologia, alla
chiromanzia, alla grafologia, valgono sostanzialmente anche per l’ antropologia criminale di
Lombroso. Come ha scritto Nicolai Hartmann in “La filosofia dell’ idealismo tedesco” (19231929), vi è, secondo Hegel, nella storia dello Spirito che cammina verso la propria coscienza, un
momento nel quale si afferma “l’ espediente di giudicare l’ interiore secondo l’ esteriore, il
soggettivo secondo l’ oggettivo: lo psichico secondo il corporeo. La mano, il viso, il cranio
esprimono l’ aspetto tipico dell’ anima, il carattere, anzi qualcosa di ben precisamente individuabile
… Ma non è possibile trovare una legge. V’ è una quantità di segni empirici e sono tutti
significativi, ma rimangono ambigui. L’ uomo è variabile, il coordinamento dell’ interno e dell’
esterno muta, nella vita dell’ individuo come nella storia”. In un “rapporto di segno” (“Zeichen”),
dice Hegel, “Per il contenuto espresso è perfettamente indifferente la costituzione di ciò con cui tale
contenuto viene espresso”. E, aggiunge Hartmann, “L’ indifferenza del segno rispetto al designato
costituisce la caratteristica generale e costante di quell’ “inessenzialità” che spetta a questo intero
genere di osservazione e di giudizio. L’ importante sarebbe trovare un esterno tale che avesse in sé
la “vera essenza” dell’ interno. Ma un tale esterno lo possediamo soltanto nella volontà e nell’
azione dell’ uomo”. Coglie bene il pensiero di Hegel, la Magli, quando appunta che “Il lavoro e il
linguaggio sono estrinsecazioni ben più significative dello spirito che la forma di un naso camuso o
le protuberanze di un mento sporgente”. Certamente i tratti di un volto o le linee della mano o il
timbro della voce esprimono un individuo, ma sono soltanto semplici segni: una “esteriorità
semplice” che si contrappone ad una “esteriorità molteplice e complessa” quale è quella dell’ opera
e dell’ azione dello stesso individuo.
38 /
Augusto Murri
Augusto Murri, clinico bolognese, con il suo eminente contributo alla metodologia scientifica,
confermò ed esaltò la propensione pragmatica del positivismo italiano ad occuparsi di concrete
ricerche. La convinzione di fondo che emerse dalle indagini dei positivisti italiani nelle varie
branche, fu che l’ essere umano può esser analizzato e compreso, nelle sue facoltà morali e
intellettuali, con lo stesso approccio deterministico delle scienze naturali, giacchè tali facoltà sono
condizionate da fattori biologici, fisici, economici e sociali, ben ponderabili. Solo per far alcuni
esempi, dal positivismo giuridico di Salvatore Fragapane (1868-1909), che subordinava le scienze
sociali, tra le quali il diritto, alla sociologia, - alla centralità della formazione scolastica come fattore
di progresso civile nella pedagogia di Andrea Angiulli 1837-1890), che riteneva fondamentale nel
processo educativo il ruolo della psicologia; - dalla psicologia a fondamento biologico di Gabriele
Buccola (1854-1885), - alla sociologia evoluzionistica di Alfonso Asturaro (1854-1917) che
concepiva i processi sociali come frutto di una complessa interazione di molteplici fattori: il
positivismo italiano mise a punto metodi e procedure delle scienze umane attraverso indagini
concrete e particolari e contribuì al loro rinnovamento (o alla loro fondazione) e ad una generale
sprovincializzazione della cultura nazionale. La vocazione antimetafisica e antispiritualistica, la
necessità di un’ aderenza ai fatti e di una rigorosa osservazione, l’ influsso dell’ evoluzionismo di
Charles Darwin e del materialismo di Jacob Moleschott e Ludwig Büchner, diedero certamente alla
ricerca italiana un’ impronta scientista, marcatamente determinista e meccanicista, ma non ne
esposero i maggiori rappresentanti al dogmatismo. Augusto Murri fece, anzi, del dubbio, della
critica, dell’ inventiva e della speculazione, i pilastri metodici dell’ indagine clinica e di ogni
scienza sperimentale. “L’ inventiva e e la speculazione sono le prime qualità dello spirito umano
anche per le scienze” scriveva, e aggiungeva che, non potendosi forzare la natura ad una risposta
immediata, debbono esser fatte “tutte le possibili ipotesi”. Una consapevolezza autenticamente
galileiana, giacchè Galileo Galilei aveva interrogato la natura per tutta la vita, non stancandosi mai
di formulare nuove ipotesi e di rivedere le proprie teorie. Il grande pisano aveva, talvolta, sostenuto
la giusta causa con teorie sbagliate, ma non si era mai arroccato dietro una presunta spiegazione
conclusiva e definitiva. L’ incertezza socratica di Murri lo spingeva a consigliare il coraggio dell’
immaginazione, in quanto non si deve temere di prospettare “tutte le possibili ipotesi”. Egli era
consapevole che “la nostra immaginazione è meno fertile della natura nell’ escogitare combinazioni
di fenomeni” ma non per questo rinunciava ad una autocritica rigorosa, ed anzi era ben certo che la
“mente scientifica” è una “mente vigilante” su quel che “le sue cognizioni implicano”. E’ proprio il
caso di dire che egli dava ampio spazio all’ immaginazione, pur imponendole le vigorose briglie di
una continua disamina razionale. Murri non indulgeva al verosimile ed al plausibile ed invitava a
non lasciarsi ingannare dall’ apparenza, persistendo nell’ interrogazione e nell’ incertezza. Era un
clinico positivista ma non ignorava i rischi di una malintesa infallibilità della ragione. In lui
risuonava l’ eco cartesiana della comprensione dell’ origine dell’ errore, che scaturisce dalla
presunzione della volontà umana, potenzialmente priva di confini e illimitata, di poter spingere il
fallace intelletto a superare i propri, salvo condurlo a madornali deviazioni. “La nostra ragione è
tutt’ altro che un infallibile congegno generatore di luce” sosteneva Murri in “Quattro lezioni e una
perizia” (1905) e aggiungeva che “siamo proprio noi razionalisti, che più diffidiamo di essa ...
Solo gli sciocchi e i semidei, che si credono invulnerabili, prendono la critica per avversione. Invece
la critica non sarà la più alta, ma certo è la più fondamentale dote dello spirito, perché la più
efficace profilassi dell’ errore”. Augusto Murri era nato a Fermo nel 1841 e sarebbe morto a
Bologna nel 1932. Docente di Clinica medica nell’ Università di Bologna, dal 1871 al 1906, diede
contributi fondamentali nella comprensione del meccanismo di compenso fisiopatologico del cuore,
dell’ emoglobinuria parossistica da freddo e nella terapia digitalica. Ma certamente il suo maggior
apporto fu proprio il richiamo ad una attenta e scrupolosa rilevazione e interpretazione dei sintomi,
in un quadro severamente logico. Tra i suoi maggiori lavori metodologici sono da ricordare: gli
“Scritti medici” (1902), “Lezioni di clinica medica edite ed inedite” (1908) e “Il medico pratico”
(1913). “Murri è un fallibilista coerente nella concezione della scienza: questa serve a spiegare i
fatti, e i fatti servono a controllare quella, cioè le teorie scientifiche” ha scritto Dario Antiseri. Nato
nel 1940, Antiseri si è laureato a Perugia e, tra il 1963 e il 1967, ha approfondito la filosofia della
scienza, la filosofia del linguaggio e la logica matematica a Vienna, Münster e Oxford. Ordinario di
Filosofia del linguaggio nell’ Università di Padova, ha contribuito alla diffusione in Italia, tra l’
altro, dell’ epistemologia di Ludwig Wittgenstein, Max Scheler, Karl Raimund Popper. E di
quest’ ultimo ha ben presente il falsificazionismo quando richiama le parole di Murri riguardo all’
irrinunciabile consapevolezza che deve guidare tanto la clinica quanto l’ esistenza quotidiana:
“Nella clinica, come nella vita, bisogna avere un preconcetto, uno solo, ma inalienabile: il
preconcetto che tutto ciò che si afferma e che par vero può essere falso: bisogna porsi una regola
costante di criticare tutto e tutti, prima di credere: bisogna domandarsi sempre come primo dovere:
perché devo io credere questo?”. Non vi è dubbio che il positivismo critico di Murri presagisse e
presentisse il fallibilismo di Popper, l’ esigenza dell’ epistemologo viennese di abbandonare il
principio di verificazione dei neopositivisti del Circolo di Vienna – arroccato sulla teoria dell’
induzione e sull’ aderenza degli asserti scientifici al dato empirico – e adottare quello di
falsificabilità. Il quale principio è soltanto un criterio negativo per distinguere tra ciò che è scienza e
ciò che non lo è. E la psicoanalisi di Sigmund Freud, ad esempio, non è, secondo Popper, una
scienza, poiché le sue leggi e suoi asserti non possono essere messi in discussione. Popper scrive, in
“Congetture e confutazioni” (1963) che, nel 1919, egli si sentì profondamente insoddisfatto da
teorie come quella marxista della storia, la psicoanalisi e la psicologia individuale, dubitando delle
loro pretese di scientificità. Cominciò a chiedersi in cosa, tali dottrine, fossero così diverse dalla
teoria newtoniana e da quella della relatività. “Riscontrai che i miei amici, ammiratori di Marx,
Freud e Adler – ricorda – erano colpiti da alcuni elementi comuni a queste teorie e soprattutto dal
loro apparente potere esplicativo. Esse sembravano in grado di spiegare praticamente tutto ciò che
accadeva nei campi in cui si riferivano. Lo studio di una qualunque di esse sembrava avere l’ effetto
di una conversione o rivelazione intellettuale, che consentiva di levare gli occhi su una nuova verità,
preclusa ai non iniziati. Una volta dischiusi in questo modo gli occhi, si scorgevano ovunque delle
conferme: il mondo pullulava di verifiche della teoria. Qualunque cosa accadesse, la confermava
sempre. La sua verità appariva periò manifesta; e, quanto agli increduli, si trattava chiaramente di
persone che non volevano vedere la verità manifesta, che si rifiutavano di vederla, o perché era
contraria ai loro interessi di classe, o a causa delle loro repressioni tuttora “non-analizzate” e
reclamanti ad alta voce un trattamento clinico”. E concluse che la loro “apparente forza” era in
effetti il loro “elemento di debolezza”. Ripartì dalla convinzione che “le teorie scientifiche non
erano sintesi di osservazioni < come crede chi si fonda sul principio di verificazione e sull’
induzione >, bensì invenzioni-congetture audacemente avanzate per prova, da eliminarsi se
contrastanti con le osservazioni. Queste osservazioni, poi, raramente erano accidentali, bensì
generalmente, venivano intraprese con la precisa intenzione di controllare una teoria, ottenendo,
possibilmente, una confutazione decisiva”. Per intenderci, “per quanto sia possibile collezionare con
profitto i coleotteri, lo stesso non vale per le osservazioni”, giacchè “l’ esperienza non consiste nell’
accumulazione meccanica di osservazioni: essa è creativa, in quanto è il risultato di interpretazioni
creative libere e audaci, controllate da una critica e da prove severe”. Così Popper concludeva che
“Tutto ciò che possiamo sperare di dire intorno a una teoria è che spiega questo o quest’ altro, che è
stata controllata severamente e che ha retto bene tutte le nostre prove. Possiamo anche confrontare,
ad esempio, due teorie, per vedere quale di esse ha retto meglio i controlli più severi – o, in altre
parole, quale di esse è meglio corroborata dai risultati dei controlli. Ma si può dimostrare, con
mezzi puramente matematici, che il grado di corroborazione non può mai essere considerato uguale
alla probabilità matematica. E’ possibile anche dimostrare che tutte le teorie, compresa la migliore,
hanno la stessa probabilità, vale a dire zero. Ma il grado della loro corroborazione … può
avvicinarsi molto all’ unità, cioè al grado massimo, anche se la probabilità della teoria è zero …”.
Una teoria, comunque, non è scientifica se si ritiene a priori che ssa sia inconfutabile e che non
possa esservi alcun evento concepibile in grado di falsificarla. Esercitare un “controllo genuino” su
una teoria equivale al “tentativo di confutarla”: “il criterio dello stato scientifico di una teoria è la
sua falsificabilità, confutabilità, o controllabilità”. Murri fece anzitempo tesoro della lezione che
Popper avrebbe dato agli scienziati del Novecento. Per dirla con Dario Antiseri (“Il mestiere del
filosofo”, 1977), “Per risolvere un problema occorre scatenare la fantasia. Occorre fantasia,
creatività, per costruire mondi possibili, con la speranza che uno di questi mondi possibili possa
spiegare (descrivere e prevedere) quel pezzo di realtà messo in evidenza dal problema. La creatività
non pare avere fonti privilegiate: ortodossia, ribellione, euforia, ignoranza, depressione, solitudine,
mito, audacia, tenacia, fortuna, ecc: sono tutte fonti di idee nuove … I mondi possibili, le congetture
o le ipotesi, queste creature della mente umana, esprimono sospetti, sono atti di accusa: imputano a
uno o più fatti o eventi di essere responsabili dell’ accadimento di quel fatto che ci ha colpito. E se
le ipotesi sono sospetti, esse, al pari di ogni sospetto, vanno provate … una teoria, per quanto
confermata essa possa mai essere, non è mai certa, mai assolutamente provata o dimostrata, poiché
non si può logicamente escludere che il caso n + 1 non smentisca la legge … la storia della scienza
è una meravigliosa storia di teorie fatte saltare in aria da fatti contrari”. Di quest’ atteggiamento
popperiano autenticamente razionale nella critica alle teorie – tentando di coglierne i limiti,
individuarne gli errori, di evidenziarne le difficoltà – Murri fu senza alcun dubbio acuto
precorritore. “Critici – scriveva - non si nasce. I bambini credono tutto e le mamme non trovano
mai difficile di farsi credere. Ma anche fra i cultori di scienze, fra i medici pratici, taluni han l’
inclinazione intellettuale a trovare sufficiente qualunque mediocre spiegazione, mentre altri durano
gran fatica ad acquietarsi. Quei primi vivono certo più in pace e d’ ordinario ispirano al pubblico
maggior fiducia, perché il pubblico, non essendo penetrato dallo spirito scientifico, non può
apprezzare l’ esitazione e la riservatezza dei giudizi. Il volgo prende l’ indecisione come principio
d’ ignoranza, e considera come indizi di sapere la sicurezza e la precisione delle formule
diagnostiche e terapeutiche. Gli altri, invece, quelli invasati da ciò che l’ Huxley chiamava il
“demonio benefico”, dal dubbio, vogliono veder chiaro prima di credere. E se il più lungo esitare li
pone in una posizione svantaggiosa rispetto al volgo, li rende però più forti nella indagine e nella
meditazione, cioè più capaci di pervenire a quella certezza ch’ è maggiormente in accordo colla
realtà delle cose e ch’ è, quindi, una forza più acconcia per agevolare gli eventi utili e per opporsi ai
dannosi …Io mi son sempre sforzato di dare alla mente de’ miei scolari questa seconda direzione,
benché non abbia mai avuto la pretesa di avere una scuola propria … “. Il richiamo all’
irrinunciabile esercizio critico non gli faceva, però, metter in ombra la “certezza scientifica”,
poiché rifiutava di confondere l’ atteggiamento clinico da lui rivendicato con lo scetticismo, il
pirronismo, il nichilismo. Il medico pratico, precisava, “deve certamente criticare colla più
diffidente severità tutte le idee, ma per concludere quale di esse è la giusta o, almeno, la più
verisimile, per noi, secondo essa regolare l’’ opera sua”.
39 /
Rosa Agazzi (1)
Rosa Agazzi – con la sorella Carolina – condusse, nel corso di tutta la sua vita, una feconda
sperimentazione educativa infantile. Essa si inserisce nell’ ampio e complesso movimento
pedagogico delle “scuole nuove”, che interessò anche l’ Italia dalla fine dell’ Ottocento. E nel quale
si riconoscono le esperienze di Maria Montessori, Giuseppina Pizzigoni e Alice Fianchetti, alcune
delle innovatrici più significative nell’ educazione delle prime età. L’ attivismo della “scuola
nuova” si alimentò di fermenti e inquietudini metodologiche, didattiche ed educative, che
corrispondevano a profondi processi di trasformazione civile, sociale e culturale. Le motivazioni, i
percorsi, i metodi, i crediti scientifici delle sperimentazioni condotte furono i più vari. Ma il
comune sostrato – per usare un’ espressione di Aldo Agazzi (“L’ attivismo pedagogico”) – era una
prospettiva paidocentrica dell’ educazione. Essa si proponeva di nutrire i processi e gli interventi
educativi con la psicologia dell’ età evolutiva e conferire loro una dimensione individualizzante.
Rosa e Carolina Agazzi nacquero, rispettivamente, nel 1866 e nel 1870 a Volongo (Cremona). Il
padre era un falegname di salde convinzioni liberali, la madre veniva da una famiglia nobile di
origini piemontesi, dalle idee clerico-liberali. A Brescia, le due sorelle frequentarono le scuole
normali e, appena dopo il diploma, ebbero un incarico a Nave, un borgo della provincia bresciana.
A Carolina spettarono gli oltre cento bambini dell’ asilo. Rosa si vide affidata una settantina di
bambine della elementare. Poste di fronte, ancor giovani ed inesperte, sebbene piene d’ entusiasmo,
alle drammatiche condizioni degli asili per l’ infanzia in un centro rurale dell’ Italia da poco unita,
dovettero provare sconforto. Rosa lamentava la discontinuità della frequenza, la carenza del
materiale indispensabile, per non dire di quello propriamente didattico, le indebite ingerenze di
“ignoranti popolane” e l’ inconsistenza giuridica ed economica del ruolo di un’ educatrice. Vissero
“sulla propria pelle” il divario tra la pratica educativa in uno Stato che non aveva investito nell’
istruzione, da una parte, e la cultura pedagogica ricevuta nelle scuole normali, dall’ altra. Alle future
educatrici si impartivano aride nozioni precettistiche e il metodo froebeliano veniva proposto loro in
modo semplicistico, ridotto com’ era all’ elencazione dei “doni”. I doni, nella didattica del
giardino d’ infanzia di Friedrich Wilhelm August Froebel (1782-1852), erano sussidi – mezzi,
strumenti, aiuti – con una funzione soprattutto giocosa (Mauro Laeng) ed avevano una forte valenza
pedagogica. Influenzato da Pestalozzi, Schelling e Novalis, Froebel credeva in una autoeducazione
che favorisse la spontanea attività dell’ uomo e che non imponesse alcun modello esterno,
consentendo a ciascuno la possibilità di una realizzazione autonoma. Gli asili infantili erano nati in
Italia come istituti di ricovero con finalità di beneficenza e assistenza alle famiglie povere. Era, la
loro, una “filosofia” assistenzialistica e vi convergevano carità cristiana, ideali risorgimentaliliberali e filantropia privata. Il froebelismo fece il suo ingresso negli asili italiani fra avversioni
nazionalistiche e volgarizzazioni metodistiche, che ne coglievano l’ aspetto superficiale ed
esteriore. La pedagogia di Froebel era ridotta alla dimensione di mero formulario pedagogico.
Anche il metodo di Ferrante Aporti (1791-1858) era appiattito: se ne accentuavano l’ intrinseco
intellettualismo e il didatticismo. In sostanza, l’ asilo aveva funzioni custodialistiche ed era privo di
finalità educative autonome dagli ordini successivi di scuola. Tali erano le condizioni dell’
educazione intantile quando le Agazzi avviarono la loro esperienza. Da Nave, dopo aver tentato
con esito negativo il concorso per l’ insegnamento nelle scuole del Comune di Brescia, Rosa si
trasferì a Villa Fuggini, nell’ asilo custodialistico di Via del Forcello, mentre Carolina era destinata
all’ asilo infantile di un altro sobborgo Bresciano, la “Fornace”. Villa Fuggini era costituita da una
notevole struttura architettonica, ampia, spaziosa e luminosa, circondata da molto verde. Rosa potè
avviarvi le prime sue originali ed autonome esperienze: giochi, canti, passeggiate. Carolina ne
seguiva l’ esempio a Rovere. Nel 1894, Rosa fu trasferita a Volta Bresciana e l’ anno successivo a
Mompiano, ove potè riunirsi a Carolina. Negli asili infantili bresciani ella aveva accudito figli di
operai e contadini, ribelli all’ igiene e alla disciplina, restii al canto ed alle attività ludiche
programmate, tanto che il suo entusiasmo e la sua educazione piccolo-borghese erano caduti in una
seria crisi. A Mompiano, come sempre prive della sia pur minima dotazione di materiale didattico,
le due maestre avviarono una sperimentazione che ebbe come protagonisti un centinaio di figli di
contadini e di operaie della locale filanda. Iniziò anche la loro proficua collaborazione con Pietro
Pasquali, da tempo impegnato in un progetto di rinnovamento dell’ asilo infantile, che era fondato
sul recupero e sulla riscoperta dell’ autentica e originaria pedagogia froebeliana oltre che sull’
introduzione del lavoro manuale nelle scuole elementari. Per la verità, le prime preoccupazioni delle
Agazzi furono rivolte alle cure igieniche dei fanciulli e non è casuale che, in un opuscolo del 1903,
destinato ad offrire fondamentali consigli alle famiglie, le due maestre segnalassero tra i più
importanti compiti dell’ asilo, l’ apprendimento delle cure igieniche. “1. L’ asilo – scrivevano –
riceve il bambino a tre anni per prodigargli cure materne, serie, illuminate, che sono di sollievo alla
famiglia e che dovrebbero da questa essere apprezzate e imitate. Dai tre ai sei anni il bambino
conduce all’ asilo una vita di moto ordinato, di scambievole affetto, di mutuo e spontaneo aiuto, e
quivi ha i mezzi per crescere nutrito, sano, educato. 2. All’ asilo, però, il bambino va per imparare a
lavarsi non già per lavare la faccia, o per pulire la testa o la persona sporca; l’ asilo abitua il
bambino a trovare piacevole, indispensabile, la pulizia per sé e intorno a sé; alla famiglia il compito
di lasciar mettere in pratica ogni mattina e sempre, questa preziosa abitudine. 3. L’ asilo fornisce al
bambino nutrimento sano ed abbondante, che non sempre la famiglia può dare; quando i mezzi della
beneficenza lo permettono, aggiunge la somministrazione del migliore dei ricostituenti, l’ olio di
fegato di merluzzo. 4. L’ asilo offre al bambino ambienti convenientemente riscaldati; acqua calda
d’ inverno; indumenti e oggetti vari di uso individuale. Permettendo le finanze, calze e zoccoli
asciutti e riscaldati, che indossa da sé nelle ore di scuola, mentre si asciugano le calzature di casa. 5.
Il bambino all’ asilo viene curato ne’ suoi piccoli mali, esterni ed interni, come suggerisce la
scienza medica, e non come vorrebbero le donnicciuole …”. Non vi alcun dubbio che se non si
tiene adeguatamente conto della realtà socio-economico-culturale in cui si svolse la
sperimentazione Agazzi/Pasquali, il fraintendimento e l’ errata valutazione sono inevitabili. E’
stato detto più volte che Rosa Agazzi fu scrittrice poco sistematica e scarsamente scientifica. Ma l’
immediatezza che le sue opere conservano, la loro aderenza alla pratica educativa, dimostrano che
Rosa e Carolina furono anzitutto delle educatrici “sul campo”. La loro sperimentazione muoveva
da una viva sensibilità sociale e univa la reazione critica all’ inadeguata istruzione magistrale
ricevuta. Fu una sperimentazione che si mosse al di fuori della psicologia e e della filosofia ufficiali
del positivismo, che attribuiva allora a tare ereditarie la “selvatichezza” dei figli del popolo. Le
Agazzi furono guidate dall’ esigenza di modificare profondamente il clima delle sale
custodialistiche e di riproporre al loro interno l’ ambiente familiare. Vollero contrapporre al
meccanicismo e al determinismo della psicologia positivista non solo la valorizzazione delle
migliori istanze aportiane ma anche un ritorno all’ autentico Froebel. Un Froebel liberato delle sue
venature mistico-romantiche, dinamicamente riproposto senza nostalgie da mediocri epigoni e
imitatori scolastici. Nella pedagogia della Agazzi, Franco Frabboni ha rilevato l’ ampia risonanza
dell’ idealismo froebeliano, del romanticismo di Pestalozzi e dello spiritualismo di Aporti, ma senza
cogliervi alcun eclettismo ripetitivo ed alcuna adesione superficiale ed acritica. Frabboni nota
anche, come del resto aveva già fatto Aldo Agazzi, che dallo spiritualismo aportiano la Agazzi
mutua il primato delle attività dello spirito ed il concetto di natura. Un concetto, quest’ ultimo, da
distinguersi tanto da quello idealistico quanto da quello positivistico. L’ educatrice di Compiano
critica il pedantismo e il nozionismo degli asili aportiani. Il mediocre metodismo non la condiziona,
e la pratica educativa le consente di riscoprire i principi dei pedagogisti cui si ispira nel loro
autentico e originario significato. Aldo Agazzi ha ben sottolineato che “Rosa Agazzi non è, per
vero, scrittrice da rigide impostazioni”, ma ha anche voluto precisare che “ci sono due generi di
organicità e sistematicità: una estrinseca – che può persino essere puramente d’ apparenza, e più
schema che sistema – e una intrinseca, interiore, costitutiva”. “Orbene – è questa la conclusione del
pedagogista – il caso della Agazzi è del secondo genere: esposizione cordiale, senza formalismi,
senza impegno di dottrinalità; esposizione da educazione vissuta, più che da pedagogia scientificofilosofica, ma in chiarezza di principi informatori, in costanza e coerenza di motivi, in intima
organicità di problematica e di soluzioni, nella sicura consapevolezza di quella che è la natura dello
spirito umano e nella chiara intuizione della vita psicologica del bambino”. Rosa Agazzi fu feconda
di scritti, come feconda fu la sua opera d’ educatrice. Tra le sue opere, sono da ricordare la “Guida
per le educatrici dell’ infanzia” (1929-1930), “Come intendo il museo didattico nell’ educazione
dell’ infanzia e della fanciullezza. Note pratiche ad uso degli istituti infantili e delle prime classi
elementari” (1922), “La lingua parlata. Esercizi pratici ad uso della scuola materna e delle prime
classi elementari” (1910-1930), “L’ arte delle piccole mani. Manuale di lavoro educativo per le
scuole materne ed elementari” (1927), “L’ abbicì del canto educativo ad uso delle scuole materne e
delle prime classi elementari” (1908), “Bimbi cantate! Melodie dell’ infanzia a compimento dell’
Abbicì del canto educativo” (1911). La Scuola Editrice di Brescia ha pubblicato tutte le opere di
Rosa Agazzi nella collana “Infanzia e educazione”, in collaborazione con il Centro di Pedagogia
dell’ Infanzia e l’ Opera Nazionale Assistenza Infanzia Regioni Confine. Aldo Agazzi e Giovan
Battista Carron hanno provveduto a riordinarne anche gli appunti e gli articoli sparsi. Gli scritti
della Agazzi, comunque nascono, con immediatezza, da concrete e quotidiane esperienze educative.
Sono certamente il frutto di appunti, di sintesi, di annotazioni; hanno il carattere della relazione e
dell’ articolo di rivista; nascono nel fervore della sperimentazione, della scoperta, dell’ intuizione.
E’ stato perciò facile accusarle di ascientificità e di scarsa logicità. Si è voluto anche notare nell’
esperienza dell’ educatrice la mancanza di un metodo. Ma le due sorelle Agazzi non intendevano
proporre un monolitico e aprioristico metodo. Non vi era altro intento in loro che quello di offrire
alle educatrici d’ infanzia suggerimenti e indirizzi da ripensare con originalità e forte senso pratico.
Aldo Agazzi sosteneva, d’ altra parte, che Rosa Agazzi non fu un’ empirica. La sua e quella della
Montessori sono concezioni ed esperienze autentiche del bambino; la loro teoria e la loro pratica
educativa sono sorrette da un robusto senso del rapporto educativo e del soggetto dell’ intervento
educativo. Certo, neppure le proposte della Agazzi sarebbero state esenti dalla mera imitazione e
dalla banale ripetitività. Ma, come sostiene Mario Mencarelli (“Infanzia e cultura nella scuola
materna agazziana”, 1983), a correggere certo “agazzismo da manuale”, da precetto anziché da
proposta, “L’ uso dei “contrassegni”, gli esercizi di vita pratica, la manipolazione delle
cianfrusaglie, gli intensi momenti di gioco e di lavoro, lo stesso concetto di “ordine” < erano > nel
loro insieme, l’ equivalente di una accezione dell’ esperienza di solido spessore, di una esperienza
che era subito “esperienza di” …, ma anche “esperienza del proprio essere”, e quindi d’ un potere di
costatazione e di valutazione che era esperienza della validità del rapporto sociale, del contatto con
la natura, d’ una significante tensione axiologica”. La sperimentazione agazziana è sorretta da una
concezione educativa che non vuol essere deterministica e naturalistica, ma finalistica e aperta a
valori. L’ “ordine”, inteso da Aldo Agazzi come il “principio cardine e regolatore a Mompiano”, è
azione secondo razionalità, educazione in vista di fini, di valori. L’ esperienza delle Agazzi non è
stata empiristica e spontaneistica e non è caduta in uno sperimentalismo fine a se stesso o dettato
dalla semplice contingenza.
40 /
Rosa Agazzi (2)
Rosa Agazzi si mosse, con la sorella Carolina, all’ interno di una realtà rurale e proto-industriale in
cui seppe costruire un’ esperienza dell’ educazione infantile dalle acquisizioni perenni e
irrinunciabili, al di fuori di ogni metodismo ed ideologismo. Ella fu, come ha ben chiarito Giuseppe
Serafini (“Rosa Agazzi pedagogista” in “Scuola materna per l’ educazione dell’ infanzia”), una
autentica pedagogista e non soltanto un’ educatrice: “Educatore è colui che è impegnato in prima
persona in un rapporto educativo. Pedagogista invece è chi svolge un’ attività di ricerca che ha per
oggetto il rapporto educativo nella sua multiforme varietà, nei diversi contesti, nelle differenti
situazioni di studio … E’ certo che Rosa Agazzi sia una educatrice che ha grandi doti personali, ma
non si può richiamare solo queste per quel che riesce a fare nella e per la scuola dell’ infanzia.
Dietro quel che avviene a Mompiano non c’ è soltanto il genio e l’ intuizione (che pure ci sono in
larga misura) come non ci sono solamente queste in quel che hanno realizzato i grandi educatori di
una stagione (e questo vale, per esempio, anche per quel che fa la Boschetti Alberti, per la quale
gran parte della critica sembra invocare invece quasi per intero quelle doti). Rosa Agazzi possiede
anche una discreta cultura pedagogica, e mi riferisco soprattutto a quella che ella comincia a farsi
dopo la prima esperienza a Nave quando s’ accorge che la cultura fornitale dalla scuola normale non
le è di alcun aiuto. Le doti personali, una cultura che va crescendo, una esperienza che si fa mano a
mano più ricca, un rapporto con Carolina sicuramente stimolante, così come lo diviene quello con
< Pietro > Pasquali, sollecitano e consentono a Rosa di mettersi alla prova come pedagogista”. La
proposta agazziana non è sempre stata adeguatamente considerata ed è incorsa, anzi, in
incomprensioni che appaiono piuttosto ideologiche che pedagogiche. Ad esempio, Remo Fornaca e
Redi Sante Di Pol collocano la Montessori tra le “posizioni esemplari” della pedagogia scientifica
del Novecento. E ne sottolineano il contributo dato, con Binet, Decroly e Claparéde, ad una più
matura concezione della scienza, dei metodi, delle tecniche e della sperimentazione, rispetto al
positivismo classico ottocentesco. In una simile prospettiva, l’ esperienza e la prospettiva agazziane
non vengono considerate. Ma, d’ altra parte, i due autori sostengono che, all’ interno del “salto di
qualità” compiuto dalla psicologia scientifica del Novecento, “Un dato da rilevare è la non
accettazione passiva dell’ impostazione scientifica; cominciano ad emergere i possibili rischi di
scelte scientifiche non inserite in un quadro umano e sociale sufficientemente ampio”. E se le
proposte agazziane non si muovono da una concezione rigorosamente positivistica, nondimeno è in
esse vivo il senso della psicologia del bambino e del suo ambiente sociale. Particolarmente severa è
la critica di Ernesto Codignola (“Le scuole nuove e i loro problemi”, 1962) al “provincialismo”
della visuale pedagogica di Rosa Agazzi. Egli richiama i presunti pericoli paternalistici e
conservatori cui il metodo agazziano si espone per la continua insistenza sull’ ordine, l’ obbedienza,
l’ operosità, la destrezza manuale. Sono critiche comprensibili alla luce dell’ evoluzione della
pedagogia contemporanea, ma prive affatto di realismo storico. Non si possono, infatti, ignorare le
condizioni nelle quali Rosa e Carolina Agazzi si trovarono concretamente ad operare ed a
sperimentare. L’ esperienza agazziana e quella montessoriana ponevano capo a due atteggiamenti
del mondo pedagogico italiano che Giovanni Genovesi ed Enzo Catarsi hanno definito come,
rispettivamente, “ruralismo” ed “industrialismo”. Vi corrispondevano due modelli d’ asilo, l’ uno
“rurale”, l’ altro “urbano”. Essi accentuavano la diversa sensibilità personale, culturale, scientifica,
antropologica, sociologica, delle Agazzi e della Montessori. Spontaneismo delle Agazzi e
scientificità della Montessori: è una contrapposizione anacronistica. L’ esperienza di Compiano, da
una parte, e le Case dei bambini, dall’ altra, mostrano una accentuazione sociologica, ambientale ed
operativa diversa. Giuseppe Lombardo-Radice era stato invitato nel 1910 dalla Lega degli
Insegnanti della Venezia Giulia per tenere alcune conferenze a Trieste, che era allora ancora città
irredenta. E lì, in un asilo d’ infanzia della città, conobbe il metodo Agazzi. Ne rimase entusiasta e,
tra il 1927 e il 1929, propose in alcuni suoi saggi le attività svolte dai bambini nell’ asilo agazziano
e descrisse in modo circostanziato il materiale didattico impiegatovi. Lombardo Radice innescava
però una polemica che avrebbe caratterizzato la seconda metà del Novecento, giacchè, preoccupato
di definire un metodo “nazionale”, contrappose il metodo Agazzi e quello della Montessori,
svalutando ovviamente quest’ ultimo. “L’ adesione all’ idealismo – ha scritto chiaramente Giuseppe
Zago – portava “naturalmente” Lombardo-Radice a guardare con diffidenza all’ impostazione
scientifico-positivistica del metodo della “Dottoressa” e a preferire il metodo Agazzi che egli
riteneva più naturale, più vivo, più spontaneo”. Non si può certo ignorare che l’ idealismo, prima, e
lo spiritualismo, poi, abbiano privilegiato il metodo Agazzi, come ha voluto sottolineare Roberto
Mazzetti, che però ha anche voluto rimarcare che l’ apporto delle due sorelle alla riforma del
froebelismo non è stato solamente didattico, ma si è inserito in una “ispirazione sociale-democratica
dell’ asilo infantile animata da un caldo respiro postrisorgimentale”. Mazzetti valorizza il contributo
teorico dato da Pietro Pasquali e scrive che costui, con le due sorelle, “operando dentro la tradizione
froebeliana, in un clima di cultura positivistica, riescono a superarne le meno valide suggestioni.
Mettono così in atto, con sperimentazioni successive e migliorative, una riforma della pedagogia
infantile e delle tecniche di Froebel, in nome di una pedagogia dell’ azione infantile, che consente di
inserire una scuola materna con finalità assistenziali, ricreative, educative, nella vita reale e nell’
ambiente sociale dei bambini”. “Maria Montessori – nota nel contempo Mazzetti – si trova invece
al di fuori di ogni tradizione aportiana e froebeliana. Dalle premesse di un orizzonte positivistico di
cultura biologica e psicologica, comincia col verificare alcune ipotesi di lavoro infantile,
psicosensoriale, con strumenti e in ambienti idonei a questo lavoro dei bambini; giunge così a
scoprire una inconsaputa vita profonda e autoformativa del bambino, resa possibile dalla capacità di
attenzione polarizzata e dal bisogno di ordinarsi interiormente. In tal modo la Montessori instaura
una pedagogia scientifica come pedagogia dell’ igiene psichica, rinnovando del tutto la tematica
filosofica dell’ autoeducazione, con l’ incentrarla sullo studio e l’ iniziativa ordinata del bambino”.
Ma come comprendere le scelte educative delle Agazzi se si ignora la politica dello Stato liberale
nei confronti dell’ istruzione popolare? Mentre il blocco della Destra storica enunciava la propria
fedeltà agli ideali risorgimentali, le sue riforme scolastiche non contribuivano certo a
ridimensionare il diffuso analfabetismo. Tra l’ altro, nel 1870, era stato introdotto il metodo
froebeliano, ma restava di gran lunga dominante, negli asili infantili, l’ enciclopedismo aportiano,
fondato sull’ insegnamento del leggere, scrivere e far di conto. Il dibattito sulla metodologia
froebeliana era stato piuttosto vivace ed aveva registrato interventi dei maggiori positivisti, da
Ardigò a Gabelli, da Vidari a Siciliani. Non vi è alcun dubbio che la pedagogia positivista
costituisse una impenetrabile barriera per le ispirazioni romantiche del froebelismo. E non si
debbono ignorare le tenaci resistenze degli aportiani. Al Congresso pedagogico italiano di Napoli
del 1871, emerse una sorta di “froebelismo adattato”, che avrebbe dovuto consentire, in Italia, la
nascita di numerosi giardini d’ infanzia. Si trattava di un metodo che privilegiava la spontaneità, la
crescita autonoma, spirituale e fisica, del bambino, rispettava lo spirito dell’ educazione materna e
intendeva evitare ogni scolasticismo e adultismo. Nella pratica educativa, comunque, il
procedimento froebeliano finì coll’ essere ulteriormente impoverito, e prevalse una metodologia
meccanica, rigida ed autoritaria. La “ventata froebeliana” costituì, in ogni caso, un salto di qualità,
anche se incontrò forti resistenze. Si muovevano al froebelismo obiezioni di vario genere: per l’
accentuato geometricismo, perché straniero, perché mortificatore della fantasia, perché coercitivo
… L’ introduzione del froebelismo provocò, comunque, un efficace dibattito sulla scuola dell’
infanzia. E dette un valido contributo al superamento della concezione custodialistica e
scolasticistica dell’ asilo. Anche se l’ indifferenza dello Stato liberale non veniva meno. Le certezze
teoriche e metodiche maturate nel dibattito non sarebbero riuscite, per parecchio tempo, a vincere le
“sfavorevoli contingenze storiche che ancora per molti anni – come ha scritto Giovanni Genovesi –
intralceranno lo sviluppo della scuola dell’ infanzia”. Tra la fine del secolo vecchio e l’ inizio del
nuovo, l’ Italia conosceva la prima industrializzazione. Le donne entravano in fabbrica e un abile
trasformista come il liberale Giovanni Giolitti era ben consapevole che lo Stato liberale, se voleva
sopravvivere alla sua gravissima crisi strutturale, politica ed istituzionale, doveva coinvolgere e
convogliare la volontà delle “masse popolari”, sino ad allora senza voto e senza rappresentanza.
Dissero malignamente i liberali conservatori che la sua “stampella” sarebbe stato il socialista
riformista Filippo Turati, il cui Partito Socialista rappresentava le “aristocrazie” operaie del Nord.
L’ idea della Sinistra liberale fu, in sostanza, quella di impartire ai ceti popolari un’ istruzione
(tecnica) funzionale alla logica di quel nuovo blocco di governo che – dopo le velleità riformistiche
di Agostino Depretis – era passato attraverso l’ autoritarismo dell’ età Crispina e che sembrava
trovare un’ occasione di sopravvivenza nel “disgelo” giolittiano. Ma, per intenderci, la condizione
alimentare dei bambini e delle maestre continuava ad essere insufficiente. Gli stessi moderati
denunciavano le carenze della refezione scolastica e sottolineavano che “mentre il figlio del povero
non può fruire che di un pasto frugale e spesso insufficiente, il figlio dell’ agiato borghese viene alla
scuola con il panierino provvisto non solo del necessario ma anche del superfluo”: così scriveva
M. Flamini in “Assistenza sanitaria infantile” (1921). La mentalità liberale conservatrice non era, in
linea di principio, sfavorevole all’ istruzione popolare, ma temeva per l’ ordine sociale. Insensibilità
ed incuria, indifferenza e trascuratezza caratterizzarono anche la politica per l’ educazione infantile.
Si comprende perché Pietro Pasquali invocasse un dignitoso stato economico per le educatrici d’
infanzia, e Maria Montessori analizzasse, con particolare attenzione, il rapporto tra società,
istruzione e delinquenza: si doveva superare il senso di impotenza, si doveva vincere l’
immobilismo della classe dirigente. Era necessario agire all’ interno dell’ asilo, modificarne
profondamente l’ assetto, elaborare nuove esperienze educative e riscoprire principi pedagogici. Un
compito improbo, da realizzarsi con mezzi limitati e nel consapevole riferimento alle condizioni
sociali, culturali, ambientali, in cui si doveva operare. L’ asilo aportiano era certo – se si ha il debito
senso delle proporzioni – una struttura educativa avanzata ed innovativa in età risorgimentale. Ma
poi era scaduto nel più freddo intellettualismo e nel più gretto autoritarismo. Degenerazioni che
Rosa e Carolina Agazzi si proponevano di vincere, mentre pensavano alla reintegrazione del
froebelismo. La riforma del froebelismo e dell’ aportismo che Rosa Agazzi intendeva avviare (con i
suggerimenti di Pietro Pasquali) voleva porsi nella continuità della tradizione, senza svalutare l’
innovazione, pur evitando salti nel vuoto. Si trattò di mutamento o fu autentica innovazione? L’
esperienza agazziana scaturì in modo endogeno dal sistema scolastico esistente, ove volle vostruirsi
una “nicchia”, oppure ebbe carattere esogeno e si mosse al di fuori del sistema? Franco Bertoldi
sostiene che le Agazzi erano “operatrici nella scuola” e si fecero interpreti dei “sintomi di disagio”
che emergevano dal sistema scolastico. Le due sorelle avrebbero quindi dato origine ad una sorta di
“tentativo isolato” di cambiamento interno. E qui rispunta il ruolo che Pietro Pasquali vi avrebbe
avuto. Il suo contributo dottrinario era esterno o interno al sistema? Il ritorno all’ autentico Froebel
non si risolse, comunque, in una mera opera di riesumazione. La sua riscoperta era mediata da una
acuta attenzione alle condizioni psicologiche, culturali e sociali dei bambini. Roberto Mazzetti ha
sottolineato che se la problematica dei rapporti tra scuola e società non fu affrontata dalle Agazzi
con la stessa consapevolezza critica con cui Ovide Decroly seppe imporla alla società americana, le
due sorelle seppero però viverla con creativo entusiasmo e concreta consapevolezza. Aldo Agazzi
inserisce il loro contributo al contemporaneo rinnovamento didattico italiano, ma precisa anche che
“Il rinnovamento agazziano … non era soltanto un’ espressione di “didattica” nuova, e di scuola
secondo naturalezza e spontaneità di vita infantile: esso, più profondamente, interpretava le
esigenze sociali e educative di una nuova scuola “di popolo””.
41 /
Rosa Agazzi (3)
Rosa Agazzi, all’ alba del nuovo secolo, avviava una originale riforma del metodo froebeliano e
dell’ asilo infantile aportiano. Nel 1895, a Mompiano, nell’ asilo dedicato a Giuseppe Garibaldi,
prendeva corpo la “scuola nuova” avviata qualche anno prina: Pietro Pasquali e le sorelle Rosa e
Carolina Agazzi progettarono persino, sulla base degli incoraggianti risultati, la costituzione di un
istituto di educazione infantile che avrebbe dovuto comprendere una scuola teorico-pratica per
bambinaie di scuola materna e familiari, un corso per le madri, oltre a strutture bibliotecarie e di
raccolta di materiale ed esperienze didattiche. La struttura non fu realizzata. Ma, nel frattempo, il
Consiglio scolastico della provincia di Brescia proclamava il loro Asilo: “asilo infantile rurale
modello”. E, soprattutto, il metodo trovava ampi consensi, si diffondeva e si affermava. La critica al
dominante custodialismo aportiano e al metodismo froebeliano fu pubblicamente enunciata da Rosa
Agazzi nel 1898 al Congresso pedagogico nazionale di Torino. Mario Mencarelli ha evidenziato l’
idea forza che animava tutta la relazione: l’ affermazione di una cultura dell’ umanità nel bambino.
E bene lo si comprende dove Rosa Agazzi auspica che l’ impiego del froebelismo sia liberato da
ogni convenzionalismo mnemonico e divenga strumento per favorire nel bambino l’ osservazione e
la riflessione sul mondo esterno, oltre all’ esigenza di un’ educazione armoniosa, che soltanto l’
attiva e spontanea partecipazione del bambino al rapporto educativo può consentire. Nella relazione
Rosa Agazzi presentava con grande coraggio e senso realistico la desolante condizione degli asili
infantili alla fine dell’ ottocento: dall’ impreparazione delle educatrici alle condizioni insalubri e
malsane dei locali, sino all’ inappagamento di una “febbre dell’ immediatezza e del bisogno” nei
bambini, la quale, lungi dal poter essere condotta alla maniera di Lombroso alla degenerazione e
all’ atavismo, invocava d’ essere incanalata, valorizzata, ordinata. Contro “l’ idolatria ed il
fanatismo dei metodi, le sdolcinature e l’ insania di coloro che rivolgendo ogni parte dell’
insegnamento alla neonata memoria del bambino, lo muovono come una macchina, lo annoiano, lo
stancano, lo incretiniscono”, occorreva, oltre che una severa riforma della formazione delle
educatrici, una nuova loro consapevolezza che avrebbe richiesto grande senso di responsabilità,
disponibilità, creatività. L’ educatrice era chiamata ad una conoscenza autentica che sottomettesse il
metodo al bambino. Era necessario conoscere la natura di quest’ ultimo, il suo linguaggio, le sue
abitudini, l’ interazione tra scuola e faniglia. Solo così si sarebbe potuto consentirgli di inserirsi a
pieno titolo nella comunità, corrispondere ai suoi bisogni, in un ambiente scolastico il più possibile
simile a quello familiare, in una scuola in sintonia con la sua vita e la sua esistenza. Al bambino
“oggetto” passivo di scolasticismo e metodismo, Rosa Agazzi opponeva il concreto bambino
protagonista dei giochi con i coetanei, dei rapporti con la madre e la famiglia. “Nella “scuola
materna” agazziana si “seconda” la natura del bambino, se ne promuovono e garantiscono la libertà
e l’ espressione “totale” e integrale. Al di là dei ripetitivi e vuoti esercizi artificiosi, di didatticismi
sterili, l’ educatrice – assumendo la naturalezza, la semplicità, l’ assiduità della madre – può
consentire la “nativa espansione” del bambino. Il metodo materno, naturale, restituisce centralità al
bambino nel processo educativo. E nel contempo coinvolge l’ educatrice, assegnandole un ruolo
attivo nel quale è posta in gioco tutta la sua personale autenticità. E qui di incontra la riscoperta del
Froebel “pedagogista che tenta, prova, riprova, eccede, modifica”, che valorizza lo spirito d’
osservazione nello studio del bambino, che è poi la vera lezione froebeliana, la quale impone una
affettuosa e continua comprensione del bambino. Nella “famiglia dei bambini”, per usare un’
espressione di Pietro Pasquali, i doni froebeliani si svincolani da deteriori aspetti originari od
acquisiti, ed i materiali didattici sono ricondotti alla loro giusta e preziosa funzione di strumenti al
servizio del metodo materno, dell’ educazione di un bambino che si esprime liberamente sia sul
piano individuale che nelle relazioni sociali, in una assidua attenzione, comprensione, disponibilità
dell’ educatrice. La Madre froebeliana si ripropone con forza laddove Rosa Agazzi è consapevole
che “Froebel ha ideato tutto il suo sistema d’ educazione basandosi non solamente sulle disposizioni
naturali del bambino, ma anche sul modo che tiene la madre educata nell’ allevarlo … Le idee di
questo grande pedagogista si riscontrano in qualsiasi esercizio, laddove l’ infanzia è guidata e
sorretta dall’ intelligenza materna”. E d’ altra parte, la Madre ideale di Rosa Agazzi – che era
pienamente consapevole delle carenze delle madri reali – è “intelligente, buona, colta quanto è
necessario per saper educare e istruire, gentile e generosa, schietta, capace di elevazione morale”.
Mentre pensava ad un più attivo coinvolgimento dei genitori anche attraverso corsi di formazione,
ella distingueva tra “famiglia ideale” e “famiglia reale”, giacchè, mentre nella seconda si educa a
partire dagli episodi quotidiani, nella prima prevale una organizzazione pedagogico-educativa
guidata e attuata da educatrici. Nelle pagine iniziali della “Guida per le educatrici dell’ infanzia”
(1929-1930), Rosa Agazzi darà proprio un tale significato alla nuova dizione di “scuola materna”. E
per chiarirlo bene, Aldo Agazzi scrive che “Il bambino … è spontaneità vivente: “germe vitale che
aspira al suo intero sviluppo”; e l’ educatrice, quindi, deve aver “il concetto della vita che è
chiamata a destare”, in un “sistema che si prefigga di non perdere mai di vista tutto il bambino”: il
bambino concreto, però, qual egli è, colto nella sua vita vera. Come codesto “germe vitale” potrà
svolgersi? Solo in un ambiente adatto (non “adattato”), vale a dire in un ambiente naturale. Ma
ambiente “naturale”, per l’ uomo, non è la selva, né la “natura” (errore rousseauiano): l’ ambiente
proprio del bambino è la sua casa: e la sua scuola dovrà perciò essere una scuola materna, che riviva
lo spirito e le forme della vita di famiglia. Ora, “che si fa in una famiglia? Ci si muove, si lavora, si
discorre, ci si lava di frequente, si mangia, qualche volta ci s’ inquieta per un incidente; in famiglia
ci si vuol bene e si procura di aiutarci vicendevolmente”: così si farà anche a scuola, vivendo la
famiglia reale nella forma di una famiglia ideale, traducendo in termini d’ educazione la vita
naturale e quotidiana del bambino”. La consapevolezza della centralità del bambino “integrale” nel
processo educativo, il rispetto dei suoi bisogni, dei suoi interessi, della sua creatività, in sintonia con
una avvertita coscienza sociale del disagio popolare, condussero Rosa Agazzi al superamento del
materiale froebeliano e del simbolismo dei doni. L’ esigenza era quella di non distaccarsi dalla
realtà, di servirsi di materiale “naturale”, di usare cose “vere”. L’ oggetto non può esser preordinato
dall’ adulto, non è di per sé educativo. E’ educativo se diventa strumento d’ educazione, se attrae l’
interesse del bambino ed offre occasioni all’ educatrice per stimolarlo, per svilupparne l’
immaginazione, l’ iniziativa, il senso pratico, ma anche la socialità. E se, come diceva Aldo Agazzi,
l’ educazione non deve essere mai o solo intellettuale, o solo sensoriale, o solo manuale … ma
sempre educazione totale, è certo che, tra le direttrici della proposta pedagogica di Rosa Agazzi, c’
è la consapevolezza che “Non si arriva allo spirito infantile se non passando per le vie dei sensi”,
assieme al rifiuto di ogni finzione e di ogni precostituzione, nell’ esigenza di mostrare le cose nella
loro realtà. Il bambino come spontaneità vivente e assoluta in autoedificazione, in libertà fra le cose
e con le cose, è la garanzia che l’ educazione sensoriale non diventi fine a se stessa, che i sensi
debbano essere educati per i sensi. Il “museo” agazziano è costituito di materiale naturale e
spontaneo. E non può esser precostituito, come non può esser precostituita la vita. E’ un museo non
da contemplare ma da usare. Ecco il “museo agazziano delle cianfrusaglie”, il “materiale agazziano
senza brevetto”: ed ecco, dice Rosa Agazzi, “come intendo il museo didattico”. Si tratta del
materiale secondo gli interessi infantili, accertati e puntuali senza errore, come lo procura il
bambino stesso; un museo non museo, di cose vive e vivificanti; usato ai fini educativi, ossia di
attivazione dei processi di sviluppo e di spiritualità del bambino medesimo”. Attraverso il
superamento del simbolismo e dell’ artificiosità dei doni dei giardini d’ infanzia froebeliani, Rosa
Agazzi propose procedimenti naturali e spontanei che avrebbero consentito l’ elaborazione di
concetti simbolici e ideali, nati però dalle cose concrete. La certezza sottintesa era che le “cose
vere” precedono le immagini e non viceversa. Ecco la riscoperta del metodo oggettivo, che parte da
cose non isolate ma da percezioni d’ insieme. Questa, almeno, è la tesi di Aldo Agazzi al riguardo:
rifiuto della discriminazione sensoriale e affermazione del principio globalistico. Cui Roberto
Mazzetti oppone che, accanto ad una “preoccupazione di concretezza, di aderenza al mondo
infantile e popolare”, nella educazione sensoriale agazziana emerge anche “una preoccupazione
persino eccessiva, di ordine discriminativi sensoriale e logico, che va oltre l’ intento educativo, in
quanto non si adegua ai tempi e ritmi molteplici dell’ apprendimento, ovvero al livello di maturità
dei bambini”. Rosa Agazzi sosteneva, comunque, che “Quando il metodo oggettivo insegnò all’
educatore che le cose, nella scuola, hanno la virtù di sostituirsi a molte parole e sono a queste utile
sussidio nella formazione delle idee, si sentì la necessità del museo scolastico”, nella certezza che
“il mondo esterno deve essere stimolo all’ osservazione, al pensare, al parlare”, e il museo può
suscitare la curiosità del bambino come “ricerca della vita delle cose, perciò ginnastica di
osservazione suscitatrice di confronti, di giudizi, di associazioni di idee”. Rosa Agazzi intendeva
superare il materiale “formalistico” froebeliano e voleva ampliare il metodo operativo. Ella era
convinta che l’ educatrice debba suscitare una progressiva, “salutare” confidenza delle cose con l’
uso del museo e che gli esercizi possono essere rivolti a finalità linguistiche, affettive, igieniche,
estetiche o propriamente sensoriali. Non si tratta, è bene sottolinearlo, di mera educazione all’ uso
dei sensi. La concretezza non si risolve nella sensorietà e nella positività del materiale. Concretezza
interiore anzitutto: la sensorialità alimenta la spiritualità e concorre a formare la persona. Il lavoro
manuale nella scuola infantile ed elementare è un tema che ricorre in tutte le opere di Rosa Agazzi.
Ne “L’ arte delle piccole mani”, pur muovendosi ancora nell’ ambito del “lavoro manuale
educativo” di Froebel, ella ne coglie già l’ inadeguatezza e per questo pensa al gioco-lavoro. Esso si
avvale delle cose semplici e naturali. E’ il lavoro effettivo, funzionale all’ educazione intellettuale,
sociale e morale, di cui ella tratterà ampiamente nella “Guida per le educatrici dell’ infanzia”. Il
principio del lavoro froebeliano era adattato all’ ambiente popolare e rurale, e il gioco dello stesso
Froebel era sottratto alla degenerazione di giardini d’ infanzia del tempo, in cui si alternavano
disimpegno, disattenzione ed esercizi ripetitivi. Ha ragione Aldo Agazzi, quando scrive che “lo
spirito di Mompiano, ispirato alle forme schiette, immediate, naturali del bambino nella concretezza
del suo ambiente sociologico, quali venivano da lui vissute nella sua vita e nelle attività quotidiane
effettive della sua famiglia e del suo gruppo sociale, operava anche nell’ ambito del “lavoro
manuale educativo”, che, nato a spunti froebeliani, diventava, proprio nella scuola materna
agazziana, “lavoro effettivo”, secondo possibilità e caratteri infantili, nelle forme degli “esercizi di
vita pratica” del giardinaggio, e di una operosità multiforme”. Negli anni successivi all’ esperienza
di Mompiano, Rosa e Carolina Agazzi avrebbero collaborato assiduamente con Pietro Pasquali a
Ripatronsone come insegnanti pratiche di lavoro, in vista del suo obiettivo prioritario: l’
inserimento del lavoro manuale nella scuola elementare e del coordinamento con l’ asilo infantile.
Tra l’ altro, a Trieste, nel 1910, le Agazzi furono calorosamente invitate dal Comune per avviare la
riforma degli asili cittadini. E qui proprio Giuseppe Lombardo Radice restò entusiasta del metodo
che ebbe modo di conoscere per la prima volta proprio in quella occasione.
42 /
Rosa Agazzi (4)
Rosa Agazzi, con la sorella Carolina, innovò in modo originale, all’ inizio del nuovo secolo, il
metodo di Froebel e l’ asilo di Aporti per l’ educazione infantile, valorizzando il gioco e il lavoro
manuale nella loro creatività ed espressività. Il gioco è l’ attività più caratteristica del bambino e
nelle Agazzi assume un significato fortemente educativo, che supera la semplice ricreazione o il
divertimento fine a se stesso. Gioco-lavoro, gioco-lingua, gioco-socialità: variano i contenuti ma la
scuola materna delle Agazzi è fondamentalmente scuola di gioco perché il gioco permette di
esprimere il bambino per quello che è: immaginazione, affettività, fantasia. Con le opportunità
educative offerte dal gioco, l’ operosità infantile viene finalmente rivalutata. Il lavoro-gioco è
momento fondamentale di educazione sociale, morale, intellettuale, artistica e religiosa. Attraverso
il gioco si può conseguire l’ ordine – autonomo ma non imposto, interiore e conquistato
progressivamente – come voleva Pietro Pasquali. Il bambino conquista il concetto dell’ ordine
tramite il confronto con il disordine. La scuola agazziana è scuola di libertà nell’ ordine, libertà con
le cose e per le cose, libertà di movimento e spontaneità nell’ ordine: libertà d’ iniziativa,
occupazioni libere e individuali, seppur guidate dall’ educatrice. Insomma, l’ ordine proposto e non
imposto, in tante occasioni, diventa progressivamente ordine interiore. Dall’ ordine delle cose all’
ordine di se stessi: non vi può essere coercizione ma obbedienza, non autoritarismo ma senso
interiore dell’ autorità. E come strumenti dell’ ordine, le Agazzi si servirono anche dei
“contrassegni”. In una “atmosfera permeata di sana libertà”, come sottolinea Giovan Battista
Carron, si attuano gli esercizi di socievolezza, partendo dalla situazione affettiva, propria e naturale
della vita e degli atteggiamenti infantili, per ordinare le manifestazioni naturali, per tradurle in
educazione. E scriveva Rosa Agazzi che “La scuola di grado preparatorio accoglie bambini che
vengono da diverse classi sociali. Si trova fra essi il buono, il meno buono, il dispettoso, il dociale,
il caparbio, il gentile per contratte abitudini familiari, il rozzo figlio della strada, il sudicio, il pulito,
il prepotente, l’ indifferente … e via sulla scala dei difetti naturali e acquisiti. Salta subito all’
occhio la necessità di creare intorno a questa massa eterogenea, ancora estranea all’ uso della
ragione, un’ atmosfera che sia per tutti respirabile, una atmosfera permeata di sana libertà in cui l’
arte della educatrice, infiltrandosi nel gioco, mira a raggiungere un primo stato di equilibrio fra le
varie manifestazioni di vita, condizione questa indispensabile nella preparazione dell’ ambiente
educativo. Si tratta di far giungere all’ animo infantile le prime sensazioni di una vita basata sull’
ordine, ovunque frutto di tolleranza, di generosità, soprattutto di reciproco rispetto …
“socievolezza” qui è un insieme di giuochi, esercizi, lezioncine occasionali diretti a stabilire
rapporti di affettività fra la piccola società infantile, unico plausibile punto di partenza per gettare i
primi rudimenti del diretto e del dovere”. Grande importanza assume, poi, la “socievolezza” ne “La
lingua parlata” (1910-1930), per la “grammatica infantile”, “grammatica senza grammatica”. Sin
dal Congresso pedagogico di Torino, Rosa Agazzi metteva in guardia contro formalismo e
mnemonismo linguistici, che, dal metodo dell’ Aporti – nel quale l’ educazione della lingua era
risolta in dialoghi preordinati – s’ era traslato nel froebelismo italiano. Ella invitava a privilegiare la
“libertà di parola”, la “lingua parlata” promossa attraverso la socievolezza. Riteneva fondamentale,
per questo, il ruolo dell’ educatrice: non servono né domande guidate né definizioni imparate a
memoria, occorre invece favorire l’ attività e la libertà dei bambini, che solo a tali condizioni
avvieranno una “conversazione animata”, nella quale l’ educatrice dovrà intervenire ripetutamente.
“La lingua – scriveva Rosa Agazzi – s’ impara ascoltando e parlando; si può anche aggiungere che
s’ impara osservando. Come prima condizione, dobbiamo avere una educatrice che sappia parlare
correttamente e sappia farsi ascoltare. Farsi ascoltare, nel nostro caso, significa rendere intuitiva la
parola per via della dizione chiara, espressiva. Però non basta saper parlare; bisogna anche saper
indurre a parlare il bambino stesso. Vi sono scuole, speriamo siano poche, in cui questo esercizio si
riduce ad una semplice espressione affermativa o negativa, rappresentata da due monosillabi: “si!
no!” oppure da due parole: “sissignora! Nossignora!”. Altrove, invece, si scopre un altro difetto:
maestra e bambini vanno a fare a chi più discorre; quella, filando via dirtto colla sua lezione, questi
infilzando spropositi che nessuno si dà cura di raccogliere e correggere. In ambedue i casi, ognuno
vede che la lingua non si può apprendere. La lingua, per chi la osserva sotto l’ aspetto formativo, è
un complesso di elementi ciascuno dei quali aspira a trovare nel discorso il posto che la logica gli
assegna. E’ compito dell’ educatrice prendere questi elementi, uno per uno, e saperli presentare al
bambino sotto una forma puerile, ma intuitiva, affinché li osservi, se li renda familiari e, mediante
speciali esercizi, impari a collocarli nell’ infantile linguaggio. Quando l’ educatrice sa fare questo,
fa della grammatica senza grammatica”. Gli esercizi di nomenclatura sono inutili, bisogna che il
bambino sia posto nella condizione di esprimere liberamente e spontaneamente il proprio pensiero,
attraverso l’ osservazione delle cose e dei rapporti tra le cose. “Non le cose senza le azioni” e “non
le parole senza le cose e le azioni”. La lingua è strettamente legata al gioco, agli esercizi di vita
pratica, al canto e così via. Educazione intellettuale, senza insegnamento della lettura e della
scrittura, ma lingua vincolata all’ esperienza del bambino. Gli stessi esercizi proposti da Rosa
Agazzi, le “lezioncine”, è lei stessa a dirlo chiaramente, hanno solo senso come esempio e valore
analogico. Contro ogni metodismo, deve prevalere sempre l’ attività spontanea riguardo a quella
intenzionale e guidata. “Io non vorrei si dicesse che il metodo Agazziano è un complesso di lezioni
di lingua parlata, bensì una fonte sempre viva di mezzi ricreativi e pratici che allenano il corpo, la
mente e lo spirito educandoli e preparandoli alla vita” scriveva Rosa Agazzi alla direttrice di un
corso per tirocinanti nel 1930. D’ altra parte, la teoria linguistica, i principi generali che sorreggono
“La lingua parlata”, pur non emergendo che a tratti, episodicamente, saltuariamente, mostrano di
esser vincolati alla concezione generale dominante in quegli anni, empiristica-positivisticaoggettivistica-intellettualistica (fondata su motivazioni fisiologiche e psicologiche). Ma si tratta di
un vincolo più nominale che reale, giacchè la fecondità didattica della Agazzi emerge anche in
ambito linguistico, nell’ acutezza con cui sono còlti i principi dell’ apprendimento e non vi è dubbio
che l’ influenza delle concezioni dominanti dell’ epoca sia riscattata dalle soluzioni della didattica e
della fidassi agazziane, perché, come ha sostenuto Aldo Agazzi, “riapprovano ai processi naturali
dell’ espressione parlata”. Più in generale, la proposta educativa di Rosa Agazzi è rivolta alla
socievolezza come socialità da intendersi quale fondamentale senso della comunità, nella generosità
e nel rispetto reciproci, nell’ affettività e nella gentilezza. La libertà si costruisce con l’ inserimento
del bambino nella comunità, con la coscienza dell’ appartenenza ad una comunità di cui si sente
parte integrante. L’ educazione alla socialità è profondamente morale perché l’ inserimento nella
comunità è acquisizione delle forme che ne regolano la vita. E’ accettazione del proprio ruolo al suo
interno, della propria personalità in svolgimento con altre personalità in pari dignità. I sentimenti di
lealtà, fratellanza, bontà, sono alimentati, per superare l’ originario egocentrismo, in vari modi,
attraverso il gioco, con “lezioncine”, con i “tutori”. Le linee delle Agazzi e di Pasquali ebbero
notevole rilievo nei nuovi programmi presentati nel 1914 dal ministro giolittiano Credano. Dopo la
Grande Guerra, l’ Opera nazionale per l’ assistenza all’ Italia irredenta, le cui finalità erano rivolte a
promuovere una educazione italiana per le minoranze, invitò le due sorelle nel trentino e nell’ Alto
Adige, ove governatore era lo stesso senatore Luigi Credano. E con la pedagogista Formiggini
Santamaria, fu attribuito a Rosa e Carolina Agazzi il compito di formare le maestre dei giardini d’
infanzia. Un’ opera instancabile la loro, se è vero che, ottacinquenne, Rosa diveniva direttrice della
Scuola materna di Volongo (Cremona -. Carolina sarebbe morta a Volongo nel 1945. Nel 1951
moriva anche Rosa. I decenni che ci separano dall’ esperienza agazziana hanno registrato un
notevole sviluppo delle tematiche e delle esperienze della pedagogia infantile. La sperimentazione e
l’ innovazione hanno arricchito e affinato la didattica con acquisizioni scientifiche e consapevolezze
educative. Ma da Rosa e Carolina Agazzi giunge tuttora un valido messaggio, laddove soprattutto
valorizzano il prezioso e delicato lavoro dell’ educatrice, chiamata ad osservare, conoscere,
studiare, valorizzare il bambino nelle sue potenzialità di persona umana. Come ha scritto Sira
Serenella Macchietti, “Secondo Rosa Agazzi, “è l’ incontrastabile individualità del bambino”
(“germe vitale che aspira al suo armonico sviluppo”) che impone all’ educatrice di attingere da se
stessa quanto occorre per farlo crescere sano, robusto, intelligente, buono, per prepararlo a vivere in
casa e “fuori”, per promuoverlo e per “orientarlo alla maturazione morale e culturale” e per
progettare e realizzare “un sistema” di educazione “pratico e razionale”. Pertanto si impegnò per
definire e organizzare un sistema educativo che ella chiamava “esperimento” alla cui base c’ era la
consapevolezza del fatto che il bambino ha bisogno di stare bene, di provare la gioia di vivere e
chiede un clima di affettività e di gioco, di essere accettato, amato, ascoltato per quello che è, per la
cultura di cui è portatore, di essere sostenuto nella crescita, nella maturazione della propria identità,
nella conquista dell’ autonomia, della sicurezza, nell’ affermazione del proprio io, nella
soddisfazione delle esigenze di reciprocità e di solidarietà”. La riscoperta e la valorizzazione
contemporanee del ruolo dell’ affettività nell’ educazione infantile confermano l’ intuizione
agazziana che il primario e insostituibile ruolo dell’ educatrice non si risolve in una mera
conoscenza teorico-scientifica della psicologia dell’ età evolutiva, seppur essa sia indispensabile.
Per il resto, se ci si interroga sull’ eredità delle Agazzi, si conferma la perennità di uno stile e di un
approccio educativo, più che di un metodo in senso stretto e prescrittivo.
43 /
Bernhard Bolzano (1)
Bernhard Bolzano restituì a Edmund Husserl, il fondatore della fenomenologia, il senso logicooggettivo dell’ esperienza. Un’ eredità kantiana e post-kantiana. L’ esperienza, in una tale
prospettiva, è valida indipendentemente dalla soggettività. L’ “inseità” delle verità logicomatematiche era il punto fermo di Bolzano. La sua riflessione logico-matematica – secondo la
lezione di Leibniz – lo induceva ad occuparsi di verità ideali, in sé e per sé sussistenti. La logica si
poneva, secondo lui, come una pura scienza teoretica. Nella quale la conoscenza “a posteriori”,
derivante dall’ esperienza, non ha alcun rilievo. Bolzano divergeva tanto dallo psicologismo di
Friedrich Eduard Beneke e James e John Stuart Mill, quanto dall’ herbartismo. (Johann Friedrich
Herbart aveva affidato alla filosofia il compito di sistematizzare in modo coerente i concetti, così da
superare la contraddizione “eleatica” tra le forme logiche del pensiero e il divenire-fluire delle cose
e concepiva la logica come “arte” del pensiero). La logica era, secondo Bolzano, una scienza
puramente formale e dai suoi principi del tutto oggettivi dovevano scaturire deduzioni del tutto
oggettive. La “verità in sé” dev’ esser separata e distinta dalla “verità per me”. La “verità in sé” è
tale anche se nessuno l’ ha ancora pensata. Le verità matematiche sono già, di per se stesse, verità,
ancor prima che qualcuno le abbia formulate e trasposte sul piano formale. Sostenere l’ esistenza di
un “insieme infinito” non è assurdo. Gli insiemi hanno una esistenza oggettiva e non sono
“costruzioni” della mente. Precursore e precorritore di coordinate fondamentali della logica
contemporanea, Bolzano espresse le sue intuizioni sulla logica e sulla metodologia della matematica
con lucida chiarezza e straordinaria semplicità. Carlo Cellucci, nell’ introduzione all’ edizione
italiana della breve opera di Bolzano: “Del metodo matematico”, ha evidenziato l’ attenzione che
egli dedicò al “doppio volto” delle proposizioni. Un conto è che siano pensate o asserite da un
soggetto razionale e pensante; altro conto è la loro “inseità-perseità”, del tutto slegata da un
intelletto che le pensi e le enunci verbalmente. Giacchè, soltanto e propriamente in questo secondo
stato, esse appartengono al dominio della scienza matematica. Le proposizioni, nella “dimensione”
matematica, sono ordinate deduttivamente e gerarchicamente.
Sconosciuto ai contemporanei, Bolzano acquisì notorietà, sul finire dell’ Ottocento – il secolo della
“metafisica del calcolo infinitesimale”, dell’ intensa riflessione sui principi –, in virtù della
rivalutazione operatane da Georg Cantor (che lo definì “un matematico e filosofo … estremamente
acuto” e giudicò “I paradossi dell’ infinito” uno “splendido e profondo trattato”) e Edmund
Husserl, il fondatore della fenomenologia, una delle più feconde e versatili filosofie del Novecento.
Costoro lo “convocarono” e lo “interpellarono”, il primo, per la questione dei fondamenti della
matematica, dell’ analisi infinitesimale e della teoria degli insiemi, e, il secondo, per l’
intenzionalità della coscienza e i suoi “vissuti”, per gli atti con cui la coscienza si dirige verso i suoi
oggetti. Edmund Husserl avrebbe ripreso il concetto di intenzionalità della coscienza da Franz
Brentano, rifiutando però lo psicologismo, che riduce l’ atto conoscitivo alla dimensione psichica
soggettiva e riferisce, dunque, la conoscenza – anche quella matematica, logica ed etica – al piano
meramente psicologico. Proprio avvalendosi dell’ apporto logico-oggettivo di Bolzano ( e di
Friedrich Ludwig Gottlob Frege), Husserl evitò il riduzionismo psicologistico-soggettivistico cui lo
esponeva Brentano. Il problema delle “Ricerche logiche” (“Logische Untersuchungen”, 1900-1901)
di Husserl, sarebbe stato quello di evitare tanto lo psicologismo quanto il logicismo, per giungere
alla tesi di una “correlazione universale”. Secondo la quale vi è un rapporto determinato tra un
determinato atto conoscitivo (soggettivo) e un determinato oggetto. Per cui, agli oggetti logici o
matematici, corrispondono dei “vissuti” (“Erlebnisse”), degli atti conoscitivi soggettivi, che sono
ben diversi da quelli che si relazionano, ad esempio, al percepito o al ricordato … Husserl avrebbe
identificato la logica pura e la matematica, distinguendo tra la logica formale (che si occupa delle
condizioni formali di validità degli asserti scientifici all’ interno delle teorie) e la logica
trascendentale (che si occupa della possibilità delle teorie). Husserl riconobbe esplicitamente il suo
debito nei confronti di quell’ istanza logico-matematica che gli proveniva da Bolzano e che gli
avrebbe evitato di cader preda dell’ ontologia di Brentano, consentendogli di sfuggire all’ univocità
dell’ ontologia (di stampo aristotelico) di costui. Paolo Bucci (“Husserl e Bolzano. Alle origini
della fenomenologia”) ha, del resto, notato come “il debito di Husserl verso … Bolzano vada ben
oltre i limiti di un < semplice > richiamo all’ oggettivismo logico …”, e si è occupato della
connessione tra le problematiche della fenomenologia e quelle logico-formali. Bucci rileva che,
quando oppone a Immanuel Kant la funzione metodologica della logica come scienza descrittiva di
nessi ideali-oggettivi, Husserl risente fortemente di Bolzano. La scienza è, per entrambi, una
“attività teoretica la cui finalità fondamentale è quella di esporre, per tramite di particolari processi
dimostrativi … “eziologici”, i nessi oggettivi che esistono fra le verità, intese … come dotate di
una sussistenza indipendente dai processi conoscitivi del soggetto”. Ma Bucci sottolinea anche che,
nel costruire la teoria dell’ intenzionalità della coscienza, Husserl deriva da Bolzano la tesi della
secondarietà del riferimento linguistico: i processi intenzionali non sono di natura linguistica e il
linguaggio non è altro che un loro strumento di manifestazione. L’ attitudine semantico-referenziale
non è intrinseca al segno. E’ l’ operazione intenzionale che “risveglia” l’ elemento segnicoespressivo.
Bolzano ha lasciato una traccia indelebile nella storia della matematica, della logica e dell’
epistemologia. Si inserì autorevolmente, anche se tardivamente, nel dibattito sull’ infinito e sulla
teoria degli insiemi, che contraddistinse il pensiero matematico nell’ Ottocento. La potenza
precorritrice delle sue idee lo sottrasse all’ oblio e all’ anonimato. Bernhard Placidus Johann
Nepomuk Bolzano era nato nel 1781 a Praga, da famiglia di origine italiana. Frequentò la facoltà di
filosofia dell’ università della città natale, dal 1796, e vi studiò filosofia e matematica. Si occupò di
teologia dal 1800. Fu ordinato sacerdote nel 1805 ed ebbe la cattedra di filosofia della religione
nella stessa Università. Nel 1804 aveva ottenuto il dottorato in geometria. “Der Binomische
Lehrsatz” è del 1816; “Ein Analytischer Beweis des Lehrsatzes” è del 1817. E’, quest’ ultimo, un
aureo libretto, rimasto misconosciuto ai contemporanei. Dopo le “Réflexions sur la métapsysique du
calcul infinitésimal” di Lazare Carnet, la “Thèorie des fonctions analytique” di Joseph Louis
Lagrange e il “Cours d’ analyse” di Augustin Louis Cauchy, offriva un’ introduzione breve ed
incisiva alla continuità delle funzioni, alla convergenza delle serie e all’ estremo superiore. Due
anni dopo, nel 1919, avrebbe perso la cattedra, dopo esser stato sospeso “a divinis”, con l’ accusa
di eresia (dovuta al suo modo di pensare all’ infinito). Ricomposta la contesa con il governo
imperiale asburgico, ottenne una pensione che gli avrebbe consentito di proseguire con tranquillità i
suoi studi attorno ad un’ esigenza fondamentale: dar densità e precisione al concetto di numero.
(anche se i suoi multiformi interessi spaziarono – accanto alla logica e alla matematica – dalla
fisica all’ estetica, dalla filosofia alla sociologia). Non vi è dubbio, comunque, che la condanna
ostacolasse la pubblicazione e la diffusione dei suoi lavori. Delle sue due maggiori opere, la prima,
“Paradoxien des Unendlichen” (“I paradossi dell’ infinito”), uscì postuma nel 1851, per l’
interessamento di un suo allievo e buon amico, F. Prihonsky, e non nella stesura definitiva che
Bolzano avrebbe voluto darle, anche se lo stile è, come di consueto, puntuale, rigoroso, chiaro,
distinto e preciso; l’ altra, la “Teoria della scienza” (“Wissenschaftslehre”), era stata data alle
stampe, in prima edizione, soltanto nel 1837. Bolzano morì nel 1848 a Praga. Le piste tracciate ne
“I paradossi” per una teoria dell’ infinito matematico avrebbero largamente anticipato la teoria degli
insiemi, mentre la “Teoria” annuncia fortemente la logica simbolica-matematica. E vi si trova,
anche, una serrata critica allo spazio e al tempo come forme “a priori” della sensibilità, oltre che
alla teoria del giudizio di Kant, di cui modifica profondamente il costruttivismo. La logica era da
intendersi, secondo lui, come rigorosa e pura scienza teoretica e il suo oggetto andava colto
formalmente e costruito deducendolo dai principi logici. La logica pura è la dottrina dei fondamenti:
essa costituisce l’ architrave del sistema delle scienze, e consente l’ euristica (la ricerca della verità)
e la gnoseologia (l’ interrogazione sulle condizioni di conoscibilità della verità). E’ certo che la
riflessione di Bolzano costituisce uno snodo e un momento cruciale nel dibattito che il Settecento
aveva avviato in sordina sul calcolo infinitesimale. Un impiego approssimativo delle quantità
infinite e infinitesime, e le generiche nozioni di infinito e infinitesimo, rischiavano di trascinare quel
dibattito nelle secche. Bernhard Bolzano, come del resto Augustin-Louis Cauchy, disse una parola
chiara sui limiti e sulle derivate. E mentre Cauchy, con Georg Riemann, formalizzava il calcolo
integrale, ed un’ operazione analoga compivano Karl Theodor Weierstrass e Julius Dedekind
riguardo ai numeri reali, il Novecento vide la conferma dell’ analisi nei confronti del ricorso agli
infinitesimi. E non vi è dubbio che il Novecento, come del resto l’ Ottocento, di fronte ai
sommovimenti tellurici della riflessione matematica, sia stata l’ età della filosofia della matematica .
I progressi della matematica non hanno mai avuta una accelerazione come negli ultimi due secoli.
Gabriele Lolli (del Dipartimento di Matematica dell’ Università di Torino) ha sostenuto (ne “La
questione dei fondamenti tra matematica e filosofia”) che “Solo di recente (dall’ Ottocento in
avanti) la filosofia si è posta anche, o piuttosto, il compito di intervenire sulla matematica, fornendo
per essa giustificazioni, o addirittura correttivi, necessari a ripristinare la fiducia nella sensatezza e
nella validità della produzione matematica (oppure al contrario a sanzionarne la negazione). La
svolta è avvenuta soprattutto in conseguenza e sotto l’ influsso, questa volta, di quanto accadeva nel
campo matematico, che non poteva più essere ignorato”. Certamente, ricorda Lolli, l’ ontologia si è
sempre chiesta di quale natura fossero gli enti matematici, mentre la teoria della conoscenza si è
interrogata sul fondamento di verità delle teorie matematiche. Ma la storia della matematica insegna
che vi sono periodi di crisi e periodi di rigore, e, nella sua “Filosofia della matematica”, Lolli ha
sottolineato che proprio la crisi genera “nuova matematica”, superando le tenaci resistenze dei
dogmatismi filosofici, e che, nelle crisi delle certezze matematiche, la filosofia trova alimento per
fecondi interrogativi e profondi ripensamenti. Così, ad esempio, scrive Lolli, “Gli evanescenti
infinitesimi che erano all’ origine del calcolo infinitesimale non hanno superato le obiezioni di chi,
come il vescovo Berkeley, vedeva in essi i fantasmi di quantità trapassate. Ma il calcolo
infinitesimale è andato avanti, confidando nella sua versione algebrica, e nelle sue regole di calcolo,
fino a che gli infinitesimi sono stati eliminati dalla definizione di limite di Cauchy e anche come
terminologia da quella di Weierstrass (per poi resuscitare negli anni Sessanta del Novecento con l’
Analisi non standard, prodotto della logica matematica)”. Su di una cosa, comunque, Lolli non ha
dubbi: all’ inizio della storia degli insiemi infiniti, e di un nuovo modo di “fare matematica”, che ha
prodotto anche una nuova filosofia della matematica, ci sono i “Paradossi dell’ infinito” di Bernhard
Bolzano. “Lo vedo ma non ci credo” avrebbe poi esclamato Cantor di fronte alle proprie strabilianti
e inattese scoperte.
44 /
Bernhard Bolzano (2)
Bernhard Bolzano seppe superare, da solo e senz’ altro ausilio che la propria acuta e profonda
razionalità, quell’ atavica “paura dell’ infinito” che, secondo Georg Cantor (“Gesammelte
Abhandlungen”, 1932), “è una forma di miopia che distrugge la possibilità di vedere l’ infinito
attuale, anche se questo nella sua forma più alta ci ha creati e ci mantiene, e nelle sue forme
secondarie di transfinito è presente intorno a noi e popola persino le nostre menti”. Pensare l’
infinito e all’ infinito non è facile. La via che ci può condurre a un tale concetto è costellata di
“ostacoli epistemologici” ed è irta di “misconcetti”. Se n’ è occupata, con approfondita attenzione,
Silvia Sbaragli, che ha indagato le erronee immagini mentali che condizionano la didattica della
matematica ai vari livelli scolastici e formativi. La Sbaragli si è interrogata, per intenderci, nella sua
tesi di dottorato di ricerca, su “Le convinzioni degli insegnanti sull’ infinito matematico”,
avvalendosi delle indagini di G. D’ Arrigo, B. D’ Amore (“Lo vedo ma non ci credo …”, 1999,
2002) e G. Brousseau (“Ostacles Epistemologiques en Mathématiques. Recherches en didactique
des mathématiques”, 1983 ; «Fondements et méthodes de la didactique de mathématiques.
Recherches en didactique des mathématiques », 1986). Un possibile « misconcetto » è, ad esempio,
quello della “dipendenza”, secondo la quale « vi sono più punti in un segmento più lungo rispetto
ad uno più corto ». Una tale misconcezione “deriva dal modello intuitivo di segmento concepito
come una fitta “collana di perle” dove i punti sono concepiti come perline”. Del resto, l’ intuizione
prigioniera del senso comune d’ aristotelica memoria, può giocare un ruolo negativo anche nella
didattica delle scienze fisiche. Attesta Andrea Frova (ordinario di Fisica generale presso l’
Università “La Sapienza” di Roma) in “Parola di Galileo”, che il principio d’ inerzia è un “Concetto
così rivoluzionario che ancor oggi fatica a penetrare le menti dei profani, come indicano certi
sondaggi fatti tra i nuovi iscritti al corso di laurea in Fisica, i quali in proposito rivelano di nutrire,
in due casi su tre, concezioni pre-galileiane”. Secondo Aristotele, e il senso comune, per garantire la
conservazione del moto e assicurare la velocità iniziale, è necessaria una forza di spinta, o qualche
altra causa. Ma una volta che un corpo sia in moto – preciserebbe Galileo –, se la risultante delle
forze (agenti o resistenti) che su di esso agiscono, è nulla, esso conserva la sua velocità. Resta
comunque vero, per dirla con David Hilbert, che, se l’ infinito ha sollecitato così fecondamente,
come mai nessun’ altra questione, la mente umana, nessun concetto più di esso esige
“chiarificazione”. Gli stessi matematici che oggi manipolano con abilità le acquisizioni
contemporanee sull’ infinito (matematico) non si esimono da rimandi “lirici” e metafisici che
rivelano una irriducibile reverenza nei suoi confronti. Potremmo evocare Bernardino Telesio, sia
pur impropriamente: l’ infinito profuma comunque d’ eternità, anche quando è “determinato” e
“definito” da teorie, postulati e dimostrazioni. Fra i matematici c’ è chi cita Robert Ghattas (“Dio
ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell’ eternità nel loro cuore, senza
però che gli uomini possano capire l’ opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Ha concluso che
non c’ è nulla di meglio per essi che godere e agire bene nella loro vita”); c’ è chi evoca Søren
Aabye Kierkegaard (“L’ infinito e l’ eterno sono l’unica certezza”); c’ è chi ricorda Blaise Pascal
(“Vedo solo infinito da tutte le finestre”); ma non vi è dubbio che tutti sono consapevoli che
occuparsi dell’ infinito vuol dire camminare su un “terreno scivoloso” ed affrontare, ad ogni passo,
trabocchetti e paradossi. Del resto, anche soltanto sul piano divulgativo, la problematica legata all’
infinito intimorisce, ma nello stesso tempo affascina e intriga. Un viaggio nell’ infinito o intorno
all’ infinito, che si rivela stimolante a vari livelli è, ad esempio, “L’ infinito matematico tra mistero
e ragione. Intuizioni, paradossi, rigore” di Thérèse Gilbert e Nicolas Rouche. Ma la letteratura di
divulgazione sull’ argomento pone soltanto l’ imbarazzo della scelta. Qualche buon titolo: Aczel
Amir, “L’ equazione di Dio”; Giuseppe Arcidiacono, “Zero, Infinito, Immaginario”; John D.
Barrow, “I numeri dell’ universo”; Nicholas Falletta, “Il libro dei paradossi”; T. Gilbert e N.
Rouchet, “L’ infinito matematico tra mistero e ragione”; Kanigel Robert, “L’ uomo che vide l’
infinito”; Paolo Zellini, “Breve storia dell’ infinito”. Che la natura dell’ infinito sia una sorta di
nodo gordiano, che porta con sé irresolubili paradossi e insuperabili difficoltà logiche, è questione
vecchia quanto la matematica e la filosofia. Bolzano, una tale questione, la prese di petto, si occupò
dei tipici paradossi dell’ infinito logico-matematico e propose un nuovo modo di considerarlo. Non
aveva alcun dubbio quando affermava, ne “I Paradossi dell’ infinito”, che le affermazioni
paradossali che incontriamo nella matematica sono in gran maggioranza proposizioni che
“contengono in modo immediato il concetto di infinito” ma non ignorava che filosofi come Hegel
fossero insoddisfatti dell’ “infinito dei matematici” e lo chiamassero “cattiva infinità”, intendendo il
“vero infinito” come l’ “infinito qualitativo”, da loro concepito “solo in Dio, e in generale nell’
Assoluto”. Una settantina di brevi ed acuti paragrafi costituisce i “Paradossi” (tradotti recentemente
in italiano da Alberto Conte, mentre una precedente edizione era a cura di F. Voltaggio). Come ha
evidenziato Francesco Armezzani, vi si enuncia, tra l’ altro, che l’ insieme delle proposizioni che
esprimono verità in sé, è infinito, e che i suoi elementi sono in corrispondenza biunivoca con i
numeri naturali del relativo insieme. Ogni oggetto appartenente ad un insieme corrisponde ad un
oggetto di un altro insieme. Dati due insiemi infiniti in relazione tra di loro, nessuno degli oggetti
del primo è senza relazione con un oggetto dell’ altro. Tra due insiemi infiniti vi può essere
corrispondenza biunivoca. Due insiemi infiniti possono però trovarsi in un rapporto di
disuguaglianza riguardo le rispettive moltitudini, per cui uno può essere una parte dell’ altro.
“Paradoxien des Unendlichen” puntualizza, sin dall’ inizio, concetti come aggregato, insieme,
moltitudine, somma, serie. In particolare, le serie prive di un termine ultimo sono infinite, e
“moltitudine infinita” è quella che è “costituita in modo tale che ogni insieme finito rappresenti
soltanto una parte di essa”. Il fatto è che una serie può esser così concepita: “Immaginiamo una
serie il cui primo termine sia un individuo della specie A, mentre ogni termine successivo viene
derivato dal suo antecedente prendendo un oggetto simile a esso e facendo in modo che quest’
ultimo formi una somma insieme con un nuovo individuo della specie A; mentre ogni termine
successivo viene derivato dal suo antecedente prendendo un oggetto simile a esso e facendo in
modo che quest’ ultimo formi una somma insieme con un nuovo individuo della specie A, risulta
perciò manifesto che tutti i termini che si presentano in questa specie, con eccezione del primo che
era un semplice individuo della specie A, sono moltitudini della specie A”. Tali moltitudini sono
“finite o numerabili” o ”più precisamente, numeri interi”. Ma allora le serie prive di un termine
ultimo sono infinite e “moltitudine infinita” sarà quella “costituita in modo tale che ogni insieme
finito rappresenti soltanto una parte di essa”. L’ infinito matematico è stato criticato da Hegel e da
altri, e non a torto, dice Bolzano. Se è vero che l’ infinito può esser concepito, semplicemente, come
quantitativo, diventa quello che Hegel chiama il “cattivo infinito”. Si tratta di una quantità che può
aumentare illimitatamente e indefinitamente, come la serie numerica. Ma Bolzano ammette che gli
insiemi infiniti sono possibili e, soprattutto, attuali. Indipendentemente dal pensiero e dalla sua
facoltà di rappresentazione. Esondiamo dal pensiero, proviamo a intendere entità da esso
indipendenti. Ci sono proposizioni che enunciano l’ essere o il non essere di qualcosa,
indipendentemente dalla loro verità o falsità, dal loro essere o non essere state pensate da una mente
umana. Ma poi, Bolzano afferma che se, tra due insiemi infiniti, i rispettivi elementi stanno in un
rapporto per cui ciascun oggetto della moltitudine del primo costituisce una coppia con un
corrispondente oggetto del secondo (in modo, però, che nessun oggetto di entrambi resti
“sconnesso” e solo, o si ripresenti più di una volta) non è necessario che i due insiemi debbano
essere eguali e non è escluso che l’ uno sia contenuto nell’ altro come una sua parte. L’ eguaglianza
vale per i sistemi finiti, non per quelli infiniti. E. d’ altra parte, è un grave errore assumere
grandezze definite come infinitamente grandi o piccole: è il caso dello spazio, del tempo, e della
forza. Muovendo dalla critica al tempo ed allo spazio come infiniti, Bolzano affronta i paradossi
dell’ infinito che la tradizione porta con sé, da Zenone eleatico e da Aristotele in poi. Se si assume
che il continuo (spaziale, temporale o materiale) non sia costituito da parti inestese e prive di
dimensioni, ma solo di parti estese, si cade inevitabilmente nei paradossi che scaturiscono dal
pensare l’ infinito. Consideriamo, invece, il continuo come costituito da parti semplici, inestese e
prive di discrezione l’ una dall’ altra. Un continuo non può esser concepito come aggregato di parti
semplici connesse le une alle altre. Le parti semplici, proprio perché semplici, non possono esser
costituite da parti. Per cui, sostenere che due corpi semplici sono a contatto, vorrebbe dire che
coincidono, e che non sono due ma uno. Un continuo deve essere omogeneo e non può quindi
essere considerato, semplicisticamente, come una somma-successione infinita di parti. Senza un
ordine di distanze degli infiniti punti, sarebbe disomogeneo e discontinuo. Bolzano distingue tra il
tempo eterno (come insieme infinito degli istanti) e il tempo finito che intercorre tra due determinati
istanti. I singoli istanti sono la misura delle variazioni delle sostanze create, prive di realtà in se
stesse. Dio è eterno e il tempo in Lui corrisponde all’ essere sempre presente senza mutamenti e
variazioni. Bolzano affronta, poi, con la “profondità speculativa” che lo contraddistingue
(Francesco Armezzani), i paradossi ricorrenti attorno allo spazio infinito. Nota Armezzani che “I
paradossi più diffusi riguardanti lo spazio sono tre. E’ giudicato paradossale che 1) molte estensioni
che si diffondono nello spazio infinito abbiano tuttavia una grandezza soltanto finita; 2) molte
estensioni che sono limitate da una regione di spazio del tutto finita abbiano tuttavia una grandezza
infinita; infine che 3) molte estensioni spaziali conservano una grandezza finita nonostante si
avvolgano infinite volte intorno ad un punto. Per quanto riguarda il punto 1) è chiaro che una retta
infinita è una grandezza infinita mentre nel caso delle superfici che hanno lunghezza e anche
larghezza infinita si dimostra che esse possono nondimeno avere grandezze finite. Immaginiamo
lungo una retta infinita di riportare all’ infinito segmenti di lunghezza 1 e sul primo segmento di
formare un quadrato, sul secondo un rettangolo di altezza pari alla metà del primo e sugli altri
segmenti altri rettangoli di altezza metà del precedente: ben presto giungeremo a immaginare una
figura di superficie infinita di area tuttavia non superiore a 2; per quanto riguarda il punto 2) si vede
come una figura spaziale limitata (finita) possa contenere al suo interno infinite rette e infinite
superfici e in maniera analoga vale la dimostrazione per il punto 3)”. Notevole è la riflessione di
Bolzano sull’ infinito materiale o delle sostanze, che lui definisce tanto fisico quanto metafisico.
“Se si prescinde – scrive Armezzani – dall’ insieme delle affermazioni sulla vera natura delle
sostanze create, che prendono in considerazione elementi di carattere ontologico e teologico e che
concludono di fatto l’ esposizione del trattato, Bolzano insiste in diversi luoghi sul carattere dell’
infinito come variazione continua dei corpi. Il tema della variazione continua della sostanza
materiale indica la natura altamente problematica e complessa del rapporto tra misurabilità e
identità dei corpi. La natura paradossale dell’ infinito diventa qui oggetto di approfondimento sulla
natura complessa e multiforme del finito e sulla sua irriducibilità a rappresentazioni oggettive
definitive, nemmeno delle parti semplici che compongono i corpi estesi. Il rifiuto da parte di
Bolzano di considerare le parti semplici come elementi immutabili, privi di vita, lo porta a criticare
la divisione cartesiana tra materia estesa e materia pensante e in generale a rifiutare la separazione
inconciliabile di anima e corpo”. E’ stato ripetutamente sottolineato che gli enunciati di Bolzano
non erano privi di incongruenze e carenze categoriali. Cantor notò, ad esempio, che Bolzano non
possedeva ancora il concetto di “cardinale” di un insieme. Resta, comunque, la “pietra miliare”
della corrispondenza biunivoca tra elementi di un insieme infinito e quelli di un suo sottoinsieme.
Per intenderci: l’ insieme dei numeri naturali e il suo sottoinsieme dei numeri pari, sono in
corrispondenza biunivoca. Uno rimanda a due, due rimanda a quattro, tre a sei, quattro a otto … E
poi (la cosa accade im matematica come in filosofia) la fecondità di un apporto si misura proprio
sulla sua problematicità: così Bolzano lasciò problemi irrisolti e da ripensare a filosofi, logici e
matematici del Novecento. Quanti sono – ad esempio – i numeri naturali? Se lo sarebbe chiesto
Georg Cantor.
45 /
Bernhard Bolzano (3)
Bernhard Bolzano soppesò l’ infinito matematico, lo svincolò dalle concezioni e dalle remore
tradizionali e, dischiudendo una nuova pista al Novecento logico, matematico e filosofico, conferì
all’ insieme infinito una realtà extramentale. Non vi sono, per la verità, oramai, operazione o
percorso matematico che non siano pervasi dall’ infinito. Bolzano volle restituire dignità a quel che
Aristotele chiamava l’ infinito in potenza ed Hegel la cattiva infinità, (in sostanza l’ indefinito della
serie matematica, ovvero quel “dover essere” che si pone sempre e comunque oltre l’ essere,
secondo Johann Gottlieb Fichte, in un progressivo ma inconcludente percorso di perfezionamento
morale) contrapponendolo all’ infnito in atto o Assoluto. Proprio muovendo da Bolzano, Georg
Cantor avrebbe sostenuto che “L’ infinito potenziale ha solo una realtà presa a prestito dato che un
concetto di infinito potenziale rimanda sempre ad un concetto di infinito attuale che lo precede
logicamente e ne garantisce l’ esistenza” (“Gesammelte Abhandlungen”, 1932). E precisava che “L’
infinito attuale si presenta in tre contesti: il primo è quello in cui si presenta nella forma più
completa, in un essere completamente indipendente trascendente questo mondo, in Deo, ed è questo
che io chiamo l’ Infinito assoluto; il secondo è quando si presenta nel mondo contingente, nel
creato; il terzo è quando la mente lo afferra in abstracto, come grandezza matematica, numero o tipo
d’ ordine”. Cantor evidenziò con chiarezza “la differenza tra l’ Assoluto e quello che io chiamo il
Transfinito, cioè l’ infinito attuale degli ultimi due tipi, poiché si tratta di oggetti evidentemente
limitati, suscettibili di accrescimento, e quindi collegati al finito”. Era da Bolzano che veniva a
Cantor l’ esigenza “di costruire il concetto di numero infinito attuale attraverso un’ astrazione
naturale opportuna, allo stesso modo che il concetto di numero naturale risulta dagli insiemi finiti
con processo di astrazione”. Bolzano, comunque, sostenne che le verità matematiche sono tali anche
se non sono state ancora formulate. Esse, dunque, non sono delle costruzioni mentali e la verità
matematica e scientifica deve essere svincolata dalla dimensione psicologica. “Esistono … insiemi
e totalità anche senza che ci sia un essere che li pensi” enunciava Bolzano, e aggiungeva che è
soltanto un pregiudizio credere che “un insieme infinito non può mai essere riunito a formare un
tutto, né può mai essere raccolto insieme nel pensiero”. Un tale pregiudizio, asseriva ne “I paradossi
dell’ infinito”, nasce dall’ errata convinzione che “per pensare un tutto consistente di certi oggetti a,
b, c, d, … ci si debba essere prima costruiti delle rappresentazioni mentali che raffigurano ciascuno
di questi oggetti separatamente”. Ma si consideri un insieme finito. Non occorre la rappresentazione
di ogni suo singolo termine. Si può pensare alla “totalità degli abitanti di Praga o Pechino” senza
essersi prima rappresentato ciascuno di essi, singolarmente. Per quanti essi siano – diecimila o dieci
milioni – posso asserire di essi enunciati veri. La rappresentazione di un insieme infinito non
richiede la rappresentazione preliminare di tutti i suoi singoli, e infiniti, elementi. “Già nel dominio
delle cose che non hanno alcuna pretesa di attualità e neppure persino di possibilità, ci sono
incontestabilmente insiemi che sono infiniti” e quindi “L’ insieme delle proposizioni e verità in sé è
… infinito; se infatti fissiamo la nostra attenzione su una qualunque verità, ad esempio sulla
proposizione: “ci sono verità”, o su una qualunque altra proposizione … e la indichiamo con A,
troviamo che la proposizione espressa dalle parole: “A è vera”, è diversa dalla proposizione A,
poiché quella ha manifestamente un soggetto completamente diverso da questa”. Per intenderci, il
soggetto di “A è vera” è tutta intera la proposizione A. E se dalla proposizione A s’ è derivata una
diversa proposizione, che chiameremo B, da B si può derivare una tera proposizione C, e così via …
all’ infinito. L’ aggregato di tali proposizioni – delle quali ciascuna susseguente sta con la
precedente come suo predicato e ne conferma la verità – è certo “un insieme di membri
(proposizioni) che è più grande di ogni insieme finito”. Della serie di tali proposizioni, Bolzano
nota la somiglianza con la serie dei numeri considerata: “una somiglianza che consiste nel fatto che
per ogni membro della seconda c’ è un membro della prima che gli corrisponde, nel fatto che per
qualunque numero intero, per quanto grande esso sia, c’ è un numero intero ad esso uguale di
proposizioni differenti”. E conclude che: “da ciò segue che l’ aggregato di tutte queste proposizioni
possiede una molteplicità che è maggiore di ogni numero intero, ed è quindi infinita”. Bolzano pose
il sostrato di quella “teoria degli insiemi” sulla quale Georg Cantor e Julius Richard Dedekind
avrebbero edificato la teoria dei numeri infiniti, feconda tanto nell’ area matematica quanto in
quella logica. Non vi è dubbio che Bolzano abbia posto capo ad una problematica complessa e,
apparentemente, senza soluzioni, svincolando il pensiero contemporaneo da una vessata questione
che si trascinava da secoli. Vi è chi ha parlato di “preistoria” della riflessione sull’ infinito,
coprendo, con questa espressione, tutti i secoli che, dalle origini della filosofia occidentale,
giungono sino all’ inquieto Settecento. Ed è vero che l’ “ápeiron” di Anassimandro di Mileto
intendeva essere un “arché” (Principio costitutivo, fonte e fine di tutte le cose) infinito, illimitato e
indeterminato. Secondo Talete, lo ionico maestro di Anassimandro, l’ “umidore” costituirebbe la
“physis” (liquida), la qualità-natura comune ed essenziale a tutte le cose. Ma, ad Anassimandro, che
il Principio fosse costituito da una determinata qualità, appariva riduttivo. E concepì un “á-peiron”
qualitativamente e quantitativamente in-determinato e il-limitato, che tutto abbraccia, governa e
regge. Tutte le cose ne sono de-limitazione e de-terminazione, e così come infinito è il Principio,
infiniti sono i mondi che sono, sono stati e saranno. Anassimene di Mileto volle far opera di
mediazione tra gli altri due milesii: il Principio deve essere, certo, infinito, ma non indeterminato, e
lo pensò come “pneuma” infinito. Si delineavano due modi di pensare l’ infinito: l’ uno come
indeterminato e incompiuto, e dunque negativo, l’ altro come comprensivo di tutte le qualità, e
dunque positivo. Pitagora di Samo intese il numero come Principio-Natura di tutte le cose,
osservando ovunque, negli eventi naturali, la regolarità e l’ armonia matematica. Il numero come
“physis” - nella sua primaria e massima concretezza – è la sintesi di due elementi, l’ uno
indeterminato e illimitato, l’ altro determinato e limitato. La serie numerica è quantitativamente
indeterminata e progressivamente si determina e si delimita. Nei numeri pari prevale l’ elemento
indeterminato, giacchè, si disponiamo per terra due sassi, la retta che passa in mezzo non viene
limitata. Al contrario, in un numero dispari, disposti a coppie gli altri sassi, ne rimane uno che,
collocato in mezzo ad esse, blocca la retta. D’ altra parte, se si aggiunge una unità, il pari diventa
dispari e il dispari diventa pari. L’ uno è “parimpari” e da esso provengono tanto i pari quanto i
dispari. Dieci sassi, disposti a formare un triangolo perfetto, costituiscono la “tetraktýs”. Tutto,
comunque, è rapporto di numeri naturali. Ippaso di Metaponto sembra abbia scontato con la vita la
sua scoperta della incommensurabilità della diagonale e del lato del quadrato: in quel caso il
rapporto non era esprimibile con un numero razionale. La razionalità si separava dall’ intuizione e
la pura intelligibilità degli enti matematici si andava imponendo e lasciava intravvedere l’ infinito.
Parmenide di Elea percorse l’ unica via alla Verità, quella del puro “Logos”, ed enunciò la teoria
dell’ essere: l’ essere è e il non essere non è, univocamente. Ingenerato, incorruttibile, immutabile,
immobile, extratemporale e privo di luogo, l’ essere di Parmenide è compiuto e perfetto, omogeneo
ed egualmente esteso in ogni senso, come una perfetta sfera. Nel suo Poema filosofico “Sulla
natura”, Parmenide scrive che l’ essere “ha un limite estremo, è compiuto in ogni senso, simile alla
massa di una sfera rotonda, di ugual forza a partir dal centro in ogni direzione; poiché non può esser
affatto più forte o più debole in un luogo che nell’ altro. Poiché non v’ è nulla, che gli impedisca di
estendersi ugualmente, né è possibile che vi sia più qui e meno là di essere, poiché è del tutto
inviolabile. Perché dove da ogni parte è uguale, ugualmente preme nei limiti”. Rodolfo Mondolfo,
autore de “L’ infinito nel pensiero dell’ antichità classica”, avvertiva che “La forma sferica,
attribuita … all’ essere, vuol significare la sua omogeneità e uguale estensione in ogni senso. Ma
questa uguale estensione, compiendosi “con ugual forza a partir dal centro in ogni direzione”, senza
che nulla possa impedirla o indebolirla in alcun punto, non può chiudersi in una sfera limitata, la cui
periferia segnerebbe un impedimento e arresto all’ estensione stessa e supporrebbe il non essere al
di là. Quindi la rappresentazione dell’ essere delineata da Parmenide è quella di una sfera infinita:
ossia ha un significato dinamico e non statico”. E che la sfera abbia un “limite estremo” non deve
essere inteso in senso spaziale: l’ essere è dominato dalla legge della Necessità o Moira, che lo
mantiene nei legami del limite. Melisso di Samo diede rigore sistematico all’ ontologia del
Maestro. Come ha scritto lo stesso Mondolfo (“Il pensiero antico. Storia della filosofia greco-
romana”) “Melisso abbandona il concetto della sfericità dell’ essere … (concetto che facilmente
suggeriva l’ idea di una limitazione); e passa alla infinità dell’ essere, sola conciliabile con l’ unità,
indivisibilità ed immobilità di esso. “Se dunque deve esistere, deve anche essere uno; e se dev’
essere uno bisogna che non abbia un corpo (delimitato):” scriveva Melisso, e aggiungeva: “… se
avesse uno spessore (limitato), avrebbe anche parti, e non sarebbe più uno. Ma inoltre nello stesso
modo che sempre è, così anche sempre deve essere infinito”. Infinità e unità sono connesse, come
emerge in Aristotele, per il quale, se l’ essere non fosse infinito, dovrebbe avere il suo limite nel
vuoto, che, al contrario degli atomisti Leucippo e Democrito, Aristotele nega recisamente. L’
“horror vacui”, il terrore del vuoto da parte degli elementi naturali, sostenuto dagli aristotelici, si
trascinerà sino alle soglie della prima Rivoluzione scientifica, nel Seicento. Melisso deduce l’ unità
dall’ immutabilità così come trae l’ infinità dall’ unità stessa. “E non potrebbe – scrive in un
frammento – perire né divenir più grande né ordinarsi altrimenti, né soffrire dolore o pena. Ché se
alcuna di queste cose gli accadesse, non potrebbe più esser uno. Perché se si altera, è necessario
che l’ essere non sia uguale, ma che perisca ciò che prima era e nasca ciò che non era. Ora se
mutasse in diecimila anni di un solo capello, perirebbe tutto quanto nella totalità del tempo”. E del
resto, aggiunge, “Se non fosse uno solo, dovrebb’ essere limitato da altro. Ché se è (infinito), dev’
esser uno; giacché se fossero due non potrebbero essere infiniti; ma avrebbero l’ uno il limite dell’
altro”. La teoria dell’ essere di Parmenide era una grande conquista per il “Logos”, ma non
giustificava ed anzi negava la molteplicità e l’ universale fluire delle cose. L’ opinione, che viene
dai sensi è ingannevole e lascia credere che “le cose sono nate ed ora esistono, e in seguito, a partir
da ora, dopo esser cresciute verranno a fine: a ciascuna di queste cose gli uomini hanno assegnato
un nome determinato”. L’ essere di Parmenide, appuntava Mondolfo, “non ammette distinzione di
passato e di futuro, di prima e di poi” e nel Poema si legge: “Né mai esso è stato né mai sarà, poiché
è, ora, tutto insieme, uno e continuo. Che specie di origine infatti cercheresti per lui? Come e donde
sarebbe cresciuto? Io non ti lascerò dire né pensare che venga dal non essere; perché non è possibile
dire né pensare che (l’ essere) non sia. E se venisse dal non essere, quale necessità l’ avrebbe
forzato a nascere prima o dopo? Così dunque o è necessario che sia del tutto o che non sia affatto.
Né mai la forza della verità permetterebbe a che che sia di nascere dal non essere accanto ad esso
…”. L’ unità dell’ essere, il principio dell’ unità permanente era una fondamentale acquisizione, ma
doveva esser conciliato con la molteplicità e il mutamento. Doveva esser, anzi, l’ uno dal quale
scaturiscono i molti e la ragione del loro divenire. E nonostante, Zenone d’ Elea difendesse le tesi
del maestro Parmenide con argomenti dialettici che contestavano movimento e molteplicità, altri
(Empedocle di Agrigento, Anassagora di Clazomene, Leucippo di Mileto e Democrito di Abdera)
“riformarono” l’ essere di Parmenide, fisicizzandolo. Ripensarono anche l’ infinito, la riflessione
attorno al quale sarebbe poi proseguita, nell’ età antica e medioevale, con Protagora di Abdera,
Gorgia di Leontini, Eudosso di Cnido, Aristotele di Stagira, Euclide di Alessandria, Archimede di
Siracusa, Tito Lucrezio Caro, Clemente Alessandrino, Diofanto di Alessandria, San Basilio Magno,
Sant’ Agostino di Tagaste, Proclo di Costantinopoli, Ruggero Bacone, Tommaso d’ Aquino,
Guglielmo d’ Ockham, Nicola d’ Oresme, Nicolò da Cues e numerosi altri. Un apporto corale, nel
quale prende progressiva consistenza la distinzione tra infinito matematico e infinito filosoficometafisico.
46 /
Bernhard Bolzano (4)
Bernhard Bolzano è tra coloro che, come Augustin-Louis Cauchy, Georg Riemann, Julius
Dedekind, David Hilbert, Karl Theodor Weierstrass e altri, hanno riformulato con precisione le
nozioni, sino ad allora scarsamente definite, di infiniti e infinitesimi, conferendo loro potenza ed
efficacia. Certamente, il punto di svolta nella comprensione e nella manipolazione teorica dell’
infinito è stato il Bolzano dei “Paradoxien des Unendlichen”, i “Paradossi dell’ infinito” (1851),
quando ancora nella stessa prima metà dell’ Ottocento, Georg Wilhelm Friedrich Hegel rifiutava la
“cattiva infinità” (l’ infinito matematico-potenziale di Aristotele), contrapponendole l’ infinito
qualitativo, l’ Assoluto. Bolzano sostenne che gli insiemi hanno esistenza oggettiva, extra-mentale.
Ne “I paradossi” poneva “la questione se non ci siano ai poli della terra corpi fluidi o solidi, se non
ci siano aria, acqua, pietre e simili, se questi corpi non agiscano l’ uno sull’ altro secondo
determinate leggi, ad esempio in modo tale che le velocità che essi si comunicano a vicenda nella
loro collisione siano inversamente proporzionali alle loro masse e simili, e se tutto questo non
avvenga anche quando non ci sia nessun uomo né alcun altro essere pensante ad osservarlo”. Se la
risposta è positiva, “allora ci sono anche proposizioni e verità in sé che esprimono tutti questi
avvenimenti, senza che ci sia nessuno che le pensi o che le conosca. E in queste proposizioni è
frequente la menzione di totalità e di insiemi; ogni corpo, infatti, è una totalità, e produce moltissimi
dei suoi effetti soltanto mediante l’ insieme delle parti da cui è formato. Esistono quindi insiemi e
totalità anche senza che ci sia un essere che li pensi”. Ed esistono insiemi infiniti. Bertrand Arthur
William Russell ha sottolineato ne “La saggezza dell’ Occidente” che “L’ infinità dei numeri aveva
provocato imbarazzo fin dall’ epoca di Zenone e dei suoi paradossi”. Zenone di Elea creò, come
attesta Aristotele, la dialettica, elaborando raffinati argomenti che intendevano dimostrare, con
rigore logico, l’ assurdità del mutamento e della molteplicità, così da sostenere l’ unità,
indivisibilità, omogeneità, immobilità, eternità dell’ essere di Parmenide. I paradossi di Zenone
contraddicevano “coloro che affermano la molteplicità degli esseri” e rendevano “loro la pariglia e
ancor più, volendo mostrare questo, che ben più ridicole conseguenze incontra la loro ipotesi che
siano i molti, che non quella dell’ essere uno, se ben si bada”. Così nel “Parmenide” di Platone. Ora,
secondo Pitagora, lo spazio vuoto tra l’ una e l’ altra cosa, è un ente reale. Obietta Zenone: “Se le
cose sono molte, è necessario che sian tante quante sono, e non più né meno di queste. Ma se sono
tante quante sono, sono in numero limitato. Se le cose sono molte, sono anche infinite: giacché
sempre ce ne sono altre intermedie fra gli enti, e di nuovo altre nell’ intervallo fra queste, e così gli
enti sono di numero infinito”. In secondo luogo, Pitagora concepiva il punto come indivisibile e
però dotato di grandezza. D’ altra parte, nella sua Scuola s’ era scoperta l’ incommensurabilità della
diagonale con il lato del quadrato: ma se il principio delle cose è numero, le cose dovrebbero essere
commensurabili con l’ unità, nota Rodolfo Mondolfo ne “Il pensiero antico. Storia della filosofia
greco-romana”. E aggiunge che della difficoltà “si era cercata una soluzione < come attesta
Aristotele > nella divisione progressiva delle grandezze incommensurabili, per vedere se si trovava
nell’ infinitamente piccolo o infinitesimo una unità di misura comune. Attraverso questi tentativi si
arrivava al concetto di infinitesimo, tanto piccolo che aggiunto non accrescerebbe e tolto non
diminuirebbe la grandezza. Ma al tempo stesso questa grandezza risultava composta di una somma
di tali particelle minime, alle quali perveniva il processo divisorio: quindi la contraddizione che
Zenone attacca con la sua “aporia” (difficoltà)”. In sostanza la contraddizione è tra la grandezza
infinita e la piccolezza infinita nel molteplice costituito di parti. Dice Zenone: “Se l’ unità non
avesse grandezza non esisterebbe neppure. Ma se esiste è necessario che ogni (parte del molteplice)
abbia una certa grandezza e un certo spessore, e che l’ una sia a una certa distanza dall’ altra. E lo
stesso discorso può ripetersi per quella che le sta dinanzi. Perché essa pure avrà una grandezza, e ci
sarà qualcosa dinanzi a lei. Ma questo può con ugual ragione dirsi una volta e ripetersi sempre (all’
infinito); poiché nessuna parte di esso (molteplice) sarà l’ ultima, né alcuna sarà senza rapporto con
altra (che le stia dinanzi”. E ancora: “Che se (tale unità) fosse aggiunta ad altro ente, non lo
renderebbe affatto maggiore; poiché essendo priva di grandezza, se viene aggiunta, non ha nessuna
capacità di contribuire alla grandezza. E così senz’ altro l’ aggiunta sarebbe nulla. Ma se,
togliendola via da altra cosa, quest’ altra non diventerà affatto minore, né aggiungendola aumenterà,
è chiaro che era nulla ciò che è stato aggiunto e nulla ciò che è stato tolto via”. L’ assurda
conclusione è che se le cose sono molteplici, “è necessario che siano insieme grandi e piccole:
piccole in modo da non aver grandezza, grandi in modo da essere infinite”. In terzo luogo, Zenone
dimostra che lo spazio, inteso come “luogo” non sia reale: Aristotele (“Fisica”) ne ricorda l’
obiezione: “se il luogo è qualcosa di reale, dove sarà?”. Insomma: “anche del luogo dovrà esservi
un luogo e così via all’ infinito”. Lo stesso Aristotele attesta poi i quattro argomenti di Zenone
contro il movimento. Il primo è il cosiddetto “paradosso della dicotomia”, che Simplicio (nella sua
opera dossografica: “Aristotelis Psycorum libros”, VI sec. d. C.) riferisce così: “Se esiste il
movimento, è necessario che il mobile percorra infiniti tratti in un tempo finito; ma ciò è
impossibile, quindi il movimento non esiste”. La distanza da percorrere, pur essendo finita, è
costituita da infiniti punti, ed il tempo necessario a percorrerla dovrà esser dunque infinito”. E’
assurdo ritenere che un corpo si muova in uno spazio che è divisibile all’ infinito (continuo). Il
secondo argomento è il “paradosso di Achille “piè veloce””. Il quale concede, alla partenza, un
certo vantaggio al debole avversario, ma, per quanto sia ben più veloce, non riuscirà mai a
raggiungerlo ed a superarlo. Achille si avvicina, infatti, sempre di più all’ altro, ma lo svantaggio,
pur riducendosi progressivamente non si annullerà mai. Se nel caso precedente, si procedeva alla
divisione di una grandezza data, ora si sommano grandezze sempre più piccole. La conclusione è
però la stessa: non può esservi movimento nello spazio continuo. Spiega così un tale paradosso
Aristotele: “il più lento non sarà mai raggiunto in corsa dal più veloce; poiché è necessario che l’
inseguitore giunga prima là, donde il fuggente è partito, sì che il più lento necessariamente
precederà sempre di qualcosa”. Il terzo paradosso è quello della freccia. Essa appare in movimento,
dopo esser stata scagliata dall’ arciere, ma è immobile. Dice Aristotele che tale argomento “deriva
dall’ assumere che il tempo sia composto di istanti; giacché, non concedendo questo, non potrà
reggere il ragionamento … Se difatti ogni ente … nell’ atto che occupa uno spazio uguale a se
stesso, o sta in quiete ovvero è in movimento, ma (d’ altra parte) il mobile è sempre nell’ istante,
(allora) la freccia in movimento è immobile”. Il tempo impiegato dalla freccia nel compiere la sua
traiettoria è diviso in istanti. In ciascuno di essi la freccia è in uno spazio determinato e uguale a se
stesso, dunque immobile. Ma se è immobile in ogni istante, lo sarà anche nella totalità degli istanti.
Il quarto ragionamento è quello, scrive Aristotele, “delle serie di punti uguali, moventisi nello stadio
da opposte posizioni, lungo una serie di punti uguali: l’ una dall’ estremità dello stadio, l’ altra dal
mezzo, con uguale velocità; in cui sembra conseguire che un tempo mezzo sia uguale al doppio”. Si
tratta di un argomento piuttosto complesso, del quale Mondolfo fornisce questa versione (pensando
alle testimonianze di Aristotele ma anche di Simplicio): “Supponendo nello stadio le tre serie
parallele … (gli A immobili, i B in moto da sinistra a destra, i C in moto simultaneo e di uguale
velocità da destra a sinistra), in ogni istante ogni B e ogni C, che si muovono con uguale velocità,
passano lungo uno degli A: e questo è l’ atomo di movimento, corrispondente all’ atomo di tempo
(istante). Ma nell’ atto stesso ogni B e ogni C passano reciprocamente lungo due termini dell’ altra
serie parallela che si muove in senso inverso; e così l’ atomo di movimento viene a dividersi in due
e l’ atomo di tempo del pari; l’ unità (indivisibile) appare da una parte uguale a ½, dall’ altra parte a
2. Ossia, dove si credeva di trovare l’ indivisibile atomo, col movimento il processo della divisione
si riapre: torniamo alla posizione stessa della prima difficoltà della prima coppia (la dicotomia) e
così ricominciamo a percorrere il circolo di nuovo, senza poterne uscire)”. Riferendo gli argomenti
di Zenone, Aristotele li aveva fortemente contestati. Ad esempio, nella “Metafisica”, dice: “se l’
unità stessa è indivisibile, secondo la proposizione di Zenone sarebbe nulla. Giacchè ciò che
aggiunto o tolto via non rende né maggiore né minore, egli dice che non è un ente reale; che
evidentemente l’ ente reale è una grandezza. Ma se è grandezza, ha un corpo; giacchè questo è reale
in ogni senso …”. E ancora, nella “Fisica”: “assume il falso l’ argomento di Zenone, che non
possano percorrersi infiniti punti o toccare uno ad uno punti infiniti in tempo finito. Perché in
doppio senso si dice infinita la lunghezza e il tempo, e in generale ogni continuo: o per divisione o
per estensione. Le cose infinite in quantità, dunque, non possono esser toccate in tempo finito, ma lo
possono quelle infinite per divisione perché anche il tempo è infinito in questo senso”. Contro il
ragionamento dell’ Achille piè veloce, infine, rileva che “è falso assumere che chi precede non
possa essere raggiunto; giacchè fin che precede, non è raggiunto; ma tuttavia è raggiunto, se si
concederà che si superi una distanza finita”. La cosa è pensabile se si rifiuta l’ ipotesi della
divisibilità infinita. La terza e la quarta aporia partono appunto dalla sua esclusione. E con quelle si
dimostra che, se si parte dalla non infinita divisibilità e quindi da un elemento non ulteriormente
scomponibile, si ritorna proprio alla divisibilità all’ infinito. Aristotele, comunque, credeva nell’
esistenza dell’ infinito. Nella “Fisica” concluse con rigore ferreamente logico che l’ infinito non può
esser negato. Ma l’ infinito al quale si riferiva era quello “in potenza”. Tutte le grandezze corporee
sono infinite nella loro divisibilità. O meglio: esse sono divisibili all’ infinito potenzialmente. Ma
nessuna di esse è mai attualmente divisa in parti di numero infinito. E così è per il tempo. Esso è
infinito in potenza. Si prenda, infatti, un intervallo di tempo finito: gli si possono aggiungere
gradualmente infiniti nuovi intervalli, ciascuno finito. La numerazione-addizione procederà senza
limite. E scrive Aristotele: “L’ infinito per aggiunzione è quasi la medesima cosa che l’ infinito per
divisione, giacchè esso si produce nel finito per aggiunta, in modo contrario all’ altro. Invero, nella
misura che una grandezza si vede divisa all’ infinito, nella stessa misura essa risulta aggiunta a
quella finita. Difatti, se noi da una grandezza finita togliamo una determinata grandezza e poi ne
togliamo ancora un’ altra nella medesima proporzione, senza però portar via la grandezza stessa
dell’ intero, non riusciremo a percorre il finito: se, al contrario, accresceremo la proporzione in
modo da portar via progressivamente la grandezza stessa, allora riusciamo a percorrerla, perché
tutto ciò che è finito si toglie via mediante la sottrazione di un qualsivoglia finito”. All’ infinito si
deve pensare, dunque, come la potenzialità di un “di più”. Il “di più” è comunque finito.
47 /
Bernhard Bolzano (5)
Bernhard Bolzano ha restituito al sapere contemporaneo l’ inquieta questione della natura dell’
infinito, gettando le condizioni per una sua più sicura padronanza. La problematica della natura
dell’ infinito, dei suoi paradossi e delle sue contraddizioni, ha tormentato la filosofia occidentale sin
dalle origini. Gli interrogativi sull’ infinito hanno sempre avuto uno spazio di tutto rispetto nella
filosofia della matematica e non vi è branca del sapere che possa mostrarvisi sorda. Chi se ne voglia
render conto può leggere, di Thérèse Gilbert e Nicolas Rouche, “L’ infinito matematico tra mistero
e ragione. Intuizioni, paradossi, rigore”. E’ un modo per penetrare gradualmente e socraticamente
nella dimensione concettuale dell’ infinito. L’ indubbio merito di Bernhard Bolzano è stato quello
di affermare l’ esistenza oggettiva del concetto di “insieme infinito”. Su cui gravavano da sempre
perplessità e incertezze. “Già nel dominio delle cose che non hanno alcuna pretesa di attualità e
neppure persino di possibilità, - scriveva ne “I paradossi dell’ infinito” – ci sono incontestabilmente
insiemi che sono infiniti. L’ insieme delle proposizioni e verità in sé è, come si può molto
facilmente riconoscere, infinito”. “L’ infinità dei numeri – ricorda Bertrand Russell ne “La saggezza
dell’ Occidente” – aveva provocato imbarazzo fin dall’ epoca di Zenone e dei suoi paradossi”.
“Quando abbiamo a che fare con insiemi infiniti”, il concetto pacifico del buon senso comune,
secondo cui il tutto è maggiore della parte, sembra non valere più. Un semplice esempio: “la serie
dei numeri interi positivi, che è un insieme infinito, comprende i numeri pari e i numeri dispari”.
Russell invita ad osservare che “Se si tolgono tutti i numeri dispari, si può pensare che rimanga la
metà di ciò da cui si è partiti. Invece i numeri pari che rimangono sono altrettanti di tutti i numeri
che vi erano all’ inizio”. Bolzano dava impulso all’ elaborazione di quella “teoria degli insiemi” che
avrebbe avuto un notevole rilievo nei progressi matematici del Novecento. Se ne sarebbero occupati
Georg Cantor e Julius Richard Dedekind. Cantor aveva rimarcato quella pessima idea che s’ era
diffusa nei filosofi dopo Kant, che “il limite ideale del finito sia l’ assoluto”. In realtà “tale limite
può venir pensato solo come transfinito”. Nel 1885, Cantor lo precisava come “il minimo di tutti i
transfiniti”. Prima di Cantor tutti erano convinti che l’ infinito è l’ assoluto insuperabile: se c’ è, è
uno solo. Ma ci sono infiniti più grandi e infiniti più piccoli. Il ripensamento dell’ infinito attuale da
parte di Cantor ha portato con sé nuove antinomie e paradossi (si pensi anche a quelli di Bertrand
Russell). Risolvendo però quelli che avevano costretto Galileo Galilei ad arenarsi nel suo approccio
all’ infinito. Comunque le antinomie di Cantor e Dedekind avrebbero generato ai primi del
Novecento la crisi dei fondamenti della matematica. E sulla natura della “scienza esatta” nacquero
varie scuole: dall’ intuizionismo al formalismo sino al logicismo. Gli intuizionisti credevano alla
sola verità della successione infinita dei numeri naturali e di ciò che ne discende. Ritenevano che
una proposizione possa essere indecidibile, e quindi né vera né falsa, concludendo per l’
infondatezza del principio del terzo escluso (“tertium non datur”). I formalisti identificarono, nell’
ambito matematico, l’ esistenza con la coerenza. E condussero all’ estremo il tentativo di
formalizzare l’ aritmetica. I logicisti vollero formalizzare la matematica con la logica. Kurt Gödel
ha stroncato, sin dagli anni trenta, la pretesa di una completa formalizzazione delle teorie
matematiche. E’ del 1964 il sistema formale di Paul Cohen che dischiude il bivio tra matematica
cantoriana e matematica non-cantoriana (l’ antinomia di Cantor, detta della “classe totale”, aveva
dato un apporto determinante alla crisi dei fondamenti della matematica). Dalle intuizioni di Paul
Cohen è scaturito il metodo assiomatico, che è ipotetico-deduttivo. Esso esclude che gli assiomi
siano originariamente e primitivamente veri e indimostrabili. Si tratta, semplicemente, di ipotesi.
Come, un centinaio di anni prima, erano nate le geometrie non euclidee, che si affiancavano a
quella di Euclide, ora nascevano le matematiche. Una pluralità che prospettava nuove piste e nuove
direttrici di ricerca, impensabili sino a pochi decenni prima. In questa complessa vicenda, fu
importante la spinta propulsiva di Bernhard Bolzano nel prender coraggio di fronte all’ infinito
attuale. Sino ad esser colpito dagli strali dell’ autorità politica e religiosa. Galileo Galilei vi aveva
rinunciato, dopo aver constatato i paradossi e le contraddizioni che l’ infinito attuale porta con sé.
Come ha evidenziato con chiarezza didattica Maria Chiara Giacomucci (“L’ infinito in
matematica”) attingendo alla “Breve storia dell’ infinito” di Paolo Zellini e alla “Storia della
matematica” di Carl B. Boyer, “Il primo a mettere in discussione il concetto di infinito così come
era stato elaborato dalla filosofia greca fu Galileo Galilei. Egli affermò la possibilità di ridurre un
continuo limitato (ad esempio un segmento) in infiniti elementi “primi” non “quanti” (cioè senza
estensione), indivisibili”. “Poiché infatti un segmento può essere diviso in quante si vuole parti
ancora divisibili, - chiarisce la Giacomucci – si deve necessariamente ammettere che esso sia
composto da infinite parti, ma se queste parti sono infinite allora devono necessariamente essere
“non quante”, cioè prive di estensione, perché infinite parti estese hanno un’ estensione infinita,
mentre il segmento ha un’ estensione limitata”. La conclusione è che “L’ infinito in atto non può
non essere pensato ed il segmento non è altro che una sua manifestazione”. Per intenderci meglio,
“Un’ altra espressione dell’ infinito attuale è la circonferenza: poiché infatti è possibile “piegare” un
segmento a formare un quadrato o un qualunque poligono regolare con un qualsivoglia numero di
lati, allora piegandolo a formare un cerchio si può benissimo dire di “aver ridotto all’ atto quelle
parti infinite che prima, quando era un segmento dicevano esser di lei contenute in potenza”.
Possiamo infatti “vedere” la circonferenza come un poligono con un numero infinito di lati”. Di
fronte ai paradossi che l’ infinito attuale portava con sé, Galilei fu comunque molto prudente. E non
volle ricorrere agli “infiniti indivisibili non quanti” in geometria. I suoi paradossi lo costrinsero a
perdersi in insormontabili difficoltà, e scrisse che “Queste son di quelle difficoltà che derivano da
discorrer che noi facciamo col nostro intelletto finito intorno a gl’ infiniti, dandogli quelli attributi
che noi diamo alle cose finite e terminate, il che penso che sia inconveniente”. Aristotele aveva
negato, nella “Fisica”, l’ infinito (“àpeiron”) in atto. Esso esiste solo in potenza. In effetti, egli
negava la realtà di un corpo infinito. Era la conclusione della sua disamina nei confronti delle
molteplici concezioni emerse dai fisici (“physiologoi”) che lo avevano preceduto. Come gli era
consueto, egli classificò il loro pensiero: alcuni lo avevano inteso come una sostanza (l’
indeterminato, illimitato, indefinito di Anassimandro, altri come una proprietà di elementi primi (le
omeomerie infinite e divisibili all’ infinito di Anassagora, gli atomi o “corpi primi” di Leucippo e
Democrito) o della diade grande/piccolo che si contrappone all’ Uno secondo le dottrine non scritte
di Platone. Un numero non è soltanto numero e una grandezza è comunque grandezza di qualcos’
altro: così argomentava Aristotele. E quindi escludeva che l’ infinito possa avere una realtà
sostanziale: non può esservi un infinito in sé e per sé. Non restava ad Aristotele che chiedersi se l’
infinito autosussista come corpo, se cioè l’ infinito possa essere una proprietà, in termini naturali,
delle cose. Un corpo infinito non avrebbe un centro, un sotto e un sopra, e neppure un “luogo”, e
dunque la sua esistenza sarebbe assurda. Ora una grandezza corporea è pensabile come
potenzialmente divisibile all’ infinito. Questo non vuol dire che, in un qualsiasi istante, essa sia
attualmente divisa in un numero infinito di parti. Si può sostenere che il tempo è infinito, ma nel
senso che ad un intervallo finito di tempo se ne possono aggiungere sempre di nuovi, anch’ essi,
comunque singolarmente finiti. Se si prende un segmento, comunque finito, gli si possono sottrarre
parti sempre più piccole, senza mai ridurlo a zero. E Aristotele scrive nella “Fisica” che l’ infinito
attuale è “quello al di là del quale non c’ è più nulla” mentre l’ infinito potenziale è “quello al di
fuori del quale c’ è sempre qualcosa”. Era un chiaro monito ai matematici affinché ignorassero l’
infinito attuale (ammesso che la matematica potesse avere, secondo lui, un qualche ruolo nella fisica
“terrestre”). “L’ infinito è in potenza, ma non in atto”. Aristotele non intendeva “sopprimere per
nulla le ricerche dei matematici per il fatto che < si > esclude che l’ infinito per accrescimento sia
tale da non poter esser percorso in atto. In realtà essi stessi, allo stato presente, non sentono il
bisogno dell’ infinito e in realtà non se ne servono, ma soltanto di una quantità grande quanto essi
vogliono, ma pur sempre finita”. Per cui, concludeva nella “Fisica” che “ai fini delle loro
dimostrazioni” ai matematici “non importerà affatto la presenza dell’ infinito nelle grandezze
reali”. E chi avrebbe messo in discussione le disposizioni di Aristotele? Per tutta la Scolastica
rinascimentale e la filosofia umanistico-rinascimentale e ancora per buon parte della filosofia
moderna, il suo veto impedirà a chiunque di affrontare e superare l’ angoscia provocata dai
paradossi dell’ infinito attuale. Del resto, come ha scritto Rodolfo Mondolfo (“L’ infinito nel
pensiero dell’ antichità classica”), “la battaglia di Aristotele contro l’ infinità dell’ universo, dello
spazio e del numero dei mondi era inspirata (più ancora che dalle difficoltà intrinseche alla dottrina
dell’ infinito) sopra tutto dal bisogno che egli aveva della limitazione, per fondare e salvare i
postulati fondamentali della sua fisica teleologica < finalistica > e antimeccanica: la dipendenza del
mondo e di tutto il divenire da una causa prima finale; la perennità del cosmo e della rotazione
celeste in corrispondenza all’ eternità della causa prima e della sua azione teleologica, che suscita l’
inestinguibile aspirazione del mondo alla divina perfezione di essa; la dipendenza di tutti gli altri
moti da questa rotazione celeste e dalla distinzione dei luoghi naturali per i singoli elementi”.
Ammettere l’ infinito attuale significava ripensare in modo radicalmente nuovo la fisica e la
cosmologia. Un’ operazione che fu compiuta con la rivoluzione astronomica e scientifica dell’ età
moderna.
48 /
Bernhard Bolzano (6)
Bernhard Bolzano è stato il primo a riconoscere l’ infinito attuale, accettandone i paradossi, senza
dichiararsi sconfitto dalle contraddizioni cui essi, apparentemente, sembrerebbero condurre. Aveva
già tentato l’ improba impresa Galileo Galilei, ma s’ era arreso. Ritraendosi dalle risultanze assurde
cui la riflessione sull’ infinito conduceva, il Pisano aveva concluso che esso trascende le limitate
capacità dell’ intelletto umano. L’ autorità di Aristotele s’ era imposta a tutta la filosofia antica, per
poi gettare la sua ipoteca anche su quella medioevale e moderna. E lo Stagirita era stato chiaro: l’
infinito non può essere attuale. Non esiste l’ infinito come totalità costante, stabile, che, in
estensione, vada oltre ogni grandezza finita. Negando che l’ infinito potesse essere una sostanza,
egli si era chiesto se vi potesse essere un corpo infinito. La sua risposta era stata negativa, in
sintonia con la sua fisica del “luogo” di ogni corpo. Non può esservi un corpo infinito poiché non vi
è un luogo infinito. E’ ammissibile soltanto l’ infinito potenziale. Esso è da intendersi come una
grandezza variabile, pur sempre finita, che cresce al di là di ogni limite finito. L’ infinito potenziale
è, in altre parole, un processo “in fieri”, mai ultimato e terminato. Georg Cantor e Richard Dedekind
(coloro che hanno elaborato l’ aritmetizzazione della matematica) nutrono certamente un grosso
debito nei confronti di Bolzano. Soprattutto il primo, che propose la teoria degli insiemi. Con la
quale egli volle estendere la matematica tradizionale al nuovo dominio rappresentato dall’ infinito.
Non vi è dubbio che Bolzano compì un grande atto di coraggio affrontando i paradossi dell’ infinito
attuale e rivendicandone l’ esistenza, superando il timore di cadere nel baratro della contraddizione.
Egli poneva fine ad una inveterata tradizione e schiudeva nuove e impensabili prospettive alla
matematica. Pur restando un illustre sconosciuto per i suoi contemporanei, trasmise a Cantor la
forza di concepire gli insiemi infiniti come insiemi attuali e già compiuti. Si può metter in
discussione che il tutto è maggiore delle parti, senza cadere in contraddizione. Un insieme infinito
non è certo lo stesso che una sua parte. Ma perché non dovrebbero poter avere lo stesso numero di
elementi? Inconsueto ma non contraddittorio. Cantor avrebbe elaborato la teoria dei numeri
transfiniti: la “cardinalità del continuo”, il numero transfinito relativo all’ insieme infinito dei
numeri reali, è maggiore della “cardinalità del numerabile”, il numero transfinito relativo all’
insieme dei numeri naturali. Non si sottolineerà mai abbastanza l’ importanza che, nelle nuove
acquisizioni della matematica contemporanea, ha avuto l’ impulso di Bolzano. La sua può esser
considerata una vera e propria “frattura epistemologica”, di quelle che consentono allo “spirito
scientifico” di superare un ostacolo epistemologico, come direbbe Gaston Bachelard, oppure l’
introduzione di un nuovo “paradigma” scientifico, per usare l’ espressione di Thomas Kuhn. Se si
scorre la filosofia greca, si nota come i naturalisti pluralisti si opponessero all’ essere unico,
concepito da Parmenide di Elea come una perfetta sfera. Lo stesso Melisso di Samo, seguace di
Parmenide, ne aveva riformulato l’ ontologia: l’ essere è certo determinato, ma non finito. L’ essere
andava concepito come infinito nello spazio, altrimenti, se lo si pensasse finito, verrebbe da
chiedere che cosa ci sia oltre di esso. Non certo il non essere, che va inteso univocamente come il
nulla. E dunque non potrebbe esservi altro che l’ essere. Anassagora di Clazomene (“Sulla natura”)
sosteneva che “Tanto nel grande quanto nel piccolo vi è lo stesso numero di particelle … rispetto al
piccolo non c’ è un minimo, ma c’ è sempre un più piccolo, perché l’ esistente non può essere
annullato (per divisioni successive). Così, rispetto al grande, c’ è sempre un più grande, e il più
grande è uguale al più piccolo come pluralità, e in se stessa, ogni cosa pensata come somma d’
infinite parti infinitesime è insieme grande e piccolo”. Anassagora aveva acquisito l’ infinito e l’
infinitesimo, anche se nell’ intendere la suddivisione infinita sembra oscillare tra l’ infinito in
potenza e quello attuale. Da buon naturalista pluralista, “fisicizzò” l’ essere di Parmenide,
disgregandone l’ unità in una molteplicità infinita e infinitamente divisibile di semi, che Aristotele
avrebbe chiamato omeomerie, giacchè ne esistono infiniti gruppi, tante quante sono le infinite
qualità riscontrabili nella natura. “Nessuna cosa nasce e nessuna perisce – scriveva Anassagora - ;
ma da cose già esistenti ognuna si viene a comporre e a scomporre. E così dovrebbero rettamente
chiamare il nascere riunirsi e il perire separarsi”. Le “cose” che si aggregano o si disgregano eran
proprio i semi. Era convinto che “… in tutte le cose che si congiungono siano molte e svariate cose,
e semi di tutte le cose, e aventi forme d’ ogni genere e colori e sapori … In ogni cosa vi sono
particelle d’ ogni cosa”. Come spiegava, allora, che noi siam costituiti da determinate qualità –
ossa, carne, sangue … - finite in numero e non infinite? “Noi usiamo –testimonia Aezio – di un
nutrimento semplice e d’ una sola specie, il pane e l’ acqua, e di questo si nutrono i peli, le vene, le
arterie, la carne, i nervi, le ossa e tutte le altre parti”. Quindi “bisogna riconoscere che nell’ alimento
adoperato sono tutte le cose, e che da cose già esistenti tutte (le parti del corpo) si accrescono. E in
quell’ alimento sono particelle generatrici del sangue e dei nervi e delle ossa e delle altre parti; le
quali particelle sono visibili solo alla mente. Poiché non si deve ricondurre tutto alla sensazione, per
la quale il pane e l’ acqua producono queste (parti del corpo); ma in essi sono particelle visibili solo
con la mente. Come potrebbe il capello nascere da ciò che non è capello, o la carne da ciò che non è
carne?”. Rodolfo Mondolfo ha, comunque, sottolineato come Anassagora, per primo, abbia
elaborato il concetto di infinito “sotto un triplice aspetto: infinitamente grande (la totalità dell’
universo), infinitamente piccolo (gli infinitesimi indiscernibili), infinitamente molteplice (la
composizione di ogni cosa)”, per cui tutto è in tutto, e le infinite omemomerie, cui corrispondono
infinite qualità, sono in ogni cosa, sia pur in diverso grado, dominando alcune qualità rispetto a tutte
le altre. Tanto il grande quanto il piccolo, pertanto, “sono uguali in molteplicità … < in quanto
risultano > entrambi d’ infiniti infinitesimi”: E, nello stesso tempo, la distinzione tra grande e
piccolo è puramente relativa. All’ univoco e monolitico essere di Parmenide vollero sottrarsi anche i
sofisti della prima generazione, Protagora di Abdera e Gorgia di Leontini. All’ univocità dell’
essere, Parmenide era pervenuto col rigore della ragione. Il “Logos” lo conduceva ad opporre l’
essere al non essere e gli faceva pronunciare implicitamente, per la prima volta, il principio di
identità (A = A). La conoscenza sensibile è, dal suo punto di vista, del tutto ingannevole: il “Logos”
mostra che non vi sono né il molteplice né il divenire: ad essi credono solo gli uomini “a due teste”,
secondo i quali esistono tanto l’ essere quanto il non essere, che convivono nelle cose. Altra realtà
non vi è che l’ essere: l’ essere è, ed è uno, unico, ingenerato, immutabile, indivisibile, omogeneo,
immobile, perfettamente sferico. Leucippo e Democrito furono fisici pluralisti come Anassagora.
Non ignorarono l’ essere univoco di Parmenide, ma lo tradussero anch’ essi sul piano fisico. Come
attesta Aristotele, nella “Generazione e corruzione”, “Leucippo credette che vi fosse una teoria, che
dicendo cose in accordo con l’ esperienza sensibile non sopprimesse né la nascita né la distruzione,
né il movimento, né la molteplicità degli esseri. Mettendosi d’ accordo coi fenomeni in questo
riconoscimento e d’ accordo con gli assertori dell’ Uno nell’ affermare che non potrebbe il
movimento esser senza il vuoto e che il vuoto è non ente, egli afferma pure che nulla di ciò che è
ente può essere non ente. Perché, a parlar propriamente, l’ essere è un pieno assoluto; ma questo
così fatto essere non è uno, ma sono infiniti in molteplicità e invisibili per la piccolezza delle masse.
E questi si muovono nel vuoto (perché il vuoto esiste) e raccogliendosi producon la nascita,
disperdendosi la distruzione”. Leucippo e Democrito non potevano ignorare le potenti acquisizioni
dell’ ontologia di Parmanide. Ma non ne accettavano l’ annientamento della molteplicità delle cose
e del loro mutamento. Attribuirono perciò le qualità dell’ essere di Parmenide ad un numero infinito
di “corpi primi”, che definirono atomi, proprio perché incomposti e indivisibili come l’ essere di
Parmenide. Tra i fisici pluralisti che “fisicizzarono” l’ essere aleatico (Anassagora, Empedocle),
Leucippo e Democrito furono i più fedeli all’ essere parmenideo. Il loro atomo ne conserva tutte le
caratteristiche e le attribuzioni, salvo che non è unico. Ve n’ è, infatti, una molteplicità infinita. Però
l’ atomo, al contrario del seme di Anassagora, non è divisibile all’ infinito. Gli atomi – attesta
Aristotele nel “De Coelo” – “sono infiniti di numero e indivisibili in grandezza”. E aggiunge che
Leucippo e Democrito affermano il vuoto, senza il quale, del resto, non si potrebbe pensare il pieno
(l’ atomo-essere molteplice): “Leucippo e il suo compagno Democrito dicono essere elementi il
pieno e il vuoto, chiamando l’ uno essere, l’ altro non essere: il pieno e solido chiamano essere, il
vuoto e inconsistente chiamano non essere (perciò dicono anche che l’ essere non ha affatto più
realtà che il non essere, né il corpo più che il vuoto)”. Parmenide non ammetteva il vuoto, perché il
non essere non è. Logicamente gli era consentito, giacchè il suo essere era uno e unico. Ma un tale
essere, reduplicato in tanti esseri all’ infinito, deve potersi trovare nel vuoto: il non essere era
necessariamente ammesso. Altrimenti come avrebbero potuto distinguersi due atomi, ovvero due
esseri? La loro discrezione deve essere assicurata da un non essere. Da un vuoto appunto. Ma il
riconoscimento del vuoto esige l’ indivisibilità dell’ atomo: “se esso < l’ essere > è divisibile in
qualsiasi parte, non c’ è più uno, e quindi neppure i molti, ma tutto è vuoto” (Aristotele). Se l’
essere non fosse indivisibile, esso si dissolverebbe nel vuoto. Gli atomi differiscono in figura
(geometrica), ordine, posizione, grandezza e peso, attestano Aristotele e Teofrasto. E se “i corpi
differiscono di forme, e sono infinite le forme, infiniti < sono > anche i corpi semplici” (Aristotele,
“De coelo”). Ma se gli atomi sono in numero infinito, infinito dev’ essere anche il vuoto in cui essi
si muovono. “Leucippo – testimonia Diogene Laerzio – dice che il tutto è infinito; parte pieno e
parte vuoto, e questi chiama elementi: da questi nascono e in questi si dissolvono mondi infiniti. E
così si formano i mondi”. Nell’ infinito vuoto, gli infiniti atomi si muovono caoticamente, secondo
traiettorie casuali. Casualmente s’ incontrano e generano movimenti vorticosi e turbini, in cui i più
pesanti si situano al centro e i più leggeri alla periferia. Ne nascono infiniti mondi. “Quelli che
supponevano infiniti di numero i mondi, come i seguaci di … Leucippo e Democrito – dice
Simplicio – supponevano che si generassero e si dissolvessero nell’ infinito, sempre generandosene
alcuni e dissolvendosene altri”.
49 /
Bernhard Bolzano (7)
Bernhard Bolzano fu il precursore della riscoperta dell’ infinito in atto nella seconda metà dell’
Ottocento, dopo l’ ostracismo cui l’ aveva costretto per secoli l’ anatema di Aristotele. I “Paradossi
dell’ infinito” (1851) di Bolzano, sia pur tardivamente, si sarebbero mostrati estremamente fecondi
per la matematica e la filosofia della matematica. Le contraddizioni logiche cui l’ infinito attuale
sembrava esporre, ne avevan tenuto lontano lo stesso Galileo Galilei. Ma nella generale indifferenza
nei confronti di quello spinoso concetto, molto aveva pesato l’ autorità di Aristotele, la cui
distinzione tra infinito in potenza e infinito in atto avrebbe mantenuto intatto il proprio peso per
secoli. Come sostiene Rodolfo Mondolfo ne “L’ infinito nel pensiero dell’ antichità classica”
(1956), “l’ infinita divisibilità – propria del tempo come di ogni continuo” vuol essere per
Aristotele “divisibile in parti sempre divisibili”. Nella “Fisica”, egli parla degli “istanti che sono
infiniti in ogni intervallo fra due momenti dati (ammettendone così la realtà e non la semplice
possibilità, e una realtà oggettiva e non soltanto nel pensiero)”. Ma, sempre nella “Fisica”,
“dichiara – ricorda Mondolfo – nella trattazione del problema dell’ infinito che l’ infinità della
divisione è sempre puramente potenziale e non attuale”. Aggiunge Mondolfo che Aristotele
“avrebbe potuto definire infinità potenziale e non attuale … l’ infinita estensione del tempo nella
direzione del futuro”. La posizione di Aristotele è comunque chiara quando dice che “L’ infinità
non è permanenza, ma processo di divenire”. L’ infinità temporale e l’ infinita divisibilità sono per
lo Stagirita, conclude Mondolfo, “forme di infinità, che possono considerarsi puramente potenziali,
come processi sempre e illimitatamente in via di svolgimento”. Lo stesso Euclide non aveva messo
in discussione, nei suoi “Elementi”, la tesi di Aristotele, e si guardò bene dal rimanere imbrigliato
nelle questioni dell’ infinito. Precisò che le figure sono tutte al finito, considerò la retta come una
linea “terminata” che si può “prolungare continuamente per diritto”. Trattava dell’ infinito ma non
lo nominava esplicitamente. Come voleva Eudosso di Cnido, l’ astronomo che nell’ Accademia
platonica suggerì ad Aristotele di Stagira il sistema geocentrico, si guardò bene dal dimostrare che
vi sono infiniti numeri primi, e si limitò a sostenere che “I numeri primi sono di più che ogni
proposto numero complessivo di numeri primi”. La teoria delle proporzioni di Eudosso evitava
accuratamente l’ infinito in atto. Contro Anassagora, Euclide affermò che il tutto è maggiore della
parte, anche se non ignorò le problematiche dell’ infinitesimo. Ma evitò, comunque, di confrontarsi
con l’ infinitesimo attuale, e non derogò mai dalla sua adesione al diniego aristotelico. Lo stesso
Archimede – che pur operò con coraggio la divisione delle figure geometriche, anche solide, in
infinitesimi attuali e in infinite sezioni – avvertì l’ esigenza di evitare il ricorso all’ infinito nel
calcolare il numero dei granelli di sabbia che sarebbero contenuti in una sfera dal raggio equivalente
alla distanza fra Terra e Sole. La negazione aristotelica dell’ infinito attuale avrebbe pesato per
molti secoli. Ancora Ruggero Bacone (1214-1292), mentre distingueva tra l’ infinito filosofico e l’
infinito matematico, negava logicamente l’ attualità di quest’ ultimo. Egli non poteva andar contro
Euclide ed ammettere che il tutto non fosse maggiore della parte. Avrebbe messo in discussione lo
stesso Aristotele. Il lato e la diagonale di un quadrato hanno una diversa lunghezza. Ma tra i punti
dei due si può istituire una corrispondenza biunivoca. E corrispondenza biunivoca vi è tra due
semirette collocate sulla stessa retta, per traslazione o proiezione doppia. La cosa gli faceva
concludere, appunto, che l’ infinito matematico in atto non è logicamente ammissibile. Tito
Lucrezio Caro (10-55) aveva implicitamente mostrato di intendere l’ universo illimitato, quando
aveva sostenuto: “Supponi per un momento che lo spazio sia limitato e che qualcuno si porti all’
estremo confine e lanci una freccia” (“De Rerum Natura”). Clemente Alessandrino (150-215)
attribuì alla natura di Dio l’ infinità, la cui comprensione è però negata alla nostra mente limitata.
Agostino di Tagaste (345-430), vescovo di Ippona, il maggior Padre della Chiesa, andò oltre:
poiché “Dio conosce tutti i numeri in modo attuale … l’ infinito attuale è nella mente di Dio” (“De
Civitate Dei”). Sant’ Agostino ammetteva, dunque, l’ infinità attuale dei numeri naturali. All’
infinita pienezza della divina perfezione guardano i filosofi, e San Basilio Magno (330-379) era
certo che non si possa parlare dell’ infinito senza connetterlo agli attributi divini. Plotino (204-270),
il maggior rappresentante della scuola neoplatonica alessandrino-romana, provò che dev’ esservi un
primo Principio: la molteplicità e l’ essere reale esigono quell’ Unità originaria che conferisca loro
sussistenza ed ordine. “… prima della dualità c’ è l’ Uno, e la dualità è seconda. Bisogna che prima
del molteplice vi sia l’ Uno, da cui anche il molteplice derivi: giacchè l’ Uno è il principio di ogni
numero. Tutti gli esseri … che cosa sarebbero mai, se non fossero uno? Giacchè privati dell’ unità
… non son più loro: né l’ esercito … né il coro … né la casa o la nave … E i corpi delle piante o
degli animali, se fugga l’ unità, disperdendosi in molteplicità perdono la loro essenza” (“Enneadi”).
E lo stesso pensiero esige l’ unità: senza il numero sarebbe impossibile. “Se non è possibile pensare
alcun che senza l’ uno o il due o altro numero, come sarebbe possibile – si chiede Plotino – che non
esistesse quello, senza il quale non è possibile pensare o dire che che sia?”. E se per il pensiero e il
discorso è indispensabile il numero, e quindi l’ uno, “bisogna che < l’ Uno> sia anteriore al discorso
e al pensiero”. L’ Uno è assolutamente semplice, assolutamente sufficiente a se stesso, e infinito. E’
infinito, scrive Plotino, “perché non è più che Uno, e non ha confine ove termini alcun che di suo …
Né dunque ha figura, perché non ha parti né forma”. E si faccia attenzione: “Si deve considerar
infinito non per l’ inesauribilità della grandezza o del numero suo, ma per la il limitabilità della sua
potenza”. Onnipresente e onnipotente, trascende il desiderio e il pensiero, e ogni altra
determinazione, è inconoscibile e ineffabile, e tutto dipende da esso. Il neoplatonismo fu l’ ultima
delle scuole pagane. Come ha scritto Rodolfo Mondolfo, esso “raccoglie nella costruzione del suo
sistema elementi derivanti, oltre che dal platonismo e dal neopitagorismo, anche dagli Eleati, dall’
aristotelismo, dagli Stoici e dai giudaico-alessandrini”. E’ la più elevata espressione del sincretismo
alessandrino e recupera i motivi più originali di tutta la metafisica antica. E Mondolfo sottolinea che
proprio perché costituì la “sistemazione di tutta la filosofia religiosa del paganesimo”, gli fu affidata
la funzione di far da “contraltare dell’ invadente dottrina cristiana … e di puntello del paganesimo e
teologia del politeismo”. Proclo fu l’ ultimo neoplatonico ed anche “l’ ultimo grande rappresentante
della speculazione greca” (Rodolfo Mondolfo). Nei suoi trattati di teologia, astronomia e
matematica, egli oscilla tra l’ infinito potenziale e quello attuale. Propende per quest’ ultimo quando
riferisce tanto il finito quanto l’ infinito all’ Uno. Sostiene, infatti, che “Tutto ciò che esiste in
qualche modo consta di finito e di infinito, per effetto del primo essere < in quanto > è chiaro che l’
essere primo comunica a tutte le cose il limite assieme all’ infinità, essendo esso stesso composto di
questi”. Del resto, “Ogni essere, che è veramente, è davvero un infinito, non per molteplicità né per
grandezza, ma per potenza soltanto. Ogni ente vero consta di limite e di infinito. Ché se ha potenza
infinita, è evidente che è infinito, e in ciò consta dell’ infinito; se è indivisibile e simile all’ uno, in
ciò partecipa del limite … Nel misto il limite è partecipe dell’ infinito e l’ infinito del limite”.
Proclo diede sistemazione definitiva alla circolarità Uno/mondo corporeo, che Plotino aveva inteso
come discesa dallo stesso Uno, attraverso l’ Intelletto e l’ Anima universale, e che vedeva compiersi
nella conversione e nel ritorno all’ Uno-Dio, dell’ anima umana. Nel compimento della conversione
vi era il principio della processione (di tutte le cose dall’ Uno). “Ogni essere che procede da un
altro e vi ritorna – scriveva Proclo – ha un’ attività circolare. Ché se ritorna là donde procede,
congiunge col principio il fine, ed è uno e continuo il suo movimento: nascendo da una parte da ciò
che permane, dall’ altra dal ritorno ad esso. Onde tutti gli esseri procedono in circolo dalle cause
alle cause”. Proclo ricondusse la dialettica del processo circolare di progressione-conversione
(discesa-ascesa) alla dottrina della triade, costituita da tre momenti, come ha chiarito Rodolfo
Mondolfo: “la permanenza dell’ essere in sé, sua uscita da sé nella progressione, suo ritorno a sé
nella conversione”. In sostanza, dice Mondolfo, nella dialettica di Proclo, “Per la sua perfezione e
sovrabbondanza di potere l’ essere, restando in sé immutato, genera un prodotto che gli è simile
(cioè insieme identico e diverso), che insieme rimane e procede; ma procedendo aspira al Bene e
perciò ritorna alla sua causa. E ogni ritorno si compie attraverso le stesse cause per cui s’ è
compiuta la processione: i due cammini si corrispondono esattamente in perfetto circolo che
ricongiunge il termine col principio”. In ogni caso, la filosofia antica ha lasciato un segno indelebile
nella riflessione sull’ infinito e sull’ infinitesimo. Tranciare giudizi e imporre drastiche soluzioni di
continuità alla storia della filosofia sarebbe iniquo. Il pensiero rinascimentale e poi quello moderno,
riguardo all’ infinito, debbono molto alla filosofia antica. Rodolfo Mondolfo ha sottolineato la
rinascita “del naturalismo ionico e pitagorico, atomistico ed epicureo … < e dello stesso >
neoplatonismo” nella più “energica affermazione dell’ infinità che si abbia nel Rinascimento”:
quella di Giordano Bruno. Essa “dà l’ impulso decisivo a tutti gli sviluppi che il pensiero moderno
poi compie di quel concetto sul terreno filosofico e scientifico”. Ma Mondolfo è convinto anche che
“le dottrine moderne dell’ infinito e dell’ infinitesimo, il cui sviluppo discende dall’ impulso potente
impresso dal Rinascimento, sono esse pure figlie delle dottrine antiche”. Laddove molti storici
hanno intravvisto l’ antitesi, vi è, in effetti, evoluzione nella continuità. Debbono essere evidenziati
i “vincoli di continuità che legano il nuovo all’ antico”. Discontinuità, novità nei percorsi, negazioni
e contrapposizioni non possono essere ignorate, ma non si possono trascurare quei “germi e <
quelle > forze vitali, che le età precorse hanno trasmesso alle successive, la preparazione e la
condizione imprescindibile dei nuovi e maggiori sviluppi”.
50 /
Bernhard Bolzano (8)
Bernhard Bolzano condusse la riflessione sull’ infinito dall’ oscura e incerta preistoria in cui l’
aveva relegata la filosofia medioevale e moderna, a nuove prospettive, anche se, per la verità, le
coppie: infinito filosofico/infinito matematico e infinito in atto/infinito in potenza avevano
tormentato già la meditazione dei maestri scolastici, degli umanisti rinascimentali e dei moderni
filosofi-scienziati. E se Ruggero Bacone (1214-1292) non aveva trovato il coraggio d’ opporsi ad
Euclide e ad Aristotele, nel sostenere logicamente l’ infinito matematico in atto, Tommaso d’
Aquino riconosceva in Dio l’ infinito attuale e riservava quello potenziale alle cose. “Dio è infinito
e perfetto – scriveva - …. < ma > non può creare cosa alcuna che sia assolutamente infinita”,
proprio perché, nonostante la sua infinita potenza, da Lui non possono derivare cose non create. Il
francescano Gugliemo d’ Ockham (1290-1350) aveva avuto la grande intuizione (e lo straordinario
coraggio) di sostenere, nelle sue “Questiones”, che è ammissibile che “la parte sia uguale o non
minore del suo tutto”: la condizione è che la parte del tutto (infinito) sia infinita. “Ciò accade –
precisava – anche nella quantità discreta o in una qualunque molteplicità, una parte della quale
abbia unità non minori di quelle contenute nel tutto. Così in tutto l’ universo non ci sono punti in
numero maggiore che in una fava, perché in una fava ci sono infinite parti”. La sua conclusione era
che “il principio che il tutto è maggiore della parte vale soltanto per tutti i composti di parti
integranti finite”. Mal gliene incolse per aver confutato Aristotele. E però i maestri medioevali
erano avvezzi alle accuse d’ eresia. Giocavano col fuoco. Guglielmo d’ Ockham, comunque, la
scampò di stretta misura. Con lui, del resto, la Scolastica medioevale andava tramontando e i
dominanti interessi scientifici della sua scuola lo lasciano ben intendere. Egli cancellava ogni
residuo di ancillarità della ragione filosofica alla fede, e mentre proponeva un nuovo fideismo,
riservava alla ragione la conoscenza del sensibile e dell’ individuale. “Credo per comprendere e
comprendo per credere” era stato il motto di Sant’ Anselmo d’ Aosta e dello stesso Sant’ Agostino.
Ma ora la ragione non si sarebbe più mossa nell’ orizzonte della fede. E la teologia razionale non
sarebbe più stata accettata come “scientia”. Fede e ragione non sono conciliabili. Scardinata dal
vincolo della chiarificazione della Verità rivelata, inadeguata a dimostrare l’ esistenza di Dio e ad
affermare di Lui alcunché, la ragione avrebbe imboccata la via della scienza del mondo naturale,
scienza “experimentalis”. E’ stato sottolineata la divaricazione cui condusse l’ empirismo logicoscientifico di Ockham: se, per un verso, la teologia era indotta alla dimensione eminentemente
religiosa e fideistica, per la filosofia si prospettava, d’ altra parte, un’ attenzione privilegiata nei
confronti delle scienze. Mentre da buon nominalista, negava ogni realtà agli universali (Dio ha
creato i singoli cavalli; la “cavallinità” non è che un’ astrazione mentale umana), sviluppava una
teoria della conoscenza fondata sull’ intuizione sensibile. Essa sola è evidente giacchè l’ oggetto
concreto le si offre direttamente e immediatamente. E un tale oggetto non può che essere
individuale. Se le “species” universali non sono che astrazioni prive di realtà, esistono solo concreti
individui. Di qui, immediatamente, il primato dell’ esperienza nella costruzione della scienza. La
filosofia naturale imboccava la via dell’ empirismo radicale. Non si dà alle scienze altro
fondamento che l’ osservazione. Esse procedono per descrizione. E’ loro preclusa la deduzione
(“ratio”) matematica o sillogistica. Lungi dall’ aver validità necessaria, i loro asserti sono soltanto
probabili. E se l’ esperienza è inesauribile, nessuna scienza potrà mai esser rinchiusa in un sistema
unitario, definitivo e dogmatico. Nel Seicento avrebbero definito “rasoio di Ockham” il principio,
da lui enunciato, secondo il quale sono da eliminare, nella filosofia naturale, modelli di spiegazione
che trascendono l’ esperienza, oppure entità che non dicono nulla di più oltre alle spiegazioni
empiriche, come le categorie usate dagli altri maestri medioevali (gli universali, ad esempio).
Perché postulare una pluralità di enti quando non sia necessario? Perché dovremmo moltiplicare gli
enti se non è necessario? Perché dovremmo sostenere una proposizione con nuovi argomenti, se se
ne sono già addotti almeno due? Ockham criticò radicalmente la fisica aristotelica e nel
riformulare le teorie sul movimento presentì, alla lontana, il principio d ‘ inerzia. La sua riflessione
sul moto dei proiettili costituì un netto distacco dalla fisica dei greci e dei medioevali. Giovanni
Buridano (1290-1368), suo discepolo, diede una nuova spiegazione del moto violento dei corpi.
Secondo gli aristotelici il moto è, comunque, una condizione innaturale, anche quello che ripristina
un sasso scagliato vero l’ alto nel suo luogo naturale, il basso, giacchè tutti i corpi pesanti tendono
naturalmente verso il cento della Terra. E nella fisica di Aristotele soltanto lo stato di quiete è
naturale. Un proiettile, secondo gli aristotelici, si muove perché l’ aria circostante riempie il vuoto
creato dal proiettile nel suo movimento. L’ “horror vacui”, l’ orrore del vuoto, induce gli elementi
naturali a colmarlo quando si formi. E l’ aria, dunque, colma il vuoto creatosi nella parte retrostante
del proiettile. Con l’ “impetus” o “vis motiva”, Buridano introduceva una forza motrice impressa
dal motore al mosso, un impeto intrinseco al corpo mosso, che in un corpo in caduta si accresce con
la gravità naturale. Nicola Oresme fu probabilmente un discepolo di Ockham e, ritenendo
impossibile dimostrare l’ immobilità della Terra, non escluse che essa potesse muoversi. Era
lontano dall’ eliocentrismo di Copernico, ma, con gli altri filosofi naturali ockhamisti inferse fieri
colpi alla stabilità della fisica aristotelica e del sistema tolemaico, e predispose le condizioni per un
contesto culturale aperto alla Rivoluzione scientifica ed astronomica del Seicento. La prima
Rivoluzione scientifica nacque, comunque, dalla matematizzazione della fisica della natura e
sarebbe impensabile senza il metodo ipotetico-deduttivo-sperimentale di Galileo Galilei. Gli
aristotelici avevano disprezzato la matematica come strumento di conoscenza della natura. L’
insegnamento del maestro li conduceva a relegarla nel regno dell’ astronomia, che si occupa del
mondo sovralunare, perfetto, eterno, imperituro e immutabile in quanto costituito di Quintessenza
(una sostanza perfetta, pura, cristallina e incorruttibile). Il mondo sublunare, le cui cose sono
aggregati delle quattro sostanze (aria, acqua, terra e fuoco), è il regno del corruttibile e del
“pressappoco”. Ad esso l’ esattezza della matematica sarebbe del tutto estranea. Disgregare i
caposaldi della fisica aristotelica e dell’ astronomia tolemaica fu l’ improbo compito dei “filosofi
naturali” del Seicento. Costoro dovettero ricongiungere fisica terrestre e astronomia celeste,
applicando finalmente la regolarità matematica anche al mondo sublunare. Galileo fu platonico:
intese la natura come un grande libro matematico scritto in caratteri geometrici e riconobbe alla
mente umana il possesso di quel linguaggio matematico che gliene avrebbe consentita la lettura. Ma
si ritenne anche un autentico aristotelico, facendo proprio l’ incoraggiamento del Maestro ad
osservare e ad avvalersi della diretta esperienza. L’ aria che Galileo respirò ai tempi suoi era
platonica ed aristotelica. Ed il merito spetta certamente a coloro che hanno saputo restituire ai
moderni i motivi più fecondi degli antichi, come il filologo umanista Marsilio Ficino che tradusse il
“Corpus Hermeticum” del mitico Ermete Trismegisto, gli “Inni” di Orfeo e i “Commentaria in
Zoroastrem”. Opere che proponevano una cultura magico-ermetica da cui gli scienziati del Seicento
si sarebbero progressivamente distinti, ma che li incoraggiò a cercar strumenti e metodi efficaci per
dominare la natura. Meritevoli sono però anche coloro che – dando continuità alla transizione dalla
filosofia scolastica a quella proto-moderna – valorizzarono la matematica, sia pur ancora in una
prospettiva teologica e gnoseologica. E’ il caso di Niccolò da Cues (Kryfts). Cusano era uomo di
Chiesa e visse nel Quattrocento. Era cresciuto nell’ ockhamismo ma la teologia l’ aveva conquistato
e si mosse tra il neoplatonismo dello Pseudo Dionigi e di Giovanni Scoto Eriugena e il misticismo
di Meister Johannes Eckhart. Al centro della sua riflessione c’ era Dio. Ma affrontò la questione
teologica in termini nuovi. Abbandonò la prospettiva ontologica e metafisica ed adottò un punto di
vista gnoseologico. Dio è alla portata della conoscenza umana? Già la conoscenza del finito gli
appariva indefinita e incompiuta. Il sillogismo aristotelico unisce due proposizioni (le premesse)
che hanno in comune un termine medio (che in esse funge da soggetto o predicato). Esso scompare
nella conclusione. Si tratta di una riduzione al termine noto. La conoscenza non coglie l’ oggetto
nella sua inseità. Essa rimanda di termine in termine. E’ comparativa. Un fenomeno viene inteso
come effetto da ricondurre ad una causa, e questa è l’ effetto di una precedente causa. In sostanza la
conoscenza del finito è indefinita. Essa induce a rivolgersi all’ infinito. Lo Pseudo Dionigi lo
spinge a riscoprire la lezione di Socrate ed a considerare la conoscenza umana dell’ infinito come
una “dotta ignoranza”. La conoscenza del finito procede per approssimazioni, riconduce l’ ignoto al
noto, l’ incerto al certo. Ma tra finito e infinito vi è un baratro incolmabile: una incommensurabilità
che esclude ogni proporzione. Non ci è consentito intendere l’ infinito attraverso successive
mediazioni: Dio è assolutamente trascendente e non vi è proposizione da noi asseribile che possa, in
qualche modo, intenderne la natura. Cusano avverte, però, che “quanto più profondamente saremo
dotti in questa ignoranza, tanto più ci avviciniamo alla verità stessa”, nel senso che, se dobbiamo
riconoscerci ignoranti di fronte al baratro che separa la nostra mente dall’ infinito, non ignoriamo l’
implicazione del finito nell’ infinito. La conferma ci viene proprio dalla conoscenza del finito, che
rimane comunque indefinita e non consegue l’ assoluta identità del suo oggetto (finito). “L’
intelletto … non comprende mai la verità – scrive – in modo così preciso da non poterla
comprendere più precisamente ancora all’ infinito, perché sta alla verità come il poligono sta al
cerchio. Quanti più angoli avrà il poligono inscritto, tanto più sarà simile al cerchio: tuttavia, non
sarà mai uguale, anche se avremo moltiplicato i suoi angoli all’ infinito, a meno che non si risolva
nell’ identità con il circolo”. L’ incommensurabilità tra la mente umana e l’ infinito non esclude l’
approssimazione a quest’ ultimo. L’ esempio di un poligono che, aumentando indefinitamente i suoi
lati, si avvicini progressivamente al cerchio in cui è iscritto senza tuttavia mai coincidere con la
circonferenza, è significativo per il metodo assunto da Cusano nell’ approssimazione all’ infinito.
Non la retorica e l’ eloquenza degli umanisti e dei classici, non la “disputatio” degli scolastici, bensì
l’ analogia matematica. Egli non giunge alla matematizzazione della natura operata da Galileo
Galilei e dagli altri “filosofi naturali” moderni. Non considera neppure le analogie impiegate nella
loro valenza propriamente matematica. Ma è certo che nella ricerca della verità intende avvalersi di
un metodo rigoroso e preciso, che gli consenta di cogliere, congetturando per analogia, sulla
relazione-implicanza tra finito ed infinito. La prima operazione consiste nel recuperare quella
teologia negativa che gli scolastici avevan coltivato: ci si avvicina di più a Dio negandogli le
proprietà delle cose finite piuttosto che cercar, vanamente, di definirne le attribuzioni positive; ed il
primo passo di Cusano consiste, appunto, nell’ attribuire a Dio proprietà opposte a quelle delle cose
finite. Si può, dunque, pensare che Dio sia uguaglianza assoluta, verità assoluta … Ma si può, in un
secondo tempo, far una vera svolta e tornare indietro, e commisurare a tali proprietà divine le cose
finite. Così l’ analogia matematica mostra una sorta di movimento pendolare: le caratteristiche
molteplici e tra loro opposte della singola cosa, rinviano all’ unità assoluta dell’ infinito; e l’
infinito, che della molteplicità di qualità opposte della cosa finita è contrazione, si esplica in quest’
ultima. In un cerchio i singoli elementi sono distinti-opposti (circonferenza, raggio, corda …). Il suo
raggio può esser progressivamente dilatato, avvicinandosi progressivamente la circonferenza ad una
sua tangente, senza tuttavia giungere a coincidere con essa. La coincidenza si ha soltanto se il
cerchio è massimo infinito. E in un cerchio infinito gli opposti coincidono. E ancora: “la linea
infinita è linea, triangolo, cerchio e sfera. Ogni linea finita ha il suo essere da quella infinita che è
tutto ciò che è. Perciò nella linea finita tutto ciò che è la linea infinita (cioè linea, triangolo, ecc.) è
linea finita … Tutte le cose nella pietra sono pietra, nell’ anima vegetativa sono anima, nella vita
vita, nel senso senso … in Dio Dio”. Nell’ infinito gli opposti coincidono. Dio è “complicatio” degli
opposti e loro coincidenza. Dio, ottimo massimo, il massimo dei massimi (ma perciò anche il
minimo dei minimi) complica in sé tutte le cose, così come, per analogia, l’ unità numerica è la
complicazione di tutti i numeri. E l’ universo è l’ immagine-esplicazione di Dio.