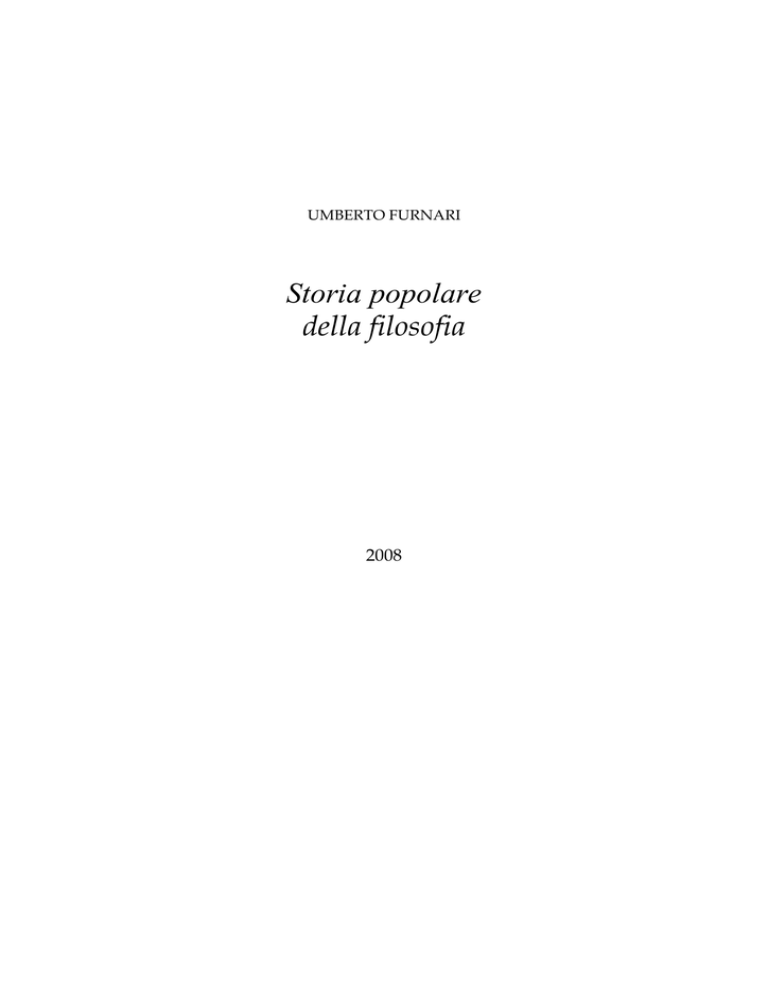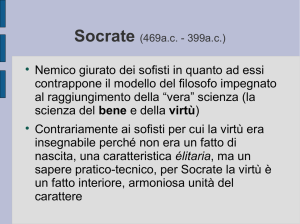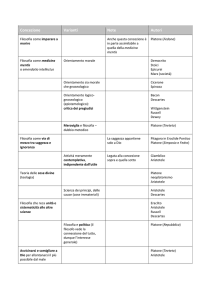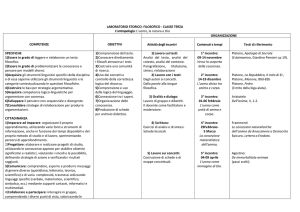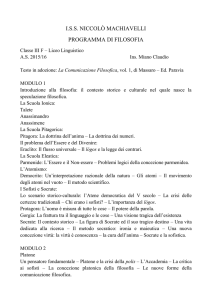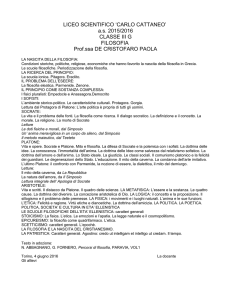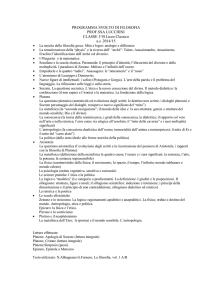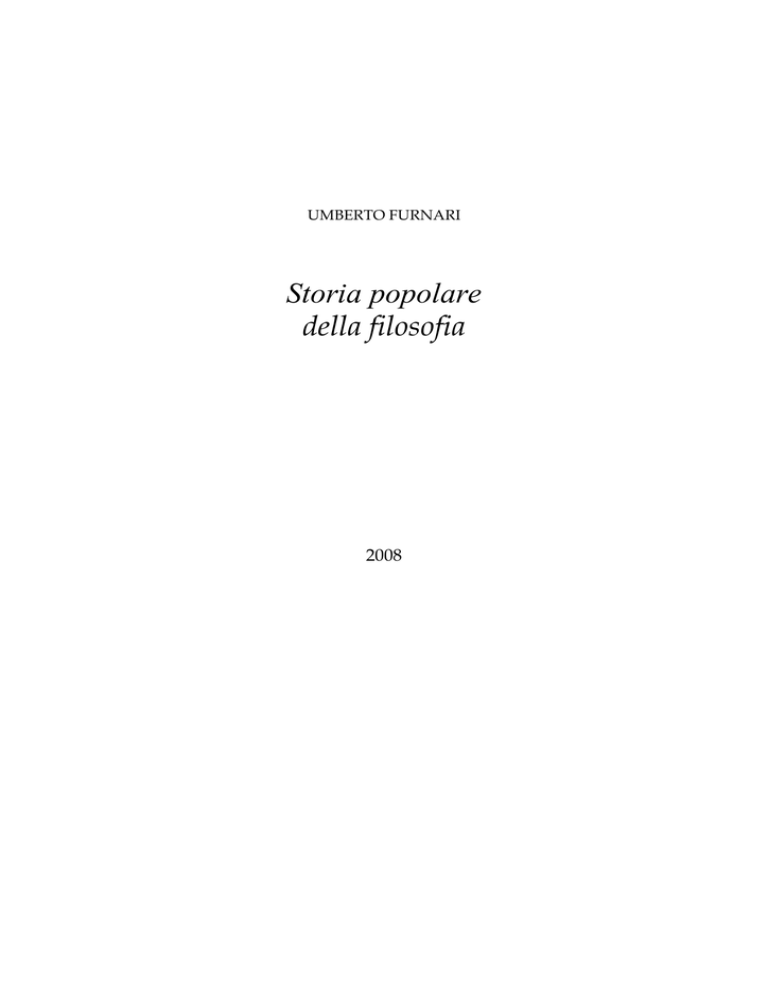
UMBERTO FURNARI
Storia popolare
della filosofia
2008
Agli Alunni
di Filosofia
Prefazione
L’epoca attuale è caratterizzata da un diffuso bisogno di cultura filosofica. Con questo lavoro
intendiamo rispondere a questo bisogno. L’uomo del nostro tempo scopre, ancora una volta, la sua
caratteristica fondamentale di essere costruttore del suo destino, dunque responsabile di ciò che
egli è. La filosofia è nata nel contesto di una cultura sostenuta da una grande vocazione alla
conoscenza. I greci del VII secolo a. C. disponevano di un sistema di sapere che era idoneo a
soddisfare l’innato desiderio di conoscere che è proprio dell’uomo. Tale sistema era costituito
dalla complessa trama del mito. Domande radicali come quelle intorno all’origine e alla
formazione dell’universo, alle leggi che governano il corso delle cose, a ciò che è bene fare e ai
modi e alle vie di conseguimento della felicità, interrogativi sul destino dell’uomo e delle cose,
dubbi e problemi, avevano nel mito la loro formulazione precisa e le risposte definitive e compiute.
Non c’era nulla da aggiungere alla compiutezza del sistema mitologico. Se, ad esempio, si voleva
sapere come fosse possibile che la terra si mantenesse sospesa nell’aria, si rispondeva che ciò era
possibile perché essa era sostenuta dalle ampie spalle di Atlante. Il mito era la puntuale risposta a
ogni problema. Quando poi si profilò la forma di una rappresentazione concettuale, si capì che la
figura di Atlante poteva essere sostituita dall’idea di una forza cosmica, intrinseca alla stessa
natura della terra e costituita con la funzione di sostenere con perfetto equilibrio i corpi celesti.
Dal mito al “logo”, dunque, dalla rappresentazione simbolica alla comprensione razionale. Si snoda così
la vicenda straordinaria della lotta della ragione per lo sviluppo di un sapere concettuale, basato sulla
trasparenza delle idee, libero e autonomo, conquista dell’uomo e non rivelazione divina.
A differenza del mito, legato alla tradizione di una determinata cultura, il “logo” è apparso fornito di una
dimensione universale, tale da potere essere accolto da tutti gli uomini e da potere, dunque, dare luogo a un
sapere “comune”. Le opinioni e le credenze sono caratteristiche di gruppi di individui; le “verità” scientifiche
sono condivise da tutti.
I primi filosofi hanno inteso cogliere la sostanza primordiale ed eterna di cui sono costituite tutte le cose:
essi chiamarono “natura” il sistema complessivo della realtà in quanto formato da una sostanza unica e
sottoposto a una legge costante e immutabile di continua trasformazione. Parmenide, il maggiore filosofo
della Magna Grecia, chiamò tale sostanza “essere”, contrapposto agli enti determinati, dando così avvio alla
metafisica. Tutti gli enti traggono la loro identità e il loro significato dall’essere. L’uomo, ad esempio, è
espressione di ciò che in generale è la condizione umana.
Se dapprima i filosofi hanno ricercato la sostanza unica e immutabile, successivamente sono passati a
indagare i principi fondamentali e immutabili dell’agire pratico e dello stesso comportamento civile e morale.
Socrate, in particolare, era convinto che il principio della vita politica fosse la virtù, configurata in primo
luogo nella giustizia. Platone ha spostato la riflessione sul piano dello stato, ritenendo compito del filosofo
tracciare le linee della repubblica ideale. Al filosofo spetta costruire la scienza dell’uomo sulla base
dell’ordine cosmico e definire, pertanto, i caratteri della perfetta esistenza. L’umanità razionale si realizza
nello stato fondato sulla giustizia e sul sistema complessivo delle virtù. La filosofia si delinea come scienza
ontologica dell’uomo e della sua felicità.
Per Aristotele la costruzione dell’edificio scientifico è già di per sé attuazione della essenziale natura
umana. L’uomo, infatti, si realizza, in primo luogo, come soggetto dell’attività teoretica, cioè come ente che
conosce se stesso e il mondo. Il sistema enciclopedico del sapere riflette il sistema dell’intera realtà. La
metafisica è la scienza fondamentale. Essa è scienza dell’essere e, immediatamente dopo, scienza dell’ente
primo e perfetto, Dio: la metafisica si profila, pertanto, in un secondo momento, come teologia razionale,
ipotesi intorno al senso fondamentale della realtà.
Le scuole filosofiche dell’antichità hanno inteso liberare gli uomini dai pregiudizi e dalle false
opinioni, instaurando, nei diversi ambiti della cultura e della vita, il dominio della ragione. Perciò
Lucrezio tesse l’elogio di Epicuro, che ha allontanato la paura degli dèi e della morte e ha espresso
il senso delle serene immensità cosmiche. La vita secondo ragione è il rimedio contro ogni pena
dell’anima. Lo stoico romano Seneca è stato maestro di tranquillità spirituale.
La filosofia, così, partecipa al dolore umano e, dandone ragione, concorre a superarlo:
richiama, quindi, l’uomo al suo destino autentico, che è l’intelligenza dell’ordine dell’universo e la
costruzione, nel mondo, di opere che attestino il potere dello spirito. Le forme della comunità
umana, l’articolazione della vita sociale, la comunicazione planetaria sono altrettante
manifestazioni della razionalità.
Ragione e intelligenza sono, per il cristianesimo, le scintille divine presenti nell’uomo, ciò per
cui l’uomo appare fatto ad immagine di Dio. Le verità razionali sono il massimo traguardo a cui
possa aspirare l’uomo nella sua condizione naturale, a parte, cioè, tutto ciò che appartiene al
soprannaturale e alla trascendenza. La filosofia, in quanto espressione propria della ragione
conoscitiva, rappresenta il culmine sulla via del sapere e informa di sé tutti gli aspetti e tutte le
forme della conoscenza. Ma qui in qualche modo la ragione appare subordinata all’ordine delle
verità rivelate. La filosofia perciò doveva tornare a lottare per riacquistare l’autonomia del sapere
concettuale. La cultura del rinascimento è il campo proprio in cui la ragione si protende e si
avventura negli stessi spazi infiniti, in cui prima si era riconosciuta l’impronta della trascendenza.
Dio stesso diveniva un oggetto della conoscenza razionale. Filosofi come Bruno e Campanella
esprimono questa istanza. Essi rappresentano l’audacia della ragione, nella sua espressione
estrema.
Nell’età moderna il soggetto razionale è visto come il criterio per cui si delinea una
rappresentazione oggettiva del mondo. L’oggettività, in quanto espressione della ragione,
costituisce il piano della scienza universale. Essa configura il reale come misurabile e calcolabile:
come un dato matematico. Più che alla costituzione ontologica del reale in sé, l’attenzione è rivolta
alla struttura della rappresentazione. L’oggettività non riguarda le cose in sé, bensì i “fenomeni”.
Analogamente per Vico conoscibili sono solo i fatti storici: l’uomo è capace di conoscere ciò che
egli fa e i processi e le leggi del fare.
Ma la distinzione tra soggetto e oggetto era superata dall’idealismo: la ragione, piuttosto che
meramente soggettiva, appariva come struttura e forma del reale; per Hegel, come forma del
“divenire”. nello stesso tempo come fondamento della trama concettuale e come criterio della
storia. Sembrano così annullate d’un colpo tutte le antinomie: tra soggetto e oggetto, tra finito e
infinito, tra essenza e fenomeno, tra struttura e storia.
La crisi dell’idealismo è esplosa nel mezzo della cultura dell’Ottocento, con l’effetto di una
lacerazione difficilmente ricomponibile.
Forse la filosofia aveva osato troppo? Si era spinta fino ad assumere la forma di un’impresa
inaudita? Probabilmente la storia del pensiero di questi ultimi due secoli riguarda lo sforzo
compiuto per restituire un senso alla speculazione filosofica. Deposta ormai ogni pretesa di dar
luogo a un sapere concettuale universalmente valido, la filosofia si è incamminata per sentieri
alternativi, procedendo, d’altra parte, a rivedere il suo cammino e tentando, quindi, di percorrere
vie nuove, in stretta solidarietà col rinnovamento dei processi scientifici e delle forme artistiche. Il
multiforme campo dell’esperienza si è aperto davanti a una razionalità problematica, rivolta a
definire se stessa.
Se, dunque, la prima grande epoca della filosofia (quella antica e quella medievale) era
dominata dalla fiducia nelle possibilità umane di costituire una scienza delle “essenze”,
corrispondenti all’essere immutabile delle cose e la seconda epoca (quella moderna) ha per
protagonista il soggetto, considerato nella sua struttura trascendentale, come idoneo a stabilire
una scienza universale della realtà oggettiva, l’epoca attuale è caratterizzata dal senso del dubbio
e della problematicità, per cui, tramontata la metafisica delle essenze immutabili e venuta meno la
certezza stabilita dal soggetto, quest’ultimo si rivolge a una prospettiva di ricerca intorno alle
possibili vie del sapere e della morale, non rinunciando definitivamente alla speranza di
rintracciare, per queste vie possibili, il senso della realtà, ma inevitabilmente consapevole che,
comunque ipotizzato, questo senso appartiene alla natura e alla dimensione di quel domandare
radicale che sembra inseparabile dalla costituzione dell’essere umano.
CAPITOLO I
L’uomo e la filosofia. Perché l’uomo è naturalmente filosofo
La filosofia, in quanto espressione dell’attitudine a conoscere, fa parte della natura umana e risponde al
bisogno di disporre di una rappresentazione concettuale del mondo dell’esperienza, in rapporto allo sviluppo
del sapere scientifico, come forma di conoscenza universalmente riconosciuta e rivolta a tradurre in discorso
l’intelligibilità del reale.
La filosofia nasce dalla meraviglia
Platone ed Aristotele fanno risalire la filosofia all’atteggiamento umano di meraviglia di fronte allo spettacolo del
mondo circostante. Emanuele Severino rileva che la filosofia risponde al bisogno dell’uomo di padroneggiare in qualche
modo l’imprevedibilità degli accadimenti e degli stessi fenomeni naturali. Ad ogni modo, si tratta di una componente
ineliminabile dell’esperienza e della cultura dell’uomo.
La filosofia (“amore della conoscenza”) risponde a un bisogno costitutivo della natura umana, al bisogno di
conoscere. Tra tutti gli esseri, solo l’uomo manifesta questo bisogno e aspira a soddisfarlo; egli è obbligato a
procurarsi le condizioni della stessa sopravvivenza, dandosi una essenziale conoscenza della realtà
circostante. Mentre tutti gli animali che popolano la terra sono dotati di sistemi istintivi di comportamento
nei confronti dei molteplici problemi della sopravvivenza, gli uomini devono sopperire a questa
“mancanza” di strumenti innati di orientamento nel mondo con forme di rappresentazione che consentano
loro di dominare le situazioni in cui vengono a trovarsi e di approntare soluzioni ai problemi che di volta in
volta si profilano nel corso della loro esperienza.
Gli uomini provano dapprima meraviglia di fronte a tutto ciò che si presenta al loro sguardo e la filosofia nasce
appunto da questo sentimento, come hanno opportunamente osservato Platone e Aristotele. A Teeteto, che
nel dialogo omonimo confessa di meravigliarsi di fronte ai fenomeni connessi alla ininterrotta
trasformazione delle cose, Socrate ribatte che questo è l’atteggiamento più naturale e più proprio dell’uomo.1
Secondo il mito ricordato da Platone, la filosofia esprime il bisogno di conoscenza e la possibilità di soddisfarlo.
In qualche modo, la filosofia, impersonata in Iride, sarebbe un nuovo dono degli dèi agli uomini: il dono
della libera indagine e della scoperta della verità attraverso l’esperienza e il ragionamento; essa avrebbe la
funzione di rispondere agli interrogativi che assillano l’umanità e di eliminare via via gli aspetti angosciosi
dell’esperienza. Infine la meraviglia si è tramutata in fiducia nell’esperienza e nella ragione, in sicuro
affidamento agli strumenti del logos (il discorso filosofico e scientifico).
Vedere e sapere
Platone ha rilevato che “sapere” è sostanzialmente un “vedere”, riferendosi al ruolo fondamentale che, per lo
sviluppo dell’esperienza, assume il senso della vista, il cui progressivo differenziarsi, secondo gli studiosi di
antropologia, ha determinato un atteggiamento di distacco e di separazione (in opposizione alla primitiva situazione di
“fusione” e di identificazione) rispetto al mondo esterno, che ha assunto la configurazione di realtà da comprendere
attraverso la conoscenza basata sulla rappresentazione (specialmente concettuale e razionale).
La filosofia è ritenuta una componente fondamentale della realtà umana. L’uomo sarebbe per sua natura
filosofo, cioè amante del sapere, desideroso di conoscere. La sua stessa struttura fisica e corporea
attesterebbe questa costitutiva conformazione di un ente particolarmente inclinato alla conoscenza. In realtà,
secondo l’etimologia della parola greca, “so”, conosco, vuol dire “ho visto”: dunque il sapere coincide col
vedere ed è il risultato dell’avere visto, dell’avere osservato i diversi aspetti della realtà. Il senso della vista è posto
alla base e alle origini del sapere. L’uomo conosce in quanto vede: e vedere vuol dire discernere, distinguere,
fissare le forme delle cose. Il sapere deriva innanzitutto dalla visione delle distinte forme della realtà. Perciò la
stessa etimologia si estende alla parola “idea” che vuol dire la cosa veduta e quindi saputa. In realtà, il
sapere si costituisce come processo di trasposizione delle cose sul piano della rappresentazione mentale. Le
rappresentazioni sono figure, immagini, forme e, quindi, concetti. La prima conoscenza è il dispiegamento della
visione dell’orizzonte che comprende le diverse forme del mondo. Da una parte si estende la visione complessiva
del mondo come totalità delle cose e dall’altra si ha la visione di ciascuna cosa nella sua precisa identità. Le
1
“Non mi pare, caro amico, che Teodoro abbia opinato male sulla tua natura. Si addice particolarmente al filosofo
questa tua sensazione: il meravigliarti. Non vi è altro inizio della filosofia, se non questo, e chi affermò che Iride era
figlia di Taumante non fece male la genealogia” (Platone, Teeteto, 155 d-e). Qui la meraviglia è impersonata in
Taumante, secondo l’etimologia di taumazo, “mi meraviglio”; e Iride impersona la filosofia. In realtà Iride, come
ambasciatrice tra gli dèi e gli uomini, aveva il compito di interpretare ed esprimere la meraviglia umana di fronte ai
fenomeni e di attingere dagli dèi conoscenze che potessero soddisfare il naturale desiderio di conoscere proprio degli
uomini. Più recentemente Emanuele Severino ha rilevato che lo stupore di fronte agli accadimenti è la prima radice di
ogni indagine conoscitiva, per cui si sviluppa non solo la ricerca “scientifica” delle cause di ciò che accade ma anche la
volontà di dominare e prevedere gli eventi stessi, in modo da superare gli stati d’insicurezza e di angoscia di fronte al
futuro. La filosofia come epistéme, scienza certa del divenire, sarebbe sorta, dunque, e si sarebbe affermata in una
cultura particolarmente incline a disporre gli strumenti idonei ad affrontare le difficoltà e a dominare la varietà dei
fenomeni; per superare, in primo luogo, il senso angoscioso del sorgere delle cose dal “niente” e del loro ritorno ad
esso. In questo senso, le dottrine dei primi filosofi, basate sull’identificazione della materia o sostanza primordiale,
avrebbero posto le fondamenta di una scienza del divenire cosmico, attraverso la chiara visione dei processi attraverso i
quale le cose si formano e si dissolvono. Rimane, tuttavia, il senso tragico del destino al quale le cose sono sottoposte.
Perciò i filosofi hanno affrontato il problema del senso del divenire, dando risposte diverse (o ottimistiche, come ad
esempio Plotino, che vede il compimento del destino delle cose nel loro ritorno, per via dell’esperienza umana, all’Uno,
o pessimistiche, come l’epicureismo lucreziano che insiste sull’inesorabile fine delle cose). Secondo Severino, la storia
della filosofia (e della scienza) comprende insieme le due istanze: quella della costruzione di un sapere che elimina ogni
traccia di imprevedibilità dal corso degli eventi e quella della impossibilità di dar luogo a una scienza certa; ma la
conclusione sarebbe quella dell’“l’estrema impossibilità di anticipare in una Legge immutabile il divenire del mondo”.
Infatti, “proprio la filosofia, che come epistéme si presenta nella storia dell’Occidente come il primo grande rimedio
contro il terrore, proprio la filosofia come epistéme viene progressivamente distrutta lungo la storia della cultura e della
civiltà occidentale” (E. Severino, La filosofia contemporanea, p. 11). In realtà, il pensiero attuale insiste sul carattere
problematico e ipotetico di qualsiasi sapere, concordando sulla impossibilità di dar luogo a una scienza che comprenda
la totalità del reale, ma rilevando il contributo che ogni sapere reca allo sviluppo storico dell’umanità.
cose sono viste anche in funzione dei rapporti che gli uomini intrattengono con esse. Esse sono associate alla
rappresentazione dell’utilità o del danno, del piacere o del dolore. La conoscenza riguarda specialmente
questi aspetti delle cose. Infatti essa ha lo scopo di mettere gli uomini in condizione di distinguere ciò che è
vantaggioso o dannoso, ciò che va ricercato e ciò che va fuggito ed evitato.
Il senso della vista assume un incontrastato primato, tanto che, come ha osservato S. Agostino, noi usiamo
il verbo “vedere” per indicare anche l’attività degli altri sensi. Diciamo, ad esempio, “vedi come è salato”,
“vedi come canta bene”, e così via, comprendendo nel fenomeno della visione ogni altra sensazione.2
Questa particolare struttura in cui la vista occupa la funzione centrale costituisce anche un fattore di
distinzione e di separazione del soggetto umano rispetto al mondo. La realtà, più che sotto la forma della
partecipazione, si offre sotto l’aspetto dell’alterità da esplorare sempre più profondamente e
dettagliatamente.3 Nel momento stesso in cui il mondo si offre alla visione nei suoi molteplici dettagli, che
sono puntualmente colti e fissati in figure precise, esso si allontana e assume sempre di più una consistenza
autonoma e inafferrabile.4 L’uomo si identifica sempre di più con lo spirito apollineo, con la facoltà della
visione chiara e distinta, che è, nel suo sviluppo, la stessa facoltà della ragione. Le idee non sono altro, come
diceva Platone, che gli oggetti della visione intellettuale.
Le basi antropologiche della filosofia
La filosofia ha i suoi presupposti nella stessa costituzione organica dell’uomo, il quale, a differenza degli altri esseri
viventi, che dispongono di sistemi innati di istinti, intesi a rispondere a tutte le esigenze connesse alla sopravvivenza
nell’ambiente, è un ente che di volta in volta progetta se stesso e il mondo di cui fa parte, sulla base di una
rappresentazione delle situazioni possibili in cui può venire a trovarsi. L’uomo è l’unico ente la cui condizione è
l’esistenza, cioè un modo d’essere alla cui configurazione egli stesso concorre col suo pensiero e con la sua azione.
La filosofia ha, dunque, le sue basi nella stessa costituzione dell’essere umano, che, come comunemente si
dice, è l’ente dotato di ragione. E’ nella stessa struttura dell’intelligenza che vanno cercati i fattori
fondamentali della nascita e dello sviluppo del pensiero filosofico.
La mente è essenzialmente progettante: essa è capace di elaborare ipotesi scientifiche che hanno un
significato per il modello di vita umana da attuare.
L’uomo è l’unico essere vivente che si trova a dover prendere posizione circa se stesso, a dovere, cioè,
crearsi una immagine di sé e dare una interpretazione della sua stessa natura.
Questo bisogno, per cui l’uomo deve prendere posizione intorno a se stesso, rimanda al suo essere in
certo modo “incompiuto”: sulla base di una “autointuizione”, egli deve sempre “fare di sé qualcosa”.
Giustamente Nietzsche ha chiamato l’uomo “l’animale non ancora definito”. L’uomo è, per alcuni versi,
“incompiuto”, non “costituito una volta per tutte”.
2
Cfr. S. Agostino, Confessiones, X, 35: Utimur autem hoc verbo etiam in ceteris sensibus, cum eos ad
cognoscendum intendimus.[…] Dicimus autem non solum, vide quid luceat, quod soli oculi sentire possunt; sed etiam,
vide quid sonet; vide quid oleat; vide quid sapiat, vide quam durum sit (Noi usiamo questo verbo “vedere” anche per
gli altri sensi, quando li riferiamo alla conoscenza). […] Diciamo quindi non solo “vedi come risplende”, il che solo gli
occhi possono percepire; ma diciamo anche “vedi come risuona”, “vedi come profuma”, “vedi come ha sapore”, “vedi
come è duro”).
3
A proposito della centralità del “vedere” nella generale condizione dell’uomo, l’Alquié ha osservato: “L’uomo è
l’essere che vede, e, per designare la conoscenza suprema, egli non ha trovato altra parola che quella d’intuizione, che
significa ancora visione. Ora, non si vede che separandosi. Dovrebbe quindi bastare all’uomo di riflettere sulle
condizioni del suo sguardo per comprendere che il suo destino non è di sintesi, ma d’analisi, che la sua condizione non è
quella della fusione e del possesso, ma quella dell’attesa e della speranza. E se l’essenza dell’amore umano è, come
pensa Platone, l’emozione davanti alla bellezza, il segreto dell’infelicità amorosa non è da cercare in primo luogo nei
conflitti delle libertà, ma nell’impossibilità in cui si trova l’uomo di diventare ciò che vedono i suoi sensi” (La nostalgie
de l’être, p. 128).
4
Come ha osservato ancora il Morot Sir, lo sviluppo del senso della vista ha insinuato nel soggetto il “sentimento
dell’apparenza, della irrealtà del mondo che essa contempla” (Philosophie et mystique, p. 184). Lo sviluppo del senso
della vista si accompagna, perciò, con l’insinuarsi di un senso di perdita: il reale tende a presentarsi come un semplice
oggetto della visione. Da qui una specie di nostalgia verso la condizione originaria, in cui il predominio degli altri sensi,
specialmente del tatto, dava all’uomo la sensazione di essere immerso nella vita stessa delle cose. “Edipo non si è tolto
gli occhi per non più vedere la realtà, ma per sfuggire a un mondo d’illusioni, per entrare in un nuovo destino che deve
condurlo verso il possesso della saggezza e verso la esistenza autentica” (Ib.).
Che è, dunque, l’uomo, alla cui costituzione appartiene, tra l’altro, il sapere filosofico? Occorre
considerare ciò che vi è di specifico nell’uomo, cioè l’uomo come “progetto particolare” della natura. Infatti
nell’uomo la natura ha avviato una tendenza organizzativa ed evolutiva particolare, non altrimenti
riscontrabile, tanto che l’esistenza umana è apparsa come qualcosa di miracoloso e straordinario, neppure
spiegabile con le leggi naturali.5 Proprio dell’uomo (della stessa organizzazione biologica corrispondente
all’”esistenza”) è che la sua esistenza diventi il suo proprio compito. L’uomo non semplicemente “esiste” ma
dispone di capacità per progettare la sua esistenza; egli non tanto “vive”, ma “dirige” la propria vita. E ciò è
possibile sulla base di capacità che si esplicano attraverso gli strumenti dell’intelligenza - la mano, l’occhio, il
linguaggio - cioè, in una parola, mediante il pensiero. La determinazione a pensare e ad agire è la condizione
generale di tutte le funzioni e capacità umane: essa è già nell’organizzazione corporea dell’uomo. L’uomo,
cioè, come essere fisicamente strutturato, è tale che può sopravvivere (e vivere) solo in quanto pensa
(percepisce, immagina, ragiona, parla, discorre) e agisce. Dal punto di vista morfologico, l’uomo è caratterizzato
da una serie di “carenze” e “inadattamenti” (non specializzazioni, primitivismi). In condizioni “naturali”,
originarie, cioè in ambienti non trasformati dalla sua attività, egli non avrebbe i mezzi di sopravvivenza.
L’”apertura” dell’uomo al mondo significa che egli “difetta” degli strumenti specifici dell’adattamento. La
sopravvivenza, perciò, per l’uomo, è un problema. L’uomo è soggetto a una serie infinita di stimoli, che deve
infine padroneggiare. L’uomo, cioè, è capace di trasformare quelle che sono, in una condizione “naturale”,
difficoltà insormontabili per la sopravvivenza in fattori di sviluppo dell’esistenza. Questa situazione
“problematica” dell’esistenza fa sì che l’uomo solo in quanto possiede l’attitudine alla filosofia (che coincide
con la messa in questione di ogni aspetto della realtà) risolve (dà soluzioni provvisorie e possibili) ai
problemi di fronte ai quali via via viene a trovarsi. La “questione filosofica”, dunque, appartiene alla
costituzione dell’esistenza ed è molto più profonda dei modi in cui l’attività del pensiero filosofico si è
venuta sviluppando nella storia della cultura.
Trasformando attivamente il mondo in qualcosa di utile alla vita, l’uomo dà luogo a una “seconda
natura”, alla “cultura”. L’”ambiente” proprio dell’uomo è sempre un ambiente culturale, cioè un “mondo”:
non esiste l’uomo allo stato “naturale”. Il mondo percettivo che vediamo intorno a noi è il risultato
dell’attività peculiare dell’uomo. Esso è, già sotto il profilo ottico, “simbolico”, cioè un campo di allusione ad
esperienze (che sono possibilità dell’agire umano). L’uomo via via apprende le modalità del dominio dei dati
dell’esperienza. La complessa articolazione e manifestazione di impressioni è trasformata in una serie
significativa di “cose”, ciascuna delle quali contiene una quantità di allusioni a possibili forme di
padroneggiamento e, dunque, a particolari campi di attività. Così l’uomo può guardare con tranquillità
intorno a sé, dominando una serie di elementi ad alto contenuto simbolico: mentre l’animale si trova ogni
volta irretito direttamente nel campo di stimoli rappresentati dalla situazione contingente, l’uomo invece
può ritrarsene, prendere le distanze da esso, rendendo disponibili i diversi dati per l’intera programmazione
della sua attività. Mediante la rappresentazione simbolica, l’uomo spezza il cerchio dell’immediatezza, nel
quale l’animale resta prigioniero e crea intorno a sé uno “spazio vuoto”, lo spazio di un mondo pienamente
dominabile, allusivo e disponibile. Egli accumula una grande riserva di capacità variabili, che possono essere
impiegate ovunque si presentino opportunità vantaggiose. Nel pensiero e nel linguaggio si compie l’esonero
dalla pressione del “qui” e “ora” e dalla reazione al contingente e al casuale. In ciò, inoltre, è racchiusa ogni
possibilità di intesa tra gli uomini, sulla base della comune tendenza all’attività, a un mondo comune e a un
comune futuro.
L’uomo è “filosofo”, già dal punto di vista biologico, in quanto è caratterizzato dalla “non
specializzazione”, dall’”apertura al mondo”, dalla necessità di doversi procurare le possibilità e le condizioni
della sua esistenza. Perciò l’uomo vive una specie di “indefinitezza” e la sua natura si esprime in un progetto
sempre aperto verso possibilità nuove e che di volta in volta deve essere definito.
La filosofia si iscrive in questa “indefinitezza” e risponde al bisogno dell’uomo di definire il suo essere
stesso e, insieme, l’orizzonte del mondo in cui vive e, al limite, dell’intera realtà. Si può dire che quest’ultima
istanza abbia costituito la principale spinta alla riflessione: la filosofia, almeno per un lungo periodo della
sua storia, è coincisa col tentativo di abbracciare sul piano concettuale l’intera realtà, considerata nel suo senso e
nella totalità dei rapporti tra gli enti che essa comprende.
Indubbiamente, si tratta della tendenza propria dell’uomo a colmare la sua “incompiutezza” e ad attuare in modo
il più completo possibile quell’”esonero” dall’infinito profluvio di stimoli e di domande che gli giunge dall’ambiente
circostante.
Secondo questa ipotesi di interpretazione generale dell’esistenza umana, i diversi livelli ai quali si attua il
padroneggiamento dell’esperienza (a partire dallo sviluppo del sistema motorio per arrivare all’astrattezza
5
Arnold Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, tr. it., Feltrinelli, Milano 1983, p. 63.
del pensiero matematico e alla filosofia) non sono altro che espressioni e forme diverse di una medesima
attitudine, che cresce, per così dire, su se stessa e si dà, via via, configurazioni più articolate, in rapporto ai possibili
problemi che si presentano nell’ambito dell’esistenza. La filosofia corrisponde a un livello di rappresentazione
concettuale, “scientifica” e razionale del “mondo” in cui si svolge l’intera sfera dell’esperienza umana.
Gli studiosi che hanno esaminato il problema relativo all’evoluzione dell’intelligenza hanno rilevato che
l’uomo da una condizione “primitiva” di sostanziale fusione con la realtà è passato via via a una condizione di distacco
e di separazione. La realtà si è sempre di più allontanata dalla soggettività umana, per configurarsi come una
sfera autonoma, distinta rispetto alla sfera delle percezioni, delle emozioni, dei pensieri e delle azioni
dell’uomo. L’uomo si è trovato, così, di fronte a una realtà estranea, interamente altra, da indagare e scoprire nei suoi
segreti nascosti e da dominare col pensiero e con l’azione.
Alcuni fattori hanno determinato questo passaggio. A. Le Roy,6 che ha esaminato il “processo di
ominizzazione”, consistente nel progressivo distacco dell’uomo dall’animalità, ha rilevato che in tale
sviluppo una funzione preminente è da attribuire al progressivo prevalere del senso della vista. Gli occhi, nel
momento in cui rivelano l’esistenza del mondo esterno, allontanano il soggetto dalla realtà e lo rendono
estraneo ad essa, sicché ormai la conoscenza del mondo diventa un problema. La realtà esterna appare
lontana e inafferrabile e il soggetto incomincia a disporre le più varie strategie per ristabilire un contatto col
mondo, per riuscire a dominare la realtà e renderla intelligibile. In tal modo, l’intelligenza, come capacità
rappresentativa, acquista una sempre maggiore importanza. Nell’esperienza primordiale, invece, la
sensibilità stabiliva un contatto immediato con la realtà. Come ha osservato acutamente E. Morot-Sir, nella
scoperta sensoriale del reale, emergono due funzioni, con attività specifiche e complementari: il tatto e la
vista. L’uno compie la scoperta immediata del dato sensibile ed è connesso al senso del reale. La vista, al
contrario, con la sua attività di rappresentazione, tende a separare la sensazione dalle cose, isolando la
coscienza e costituendola come spettatore di un mondo in cui si svolgono degli eventi. In questo modo, la
coscienza del reale si compie in un distacco. E ad un certo punto può accadere che le rappresentazioni
appaiano come semplici apparenze, fantasmi creati dalla mente.7 La funzione eminente acquistata dal senso della
vista ha favorito lo sviluppo dell’intelletto come facoltà dell’elaborazione concettuale. C’è, infatti, una profonda
analogia tra la visione sensibile, rivolta alla distinguere nei loro minimi dettagli le cose, e la comprensione
intellettuale, anch’essa analitica. L’idea, come sappiamo, è originariamente l’oggetto della visione, la forma
colta con estrema precisione. L’osservazione dei fenomeni costituisce un presupposto della scienza,
altrettanto quanto lo è l’intelletto. In tal modo si è sviluppata la facoltà della determinazione, rivolta a cogliere
e comprendere l’identità di ogni forma, al di là dell’apparenza visiva, attraverso la visione intellettuale.
L’evoluzione psichica, come ha rilevato D. Katz, procede verso un’emancipazione dell’intelligenza dal
complesso percettivo, e “l’uomo non è soprattutto caratterizzato dal fatto che anch’egli abbaia forme
percettive, ma piuttosto dal fatto che, a differenza dell’animale, è capace di emanciparsi da esse”8.
La filosofia riflette, in modo particolare, questa tendenza della mente umana a emanciparsi dalla
“apparenze” sensibili, per pervenire a una comprensione di ciò che il reale “è” per se stesso, si può dire,
indipendentemente dai modi in cui viene percepito. La sua nascita, infatti, si colloca nel momento in cui dalla
rappresentazione della realtà in simboli e figure esemplari (specialmente nel mito) si passa a una comprensione
concettuale (per cui il logos stesso venne considerato l’essenza e la struttura “vera” della realtà). Già dai pitagorici la
realtà è concepita come un sistema di rapporti numerici, aritmo-geometrici, cioè sostanzialmente come un
sistema interamente intelligibile, la cui via di accesso non è quella empirica della manifestazione sensibile
della realtà, bensì quella intellettuale dell’astrattezza matematica. Si può dire che, nell’impostazione di
questa ipotesi di interpretazione della realtà, sia già presente in nuce l’intero programma della scienza esatta
della natura, quale sarà realizzato nell’età moderna. Per Platone l’intelligibilità coincide con la realtà stessa,
considerata nei princìpi della sua costituzione: le idee, che sono le strutture fondamentali della
determinazione, per cui l’essere indefinito si dispiega nella molteplicità degli enti, sono interamente
intelligibili, in quanto forme per la visione intellettuale. Nell’ambito di questa prospettiva si è sviluppata,
quindi, la tecnica, come procedura basata sulla scienza analitica e rivolta ad agire sul reale, scomponendolo e
ricomponendolo artificialmente. I timori e le perplessità che oggi si profilano intorno alle conseguenze della
tecnica sono dovuti al fatto che esse appaiono imprevedibili, per cui lo sviluppo scientifico, disposto per
difendere l’umanità dall’”imprevedibilità del divenire” (secondo una nota espressione di E: Severino),
appare oggi come il fattore irrimediabile dell’imprevedibilità stessa.
6
7
A. Le Roy, Les origines humaines et l’evolution de l’intelligence, Paris 1931.
E. Morot-Sir, Philosophie et mystique, Paris 1948, p. 184.
8
D. Katz, La psicologia della forma, tr. it., Einaudi, Torino 1950, p. 196.
CAPITOLO II
La nascita della filosofia
La filosofia è lo sbocco proprio delle forme dell’esperienza culturale, sapienziale, religiosa e politica dei
Greci. Essa costituisce lo specchio in cui si riflette il progetto di fondazione di un’umanità caratterizzata da
forme comuni di pensiero e di azione, dunque tale da superare i differenti modelli di civiltà contrapposti.
Le fondamentali componenti della cultura greca
Le ragioni della geografia. L’ambiente storico
La filosofia è sorta a Mileto, colonia greca dell’Asia Minore, dunque riflette un ambiente caratterizzato da forti spinte
alla libera circolazione delle idee e allo sviluppo di nuove esperienze culturali e politiche, quali erano favorite dalla
configurazione territoriale di reciproca integrazione di terre e mari. Ulisse è l’emblema dello spirito greco, proiettato
verso un mondo aperto e mai compiuto, mai pago delle esperienze compiute e sempre intento a cercare e definire la
propria immagine umana.
Se la filosofia è connaturata alla condizione dell’esistenza umana, altrettanto essa sembra naturalmente
appartenere alla forma dell’ambiente in cui si è sviluppata la civiltà nel cui ambito essa, nella maniera in cui
la conosciamo in Occidente, è sorta e ha avuto quindi la sua storia. Il contesto territoriale del mondo greco è
quello proprio dell’arcipelago, di un sistema proiettato nel mare attraverso una inseminazione di isole e di
penisole, in un giuoco complesso e mirabile di prolungamenti e di rientranze, di rispecchiamenti e di fughe,
ove per gli uomini si disegna un destino di continua ricerca, di partenze e di ritorni, di avventura e di
espansione, di continuo essere in viaggio e, nello stesso tempo, di nostalgica memoria e di fortissimo
attaccamento alla propria terra. Ulisse è esploratore per vocazione ma uomo che mette in questione la
propria vita per tornare in patria, vagabondo per il vasto arcipelago mediterraneo, dove le diverse terre sono
in comunicazione e il mare è appunto la grande via che le mette a contatto e continuamente le mette al centro
di un progetto politico proiettato al di là di confini stabiliti.9 La terra è perciò immagine e simbolo
dell’esistenza, di una situazione che non si riconosce in una stabilità permanente, ma che assume come
proprio il destino della temporalità, col continuo andare oltre e tendere verso qualcosa, di cui è espressione
emblematica la curiosità, come desiderio mai appagato e sempre risorgente di conoscere. Come
nell’immagine dell’Ulisse dantesco, solo il contatto col mistero (l’estremo confine della terra) pone fine alla
curiosità, attraverso il naufragio nell’elemento stesso dell’oltrepassamento (il mare che mette in
comunicazione le varie terre e stabilisce un rapporto e una tensione tra le varie conoscenze e le diverse
modalità dell’esistenza). “Nel carattere assolutamente specifico della sete di Ulisse – ha osservato Massimo
Cacciari – si riconosce la forza irriducibile della coscienza di Europa”. Il grande fattore ambientale che ha
presieduto alla nascita della filosofia rappresenta oggi l’emblema del compito immenso di fronte al quale
viene a trovarsi la civiltà europea (attraversata dalla riflessione razionale): costituire un ponte tra le varie
parti del mondo ed essere ancora una specie di luogo del dialogo tra le diverse culture e il tramite
dell’unificazione planetaria. Quella sete di sapere unitario ora diventa la spinta alla ricerca di un programma
organico di unificazione del pianeta. Ulisse si presenta ora come la figura-simbolo della civiltà planetaria che
è coesistenza delle esperienze nelle quali si riflette lo spirito inquieto che è sempre in viaggio, pronto a
cogliere e decifrare i segni del “nuovo”, e tuttavia esposto al rischio estremo, che la hybris tragica della sfida
all’Altro può tramutare in naufragio.
Comunque, questo appare il traguardo dello spirito europeo: la scoperta del “Dio straniero”, la meraviglia
di fronte alla bellezza e alla verità del multiforme arcipelago delle culture “diverse”. E ciò sarebbe il
compimento del grandioso progetto avviato alle origini della civiltà greca, limpidamente rispecchiato
nell’irrequieta anima di Ulisse, il simbolo dello spirito che è attratto dalla ricerca continua della sua dimora.
Tale ci appare il quadro geo-storico della nascita della filosofia: un “ambiente” in cui configurazione fisica
e forma della cultura sono così compenetrati da costituire un’unità indissolubile. L’uomo greco vive in un
mondo praticamente senza confini e costituito in modo che a lui spetti continuamente andare “oltre”,
9
. Cacciari, L’Arcipelago, Adelphi, Milano 1997.
valicando i limiti provvisori via via posti e, infine, fare ritorno in patria e chiudere, così, circolarmente
l’esperienza del suo avventuroso viaggio attraverso i possibili territori dell’esistenza.
Il mondo omerico e la formazione dell’ideale greco dell’umanità
In Omero troviamo, come in nessun altro testo, la rappresentazione dell’umanità come destino storico, soggetto
spirituale che è alla continua ricerca di sé.
Nei poemi omerici troviamo una rappresentazione dell’uomo che costituisce un indubbio superamento
della concezione magico-misterica e prelude a una vera e propria “liberazione” dai condizionamenti della
ritualità tradizionale. Nella sfera magico-misterica tutto ciò che è compiuto dagli uomini rientra in un ambito
definito di comportamenti e azioni rituali: agli individui non rimane altro che ripetere ciò che è stato
compiuto dai loro predecessori, secondo procedure e modalità fissate una volta per sempre. Si può dire che
il mondo omerico è, invece, ormai il mondo delle azioni libere, anche se ancora domina il concetto di un
principio che è al di là di ogni volontà e si identifica con la necessità fatale cui tutte le cose sono sottoposte, il
campo delle azioni umane presenta una varietà e una mobilità che preludono alla scoperta della libertà
spirituale. L’atto eroico è quello che consegue nuovi obiettivi e arricchisce la sfera storico-sociale di elementi
che prima non erano presenti, assicurando ad essa sempre nuovi orizzonti e possibilità di sviluppo. La sfera
umana è identificata in un processo di continuo sviluppo, il cui principio, la cui regola e la forza propulsiva sono interni
ad essa. Così si afferma in una forma esplicita ed esemplare il principio della autonoma creatività spirituale: si
suppone che almeno alcuni individui collaborino con gli dèi e ricevano da essi suggerimenti e aiuto a portare
a termine imprese straordinarie, che si concludono non solo con qualche definito vantaggio materiale ma
anche con ‘arricchimento dell’intero patrimonio di cultura e di civiltà con l’acquisizione di nuove conoscenze
e abilità tecniche. Gli dèi omerici esprimono le stesse possibilità umane e simboleggiano le forme esemplari
dell’esistenza. Essi rappresentano, per così dire, la società ideale degli uomini, che comprende i principi e le leggi
per cui una società può reggersi e svilupparsi. La giustizia, la legge, la saggezza, la tecnica, la scienza, la
moderazione, l’intelligenza, la bellezza, e così via, appaiono nella molteplicità delle loro funzioni, come
condizioni di una serena e armonica comunità. Si tratta di una vera e propria scoperta dell’umanità come
universo autonomo, che ha in sé i principi del suo sviluppo.
L’idea di una realtà spirituale che viene formandosi secondo leggi e principi intrinseci è già chiaramente
delineata nella concezione omerica degli dèi come forze attive, che intervengono continuamente a disporre
‘ordine delle vicende umane. Gli dèi rappresentano il patrimonio di spiritualità che si esprime nel mondo
degli uomini, sovrintendendo ad esso, in mood specialmente che sia mantenuto entro i limiti della sua
identità peculiare, che sono quelli di una misura che non va travalicata, cioè di una razionalità che riconosce i
suoi stessi limiti. Così abbiamo l’idea dell’umanità come formazione storica. Più che come ripetizione di atti e
comportamenti esemplari, stabiliti una volta per sempre, la vita degli uomini è concepita come continuo
sviluppo, come processo inarrestabile di formazione, dunque come ricerca, cammino inquieto verso se stessa
(come Ulisse in viaggio errante verso la patria). In ciò consiste il superamento della visione propria delle
società primitive, fondate sulla ripresentazione di modelli immutabili di vita e d’esperienza. Con l’immagine
di un’energia spirituale supposta come perfetta e in sé compiuta (sul piano divino) ma tale da riversarsi e
manifestarsi sul piano dell’esistenza umana come processo storico, invenzione di cose nuove, strumento di
civiltà operosa, la concezione dell’uomo compie un salto radicale. Ciò che conta è la manifestazione del
divino nella storia, il rapporto tra l’ordine immutabile e il suo farsi evento. L’organizzazione della vita
spirituale ha una dimensione temporale: essa è governo e risoluzione di problemi che si presentano nelle
diverse circostanze e che esigono di volta in volta forme di risoluzione, che, pur riportandosi a modelli
esemplari, assumono le caratteristiche dell’esistenza storica. Perciò l’aedo canta il succedersi degli eventi, più che
l’ordine stabilito una volta per sempre. Gli dèi omerici sono le forze attive che agiscono e si manifestano
attraverso gli uomini. In quanto soggetti di eventi, gli uomini dispongono specialmente dell’intelligenza,
come facoltà propria e peculiare. Il patrimonio di sapere di cui, ad esempio, Ulisse dispone è il risultato di un
lungo apprendimento e di una multiforme esperienza.10 Così abbiamo l’idea dell’esperienza tradotta in
scienza, epistéme, sapere basato sulla multiforme visione delle cose. Ulisse è colui che ha molto visto e
osservato. Dall’interesse per le forme delle cose nasce la conoscenza. Il mondo già appare in Omero come un
10
Polymatis vuol dire: “dall’intelligenza molteplice”, “ricco d’ingegno”, “che sa molte cose”, “che ha molto
imparato”; e polymatia: “sapere enciclopedico”, “conoscenza molteplice”, “esercizio in tante discipline”. Manthano,
“imparo”, deriva da men e dho, corrispondente al latino animum adverto, “rivolgo gli occhi a qualcosa”.
cosmo razionale, interamente accessibile all’intelligenza, all’uomo che abbia la forza di scrutarlo e di fissarlo
nella costante contemplazione.
E’ ovvio, pertanto, che, per Omero, la più grande sventura è la morte, che chiude al mortale lo spettacolo
molteplice del mondo. Achille dice che preferirebbe essere l’ultimo servo sulla terra anziché re
nell’oltretomba. Tuttavia la fondamentale certezza dell’uomo è il suo destino di essere mortale.
Il nesso tra mondo umano e realtà divina è il motivo fondamentale della concezione omerica: in effetti, le
due sfere costituiscono una sola realtà. Le decisioni degli dèi sono i sentimenti degli uomini; la comunità
olimpica è specchio della polis. Questa realtà unitaria è lo spirito greco, ciò che di più straordinario e sublime è
toccato agli uomini di avere in dono.
Le forme della sapienza greca: mito, mistero, enigma, “logos”
La cultura greca rappresenta il terreno nel quale affondano le radici della nostra civiltà e nelle cui componenti ancora
ci riconosciamo, tanto più se pensiamo che l’altro grande filone culturale, l’ebraismo biblico e il cristianesimo, si è
venuto integrando e ha assorbito in sé, specialmente attraverso il dialogo tra ragione e fede continuato per l’intero
periodo medievale, l’esperienza di pensiero dei Greci. In questo senso mito, mistero, enigma, logo costituiscono ancora le
forme in cui si declina la civiltà cristiana (che si identifica con la stessa civiltà europea). Queste forme rappresentano i
modi in cui si è prospettato, nel suo sviluppo storico, il problema della conoscenza: il mito è la conoscenza dispiegata
nelle figure simboliche e nella trama degli eventi originari, l’enigma coincide con l’emergere della forma problematica,
per cui l’uomo avverte che si trova di fronte a problemi da risolvere e che la conoscenza è una sfida e una conquista per
mezzo dell’intelligenza, il mistero è il residuo inintelligibile, per la cui comprensione è necessario lo stesso intervento
divino, cioè la rivelazione. Questa situazione ha attraversato l’intera storia della cultura ed è ancora quella che
caratterizza il nostro tempo. In particolare, essa è tipica della cultura cristiana, in cui, appunto l’apporto della verità
rivelata assume un rilievo fondamentale e appare come decisivo per la costruzione del nostro sistema della conoscenza.
Mito, mistero, enigma, “logos” costituiscono le componenti essenziali della sapienza greca e, insieme, le tappe
fondamentali del suo sviluppo.
Il mito è il sapere fondato dalla poesia, per diretta ispirazione della divinità. Il mistero è il sapere
conquistato attraverso la partecipazione alla vita del dio. L’enigma rappresenta il momento in cui il dio sfida
l’uomo a conquistarsi un sapere autonomo. Il “logos” è il sapere scoperto dall’uomo dentro se stesso e
conseguito mediante l’intelligenza.
Come ha osservato Giorgio Colli,11 i misteri costituivano “una festa della conoscenza”, durante la quale
avveniva lo svelamento della divinità e l’uomo era ammesso alla visione della verità. La scienza così rivelata
riguardava il destino dell’esistenza come fondamentale destino di immortalità. Eleusi è, in questo senso,
come osserva ancora il Colli, il paradigma della “suprema esperienza conoscitiva”, resa possibile e
partecipata da Dioniso, il dio che è emblema dell’aspirazione umana all’immortalità.
Nell’orfismo, legato al culto di Dioniso e ai misteri eleusini, troviamo l’idea della presenza nell’uomo di un
principio immortale. Come rileva Giovanni Reale, allora è incominciata la storia della credenza nell’anima
come principio spirituale di origine e costituzione divina, presente nell’uomo come sua essenza e
provvisoriamente unita al corpo, che, invece, è di sostanza opposta, corruttibile e mortale.12
Orfeo rappresenta, in qualche modo, la sintesi di Dioniso e Apollo: perciò il Colli rileva “il nesso orficodionisiaco-eleusino”. Infatti, “Orfeo racconta la storia del dio, e avvia alla conoscenza suprema”, e, nello
stesso tempo, imita Apollo, suonando la lira. La presenza di Orfeo esprime la consapevolezza che “solo
Dioniso esiste: noi e il nostro mondo siamo la sua parvenza mendace”, e che “il conoscere è l’essenza della
vita”.13 Con l’orfismo matura già, quindi, la consapevolezza che il principio della conoscenza sta nell’anima
ed è quasi un frammento della natura divina, che l’uomo ha il compito di portare alla luce, liberandola il più
possibile dall’oscurità in cui l’avvolge la densa opacità del corpo.
La luminosità dell’anima razionale è assimilata allo spirito apollineo. La fusione e la sintesi di apollineo e
dionisiaco rappresenta, in questo senso, il culmine dell’esperienza sapienziale dei greci.
G. Colli, La sapienza greca, I.
In tal modo, è venuto sviluppandosi un nuovo modello antropologico, consistente “in una concezione dualistica
dell’uomo che contrappone l’anima immortale al corpo mortale e considera la prima come il vero uomo, o, meglio, ciò
che nell’uomo veramente conta e vale”, cioè, praticamente, in una concezione che ha inserito nella cultura europea
“un’interpretazione nuova dell’esistenza umana” (G. Reale, Storia della filosofia antica, Milano 1987, I, pp. 439, 441).
13
Ib., p. 43.
11
12
La conoscenza si configura come il frutto di una lotta dell’uomo per la liberazione dell’elemento immortale che sta
dentro di lui. Il corpo rappresenta l’opacità, ciò che ostacola la conoscenza e la salvezza: esso è la sede e la causa di tutti i
mali. La morte, in primo luogo, che è alla cima dei mali, caratterizza la vita corporea e la volge alla sofferenza e alla
dissoluzione. Il principio immortale si identifica sempre di più con la razionalità, il principio luminoso dello spirito
apollineo. La conoscenza, però, diventa anche principio di immortalità, secondo la tradizione dionisiaca. Se la
conoscenza si configura secondo il modello apollineo, come svelamento dell’ordine dell’universo, dunque come
espressione della ragione, d’altra parte essa assicura l’immortalità, poiché libera l’anima dalla opacità corporea che
l’avvolge e la restituisce alla originaria condizione divina. L’anima, in quanto frammento della divinità (di Dioniso),
conosce tutto, per cui si tratta, dopo la sua incarnazione, di condurla a riacquistare la sua natura originaria. In tal
modo, Dioniso e Apollo diventano componenti dell’anima, parti dello spirito umano, così come esso si configura in
quanto creatore della cultura greca.
Il mistero celebra la presenza del divino nel mondo umano. Esso è il tempo in cui la divinità scende tra gli
uomini e li investe della sua luminosità e della sua sapienza. La presenza del dio è promessa di immortalità
e di partecipazione alla condizione divina, anticipata attraverso la celebrazione dei riti sacri (tra cui il
banchetto in cui il corpo della stessa divinità era distribuito tra i fedeli).
Prima che il “logos” erediti questa esperienza di sintesi di divino e umano, la sapienza greca passa
attraverso il momento che possiamo dire “agonistico”, nel quale il dio sfida l’uomo ad acquistare da solo
quella conoscenza che prima riceveva dalla rivelazione e acquistava, quindi, attraverso un’esperienza di
partecipazione alla condizione divina. La consapevolezza della presenza nell’anima dello spirito dionisiaco e
apollineo conduce, cioè, l’uomo stesso a ricercare dentro di sé le condizioni della conoscenza. Ma egli sa che,
in questo modo, si pone in una specie di situazione agonistica, cioè di aperta sfida con la divinità. Questa
esperienza sapienziale si configura come posizione e soluzione di problemi, cioè come “incontro” (durante il
cammino e sulla via ritorno alla “patria originaria”) di “enigmi”, cioè di domande minacciose intorno al
mistero dell’esistenza. La soluzione dell’enigma radicale (che comprende una domanda sull’uomo, sulla sua
costituzione e sulla sua storia) pone fine alla sudditanza dell’uomo rispetto alla divinità e apre l’era del
pieno dispiegamento dell’intelligenza.
Il “logos” è il pensiero umano che coglie, comprende ed espone (nel discorso) l’ordine razionale
dell’universo. Esso contiene gli elementi presenti nello spirito apollineo e nello spirito dionisiaco, sintetizzati
nello spirito della conoscenza, intesa questa anche come fattore di liberazione escatologica, “salvezza”
definitiva, restituzione alla natura originaria e recupero dell’immortalità.
Apollo e Dioniso, due paradigmi della sapienza greca
Apollo e Dioniso rappresentano le due opposte forme della spiritualità greca: l’uno simboleggia lo spirito della
identità, della distinzione, dunque della visione chiara e della compiuta comprensione delle cose; l’altro rappresenta la
condizione di “fusione” dell’uomo nel Tutto. L’intera cultura greca sarebbe il frutto del confronto, variamente
articolato, tra questi due atteggiamenti. Nietzsche ha cercato di dimostrare che il momento poetico della tragedia
(specialmente di Eschilo e di Sofocle) costituisce l’esperienza della sintesi più felice dei due momenti: in particolare
questi si esprimerebbero da una parte nella complessa avvertenza del divino in quanto inspiegabile causa degli eventi
umani e dall’altra parte nella progressiva conquista, da parte degli uomini, di una consapevole e responsabile capacità di
azione. La filosofia è la più alta espressione dello spirito apollineo. Per essa l’universo assume la forma della trasparenza
e della chiarezza razionale.
Apollo e Dioniso rappresentano le due fondamentali forme della sapienza greca: da una parte, il sapere
che distingue le cose, numera e comprende l’ordine dell’universo, cioè il sapere esatto, incontrovertibile,
comunicabile, razionale; e, dall’altra parte, il sapere mistico, fondato sull’unione con la divinità, partecipato
direttamente, misterico, costituito come esperienza della salvezza dai limiti della finitezza e della mortalità.
Apollo è il paradigma dell’ingegno umano che si dispiega nel mondo; e le Muse, il cui consiglio egli
presiede, rappresentano le diverse attitudini spirituali che convergono nella poesia, identificata come la via
attraverso la quale lo stesso dio comunica il sapere agli uomini. In questo modo, si esalta specialmente
l’opera dell’uomo nel mondo e, insieme, la sua trasfigurazione nel canto che intende perpetuarne la
memoria. Le Muse, infatti, sono figlie di Mnemosine. Clio presiede al canto epico, e così insegna la via
attraverso la quale gli uomini possono guadagnarsi la memoria e la gloria mediante la poesia (cioè la via
della virtù e dell’eroismo); Euterpe dà al canto la melodia che lo rende piacevole; Talia collega il canto alla
celebrazione festiva, per cui gli uomini si sentono vicini agli dèi; Melpomene e Tersicore collegano la poesia
alla musica e alla danza, completando la triade indissolubile in cui si articola l’esperienza sapienziale; Erato
suscita il desiderio di questa esperienza; Polimnia alimenta la varia ricchezza dei ritmi; Urania eleva il canto
fino al cielo, cioè fa sì che esso congiunga l’umano e il divino; Calliope cura la bellezza della voce, facendola
risplendere della stessa luce che illumina le cose (Apollo, tra l’altro, è il dio della luce). La poesia è il regno
della parola: in essa si rispecchia lo spettacolo dell’universo e si racconta la storia degli uomini: ogni aspetto
della realtà vi è rappresentato, l’intero universo è declinato nel complesso unitario di canto, musica e danza.
Apollo è, perciò, il dio che presiede alla creazione umana, le cui opere riproducono l’armonia del cosmo. A
questo dio si riconduce la radice del progetto dell’umanità razionale.
Dioniso rappresenta l’altro lato della spiritualità greca: il lato misterico (o mistico) dell’esperienza
religiosa come partecipazione all’immortalità del dio. Tale partecipazione è anche rivelazione della sapienza.
L’assenza della conoscenza della via della salvezza costituisce il vero limite dell’uomo, costretto a errare
attraverso il dolore, la continua ricerca, il desiderio inappagato, il dissidio e la contraddizione. Nella tragedia
confluisce questo tipo di sapere, connesso all’esperienza dionisiaca. L’enumerazione dei mali e delle
sventure costituisce un motivo costante della poesia tragica. Ma già anche in Omero, che riflette, in
particolare, la visione apollinea del mondo e dell’esistenza, trova posto una tale riflessione. Perciò Dioniso
completa Apollo e colma il limite dovuto a quel margine di oscurità che la luce apollinea non riusciva a
diradare e che era rappresentato dal dolore e dalla morte, nonché dalla incerta raffigurazione del destino
dell’uomo nell’oltretomba. Dioniso vince pure quel margine di oscurità e assicura all’uomo spirituale
l’immortalità e il possesso di una conoscenza piena: egli è, perciò, il dio che colma il limite dell’esistenza e
restituisce l’uomo alla compiutezza armoniosa del “tutto”.
La grande opposizione: “uranico” e “ctonio”
I Greci hanno avuto chiara la distinzione tra il “cielo” (impersonato da Urano) e la “terra” (impersonata da Gea), la
sede delle divinità e quella degli uomini; e che era distinzione tra l’elemento secco, proprio della realtà immutabile,
definita una volta per sempre, e quello umido, proprio delle cose soggette al mutamento.
La cultura greca conosce un’altra grande opposizione: quella tra l’elemento “uranico” e l’elemento
“ctonio”. Il primo rappresenta il principio dell’ordine e della distinzione, il secondo quello del caos e
dell’indistinzione. Possiamo articolare intorno a questa fondamentale coppia di opposti una serie di termini
che, in modi diversi, si riportano a tale dualismo.
Sul piano metafisico, troviamo l’opposizione tra l’unità e la molteplicità, tra il limite e l’illimitato, oppure tra
l’essere e il divenire. Si ha l’idea che lo sviluppo della realtà è basato sul rapporto dialettico tra questi termini.
Da questo punto di vista, l’opposizione che troviamo in Anassimandro (tra l’apeiron e il péras), nei pitagorici
(tra il dispari e il pari, tra il definito e l’indefinito, e così via), in Parmenide (tra l’essere e l’ente) ha una funzione
analoga.
Sul piano cosmologico, il dualismo si riflette, ad esempio, in modo preciso nella distinzione aristotelica tra
la sfera sovralunare e quella sublunare, l’una sede della perfezione e dell’immutabilità, l’altra sede del
divenire, con le cose mutevoli e corruttibili.
Sul piano antropologico, abbiamo l’opposizione tra il principio razionale e quello sensibile, tra l’intelletto e
l’impulso vita, tra la contemplazione delle forme ideali e il piacere illimitato.
Sul piano politico, abbiamo la distinzione tra la sfera pubblica e quella privata, l’una sede della libertà e
dell’uguaglianza civile e giuridica, l’altra sede della violenta affermazione dell’individuo e della necessità
naturale. Così lo spazio pubblico è segnato dall’ordine, dal rispetto della legge, da rapporti armonici e
regolati in vista del bene comune; lo spazio privato, invece, è il campo della competizione sfrenata, della
violenza e della lotta tra gli individui e i gruppi. Inoltre, nell’ambito della città si consegue quella specie di
immortalità che è riservata agli eroi, cioè ai cittadini che si sono distinti per azioni meritevoli di gloria.
Invece nella sfera privata predominano il dolore, la morte e la dimenticanza.
La tragicità della condizione umana sta nel fatto che essa è collocata al centro di questo dualismo e che,
pertanto, è sottoposta alla pressione di forze opposte. Da una parte, l’uomo partecipa dell’ordine uranico (e
in questo senso egli è essenzialmente “politico”), e d’altro lato è esposto alle forze naturali, alla necessità del
lavoro, alla penuria e alla sofferenza. La logica ctonia adotta un modello di “giustizia” basato sul sangue e
sulla vendetta; invece il modello uranico segue la volontà di Zeus (“Dike” impersona questo modello). Il
dramma dell’uomo consiste, dunque, nel fatto che egli è esposto al principio irrazionale della vita
indifferenziata, che lo porta ad agire secondo l’impulso e il desiderio, e in modo che, pur nell’ambito
dell’esistenza ordinata della città, egli non possa mai essere sicuro di essersi comportato secondo giustizia. In
particolare, poi, le forze terrestri talvolta si impadroniscono della città, e allora si scatenano disordini e si
hanno violenti cambiamenti di regime politico: la tirannide, ad esempio, è l’assunzione violenta del potere al
di là dell’ordine stabilito: Così si hanno casi in cui è la stessa avidità di ricchezze (un principio “terrestre”) ad
esercitare il potere. La tragedia greca è la rappresentazione di alcuni accadimenti paradigmatici connessi a
questa condizione contraddittoria dell’uomo. Essa riguarda, specialmente, i fattori ctonii che ostacolano
l’attuazione della giustizia politica ed espongono l’ordine della città alle forze irrazionali che occupano
generalmente la sfera privata.
Il “nomos”: da ordinamento divino a criterio umano
I Greci hanno avuto fin dai tempi più antichi l’idea che l’universo è governato da una legge inflessibile, di cui
ministro era considerato il Fato o la Necessità. Tutto ciò che accadeva era inteso come l’esecuzione di un destino
immodificabile e del tutto estraneo alla volontà degli uomini. L’esperienza politica, con la molteplice articolazione
dell’attività legislativa nelle diverse città, contribuì a diffondere il concetto della origine umana e sapienziale del sistema
di leggi preposto all’ordinamento della società.
Il sostantivo greco nomos, “legge”, dal verbo némein, “spartire”, rimanda a un atto legislativo
fondamentale, cioè a una originaria attribuzione alle cose dell’universo di un proprio “stato”, mediante
l’assegnazione a ciascuna di esse di qualità specifiche, immutabilmente stabilite. Il “nomos” di Zeus,
identificato col principio legislatore, rappresenta, in questo modo, il fondamento di ogni “diritto”, per cui
ogni ente rivendica ciò che gli è attribuito come “proprio” e nessuno può travalicare la condizione
assegnatagli. L’ordine stabilito da Zeus regna sovrano, è veramente il supremo basileus, che mantiene tutto ciò
che sta nel mondo (dèi, uomini, cose) in perfetto equilibrio, sotto il dominio di una legge inflessibile
(qualcosa come un “destino”), configurata come “Moira”. Il senso di questo vocabolo allude, infatti, a un
ordinamento spaziale delle cose in seguito a un’assegnazione per sorteggio (moira, “parte toccata in sorte”:
cfr., ad esempio, Iliade, XV, 195, dove si ricorda come i tre figli di Crono, Zeus, Rea e Posidone, abbiano avuto
in sorte rispettivamente i regni del cielo, della terra e del mare). Così, come è detto in un frammento di
Eraclito, Elios (il sole) segue in cielo un percorso definito e se deviasse le Erinni, guidate da Dike, lo
riporterebbero sulla rotta stabilita, perché la vicenda notte/giorno appartiene all’ordine immutabile
dell’universo. E se i sovrani, nell’esercizio del loro potere, emettono sentenze inique, Zeus stesso infligge
terribili punizioni. Dike, che rappresenta la giustizia nell’ordine del mondo, interpreta i decreti custoditi da
Themis, la quale, a sua volta, amministra le norme legislative poste da Zeus come cardini dell’ordine
cosmico. A Zeus spetta di stabilire la conformità degli istituti umani e delle decisioni politiche alla legge
divina (ad esempio, egli invalida la disposizione di Creonte relativa al divieto di dare sepoltura a Polinice).
La legge così stabilita esclude da ogni cosa l’”indifferenza”: ogni cosa, infatti, è costituita sulla base di
qualità determinate, che la identificano per ciò che è e in modo che non possa trapassare in altro, restando se
stessa. Non si pone una differenza tra ciò che è stabilito per decreto di Zeus e ciò che vale per natura (katà
physin). Con la parola “natura” non si indica altro che l’ordinamento seguito dalle cose stesse, cioè il fatto che
ogni cosa si comporta secondo la legge stabilita. E’ la medesima “dike” che costituisce la matrice di ciò che è
regolare nel divenire universale e di ciò che è “giusto” (legittimo) nella sfera dei rapporti umani. Esiodo ci
rappresenta come i misfatti degli uomini vengano puniti mediante catastrofi naturali: si tratta, infatti, dello
stesso ambito normativo. Solone, invece, in un momento successivo, stabilisce la catena di delitti e punizioni
che si dà nell’ambito della sfera politica, distinguendo i due ordini, quello naturale e quello politico: così i
delitti dei capi che usurpano i beni della comunità provocano la rivolta violenta dei cittadini e la decadenza
della città (Fr. 3, 17-28).
In questo modo, affiora già l’idea di un ordine umano, nel quale sono gli uomini i soggetti che agiscono,
creando lo spazio pubblico della città e successivamente contribuendo, con le loro prevaricazioni, a
corromperlo e, quindi, con gli opportuni interventi (anche punitivi) a ristabilirlo. Il poeta legislatore, infatti, è
consapevole della sua opera, rivolta a porre riparo a una situazione di crisi e a ristabilire un ordine di
giustizia ad Atene. 14 Egli, in particolare, trova in sé quella “misura” che è criterio di azione legislativa e che
viene trasferita nella costituzione politica.15
14
Cfr. Solone, fr. 3 Diehl: “La nostra città, secondo il volere di Zeus e la disposizione d’animo degli dèi immortali,
non morirà mai; una troppo grande custode protende le mani su di essa, Atena dal coraggio inesauribile, figlia della
potenza di Zeus. I cittadini stessi, invece, schiavi della ricchezza, con la loro incoscienza, fanno di tutto per mandare in
rovina la loro potente città; gli intendimenti dei capi del popolo sono contro la misura della giustizia […]. [Essi] non
risparmiano né i beni sacri né quelli dello stato e rubano e rapinano chi di qua chi di là a più non posso, senza osservare
“Ordine” e “misura” nell’universo. L’idealizzazione del mondo sensibile,
le geometria e l’inizio del processo di matematizzazione della natura.
L’idea che l’universo è costituito “secondo ordine, peso e misura”appartiene all’esperienza culturale più antica ed è
comune a diversi ambiti di civiltà. Infatti gli uomini vengono a contatto, dapprima, con il regolare, alterno ciclo delle
stagioni, del giorno e della notte, della stessa nascita e morte degli esseri che popolano la terra. Questa comune
esperienza si è, progressivamente, rafforzata e arricchita di elementi di misurazione esatta, attraverso l’osservazione del
periodico ritorno delle stelle alle medesime posizioni in intervalli determinati, matematicamente calcolabili, dunque. e
oggetto di studio. L’astronomia può dirsi la prima scienza esatta, fondata su dati di calcolo numerico. I numeri
divennero così oggetto di studio a sé e sono stati considerati come base di ogni realtà e di ogni accadimento.
Proclo, nel suo commento a Euclide, riporta un giudizio di Eudemo, secondo il quale Pitagora avrebbe
per primo elevato la matematica alla dignità di “disciplina libera” (eleuthéra paidéia), risalendo ai suoi
princìpi e trattandone i problemi in modo puramente teorico. Oggi si riconosce che le nozioni matematiche,
che nelle altre culture ebbero uno sviluppo essenzialmente “pratico”, divennero per opera dei greci oggetto
di speculazione scientifica.
i venerandi capisaldi di Giustizia. […] Allora si apre fra i cittadini una ferita che coinvolge ognuno e la città precipita
nella vergogna della schiavitù, mentre si ridestano la discordia civile e la guerra a far perire l’amore e la giovinezza di
tanti. Per opera di fomentatori di discordia, infatti, in breve la città si disgrega mentre si formano le fazioni care a chi
non ama la giustizia. […] Questo l’animo mi comanda d’insegnare agli Ateniesi, che un cattivo ordinamento appresta
alla città una massa di sventure, la buona costituzione invece rivela tutte le possibilità di rodine e regolarità e sovente
riesce a incatenare gli ingiusti; appiana le asperità; pone fine all’ingordigia, annebbia la prepotenza, dissecca i germogli
dell’insano delirio, raddrizza i giudizi fraudolenti, addolcisce i frutti dell’orgoglio, fa cessare le opere della discordia,
rende innocui i rumori della contesa deforme; tutto, nella buona costituzione, è per gli uomini regolato secondo la retta
misura”. Solone, quindi, illustra i punti fondamentali della sua opera di legislatore (fr. 5): “Ho concesso al popolo tante
prerogative quanto bastava, senza togliergli nulla di quel che gli era dovuto e senza esagerare; mi preoccupai anche di
coloro che avevano in mano il potere ed erano segnati a vista per la ricchezza, perché non accadesse loro nulla di
sconveniente. E mi posi, fermo, come uno scudo impenetrabile per entrambi, per non permettere che nessuno dei due
partiti ottenesse una vittoria tale da sconvolgere le proposizioni della giustizia. […] in questo ordinamento il popolo
potrà seguire vantaggiosamente i reggitori, non troppo lasciato a se stesso e non troppo oppresso; infatti l’ingordigia
genera dismisura e prepotenza, quando un benessere troppo largo si accompagni a uomini che non abbiano una mente
regolata”. Come si vede, qui il merito di un giusto ordinamento e di una vita cittadina armonica è attribuito
all’equilibrio umano, così come alla mancanza di “misura” nello spirito degli uomini è ascritta la decadenza della città
nel disordine e nella discordia. In realtà, qui affiora il concetto dell’uomo che è capace di costituire, da sé, “misura”
dell’ordine cittadino. Il legislatore non fa altro che esplicare questa capacità, che egli possiede in un grado eminente.
15
Come osserva Aldo Masullo, il passaggio da una concezione “teologica” del diritto a una concezione
“antropologica” si compie allorché si scopre nell’uomo stesso un criterio di “misura”: “Per difendere l’umanità
dell’uomo dalla prevaricazione religiosa, senza gettarla nella pulviscolare dispersione della mera effettualità, anziché
sopprimere la distinzione tra la dimensione effettuale e quella normativa, bisogna scoprirne la mediazione o nesso
dialettico nell’uomo medesimo, nel faticoso lavoro comune con cui gli uomini costruiscono le relative stabilità della
cultura. Si tratta insomma non di negare lo scarto tra il fatto e il valore, tra la natura sempre individuata e differente e
l’universale, tra le cose e azioni da misurare e la misura con cui misurarle, ma di cercare nell’ambito stesso dell’uomo
l’origine della misura. O, se si vuole usare un’espressione irreligiosamente religiosa, si tratta di cercare nell’umano
stesso, e non fuori di esso, il divino, che è appunto quella religiosità che fece accusare d’irreligione il Socrate platonico”
(Metafisica, Milano 1980, p. 48).
La fondazione scientifica della matematica (specialmente della geometria) avviene nell’ambito di un
atteggiamento speculativo che investe tutti gli aspetti della cultura. Il Cassirer la riporta a un concetto che
nella cultura greca costituisce la categoria fondamentale in virtù della quale sono interpretati tutti i processi
fisici e umani: il concetto di “misura” o di “limite”, che è l’espressione tipica di una visione razionalistica
(“apollinea”), rivolta a definire, comprendere esattamente, contemplare in forma di figure idealizzate gli
aspetti mutevoli del mondo.16 Husserl ha analizzato in modo esemplare il processo di fondazione del
pensiero geometrico a partire dalla tendenza alla definizione di forme ideali, intese come espressioni razionali
del limite. La geometria nasce da una idealizzazione delle forme esperite nel mondo fisico direttamente
intuito. In questo mondo noi esperiamo forme corporee, che possono essere liberamente plasmate
dall’immaginazione; ma questa non può che trasformare le forme sensibili in altre forme sensibili; invece il
pensiero geometrico compie l’idealizzazione completa di quelle forme, il loro assoluto “perfezionamento”.
Le “forme pure” corrispondono alle forme spazio-temporali assolutamente idealizzate, cioè proiettate in uno
spazio ideale. 17
Poiché l’universo delle forme geometriche è una realtà esattamente pensabile e determinabile in tutte le
sue parti e strutture, esso finì presto per costituire l’oggetto privilegiato di ogni scienza rivolta all’esattezza e
all’onnicomprensività (l’epistéme medesima). L’universo delle forme geometriche si presenta, così, come
l’oggetto proprio di ogni pensiero che cerca di oltrepassare la sfera mutevole del sensibile e di raggiungere la
sfera immutabile dell’ideale, che è fatto coincidere con lo stesso essere in sé. L’idea di un’epistéme globale,
configurata come scienza matematica dell’intero reale, si precisa in modo netto nei pitagorici.
Giorgio de Santillana ha rintracciato l’idea dello spazio puro in Parmenide, il quale, come è noto, definisce
l’essere come continuo.18 Egli, da un esame attento del testo, desume il concetto di “puro spazio geometrico”,
sul quale si fonderà la geometria euclidea.19 Infatti, questa geometria richiede che lo spazio abbia le tre
proprietà indicate da Parmenide, cioè: 1) sia continuo; 2) sia uguale, completamente omogeneo, in modo che
le figure possano essere spostate liberamente da luogo a luogo senza che si alterino le loro proprietà
geometriche; 3) sia isotropo, ossia lo stesso in tutte le direzioni, cosicché le figure possano essere ruotate
senza che in esse avvengano mutamenti.
Col concetto del “continuo”, Parmenide superava le difficoltà connesse all’atomismo numerico dei
pitagorici. Perciò, proprio il filosofo dell’essere sviluppa per primo una riflessione logica sull’idea di
numero, riuscendo a concepire un “continuo” come substrato del numero stesso.20 Il concetto di “continuo”
16
“Ciò che rendeva i greci capaci di possedere questo tesoro nascosto nella geometria è il fatto che il concetto di
misura sta al centro di tutto il loro pensiero e del loro modo di concepire l’universo. Questo concetto non è limitato ad
un campo particolare e non si esaurisce in applicazioni speciali: esso comprende l’essenza del pensiero dell’essere. E’
compito di ogni conoscenza trovare il limite e la misura delle cose, il péras nell’apeiron. Ma il concetto di misura
oltrepassa di molto questa funzione puramente intellettuale. Esso rappresenta non solo il nucleo di ogni ordine cosmico,
ma anche di ogni ordine umano: sta al centro dell’etica, come pure della logica. Per i pensatori greci più antichi i due
aspetti del concetto di misura non sono ancora distinti. Eraclito vede nel concetto di misura (métron)il legame che
unisce il divenire del mondo e l’esistenza umana: tutti e due cadrebbero nel caos, se non fossero legati da misure
rigorose” (E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, tr. it., Torino 1961, vol. IV, p. 82).
17
“Al posto della prassi reale – sia di quella attiva, sia di quella che considera le possibilità empiriche e ha a che fare
con corpi empirici e reali-possibili – abbiamo ora la prassi ideale di un ‘pensiero puro’ che si mantiene esclusivamente
nel regno delle pure forme-limite […]. Ma questa prassi matematica ci permette di attingere ciò che ci è negato nella
pratica empirica: l’’esattezza’; perché, per le forme ideali, sorge la possibilità di determinarle in un’assoluta identità
[…]. Da questo punto di vista esistono singole forme privilegiate, come, ad es. le linee rette, i triangoli, i cerchi. E’ però
possibile – ed è stata questa la scoperta da cui è nata la geometria – costruire grazie ad esse, che sono generalmente
disponibili, forme elementari privilegiate e non soltanto, mediante operazioni attuabili con esse, sempre nuove forme
univocamente e intersoggettivamente determinate grazie al metodo che le genera. Perché infine si dischiuse la
possibilità di costruire tutte le forme ideali pensabili in generale mediante un metodo a priori onnicomprensivo e
sistematico” (E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, tr. it., Milano 1961, pp. 5556).
18
Parmenide dice dell’essere: “Né esso è divisibile perché è tutto uguale, e non c’è un di più che gli impedisca di
essere continuo, né un di meno, ma tutto è pieno di essere. Perciò esso è tutto continuo, perché l’essere è connesso
all’essere […]. Ma poiché il limite estremo è definito da ogni parte, come una sfera ben rotonda, esso è equidistante dal
centro in tutte le direzioni, poiché non può essere in una direzione più grande e in un’altra più piccola. Né vi è il nonessere ad impedirgli di adeguarsi all’eguaglianza, né è possibile che l’essere sia qua più e là meno, perché esso è tutto
inviolabile. Infatti esso è da ogni parte uguale a se stesso e sta in modo uguale nei suoi limiti” (fr. 8, vv. 22 sgg.).
19
Cfr. G. de Santillana, Prologo a Parmenide, in “De homine”, nn. 22-23, settembre 1967, pp. 7-50.
20
“Nella riduzione della geometria ai numeri, per poter esprimere tutte le grandezze geometriche che si presentavano
nella teoria delle proporzioni, si aveva bisogno di una unità comune per misurare tutte quelle grandezze che
contiene una critica (e costituisce un superamento) del concetto pitagorico dello spazio come insieme di
“punti” separati da “vuoti”. Analogamente lo spazio pitagorico non è “isotropo” e risulta da un intrecciarsi
di direzioni stabilite sulla base di coppie di opposti (alto/basso, destra/sinistra, avanti/indietro). Lo spazio
parmenideo, invece, non implica misura definita (rimane, perciò, base e condizione di ogni misura),
grandezza (dunque non pone limite al grande o al piccolo), luogo (dunque supera ogni limitazione spaziale
ed è condizione di ogni spazio definito), parti (non può diventare maggiore o minore): è, perciò, il
fondamento di tutte le determinazioni e di tutte le relazioni, il substrato che non ha forma ma che è matrice
di tutte le forme.21
Da questo punto di vista, l’”essere” di Parmenide rappresenta il momento estremo di un processo di
astrazione e di idealizzazione che (anche attraverso la via della geometria) investiva ormai l’intera realtà. Il
concetto di “essere”, corrispondente al “reale” come “assoluto” idealizzato, “intelligibile” puro, costituiva lo
strumento idoneo a consentire l’intelligenza di ogni aspetto del reale, al di là dei limiti dell’esperienza
sensibile. E l’”essere” come “spazio puro” rappresenta la condizione generale della pensabilità matematica,
per cui il reale si configura come una particolare determinazione del “possibile” logico, che rientra nel
dominio del puro pensiero.
In realtà, sembra che a questo punto, una volta scoperto il principio metodico di pensabilità del reale nella
sua assolutezza, indipendentemente, cioè, dalle sue forme particolari, si sia dischiuso qualcosa come la
metafisica come conoscenza assoluta. In questo senso, è tanto più significativa l’affermazione di parmenide,
che presenta la sua dottrina dell’essere come rivelata dalla stessa divinità. Tra conoscenza divina e
conoscenza umana si stabilisce una fondamentale uguaglianza. L’“essere” di Parmenide costituisce
quell’unità di misura universale che consente di comprendere razionalmente ogni aspetto della realtà, sia
pure in modo approssimativo (poiché oggetto di conoscenza assoluta è solo l’essere). Il pieno sviluppo di
questo complesso concettuale si ha, appunto, con Platone, il quale, con lo sviluppo della metafisica dell’essere
dell’ente e con la critica dell’essere/uno parmenideo, mostra la via attraverso la quale la pensabilità e
l’intelligibilità riguardano le determinazioni dell’essere, assunte come forme ideali.
“Dialéghein”, “dialéghesthai”, “dialogos”
I Greci ebbero particolare attitudine alla discussione: la libera espressione delle opinioni e il confronto tra le varie
tesi erano ampiamente adottate nell’età dell’aristocrazia, allorché il governo era esercitato dall’assemblea dei grandi
proprietari terrieri, che rivestivano dignità di “primi inter pares”. Conosciamo da Omero le continue diatribe che
sfociavano spesso in alterchi, per i quali si rendevano necessari gli interventi dei più saggi. Nel successivo periodo della
democrazia, il confronto delle idee si avvaleva di particolari strumenti retorici appresi a specifiche scuole. Comunque il
dialogo divenne la forma di ricerca in comune e venne elevato a forma classica del discorso filosofico da Platone. La
civiltà greca e antica è generalmente una civiltà del dialogo e il dialogo è il genere letterario più comune e diffuso.
Il verbo “dialéghein”, “dialéghesthai”, frequente in autori del V secolo, ma già presente in Omero, indica
l’attitudine a concordare una linea di condotta comune attraverso il confronto delle varie opinioni. Esso si
riferisce al perseguimento di uno scopo attraverso (“dia”) il discorso (“lèghein”). Dunque, “dialéghein” vuol
dire ”discutere convergendo su qualcosa”, parlare insieme per giungere a una conclusione comune. Ciò che
è essenziale è il concorso di più soggetti, che insieme “ragionano”: perciò il secondo elemento fondamentale
diventavano sempre più piccole. La comune misura universale doveva ridursi gradualmente ad una quantità minima al
di là di ogni misurazione, e tuttavia doveva rimanere un’unità: una specie d’infinitesimo attuale” (l. cit., p. 28).
21
“Non c’è niente che visualizzi questo genere di substrato; lo dobbiamo costruire mentalmente, passando
continuamente al limite. Checché si possa pensare tra cose o punti fissi, si suddivide continuamente all’infinito;
qualsiasi sostanza vi poniamo nella nostra immaginazione, essa si suddivide in tanti punti, e così via all’infinito, sinché
diviene evidente che ciò che noi dobbiamo afferrare è la tessitura stessa che è poi quella del continuo […]. In quel
continuo di nuovissima concezione, tutta la matematica ha il suo terreno nativo e la sua dimora. Ad esso appartengono
tutte le linee, superfici, figure, numeri, proporzioni e relazioni che lo spirito può generare. Il regno della verità è quello
della matematica nella sua formulazione più ampia quale è stata avanzata nella nostra epoca: il dominio di tutte le
possibilità del pensiero rigoroso. Esso è inalterabile e immobile, ma lo spirito si muove liberamente in esso, poiché esso
è dello spirito. Esso contiene la vita della ragione [e in questo senso si può interpretare anche l’identità parmenidea di
essere e pensiero: l’essere come “spazio” intelligibile è il “logos”, come fondamento di tutte le determinazioni, cioè di
tutte le forme]. Esso ‘è’, come ‘è’ la ragione. Tale è il vero mondo al di là dell’esperienza sensoriale, la cui esistenza è
stata rivelata a Parmenide da qualcosa che egli avvertì come ispirazione divina” (l. cit., p. 30).
è l’uso del ragionamento, l’analisi coerente delle situazioni che si presentano problematiche e intorno alle
quali si tende a trovare soluzioni che siano soddisfacenti per tutti.22
Il dialéghein indica un atteggiamento fondamentale dello spirito greco. I discorsi che Omero fa pronunciare
ai suoi personaggi (uomini e dèi) hanno una tale densità argomentativa da costituire dei veri e propri
modelli di oratoria. In essi emerge non solo la forza del ragionamento, ma anche l’armonia della forma: così
ogni situazione, trasferita sul piano della parola, assumeva già i caratteri della composizione armonica.
Non è, perciò, un caso che il dialéghein assume, infine, nel suo sviluppo più maturo, la forma del dialogos,
che è la forma più appropriata del discorso filosofico.
Il desiderio di conoscere. Eros, simbolo dell’amore per il sapere
La figura di Eros più significativa è quella tratteggiata da Platone nel Convito. Secondo il mito esposto da Diotima e
riferito da Socrate nel corso della molteplice articolazione dei discorsi in onore del dio che simboleggia la potenza
dell’amore, Eros è figlio di “Povertà” e “Ricchezza”, dunque si configura come il demone costituito essenzialmente dalla
irrefrenabile aspirazione a conoscere, a impossessarsi del sapere intorno alle cose del mondo.
“Gli uomini per natura desiderano conoscere”: con questa osservazione si apre la Metafisica di Aristotele,
l’opera fondamentale che è stata dedicata alla scienza filosofica in quanto conoscenza speculativa, costituita
solo attraverso l’attività del puro pensiero. Un tale sapere appartiene alla natura umana, è, cioè, qualcosa che
l’uomo possiede intrinsecamente,
non acquista, dunque, dall’esterno, ma viene svolgendo per via
dell’impegno mentale, della riflessione e del ragionamento. Questo carattere del sapere filosofico è stato
principalmente messo in rilievo da Platone, per il quale, come vedremo, “conoscere è ricordare”, cioè il
prodotto di un’attività creativa dello spirito, per il cui svolgimento l’esperienza del mondo è solo
un’occasione. Platone ha simboleggiato questa attitudine (che è una forte spinta interiore) al sapere nella
figura mitica di Eros, figlio di Ricchezza e Povertà, di Possesso e Mancanza, il demone che tende a
conquistare ciò che gli appartiene già per natura e di cui, tuttavia, egli avverte il bisogno. Tale è la natura
“filosofica” dell’uomo: di possedere la conoscenza ma di non averne la consapevolezza. L’uomo “sa” ma non
ha presenti (già dispiegati) i contenuti del suo sapere; egli deve via via procedere col pensiero a impadronirsi
di tali contenuti, attraverso un processo di ricerca continua, di costante “ascesi”. Questa è la forma stessa
della filosofia come sapere generato autonomamente dalla mente umana. Platone opportunamente paragona
questa condizione a quella della donna gravida che ha bisogno di qualcuno che l’aiuti a partorire. Socrate è
stato il “filosofo” esemplare, ricco di sapere ma consapevole della sua ignoranza e tuttavia capace di aiutare i
suoi interlocutori a conquistare da sé i contenuti della conoscenza. Il sapere, in altre parole, è una conquista
umana, qualcosa che appartiene più propriamente alla mente umana e del quale l’uomo deve impossessarsi,
sviluppandolo, generandolo con le sue forze, riuscendo a “riconoscerlo” come il suo patrimonio più
originario. Il sapere è il più significativo prodotto dell’attività spirituale.
La comprensione della finitezza umana
I Greci hanno specialmente considerato i limiti dell’esistenza e la realtà del dolore e della morte. Si può dire che la
loro concezione della vita sia attraversata da una nota di pessimismo, espressa dalla celebre constatazione che la cosa
migliore per l’uomo fosse il non nascere, evitando così la serie delle sofferenze a cui inevitabilmente ognuno appare
esposto inspiegabilmente per un motivo che rimane misterioso, in quanto racchiuso nei decreti del Destino che tiene
unite tutte le cose. Storicamente i Greci sostennero vicende particolarmente connesse all’imprevedibilità degli eventi: al
contrario dei popoli dell’Oriente, piuttosto stabilmente insediati dei loro territori e legati a istituzioni antiche e destinate
a conservarsi immutabili nei secoli, i Greci vissero in ambienti esposti ai pericoli del mutamento, a muove invasioni,
alla necessità di difendere con le armi le loro città e le loro istituzioni. Essi ebbero specialmente l’esperienza della
precarietà di ogni forma in cui si declina l’esistenza, dunque si trovarono nella condizione di dovere lottare per vincere
lo stesso Destino. Questa consapevolezza della finitudine attraversa l’intera storia della riflessione sull’uomo.
22
Omero usa questo verbo per indicare il ragionamento interiore mediante il quale Ulisse medita sulla sua situazione,
al fine di discernere quale fosse la decisione migliore da prendere, nel momento in cui l’eroe, rimasto solo nel campo,
dopo che gli Achei si sono dati alla fuga, delibera di restare al suo posto, mentre il combattimento infuria (Iliade, XI,
407: allà ti tauta philos dielexato thymòs;, “ma perché il cuore amico esamina queste cose?”).
La storia della comprensione greca dell’uomo è segnata specialmente dalla consapevolezza della
essenziale finitudine dell’esistenza. Il destino dell’uomo è quello delle foglie che vivono lo spazio d’una
stagione. Ciò che in particolare colpisce con una sensazione di assurdo dolore è l’esperienza della morte,
specialmente di quella improvvisa e violenta che capita nel fiore degli anni, dunque lo spettacolo della fine
tragica dei figli per una madre o quello della guerra fratricida. L’esistenza appare, in tal senso, come una
realtà misteriosa che può d’un colpo essere sottratta e della quale, dunque, si deve subire la privazione.
L’incombenza della morte è il dato che caratterizza già l’esistenza come un evento tragico, come
un’eventualità carica di dolore. La lirica greca è una riflessione particolarmente efficace e carica di
sentimento su questi aspetti dell’esistenza.
Il mito della colpa originaria. Le tappe della rappresentazione tragica: Eschilo, Sfocale, Euripide
La riflessione greca sulla condizione umana riserva un posto notevole all’irrazionale, all’inspiegabile, all’oscuro,
altrettanto di quanto ne assegna alla visione apollinea della chiarezza e della distinzione. Alla radice dell’esistenza vi è,
per i Greci, un limite radicale che è fonte di infelicità, di contrasto, di discordia. La serie di lutti seminata dalla guerra,
dalla lotta per l’espansione, per il potere e la stessa sopravvivenza, è dovuta a una colpa originaria, che grava su ogni
popolo, città o individuo e che richiede l’espiazione attraverso l’eventualità tragica. La tragedia rappresenta questa
situazione, particolarmente oscura e irrazionale. Particolarmente in Eschilo tale condizione è iscritta nel rapporto
misterioso dell’uomo con la divinità ed è vista come il segno della incolmabile lontananza del divino; in Sofocle si assiste
specialmente alla lotta dell’uomo per conquistare quella consapevolezza che è motivo principale di liberazione e di
espiazione; in Euripide, infine, la consapevolezza del mito investe l’irrazionale e lo riporta, in misura notevole, sul piano
della comprensione razionale, ora ampiamente dispiegata, in concomitanza dello sviluppo della filosofia.
La cultura greca reca in sé, nelle profondità del suo “inconscio”, si può dire, il mito di una colpa originaria,
connessa alla stessa esistenza umana. Questo mito racchiude l’intera sfera dei motivi e degli elementi di
drammaticità che accompagna la rappresentazione di un’esistenza così esposta al limite della sofferenza e
della morte. I Greci hanno avuto fortissimo il senso della precarietà dell’esistenza. Nel mito di Atlante che
sostiene sulle spalle il peso del mondo è rappresentata efficacemente questa inevitabile sofferenza alla quale
l’uomo è condannato. L’uomo deve sopportare il peso smisurato della sua stessa esistenza. La tragedia
rappresenta le vie e i modi attraverso cui l’uomo si libera dalla colpa originaria, espiandone il fio. Questa è la
condizione al cui prezzo l’esistenza si apre alla storia, allo sviluppo della civiltà. Ogni popolo ha alla base
della sua vicenda storica l’espiazione, da parte di un eroe, della colpa che costituisce, si può dire, una
componente della sua condizione originaria.
Questa caratteristica della condizione umana in generale si proietta sulla dinamica secondo la quale si
pone il rapporto con il divino. Questo rapporto si configura come tensione tragica, dunque come attesa di
eventi traumatici, che dipendono dalla imprevedibile manifestazione della potenza divina nei riguardi della
“tracotanza” umana. L’umanità è vista come la probabile portatrice di mali e di errori nel mondo. Essa
medesima si percepisce come un possibile fattore di turbamento e di sconvolgimento dell’ordine cosmico.
Ogni individuo reca in sé una passione che si spinge fino a toccare il divino ordinamento delle cose.
Prometeo sconvolge radicalmente l’ordine stabilito da Zeus, svelando all’umanità il segreto del fuoco.
L’esperienza religiosa si sviluppa come rappresentazione degli eventi originari attraverso i quali si compie la
riconciliazione col divino. Le divinità diventano guardiane e garanti del nuovo ordine che i diversi popoli
riescono a darsi. Si tratta ormai della situazione storica, cioè di quella dimensione “politica” secondo cui i
popoli si governano, avendosi dato leggi inviolabili.
La tragedia greca rappresenta questa complessa vicenda del riscatto dalla colpa originaria e della
costituzione di ordinamenti civili sul fondamento di forme tipiche di religiosità. Possiamo individuare nei
grandi autori tragici, Eschilo, Sofocle ed Euripide l’evoluzione dell’esperienza religiosa che sta alla base del
grande mito della colpa e dell’espiazione.
Eschilo rappresenta la condizione tragica nella sua forma originaria, come una situazione diretta
dall’iniziativa divina e nella quale l’umanità è destinata a subire la condanna, pur in una forte tensione e una
volontà di riscatto. L’eroe protagonista si trova in una condizione originaria di peccato, che si estende
all’intera comunità. Tale condizione si identifica con la stessa libertà di cui egli è fornito e che lo induce ad
agire in senso contrario a ciò che gli dèi hanno stabilito. Lo sforzo dell’eroe è rivolto in primo luogo a
comprendere (a prendere conoscenza, sperimentandola su di sé) la situazione in cui si trova, e dunque
principalmente l’atteggiamento della divinità nei suoi confronti, per cercare di disporla in senso favorevole.
La sofferenza è intesa come il prezzo da offrire in cambio di una disposizione positiva al compimento del
riscatto. La struttura della rappresentazione tragica, articolata in una trilogia, corrisponde ai momenti in cui
si svolge l’intera vicenda, con l’originaria esposizione nella colpa e nel peccato, la successiva caduta in un
altro peccato, commesso nel tentativo di sfuggire alla situazione determinata dal primo, e infine la
risoluzione positiva o negativa, a seconda che il protagonista pervenga a quella consapevolezza che lo rende
meritevole di perdono oppure insista nel suo atteggiamento di tracotanza, per cui tutta la vicenda si
conclude con la rovina generale (che è presupposto per lo svolgimento di altre situazioni tragiche).
Comunque, solo peccando (ed errando) l’uomo perviene alla consapevolezza di sé: l’esercizio del potere
implica azioni e comportamenti violenti e ingiusti, della cui consapevolezza è condizione la sofferenza
tragica. E la conoscenza è condizione della purificazione e della disposizione di un ordine di giustizia.
Sofocle accentua il respiro umano della vicenda tragica e questa si sviluppa e si risolve nell’esperienza che
l’eroe si trova a compiere lungo lo svolgimento della situazione drammatica. Antigone vive la sua situazione
di radicale contrapposizione alla legge della sua città e attende le conseguenze che derivano dal suo
atteggiamento con lucida consapevolezza. Altrettanto Edipo compie l’esperienza tragica con l’accettazione
della punizione alla quale è esposto.
In Euripide, infine, la tragedia si risolve interamente nell’atto della rappresentazione. Il poeta dispiega il
significato del mito e la rappresentazione si concentra nell’aspetto spettacolare e culturale, specialmente
nelle impressioni che si propone di suscitare negli spettatori. In giuoco non è più tanto il rapporto tra l’uomo
e la divinità bensì il modo in cui era vissuto questo rapporto nell’epoca storica che coincide con lo sviluppo
dell’umanesimo e del relativismo dei Sofisti. In realtà Euripide lascia aperte le diverse interpretazioni che
potevano darsi dell’esperienza religiosa, in conformità alle idee e alle concezioni personali, senza prospettare
verità definitive. Così non è tanto il divino in sé a essere in giuoco, bensì l’esperienza del divino nelle sue
molteplici forme.
La rappresentazione dell’esistenza umana in Eschilo
I grandi tragici (Eschilo, Sofocle, Euripide) rispecchiano, dunque, tre momenti dell’evoluzione della spiritualità greca.
Eschilo è interprete della coscienza religiosa tradizionale, per la quale il rapporto col divino si dispiega nel senso di una
misteriosa vicenda in cui si sta espiando una colpa commessa in tempi primordiali. Sofocle esprime una sensibilità in
cui l’uomo si accinge ad assumere consapevolezza dei suoi errori e delle sue colpe e si dispone a espiarli. Euripide ha la
consapevolezza che ogni vicenda ha per protagonista l’uomo, sicché le stesse divinità assumono il ruolo di
rappresentazioni e simboli dell’umano.
Per la rappresentazione dell’esistenza umana in Eschilo possiamo riferirci alla trilogia sul mito di
Prometeo e specialmente al Prometeo incatenato, che è l’unica tragedia, fra queste tre, rimastaci completa.
Prometeo è presentato come il tipico eroe che, recando il fuoco fra gli uomini, dà inizio al vero e proprio
cammino della civiltà e della storia: infatti il fuoco simboleggia la forza stessa della natura, che l’uomo è
capace di padroneggiare. Il mitico eroe è condotto da Cratos e Bia (il Potere e la Forza), ministri di Zeus, su
un dirupo della lontana Scizia (la regione caucasica) e colà viene legato. Appena egli rimane solo e
incomincia la sua dolorosa espiazione, esplode in un alto lamento, che viene raccolto dalle ninfe Oceanidi.
Ad esse l’eroe racconta la propria vicenda, soffermandosi specialmente sui benefici cn i quali ha voluto
consolare la vita degli uomini; e respinge ironicamente i consigli di Oceano, che cerca di riportarlo
all’ubbidienza e alla sottomissione. Appare, quindi, una giovane, Io, perseguitata da Era che è gelosa di
Zeus, e racconta al Coro le sue sofferenze. Prometeo sa che un discendente di Io, Eracle, sarà il suo liberatore
e rivela alla giovane particolari intorno alle altre sventure che lei dovrà patire nel futuro. Prometeo conosce
anche la fine del regno di Zeus e, allorché Ermes inviato da Zeus va a domandargli particolari su questo
evento, si rifiuta e perciò precipita nel vuoto che si è aperto nella spaccatura della roccia alla quale è legato.
All’inizio del secondo dramma, il Prometeo liberato, l’eroe viene riportato sulla Terra a continuare l’espiazione
della sua colpa, che si prolunga per un periodo complessivo di trentamila anni, alla cui conclusione viene
riammesso all’Olimpo. Come è stato acutamente osservato, “viste in questa luce, le sofferenze del prometeo
eschileo si identificano con le sofferenze dell’uomo stesso, caduto dal cielo nella miseria e nella morte, ma
destinato a risorgere”.23 In effetto, dunque, Prometeo è l’uomo che lotta con la sua intelligenza per sfuggire a
una condizione di miseria e schiavitù e che solo attraverso una lunga pena riesce a vincere definitivamente
l’oscuro potere e la forza misteriosa che lo tengono incatenato al suo dolore e alla sua pena. Zeus impersona
l’oscura tirannia alla quale l’uomo è sottomesso; ma al di sopra di lui domina il Tempo col suo corso fatale.
23
George Thomson, Eschilo e Atene, tr. it., Torino 1949, p. 436.
Intanto l’umanità percorre il suo cammino storico e sviluppa via via le tecniche mediante le quali
progressivamente instaura il suo potere sulla natura medesima. Prometeo è tutto preso dall’entusiasmo per i
benefici che il suo gesto ha recato agli uomini;24 e l’intero dramma può considerarsi una profonda
esaltazione dell’uomo. Si tratta di una delle più alte e significative espressioni di quell’umanesimo che è la
caratteristica essenziale della nostra cultura. L’etica che viene enunciata è quella della liberazione: l’uomo ha
il compito di lottare per conseguire una condizione di sempre maggiore libertà: E libertà è la tecnica, ma è
specialmente l’ordine politico e sociale fondato sui princìpi del diritto e della morale. Allora alla società
arcaica, basata sulla subordinazione gerarchica, subentrava una società fondata sul riconoscimento di diritti
comuni e di una legge che riconciliava l’umano e il divino e suggellava una fondamentale armonia tra
l’uomo e la natura.
Sofocle e il mito di Edipo
Il “divino” rappresenta generalmente ciò che è al di là dell’ordine umano: perciò esso si afferma e si
esplica nella trasgressione. Le proibizioni, che si applicano agli uomini, non si applicano alla divinità, o non
valgono nella stessa maniera. Nel caso di personaggi umani che siano in qualche modo coinvolti nella
vicenda divina, si riproduce questa logica della differenza: così Edipo sta al confine tra l’ordine umano e
quello sovrumano e perciò la conquista del potere regale avviene, per lui, attraverso la trasgressione di un
divieto, quello che riguarda l’incesto; egli diventerà sovrano a Tebe, sposando la madre. La trasgressione è il
segno dell’appartenenza all’ordine e alla logica della divinità; il potere si legittima in base all’appartenenza
alla sfera del divino o del semidivino ed eroico. Edipo è separato dalla casa in cui è nato: e ciò è già il primo
atto di una separazione dalla condizione dei mortali; e se è separato dalla condizione umana è perché, come
dice il Coro, “è figlio di qualche dio, delle ninfe del cicerone, di Pan o di Apollo, di Hermes o Dioniso”. Ma
nel tempo stesso in cui Edipo è il re divino e purificatore, così può essere anche strumento di perdizione per
il suo popolo. Assumendo, quindi, su di sé la condanna e la maledizione del destino, l’eroe torna ad essere
motivo di salvezza: quella maledizione che altrimenti ricadrebbe sulla città viene assunta e scontata
interamente da chi è responsabile del potere, dal re, che così diventa il capro espiatorio. L’eroe diventa il
luogo in cui il sovrumano e l’umano si incontrano: la società umana da una parte si dà un potere che la
governi e d’altra parte trova una valvola di sicurezza per scaricare il male che la opprime. Così Edipo vive la
sua tremenda ambiguità; e dopo avere salvato Tebe, di fronte al peso insopportabile dell’impurità e della
colpa, si dà quella pena che costituisce una liberazione per la città. Tuttavia, l’atto della trasgressione, valido
per la sfera divina, non può fondare l’ordine umano. Su Tebe, dunque, grava ancora il peso di una colpa, che
richiede altri atti liberatori.25
Le figure dell’umano: Prometeo, Ulisse, Atlante
Prometeo rappresenta l’eroismo dell’uomo che sfida la divinità e per la sua arditezza è condannato ad assistere allo
spettacolo crudele di se stesso ferito e lacerato nella parte del suo essere che è deputata ad alimentare il coraggio e la
volontà di progresso. Ulisse è simbolo della multiforme intelligenza, mediante la quale l’uomo affronta e risolve le
situazioni problematiche di fronte alle quali viene di volta in volta a imbattersi. Atlante regge il peso del mondo e
rappresenta la condizione dell’uomo il cui destino è indissolubilmente legato a quello dell’intero universo.
Prometeo vince la sfida dell’umano incivilimento. Egli assicura e fonda l’esistenza come svolgimento di
civiltà basato sulla tecnica. La conoscenza della natura è, in questo senso, il destino stesso dell’umanità
occidentale. Ulisse attua esemplarmente il desiderio di conoscere, di compiere esperienze inesauribili. Il
campo che si apre all’esperienza umana è inesauribile. L’uomo si trova sempre di fronte a nuovi problemi:
ma, in quanto dotato di una capacità duttile e molteplice, adattabile in modi sempre nuovi, egli risolve le
difficoltà, dispone i rimedi, assicura il progresso. Egli porta sulle spalle il peso del mondo, per quanto
smisurato esso sia. Ulisse, In questo senso, è simbolo della multiforme intelligenza dell’uomo
La conoscenza attraverso il dolore
Niobe, un archetipo della sofferenza umana
24
25
Cfr. vv. 458-522: “Udite invece/ de’ mortali i bisogni, e come in essi,/ stupidi pria, senno e intelletto io posi./ […]”.
Cfr. Vernant, Mito e tragedia nella Grecia antica, tr. it., Torino 1970, pp. 104 sgg.
Il dolore e la sofferenza sono vie per la conoscenza. L’esistenza è rischio. L’intera vita dell’uomo è rischio continuo. Il
filosofo rinuncia alla felicità: la sua vita è un itinerario di ricerca; egli non raggiunge mai una meta definitiva, in quanto
il sapere è sempre posizione di nuove domande, sollecitazione e richiesta di nuovo sapere. Il filosofo è destinato
all’inquietudine.
La consapevolezza intorno alla condizione umana costituisce la direzione stessa del cammino dell’uomo
greco: si tratta di un itinerario che Hegel traccerà nella mirabile sintesi della Fenomenologia. Eschilo mostra la
grande funzione catartica del dolore, come via della conquista della celebre sapienza intorno al mondo degli
uomini. Attraverso il dolore l’uomo acquista la coscienza di sé, soprattutto del suo essere limitato e gettato nel
mondo. La beatitudine è riservata solo agli dèi; agli uomini è riservata una condizione di infelicità e di
angosciosa tensione. Sofocle rappresenta questa consapevolezza come una condizione di appagamento, di
lucida consapevolezza intorno a ciò che appartiene all’uomo e di ciò che, invece, è proprio della divinità.
Un singolare “archetipo” proprio di un mitologema che il Kerényi ha ampiamente illustrato26 riguarda il destino
tragico di Niobe, la madre condannata ad assistere allo spettacolo dei figli colpiti dall’invidia di Artemide e abbattuti
dalle saette della dea e del fratello Apollo, quindi pietrificata dal dolore e trasformata in fonte perenne di lacrime che
testimoniano tutte le vicende dolorose.
Certo nel mito di Niobe si rappresenta la follìa dell’uomo che intende gareggiare con la divinità, la ybris o
tracotanza alla quale l’uomo è portato per il potere meraviglioso e i molteplici doni che pure sono in suo
possesso e che destano persino l’invidia degli immortali. Eppure la storia degli uomini è anche questa sfida
continua nei confronti della natura o della misteriosa forza che alimenta la generazione continua delle cose.
Artemide, anche se non ha partorito figli, rappresenta comunque un aspetto della potenza generatrice della
donna, è comunque una figura della maternità universale. E contrapporre a questa potenza divina la
magnificenza umana, la grande prolificità della donna terrena, costituisce comunque un atto di superbia che
l’implacabile ira divina non risparmia dalla orrenda punizione. Tutto è dono degli dèi, tutto proviene dalla
divinità. Questo vuol dire la figura di Niobe impietrita e divenuta fiume di lacrime.
Forma ed evento: le radici della metafisica
Nell’ambito della cultura greca la conoscenza scientifica è riservata alle strutture permanenti, alle “essenze”
immutabili, mentre per le cose del mondo, che nascono e muoiono, appaiono e scompaiono, si può avere solo una nozione
approssimativa, soggetta all’instabilità dell’opinione: Tale, ad esempio, è la descrizione delle cose a partire
dall’esperienza sensibile e tale è la conoscenza “storica”. Degli enti particolari, le cui qualità e la cui struttura stesa
sono variabili, si dà una rappresentazione provvisoria, un’opinione soggettiva, relativi ai modi in cui si declina
l’esperienza. Invece delle “forme” immutabili (le “idee” o le “essenze”) si dà una scienza esatta, basata
sull’intelligibilità stessa e, dunque, su un’intuizione intellettiva o razionale. La filosofia è apparsa come lo sviluppo di
questo tipo di conoscenza puramente intellettuale, che coglie le strutture razionali in cui si articola la realtà.
La cultura greca è attraversata dal problema del rapporto tra l’impalcatura immobile del reale (ciò che si è
costituito nel tempo mitico) e il fluire delle cose, l’inarrestabile vicenda del divenire (ciò che accade nel tempo
storico). Tutto ciò che accade reca l’impronta delle leggi generali del divenire. “Forma” ed “evento” (secondo
la felice espressione di Carlo Diano) sono i due piani entro i quali scorre la vicenda del reale, che è insieme
struttura e “forma” permanente, e incessante e infinito processo di formazione e trasformazione
dell’esistente. Il reale viene articolandosi come “esistenza”, rapporto tra l’immutabile struttura e legge
dell’essere e la mutevole “eventualità” dei fatti e delle cose. La metafisica riguarda la sfera immutabile,
l’essere, le scienze particolari considerano le molteplici manifestazioni dell’esistenza. Prima che Parmenide
parlasse esplicitamente dell’essere, questo termine appartiene già alla concezione greca nella sua forma più
originaria. L’accadere ha la sua radice nell’immutabile decreto del Fato, in una legge che appartiene
all’essere. Ciò che è dell’essere è necessario ed eterno, costituisce la forma della realtà; perciò non è toccato
dal non-essere, che è accidentale e provvisorio.
L’affermazione del “logos”
26
Cfr. K. Kerényi, Prometeo e Niobe due archetipi del modo d’esistere umano, in “Atti del Congresso internazionale
di filosofia”, vol. II, Milano 1948, pp. 269-277.
Il “logos”, come rilevò Eraclito, è “unico” per tutti gli uomini, dunque è fondamento di “verità” e di conoscenza
certa. L’esperienza sensibile, invece, è relativa e dà luogo a diverse opinioni. Parmenide, a sua volta, rilevò che il “logos”
è proprio dell’essere immutabile, mentre le opinioni si riferiscono alle cose mutevoli. Pertanto solo quando si è
sviluppata l’attività del puro pensiero si è incominciato a produrre scienza vera. Il “logos” è, appunto, il pensiero puro,
che si esprime nel ragionamento e non si avvale dell’apporto dell’esperienza. La filosofia incomincia, infatti, quando si
incomincia a cercare il principio di tutte cose, identificandolo mediante un concetto (l’acqua di Talete, l’infinito di
Anassimandro, l’aria di Anassimene non sono sostanze comprensibili attraverso l’esperienza).
La filosofia nasce allorché è interamente compiuto il passaggio a una forma di sapere fondato
dall’intelligenza umana come facoltà autonoma di comprensione (“intelligenza”) della realtà (sia pure
considerata dapprima come una espressione dell’originario elemento divino presente nell’anima). Nello
stesso tempo si è affermata l’idea della realtà come sfera unitaria, facente capo a un principio sostanziale
(“arché”) e a una interna legge immutabile. Il “logos” è, insieme, il principio dell’intelligibilità del reale e la
legge interna del pensiero “scientifico” (che fonda una conoscenza certa, un’epistéme). Sulla base di questo
principio, il reale, configurato come “natura”, cioè come una totalità organica, diventa l’oggetto di un sapere
sistematico, che comprende tutti i suoi aspetti e li spiega in base a leggi uniformi. Una tale forma di
conoscenza è emancipata dalla relatività dell’esperienza e assume validità universale. L’”epistéme”
riguarda, infatti, quel sapere che segue il “logos” (ed è espressione di esso) e non, invece, le modalità
dell’esperienza sensibile. Per questa via, si è andato precisando il divario tra la scienza dell’essere
immutabile e l’opinione mutevole, l’una costituita come “contemplazione” pura, sapere disinteressato, l’altra
come strumento “pratico” (tecnica). Si può dire che questa distinzione, per cui da una parte si colloca un tipo
di conoscenza interamente libero da ogni preoccupazione pratica e dall’altra, invece, una conoscenza
inferiore, costituita in rapporto all’uso delle cose e connessa alle modalità dell’apparire fenomenico,
caratterizza tutta la cultura dell’antichità (e ancora del medioevo). L’epistéme, conoscenza puramente
“teorica”, risponde a un impulso naturale dell’uomo, alla curiosità (desiderio di sapere) che nasce dalla
meraviglia, e si alimenta delle risorse del puro pensiero, che riguarda il reale in quanto intelligibile (a sua
volta, espressione del “logos”). L’epistéme si sviluppa nell’ambito del “logos” e riguarda, in qualche modo, il
reale (l’essere in generale ma anche l’essere degli enti) in quanto ambito della rivelazione di sé (e il pensiero
in quanto luogo di questa rivelazione). 27
27
Secondo Aristotele, c’è nell’uomo un impulso al sapere puro (orexis toy eidenai) che si esprime nella meraviglia e,
quindi, si trasforma nella ricerca intorno alla costituzione dell’essere delle cose (episkepsis ton onton). Infatti, “è in
quanto stupiscono che gli uomini presero a filosofare” (Met., A 2, 982 b 11-24). Il sapere fondamentale corrisponde,
dunque, a un bisogno dello spirito umano e riguarda l’interna struttura del reale: esso riguarda l’”essere” e, perciò, si
configura come “ontologia”: l’uomo avverte stupore di fronte alla totalità delle cose e incomincia a domandarsi come il
“tutto” possa esistere e quale principio o forza lo sostenga e lo alimenti. La domanda filosofica sull’”essere” non è altro
che la formulazione matura di questa originaria meraviglia di fronte al prodigio dell’esistenza in generale. Aristotele, in
questo senso, afferma che l’uomo è filosofo per natura. E la filosofia è definita come perì tes aletheias theoria ed
epistéme aletheias. Lo stesso Aristotele dice che il compito del filosofo è quello di “far sì che [l’ente] si manifesti”, cioè
di “fare apparire” (all’interno del “logos”), e lo indica con l’espressione apophainesthai perì tes aletheias. Tra le varie
forme dell’apparire (che avviene in forma sensibile e in forma intelligibile, aistheton e noeton, e si articola in modi
molteplici, relativi alle due forme fondamentali: katà to pragma, katà physin, physikos, kat’aletheian, katà doxan,
loghikos, dialekticos, phainomenos). In particolare, la “verità” riguarda il manifestarsi dell’essere, non il manifestarsi
secondario dell’opinare e della prassi umana. E l’espressione perì ton onton aletheuein non riguarda l’ambito del
discorso (dire il “vero”), ma ha significato ontologico, cioè è riferito al disvelamento dell’essere (o dell’essere
dell’ente). L’umano disvelare consiste nel comprendere gli enti secondo la loro intrinseca manifestabilità e nel
comprenderli seguendo il movimento del loro manifestarsi (Per questa tematica, cfr. Leo Lugarini, L’idea di filosofia in
Aristotele). L’”epistéme” riguarda questo tipo di sapere che segue il “logos” interno della realtà (i modi in cui l’essere si
manifesta nel pensiero) e non, invece, le modalità dell’opinare. Inoltre, essa è puramente teorica e non assume una
connotazione “tecnica” di strumento della prassi umana. Una tale connotazione distingue, invece, la scienza moderna,
che intende costituirsi come conoscenza delle cause dell’accadere fenomenico. Così il “logos” moderno è proprio della
ragione umana che decide intorno al “vero” e al “falso” (stabiliti sulla base della corrispondenza logica): Per il pensiero
moderno le modalità del “giudicare” diventano “criterio” di verità (mentre nel pensiero antico la verità come
manifestazione è fondamento dello stesso “giudizio”). La ragione moderna si profila, così, come il criterio medesimo in
base al quale il reale diventa accessibile al dominio della prassi. L’intelligibilità non riguarda più il reale in sé, bensì
riguarda il reale in quanto oggetto del giudizio scientifico e, in un secondo momento, della prassi razionale, disposta
scientificamente, sulla base di procedure “esatte”, definite in rapporto a determinati scopi. Qualcuno ritiene che, con
l’affermarsi del “logos”, questo cammino sia già avviato. Le circostanze storiche e altri elementi culturali avrebbero
favorito questa evoluzione. Un elemento decisivo, a questo proposito, può essere ravvisato nella concezione cristiana
Quando è nata la filosofia. Il contesto storico
La nascita della filosofia si colloca nel VI secolo a. C.: secondo Aristotele, Talete è l’iniziatore della filosofia , in quanto
è il primo che indaga sulla natura non più percorrendo la via simbolica e mitologica, ma procedendo attraverso
l’osservazione della realtà e la riflessione razionale, per pervenire, dalla complessa e confusa varietà dei fenomeni,
all’identificazione di un principio, di una causa e di una legge fondamentale e unica per tutte le manifestazioni e le
forme della realtà (natura).
Quando sorge la riflessione filosofica, nel VI secolo s. C., la cultura greca aveva già compiuto un progresso
notevole ed era giunta a un alto livello di maturità. Essa, d’altra parte, aveva assimilato elementi molteplici
dell’intera area mediterranea e medio-orientale, innestandoli sul ceppo più originario che si era sviluppato
dal più antico nucleo della civiltà egeo-cretese. Fin dal 2000 a. C., infatti, la cultura e l’arte erano fiorite a
Creta, nell’ambito di quella civiltà che è stata detta “minoica” (dal leggendario re Minosse). Tra il 1600 e il
1260 i protoelleni, dicsesi in Grecia da nord, fondarono una nuova civiltà, unendo gli elementi originari
della loro cultura con quelli egeo-cretesi: da quella fusione ebbero luogo una nuova cultura e una nuova arte,
che ebbero il loro centro a Micene nel Peloponneso. Il periodo della massima fioritura della civiltà micenea si
colloca intorno al 1400 a. C. e tra il XIII e il XII secolo iniziò la decadenza, dovuta all’irrompere di una nuova
ondata migratoria proveniente da nord e costituita da tribù doriche che avevano occupato fino allora le
regioni della Grecia settentrionale e che, sotto la spinta degli Illiri, provenienti dal bacino danubiano, scesero
nel Peloponneso, distruggendo la civiltà micenea e facendo della stessa Micene il centro della loro civiltà. In
seguito all’invasione dorica, una parte della popolazione appartenente alle tribù della prima migrazione,
principalmente gli Ioni, abbandonò la penisola e si stabilì nelle isole vicine e lungo le coste dell’Asia Minore,
mentre altri gruppi (appartenenti allo stesso ceppo ionico e specialmente a quello eolico) vi rimasero, in
modo che i loro stati e territori erano confinanti con quelli dorici. Ioni, Eoli, Dori, in tal modo, costituirono i
grandi ceppi della popolazione greca e, nel corso del tempo, mantennero alcuni caratteri peculiari, che li
rendevano (a parte altri elementi, comuni alle diverse etnie) notevolmente differenti. In particolare, la
diversità divenne marcata tra i Dori e gli Ioni e riguardava l’organizzazione della vita politica, la mentalità,
la visione delle cose. I Dori erano piuttosto conservatori e rimasero legati ai loro regimi aristocratici, mentre
gli Ioni, sollecitati dallo stesso ambiente geografico aperto sul mare, conobbero una complessa evoluzione e,
sul piano politico, svilupparono infine sistemi di governo democratico. I Dori conservarono le loro
tradizioni, mentre gli Ioni, curiosi delle novità e aperti alle trasformazioni e ai mutamenti anche radicali, non
solo assimilarono la cultura micenea, ma l’arricchirono con elementi della più antica civiltà cretese e
subirono anche notevoli influssi dall’Oriente (specialmente assiro-babilonesi) e dall’Egitto. Sia gli Ioni che i
Dori parteciparono al processo di espansione della civiltà greca nell’area mediterranea. Gli Ioni fondarono
colonie specialmente sulle coste dell’Asia Minore, i Dori specialmente in Occidente, nell’Italia meridionale e
in Sicilia. Fino al VII secolo lo sviluppo commerciale e industriale dei Greci era stato piuttosto limitato: la
maggior parte dei prodotto veniva acquistata dai Fenici. Invece dopo la colonizzazione di vaste aree
mediterranee, i Greci fabbricarono prodotti non solo ai fini del mercato interno ma anche per l’esportazione.
Dappertutto si diffuse l’industria della metallurgia, della ceramica, della tessitura. L’industria, il commercio,
la navigazione contribuirono ad accrescere non solo la ricchezza dei Greci, ma anche la loro conoscenza del
mondo, il loro gusto artistico, il senso politico. In particolare, si ebbero trasformazioni nella vita civile: la
formazione di una prospera borghesia, infatti, determinò il crollo dei vecchi regimi patriarcali sostenuti
dall’aristocrazia e il sorgere di regimi prima oligarchici (timocratici) e poi democratici (che realizzavano una
certa unità tra le classi sociali).
Il periodo della storia greca che va dalla occupazione dorica nel XII secolo fino al V secolo è detto
“arcaico”. Ma dal VII fino all’inizio del V secolo a. C. già troviamo i caratteri “classici” della cultura greca nei
campi della politica, del pensiero e dell’arte. Il secondo periodo è quello “classico”, un’età particolarmente
splendida, per l’affermazione della civiltà ellenica in una vasta area geopolitica mediterranea, il
del mondo, secondo la quale l’universo fisico appare proiettato in una sfera “separata”, affidata al governo dell’uomo.
In qualche modo, questa concezione è presente già in Plotino, per il quale, come è noto, all’uomo è attribuita la
funzione di “copula mundi”, fattore di raccordo tra gli enti e di elevazione del mondo all’Uno. Nel cristianesimo questo
motivo ascetico passa in secondo piano, poiché il soggetto dell’ascesi non è più l’uomo/mondo bensì è l’uomo/persona,
mentre al mondo è attribuita una specie di condizione “provvisoria”, connessa allo stato “in via” dell’uomo, il cui
destino si compie sul piano dell’eternità.
raggiungimento di una grande prosperità economica e il livello ineguagliabile raggiunto nell’espressione
artistica e poetica e nel pensiero filosofico-scientifico.
I fattori della nascita della filosofia.
Gli influssi delle culture orientali
Rodolfo Mondolfo nelle sue note di aggiornamento alla “Filosofia dei Greci” dello Zeller ha esaminato ampiamente la
questione degli influssi orientali sullo sviluppo di concetti confluiti nella filosofia e nella scienza greca, dimostrando i
molteplici canali di rapporto e di diffusione di elementi propri dell’astronomia, della matematica, della medicina.
La filosofia è un prodotto tipico della civiltà greca. Ci si è chiesti se si possa parlare, ad esempio, anche di
una filosofia indiana e cinese, ma non si è giunti a conclusioni definitive. Si è notato che gli orientali non
distinguono una filosofia vera e propria dalla religione e che, dunque, i motivi di concezione globale della
vita e del mondo non sono organizzati in discorsi forniti di adeguato rigore logico e deduttivo. Già Hegel
avvertiva che “ciò che chiamiamo filosofia orientale è, piuttosto, la rappresentazione religiosa che gli
orientali si fanno della realtà”.28
Ma, se pure la filosofia deve ritenersi un aspetto tipico della cultura greca, occorre domandarsi se essa
debba considerarsi anche una creazione originale dei greci oppure se alla sua nascita abbiano concorso
fattori diversi e, specialmente, significativi elementi di altre civiltà, con le quali i greci entrarono in rapporto
e delle quali subirono l’influsso. Lo Zeller affermò con risolutezza l’originalità del pensiero greco, sostenendo
che non vi sono ragioni per credere che esso abbia una qualche derivazione dalle scienze e dalle religioni
orientali e che l’intera filosofia “si sviluppa in maniera affatto naturale dalle condizioni date dalla vita del
popolo greco”.29 Il Mondolfo, nelle ricchissime note di aggiornamento all’opera dello Zeller, ha, invece,
ampiamente documentato i rapporti e gli influssi dell’Oriente assiro-babilonese e dell’Egitto sulla civiltà
greca. I greci indubbiamente conoscevano quelle civiltà; essi in particolare erano presi da ammirazione per i
saggi sacerdoti della Caldea e dell’Egitto, depositari di una sapienza secolare. Motivi della scienza e della
generale concezione del mondo degli orientali dovettero perciò essere determinanti nella formazione dello
stesso spirito scientifico che poi divenne una caratteristica peculiare della cultura razionalistica dei greci.
Le scoperte archeologiche, ormai da quasi due secoli a questa parte, hanno portato alla luce documenti
importanti che attestano il notevole sviluppo delle concezioni scientifiche (specialmente astronomiche e matematiche)
presso i babilonesi e gli egiziani. Le tavolette di Ninive (che facevano parte della biblioteca di Assurbanipal nel
VII secolo a. C.) attestano che fin dal II millennio a. C. l’astronomia caldea aveva raggiunto uno stadio di
notevole estensione e precisione nella raffigurazione dell’universo. In essa troviamo elementi fondamentali
per lo sviluppo del successivo sistema astronomico: la divisione del tempo e del cerchio in gradi e minuti, la
determinazione del corso del sole e dell’eclittica, l’individuazione delle costellazioni dello zodiaco, il metodo
di proiezione degli archi dell’eclittica sull’equatore per calcolare la durata delle ascensioni zodiacali, il
calcolo dell’esatta posizione degli astri, la distinzione dei pianeti dalle stelle fisse e lo studio dei loro
movimenti (fino alla rilevazione delle stazioni e retrogradazioni), la determinazione dell’ordine di distanza
dalla Terra, la registrazione e la previsione delle eclissi.30
Ciò che risulta, in sintesi, dall’astronomia caldaica è la determinazione di cicli astronomici regolarmente
ricorrenti, dunque l’idea di un ordine di successione regolare e costante (e perciò di una legge regolativa del
corso dell’universo).
Il concetto scientificamente più importante (a parte le specifiche conoscenze) è dato proprio dall’idea di
una successione costante e regolare dei fenomeni e dall’applicazione del calcolo matematico, in modo che già
si intravede nel numero il fondamentale mezzo d’intelligibilità dell’ordine dell’universo. Anche se tutta
l’astronomia caldaica era rivolta a uno scopo pratico, cioè alla formulazione delle previsioni astrologiche
(basate sull’idea di un necessario influsso degli astri sulle vicende terrene e umane), e se essa appare rivestita
di un involucro mitico, quale è, ad esempio, l’idea di una ripetizione costante o di un “ritorno” dei grandi
periodi cosmici, non si può negare la portata scientifica di tutta quella costruzione astronomica.
28
G. G. F. Hegel, Storia della filosofia, tr. it., I, p. 115.
E. Zeller, La filosofia dei greci, tr. it., I/1, p. 58).
30
Cfr. Mondolfo, in Zeller, I/1, pp. 83-84.
29
Il contributo dei greci è stato principalmente quello di aver perfezionato quel sistema scientifico,
depurandolo di ogni residuo elemento mitologico. Rimane, tuttavia, l’idea di una necessità e di una legge
inflessibile che domina l’universo e regola il corso di tutti i fenomeni.31
Documenti sicuri abbiamo per la derivazione della matematica caldaica della divisione della circonferenza in
360 gradi, ognuno diviso in 60’ e ognuno di questi in 60”. La figura del cerchio richiamava quella
dell’orizzonte, l’orbita circolare sulla quale nel corso di 360 giorni gli astri appaiono ricondursi alla stessa
posizione. Il numero 60 veniva ad assumere, quindi, un valore astrologico e magico: una tavoletta della
biblioteca di Ninive contiene una lista degli dèi principali, rappresentati dai primi 60 numeri interi, e quella
degli spiriti (demoni) che sono designati per mezzo di frazioni. Così anche il giorno ha una divisione analoga
a quella dell’anno: o in sessantesimi o in 360 parti risultanti dalla divisione in 30 parti di ognuna delle 12 ore.
Il papiro Rhind ci mostra quanto progredite fossero presso gli egiziani le conoscenze matematiche. Esso
contiene un vero e proprio manuale di tecnica delle operazioni aritmetiche e geometriche e di soluzione di
problemi (operazioni sui numeri interi e sulle frazioni; calcolo di volumi, capacità, aree, angoli di
inclinazione; problemi di divisione in proporzioni diseguali; progressioni aritmetiche e geometriche, e così
via). Si tratta di una matematica rivolta alla soluzione di problemi pratici e manca ogni motivo di
sistemazione logica e razionale: ma non si può non riconoscere la presenza di importanti spunti
d’impostazione generale e, dunque, di elaborazione di una visione sistematica e unitaria delle leggi
matematiche.
Motivi rilevanti e significativi per lo sviluppo del pensiero greco troviamo anche nelle concezioni
cosmogoniche babilonesi ed egiziane. Il problema dell’origine dell’universo e della genesi dell’attuale ordine
cosmico è presente in quasi tutte le civiltà: ma ciò che caratterizza le cosmogonie orientali è l’idea di una
sostanza primordiale, dalla quale si sarebbero differenziate le regioni dell’universo, attraverso l’azione di forze che, se
ancora sono raffigurate mitologicamente, prefigurano il concetto degli opposti principi materiali (il pieno e il vuoto,
l’umido e il secco, il luminoso e l’oscuro, il caldo e il freddo, ecc.) in continuo e dialettico rapporto tra loro.
Nel mito babilonese sulla formazione dell’universo troviamo che l’originario caos acquoso (simboleggiato
specialmente nel corpo di Tiämat) è sopraffatto da una triade di divinità cosmiche (simboleggianti il cielo,
l’aria e l’acqua), con la successiva generazione dell’intera serie delle divinità (in realtà rappresentanti le parti
e gli aspetti dell’universo). Il principale di questi dèi, Marduk (la potenza ordinatrice dell’universo), vince e
distrugge le preesistenti potenze della tenebra e del caos, e dal corpo di Tiämat, tagliato in due, forma la
calotta celeste e quella terrestre, dando in tal modo luogo alla forma definitiva dell’universo.
Nella mitologia egiziana troviamo la lotta tra Hor (dio del cielo) e Seth (dio delle tenebre).
Queste rappresentazioni contengono alcuni elementi speculativi di profondo significato scientifico: 1) il
concetto della nascita del cosmo da una condizione originaria di caos e da una materia primordiale; e la triade
cosmica di cielo, aria e acqua (su cui galleggia la terra) rappresenta il primo abbozzo della dottrina degli
elementi materiali fondamentali; 2) la concezione dell’unità dell’universo (per l’unicità della materia da cui tutte
le sostanze e tutti gli enti derivano); 3) L’affermazione di un dualismo fondamentale di forze cosmiche (come
quelle della vita e della fecondazione e quelle della morte, o tra quelle della luce e quelle della tenebre).
Un altro campo, in cui le concezioni orientali possono avere influenzato la cultura greca, è quello relativo
alla fede nel ciclo delle rinascite o trasmigrazioni dell’anima. La via di liberazione dalla morte è trovata in Egitto
nella religione osirica, nel culto della divinità agraria della fecondazione, la cui annua morte e seguita
dall’annua rinascita, e i cui misteri sono celebrati per la resurrezione eterna di tutti i fedeli. Troviamo così
l’idea che nello spirito infinito che pervade l’universo ogni vita si rigenera: questo spirito mantiene l’ordine del
mondo, assicura la continua rigenerazione delle cose, secondo una legge che, poi, appare come una
necessità.
Tutti questi motivi noi ritroviamo nella cultura greca, ma rielaborati e poi espressi a un livello di
sistemazione scientifica e razionale. D’altra parte, questi influssi e derivazioni dalle conoscenze e dalle
dottrine orientali non infirmano affatto l’originalità della filosofia e della scienza dei greci, i quali hanno
attuato il passaggio decisivo dalla rappresentazione mitologica al discorso scientifico, adottando il metodo della
rigorosa dimostrazione razionale e dando luogo, così, alla filosofia come indagine concettuale intorno ai
problemi della realtà naturale e della vita umana.
La mitologia.
Il mito come riflessione intorno ai principi di costituzione cosmica
31
La regolarità dei cicli celesti appare come la fonte della regolarità di ogni fenomeno (comprese le stesse vicende
umane, esattamente prevedibili, sulla base del corso del cielo).
Il mito è la rappresentazione simbolica di aspetti della natura e del mondo umano e il racconto di eventi esemplari che
costituiscono la base dello stesso sviluppo storico del mondo greco. Esso riguarda l’ordine dell’universo e il processo
della sua formazione, dunque le figure che simboleggiano i caratteri e lo stesso destino della condizione umana, nonché
le vicende che costituiscono la radice degli accadimenti di cui sono protagonisti i diversi popoli. Tutto, insomma, trova
una spiegazione nel mito.
La mitologia greca è una forma di riflessione, profonda e completa, intorno alla struttura e alla
costituzione dell’universo, all’ordine dei fenomeni e alle leggi che li governano, al destino dell’uomo e al
significato della vita. Gli aspetti costanti dell’universo e della vita, ciò che è permanente nella mutevole vicenda della
natura e della storia, la legge universale che governa tutte le cose: tutto ciò è oggetto di riflessione e confluisce in una
visione sistematica e coerente che ha i caratteri della rigorosa concatenazione logica. Perciò la mitologia è considerata
come la fondamentale matrice della filosofia.32
Nella rappresentazione mitologica dell’universo non vi è distinzione netta tra mondo fisico e mondo
umano: una stessa legge e uno stesso destino attraversano le due sfere, in un intreccio profondo di analogie e
corrispondenze.33
Vediamo alcuni concetti fondamentali che si riscontrano nella rappresentazione mitologica e che si
riferiscono unitariamente sia all’ordine della natura che alla vita dell’uomo e alla costituzione della città
(ordine politico).
In primo luogo, lo schema della generazione è applicato alla stessa origine e formazione dell’universo. Omero
tramanda la leggenda di Oceano progenitore di tutti gli dèi, dunque l’idea della derivazione del cosmo da un
principio materiale unico, rappresentato dal caos acquoso.34
Esiodo pone tre potenze primarie nello sviluppo dell’ordine dell’universo: Caos, Terra, Eros. Il Caos
rappresenta l’indeterminato, il miscuglio indefinito, la materia di ogni determinazione; la Terra rappresenta la
materia generatrice; Eros, invece, la forza che presiede alla unione di elementi diversi (dunque una specie di
forza aggregatrice). Tutte le altre forze, sostanze ed entità si sono prodotte da quelle tre potenze primordiali.
“Da Caos vennero Erebo e la nera Notte”, cioè le potenze tenebrose; “da Notte poi vennero Etere e Giorno”,
le potenze luminose. Le potenze tenebrose, dunque, si staccarono dal Caos; quelle luminose dalla Notte. La
Terra prima generò da solòa Urano, il cielo stellato “che la coprisse tutta intera” e “dove gli dèi beati hanno
una sede sicura per sempre”, e poi le Montagne grandi e il Mare infecondo. Così Urano sta sopra la Terra, e
questa è sopra il Caos o “abisso dalle fauci spalancate£. Le potenze oscure e quelle luminose si succedono
nello spazio tra Urano e Terra.
Esiodo enumera, quindi, le potenze generate dalla Notte (senza il concorso di un padre): Sestino, le Moire
o Parche, Morte, Sonno e la schiera dei Sogni, e poi anche Invidia, Inganno, Vecchiaia, Contesa, Fatica, Fame,
Dolore, Assassinio, e così via, le potenze che insidiano e minacciano la vita. Dall’unione di Urano e della
Terra, Esiodo fa nascere le stirpi delle divinità: per primi i Titani, sei maschi (Oceano, Coio, Crios, Iperione,
Giapeto, Cronos) e sei femmine (Thea, Rhea, Temi, Mnemosine, Febe e Teti). Discendenti dei Titano sono,
poi, altre divinità: Prometeo, Epimeteo, Atlante (figli di Giapeto); Leto o Latona (figlia di Coio); Helios,
Srelene, Eos (figli di Iperone) e altri. Figli di Urano furono anche i Centauri o Ecatomchiri (giganti con cento
mani e corporatura forte: Briareo, Cottus, Byas, che rappresentano la potenza violenta delle acque) e i Ciclopi
(Bronte, il tuono; Sterpe, il lampo: Arge, il fulmine). Urano aveva paura che questi figli lo detronizzassero e,
appena nati, li nascose nelle profondità della Terra. Ma Gea, adirata, incitò i Titani a ribellarsi al loro padre e
uno di essi, Cronos, evirò con una falce Urano. Dal seme che uscì dalla ferita di Urano nacquero le Erinni o
Furie (Aletto, Tisifone, Megera), divinità della vendetta, e, inoltre, i Giganti (i più noti sono Alcioneo,
Porfirione, Efialte, Eurito) e le ninfe Meliadi. I Titani, quindi, posero sul trono il loro fratello Cronos, il quale,
a sua volta, ripiombò nel Tartaro i Centauri e i Ciclopi. Cronos, il più giovane dei Titani, sposò Rhea ed ebbe
parecchi figli: Hestia, Demetra (o Cerere), Hera, Hades (o Plutone), Poseidone, Zeus. Ma, sapendo che uno
32
Già Aristotele notava che l’“amante del mito” (philomythos) è in un certo modo un filosofo” (Metafisica, I, 2, 982
b). Infatti anche il mito, come la filosofia, nasce dalla meraviglia. Come anche notava Platone (Teeteto, 155d): “E’
proprio caratteristico del filosofo questo stato d’animo: della meraviglia; perché altro non è che questo il principio della
filosofia; e chi ha detto che Iride (la filosofia) è figlia di Taumante (la meraviglia) pare che non abbia stabilita male la
genealogia”. E ancora Aristotele: “La meraviglia è stata sempre, così ora come per l’innanzi, la causa per la quale gli
uomini hanno cominciato a filosofare” (Metafisica, I, 2, 982 b).
33
Perciò il Mondolfo ha potuto notare la proiezione di caratteri tipici della sfera umana (per esempio, l’ordine seguito
nella danza, nello schieramento degli eserciti, ecc.) nella compagine naturale (il “cosmo” come totalità ordinata degli
enti e corso regolare dei fenomeni e degli eventi).
34
Questa idea risale alla cultura preellenica (egeo-cretese) ed è, del resto, comune a tutte le antiche culture orientali
(babilonese, egiziana, ebraica, fenicia, ecc.).
dei figli lo avrebbe spodestato, Cronos ingoiava i suoi figli appena nati. Rhea, quando seppe che le sarebbe
nato un altro figlio, per salvarlo, discese dal cielo e si nascose in una profonda caverna del monte Ida,
nell’isola di Creta; ove diede alla luce Zeus. Quando Zeus diventò giovanetto, salì al cielo, si presentò alla
corte di suo padre Cronos, lo costrinse a bere un ematico, che gli fece rigettare i cinque figli fino allora
trangugiati, poi lo detronizzò e prese il suo posto di re degli dèi. Zeus, poi, sostenne una lotta coi Titani che
si rifiutavano di accettare il suo dominio, quindi vinse anche i Giganti e poté instaurare definitivamente il
suo dominio sul mondo.
Mentre Omero ci parla quasi esclusivamente delle divinità “olimpiche” (che si ritiene creazioni originarie
dei Greci), Esiodo ha conservato certi miti antichissimi provenienti dall’Oriente, come le storie crudeli di
Urano e Crono, delle quali i Greci si erano liberati ben presto. Tuttavia quelle atrocità sono presentate come
avvenute prima che Zeus instaurasse l’ordine e la giustizia (relegate, dunque, in un mondo che nulla ha a
che fare col cosmo nel suo ordinamento definitivo). E’ da notare peraltro che in Esiodo il negativo,
l’inquietante, ha un rilievo maggiore di quello che vi è attribuito da Omero.35 I lati negativi e paurosi del
mondo non sono qualcosa di definitivamente superato nel tempo: le potenze demoniache generate dalla
Notte continuano a far sentire la loro presenza nel mondo. Nella Teogonia Esiodo sostiene che tanto le tanto
le potenze negative quanto quelle buone e positive esistono in tutti i tempi e operano nel mondo e tra gli
uomini. Le potenze positive presiedono all’ordine e sono coerenti con la giustizia instaurata da Zeus; quelle
negative tendono a turbare quest’ordine e a diffondere ingiustizia, male e dolore. Esiodo mostra Zeus come
il giusto ordinatore del mondo, simbolo e interrete dell’ordine e della giustizia. Ma il trionfo dell’ordine
armonico dell’universo non è stato immediato: esso è seguito a un lungo travaglio cosmico, durante il quale
sono talvolta prevalse le potenze negative e si sono avuti tentativi di ordinamento dell’universo secondo
ingiustizia.
Esiodo ripete continuamente che il principio dell’ordine dell’universo è Zeus, che “ha distribuito tra gli
immortali tutte le cose” e “ha assegnato equamente gli onori”. Questo ordine fisso e immutabile del mondo,
stabilito dalla più alta divinità, è il senso dell’intero mito cosmogonico. Nell’universo così ordinato divinità
specifiche hanno il compito di presiedere ai diversi ambiti della vita e della realtà, sia relativi all’esistenza
dell’uomo che alla natura: così ninfe di varie specie presiedono ai boschi, ai fiumi, al mare, e così via.
Prendiamo, per esempio, la sfera dell’arte e della poesia/musica/danza, di quell’attività, cioè, che
nell’antichità aveva la funzione di accompagnare la celebrazione dei riti religiosi e, inoltre, di conservare e
tramandare la memoria delle imprese eroiche e degli eventi significativi per la comunità. Le Muse, dice
Esoso, sono figlie di Zeus e di Mnemosine; e nei loro nomi c’è l’indicazione della funzione che ciascuna
svolge: Clio fa sì che il canto (del poema epico) dia gloria; Euterpe, che il canto, col suo dolce suono, allieti
colui che l’ascolta; Talia, che la poesia accompagni lo svolgersi della festività; Melpomene e Tersicore, che il
canto sia collegato armonicamente alla musica e alla danza; Erato, che sia suscitato negli uomini il desidero
della poesia; Polimnia, che sia creato il più ricco e vario avvicendamento dei ritmi; Urania, che il canto sia
elevato al cielo; Calliope, che la bellezza della voce sia assicurata sempre alla recitazione.
Invece nella cosmogonia di Ferecide di Siro l’essere perfetto è collocato agli inizi, come principio generatore
dell’universo. Tale essere è configurato come la triade di Zas (Zeus), Chronos e Ctonia, di cui il primo
termine funge da forza unificante (impersonata da Eros) tra gli altri due, e in tal modo presiede al processo
di formazione dell’universo.
Nelle antiche rappresentazioni cosmogoniche greche appaiono, dunque, alcuni concetti che sono
fondamentali per l’ulteriore sviluppo della filosofia della natura: 1) l’idea di una materia primordiale (il Caos)
o di elementi diversi che siano all’origine dell’universo (la Terra, il Tempo ed Eros, come in Ferecide; il Caos
e la Notte, che nei recessi dell’Erebo genera il primissimo Uovo, secondo la cosmogonia orfica); 2) L’idea
dell’unità del principio e unità del tutto, identificato con la stessa divinità (panteismo: “Zeus è il principio, Zeus
il mezzo, da Zeus tutte le cose sono derivate”, secondo quanto recita un antico inno orfico); 3) l’idea di un
principio dell’ordine che presiede alla stabile configurazione dell’universo e assicura il governo di ogni
fenomeno e di ogni vicenda secondo una legge inflessibile; 4) e, dunque, l’idea di una legge universale di
giustizia (Dike, Ananke (la Necessità), il Fato); 5) l’idea di una forza originaria (Eros) che ha agito sulla
materia, organizzandola in un progressivo processo di differenziazione e di formazione di sostanze, enti e
strutture stabili dell’universo.
35
A questo proposito B. Snell osserva: “Quando cantava gli eroi e le loro imprese, Omero poteva descrivere un
mondo di pura luce, dove gli aspetti notturni della realtà quasi scomparivano. Ma Esiodo, che si propone di dare un
quadro realistico del mondo, non può fare come se le ombre non esistessero; nella sua Teogonia ciò che minaccia
l’uomo, l’orrido e l’infame, ha una parte molto più importante che in Omero, poiché la sua poesia vuol dire la verità e
non belle menzogne” (La cultura greca e le origini del pensiero europeo, cit., p. 80).
Questa fondamentale visione vale anche per il mondo umano. Così, anche per quanto riguarda la
concezione dell’ordine politico e la legge dell’umano accadere, riscontriamo significative anticipazioni della
successiva riflessione filosofica intorno alla sfera della morale e della politica. Vediamo sinteticamente i
principali di questi concetti: 1) l’idea di un destino (Fato) ineluttabile: in Omero troviamo riflessioni
sull’ineluttabilità del Fato, al quale tutte le vicende sono sottoposte, tanto che, ad esempio, il destino è
ritenuto responsabile delle azioni e delle passioni umane (questo concetto è ricorrente anche nei poeti tragici,
specialmente in Eschilo); 2) ma accanto a questa idea troviamo quella opposta, secondo cui i mali derivano
da colpe di cui è responsabile lo stesso volere umano: troviamo questo concetto specialmente in Esiodo (nelle
Opere e giorni Prometeo è responsabile del furto del fuoco divino, episodio che è posto all’origine di tutti i
mali); 3) l’idea di una legge universale di giustizia (Dike), che immancabilmente colpisce il colpevole (e dunque
la stessa umanità, considerata colpevole); 4) dunque la visione pessimistica, per cui la vita è considerata di per
sé un male; 5) l’idea dell’insondabilità dei decreti divini: Solone dice che la volontà degli dèi è nascosta agli
uomini; in altri poeti sono ricorrenti gli accenni al fatto che gli dèi sanno tutto, mentre agli uomini ogni cosa
è nascosta; “creature effimere, noi viviamo come bestie al pascolo, ignari di come la divinità condurrà a
termine ciascuna cosa”, troviamo scritto in un frammento di Simonide di Amorgo.
In rapporto a questi concetti fondamentali sulla vita, troviamo l’idea di una “giusta misura”, che
rappresenta la condizione ideale per l’uomo. L’uomo, infatti, deve evitare di gareggiare con gli dèi (è
tracotanza, ybris, ogni tentativo di superare i limiti imposti alla condizione umana), e, accontentandosi di ciò
che gli è pertinente per natura, può riuscire a conseguire una certa felicità. Gli antichi poeti, specialmente
Solone, invitano gli uomini ad avere coscienza della propria natura limitata (“Conosci te stesso”, secondo il
celebre motto che i saggi, discepoli di Apollo, incisero nel tempio di Delfi, come sintesi della loro sapienza,
ispirata dal dio) e a cercare nella loro stessa condizione i presupposti della felicità.
La religione greca
La religiosità dei Greci si espresse in diverse forme: oltre che in quella maggiormente nota della fede negli dèi
dell’Olimpo omerico, abbiamo le molteplici esperienze religiose dei “misteri”, tra le quali spicca l’orfismo. Queste forme
erano specialmente professate dalle popolazioni rurali, costrette a condizioni precarie d’esistenza, per cui appariva
fondamentale la promessa e la via di un redenzione dalle sofferenze presenti in una vita felice di partecipazione alla
realtà divina dopo la morte. In questo senso appariva fondamentale la liberazione dell’anima dal carcere corporeo.
La dottrina religiosa che specialmente ha influito sullo sviluppo di alcuni concetti filosofici è l’orfismo.
Risale a questa dottrina l’idea che l’anima è immortale. Interpretando i sentimenti delle masse popolari,
condannate a una di sofferenza, di fatica e di dolore, gli orfici hanno fondato le loro credenze religiose sulla
destinazione immortale dell’anima e, dunque, sull’idea di un’altra vita, prefigurata come liberazione da ogni
limite corporeo e, perciò, da ogni sofferenza.
Nella mitologia orfica la colpa originaria, per cui l’anima è condannata al carcere corporeo, è quella dei
Titani, che hanno sbranato e divorato Dioniso fanciullo (figlio di Zeus e di Semele). Secondo questo mito,
Zeus avrebbe fulminato i Titani ribelli e dalle loro ceneri avrebbe creato l’uomo, il quale, così sarebbe
composto da una parte titanica, peccaminosa, e da una parte dionisiaca, divina, appunto l’anima, che aspira
a liberarsi dall’unione col corpo. La liberazione dal ciclo delle nascite (trasmigrazione) avviene, secondo la
stessa dottrina orfica, attraverso l’iniziazione ai misteri e l’osservanza del rituale della vita orfica (descritta
nelle iscrizioni delle laminette d’oro trovate nei sepolcri orfici di Thurii). Secondo l’orfismo, l’iniziato
apprende già in questa vita l’itinerario che l’anima seguirà dopo la morte e le tappe e i riti che essa dovrà
adempiere, per conseguire la completa purificazione, che la renderà libera dal ciclo delle trasmigrazioni
corporee e, dunque, meritevole della immortalità e della beatitudine eterna.
Dioniso, il ditirambo, la tragedia
Con l’evoluzione della società greca e la progressiva affermazione della democrazia, si hanno
modificazioni nel complesso dei culti e riti religiosi. Quelle divinità che prima erano relegate a un ambito
periferico, agrario, proprio delle classi subordinate, via via vennero accolte nell’”olimpo” delle divinità
ufficiali (quelle omeriche della società aristocratica). Già il dio degli artigiani, Hephaisto, è da Omero stesso
ammesso alla comunità degli dèi olimpici (anche se egli ha la sua sede nelle profondità della terra). Ai tempi
di Pisistrato ad Atene venne introdotto il culto di Dioniso, già diffuso in Tracia: così esso assunse caratteri
nuovi, venendo assimilato nello schema mitologico della religione ufficiale. Dioniso (il dio terrestre meno
legato alla terrestrità) era figlio di Zeus e di Semele (figlia di Cadmo, re di Tabe). Hera, adirata, indusse i
Titani a ucciderlo ancora bambino; ma Zeus colpì i titani col fulmine e diede vita nuova vita a Dioniso, il
quale rappresenta emblematicamente la vicenda del dio che muore e rinasce, assunta come simbolo
dell’esistenza umana.
Dioniso divenne così il simbolo della rinascita, del superamento della morte. Il suo culto era
un’iniziazione a tale superamento, alla rinascita in qualcuna delle molteplici forme della vita, attraverso
l’assimilazione rituale al dio, identificato col Tutto nel suo continuo processo di nascita, morte e rinascita. Il
culto veniva affidato allora a comunità che conservavano quella tradizione rituale. Il “thìasos” dionisiaco era
costituito da donne guidate da un sacerdote. Il rito consisteva nella “rappresentazione” della “passione” di
Dioniso, in modo che tutti i partecipanti potessero usufruirne gli effetti. Esso comprendeva tre momenti: un
esodo orgiastico in aperta campagna (le “baccanti” invase dallo spirito del dio si abbandonavano a danze
frenetiche); una cerimonia sacrificale, durante la quale la vittima (un toro o un capro) era fatta a pezzi e
mangiata cruda (dunque l’assimilazione della stessa divinità); il ritorno trionfale.
Questo rituale ad Atene subì notevoli modificazioni: la “passione” di Dioniso fu oggetto di
rappresentazione e la processione orgiastica divenne un inno che rievocava i momenti principali della
vicenda. Dall’inno sorse il ditirambo, dalla sacra rappresentazione l’evento teatrale, cioè la tragedia. Ad
Atene le “Grandi Dionisiache” duravano almeno cinque giorni. Il primo giorno si incominciava con la
processione: l’immagine di Dioniso Eleuterio era tolta dal tempio in cui stava collocata tutto l’anno ed era
portata fuori della città in un tempietto accanto all’Accademia, sulla strada di Eleutera (un villaggio fra
l’Attica e la Beozia). L’immagine era scortata dagli “epheboi”, che procedevano armati; seguivano gli animali
destinati al sacrificio e le vergini che recavano in testa canestri con gli strumenti del sacrificio, e quindi la
folla (coi più ricchi sui loro cocchi e adorni di corone e maschere). Sulla piazza del mercato un coro innalzava
inni alle statue dei Dodici Dèi; poi la processione procedeva fino all’Accademia. L’immagine di Dioniso
veniva deposta su un basso altare, si cantavano inni in suo onore e si sacrificavano gli animali. Al cader
della notte, la processione tornava in città, alla luce delle torce: ma, invece di essere riportata nel suo tempio,
l’immagine del dio veniva scortata dagli efebi fino al teatro e deposta su un altare al centro dell’orchestra,
ove rimaneva fino al termine della festa.
Gli altri giorni erano dedicati alle competizioni teatrali (anch’esse indicate col nome di “agòn”). Le
competizioni erano di due specie: drammatiche e ditirambiche. Queste erano di due tipi: uno si svolgeva tra
cinque cori si fanciulli, l’altro fra cinque cori di adulti (introdotti dopo la caduta della tirannide). Il poeta
poteva essere egli stesso corifeo, come Archiloco di Paro: improvvisava le strofe e accompagnava i ritornelli.
In un secondo momento, invece di essere cantato durante la processione, il ditirambo fu recitato in piedi,
accanto all’altare: si chiamò “stàsimon” o “canto da dirsi in piedi”, stando fermi. Il tema dei ditirambi
doveva essere corrispondente al rito che si stava celebrando, cioè la passione di Dioniso. E poiché il corifeo
forse impersonava il dio, ci troviamo di fronte al primo germe del dramma rituale. Quando il corifeo
cominciò a parlare come “personaggio”, il ditirambo si trasformò in sacra rappresentazione. Il ditirambo in
un secondo momento assunse due forme diverse: una forma, più propriamente musicale, rimase più
aderente al nucleo originario (musica e canto), la figura principale divenne dil suonatore di flauto, la musica
prevaleva sulla parola e l’elemento mimetico-drammatico scomparve; nella seconda forma dominò la parola
e acquistò maggiore sviluppo l’azione drammatica, con la partecipazione di un attore e poi di due e di tre.
La tragedia nacque, dunque, dalla rappresentazione della passione di Dioniso. Dioniso è il dio che
assicura il riscatto dalla condizione di limite, di colpa e di sofferenza propria dell’uomo. Ogni
rappresentazione tragica riguarda una vicenda che ha il modello nell’espiazione di una colpa e in un atto di
liberazione da una condizione di sofferenza e di morte. La tragedia esprime, perciò, nella sua forma
generale, l’aspirazione dell’uomo a una condizione di libertà, di pacificazione con tutti gli aspetti della vita
universale.
L’orfismo
Allo scopo di ridimensionare il privilegi politici della vecchia aristocrazia, Pisistrato cercò di ridurre il
suo controllo sul culto, appoggiando l’introduzione ad Atene di culti popolari, specialmente di quello di
Dioniso. Già Periandro, tiranno di Corinto, aveva accolto presso la sua corte Arione di Metimna, l’inventore
del ditirambo (il canto corale in onore di Dioniso).
Nel corso del VI secolo a. C. si diffuse un nuovo culto di Dioniso, identificato con l’orfismo. Secondo la
versione più antica della leggenda, codificata da Eschilo nella “Licurgia”, Licurgo re degli Edoni in Tracia
aveva tentato di opporsi alla diffusione del culto di Dioniso e, per impedire ogni orgia, aveva fatto
distruggere i vigneti. Ma il dio fece sorgere nuove viti, spingendo alla follia i sudditi di Licurgo, il quale morì
sul monte Pangeo, straziato dai propri cavalli. Ma neppure dopo la morte di Licurgo la religione dionisiaca
ebbe vita liberta in Tracia. Là un altro culto si stava diffondendo. Orfeo, sacerdote di Apollo, citarista e
cantore tale da trascinare col suo canto uomini e fiere, adorava il sole proprio sul monte Pangeo la mattina
salutava l’astro che era la manifestazione diurna del suo dio. Dioniso scagliò contro Orfeo le sue seguaci, le
Bassaridi, che lo uccisero e ne fecero il corpo a brani. Ma proprio per questa sua morte, per avere, cioè,
rivissuto la passione di Dioniso (che ancora bambino era stato dilaniato dai Titani, per poi rinascere dal
cuore salvato da Atena), Orfeo diveniva il nuovo eroe dionisiaco: simbolo dell’anima che si libera dal ciclo
delle vite umane e rivive in un’esistenza superiore.36 Nella figura di Orfeo poté trovare un punto di sintesi e
di mediazione il precedente contrasto tra religione apollinea e religione dionisiaca. Fu accettato il senso del
culto dionisiaco (basato sulla promessa della resurrezione e della liberazione finale), ma con rituali
soprattutto apollinei.37
Al tempo di Pisistrato troviamo già stabiliti ad Atene i seguaci dell’orfismo: il loro capo, Onomacrito, era
autore di un libro intitolato Iniziazioni.38 Secondo la dottrina orfica, la vita è per l’uomo penitenza ed
espiazione della colpa dei Titani. Ananke (la Necessità) rappresenta specialmente la condanna alla
sofferenza.39 La raccolta degli Inni orfini comprende 87 componimenti.
La “polis”
I Greci non concepivano l’individuo come naturalmente appartenente alla comunità politica, per cui la felicità,
connessa alla attuazione della natura umana, era conseguita nella città e attraverso l’attività politica. Nel periodo
ellenistico, tuttavia, in seguito alla decadenza della “polis” come sistema dell’organizzazione sociale, si è venuto
affermando il principio dell’autonomia del soggetto umano.
La polis appare come lo spazio proprio di attuazione (di manifestazione e attività) dell’uomo greco. Fuori
della “città” sembrava impossibile conseguire qualsiasi obiettivo proprio dell’uomo: all’interno della “polis”,
invece, sembrava possibile il raggiungimento della “felicità” (coincidente con la piena realizzazione di sé).
La “polis” consente di vincere e superare in qualche modo i limiti connessi alla condizione essenzialmente
“tragica” dell’uomo (secondo cui l’uomo è destinato alla fatica, alla sofferenza e al dolore). Nella “polis”,
infatti, gli uomini superano lo stato di istintivo egoismo, si sottomettono a una legge di giustizia e di
uguaglianza, evitando così i contrasti e le discordie. Così si configura uno scenario di “libertà”, nel quale gli
uomini si sottraggono alla necessità della natura e danno luogo a un “bene pubblico” e a un’“uguaglianza”
che è condizione di perfetta “giustizia”.
36
Le religioni misteriche allora promettevano agli adepti proprio questo: la liberazione dal ciclo delle nascite e la vita
degli dèi: secondo la credenza allora diffusa, solo dopo il ciclo completo di un anno cosmico (circa 13 mila anni) gli
spiriti puri potevano assurgere al cielo, tra gli dèi, mentre quelli malvagi e impuri erano destinati alla distruzione nel
cataclisma il mondo. I più antichi misteri in Grecia furono quelli di Demetra (legati a una società patriarcale). In età
micenea, accanto a Demetra si introdusse Dioniso. In un terzo momento, a fungere da mediatore tra l’uomo e il dio,
venne assunto l’eroe che aveva riprodotto in sé l’esperienza del dio; così dal mistero dionisiaco si passò all’orfismo.
37
Nel rituale orfico, l’iniziando, dopo un digiuno di alcuni giorni (da uno a tre), veniva purificato con vapori di zolfo.
L’iniziazione comprendeva, quindi, sette momenti: vestizione, catechesi (apprendimento di ciò che si intendeva ottenere
e della via da percorrere), agape (convito, a ricordo dell’originario banchetto sacro, durante il quale si mangiava la carne
dell’animale sacrificale), comunione (col dio: e che avveniva stringendo al seno l’animale simboleggiante il dio stesso:
capretto o cerbiatto), annunciazione (della nuova sorte e della nuova vita), passione (mediante fustigazione, poiché si
credeva che senza dolore non si potesse giungere alla conoscenza della via della liberazione), resurrezione alla nuova
vita. Iscrizioni su laminette d’oro trovate in tombe orfiche (specialmente tra Metaponto e Crotone) contenevano
ammaestramenti sul modo di comportarsi nell’oltretomba, in modo da giungere alla fonte di Mnemosine e bere di
quell’acqua.
38
Forse a Onomacrito si deve l’introduzione del mito sull’origine della razza umana dalle ceneri dei Titani ancora
grondanti del sangue di Dioniso. Così si spiegava il carattere duplice (puro e impuro, buono e malvagio) dell’uomo.
39
Una formula orfica diceva: “Mi sono liberato dalla ruota del dolore e della sofferenza”. La ruota, originariamente
simboleggiante il ciclo della vita, rappresentò anche la condanna degli schiavi (infatti era lo strumento di tortura).
Perciò “liberarsi dalla ruota della vita” significava uscire dalla situazione di sofferenza propria della condizione mortale
e tornare alla originaria beatitudine.
Questa concezione si riporta all’idea del fondamentale dualismo tra l’elemento uranico (celeste) e quello
terrestre (ctonio), cioè tra il principio dell’ordine, della legge e della giustizia, e quello dell’istinto, del sangue,
della vendetta, della discordia.40
La vita politica appare come la condizione indispensabile per superare lo stato di confusione naturale (e di
ingiustizia) e conseguire la razionalità dell’ordine cosmico, attingendo la stessa radice divina della legge
universale. Allorché il “privato” invade la scena del “pubblico”, portando disordine e sconvolgimento, si ha
la crisi della città, che si supera solo col successivo sforzo di riorganizzazione della vita politica mediante
l’opera di un legislatore.41
Se noi pensiamo che il problema politico è dominante almeno in un periodo decisivo per lo sviluppo della
filosofia greca, quale è quello del V secolo e che comprende i Sofisti, Socrate e Platone, possiamo allora
capire come la rappresentazione della scena politica abbia costituito l’ambito più proprio per lo sviluppo
delle idee filosofiche centrali, come quelle di giustizia, di ordinamento cosmico, di contrapposizione tra i
principi del razionale e dell’irrazionale, del limite e dell’illimitato, del pubblico e del privato. Concetti,
questi, che, come sappiamo, hanno un ruolo centrale dell’elaborazione del pensiero metafisico, oltre che
nello sviluppo della concezione greca della vita politica e della struttura della “polis”.
40
Nelle Baccanti di Euripide si trova una rappresentazione simbolica molto efficace di tale conflitto: l’indovino
Tiresia, rivolto a Penteo, dice: “Due, infatti, o giovane amico, sono le cose principali fra gli uomini: Demetra, la dea
della terra, o Ctonia, come la si voglia chiamare: costei nutre i mortali con quanto è secco. Colui che giunse invece poi,
il figlio di Semele (Dioniso), scoprì il grappolo e l’umida bevanda che è l’opposto e la portò in dono ai mortali” (vv.
266-275). Qui si rappresenta la differenza tra ciò che s’intende come stabilità e ordine definito (il secco) e ciò che,
invece, rappresenta l’indivisibile e l’unitario, l’indistinto e l’indifferenziato, ciò che disgrega qualsiasi ordine e riporta
ciò che è distinto all’unità indifferenziata (l’umido).
41
I greci ebbero un’esperienza lunga e complessa della dinamica della vita politica, conobbero la realtà tragica delle
discordie interne, delle violenze e delle lotte per il potere da parte di individui o gruppi sociali. Questa esperienza ha
avuto un indubbio influsso sulla nascita della filosofia come comprensione delle forze che dominano l’accadere naturale
(e che sono quelle opposte dell’umido e del secco, del limite e dell’illimitato, dell’amore e dell’odio, e così via), delle
leggi che presiedono alla vicenda cosmica, dello stesso significato dell’opposizione dei contrari e dell’armonia che
deriva dalla conciliazione (dialettica) degli opposti.
CAPITOLO III
I primi filosofi: il naturalismo tra scienza e metafisica
Il primo periodo della filosofia è detto “naturalistico”, in quanto i filosofi concentrarono l’indagine intorno al sistema
unitario del reale, concepito come “natura”, cioè come un sistema regolato da leggi e comprendente tutti i processi di
formazione e di trasformazione delle cose. Allora però si è incominciato a distinguere l’universo degli enti rispetto al suo
“principio”immutabile o “fondamento”, l’uno oggetto di una scienza alla cui costruzione contribuivano sia l’esperienza
sia il pensiero puro, l’altro invece puramente intelligibile e oggetto di riflessione speculativa.
I filosofi della scuola di Mileto
Per Talete principio di tutte le cose è l’acqua che, per l’azione del calore e del freddo, si trasforma assumendo le
caratteristiche e le qualità proprie delle diverse cose.
Anassimandro ha posto come principio lo stesso essere “indeterminato”, l’”infinto”, dal quale tutte le cose si
generano ma in cui anche si dissolvono, “pagando il fio” per il tentativo di instaurare il dominio degli enti finiti che
inevitabilmente si combattono, cercando di prevalere a vicenda gli uni sugli altri.
Anassimene tornò a porre come principio una sostanza, l’aria, cioè la più adatta ad assumere le forme delle tante cose
e ad alimentare la vita nel cosmo.
Tra la fine del VII e l'inizio del VI secolo a. C. nella Jonia sorse la prima scuola filosofica, che assunse come
suo principale campo d’indagine la natura, intesa come sfera unitaria dei fenomeni. Il problema
cosmologico, relativo alla costituzione dell’universo e alle leggi uniformi dell’accadere fisico, è quello che,
per primo, costituisce oggetto di riflessione filosofica, dando luogo a una forma di sapere che poggia ormai
non più sull’autorità della tradizione sapienziale e mitopoietica bensì su11a capacità autonoma della mente
umana di comprendere i principi e le leggi fondamentali dell’accadere naturale e cosmico. Al posto dei miti
teogonici e cosmogonici subentrò allora una prima vera e propria scienza della natura.42
Il concetto di “natura” soddisfa la fondamentale esigenza di spiegazione unitaria di tutti i fenomeni; essa è
principio generatore delle cose e, insieme, sostanza primordiale da cui deriva e a cui sempre ritorna la
molteplicità degli enti.43
Già nelle teogonie questo concetto è presente sotto la forma di un unico principio divino (“tò theion”), che
pervade e in sé contiene l’intero universo che esso medesimo continuamente genera. Questo principio è
identificato dai primi filosofi con l’unica sostanza, animata e vivente, che da sé, in virtù di una propria
“materia”, nonché di una forza e di una legge intrinseca, genera tutte le cose, continuamente trasformandosi
e ritornando alla sua forma originaria. Perciò questo naturalismo è stato definito hylozoismo o hylopsichismo
(la materia è vita e mente nello stesso tempo). Nella natura è, dunque, implicito il principio regolatore (che
può essere identificato con un intelletto ordinatore o un “logos”), che dispone l’intera realtà secondo un certo
disegno (e anche un certo fine), che è concepito, tuttavia, come una necessità, in quanto è ritenuto come
l’unico possibile e attuabile. In questa concezione, le idee di sostanza o materia primordiale, legge unica di
42
Nel concetto di “natura” confluiscono le idee mitologiche relative a una inflessibile legge che domina l’ordine
cosmico (“Ananke”, necessità, destino) e a una fondamentale “giustizia” (“Dike”), che, al di là di ogni particolare
affermazione fenomenica di enti e di processi tisici, infine emerge e si afferma, come supremo principio di equilibrio.
che impedisce la prevaricazione di alcuni elementi su altri. In questo senso l’immagine dell’ordine naturale è
assimilata a quella del mondo umano e sociale, che ha la sua tipica espressione nella città-stato. Come ha notato W.
Jaeger, si ha una proiezione della “polis” nell’universo, col trasferimento alla sfera dell’accadere naturale di una
serie di concetti originariamente sorti nell’ambito giuridico~socia1e; la “causa” (aitia), ad esempio, in origine
significa “imputazione” e la “giustizia” (dike) indica la legge che, inf1iggendo una pena, ristabilisce l’equilibrio
infranto da una “colpa” (Cfr. W. Jaeger, Paideia, tr. it., I, p. 255).
Il concetto di “natura” (phvsis) compendia questi elementi nell’ambito dell’ordine cosmico, che appare, in primo
luogo, come una vicenda continua di trasformazione e per cui s’impone, pertanto, un “principio” regolatore, in quanto
l’incessante mutare delle cose deve, infine, apparire dominato da una legge che sia anche ristabilimento continuo
dell’equilibrio infranto.
43
Come ha notato Aristotele, i primi filosofi “concludono che nulla nasce e nulla perisce, perché questa natura si
conserva sempre, […] giacché è necessario che ci sia una tal natura, sia unica sia molteplice, da cui si generino le altre
cose, conservandosi essa stessa” (Metafisica, I, 3).
tutti i processi naturali, ordine universale e necessario, costituiscono un insieme unitario, che è espresso,
appunto, dal concetto di natura.
Il fondatore della Scuola ionica e l’iniziatore della filosofia è considerato Talete di Mileto.44 Ponendo l’acqua
come principio (arké) di tutto l’universo e legge fondamentale di tutti i fenomeni (poiché tutto si produce
nella natura attraverso i fondamentali processi di rarefazione e di condensazione di questa sostanza), egli
formulò la prima ipotesi di spiegazione scientifica generale. Infatti, la scienza sorge con la prima esplicita
formulazione di un principio causale e di una legge unitaria, che dia “ragione” della molteplicità delle
sostanze e dei processi attraverso i quale esse mutano. Talete intese l’acqua come il principio intelligibile,
idoneo a consentire la comprensione di tutti i fenomeni come processi di trasformazione di un’unica
sostanza fondamentale.45
Anassimandro, contemporaneo di Talete, è considerato il primo autore di un’opera filosofica (Sulla
natura).46 Egli usò per primo il termine “arké” e identificò il principio non in una sostanza determinata, bensì
nell’infinito, ponendo così l’accento sulla proprietà essenziale di ciò che sta a fondamento del tutto, che
genera da sé tutte le cose e in sé le riassorbe, secondo una legge necessaria che sovrasta sull’intero divenire.
L’apeiron trascende tutti gli enti finiti, è al di là di ogni determinazione spaziale e temporale, ma, nello stesso
tempo, è la spazialità infinita e l’eternità (il tempo infinito). Dal punto di vista fisico, il processo
fondamentale attraverso il quale tutte le cose derivano dall’“arké” è la separazione: l’infinito spazio materiale
è animato da un eterno movimento, in virtù del quale da essa si separano in primo luogo i contrari: caldo e
freddo, secco e umido, pesante e leggero, e così via. Dal vario combinarsi di questi si producono i mondi
infiniti, che si succedono in un ciclo eterno. Per ogni mondo, i tempi della nascita, della durata e della fine
sono segnati: “Tutti gli esseri devono, secondo l’ordine del tempo, pagare gli uni agli altri il fio della loro
ingiustizia”, recita il frammento più antico della storia della filosofia che ci è stato tramandato. Qui la legge
di giustizia, che punisce la prevaricazione per cui l’ente finito si separa dall’apeiron, è considerata legge
cosmica universale. La colpa è identificata con la stessa nascita, per cui ogni ente aspira a quella condizione
che propriamente appartiene all’infinito: è colpa la separazione dal tutto originario, poiché, in qualche
modo, essa è una rottura dell’unità. Perciò il processo per cui dall’unità primordiale si genera la diversità è
continuamente annullato: ogni ordine determinato, infatti, reca in sé, per quanto i contrari possano
armonizzarsi, motivi di contrasto, che determinano una condizione di instabilità. Troviamo così l’idea di una
44
Talete fu contemporaneo di Solone e il momento della sua massima fioritura è posto intorno al 585 a. C., per cui la
sua nascita risalirebbe al 624-23 e la sua morte sarebbe avvenuta nel 546-45. Il suo nome compare in un elenco dei
Sette Sapienti. Egli avrebbe avuto un ruolo decisivo nell’introduzione in Grecia delle conoscenze matematiche e
astronomiche degli Orientali.
45
Diversi studiosi hanno ricercato la genesi della concezione dell’acqua come principio. Il Tannery l’ha trovata in
una cosmogonia egizia, esposta in alcuni antichissimi papiri, in cui si legge che “in principio era ‘Nun’” (il caos
acquoso), dal quale è uscita l’“Enneade divina” (primo il Sole e poi, generati dalla potenza magica di questo, l’Aria, la
Pioggia, la Terra, il Cielo, e infine Isis e Osiride (copia di forze della fecondità e della vita) e Nephtys e Seth (coppia di
forze dell’isterilimento e della morte). Questo schema cosmogonico è stato rinvenuto presso altre culture. Anche
l’“Enuma Eis”, il poema babilonese della creazione, pone alle origini di tutto la triade primordiale del caos acquoso:
l’Abisso, l’Oceano universale e lo scroscio delle Acque. E così nella cosmogonia ebraica si dice che “sopra le acque il
Signore ha distesa la Terra” (Salmo 136) e che in principio, quando “le tenebre erano sopra la faccia dell’Abisso, lo
Spirito di Dio si muoveva sopra la distesa delle acque” (Genesi, I, 2), e poi quando, fatta la luce, Dio ordinò che le
acque si separassero e si formassero il cielo e i mari, e che il cosmo fosse circondato tutto da acque; quindi per lo
scoppio di tutte le fonti si è prodotto il diluvio, che è finito con la loro chiusura (I, 6, VII, 11; VIII, 2). In analogia con
queste concezioni, troviamo in Omero tracce della leggenda di Oceano, universale progenitore e contenitore di tutto
l’universo (Iliade, XVIII, 607). L’idea dell’acqua come elemento primordiale è posta dal Furlani (e da altri storici delle
religioni) in relazione con l’idea delle grandi lotte cosmiche, suggerita dall’esperienza dei maggiori fenomeni naturali,
specie della lotta della primavera con l’inverno e del sole contro le tenebre tempestose. Così l’ordine luminoso del
cosmo si presenta come una conquista sopra l’informe, il tenebroso stato primordiale. “Perciò è accaduto – osserva il
Mondolfo – quel che notava Aristotele (Metaph., I, 8, 989 a), che cioè nessuno dei naturalisti ha posto a principio la
terra. La “Terra Madre”, che pure nei culti agrari, nelle pratiche magiche e nei misteri era fonte, riserva e foce della vita
organica e delle anime, non poteva assumere tale funzione per tutto il divenire cosmico: nella persistente stabilità e
scarsa plasticità che la caratterizza, non si prestava a funzionare da principio universale del movimento, della
mutazione, della temporalità, del nascere e perire” (Cfr. Zeller-Mondolfo, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo
storico, cit., I/II, p. 130). Trale giustificazioni empiriche che concorrevano a privilegiare l’acqua, possiamo citare:
l’importanza dell’umidità per la vita, l’azione fecondante dell’acqua, il fatto stesso che la terra sta sopra l’acqua, la
quale ha la funzione di subiectum (che sta sotto e che sostiene la terra).
46
Sarebbe vissuto tra 610 e il 546 a. C.
legalità universale, che appare proiettata dal mondo umano e sociale nella realtà cosmica.47 Gli alterni
squilibri, che si mantengono nei limiti di durata di ogni mondo, trovano infine il loro pareggiamento nello
sbocco finale del riassorbimento dei contrari nell’unità dell’apeiron, allorché l’adikia estrema (disseccamento
dell’umido ad opera del fuoco) distrugge il mondo e fa svanire insieme sopraffattore e sopraffatto
nell’indistinto primordiale.48
L’infinito di Anassimandro è la prima forma in cui il fondamento (l’arké) è pensato metafisicamente, come
trascendente rispetto all’ordine della natura (considerata come l’insieme degli enti e dei processi di
mutamento ai quali sono sottoposti.49
47
Così nelle città i partiti e le fazioni si avvicendano nel governo, e analogamente, nell’ordine della natura, il caldo e
il freddo si alternano in periodi di prevalenza dell’uno e dell’altro.
48
Anassimandro si pose il problema onde possa nascere un cosmo dallo stato caotico primordiale; e ricorrendo
all’ipotesi del vortice, suggeritagli dall’idea tradizionale della tempestosità del Caos, è stato condotto alla concezione di
una molteplicità innumerevole di vortici e quindi di cosmi tra loro diversi. L’opinione oggi prevalente tra gli studiosi,
riguardo alla molteplicità infinita dei mondi in Anassimandro, è che non si tratti solo di mondi successivi (come
sosteneva lo Zeller), ma di mondi o “cieli” coesistenti nello spazio infinito che tutti li contiene, collocati a lunghi
intervalli l’uno dall’altro, formantisi e dissolventisi di continuo e in ogni direzione (come appare in Lucrezio, I, 1007:
finibus exemptis in cuctas undique partes). In questa rappresentazione (nota il Rivaud) ogni cosmo (“ouranos”), con la
sua limitazione e perfezione geometrica di forma circolare, si contrappone all’infinità caotica dell’apeiron; e c’è un
motivo prepitagorico nell’idea degli intervalli regolari e dell’ordine interno delle ruote astrali, in cui dominano misura,
proporzione e numero. Questi elementi rappresentano così anche i princìpi della meccanica, basata sulle leggi del moto
vorticoso. La separazione del caldo dal freddo, dell’asciutto dall’umido, compiuta da questo moto, significa, in primo
luogo, distribuzione in zone concentriche di fuoco, aria e acqua-terra. Nel processo di formazione cosmica, si sono
formati anche quegli anelli o cerchi d’aria rotanti, che racchiudono in sé ruote di fuoco strappato dalla corteccia ignea
circostante al mondo, e ne lasciano apparire a noi il fulgore solo attraverso fori, paragonati alle bocche dei mantici, per
cui mezzo si alimenta il fuoco. Per effetto del vortice si forma la sfera rotante della massa cosmogonica; e per esso si
distinguono la zona periferica del fuoco e la massa centrale del freddo-umido, che sotto l’azione del caldo periferico in
parte evapora, convertendosi in aria, in parte si differenzia in acqua e terra, mentre l’umidità evaporando si espande,
sicché l’aria, spinta in forma di vento contro la corteccia di fuoco, ne lacera brani e li avvolge entro i suoi anelli rotanti.
Quanto alle proporzioni attribuite ai cerchi astrali, Anassimandro, assumendo a unità di misura il diametro terrestre, ha
applicato la progressione 9, 18, 27 (multipli di 3) rispettivamente ai cerchi di stelle, luna, sole. Riguardo alle stelle, il
Tannery e il Burnet hanno creduto trattarsi di ruota unica, da identificarsi con la Via Lattea; al che contrasta il fatto che
l’apparenza di questa dà un’estensione luminosa continua, invece dei fori da cui è detto apparire negli astri il fuoco
chiuso nelle ruote d’aria. La dossografia, infatti, parla al plurale di ruote astrali o di stelle fisse e pianeti. E’ probabile
che Anassimandro, come poi Anassimene, inserisse in anelli rotanti i pianeti, ma considerasse fissate alla volta celeste
le stelle. Così, restando al di sotto delle ruote lunare e solare quelle planetarie, le stelle sarebbero respinte ai confini del
cosmo: fiammelle soffianti da bocche rivelatrici della corteccia di fuoco onde l’ouranos è recinto. La terra è stata spinta
al centro del cosmo dal vortice stesso, e alla stessa causa sembra doversi attribuire la forma di ruota o disco rotondo,
quasi tamburo e frammento di cilindro o di colonna, a facce convesse. E’ dubbia l’idea di una persistenza di una
rotazione, sia pur lenta, della terra. Il fatto che la terra sta al centro del cosmo è dovuto al motivo che essa ha uguale
rapporto da ogni parte (è un fatto di equilibrio, e non di inerzia; che si produce per l’azione del moto vorticoso e non per
una certa collocazione secondo il “luogo naturale”, come dirà Aristotele) (Cfr. Zeller-Mondolfo, op. cit., I/II, pp. 196205).
49
Il fondamento non è più considerato come una sostanza determinata, bensì come l’indeterminato stesso, cioè la
materia come assenza di ogni qualità, forma o aspetto determinato, e che è illimitata anche nel senso dell’estensione e
della grandezza. Queste sorgono, infatti, assieme alla determinazione delle sostanze, appunto come elementi
fondamentali della determinazione. Tutto ciò che riguarda l’infinito e illimitato appartiene alla materia: in primo luogo
vi appartengono il tempo e lo spazio infiniti. Così il tempo di cui noi abbiamo esperienza si dissolve nell’infinità dei
suoi istanti e lo spazio nell’infinità dei suoi punti. C’è, in questo modo, un tempo originario, privo di determinazione e
di misura, come c’è uno spazio assoluto, privo di coordinate. In questo senso, parliamo del tempo e dello spazio
indipendenti da qualsiasi universo, invece il tempo e lo spazio connessi a un universo sono legati a modalità determinate
di misura e di ordine. Il tempo, in particolare, assume la misura connessa al movimento generale dell’universo, che
nell’antichità è inteso come movimento del cielo e degli astri. Analogamente lo spazio coincide con l’ordine stesso
dell’universo. Il tempo proprio di un universo è finito e misurabile. Il divenire è il processo per cui l’infinito genera gli
universi finiti e, dunque, si costituisce come modalità spaziali e temporali determinate. Come preciserà Eraclito, il
divenire riguarda l’intersecazione dell’infinito nel finito, cioè il fatto per cui ogni determinazione si genera e insieme si
dissolve nell’indeterminato. L’istante è l’elemento costitutivo del divenire: esso, infatti, fa sì che ogni determinazione
trapassi nell’indeterminato e che questo continuamente si determini in modi infiniti. Nel momento in cui è posta una
determinazione, è posto anche il processo della sua trasformazione: ogni cosa è posta insieme al suo destino di
mutamento e di morte.
In Anassimandro troviamo una prima distinzione tra fisica e metafisica, cioè tra la scienza che riguarda
l’ordine dell’universo e quella che riguarda il fondamento immutabile. Realmente eterno e immutabile è
l’infinito, mentre l’ordine dell’universo fa parte del divenire. La natura è la sfera del mutamento e si
manifesta in un determinato ordine fisico che si svolge secondo certe leggi.
Anassimene, forse discepolo di Anassimandro, tornò a porre come arké una sostanza fondamentale, l’aria,
alla quale attribuì i caratteri dell’apeiron, l’infinità e il movimento incessante.50 L’aria era intesa come la forza
che presiede all’organizzazione di tutte le sostanze, mediante il duplice processo di condensazione e di
rarefazione. Rarefacendosi, l’aria diventa fuoco; condensandosi, diventa vento, poi nuvola e poi acqua, terra
e pietra. Anche il caldo e il freddo sono dovuti ai medesimi processi. L’aria è paragonata anche all’anima.51 Il
mondo è come un gigantesco animale che respira. Inoltre, Anassimandro ammetteva il divenire ciclico
dell’universo, quindi il suo dissolvimento periodico nel principio originario e il periodico rigenerarsi da
esso. Poiché tutte le cose non sono altro che aspetti e modificazioni dell’aria, determinati in base ai diversi
rapporti in cui intervengono il caldo e il freddo, abbiamo qui una prima idea della fondamentale struttura
quantitativa dei fenomeni.
Motivi etici e religiosi della prima riflessione naturalistica
Ancora lo Zeller vedeva nella filosofia presocratica il predominio unilaterale del problema della natura;
tuttavia osservava che non è possibile applicare ad essa la distinzione di idealismo e realismo. “Né il numero
pitagorico – scriveva – né l’Uno eleatico sono esseri spirituali, differenziati dagli esseri sensibili come sono le
Idee platoniche. Il numero e l’essere son qui la sostanza stessa dei corpi, la materia di cui constano, ed essi
per questo otivo sono tuttavia concepiti ancora sotto forma sensibile; le determinazioni numeriche nei
Pitagorici si mescolano e si confondono con quelle di grandezza, e i numeri diventano qualcosa di
sostanzialmente esteso; e fra gli Eleati lo stesso Parmenide descrive l’essere come una sostanza che riempie
lo spazio”.52 Questa tesi è ampiamente discussa dal Mondolfo nella Nota sulla filosofia presocratica: processo di
formazione, caratteri, sviluppi. In realtà, la tesi della filosofia presocratica come “filosofia della natura” è stata
successivamente accolta dalla storiografia come un dato certo: il Windelband designava quel periodo come
“cosmologico” e il Tannery chiamava “fisiologi” tutti i primi filosofi, in quanto essi elaborarono delle ipotsi
di spiegazione generale dei processi naturali (tra i quali sono compresi i fatti umani). Lo Joel, invece, ha
messo in rilievo l’interesse di quei filosofi per la realtà umana, per i problemi della morale e della politica,
per la religione e il destino dell’anima. Egli sottoliena specialmente la proiezione cosmica di aspetti
fondamentali del mondo storico: così, ad esempio, nel concetto di Anassimandro di un processo universale
di riproduzione continua di una colpa con la nascita degli enti e di una espiazione mediante la loro
dissoluzione nell’infinito, secondo una inflessibile legge di giustizia; e analogamente in Parmenide, con la
personificazione della divinità in Dike (Ananke o Moira), che tiene le chiavi della Verità e chiude l’essere in
rigidi confini; in Empedocle, con l’idea che il mistero delle cose è iscritto nell’uomo, in quanto le forze
cosmiche e i vari elementi sono presenti nella sua costituzione, sicché noi possiamo conoscere il simile dal
simile, cioè il mondo nella sua totalità, che nel suo insieme è un immenso essere vivente. A questo proposito,
è stato rilevato che gran parte della filosofia presocratica presenta significative connessioni con la dottrina
orfica. Orfismo e filosofia della natura sarebbero, in questo senso, espressioni di una stessa temperie
culturale, come osserva lo stesso Mondolfo.53 I “misteri”, in particolare, sarebbero inseriti in questa visione
“panteistica”, per cui l’intero universo sarebbe identificato col dio e con la sua vicenda di nascita, morte e
resurrezione. Gli uomini parteciperebbero a questa vicenda universale, che è anche la vicenda dominata
dalla legge naturale. Questa legge implica la nascita e la dissoluzione degli enti e il loro ritorno ciclico, in
modo che essi (cose e fenomeni della natura) partecipano della stessa esperienza umana, contrassegnata
dalla colpa della nascita, dall’espiazione attraverso la sofferenza e lo stesso peso della mortalità e della
finitezza, e, infine, dalla rinascita attraverso il dio. In effetti, l’acquisizione dell’immortalità era concepita
come un ritorno all’unità dello spirito del dio e, dunque, come un superamento della vicenda naturale. Il
dio, l’anima umana e il tutto sarebbero così uniti nel mistero, che è vicenda divina, cosmica e umana insieme.
Nella filosofia, il motivo della natura ha assunto un posto centrale: i naturalisti, pur aderendo alla dottrina
dell’universale connessione degli esseri, hanno rivolto la loro attenzione alla legge unica di produzione e di
50
Anassimene sarebbe vissuto tra il 586 e il 528 a. C.
“Come l’anima nostra, che è aria, ci sostiene, così il soffio e l’aria circondano il mondo intero” (fr. 2).
52
Zeller-Mondolfo, La filosofia dei greci nel suo sviluppo storico, I/II, pp. 9-10.
53
Op. cit., p. 34.
51
trasformazione delle cose, in modo da dare luogo a una conoscenza specifica, distinta da quella
“sapienziale” (ancora mitologica) e basata sull’osservazione e sul ragionamento. Una importante tappa in
questa direzione appare la stessa riflessione di Parmenide, per cui la divinità si configura come dea della
verità e del “logos”, dunque come principio di una conoscenza che è conseguita attraverso il pensiero. E’
significativo, del resto, come in Platone i motivi “dialettici”, propri della filosofia come indagine razionale,
siano sempre connessi coi motivi sapienziali, evidenti specialmente nell’escatologia (che appare
sostanzialmente modellata sulla dottrina orfica).
Il Mondolfo ha tracciato la via per la quale le opposte tesi del Tannery e dello Joel sono conciliate in una
più completa visione unitaria. In questo senso, religione, scienza, arte, tecnica, morale e politica
costituiscono, nella Grecia del VI secolo a. C. e, si può dire, ancora prima e anche dopo, un’unità inscindibile,
un tutto organico e unitario. Accade così che in quegli antichi filosofi la ricerca, la speculazione e la scienza
(e anche la tecnica) acquistano il carattere di una iniziazione religiosa e si fondono in un processo di
elevazione spirituale, di catarsi dal mondo, di purificazione e di attingimento del divino. Come appunto
spiega il Mondolfo: “Le scuole hanno un carattere di thiasoi, anche perché vi si compie un’iniziazione e vi si
adempie, oltre che una purificazione spirituale, anche una specie di missione rinnovante l’orfica katabasis eis
Aidou, come mostrerà poi Platone nell’allegoria della caverna. La conoscenza, che tende a risalire dalla
molteplicità confusa dei cangiamenti particolari all’unità del principio universale – thò theion, secondo
l’espressione di Anassimandro – come a fonte di ogni esistenza individuale, che in quella deve infine
sfociare, è katharsis spirituale; il theorein – spiegherà poi Aristotele nell’Etica Nicomachea sulle orme dei
Pitagorici – costituisce la più alta tra le vite (teoretica, etica, utilitaria) possibili all’uomo” .54
Il Mondolfo ritiene che i concetti di “legge”, “destino”, “ordinamento”, e così via, siano sorti prima nel
campo della riflessione morale e dell’osservazione del mondo umano e politico e da qui siano stati estesi alla
rappresentazione dell’universo e della natura. “Onde appare chiaro – egli scrive – sotto ogni rispetto che il
cammino della riflessione greca non si è compiuto affatto dalle stelle alla vita; ma, proprio al contrario, dalla
vita alle stelle, per estendere a tutta la realtà universale extraumana quei concetti sistematici di ordine
necessario e di legge ineluttabile, che s’erano prima formati nell’ambito delle esperienze ed esigenze
riguardanti la vita umana. Così avviene che il concetto di legge fatale (katà tò khreon), di espiazione (dike) del
peccato, che si erga insolente a violare la legge (adikia), si trasferisca con Anassimandro dal dominio della
vita umana a quello delle vicende cosmiche, in cui al Milesio appare ybris quel distacco dall’eeterna
indistruttibile unità primordiale divina, onde si costituiscono e si pongono a sé i singoli esseri cosmici. E
forse nella analoga estensione universale di un concetto generale di necessità l’aveva preceduto già Talete,
cui Diog. L., I, 35, attribuisce la sentenza: ‘nulla più forte della Necessità’ (iskyrotaton Ananke). Così poi con
Eraclito si afferma che per tutto l’universo ciò che da omero alla gnomica era stato asserito per le vicende
umane: tutto avviene secondo un fato, che si dice anche necessità. E così alle Erinni, ministre di Dike, cui già
la riflessione etica affidava il compito di vigilare la condotta degli uomini, Eraclito assegna la funzione di
sorvegliare il corso del sole, per impedire a lui pure, con la minaccia del loro intervento, di prevaricare le
misure stabilite” .55 “Moira, Ananke, Dike e altre consimili rappresentazioni della legge di necessità e di
giustizia sono soltanto elementi e condizioni di un più complesso concetto unitario, quello di ‘natura’
(‘physis’), in cui la prima speculazione greca cerca non soltanto il centro di raccoglimento e di sintesi della
scarsa e caotica molteplicità fenomenica, ma ancor più il principio permanente, di fronte alla mutazione e
instabilità di tutte le cose” .56
La filosofia nella Magna Grecia
I Pitagorici
Pitagora pose il numero come principio di tutte le cose, dando luogo a una prima concezione matematica (aritmetica
e geometrica) della natura. Prima delle cose ci sono i principi dell’ordine cosmico; alla base di ogni processo fisico ci sono
i rapporti (di carattere quantitativo) secondo cui le cose stanno in rapporto tra loro, secondo una legge di armonia e di
equilibrio. I numeri si generano tutti dall’unità, secondo una fondamentale differenza tra pari e dispari. Dalla dottrina
pitagorica deriva la numeroogia, per cui i numeri hanno significati simbolici riferiti sia all’ordine naturale sia alla
costituzione dell’anima e alla sfera umana in generale (specialmente all’ambito dei comportamenti morali).
54
55
Op. cit., p. 49.
Op. cit., p. 57.
56
Op. cit., p. 57.
Già Eraclito osservò che “Pitagora spinse le ricerche più lontano di tutti gli altri uomini” (fr. 129), ma,
polemicamente, individuò nella sapienza pitagorica solo una vasta e disorganica erudizione (“polimathia”),
laddove la vera scienza consisterebbe nell’intelligenza unificante. Giamblico (Vita Pythag., 58) rilevò il
carattere religioso della dottrina pitagorica, osservando che per Pitagora “la più pura specie di uomo è quella
che si eleva alla contemplazione delle supreme bellezze, e tale è il filosofo”.57 La “filosofia”, così, come
“amore della sapienza” (e questa definizione è attribuita, appunto, a Pitagora), indica essenzialmente un tipo
di vita, cioè quello dedito alla ricerca e alla contemplazione delle “essenze” o realtà prime (i numeri, le figure
geometriche, i rapporti matematici). Infatti, attraverso la filosofia l’anima si ricongiungerebbe al principio
divino, dal quale dapprima si è separata.58
Per Pitagora, il principio di tutte le cose è il numero, inteso in senso aritmo-geometrico, cioè come rapporto
quantitativo e, insieme, grandezza spaziale e figura geometrica. “Ordine” spaziale e “misura” costituiscono
una dimensione unitaria, che, nel suo sviluppo, dà luogo all’universo degli enti. Lo spazio/materia
originario contiene in sé i princìpi del suo sviluppo: esso genera i vari rapporti aritmetici e le corrispondenti
forme geometriche, dando luogo alle proprietà qualitative che concorrono a configurare non solo i corpi ma
anche i princìpi morali che sono parte integrante della vita dell’universo.
A questa concezione i Pitagorici sarebbero stati condotti dalla riflessione sviluppata nelle precedenti
visioni cosmogoniche:59 interpretando il processo fondamentale di formazione dell’universo come processo
di determinazione dell’“illimitato” mediante condensazione e rarefazione, i Pitagorici hanno identificato il
fuoco come principio di determinazione (“peras”) che aspira il “pneuma” indefinito circostante (l’aria di
Anassimene o l’“apeiron” di Anassimandro). Un principio determinante opera continuamente su un
principio indeterminato; e la determinazione è identificata con lo sviluppo dei rapporti numerici e
geometrici.60 La molteplicità degli enti (e, prima ancora, delle “essenze” secondo cui gli enti sono costituiti)
viene a costituirsi nel cosmo a livello di determinazione numerica: i numeri sono considerati come entità
fisiche, prodotte dalla determinazione (ad opera dell’Uno) dell’indeterminata materia. Questa, identificata
con l’infinito “pneuma”, avrebbe assunto, attraverso l’azione dell’Uno/cielo, la configurazione “cosmica” di
un insieme di rapporti ordinati. L’Uno ordina la materia, configurandola in un universo ordinato di strutture
reali esattamente determinate: e queste sono, insieme, forme della determinazione quantitativa e spaziale
57
Pitagora nacque a Samo intorno 570 e morì a Metaponto intorno al 480 a. C. Fondò una comunità filosoficoreligiosa a Crotone e sull’esempio di quella ne fiorirono altre, ma vennero poi travolte dall’opposizione popolare,
poiché avevano un carattere aristocratico e favorivano l’ascesa al potere delle oligarchie prevalenti. Si tramanda che il
pitagorico Liside avesse fondato una comunità pitagorica a Tebe e che a questa avessero appartenuto Filolao, la figura
più notevole del movimento, e Simmia e Cebete, che appaiono come ultimi interlocutori di Socrate nel Fedone
platonico. Una importante comunità pitagorica venne fondata a Taranto da Archetto e ad essa appartenne Archita,
amico di Platone.
58
I Pitagorici hanno derivato dagli Orfici la credenza di un’origine divina dell’anima e di una caduta che, quindi, la
condanna a una trasmigrazione di corpo in corpo, fino alla purificazione e alla liberazione dal ciclo delle vite corporee.
Il processo di purificazione, che per gli Orfici si compie attraverso l’iniziazione a particolari riti, che hanno lo scopo di
insegnare le regole che l’anima deve seguire per raggiungere la beatitudine eterna, per Pitagora consiste
nell’applicazione alla filosofia. La vita dedita al culto del sapere è, perciò, indicata come mezzo per il ritorno dell’anima
all’originario stato divino. D’altra parte, l’esercizio della filosofia ha lo scopo di attuare, già in questa vita, quanto di più
divino vi è nell’anima, cioè la conoscenza contemplativa dell’ordine armonico dell’universo e delle leggi matematiche
sulle quali esso è fondato.
59
A. Rey (La jeunesse de la science grecque, Paris 1933, pp. 364 sgg.) ha messo in rilievo la genesi della cosmologia
pitagorica nella tradizione della filosofia jonica.
60
Così si spiega il rapporto che lega la dottrina del numero come essenza dell’universo con la teoria della
respirazione cosmica (documentata dalla polemica di Senofane nel primo pitagorismo). Questa teoria, infatti, tende a
risolvere il problema dell’origine del molteplice dall’Uno: la separazione e differenziazione delle realtà particolari
(sostanze fondamentali, elementi) esige l’introduzione tra di esse di un intervallo (vuoto), cioè l’azione sull’àpeiron
8identificato col “pieno”) dell’opposto principio del limite (Uno, cielo), che lo avrebbe inalato dentro di sé. L’infinito è
identificato con l’aria (identificata con la materia indefinita, massa continua e informe), mentre il fuoco (il cielo, come
principio della determinazione) è il principio attivo che in sé assorbe l’aria e organizza il tutto secondo rapporti
matematici, compiendo, mediante il vuoto, la separazione delle sostanze. Dunque il vuoto funge da principio
delimitante; e la delimitazione avviene, in primo luogo, nella forma della determinazione numerica e geometrica. Come
scrive Aristotele: “I Pitagorici ammettevano l’esistenza del vuoto e dicevano che esso, per opera del ‘soffio infinito’,
avanza nel cielo, come se questo respirasse, e che è proprio il vuoto a delimitare le cose della natura, quasi che il vuoto
fosse un elemento che separa gli enti e li delimita; e asserivano che ciò si verifica anzitutto nei numeri, giacché il vuoto
delimita la loro natura” (Phys., 213 b, tr. A. Russo).
(cioè rapporti numerici e figure geometriche) e “nature”, cioè entità reali (per cui i due aspetti sussistono
insieme e sono inseparabili). L’essenza del numero è la stessa legge della distinzione; e poiché ogni cosa ha la
sua ragion d’essere nella forma o essenza che la distingue da ogni altra, il numero esprime questa stessa
essenza.61
L’unità, come principio di ogni determinazione, è la sostanza fondamentale. L’Uno, infatti, contiene in sé
il “pari” e il “dispari”, cioè il principio dell’illimitatezza e quello del limite. Il “pari” è “compreso e terminato
dal dispari”, dunque rappresenta l’infinito e illimitato.62
Finito/infinito, dispari/pari, unità/molteplicità sono le prime fondamentali coppie di opposti. Le altre
coppie di contrari che completano la serie sono. Destra/sinistra, maschio/femmina, in quiete/in movimento,
retta/curva, luce/tenebra, quadrato/a lati diseguali.63
I Pitagorici hanno messo in rilievo la perfetta concordanza tra i numeri e i rapporti armonici da un lato e
le entità fisiche e morali dall’altro.64
I numeri pitagorici non sono, dunque, enti aritmetici astratti (o ideali), ma sono figure e grandezze
geometriche. 1 è il punto, 2 la linea, 3 il triangolo (figura piana), 4 il tetraedro (solido). I numeri sono causa
ed essenza delle cose, in quanto sono fattori della determinazione; perciò non sono rappresentati
semplicemente da segni ma da figure geometriche (che rappresentano modalità di determinazione di
un’estensione illimitata).65
61
Aristotele adduce come principale ragione che ha indotto i Pitagorici a considerare il numero sostanza o essenza
dell’ente il concepire “i limiti del corpo, come la superficie, la linea, il punto e l’unità, [come] sostanze, anche più che il
corpo o il solido” (Metaph., III, 1002). Ne deriva che questi elementi che limitano il corpo “sembrano poter esistere
senza il corpo”; mentre questo “sembra che non possa essere senza di essi”. Le determinazioni numeriche e spaziali
stanno, perciò, all’origine della formazione dei corpi e ad esse è attribuita una realtà più originaria rispetto a quella dei
corpi stessi nella loro solidità e materialità; e poiché quelle determinazioni sono basate su misure quantitative e
numeriche, il numero finisce per costituire la sostanza prima delle cose. Come dice ancora Aristotele: “Poiché anche nel
resto la natura appariva assimilarsi tutta quanta ai numeri, e i numeri sono primi di tutta la natura, supposero che gli
elementi dei numeri siano elementi di tutte le cose” (Metaph., I, 986 a). Lo stesso Aristotele osserva che l’introduzione
del vuoto nel processo di formazione dell’universo è detto avvenire prima di tutto nei numeri (Phis:, 213 b): “onde il
concorso di péras ed àpeiron a costituire ogni realtà risulta nelle cose una somiglianza o imitazione di quanto avviene
primamente nei numeri” (R. Mondolfo, in Zeller-Mondolfo, op. cit., I/II, p. 671). In tal modo, non appare alcuna
contraddizione tra le formule che emergono dai testi aristotelici: “le cose sono numeri”, “le cose somigliano ai numeri”,
“gli elementi dei numeri sono elementi delle cose”. Non sembra, pertanto, condivisibile l’opinione del Burnet, che vi
sarebbe stato un processo nello sviluppo della dottrina dei numeri, col passaggio da una fase originaria, caratterizzata
dalla formula “le cose sono numeri” a una fase successiva, nella quale sarebbe affermata non più l’identità delle cose
coi numeri, bensì una semplice somiglianza o imitazione (prospettiva che anticiperebbe la dottrina platonica delle ideenumeri).
62
Aristotele, Metaph., I, 5, 986. Come spiega Simplicio (Fisica, 455, 20): “[I Pitagorici] dicevano che l’infinito è il
numero pari, per il fatto che ogni pari (come dicono gli esegeti) si divide in parti uguali, e il divisibile in parti uguali è
infinito nella divisibilità per due; giacché la divisione in parti uguali e mezze procede all’infinito; invece il dispari
sopraggiungente lo limita, giacché ne impedisce la divisione in parti uguali”.
63
Aristotele, Metaph., I, 5, 986.
64
Così, ad esempio, la giustizia è assimilata a un numero quadrato (4 o 9), per essere questo l’“eguale per l’eguale”;
la ragione è identificata con l’1 e l’opinione col 2, perché l’una esclude e l’altra ammette divergenze e divisioni; il
matrimonio al 5, in quanto somma del primo numero pari (femminile) col primo dispari (maschile), oppure al 6, loro
prodotto; il bene al 7, in base all’osservazione di una serie di fatti, in cui l’anno o il mese o il giorno critico è il 7°. Al
numero 3 era attribuito un significato mistico (in quanto identificato con la divinità): esso, infatti, è il primo dei numeri
dispari (perciò rappresenta l’ente perfetto), è il simbolo della maschilinità (in contrapposto al 2, simbolo della
femminilità), inoltre esprime il rapporto degli accordi fondamentali (in quanto sintetizza gli opposti ed è simbolo
dell’armonia). Anche al 4 è attribuito un significato mistico: esso, infatti, è il primo numero quadrato, simbolo della
giustizia, ed è il numero delle stagioni e della vita, delle forme geometriche (punto, linea, superficie, solido), degli
elementi della sfera cosmica (fuoco, aria, acqua, terra), dei centri del corpo e delle funzioni vitali. Altri numeri dotati di
significato particolare sono il 7 e il 10. Il 10 è il numero veramente perfetto, perché, come dice Filolao (fr. 11), meglio
manifesta la “virtù” del numero: “giacché essa è grande, essa porta a compimento e realizza ogni cosa; principio e guida
della vita, altrettanto divina e celeste che umana […]; senza di essa, tutto è indeterminato, misterioso e oscuro”. Nella
“decade” (sacra tetraktys) è compreso un uguale numero di dispari e pari (l’unità col primo pari e il primo dispari col
primo quadrato); essa è costituita dalla serie dei primi quattro numeri disposti in modo da formare un triangolo.
65
La costruzione dei numeri avviene mediante quello strumento detto gnomone (la squadra): così, partendo
dall’unità, la prima figura che si forma mediante lo gnomone disposto intorno all’1 è il quadrato; la seconda figura è un
altro quadrato delimitato da un lato di tre punti e comprendente 9 punti, e così via. In tal modo, cioè, si vengono a
configurare i numeri “quadrati” (4, 9, 16, ecc.), formati attraverso la disposizione intorno allo gnomone dei numeri
Per i Pitagorici, ogni ente, in quanto costituito da rapporti numerici (mode della determinazione
dell’illimitato e dunque forme di composizione dell’opposizione originaria tra limite e illimitato), risulta
dall’unione armonica di elementi opposti (temperamento o armonia).
Il cosmo nel suo insieme comprende il sistema di tutte le armonie. L’etere è l’elemento che comprende tutto
l’universo.66 Nella cosmologico dei Pitagorici abbiamo, quindi, la seguente disposizione dei pianeti e degli
astri: 1) stelle fisse; 2) fuoco esterno; 3) Giove; 4) Marte; 5) Terra; 6) Venere; 7) Mercurio; 8) Sole; 9) Luna; 10)
Antiterra. La Luna e il Sole ricevono luce dal Fuoco centrale. L’Antiterra è stata posta per raggiungere il
numero perfetto di 10.67
Anche l’anima risulta da una composizione armonica di parti.68 L’idea che l’anima è “temperamento” di
elementi opposti si riflette specialmente nelle teorie mediche di orientamento pitagorico. La musica, in
questo senso, concorrendo a ristabilire l’armonia, costituisce la medicina dell’anima.
dispari (3, 5, 7, ecc.). Invece, volendo inquadrare con lo gnomone numeri pari, ricaviamo numeri “rettangolari”,
rappresentati da figure rettangolari. La serie di questi numeri appariva, poi, sempre divisibile in due numeri triangolari
uguali, per mezzo di una diagonale; invece ciò non era possibile per i numeri quadrati. Abbiamo qui un’anticipazione
dell’antitesi platonica di Uno e Diade.
66
L’universo è costituito dai quattro elementi fisici e dall’etere. Filolao dice (fr. 12): “E cinque sono i corpi della
sfera: i [quattro] che sono nella sfera, fuoco, acqua e terra e aria, e quindi l’involucro della sfera”. L’involucro di etere
luminoso circonda, dunque, l’universo. L’etere è considerato da Orfici e Pitagorici come origine delle anime e meta del
loro ritorno dopo la purificazione e liberazione dal ciclo delle nascite. Proclo darà all’etere il nome di empireo
(infuocato) e questa immagine si trasmetterà all’astronomia e alla teologia medievale. Nel Timeo di Platone i cinque
elementi sono identificati coi cinque poliedri regolari (terra = cubo, acqua = icosaedro, aria = ottaedro, fuoco =
tetraedro, etere = dodecaedro). Come avverte il Mondolfo, gli studi sulla storia del pitagorismo hanno dimostrato che i
Pitagorici conoscevano solo il cubo, la piramide e il dodecaedro e la costruzione matematica dei cinque poliedri è
posteriore a Filolao ed è dovuto a Teeteto (La filosofia antica, p. 62).
Nella cosmologia dei tempi di Filolao troviamo i seguenti elementi concettuali: 1) la terra non è il centro immobile
dell’universo, ma un pianeta rotante (il che apre la via all’eliocentrismo di Eraclide Pontico e di Aristarco di Samo 8280
a. C.), il pitagorico precursore di Copernico; 2) al centro dell’universo è posto un Fuoco, come “potenza demiurgica,
che dal centro vivifica tutta la Terra e riscalda la sua frigidità” (Simplicio, De coelo, II, 13); 3) l’universo è infinito:
infatti i Pitagorici rilevavano che “il non essere la Terra al centro, ma distarne di tutto un emisfero, non può impedire
che i fenomeni si presentino come si presenterebbero a noi […] anche se la Terra fosse al centro del cosmo” (Aristotele,
De coelo, 293): il che vuol dire che il diametro dell’orbita percorsa dalla terra rappresenta una grandezza insignificante
rispetto alla distanza dalla periferia dell’universo.
67
Sull’armonia prodotta dalle sfere celesti, Aristotele osserva: “Risulta evidente da tutto questo che anche l’affermare
che il moto dei corpi celesti produce un’armonia, in quanto i loro suoni generano un accordo, è sì affermazione mirabile
e ingegnosa” (De coelo, II, 9, 290 b).
68
“L’idea che l’anima e la mente siano temperamento o armonia di elementi opposti si vede riflessa non solo nelle
teorie connesse al piagorismo (da Alcmane a Filolao e a Filistione di Locri), ma anche nella doxa di Parmenide, e in
tstimonianze su Zenone e in frammenti di Empedocle; e fino a Platone, che nel Timeo, 35 sgg., compone, come
temperamento e armonia di contrari, l’anima del mondo, da cui costituisce poi le anime umane. Così queste sono
immortali, ma, nella mutevolezza data loro dalla composizione, sono legate al temperamento del corpo; dal quale
appunto Platone, nello stesso Timeo (86 sgg.), fa derivare le malattie dell’anima, pazzia e ignoranza. Perciò egli vuole
che si mantenga fra anima e corpo una simmetria, purificandoli entrambi armonicamente, con l’associazione di
matematica, musica e filosofia alla ginnastica e medicina” (R. Mondolfo, Il pensiero antico, pp. 67-68).
Dalla concezione dell’immortalità dell’anima derivano alcune conseguenze rilevanti per la “vita filosofica”: in primo
luogo, un comportamento di rispetto e di pietà per gli animali, nei quali si ritiene che le anime si trovino incarnate (così
in un frammento di Senofane (fr. 7) troviamo riferito il racconto di Pitagora che prova pietà per un cane bastonato e
dichiara di riconoscere dal pianto dell’animale la presenza in esso dell’anima di un suo amico); quindi la credenza nelle
capacità profetiche, poiché durante il sonno l’anima si distacca in certo modo dal corpo e riacquista parte del suo potere
divinatorio che la comunione col corpo oscura.
Come osserva Aristotele (De anima, I, 2, 405), il ciclo di trasmigrazioni dell’anima ha un’analogia col movimento
ciclico degli astri, sulla base di un’affinità di natura divina tra l’anima e i corpi celesti. Riferendosi ad Alcmeone, egli
dice, infatti: “Il crotoniate chiama l’anima immortale, poiché assomiglia alle cose immortali; questa somiglianza sta nel
muoversi sempre, ché anche tutte le cose divine si muovono costantemente, sempre. Luna, sole, gli astri e il cielo
intero”.
Infine è da rilevare che, per i Pitagorici, la conoscenza è fattore di pacifica vita sociale. Perciò Archita dice che
dobbiamo acquistare conoscenza, in quanto questa promuove la concordia e l’armonia morale e sociale. Ragione e
conoscenza, infatti, rappresentano un freno per chi intende commettere ingiustizia. La rappresentazione dell’ordine
dell’universo contribuisce alla fondazione dell’ordine politico.
La scuola eleatica. Parmenide e la nascita della metafisica
Parmenide ha parlato per primo dell’essere come fondamento e principio di ogni realtà. Ma l’essere è in stretto
rapporto con gli enti molteplici e costituisce la loro stessa sostanza e legge. Esso è oggetto di comprensione puramente
intellettuale, dunque è interamente intelligibile e perciò costituisce l’oggetto di una conoscenza assoluta, basata sul solo
pensiero, mentre l’universo degli enti, basata anche sull’esperienza, è oggetto di una scienza mutevole e relativa. Così si
ha la distinzione tra la metafisica e quelle che oggi si chiamano le scienze empiriche.
Parmenide è il più famoso e il più discusso tra i filosofi antichi. E’ anche il più grande e il più difficile. “La
filosofia degli Eleati – si è osservato recentemente – forma ancora un capitolo oscuro nella storia della
filosofia”.69
Il poema di Parmenide Sulla natura (del quale ci rimangono circa 160 versi) si apre con la stupenda
immagine del poeta/filosofo che è sollevato in aria su un misterioso carro trascinato da cavalle e guidato da
fanciulle divine figlie del Sole oltre la porta che separa il Giorno e la Notte fino al cospetto della dea della
Verità, che solennemente gli rivela la più segreta dottrina intorno all’essere uno e immutabile e alla
molteplicità degli enti finiti.70 Così il filosofo apprende la verità intorno al principio unico e alla stessa
costituzione unitaria dell’universo, dunque la scienza dell’immutabile, del permanente e dell’eterno, e,
d’altra parte, quella che riguarda la vicenda mutevole, temporale, molteplice, degli enti determinati.
Parmenide è considerato come il fondatore della metafisica. Egli infatti ha distinto la sfera dell’essere
dalla sfera dell’universo degli enti. Ma queste due sfere costituiscono, tuttavia, un’unità. E tale unità
rappresenta, principalmente, il tema della metafisica.
La metafisica, infatti, nasce dal detto di Parmenide, secondo cui non è possibile “separare l’essere
dall’essere”. Che cosa vuol dire il filosofo? In primo luogo, vuol dire che non è possibile dividere l’essere, in
modo che questo, da uno, diventi molteplice. L’essere (che rappresenta il reale nella sua totalità) non può
essere che “uno”: la realtà costituisce un insieme unitario, in qualsiasi modalità essa si articoli e si esprima.
Dunque l’unità del reale non esclude gli infiniti modi del suo determinarsi. Perciò lo stesso Parmenide pone,
accanto all’essere, l’universo degli enti, cioè il dominio della “molteplicità”; e ammette che per tale sfera non
può mai esservi una scienza univoca, poiché, appunto, in essa le modalità mutano, si moltiplicano e si
trasformano continuamente l’una nell’altra.
Ma che rapporto c’è tra l’essere e gli enti? Ovviamente questi non possono costituire una sfera dell’essere
separata dall’essere vero e proprio, poiché in tal modo questo medesimo risulterebbe molteplice. Dunque il
famoso detto di Parmenide vuol dire anche che non sarà mai possibile “separare l’ente (gli enti) dall’essere”.
La metafisica, in questo modo, riguarderebbe proprio, in modo particolare, le modalità della derivazione
degli enti dall’essere e il medesimo “stare” di essi nel loro fondamento e principio. In questo senso,
Parmenide ha voluto dire che, accanto a un modo di considerare gli enti, che è quello “empirico”, per cui gli
enti sono, per così dire, “separati dall’essere”, descritti e conosciuti nei loro caratteri specifici, vi è un modo
“metafisico”, per cui gli enti sono considerati nella loro unione con l’essere, in quanto espressioni dell’essere
medesimo. Il nocciolo della metafisica consiste appunto in questo nesso, in questa unione fondamentale, che
non sarà mai possibile dividere. La metafisica riguarda l’essere non solo in quanto “uno” e per se stesso,
bensì anche in quanto principio della molteplicità degli enti; essa, perciò, riguarda le modalità di
appartenenza fondamentale degli enti all’essere.
E’ stato rispettato questo principio parmenideo, che rappresenta l’essenza della metafisica? Oppure questa
ha finito per considerare gli enti separati dall’essere? La storia della metafisica non costituisce un processo
lineare di sviluppo e all’interno di essa si sono profilate prospettive diverse; tuttavia, si tratta di vedere in
che modo, eventualmente, il divieto di cui parla il fondatore della metafisica sia stato violato.
Evidentemente, dobbiamo trascurare i filosofi che esplicitamente hanno ammesso l’impossibilità di risalire al
principio o fondamento e hanno considerato la scienza umana come relativa, empirica, inevitabilmente
legata alla vicenda mutevole degli enti (dunque l’impossibilità di “nominare” l’essere). Diciamo subito che la
prima impressione è che in realtà tutta la storia della metafisica non sia altro che lo sviluppo del pensiero
69
L’osservazione è di J. H. M. Loenen ed è riportata da G. de Santillana, Prologo a Parmenide, “De Homine”, n.2223, settembre 1967, p. 3.
70
L’assoluta prevalenza dell’elemento femminile è probabilmente da riportare alla tradizione dei culti mediterranei
della “Grande Madre”, per cui l’intera sfera divina era considerata prerogativa di questa divinità fondamentale. In
Parmenide ciò si esprime in un assolutismo matriarcale: così alla sfera femminile appartengono la dea della Verità, le
sue ministre e seguaci, Dike, Ananke, Moira, Themis, le Elidi, fino alle intelligentissime cavalle.
parmenideo intorno all’essere: tutti i discorsi che si sono via via fatti in realtà non sono stati altro che
interpretazioni della prospettiva iniziale, sviluppi e approfondimenti, se si vuole, ipotesi di svolgimento
sistematico, chiarimenti e commenti, o come altro si voglia dire. E in questa luce e da tale punto di vista
cercheremo di esaminare, a grandi linee, questa storia.
Platone è famoso per avere introdotto la molteplicità nell’ambito dell’essere medesimo. Ma, in realtà, egli
non ha fatto altro che esplicitare, in modo coerente e sistematico, il concetto parmenideo di “essere”. E’ nella
logica di questo concetto che egli scorge il principio della molteplicità, in modo che questa non abbia a
cercare di se stessa un principio in una sfera diversa e separata dall’essere. In questo senso, Platone ha
rispettato il “divieto” parmenideo: anzi ha fatto in modo che mai più si potesse tentare di separare l’ente
molteplice dall’essere. La metafisica, in questo modo, ha la sua prima organica sistemazione: essa riguarda la
connessione degli enti con l’essere, dunque non le modalità empiriche degli enti, bensì le modalità
“ontologiche” , secondo cui gli enti appartengono essenzialmente all’essere. Si tratta di considerare gli enti
per ciò che essi “sono”, dunque nella loro “identità” univoca e permanente. La metafisica di Platone finisce
per riguardare non solo le modalità secondo cui le idee molteplici sono connesse tra di loro sulla base della
loro appartenenza a un medesimo principio o fondamento, bensì anche le modalità secondo gli enti sensibili
partecipano dell’identità dell’essere attraverso la loro partecipazione alla realtà delle idee.
Aristotele ha quindi approfondito la metafisica come dottrina dell’essere in quanto tale, distinto dall’essere
in quanto ente, ma strettamente legato ad esso nella struttura unitaria della realtà. La metafisica, anzi,
riguarda propriamente questa unità fondamentale. Le categorie, ad esempio, che sono le modalità generali
secondo gli enti sono costituiti, appartengono all’essere: così la “qualità” in quanto tale non appartiene a un
qualche ente determinato (al quale appartengono qualità specifiche), e così analogamente il “tempo” in
generale. L’essere, in quanto fondamento della realtà, si articola nelle modalità che costituiscono il reale nelle
sue determinazioni: ad esso appartiene tutto ciò che ha un carattere fondante. In questo modo è mantenuta
la distinzione parmenidea tra la sfera dell’essere e quella degli enti. Dio rientra nella metafisica in quanto
rappresenta la totalità delle potenzialità ontiche nella sua piena attualità. Così l’essere diventa causa del
sistema degli enti attraverso la mediazione della “natura”. Tra l’essere, Dio e la natura si stabilisce un nesso
che costituisce, si può dire, la struttura del fondamento.
Questo schema unitario si ritrova ancora più accentuato in Plotino, dove l’essere/Uno in sé assorbe anche
la sfera degli enti e della natura. La ricerca dell’unità del reale diventa il vero compito della metafisica, intesa
come esperienza e vita filosofica, ascesi dell’io e contemplazione estatica dell’Uno medesimo, anticipata dalle
forme dell’esperienza nel mondo, a partire dalla pratica delle virtù fino alla visione delle idee nelle forme
sensibili e alla scienza intesa come discorso e connessione logica delle idee stesse.
La metafisica, riguardando l’articolazione del reale nelle sue varie forme, è anche la scienza della connessione tra
queste forme. Così si spiega il tentativo di Hegel di restaurare questa scienza filosofica nel suo carattere sistematico. Ciò
che, tuttavia, rappresenta una specie di limite di questa poderosa costruzione è la base idealistica (sostanzialmente
soggettivistica) ereditata dalla filosofia moderna. Nell’“età della rappresentazione del mondo”, infatti, l’essere si dissolve
nell’ “essere pensato”, con una infrazione, si può dire, del divieto parmenideo di separare il pensiero dall’essere, in modo
che esso potesse anche diventare possibilità di pensare il “nulla”. Il dramma della coscienza moderna consiste, appunto,
nel suo configurarsi come il soggetto che ha anche un potere nullificante, in rapporto a cui l’essere si manifesta e si
ritrae. L’essere è consegnato, così, alle mani di un ente (l’uomo) che decide intorno a ciò che è o non è realtà. Hegel
eredita questa prospettiva pervasa di nichilismo. Perciò il “ritorno a Parmenide” di cui oggi si parla, anche come
condizione di una restaurazione metafisica, rappresenta un’istanza legittimata dalle conseguenze fallimentari della
svolta moderna, che sostanzialmente ha operato prima la doppia separazione dall’essere dell’ente e del pensiero e, dopo,
ha cercato, ma senza successo, di ricostituire l’unità irrimediabilmente scissa.
La concezione metafisica della realtà come totalità ha sostanzialmente sviluppato la tesi parmenidea e la
filosofia antica si è mantenuta aderente ad essa, con particolare riguardo al divieto perentorio di separare
l’ente dall’essere e di concepire come distinti princìpi l’essere e il pensiero. Questa fondamentale linea di
matrice eleatica è anche quella nella quale prosegue la filosofia cristiana e medievale, per la quale, anzi, il
principio o il fondamento di ogni realtà, l’essere parmenideo, è concepito come il creatore dell’ente, Dio, che
vuole l’esistenza dell’universo degli enti. Dio è il custode dell’ente ed è garanzia di senso, di ragion d’essere.
L’ente, in quanto creato da Dio, è investito di un significato, ha una funzione, una finalità, una costituzione
connessa a un ordine. La metafisica si lega strettamente alla teologia, che è la scienza, basata essenzialmente
sulla rivelazione, della creazione e del rapporto tra l’ente e Dio. E’ la teologia che può rispondere alle
domande sul senso della realtà, sul destino dell’uomo e delle cose. L’ente viene, così, ancora doppiamente
legato all’essere: senza un riferimento a Dio, non è possibile dire nulla intorno al mistero della creazione e al
senso del mondo; non solo non è possibile separare l’ente dall’essere, ma non è neppure possibile attribuire
un senso all’ente fuori del rapporto con l’essere. L’ente trova nell’essere che lo fonda non solo il suo
principio ma anche il suo destino. E il pensiero ha lo stesso fondamento: esso ha senso in quanto coglie le
ragioni della creazione e, in qualche modo, comprende il senso dell’ente, in quanto questo è depositato nel
“logos”, che è Dio stesso in quanto principio del pensiero. In quanto l’ente ha senso e si sviluppa secondo un
ordine, esso è incardinato in un pensiero; e il discorso che noi facciamo è in qualche modo una “imitazione”
di tale pensiero (che appartiene all’ente, come sua “ragione”). Il pensiero, anzi, è condizione della creazione
del mondo; e questo non è altro che come un immenso libro scritto coi caratteri del pensiero divino. Le vie e
gli strumenti della filosofia cristiana sono, infatti, la ragione e la fede: l’interpretazione dei caratteri in cui è
scritto il libro dell’universo non è possibile soltanto sulla base dell’esperienza sensibile e intellettuale, ma
implica una spiegazione data direttamente da Dio e consegnata a una “scrittura”. Ma tutto ciò è possibile
sulla base e nell’ambito del pensiero. Non solo il pensiero non è separato dall’essere, ma esso è l’essere nella
forma in cui si rivela e nel modo in cui costituisce la scrittura fondamentale.
Il pensiero moderno, invece, opera la frattura che consiste essenzialmente nell’infrazione del divieto
parmenideo. Esso distingue nettamente ciò che è dell’essere e ciò che è dell’ente e, inoltre, ciò che è pensiero
e ciò che è realtà. L’essere è il fondamento trascendente, per il quale nessuna analogia con l’ente è possibile
stabilire; ed è al di là del pensiero. Ecco, dunque, la separazione dell’essere dall’ente. Dell’essere non è
possibile nessuna scienza; né il rapporto tra l’essere e l’ente è pensabile, poiché esso è di intera pertinenza
dell’essere. In questo modo vengono meno le ragioni della metafisica, poiché questa si basa sulla
comprensione di quel rapporto, cioè del modo in cui l’essere tiene in sé l’ente e in cui l’ente appartiene
all’essere (o secondo cui l’essere e l’ente si appartengono reciprocamente).
Così anche il pensiero viene separato dall’essere. Esso viene inteso come lo strumento per pensare (o
comprendere) l’ente; e questo viene considerato come un “intelligibile”, come un termine del pensiero, come
il cartesiano “cogitatum” (“pensato”), correlativo all’atto del “cogito” (“io penso”). La filosofia moderna è
principalmente una filosofia del soggetto. La soggettività costituisce il campo d’indagine dell’intera
riflessione. I razionalisti intendono il soggetto come razionalità, capace di operare l’analisi della costituzione
del reale, per comprenderne la costituzione matematica. L’universo fisico può essere scomposto e
ricomposto attraverso i procedimenti dell’analisi matematica. Gli empiristi mettono in rilievo i limiti
dell’esperienza e, sempre di più, sottolineano il carattere soggettivo di ogni rappresentazione del reale. Noi,
più che con le cose, abbiamo a che fare con le nostre rappresentazioni. Kant ha specialmente rilevato il
carattere trascendentale (relativo alla costituzione universale del soggetto) della scienza del mondo
fenomenico.
Gli idealisti hanno tentato di ricostituire l’unità dell’essere e del pensiero, ma in realtà hanno risolto le
strutture ontologiche nelle categorie logiche, proclamando, inevitabilmente, l’assunzione della logica (in
quanto scienza della razionalità del reale) a metafisica. Analogamente, il tentativo di ristabilire la
connessione dell’ente con l’essere si è risolto quasi generalmente nell’affermazione di un Assoluto nel quale
l’ente finito perde la sua stessa ragion d’essere.
La rivendicazione quasi violenta dell’autonomia del finito operata dalle filosofie post-hegeliane ha
praticamente portato a quella crisi generale della metafisica, che ha in Nietzsche il suo interprete più
conseguente. Nietzsche ha riassunto questa condizione del pensiero (e dell’intera temperie culturale) con la
famosa constatazione che “Dio è morto”, cioè che si sono dissolte tutte le concezioni metafisiche relative al
fondamento, ai princìpi e ai valori ontologici, a ogni ipotesi di rapporto tra l’essere e l’ente e a ogni idea di
“ragion d’essere” o di senso del mondo e dell’esistenza. In questo modo siamo giunti all’epoca che ormai
concordemente è chiamata come “età del nichilismo”.
Il “ritorno a Parmenide”, invocato recentemente da Emanuele Severino, appare come il rimedio per la crisi profonda
che il mondo occidentale sta attraversando. Ma in che modo potrebbe oggi configurarsi la ricostituzione dell’unità di
essere ed ente e di essere e pensiero? Quali potrebbero essere le linee di una filosofia neoeleatica? La via indicata e in
gran parte percorsa da Heidegger ci sembra ancora quella più verosimile. In particolare, la riproposizione dell’analitica
esistenziale come indagine intorno al senso dell’essere avrebbe il vantaggio di muoversi in un ambito, si può dire, di
ricongiunzione dell’essere e dell’ente (anche se questo è emblematicamente assunto nell’esistenza dell’uomo). L’analisi
della condizione umana dovrebbe costituire il presupposto per un discorso, che sia insieme “ontico” e “ontologico”, cioè
che riguardi il senso degli enti e il senso dell’essere in generale. Il discorso sulle cose, su tutto ciò che appartiene al
dominio della natura e a quello della tecnica, va approfondito, secondo punti di vista che significhino il più possibile un
superamento della prospettiva antropocentrica. Si può, ad esempio, sviluppare un discorso sulla natura, in modo che
questa emerga come una sfera dotata di prerogative e caratteri propri, anche indipendentemente da tutto ciò che può
apparire legato alla condizione dell’uomo? Si può, cioè, parlare ancora di un “essere” della natura? In primo luogo, ci
sembra che il divieto parmenideo riguardi, appunto, la separazione dell’essere dall’ente e che, pertanto, lo sviluppo della
metafisica vada perseguito nella forma dell’indagine intorno all’essere dell’ente. La costituzione di un complesso di
“ontologie regionali” (secondo il progetto fenomenologico delineato già da Husserl) potrebbe essere presa in
considerazione come possibile compito della filosofia (come rinnovata metafisica) nel contesto attuale. Se si dà un essere
dell’ente, allora risulterà anche improbabile un destino dell’ente nel senso (tanto enfatizzato da Severino) del continuo
venire di esso dal nulla e dissolversi in questo medesimo. L’ente che viene dall’essere a ad esso ritorna ha la consistenza
dell’essere stesso.
Che vuol dire, dunque, il tanto parlare che nel nostro secolo si è venuto facendo intorno all’“oblìo
dell’essere”, alla messa da parte del problema dell’essere e alla assunzione dell’ente come oggetto della
metafisica? In definitiva, Heidegger (e più recentemente Emanuele Severino) ha inteso rilevare che la realtà,
sulla base dell’eliminazione del problema dell’essere, si è configurata sotto l’aspetto della “semplice
presenza”: reale è ciò che di volta in volta si presenta, cioè che diventa oggetto di rappresentazione,
configurandosi come “idea” o come “cosa” (che io immediatamente percepisco) o come figura ricordata o
pensata, e così via. Il reale, cioè, non ha, da questo punto di vista, un “essere” stabile, definitivo, permanente.
Del reale non si cerca l’essere, ciò che, cioè, lo costituisce in una identità permanente, bensì si cercano le varie
forme del suo apparire. Per Parmenide, l’essere “è”, mentre gli enti “appaiono”. Al di là dell’apparire,
occorre tendere a trovare l’essere. Ad esempio, qual è l’essere dell’uomo? Noi dell’uomo conosciamo le
molteplici forme o modalità nelle quali esso si è storicamente attuato; e diciamo pure, ad esempio, che
l’uomo tende a realizzare se stesso e che tutte le particolari modalità di attuazioni sono modalità limitate e
imperfette rispetto all’uomo ideale, oppure all’essere proprio dell’uomo. Le cose sono copie imperfette di un
modello. Il pensiero greco è attraversato da questa tensione. La filosofia ha il compito proprio di giungere a
concepire, di ogni cosa, l’essenza immutabile (ad esempio l’essere dell’uomo). L’oblìo dell’essere conduce a
considerare dell’ente non ciò che esso propriamente è, ma i modi del suo essere presente, cioè del suo
apparire. In questo modo emergono le “qualità” dell’ente: così dell’uomo si considera la razionalità, l’abilità
tecnica, la virtù politica, e così via; di volta in volta, l’uomo emerge come portatore di qualità variabili.
Questo vuol dire probabilmente Severino, il quale osserva che l’ente è considerato come qualcosa che viene
dal nulla e al nulla ritorna, senza che abbia una consistenza nella quale permanere.
L’essere è un “indefinibile”: ad esempio, lo spazio è al di là delle maniere determinate in cui esso è stato o
può essere concepito (lo spazio euclideo, quello aristotelico, quello newtoniano, quello kantiano, e così via);
in quanto “in sé”, non è definibile. Esso è il termine di riferimento “ideale” di ogni determinazione: è ciò per
cui quello euclideo e quello aristotelico (e anche quello kantiano) possono essere considerati come modalità
dello spazio. Perciò Platone vide l’essere nell’idea (o archetipo ideale). L’idea non ha una derivazione
empirica, poiché è il presupposto di ogni determinazione reale. Essa non ha neppure una origine e un
termine; né può trapassare in altro: perciò è sempre identica a se stessa. Così noi diciamo che l’essere della
giustizia è l’idea di giustizia, la quale non è derivata da una qualche realtà particolare (ad esempio il modo in
cui avviene lo scambio in una determinata società), ma è presupposto e condizione di ogni particolare
determinazione che rientri nel termine “giustizia” (ad esempio, un determinato comportamento definito
come tale).
Parmenide vide bene gli attributi dell’essere: ingenerato, immobile, immutabile, continuo, e così via.
Questi attributi si possono attribuire all’essere di ogni ente.
L’oblìo dell’essere si ha allorché non si considera l’essere dell’ente e, piuttosto, si assume l’ente nella sua
determinazione particolare, per ciò che esso si presenta (o si è presentato in una generalità di casi). Così si
finisce per considerare come “giustizia” la pratica dell’equilibrio del dare e dell’avere in una società, senza
tenere conto che questa è una modalità particolare, e che la giustizia in sé è il termine di riferimento ideale di
ogni modalità particolare della sua attuazione. La geometria euclidea considera lo spazio euclideo come lo
spazio assoluto; ma la scoperta delle geometrie non euclidee ha dimostrato che non è così. Se si vuole
considerare qualcosa dal punto di vista filosofico (metafisico), bisogna tenere conto dell’essere, non cercando
di definire l’essere stesso, ma orientando la ricerca sull’essere dell’ente in rapporto al senso dell’essere in
generale. Il concetto filosofico deve essere comprensivo rispetto a ogni concetto determinato di cui si
disponga. Se si rinuncia alla metafisica, si considera l’ente nelle sue determinazioni empiriche; e, mentre il
reale è inteso come l’ente determinato, si profila il concetto dell’essere come semplice presenza. L’essere non
può darsi, infatti, che nella “presenza” dell’ente.
Sviluppi dell’eleatismo
I paradossi contro la molteplicità e il movimento di Zenone di Elea
Zenone di Elea è famoso per i suoi argomenti contro la molteplicità e contro il movimento. L’essere è uno e immobile;
molteplicità e movimento appartengono alla sfera dell’esperienza umana e, dunque, al nostro modo di vedere e
comprendere le cose. In realtà, il filosofo intende dire che è impossibile considerare la realtà per sé, indipendentemente
dalle forme dell’esperienza, e che, se essa viene considerata dal punto di vista del puro pensiero, si presenta una e
immutabile. Solo l’immutabile, infatti, è oggetto del puro pensiero, mentre l’esperienza e l’opinione considerano le cose
sotto l’aspetto della mutevolezza e della molteplicità.
Questi sono gli argomenti contro la molteplicità:
1) Scomposizione all’infinito di ogni unità:
a) se i molti sono, hanno grandezza; infatti, se l’ente non ha grandezza, non è;
b) se i molti sono, non hanno grandezza; infatti il molteplice è costituito da più unità; ma ogni singola
unità, se ha grandezza, si scompone in altre singole unità e così via: quindi ogni singolo uno, e di
conseguenza i molti, non possono avere grandezza.
2) Infinito accrescimento e infinita diminuzione:
a) se i molti sono, sono grandi fino all’infinito; infatti la grandezza comporta un infinito accrescimento;
b) se i molti sono, sono piccoli fino a non avere nessuna grandezza; infatti ogni singolo uno di cui si
compone la molteplicità è identico a se stesso; ma se è identico a se stesso, non sarà altro da sé, cioè non
avrà parti e non sarà divisibile; ma indivisibile è ciò che è tanto piccolo da non ammettere più parti
all’interno di sé.
Ed ecco gli argomenti contro il movimento:
1) Dicotomia. Se si divide un segmento indicante una distanza, non si può stabilire il punto da cui comincia il
moto di chi percorre la distanza segnata dal segmento, poiché ogni parte può essere divisa in due in un processo
che va all’infinito. Se si divide in senso contrario, si dimostra la generica impossibilità logica del movimento (in
quanto il mobile non riuscirà mai a raggiungere il punto di arrivo).
2) Achille e la tartaruga. Se Achille parte da A e la tartaruga da T, e la velocità di Achille è 10 volte quella della
tartaruga, quando Achille ha raggiunto il punto T, la tartaruga sarà in T’, avrà percorso cioè una distanza
AT/10 da T; arrivato Achille al punto T’, la tartaruga sarà in T”, ad una distanza TT’/10 da T’, e così
all’infinito.
3) L’argomento della freccia. La freccia mentre si muove occupa sempre uno spazio uguale a se stessa, quindi è
in quiete; ad ogni istante, infatti, occupa uno spazio uguale a se stessa.
4) L’argomento dello stadio. Se si immagina che le masse della fila A siano ferme, quelle della fila B si muovono
verso destra e quelle della fila C verso sinistra, dopo che B e C avranno percorso ciascuna un tratto di due unità,
avranno guadagnato metà lunghezza rispetto ad A, ma una lunghezza intera l’una rispetto all’altra. Chi è
rimasto fermo ha visto muoversi di due unità le due masse, ma le masse in movimento, rispetto a se stesse, si
sono mosse di quattro unità. Si intende dimostrare, così, che il tempo impiegato da una massa in movimento per
incrociarne l’altra che si muove in senso contrario è uguale a quello impiegato dalla stessa massa a superare la
metà di massa uguale che sta ferma; dunque nello stesso tempo una massa percorre un certo spazio e la sua metà:
il che è assurdo.
Approfondimenti metafisici. Melisso
Secondo Aristotele (fr. 577), Melisso avrebbe comandato la flotta di Samo nella vittoria sugli Ateniesi del 422 a. C.;
Diogene Laerzio attesta che egli fu discepolo di Parmenide; i frammenti sono conservati da Simplicio.
In particolare, la dottrina di Melisso si incentra sull’accentuazione dei caratteri dell’essere, identificati nelle
determinazioni dell’eternità, dell’infinità, dell’unità e dell’immutabilità. Gli studiosi moderni hanno
sottolineato la novità della concezione di Melisso rispetto a Parmenide. Il Calogero (Studi eleatici, pp. 60
sgg.), ad esempio, ha messo in rilievo il significato nuovo dell’eternità in Melisso. “La netta differenza
rispetto a Parmenide – egli scrive – è nel fatto che mentre questi, partendo dal suo “è”, esclude del tutto
tanto l’era quanto il sarà, e vede quindi l’assolutezza temporale dell’ente come un puro presente, immune da
ogni differenziazione temporale di passato e futuro, Melisso concepisce invece la sua eternità nel senso
dell’estensione temporale, che non può avere limite né verso il passato né verso il futuro. In Parmenide
l’eternità è superiorità al tempo, presente senza passato e senza futuro; in Melisso l’eternità è totale
estensione del tempo, somma del passato, del presente e del futuro”. Melisso faceva il seguente
ragionamento: “Ciò che è generato ha una parte iniziale e una parte terminale: l’essere è ingenerato, quindi
non ha parte iniziale e terminale, cioè è infinito” (Fisica, A 3, 186 a 13). Dunque eternità di durata e infinità
spaziale si implicano reciprocamente. L’essere, in quanto “eterno” non ha limiti temporali; e in quanto
“tutto” e “intero” non ha limiti spaziali. L’infinità spaziale è collegata anche al fondamentale carattere
dell’unità dell’essere. Nel fr. 8, infatti, troviamo la seguente argomentazione: “Se dunque deve esistere, deve
anche essere uno; e se dev’essere uno bisogna che non abbia un corpo (delimitato). Poiché se avesse uno
spessore (limitato), avrebbe anche parti, e non sarebbe più uno”. L’essere non può concepirsi, perciò, come
un corpo, poiché ogni massa corporea ha una limitazione ed è composta da parti. Allo stesso modo, l’essere
non può essere concepito sulla base dei concetti di denso e di raro, di pieno e di vuoto, poiché questi servono
a caratterizzare i corpi. L’essere è immobile ed esclude il vuoto. Infatti esso non si muove in nessuno spazio
esterno e non ammette, all’interno di sé, nessuna differenza.
Nel fr. 8 Melisso nega la molteplicità dell’essere degli enti. Non possiamo chiamare “essere” ciò che nelle
cose appare ora in un modo e ora in un altro, né possiamo dire che sia oggetto di vera conoscenza. Infatti che
identità si può attribuire a ciò che muta da un momento all’altro? E che conoscenza può essere quella che
riguarda tali condizioni di mutevolezza?
La concezione del divenire universale. Eraclito71
Eraclito ha introdotto con forza nella tradizione del pensiero occidentale la dottrina dell’universale trasformazione
continua di tutte le cose, per cui viene a dissolversi la stessa identità stabile e permanente di qualsiasi ente. Unica
sostanza permanente è il fuoco, concepito come una specie di energia attiva, che continuamente trapassa nelle diverse
forme della materia e contiene in sé i principi e le leggi della sua trasformazione, per cui configura anche come
“ragione” (logos), di cui è espressione l’anima, per cui noi conosciamo l’essenziale realtà come vicenda di lotta e
contrasto universale. Coloro che intendono ciò ragionano e pensano correttamente, mentre gli altri si abbandonano alle
opinioni ingannevoli derivate dall’esperienza sensibile che ci pone di fronte a semplici apparenze.
La concezione eraclitea si basa sul fondamentale superamento della contraddizione che caratterizza il
divenire. Ciò che sembra una condizione di inintelligibilità diventa ciò che veramente è conoscibile. Infatti,
se si ammette solo il divenire, quale è attestato dai sensi, la conoscenza diventa impossibile, non potendosi
stabilire neppure un rapporto tra il soggetto e l’oggetto, entrambi coinvolti nel continuo mutamento (sicché
nel momento in cui si percepisce qualcosa, questo è già mutato; e lo stesso soggetto non può propriamente
dire di avere determinate impressioni, poiché queste costituiscono un flusso continuamente mutevole e non
si può dire di sperimentarne alcune o altre in relazione di qualcosa).
Attraverso tre momenti, dunque, si viene articolando la visione dialettica per la quale il divenire viene
affermato come la condizione della realtà e della sua stessa conoscibilità: l’esperienza del flusso universale;
l’esigenza di superare la visione immediata (ingenua) del divenire; il riconoscimento razionale della
contraddizione come principio del divenire e della costituzione di ogni ente sulla base della sintesi armonica
degli opposti.
Perciò Eraclito insiste sulla funzione della ragione (intelletto), che è capace di comprendere lo stesso
“Logos” come legge del divenire. L’intelletto consente di cogliere l’universale, al di là dell’apparenza
sensibile.72
La realtà essenziale, che consiste nel “Logos” (in quanto principio universale) ed è compresa attraverso di
esso (in quanto principio della conoscenza universale), è scoperta da ognuno dentro di sé, in seguito a una
accanita ricerca, che fa somigliare i filosofi ai cercatori d’oro (fr. 22).73
La ragione coglie quella sostanza che, insieme, permane e si trasforma: tale sostanza è il “fuoco
eternamente vivo, che a misura s’accende e a misura si spegne” (fr. 30). Il fuoco contiene in sé la legge del
suo mutare continuo, per dare luogo ai vari processi fisici e alle varie cose. E la generazione di ogni cosa
71
Eraclito visse all’incirca tra il 540 e il 480 a. C. Apparteneva a una famiglia che vantava ascendenze illustri: alcuni
suoi antenati avevano regnato a Efeso; e da quella tradizione egli ereditò le funzioni di sacerdote. Si tramanda che fosse
stato in rapporto col re persiano Dario e che perciò Mileto si astenne dal partecipare alla rivolta delle città greche
dell’Asia Minore nel 499 contro i Persiani. Dedicò alla dea Artemide il suo poema Sulla natura, scritto in dialetto
ionico. Fu detto “l’oscuro” per il tono oracolare dei suoi detti e lo stile ispirato e solenne.
72
“Chi parla con intelligenza deve appoggiarsi su ciò che è comune a tutti” (fr. 114); e perciò “conviene che si segua
l’universale (Ragione), cioè (la ragione) comune: sicché l’universale è il comune” (fr. 2). Ma a questo principio di
comprensione universale gli uomini comunemente non riescono a elevarsi, rimanendo prigionieri dell’apparenza, “come
se avessero una intelligenza del tutto individuale” (fr. 2) e non riuscendo a superare questo stato che somiglia più al
sonno che alla veglia neppure allorché ascoltano il discorso del filosofo che espone la verità (fr. 1).
73
Infatti, “i limiti dell’anima forse non potrai mai trovarli, qualsiasi via tu percorra: così ha profonda la sua ragione”
(fr. 45). E la ricerca è sostenuta dalla fede: “Se tu non speri, non troverai l’insperato, che è introvabile e inaccessibile”
(fr. 18), sicché “per mancanza di fede sfugge la conoscenza” (fr. 86). Eraclito è il più convinto assertore di questa via
interiore della conoscenza: “Io ho cercato me stesso”, egli dichiara (fr. 101), e afferma che la ragione dimora nella
profondità dell’anima, dove essa “cresce su se stessa” (fr. 15).
avviene attraverso la conciliazione di elementi opposti, nei quali lo stesso fuoco originario si scinde.74 Infatti
l’uno si scinde nel suo opposto (la dualità) e si hanno le fondamentali coppie di opposti: il caldo e il freddo, il
secco e l’umido, la luce e l’oscurità, il vivo e il morto, il giovane e il vecchio, il desto e il dormiente, e così via.
Questi opposti, in realtà, si fondano l’uno sull’altro: “perché queste cose mutandosi sono quelle, e quelle a
loro volta mutandosi sono queste” (fr. 88).
Questo processo dialettico caratterizza anche il destino dell’anima, la cui natura sostanziale è identificata
con l’elemento igneo. L’anima (che ha natura divina) muore entrando nel corpo (che è costituito
dall’elemento umido dell’acqua) e risorge alla morte di esso. Perciò Eraclito può dire che noi siamo nello
stesso tempo mortali e immortali.
Le ipotesi pluralistiche nella fisica: Empedocle75
Empedocle di Agrigento fu filosofo e taumaturgo. Egli ipotizzò la realtà costituita dalla varia mescolanza e
sintesi di quattro sostanze fondamentali (terra, acqua, aria, fuoco) e la vicenda della formazione cosmica
come articolata in due fasi, una come processo che dalla fusione in unico “sfero” delle quattro sostanze, per
l’azione contrastante delle forze dell’amore (amicizia) e dell’odio (contesa), conduce, passando attraverso le
diverse fasi fenomeniche, alla separazione di quelle, e l’altra come processo opposto di ritorno all’unità
originaria. Duplice dunque è tale vicenda universale, l’una dominata dal processo di separazione, l’altra dal
processo di riunificazione. In tale concezione era chiaramente ipotizzata la presenza delle forze opposte, di
attrazione e di repulsione, come tali che presiedono a tutti i processi fisici.
Empedocle è una singolare figura di mago/scienziato: egli stesso si vantava di avere poteri straordinari,
come quello di fermare i venti, allontanare le malattie o anche di riportare in vita i morti. E ciò in base alla
sua teoria che poneva le forze primordiali dell’amore e dell’odio come i grandi fattori dei processi di
trasformazione delle cose, considerati nella loro duplice direzione, determinata dal prevalere dell’uno o
dell’altro principio attivo.
L’indagine naturalistica si trovava di fronte all’esigenza di conciliare il principio dell’unità permanente
della realtà totale con l’esperienza della molteplicità mutevole delle cose. Gli Eleati mettevano in rilievo il
carattere tipico dell’essere immutabile, mostrando come tale essere non può costituire un principio di
spiegazione dell’universo mutevole degli enti molteplici. Perciò, una volta stabilita la differenza tra
l’essere/uno e il mondo/molteplice e tra la scienza del primo e quella del secondo (la prima come
conoscenza teorica indubitabile, la seconda come opinione relativa). I “fisici” cercano ora di percorrere
un’altra via, che accoglie il concetto di molteplicità nell’ambito della stesso principio primordiale, in modo
che tutto possa essere spiegato mediante la complessa aggregazione e disgregazione dei diversi “elementi”,
supposti come immutabili.
Empedocle riconduce la formazione delle diverse sostanze alla aggregazione e alla disgregazione dei
quattro “elementi” (terra, acqua, aria, fuoco) mediante l’azione delle forze dell’amore e dell’odio,
rispettivamente aggregante e disgregante. I processi fisici s’inquadrano in due grandi fasi di un ciclo
cosmico: l’una che procede dall’unità indistinta degli elementi nello “sfero” compatto e l’altra che procede in
senso inverso, dalla separazione completa degli elementi verso la loro progressiva aggregazione. Nell’una e
nell’altra fase si ha la formazione delle cose inanimate e dei viventi. Secondo la concezione magica, che attribuiva una
natura divina agli elementi, il sacerdote, interprete delle forze naturali, ha il potere di influire sul concorso dell’amore e
dell’odio, determinando perfino inversioni e modificazioni notevoli nei processi fisici.
La teoria dei quattro elementi è stata per prima affermata da Empedocle, che la espresse con immagini tratte dalla
mitologia: “Sappi in primo luogo che quattro sono le radici di ogni cosa: Zeus lucente, Era donatrice di vita, Edoneo e
Nesti, le cui lacrime sono fondi di vita per i mortali” (cioè fuoco, aria, terra, acqua: fr. 6). Questi elementi materiali
alimentano il continuo processo di formazione e trasmutazione di tutte le cose, sotto la spinta delle due forze opposte di
Filia e Neikos. Queste forze si combattono in processi alterni che vedono la prevalenza dell’una o dell’altra e stadi di
74
Come, ad esempio, l’elettricità si divide in corrente positiva e negativa.
La fioritura di Empedocle è collocata intorno al 440 a. C. Fu uomo politico e legislatore, nonché medico, mago e
taumaturgo, oltre che filosofo indagatore della natura delle cose. Partecipò attivamente alle vicende politiche della sua
patria, Agrigento, e, dichiarandosi amico del popolo, contribuì al successo della parte democratica, impedendo
l’instaurazione della tirannide. Tuttavia, perduto il favore popolare, fu costretto a lasciare a città e a riparare nel
Peloponneso, dove morì intorno al 424 a. C. Delle due opere che sicuramente gli sono attribuite, La natura e
Purificazioni, abbiamo numerosi frammenti (circa 400 e 120 rispettivamente per le due opere), sufficienti a consentire
una generale ricostruzione della sua dottrina.
75
relativo equilibrio. Così in una fase dell’intero ciclo (che nel fr. 115 è indicato in “tre volte diecimila anni”, il “grande
anno”) si ha il progressivo prevalere dell’odio (che spezza l’unità dello “sfero” compatto e separa gli elementi che la
contrapposta forza dell’amore trattiene uniti in varie forme), fino alla separazione completa di quelle “radici”; mentre
nell’altra fase si ha la progressiva affermazione dell’amore fino alla ricomposizione dell’unità originaria dello “sfero”.
Gli enti particolari e gli organismi viventi76 si generano e si distruggono nel corso di entrambi i processi, prima per via
di separazione crescente dell’originaria unione degli elementi, nella fase di relativo equilibrio delle due forze, poi per
congiunzione crescente, in un’altra analoga fase di equilibrio.77
Empedocle riporta alle sue basi fisiche il complesso delle attività mentali e spiega la conoscenza con la teoria per cui il
simile conosce il simile:78 sicché le cose sarebbero conosciute in rapporto alla analoga costituzione che esse hanno
rispetto al nostro corpo. Egli mette in rilievo i limiti della conoscenza e come “è difficile che le cose sian viste o udite
dagli uomini e comprese dalla loro mente” (fr. 2); d’altra parte riconosce che il processo conoscitivo avviene attraverso
l’esercizio dei poteri mentali, poiché “nella conoscenza la mente s’accresce” (fr. 12): cioè le stesse conoscenze concorrono
ad ampliare le facoltà conoscitive. E occorre che la mente contenga una molteplicità di disposizioni, in rapporto alla
molteplicità delle qualità presenti negli enti. Perciò Empedocle dice: “E nella misura in cui gli uomini diventano
differenti, altrettanto ad essi sempre si porgono diverse cose a pensare” (fr. 108). Nel processo conoscitivo concorrono,
poi, sia l’esperienza che la riflessione intellettiva. Da una parte è necessario l’apporto di tutti i tipi di sensazione.79 Ciò
che appare alla percezione sensibile occorre, quindi, che venga fatto oggetto di riflessione, poiché ogni cosa deve anche
essere contemplata dall’intelletto (fr. 17). Al divino non è possibile giungere per la via della percezione, poiché esso non
può essere concepito al modo degli enti sensibili (come era raffigurato nella mitologia).
Empedocle accoglie la dottrina pitagorica della trasmigrazione delle anime e perciò condanna l’uso di cibi a base di
carne (i quali, in realtà, porterebbero all’antropofagia, per cui i figli si ciberebbero, ad esempio, dei propri padri, le cui
anime risiederebbero nei relativi animali uccisi o sacrificati).
Anassagora
Anassagora per primo portò la filosofia ad Atene, ma venne processato per empietà e costretto a lasciare quella città.
Egli introdusse la prima teoria pluralista, che prevedeva la realtà fisica costituita da particelle semplici, differenziate
qualitativamente e perciò riferite all’intera gamma delle sostanze esistenti in natura. Tali particelle, in quanto tra loro
somiglianti, egli chiamava omeomerie, e sosteneva che la loro formazione e il loro ordinamento cosmico fossero opera di
un principio attivo, il nous (intelletto) universale, fondamento della ragion d’essere di tutte le cose e di tutti i processi
fisici e umani.
Anassagora subì ad Atene un processo per empietà e, per sottrarsi alla condanna, fu costretto a esiliare.
La conoscenza risulta dall’apporto dell’esperienza sensibile e da quello dell’intendimento razionale. “Per
la debolezza (dei sensi) - egli afferma nel fr. 21 dell’opera Sulla natura, di cui Simplicio ci ha conservato
frammenti tratti dal I libro – noi non siamo capaci di discernere il vero”. Perciò egli si pone il problema di
pervenire da ciò che appare alla comprensione di ciò che è invisibile (fr. 21 a), di risalire dall’esperienza del
76
Nella descrizione della formazione delle specie viventi, Empedocle ci dà un primo nucleo del concetto di selezione
naturale: infatti tra le varie specie, la sopravvivenza è assicurata a quelle dotate di conformazione più adatta alle
caratteristiche ambientali. Nello scenario della vita, così, forme mostruose come “teste senza colli, braccia nude prive di
spalle, occhi soli sprovvisti di fronte” sono destinate a rapida estinzione.
77
Perciò Aristotele osserva: “E’ chiaro che per Empedocle la Discordia non è causa della distruzione più che
dell’esistenza; e allo stesso modo l’Amore non è causa dell’esistenza più [che della distruzione]: esso infatti
raccogliendo [gli elementi] nell’Uno distrugge gli altri enti” (Metafisica, II, 4, 1000). Così le due forze assumono una
funzione uguale, di formazione e di dissoluzione: “Spesso infatti l’Amore separa e la Discordia unisce. Quando, infatti,
per opera della Discordia, il tutto si disgiunge negli elementi, allora il fuoco si raccoglie in un’unica massa, e così
ciascuno degli altri elementi; quando al contrario, per azione dell’Amore, essi si raccolgono nell’Uno, è necessario che
di nuovo le parti di ciascun elemento si separino tra loro” (Metafisica, I, 4, 985).
78
“Con la terra vediamo la terra, con l’acqua l’acqua, con l’etere l’etere divino, e col fuoco il fuoco distruttore, con
l’Amore l’Amore e con la funesta Discordia la Discordia” (fr. 109). Questa teoria si basa sull’ipotesi degli “effluvi”,
cioè della corrente di particelle piccolissime di elementi che proviene dai corpi e che s’incontra con l’analoga corrente
che emana dai nostri organi di senso. Gli effluvi provenienti dalle cose si infiltrano attraverso i pori negli organi di
senso, che sono disposti a riceverli, secondo modalità specifiche per ciascuno di essi. Così la sensazione risulta
dall’adattamento ai pori delle diverse correnti di effluvi. Cfr. Teofrasto, De sensu, 7-11.
79
“Non avere nella vista maggiore fiducia che nell’udito, né fidarti dell’udito risonante più che delle chiare
testimonianze del gusto; e non rifiutare fiducia ad alcuno degli altri organi, per i quali c’è una via di conoscenza; ma
considera ogni cosa come essa è chiara” (fr. 4).
mutamento (della vicenda fenomenica) alla comprensione dell’identità permanente per mezzo della ragione.
Il mutamento, infatti, rimanda a una sostanza permanente e si può dire che “nessuna cosa nasce e nessuna
perisce, ma da cose già esistenti ognuna si viene a comporre e a scomporre”, sicché “dovrebbero rettamente
chiamarsi il nascere riunirsi e il perire separarsi” (fr. 17).
Gli elementi permanenti di cui tutte le cose sono composte sarebbero, come riferisce Aristotele (De coelo,
302), omeomerie invisibili (invece nei frammenti anassagorei si trova l’espressione spermata, “semi”, “radici”).
Queste particelle semplici, “semi di tutte le cose”, avrebbero “forme di ogni genere e colori e sapori” (fr. 4),
dunque corrisponderebbero alle varie sostanze, interamente definite nei loro aspetti qualitativi. Ciascuna
cosa, quindi, sarebbe determinata dalla presenza, in essa, di una prevalente quantità di omeomerie relative al
suo essere sostanziale.80 Bisogna tenere presente che, in realtà, per Anassagora non vi è un limite al processo
di divisione della materia (sicché il grande e il piccolo risultano costituiti di infinite particelle infinitesimali) e
non è neppure possibile separare le sostanze diverse (che, pertanto, sono distinte a livello teorico, ma di fatto
risultano sempre, in varia misura, mescolate). Così l’originaria mescolanza permane sempre e in ogni cosa
restano presenti tutte le sostanze. “E così stando le cose, conviene credere che tutte le cose sono nel tutto” (fr. 4).
Tutte le sostanze, infatti, in origine non erano separate e costituivano un tutto, in cui non vi era nessuna
distinzione: per la loro infinita piccolezza erano indiscernibili.81 La mescolanza originaria costituiva,
pertanto, una massa indifferenziata. Da tale stato si è poi sviluppato l’universo infinito, per progressivo
processo di separazione e differenziazione. Questo processo è avvenuto sotto la spinta di una forza
ordinatrice che Anassagora chiama “Intelletto” (Nous, principio di pensiero). 82
L’Intelletto è una forza che pervade tutte le cose e presiede a ogni processo di formazione e di mutamento,
“poiché è la più sottile e la più pura di tutte le cose ed ha ragione intera su ogni cosa e possiede la massima
forza” (fr. 12).83
“Il denso e l’umido, il freddo e l’oscuro si riunirono là dove ora è la terra, mentre il rado, il caldo, il secco
si portarono verso la regione esterna dell’etere” (fr. 15). In realtà, dunque, l’azione ordinatrice dell’Intelletto
finiva per identificarsi con la forza meccanica che spinge il denso verso il centro e il raro verso la periferia del
sistema cosmico.84 Probabilmente Anassagora ha ipotizzato un processo di differenziazione nell’indistinta
massa originaria, avvenuto in luoghi diversi, con la conseguente formazione di una pluralità di mondi.
Aristotele riferisce che “Anassagora dice che l’uomo è il più intelligente di tutti gli animali in virtù del
possesso delle mani” (De part. animalium, 606). Le mani (simbolo delle tecniche) rappresentano il momento
riassuntivo delle capacità umane: infatti i dati dell’esperienza vengono accumulati dalla memoria, poi
organizzati in sapere e, infine, utilizzati nella prassi operativa secondo le necessità della vita (fr. 21 b).85
Gli atomisti
Democrito, insieme a Leucippo, fu il fondatore della scuola atomistica, che espresse una concezione della natura
rigorosamente materialistica. Per tale concezione, infatti, tutto è costituito da atomi, particelle indivisibili, diverse per
80
“E a nessuna cosa è uguale nessun’altra, ma di quali cose in essa è maggiore quantità, questo nel modo più
manifesto ciascuna cosa è e fu” (fr. 12). Come spiega anche Simplicio (Fisica, 272): “Essendo ogni cosa caratterizzata
secondo ciò che in essa predomina, appare infatti oro quello nel quale sono molte particelle d’oro, sebbene vi siano tutte
le sostanze”. Perciò Anassagora può dire che “come era in principio, così anche ora tutte le cose sono insieme; e in tutte
son contenute molteplici cose, ed è uguale la molteplicità nelle maggiori e nelle minori delle cose separate” (fr. 6).
81
“E stando insieme tutte le cose, nessuna di esse era discernibile a cagione della piccolezza” (fr. 1).
82
“Tutte le cose erano insieme; poi l’Intelletto sopraggiungendo le ordinò a cosmo”: con questa affermazione,
secondo Diogene Laerzio (II, 6), incominciava l’opera di Anassagora. Cfr. Aristotele, Fisica, VIII, 1, 250: “Egli dice
che, essendo tutte le cose insieme, e stando per un tempo infinito in quiete, l’intelletto vi portò il moto e le separò”.
83
“L’intelletto ordinatore del mondo è la divinità”, interpreterà poi Aezio (I, 7, 14). E infatti dice lo stesso
Anassagora: “L’Intelletto, che è eterno, è certamente anche ora dove anche tutte le altre cose sono, nella massa
avvolgente e in ciò che è stato unito ad esso e in ciò che ne è stato separato” (fr. 14).
84
Perciò nel Fedone Platone fa muovere da Socrate questa critica alla concezione di Anassagora: che l’Intelletto,
dapprima posto come principio ordinatore del mondo e causa di tutte le cose, viene poi annullato dalla funzione di
causa, che viene invece assunta da elementi naturali come i vapori, l’etere, le acque “e mille altre cose assurde” (97 b).
85
“L’indicazione delle mani come caratteristica fondamentale del tecnico era un topos classico della cultura greca, da
Solone a Senofane, a Empedocle e Democrito. Ma in Anassagora il possesso delle mani, cioè di un equipaggiamento
biologico-organico che si tramuta subito in una qualificazione a livello culturale, è indicato decisamente come la linea
di demarcazione fra uomo e animali. Ciò significa che il modello di uomo che Anassagora ha di fronte è l’uomo-tecnico
[…]. In tal modo […] il lavoro manuale era non soltanto rivalutato contro una tradizione aristocratica che lo disprezzava
e collocato su un piano di uguale dignità con le altre attività lavorative, ma era addirittura posto in primo piano come
contrassegno costante dell’umanità” (F. Cambiano, Platone e le tecniche, Einaudi, Torino 1971, pp. 55-56).
forma e grandezza, che, unendosi e separandosi per azione del freddo e del calore, danno luogo alle diverse sostanze e alle
loro trasformazioni. La teoria atomistica sarà ripresa da Epicuro e da Lucrezio, col principale intento di sgombrare il
campo da ogni superstizione e opinione ingannevole.
Gli atomisti sono i primi a proporre un modello materialistico di interpretazione del sistema cosmico.
L’universo, pur nel suo mirabile ordine, è il risultato del movimento di particelle materiali semplici, che,
aggregandosi e separandosi, danno luogo ai diversi processi fisici e alla formazione e disgregazione delle
cose. Non vi è, come per Anassagora, un principio intelligente o, come per Eraclito, un “logos”, che dispone
gli elementi materiali secondo un disegno prestabilito. La realtà è costituita solo da atomi e vuoto. I processi
mentali e spirituali, infatti, sono anch’essi il prodotto dei movimenti complessi che sono compiuti dagli
atomi del nostro sistema nervoso e dei nostri organi di senso. Anche i sentimenti e le passioni sono una
manifestazione del diverso moto degli atomi che costituiscono la nostra anima (anch’essa materiale). Il
freddo e il caldo (che a loro volta producono i fenomeni di aggregazione e disgregazione) corrispondono a
condizioni di stasi o di movimento o di movimento più lento o più veloce. Gli atomi movendosi a grandi
velocità, sfregandosi tra loro, producono calore ed energia; stando fermi o movendosi assai lentamente
producono freddo e condizioni d’inerzia. I fenomeni vitali sono espressioni di sistemi di movimento.
Gli atomi sono identici per le loro qualità, sono diversi per le dimensioni e le forme.86 Le irregolarità della
forma consentono e determinano le loro aggregazioni. Accade che essi s’incastrino gli uni negli proprio in
ragione delle sporgenze e delle rientranze di cui sono dotati. Il movimento, producendo calore, separa gli
atomi gli uni dagli altri, mentre la stasi li mantiene uniti. Così avvengono, ad esempio, i processi di
liquefazione o di evaporazione, e per le condizioni opposte quelli di condensazione e solidificazione.87
La storia dell’atomismo attraversa l’intera cultura antica. Il nucleo della concezione atomistica
(materialistica e meccanicistica) è stato elaborato da Leucippo, vissuto nel V secolo e perciò contemporaneo
di Empedocle e di Anassagora e del quale sappiamo poco, ed è stato sviluppato dal più celebre Democrito, il
suo scolaro, più giovane di lui di almeno quarant’anni (dunque nato intorno al 460), e del quale sono stati
tramandati numerosi frammenti e i titoli di una lunga serie di scritti. L’atomismo venne poi ripreso
sistematicamente da Epicuro nell’età ellenistica e divulgato massimamente dal poeta latino Lucrezio.
Democrito ammette che la conoscenza vera è quella che riesce a cogliere la realtà oltre le apparenze
sensibili: così reali sono i processi di modificazione dei rapporti tra gli atomi, mentre apparenti sono i modi
in cui tali modificazioni o stati si manifestano ai nostri sensi.88
86
Come riferisce Aristotele, tre sono le caratteristiche che differenziano gli atomi: “la figura, l’ordine e la posizione:
poiché (gli atomisti) dicono che l’essere non si differenzia che per proporzione, contatto e conversione: ora la
proporzione è la figura, il contatto è l’ordine e la conversione è la posizione. Giacché A differisce da N per figura, AN
da NA per ordine, Z da N per posizione” (Metafisica, I, 4, 985). Aristotele aggiunge anche la grandezza come
caratteristica che differenzia gli atomi democritei: “Democrito dice che nessuno dei principi si genera l’uno dall’altro;
ma tuttavia lo stesso corpo comune è principio di tutte le cose, differente nelle sue parti solo per grandezza e figura”
(Fisica, III, 203). Teofrasto riferisce insieme le quattro caratteristiche: “Democrito non parla sempre ugualmente di tutte
le cose, ma alcune distingue per le grandezze, altre per le forme, alcune poi per l’ordine e la posizione” (De sensu, 60).
Connesso alla grandezza è il peso: “Democrito dice che ognuno degli indivisibili (atomi) è più pesante in proporzione
del suo eccesso di grandezza” (De gen. et corr., I, 8, 326).
87
“Democrito e Leucippo, avendo poste le forme, da queste derivano la mutazione e la generazione: per via di
riunione e separazione la nascita e la distruzione, per via di ordine e di posizione il mutamento” (Aristotele, De gen. et
corr. I, 2, 315).
88
“Vi sono due specie di conoscenza, una vera e l’altra oscura. E all’oscura appartengono tutte queste cose: vista,
udito, odorato, gusto, tatto. La vera invece è quella che giudica dell’altra. […] Quando l’oscura non può più vedere
diminuendo, né udire, né odorare, né gustare, né sentire col tatto, ma deve cercare nel più sottile, allora sopraggiunge la
vera, che ha l’organo più sottile nella mente” (fr. 11). La mente coglie, al di là delle mutevoli apparenze, la realtà
immutabile, costituita dagli atomi. Perciò Democrito dice: “Opinione il dolce, opinione l’amaro, opinione il caldo,
opinione il freddo, opinione il colore: verità solo gli atomi e il vuoto” (fr. 5).
CAPITOLO IV
I Sofisti
Nel V secolo a. C. si sviluppa ad Atene il movimento culturale dei Sofisti, con l’intento di diffondere il sapere
enciclopedico e di promuovere la formazione (“paideia”) del cittadino consapevole del suo ruolo politico e capace di
partecipare al dibattito nelle pubbliche assemblee conseguendo il successo in virtù del possesso dell’arte oratoria.
Il significato storico dei Sofisti è stato messo in rilievo per la prima volta da Hegel. Infatti, per secoli si era
tramandata la fama dei Sofisti come maestri di una retorica rivolta a sostenere i punti di vista soggettivi e a
risolvere la conoscenza in una opinione convenzionale affidata alla potenza del discorso. Hegel ha rilevato
l’alto livello di consapevolezza umanistica che, a parte la notevole affermazione del ruolo del pensiero nello
sviluppo di una prassi etica e politica basata sull’intelligenza della realtà umana, già operata dai filosofi
precedenti, doveva costituire il presupposto per le grandi sistemazioni successive. Sia pure preoccupato di
trovare in quella filosofia le più lontane anticipazioni del suo antropocentrismo metafisico e storicistico, egli
ha messo in luce il fondamentale apporto dei Sofisti alla scoperta del soggetto, con l’idea relativa
all’impossibilità di separare il pensiero dalla realtà. Anche se l’idea del principio soggettivo è già presente in
Eraclito (per cui il “logos” è, insieme, principio del divenire e intelligenza del reale espressa nel discorso
filosofico), Parmenide (in cui è nota la connessione tra l’essere e il pensiero), Anassagora (per il quale la
realtà rientra in gran parte nel processo della prassi umana) e lo stesso Democrito (assai vicino ai Sofisti per i
rilievi sulle origini delle istituzioni), non si può non riconoscere l’apporto decisivo dei Sofisti allo sviluppo di
una nuova concezione, per la quale l’uomo è posto al centro dell’intera realtà ed è considerato come l’ente
che per natura possiede le capacità che lo rendono libero artefice del suo mondo.
I Sofisti rappresentano, nella cultura greca, il momento del riconoscimento della centralità dell’uomo nella
configurazione dell’intera realtà: si può dire che essi abbiano elaborato la prima ideologia della tecnica come
complesso dei metodi e delle vie attraverso i quali l’uomo domina e modella la natura stessa. Al posto
dell’idea di una natura immodificabile, configurata come necessità, subentra la convinzione che la realtà è il
prodotto della prassi umana ed è costituita non già da enti definiti nella loro essenza, bensì da pragmata (una
parola che serve a indicare le cose stesse, in quanto connesse con l’attività umana e significative solo in
rapporto ad essa). La funzione della conoscenza, in questo senso, non è più quello di fissare e comprendere
le strutture immutabili della realtà (metafisica), bensì quello di definire le vie e le modalità migliori (più
efficaci e più razionali) di organizzazione della prassi.
I Sofisti sono i maestri e i divulgatori del sapere nell’età della democrazia. Essi considerano il sapere come
un importante strumento di emancipazione sociale e politica: non solo esso concorre a formare l’uomo
libero, ma costituisce un fattore di elevazione del livello politico della convivenza cittadina. Le conoscenze
non hanno un valore per sé ma risultano utili in quanto favoriscono la concordia e orientano nella scelta
delle soluzioni migliori per la comunità. L’insegnamento dei Sofisti spaziava per l’intero campo dello scibile,
ma principalmente riguardava la formazione dell’uomo politico, la cui capacità principale doveva essere
quella di persuadere e convincere i concittadini ad aderire alle sue proposte e a sostenerlo nella conquista o
nell’esercizio e mantenimento del potere. Ma l’enciclopedia scientifica dei Sofisti comprendeva, ovviamente,
anche la conoscenza filosofica e, pertanto, abbiamo uno sviluppo della riflessione autonoma anche per opera
di essi. Molti Sofisti, cioè, furono filosofi in senso proprio e proseguirono l’indagine intorno a problemi di
carattere teorico in gran parte già discussi o intorno ai quali la discussione era stata avviata. E’ chiaro che la
loro riflessione si indirizzasse specialmente al campo umano, morale e politico. Infatti l’età dei Sofisti è detta
anche età umanistica.
Protagora ha proclamato il primato dell’uomo nell’ordine della realtà, con la sua celebre affermazione:
“L’uomo è misura di tutte le cose, in quanto sono e in quanto non sono”. Ciò vuol dire che intorno alle cose
si sviluppa il pensiero e il discorso dell’uomo e che noi non possiamo mai attingere le cose per sé, in una loro
ipotetica e presunta realtà in sé. L’essere delle cose dipende dai nostri modi di averne esperienza, di
pensarne e di parlarne. Ciò di cui noi possiamo parlare sono le nostre stesse esperienze, i molteplici modi in
cui si articola la nostra riflessione sulla realtà e la nostra comprensione delle cose. Protagora parla dell’uomo
in generale, non del singolo soggetto: dell’uomo in quanto soggetto che appartiene a un contesto culturale e
sociale. Così, ad esempio, le abitudini, le convinzioni, i costumi sono quelli di un popolo, di una città, di un
gruppo. L’uomo-misura è sempre intersoggettivo, storico, sociale. E le “cose” sono i prodotti dell’attività
umana: strutture del mondo, credenze, leggi, costumi, conoscenze, idee.
Si potrebbe chiamare l’orientamento dei Sofisti come “esistenzialistico”, poiché, in quanto filosofi, essi
riportavano ogni struttura reale all’esistenza umana e tale che acquistasse significato e valore proprio entro
l’orizzonte della storia e della cultura. Protagora distingueva un “discorso migliore” e un “discorso
peggiore”: il Sofista aveva il compito di favore il primo e di evitare il secondo; infatti quello era vantaggioso
per la città ed era condiviso dalla maggioranza dei cittadini, l’altro era dannoso. E’ stato anche detto (da
Jaeger) che il discorso peggiore è quello della tecnica e quello migliore il discorso della politica, nel senso che
proprio sul piano politico l’uomo raggiunge ed esprime la sua umanità. I Sofisti lottavano per l’elevazione
morale e politica dei cittadini, per la divulgazione della cultura politica.
Jacopo Gegl agli inizi dell’Ottocento compì la prima importante ricostruzione dell’opera e del pensiero
dei Sofisti (1823); seguirono una monografia dello Hebst (1832), le Questioni protagoree di Giovanni Frei
(1845), uno studio del Vitringa, I Sofisti del Wecklein. Nel 1879 il Laas dedicava a Protagora uno studio nel
primo volume di Idealismo e positivismo; venivano poi due studi del Natorp (!884, 1891) e altri saggi di
studiosi tedeschi su riviste del tempo. L’ultimo e anche il migliore dei lavori del secolo XIX è lo Studio della
filosofia teoretica di Protagora di Aurelio Covotti (in “Annali della Scuola Normale di Pisa, Filosofia e
filologia”, 1897). Il primo notevole lavoro sui Sofisti è quello del Gomperz, Sofistica e retorica (1912). Per
Gomperz la Sofistica si risolve nella retorica, con la ricerca dell’effetto estetico, della tecnica oratoria, rivolta a
commuovere e persuadere, a comporre discorsi e a declamarli. Ma, come osserva il Buccellato, è più vicino
alla verità supporre un nesso tra l’interesse retorico e quello più propriamente filosofico e scientifico, poiché
i Sofisti discussero e impostarono su nuovi basi teoretiche i problemi del sapere del tempo, comprese le
problematiche filosofiche (specialmente quelle dell’eleatismo e dell’eraclitismo).89 Lo Joël, pur condividendo
la tesi dei Sofisti maestri di retorica, ha rilevato l’interesse ampiamente culturale ed enciclopedico che
consentiva ai rappresentanti di questo movimento di discutere le tematiche più diverse. In questo senso si
profila l’interpretazione dei Sofisti come “maestri di sapere”, divulgatori delle stesse conoscenze scientifiche
del tempo.90 Sulla stessa linea si collocano le pagine dedicate dal Maier ai Sofisti nel suo Scorate. I Sofisti
sarebbero anche spinti da un progetto di rinnovamento culturale, basato sulla completa liberazione dal mito
e sullo sviluppo di una visione critica dei problemi pratico-politici e culturali.91
Qualche elemento di novità presenta l’interpretazione dello Jaeger nella sua opera sulla “formazione
dell’uomo greco”. L’elemento pratico-politico dominante nei Sofisti s’inserisce in una generale “finalità
educativa quale cultura dello spirito includente una straordinaria molteplicità di mezzi e di metodi
d’insegnamento”. Lo studioso colloca al centro dell’interesse dei Sofisti il discorso retorico-politico, capace di
indirizzare le comunità a elaborare i migliori progetti di vita associata. Lo studioso ritiene che la posizione
89
“Discorsi orali e scritti che prendano a tema di esercitazioni argomenti di ogni campo della fisica (dall’astronomia
a una teoria dei colori), la tematica dell’essere e del non-essere, teorie della sensazione e della conoscenza come
momenti dell’apprendimento e della comunicabilità del sapere, esercitazioni retoriche che abbozzano o enunciano
spiegazioni sull’origine e i limiti della parola come espressione del pensiero, che tendano a definire il significato di
nozioni e valori come realtà e apparenza, che rivelano conoscenze di etica, sociologia, estetica, psicologia, ‘discorsi’ ed
‘esercitazioni’ di tal genere assai malagevolmente si lasciano ridurre al denominatore comune dell’interesse formale,
estrinseco, di una tecnica; tanto più quando si considera che di gran parte di quelle materie i compositori di quei discorsi
possedevano tale qualità, oltre che quantità, di conoscenze da consentire loro di costituirle in téchnai, ossia in discipline
distinte e organiche, che oltretutto esercitarono un’influenza duratura presso gli stessi Platone e Aristotele”M.
Buccellato, Rassegna di studi sofistici, in “Rassegna di filosofia”, 1953, p. 116.
90
Lo Jöel ricorda che l’interesse dei Sofisti per la filosofia della natura è ampiamente documentato: Infatti ci sono
tramandati scritti e discorsi “sulla natura” di Protagora, Gorgia, Trasimaco, Prodico; che Ippia insegnò scienze e storia
delle scienze; che Antifonte scrisse un’opera Sulla verità, in cui prendeva le difese dell’elatismo contro le tesi sostenute
da Protagora nel suo scritto dallo stesso titolo, e che discusse tesi matematiche e fisiche; che Crizia materializzava
l’anima nel sangue; che Gorgia è rappresentato nell’atto di osservare la sfera celeste (sul monumento sepolcrale del suo
discepolo Isocrate) e che nell’Encomio di Elena manifestava interesse per le dottrine astronomiche e fisiche. [I
Presocratici (?)]
91
“Si voleva sostituire a quella filosofia dell’almanaccare, stantia, estranea al mondo e alla vita, inintelligibile e
inaccessibile all’uomo normale, che trascinava allora la sua esistenza in silenziose associazioni scolastiche, una filosofia
per il mondo e per la vita” (H. Maier, Scorate, tr. it., p. 224). Quei filosofi si proponevano, perciò, di far discendere
l’influenza del discorso nella vita, movendo con la stessa forza del ragionamento le istituzioni politiche e sociali,
cercando così di “promuovere una grande riforma etica degli ordinamenti politici e sociali esistenti”.
storica dei Sofisti si spiega riallacciandoli, piuttosto che ai filosofi della natura e dell’essere, alla tradizione
educativa dei poeti (da Omero a Pindaro), avvertendo, tuttavia, che la critica sofistica nei riguardi del
patrimonio religioso, etico e sociale tradizionale non si spiega senza il riferimento a quei filosofi.
Ma ogni tentativo di rivalutare il contenuto dottrinale e scientifico-speculativo dell’insegnamento e della
ricerca dei Sofisti deve rifarsi alle indagini dello Joël, il quale non condivide l’opinione di coloro che vedono
una frattura tra filosofia della natura e sofistica. I Sofisti proseguono la ricerca intorno all’essere,
approfondendola nella direzione dell’esame del rapporto tra essere e logos. L’oggettività assoluta che gli
Eleati nella sua unità, nel secolo V è frantumata ad opera dell’atomismo; e in rapporto a ciò anche l’unità del
logos subisce una frantumazione. Ciò avviene nell’ambito di una concezione generale della realtà, per cui
l’uomo è un elemento del cosmo e interviene attivamente nella definizione della verità, in modo che non solo
l’alétheia e il logos alethés devono adeguarsi alle cose ma anche queste devono adeguarsi agli elementi
soggettivi e alla costituzione dell’uomo. In tal modo una fondamentale corrispondenza viene pensata tra il
“logos” e il “kosmos” e l’uomo è posto come intermediario tra i due termini metafisici fondamentali.92 Il
principio di verità non è più considerato come oggettivamente appartenente alla “natura” ma viene messo in
rapporto all’intelligibilità. L’uomo (osserva lo Joël) viene concepito dai Sofisti come il criterio stesso di verità,
il punto immobile nel flusso delle apparenze, l’unico vero “principio” e il punto di riferimento nella
relatività di tutte le cose e di tutti i valori. L’uomo, in tal modo, appare come il piano in cui può trovare la
soluzione l’opposizione apparenza-verità, essere-divenire. L’apparenza cessa di essere considerata come
rigidamente opposta alla verità e questa non è concepita univocamente come una struttura “reale” e
immutabile; la verità è definita specialmente in rapporto all’uomo, che appare ora per la prima volta come
principio attivo di fondazione della verità stessa. Il concetto di verità come “manifestazione”, così
importante nello sviluppo del pensiero di Platone, ha qui la sua prima formulazione. La sensazione di
costituisce come una non trascurabile via di accesso alla verità, in quanto è una componente non trascurabile
dell’esperienza umana (che è l’orizzonte generale in cui si rivela la verità).
Di questa esigenza tiene conto lo studio finora più completo e approfondito sui Sofisti, quello di Mario
Untersteiner. I Sofisti si definiscono come filosofi delle “esperienze” e non più delle “essenze” o dei
“principi”: essi traggono i temi del loro pensiero dall’esame delle situazioni umane; in questo senso si può
dire che iniziano un nuovo periodo nel pensiero greco, diverso da quello del naturalismo metafisico, volto a
cogliere le essenze delle cose e le leggi generali di produzione dei fenomeni. L’Untersteiner riconduce il
pensiero sofistico al filone dell’esperienza culturale della tragedia: là infatti erano confluiti i motivi del
dissidio umano, del contrasto tra le diverse “ragioni”, le opposte valutazioni della realtà.93
Nei Sofisti prevale la consapevolezza che tutti gli elementi conoscitivi e tutti gli strumenti pratici sono
prodotti dell’uomo e che l’uomo ha sempre a che fare con dati culturali, per cui si tratta, di volta in volta, di
esaminarne la genesi nello sviluppo dell’esperienza. La stessa affermazione di alcuni elementi al posto di
altri avviene non senza motivi di conflitto e di opposizione: leggi e istituzioni sociali si confrontano con altre
e cercano di affermarsi al posto di esse; idee e punti di vista opposti rivelano la loro efficacia rispetto a
determinati problemi. I Sofisti mettono in rilievo come sono destinati ad affermarsi i discorsi e le prospettive
che sono forniti dei più convincenti elementi argomentativi e che offrono le soluzioni migliori per il buon
equilibrio della vita sociale. Comunque tutto è attribuito all’uomo. Gli uomini non hanno a che fare con fatti
o strutture fondati miticamente da divinità; anzi sono essi medesimi che si creano e immaginano principi
eterni e realtà divine, per spiegare i processi reali e le loro esperienze medesime. I Sofisti affermano che di
tutte le esperienze umane si dà una genesi e una spiegazione: e in questo senso pongono le base per il primo
sistema organico di “scienze umane”.
Protagora
92
Come osserva il Bucellato (l. cit., p. 211): “Se si può riconoscere con Joël che l’atomismo e l’omeomerismo e in
genere il pluralismo non dissolvono nel nella l’oggettività, si potrà riconoscere analoga,mente che il moltiplicarsi dei
discorsi, il frantumarsi della ‘verità’ nelle verità, né dissolve nel nulla il discorso e la verità, né tanto meno inizia una
diaframmazione del tipo di quella odiernamente significata dalla distinzione soggetto-oggetto, o anche uomo-natura”.
93
“I Sofisti coincidono in una concretezza antidealistica, che non batte le vie dello scetticismo, ma piuttosto quelle di
un realismo e di un fenomenismo, che non imbrigliano la realtà in uno schema dogmatico, perché, al contrario, la
lasciano fremere in tutte le sue antitesi” (M. Untersteiner, I Sofisti, p. 6).
Per Protagora la “verità” dipende dal tipo di discorso che intorno a un argomento si riesce a sviluppare: così
“discorso migliore” è quello che è condiviso da un pubblico più vasto e “peggiore” è quello che non persuade. Jaeger
interpreta questa differenza come riferita a due forme di civiltà: quella basata sulla tecnica e quella fondata sull’ordine
politico e sociale.
La crisi del mito esplode nell’esperienza del pensiero dei Sofisti. E’ interamente abbandonata ogni
supposta interferenza di elementi metafisici, divini o naturali, nello sviluppo del pensiero umano.
Protagora94 per primo scoprì la forza del logo che dissolve il mito; si tratta di un logo contrapposto a un
altro logo: “per primo sostenne che intorno a ogni esperienza vi sono due logoi in contrasto tra di loro” (Diogene
Laerzio, IX, 51). La duplicità (molteplicità) irrompe nel cuore del logo, che cessa di essere compatto e rigido e
di avere i caratteri dell’essere e del principio unico della realtà e acquista la forma dell’esperienza umana.
L’interno contrasto del logos appariva soprattutto nel campo dell’esperienza morale. Tale situazione si
profilava nella tragedia come polarità e tensione di opposte leggi (la legge del cuore e la legge dello stato).95
Il nucleo del pensiero di Protagora è espresso dalla celebre affermazione che l’uomo è misura di tutte le cose,
in quanto sono e in quanto non sono. E’ evidente che intorno al significato di questa proposizione si siano
moltiplicate le interpretazioni. Nell’antichità si è vista generalmente l’affermazione della impossibilità di
andare oltre i modi in cui le cose appaiono nell’ambito dell’esperienza umana.96 Ma la critica moderna tende
94
Protagora nacque ad Abdera, come riferisce Eraclide Pontico nell’opera Intorno alle leggi, verso il 485.
Apollodoro riferisce che esercitò l’insegnamento sofistico per 40 anni. Filostrato attesta che fu discepolo di Democrito
(ma perché la notizia sia verosimile bisogna accettare per il rappresentante dell’atomismo la cronologia di Diodoro
(494-404) e non quella di Apollodoro, di circa trent’anni più avanti) e che ebbe rapporti anche coi magi persiani in
occasione della spedizione di Serse e avanza l’ipotesi che da essi abbia tratto l’aporia intorno all’esistenza della divinità
(ma l’ipotesi sarebbe verosimile se si potesse collocare la nascita di Protagora intorno al 495). Sicuramente Protagora si
recò ad Atene ed ebbe da Pericle l’incarico di disporre la legislazione di Turi, la nuova colonia fondata nel 444 con
spirito panellenico. Un altro soggiorno ad Atene cade intorno al 432, anno in cui si colloca verosimilmente l’azione del
Protagora di Platone. Forse risale a un terzo soggiorno ateniese l’attacco di Eupoli nei suoi Adulatori e che suona come
una velata accusa di empietà (simile a quella mossa ad Anassagora, che aveva negato il carattere divino degli astri).
Diogene Laerzio riferisce che in casa di Euripide lesse il suo scritto Intorno agli dèi. Dei suoi viaggi, che fece come
sofista, coperto di onori e ricercato, sappiamo di quello in Sicilia, dove incontrò Ippia il Giovane, forse prima della
spedizione ateniese. Ad Atene intorno al 411 Protagora venne accusato di empietà da Pitodoro figlio di Poliselo (uno
dei Quattrocento), in coincidenza con la reazione religiosa propria dell’ambiente oligarchico. Non si sa se egli si sia
sottratto alla condanna fuggendo da Atene o se sia stato bandito dalla città. Sarebbe morto nel naufragio della piccola
nave sulla quale era imbarcato. I suoi libri sarebbero stati dati alle fiamme in seguito a un decreto dell’assemblea
popolare degli Ateniesi (come riferisce Sesto Empirico, Adv. m. IX, 55, riportando un passo dei Silli di Timone di
Fliunti: “vollero cenere fare delle sue opere/ perché egli scrisse di non sapere/ né di poter scrutare quali e chi fossero i
numi./ Questo a lui non giovò ma la fuga bramò per non bere/ la fredda bevanda socratica e scendere quindi nell’Ade” ).
L’elenco delle opere tramandato da Diogene Laerzio sembra incompleto e relativo solo ai sottotitoli dell’opera
principale, le Antilogie, che trattavano quattro problemi fondamentali: 1) intorno agli dèi e intorno alla sorte nell’Ade;
2) intorno all’essere; 3) intorno alle leggi e a tutti i problemi inerenti al mondo della polis; 4) intorno alle arti.
Sappiamo anche di un’opera intitolata La verità. Altri titoli di trattati autonomi o sezioni di opere generali sono: Intorno
allo Stato; Intorno alla condizione originaria dell’uomo; Intorno alle virtù; Intorno alle azioni non compiute rettamente
dagli uomini; L’arte dell’eristica; il Grande trattato (che però doveva indicare l’insieme dei libri in cui Protagora
esponeva le sue tesi oppure era un altro titolo dell’opera sulla verità, come sostiene l’Untersteiner, I Sofisti, cit., p. 25).
95
A questo proposito l’Untersteiner osserva: “E’ caratteristico del dramma eschileo il rigore spasmodico con cui
questa duplicità del reale trova espressione. Questo pensiero è dominante in tutte le tragedie di Eschilo: nelle Supplici,
ove contrasta il logos delle Manaidi contro quello del responsabile dello stato; nei Persiani il divino impone a Serse
un’azione contraddittoria cosicché si è potuto parlare di uno sdoppiamento in Dio; nel Prometeo si solleva il più grande
contrasto di dio con se stesso. Nelle Coefore il dissidio che si spalanca in seno a di##kh è portato a una tragicità
sofferta con ansia durante il corso di tutta la tragedia in modo che un po’ alla volta tutti ne sono investiti. Oreste che
deve, per volere divino, compiere il matricidio, violando così un alto volere divino, quando dopo molto pensare la sua
realtà gli si illumina, proclama: ‘Ares contro Ares a lotta verrà, Dike contro Dike’. – L’esperienza relativistica già
abbozzata in Archiloco, con Eschilo è diventata tragica” (I Sofisti, cit., p. 32).
96
Cfr. Platone, Cratilo, 386 a: “Suvvia, Ermogene, riflettiamo se a te pare che anche per gli enti la questione stia
così: che la sostanza delle cose sia propria particolarmente per ognuno, come sosteneva Protagora, dicendo che ‘di tutte
le cose misura’ è l’uomo, sicché quali a me esse sembrino, tali esse siano per me, e quali sembrino a te, tali esse siano
per te. O sembra a te che esse di per se stesse abbiano una loro saldezza nella loro sostanza?”. Secondo Platone, la
prospettiva di Protagora è quella di un relativismo soggettivistico: non sarebbe possibile, in questo modo, pervenire a
una “verità” universale, valida per tutti i soggetti. L’unica verità sarebbe quella fenomenica, propria dell’apparire
fenomenico delle cose ai singoli soggetti. L’accettazione di una verità comune avverrebbe per convenzione. In questo
a escludere un radicale relativismo. Protagora, del resto, se ammette l’infinita molteplicità delle esperienze in
cui appaiono le cose, ammette anche modalità “migliori” del manifestarsi delle cose stesse nell’orizzonte
percettivo e quindi nello sviluppo delle descrizioni e dei discorsi. Ci sono modi difficilmente condividibili e
modi generalmente condivisi da una moltitudine di soggetti. Si tratta di vedere il punto di vista più
verosimile e anche più vantaggioso per una comunità. In questo senso significativa sembra la traduzioneinterpretazione avanzata dall’Untersteiner: “L’uomo è dominatore di tutte le esperienze, in relazione alla
fenomenalità di quanto è reale e alla nessuna fenomenalità di quanto è privo di realtà”.97 Delle cose si danno,
dunque, esperienze e le esperienze sono in dominio dell’uomo. I modi in cui le cose sono corrispondono,
dunque, ai modi in cui gli uomini possono averne esperienza.
Poiché l’interpretazione della proposizione di Protagora ha avuto complesse vicende, conviene accennare
al significato che ai singoli termini si è variamente attribuito: 1) crhma@twn : H. Gomperz traduce questo
termine con “il tutto”; Natorp sostiene che il termine si riferisce ai possibili giudizi veri e falsi; Th. Gomperz
intende “le cose esistenti” e accessibili all’uomo (alla mente umana); Schmid traduce con “la mutevole
apparenza esteriore delle cose”; Nestle, “proprietà e valori delle cose che si presuppongono esistere e
manifestarsi ai sensi, vale a dire delle qualità sensibili ed etiche”, perciò “non cose concrete, ma predicati,
che si attribuiscono alle cose sul fondamento delle rappresentazioni e delle percezioni”;98 2) meètron: il senso
che si attribuisce generalmente a questo termine è quello di “criterio” (Teet. 160 b; Ipotesi Pirr., I 216);
l’Untersteimer giunge alla traduzione di “dominio”, sulla scorta di un’espressione di Eraclito (il quale dice
che il cosmo è retto da una legge che esercita il suo meètron, cioè il suo dominio sul divenire); 3) aònqropov: gli
antichi interpreti e la maggior parte dei moderni (da Hegel fino a Zeller, Natorp, H. Gomperz, Rensi,
Calogero, Levi) hanno inteso l’uomo nel senso individuale; Th. Gomperz ha sostenuto la tesi opposta; lo Joël
ha cercato di conciliare i due significati.99
senso convenzionali sarebbero, ad esempio, i nomi coi quali si designano le “cose”, corrispondenti a esperienze simili (è
chiaro, ad esempio, che nessuno ha mai avuto esperienza della rosa ideale, ma ognuno ha visto e può sempre vedere
rose particolari e diverse). Analogamente Sesto Empirico (Ipotesi pirroniane, I, 216 sgg.): “Con ‘misura’ egli intende il
criterio, con ‘esperienze’ le esperienze obiettive, cosicché secondo il suo pensiero egli afferma che di tutte le esperienze
obiettive misura è l’uomo, ‘in relazione alla fenomenalità di quanto è reale e alla nessuna fenomenalità di quanto è
privo di realtà’. E, di conseguenza, egli ammette solo le cose che appaiono a ciascuno e, in tal modo, introduce il
relativismo”. L’obiettività delle cose, dunque, non è altro che una dimensione della nostra esperienza; essa si moltiplica
e si disperde in relazione alla molteplicità delle esperienze umane o alla infinita molteplicità dei modi in cui una cosa
può apparire. Anche Aristotele sembra dare la stessa interpretazione relativistica (Metafisica, K 6 1062 b 12):
“(Protagora) sosteneva che di tutte le esperienze misura è l’uomo e con ciò non esprime altro concetto che questo: che
quanto ognuno sembra, possiede anche una realtà effettiva. Se questa proposizione è vera, ne segue che una medesima
cosa esiste e non esiste, ed è male e bene e così sono vere tutte le altre proposizioni che sono svolte secondo le opposte
tesi (cioè affermazione e negazione)”. E ancora (Metafisica, IV 5 1009): “Su ogni argomento si possono avanzare due
discorsi in perfetta antitesi fra loro. Se tutte le opinioni e tutte le apparenze sono vere, ne deriva di necessità che ognuna
è vera e falsa nello stesso tempo”.
97
M. Untersteiner, I Sofisti, cit., p. 55.
98
Per questo termine proporrei la traduzione “eventi”, nel senso di formazioni storiche che sono, appunto, disposte
dagli uomini. Non può trattarsi, infatti, di “cose” già costituite nel mondo, bensì di elementi oggettivi correlativi di
azioni umane. Gli uomini, cioè, incontrano nel mondo forme che essi medesimi hanno contribuito a fondare con la loro
attività conoscitiva e pratica. In definitiva, può valere l’uso del termine generico “cose”. Come spiega ampiamente
l’Untersteiner, infatti, crh@ indica il bisogno che si ha o l’uso che si fa di una cosa e crh^ma designa l’oggetto così
specificato. In questo senso crh^ma indica l’evento nel quale il soggetto s’imbatte o che egli stesso concorre a istituire
con la sua attività, “sia come stato di fatto di fronte al quale interviene l’azione del singolo, sia nel suo svolgersi” (I
Sofisti, cit., p. 96). “La parola dunque oscilla tra il significato obiettivo di evento e quello di scopo (ciò che sta al
termine di un vento), in modo da imporre il senso subbietivo di decisione. Ma una volta che la parola è stata trasportata
entro questo dominio, essa può esprimere tanto il soggetto della percezione sensibile, quanto l’attività intellettuale” (Ib.,
p. 97). In conclusione: “Risulta evidente che la parola crh^mata costituisce tutto quello che sta innanzi all’uomo, dal
sensibile all’intelligibile, dall’evento come realtà accaduta, all’evento nel suo divenire. Questo mondo designato con
crh^mata costituisce la sfera d’azione dell’uomo il quale davanti ad essa deve esercitare un’opera di interpretazione
o di dominio” (Ib.).
99
“Se si rifiuta completamente l’interpretazione in senso generale si toglie alla proposizione molto della sua
grandezza. Essa infatti proclama, per la prima volta, il regnum hominis. Protagora non solo vuole sollevare il singolo
uomo in rapporto con gli altri, ma l’uomo in sé di fronte alla natura e agli dèi. E tuttavia il sofista non si arresta all’unità
dell’uomo; egli accoglie, anzi accentua il pluralismo del secolo dell’illuminismo; egli non vede solo l’uomo, ma scorge
ancor più chiaramente gli uomini nella varietà dei loro tipi. Così Protagora parla dell’uomo in sé, ma intende anche il
singolo, poiché non ha ancor veduto il contrasto tra i due. In verità con uomo intende il soggetto della conoscenza, che
Poiché l’orizzonte dell’esperienza è dinamico e non c’è un criterio assoluto di verità, ciò che costituisce un
criterio di conoscenza è un rapporto che si stabilisce tra “logoi” diversi, cioè tra un logos meno valido e un
logos più valido. Il “logos peggiore” si identifica con il contenuto delle percezioni immediate che
corrisponde alla materia scorrevole nella rudimentalità dell’esperienza in cui confluisce. Il “logos migliore”
invece è un’esperienza più universale che si costituisce attraverso la mediazione e il superamento delle
esperienze immediate. Secondo il Maier, ciò che costituisce il problema di Protagora e di tutti i Sofisti non è
tanto un problema di verità ontologica quanto un problema di valore che si riferisce e si estende soprattutto
al campo etico-pratico. In modo analogo l’Untersteiner pensa che il “discorso migliore” sia quello che si
stabilisce sul piano etico, mentre sul piano gnoseologico non è possibile uscire dalla frammentarietà del
“discorso peggiore” e delle esperienze a cui esso si riferisce. Sul “discorso migliore” sarebbe fondato il
mondo delle leggi e delle istituzioni, l’ordine della giustizia, qualcosa che si basa sull’universalità di un logos
che trascende il mobile mondo fisico e instaura un superiore mondo morale. Questo mondo è, secondo
l’interpretazione data dall’Untersteiner al mito di Prometeo nel Protagora, il dono caratteristico che gli dèi
hanno concesso agli uomini.100
Gorgia
Gorgia ha esaltato specialmente il potere della parola. La parola e il discorso sono al centro dell’esperienza umana e
della stessa costituzione del mondo. La storia è determinata dall’influsso persuasivo della parola. La parola, infatti,
spinge gli uomini a compiere determinate scelte e ad agire di conseguenza. Lo dimostra l’episodio della guerra di Troia,
causata dalla scelta di Elena, indotta dal discorso di Paride. Esiste solo ciò che può essere ricondotto all’ambito e al
dominio della parola. E ciò consiste nel complesso delle esperienze umane, in ciò che gli uomini fondano con la loro
attività. Invece ciò di cui non può parlare non si può dire né che è e né che non è. Perciò sono infondati tutti i discorsi
sull’essere e sul non-essere. L’ontologia non è possibile e legittima in quanto scienza. L’impossibilità di ricondurre
l’essere al discorso rappresenta il grande limite (tragico) dell’uomo.101
egli, senza distinguere se come essere inteso in senso generale o in senso individuale o piuttosto tutte e due a un tempo,
vuole sollevare al disopra degli oggetti” (Gesch. Phil., pp. 704-707).
100
Cfr. Protagora, 317 b sgg.: “- Io quindi ho seguito il metodo contrario a quello di costoro, e ammetto di essere
sofista e di educare gli uomini […]. E sì che son molti anni che mi dedico a quest’arte […] O giovinetto, ti sarà dunque
possibile, se diventerai mio discepolo, ritornare a casa migliore […]. Gli altri corrompono i giovani; questi, infatti, che
sono sfuggiti alle scienze tecniche essi li riconducono, sebbene non vogliano, e li gettano in potere delle scienze
tecniche, mediante l’insegnamento del calcolo, dell’astronomia, della geometria e della teoria musicale (e
contemporaneamente gettò il suo sguardo su Ippia); invece chi si presenterà alla mia scuola avrà un insegnamento che
non riguarda argomento diverso da quello per cui è venuto. Questa scienza consiste in una capacità di bene consigliarsi
intorno ai beni familiari, allo scopo di amministrare nel modo migliore la propria casa, e intorno agli affari della città,
allo scopo di essere assai efficace nell’azione e nella parola. - – Io credo che tu parli della scienza politica e che
prometta di rendere gli uomini buoni cittadini. - – Questa appunto, dicevo, è la professione che m’impegno di
professare. - - Col farti proclamare pubblicamente davanti a tutti gli Elleni, col darti il nome di sofista, ti rivelasti
maestro di educazione e di virtù e fosti il primo a pretendere di ottenere un compenso per questo insegnamento – “. Da
questo passo emerge chiaramente come, per Protagora, la vera formazione dell’uomo consistesse nell’educazione
politica e come ad essa si subordinasse l’acquisizione delle competenze professionali specifiche. In primo luogo
bisognava essere buoni cittadini e le abilità tecniche non avevano una funzione efficace senza una chiara visione del
modello di società politica in cui inserirsi e operare. In questo senso lo Jaeger ha potuto interpretare il “discorso
peggiore” come quello relativo all’acquisizione delle tecniche e come “discorso migliore” quello relativo alla
formazione politica del buon cittadino. A quali eccessi conduca una tecnica priva di consapevolezza politica è mostrato
dalla situazione attuale, nella quale si ravvisa, appunto, un dominio generale della tecnica come semplice pianificazione
dei mezzi in rapporto a scopi che finiscono per configurarsi come aspetti e forme di quel dominio.
101
La nascita di Gorgia di Leontini (Lentini) si colloca intorno al 480. Secondo Diogene Laerzio, fu discepolo di
Empedocle. Il primo avvenimento cronologicamente sicuro della sua vita si riferisce all’ambasceria che egli guidò ad
Atene per chiedere aiuti a favore della sua città contro Siracusa (Diodoro, XII 50 1 e Pausania, VI, 17 8). L’aiuto non
mancò ma la protesta della piccola Leontini contro Siracusa che diveniva sempre più potente fallì. Quindi lo troviamo
qua e là nelle diverse città del mondo greco, a esercitare la sua professione di maestro di retorica: in Tessaglia presso gli
Alevadi (Menone, 70 a-b), in Beozia e ad Argo, frequentemente a Delfi e ad Olimpia, dove in occasione delle feste
pronunciava applauditi discorsi (Filostrato, Pausania VI, 17, 8). Trascorse gli ultimi anni della sua vita in Tessaglia,
presso Giasone tiranno di Fere. Morì a 109 anni. Ebbe numerosi scolari: Menone, Aristippo l’Alevade, Isocrate,
Eumolpo, Crizia, Alcibiade, Tucidide, Pròsseno, Polo di Agrigento, Sicimnio, Protarco, Alcidamante di Elea. Sulla
successione cronologica delle opere i critici sono discordi: 1) Encomio di Elena; 2) Apologia di Palamede: il Maas la
considera posteriore alla precedente. Lo Schupp ritiene che i discorsi sono posteriori allo scritto sull’essere del 444; Del
La dottrina di Gorgia oscilla tra un interesse verso il problema dell’essere (problema ontologico derivato
dal naturalismo metafisico) e un prevalente interesse retorico. All’incrocio troviamo un significativo
orientamento verso il problema dell’arte e della poesia. Gorgia dimostra che ciò che noi consideriamo come
una struttura dell’essere (necessaria) è piuttosto un orizzonte creato dalla forza dell’arte e comunicato
attraverso la suggestione esercitata sull’anima.
L’Encomio di Elena contiene già i presupposti della concezione gorgiana intorno all’essere. Gorgia
immagina di difendere Elena dall’accusa di avere abbandonato il focolare domestico, Egli dimostra che a ciò
Elena è stata indotta da forze superiori e da circostanze inevitabili. Espone perciò “le cause, per le quali era
naturale che avvenisse la partenza di Elena alla volta di Troia”. Ecco quelle cause: “o per decisione
dell’Evento (Destino) o per ordine degli dèi, o per decreto della Necessità attuò quello scopo, o rapita con
violenza o persuasa dalla parola”. In effetti, dunque, quell’avvenimento è condizionato da una legge
superiore alle capacità di comprensione dell’uomo: dalla legge divina del Destino, incomprensibile per la
ragione. Questa legge che coincide con la profonda struttura della totalità dell’essere sfugge a qualsiasi
comprensione razionale. Strumento o via di una certa comprensione dell’ordine totale dell’essere è l’arte che
attinge quasi la parola degli dèi. Gorgia attribuisce, in questo senso, un immenso potere alla parola: e questa
maniera d’agire della parola si potrebbe chiamare “oscura persuasione” (correntemente “inganno”, “apate”).
Si tratta di una forza travolgente, immensamente superiore a quella del chiaro ragionamento e infinitamente
trascendente la comune comprensione umana. I poeti tragici consideravano questa facoltà di persuadere
ingannando come un attributo della divinità. Gorgia la riporta piuttosto alla sfera dell’arte, ove egli pensa
che si eserciti l’influsso di una forza superiore, irrazionale e demonica.
Illuminato così il carattere “oscuro”, “irrazionale” del mondo, Gorgia nell’Apologia di Palamede insiste
sulla situazione dell’uomo riguardo alla verità. Naturalmente la verità non entra nella sfera del pensiero e
del ragionamento dell’uomo; e se attraverso la suggestione dell’arte il logos può assumere un carattere di
universalità, nel momento in cui si determinano situazioni sentimentali identiche nei diversi spettatori, non
così può dirsi nel caso che il logos voglia comunicare una verità: in realtà attraverso la molteplicità dei
discorsi si rivela una verità tutt’altro che univoca. L’accusa di Elisse contro Palamede si rivela una mera
presunzione, fondata su supposizioni piuttosto che sulla effettiva realtà. Infatti Palamede può contrapporre
una tesi opposta. E ad ogni modo la verità rimane lontana. L’Apologia di Palamede mette in luce il carattere
tragico dell’esistenza umana: l’impossibilità di ancorarsi a un criterio di verità getta l’uomo in un groviglio
di contraddizioni, di antinomie inevitabili. Non c’è situazione umana che possa dirsi autentica, non c’è
umano discorso in cui risplenda la luce della verità. Ne deriva una concezione metafisica che riflette quella
caratteristica dimensione dello spirito greco ai tempi dello straordinario fiorire del pensiero tragico.
Questa concezione è espressa nell’opera Intorno al non ente e alla natura. Il contenuto di quest’opera ci è
tramandato da Sesto. Gorgia dimostra tre proposizioni fondamentali, strettamente connesse e il cui
svolgimento ha una ferrea consequenzialità logica. La prima è che nulla è, la seconda afferma che anche se vi
è un’esistenza, non può venire rappresentata, la terza che se anche può venire rappresentata, con può
certamente essere comunicata e spiegata agli altri. Ed ecco la dimostrazione della prima proposizione: se vi è
un’esistenza, esiste l’ente o il non ente, o entrambi; ora è evidente che il non ente non esiste; se esiste l’ente, è
eterno o generato: se è eterno non ha principio ed è infinito, dunque indeterminato, in nessun tempo e in
nessun luogo; se è generato, deve esserlo o dall’ente o dal non ente, condizioni entrambe assurde; infine
l’ente non può essere considerato né come uno né come molteplice. La seconda proposizione è dimostrata
mettendo in rilievo la differenza tra l’essere e il pensiero: perché l’ente sia pensabile, bisogna che il contenuto
del pensiero coincida con l’ente medesimo; invece è chiaro che si tratta di termini diversi: la conseguenza è
che “se i contenuti del pensiero non sono ‘esistenti’, quello che esiste non è pensato”. La terza proposizione
mette in rilievo l’impossibilità che ciò che è rappresentato sia anche comunicato: si osserva che la
comunicazione avviene attraverso la parola, mentre i contenuti sono relativi ai tipi di sensazione, sono cioè
rappresentazioni visive, uditive e così via. D’altra parte una cosa è la parola e un’altra cosa è il pensiero.
Grande colloca il “Palamede” intorno al 415, in quanto si può supporre che sia stato suggerito dall’omonima tragedia di
Euripide, che è di quell’anno. 3) Epitaffio: probabilmente è ispirato da precise occasioni politiche e non è un semplice
esercizio epidittico; potrebbe riferirsi a un’esplosione di patriottismo, coincidente con l’entusiasmo provocato dai piani
di Alcibiade dopo la pace di Nicia (421). 4) Discorso olimpico, pronunciato a Olimpia per lanciare il piano di concordia
tra le città greche contro il barbaro, in nome di un ideale panellenico (intorno al 392). 5) Intorno al non-ente e alla
natura, lo scritto teoretico tramandato in due versioni dossografiche, una dovuta a Sesto Empirico (Adv. Math., VII 6587) e l’altra all’anonimo autore dello pseudoaristotelico De Melisso, Xenophane et Gorgia.
Quest’ultimo non può mai venire ricondotto (ridotto) a quella. Dunque l’ente pensato non può essere
comunicato.
La critica di Gorgia coglie nel segno e mette in rilievo tutte le difficoltà della metafisica basata
specialmente sul principio parmenideo dell’unità dell’essere e sull’identità di essere e pensiero. Questi,
infatti, erano i capisaldi della metafisica. Una scienza dell’essere, infatti, presuppone, innanzitutto, l’unità del
reale e la negazione di ogni molteplicità all’interno del principio; e d’altra parte presuppone la pensabilità
piena dell’essere, l’intelligibilità di ogni esistenza. Gorgia intende dimostrare che in realtà la metafisica esula
dalle possibilità del pensiero umano. Infatti noi possiamo dimostrare coi mezzi della logica sia l’essere che il
non essere. Il nostro pensiero è molteplice e perciò di natura opposta a quell’essere unico che dovrebbe
dimostrare. Non rimane che affidarsi ai poteri della mente, che non sono, peraltro, quelli che riguardano la
sola sfera logica, bensì si estendono al potere irrazionale della parola stessa. La metafisica, in questo senso,
sarebbe possibile su questo piano più propriamente artistico ed estetico che riguarda la comunicazione di
emozioni, di stati d’animo, di sentimenti. A tale livello Gorgia riconosce quasi un’intersezione con il potere
della parola divina. La parola diventa annuncio, profezia, rivelazione: qualcosa che ha a che fare con la sua
dimensione misteriosa. Gorgia, nel momento in cui affermava l’efficacia pratica della retorica (considerata
come la vera molla dell’azione), metteva in rilievo i limiti della parola umana e lasciava intravedere i confini
per i quali, nell’ambito della parola stessa, passano la natura umana e quella divina. Sembra che in questo
senso vada letta la dottrina di Gorgia sulla verità. Questa sarebbe possibile solo sulla base della verifica del
pensiero umano mediante la parola della divinità.
Natura e convenzione nei Sofisti minori: Callicle, Ippia, Antifonte, Prodico.
Il dibattito nell’ambiente dei Sofisti ha riguardato specialmente il modo di concepire i principi dell’ordine sociale: per
Trasimaco e Callicle la legge dipende dalla capacità di imporla e dunque dal “più forte”, per Ippia e Antifonte dipende
dai caratteri universali della natura umana.
Contro le tendenze relativistiche di Protagora e Gorgia, altri Sofisti affermano l’esistenza di un criterio
assoluto, giuridico e morale, coincidente con una legge di natura, universale e non soggetta a variazioni.
Questa legge si identifica col diritto del più forte (e quest’ultimo è la classe dominante per Trasimaco, il
superuomo audace e tiranno per Callicle) oppure si esprime come principio di eguaglianza e fratellanza
umana, al di sopra delle differenze di nazione e di classe (Ippia e Antifonte).
Nella seconda metà del V secolo, in seguito agli sviluppi concettuali messi in atto dalla prima generazione
dei Sofisti, si articola la discussione intorno al primato della natura o della legge nell’ambito della
convivenza umana. Il motivo fondamentale è la scoperta del valore autonomo dell’individuo per se stesso,
indipendentemente dallo spazio pubblico della vita politica.
Secondo la prospettiva tradizionale, l’uomo si attua nello spazio politico (nello stato) e specialmente
attraverso azioni degne di memoria. La riflessione dei Sofisti conduce alla scoperta della “natura” dell’uomo
come condizione originaria, anteriore alla costituzione della “città”.
Dunque, qual è questa “natura” dell’uomo?E che rapporto si stabilisce tra i diritti connessi a tale natura e i
doveri civili, imposti dalla vita politica e dall’organizzazione sociale? Inoltre: come rifondare i principi della
convivenza politica, in riferimento a questa condizione naturale? Forse occorre mettere in discussione la
stessa validità della legge politica, come contraria alla natura dell’uomo? L’indagine si allarga fino a
riguardare l’origine storica dello stato e lo sviluppo delle forme di vita politica.
Intorno a questi problemi i Sofisti danno soluzioni diverse.
1) Secondo Protagora, allo stato naturale gli uomini sono stati dotati solo di capacità “tecniche”; dunque
incapaci di organizzare una efficace vita comune; infatti, fuori di un contesto politico, basato sul
riconoscimento dei diritti reciproci, l’uso di quelle capacità è inefficace. Gli uomini, perciò, si sono associati,
mettendo reciprocamente a disposizione le capacità specifiche (ed è Zeus che per salvare gli uomini concede
loro le “virtù politiche”); e in tal modo attuano una condizione di vita ottimale.102
2) Secondo Trasimaco, la giustizia è basata sulla legge stabilita dalla classe dominante per il bene
comune.103
3) Secondo Ippia, invece, la giustizia sta nella condizione naturale, che è condizione di uguaglianza tra gli
uomini.104
102
103
338).
Protagora, 323-26.
“Io affermo che il giusto non è altro che l’utile del più forte […] ciò che conviene al governo costituito” (Rep.,
4) Secondo Antifonte, la condizione naturale è originaria radice di fratellanza umana (tutti gli uomini sono
uguali per natura e hanno gli stessi diritti; la legge, invece, introduce la disuguaglianza).105
5) Secondo Crizia, legge e religione sono dei rimedi necessari allo stato di ferinità naturale.106
6) Secondo Callicle, la legge è un freno inventato dai deboli per contrastare il diritto dei più forti; lo stato
di natura, infatti, è la condizione del prevalere del forte sul debole, e tale stato è preferibile a quello creato
dalla legge (che è innaturale).107
7) Secondo l’Anonimo di Giambico, la legge non è per natura, ma al di fuori della legge non vi è salvezza
per l’uomo.108
104
Protagora, 337.
Fr. II del Papiro di Ossirinco.
106
Crizia, Sisifo, fr. 25 (cfr. Frasnedi, pp. 150-51).
107
Gorgia, 482-84.
108
Giambico, Epistola sulla concordia, 6.
105
CAPITOLO V
Socrate
Socrate, condannato a morte con l’accusa di “empietà” ma in realtà per le critiche che egli muoveva alla
classe politica del tempo, può essere considerato il simbolo della filosofia come ricerca della verità e impegno
morale. Egli esercitava la professione di “maieuta”, l’arte della madre Fenarete, aiutando le menti a
“partorire” da sé il sapere, piuttosto che apprenderlo passivamente; perciò guidava i suoi interlocutori a
problematizzare e cercare, fino alla scoperta dei concetti universali, cioè alla comprensione della natura
propria delle cose.
Il problema storiografico
Socrate non scrisse nulla e quello che sappiamo di lui lo dobbiamo ai suoi discepoli, Platone e Senofonte.
Il primo, in particolare, ha dedicato la sua vita a sviluppare, nei suoi dialoghi, il discorso socratico, portando
l’indagine filosofica ai suoi più alti e maturi livelli.
La realtà storica del filosofo, fondata su scarsi documenti contemporanei, è stata perfino messa in dubbio
da alcuni studiosi, che hanno interpretato la figura di Socrate come un’espressione della cultura ateniese,
che, al momento della sua “acme”, ne fece un simbolo della sua storia e specialmente del suo ideale e, anche,
delle sue contraddizioni.109
Nato ad Atene nel 470/69, Socrate si era dedicato fin da giovane alla missione “politica” di riformare lo
stato ateniese impiantando i princìpi della giustizia e della morale nella coscienza dei cittadini: egli, pertanto,
deve essere visto come l’espressione del massimo sforzo civile ed educativo della “paideia” ateniese. In
realtà, Socrate si attribuiva un compito che fino allora era stato prerogativa dei “politici”, che si erano
avvicendati nel governo della città e che, in generale, non avevano dato prova di buon governo: così si
comprende tutta la critica socratica della realtà politica ateniese, dominata specialmente dall’ambizione
personale, dall’uso privato della cosa pubblica, dalle eccessive lotte interne per la conquista del potere. Si
trattava di instaurare il governo del “bene” come principio universale dell’agire umano, eliminando tutte le
passioni e gli impulsi egoistici e particolari. Socrate intendeva portare l’idea dell’uomo nella città e
realizzarla mediante le istituzioni politiche.
Ma l’opera di Socrate veniva a svolgersi in un contesto non favorevole. Gli uomini che nel 403
restaurarono la democrazia intendevano rinnovare lo spirito della città antica, strettamente unita intorno alle
tradizioni patrie; e in questo senso un particolare rilievo era acquistato dalla restaurazione religiosa, dopo la
grande ventata illuministica recata dai sofisti. Socrate richiamava l’attenzione sulla necessità di una riforma
religiosa in senso universalistico e partendo dall’interiorità della coscienza come sede originaria della
fondamentale idea della divinità: che sia la divinità, cioè, non è tanto attestato dalle diverse tradizioni
religiose e non è espresso dalle tante divinità onorate nelle varie città, bensì è iscritto nella coscienza umana;
anzi, la divinità, secondo Socrate, parla nell’interiorità della coscienza a chi sa ascoltarne la voce. Si
profilavano, così, i termini per consentire al giovane poeta tragico Meleto, sostenuto da Anito e da Licone, di
presentare all’arconte re la sua accusa: “Socrate commette reato corrompendo i giovani e non riconoscendo
gli dèi in cui la città crede e introducendo nuove e diverse divinità”.
E’ vero che tra le testimonianze ve ne sono alcune che mirano a mettere Socrate in cattiva luce. Aristosseno
di Taranto dice di avere appreso da suo padre, Spintaro, che lo conobbe, tutte le maldicenze che egli si
preoccupa di riferire: ne viene fuori un Socrate dal carattere difficile, privo di cultura e di princìpi morali,
incline all’ingiuria e alla violenza, lussurioso e, infine, bigamo.110 Secondo il ritratto che ne fa Aristofane nelle
Nuvole, Socrate è un cattivo maestro, che ha una scuola, una specie di pensatoio, per essere ammessi al quale
109
E. Dupréel (La légende socratique et le sourses de Platon, Bruxelles 1922) ha interpretato Socrate come una
invenzione letteraria del nazionalismo ateniese, costruita da Platone e dai “socratici”; O. Gigon (S., Berna 1947) lo ha
considerato come una definizione dell’ideale del “saggio”. Ma gli studi più recenti hanno restituito a Socrate i
lineamenti della personalità storica (Cfr., ad esempio, V. de Magalhaes-Vilhena, Le problème de S.: le S. historique et le
S. de Platon, Parigi 1952; R. Mondolfo, S., Buenos Aires 1955).
110
Diogene Laerzio, II, 20.
occorre pagare un contributo, e ove si trovano alunni ridotti alla condizione di esseri “mezzo morti”, quasi
pure anime di oltrepassati, e poi sporchi, straccioni, che non hanno nulla mangiare. A quella scuola si
studiavano le scienze fisiche e la retorica: tra l’altro, si ammetteva l’aria come principio delle cose e del
pensiero e si considerava il “logos” come un dio; Socrate era un sofista che insegnava i trucchi della retorica
per fare trionfare il discorso “debole” o l’“ingiusto” su quello “forte” o sul “giusto”.111 Questo Socrate,
fautore della dottrina di Diogene di Apollonia, era un fisico eclettico e un sofista.
Ma certo gli elementi per una biografia di Socrate si possono trarre, più proficuamente, dagli scritti di
Platone e di Senofonte. Socrate apparteneva alla tribù Antiochide e, in questa, al demo di Alòpece; suo
padre, Sofronisco, era forse scultore, e sua madre, Fenarete, un’abile levatrice. Dopo avere studiato le
dottrine dei fisici, non soddisfatto del determinismo professato in esse, si rivolse allo studio dell’uomo. Una
spinta al suo pensiero dovette venire dalla conoscenza della filosofia di Parmenide. Uno dei suoi discepoli,
Cherefonte, chiese alla Pizia di Delfi se vi fosse qualcuno più sapiente di Socrate; e la risposta fu negativa.
Perciò Socrate stesso cercò di capire le ragioni di una tale affermazione e la trovò nel fatto che egli avesse la
consapevolezza di “non sapere”: infatti tale consapevolezza era la premessa per qualsiasi saggezza. Liberare
la mente dalla false opinioni, rendersi conto della propria fondamentale ignoranza, affrontare, dunque, il
problema della costruzione di un vero sapere. Su un tale sapere, infatti, doveva essere ricostruita la città
(sulla scienza di ciò che è giusto). Il ginnasio era la sede preferita dal filosofo: là Socrate era capace di passare
giornate intere a discutere coi giovani, con l’intento di educarli alla vera scienza, liberandoli dalle false
opinioni di cui era ancora ampiamente impregnata la cultura corrente. Poi c’erano gli scolari che lo
accompagnavano quasi sempre nella sua inarrestabile attività di indagatore delle coscienze: Critone,
Apollodoro, Fedone, Eschine; e altri che già appartenevano a qualche altra scuola, come i pitagorici Scimmia
e Cebete, i sofisti Antistene e Aristippo, l’eleate Euclide.
Socrate si impegnò anche nella vita civile: non solo militò come oplita a Potidea (432-429), ad Anfipoli
(422) e Delio (424), ma fece parte del Consiglio dei Cinquecento e della commissione dei pritani che
condannò gli strateghi delle Arginuse.
Sintesi su Socrate
Socrate intendeva il sapere come strumento di comportamento morale. Chi conosce il bene e le virtù si comporta
necessariamente in conformità a tali principi, mentre l’ignoranza è fonte di errore e di immoralità. Platone ha mitigato
questa forma rigorosa ed estrema di “intellettualismo etico”, rilevando che condizione essenziale del comportamento
morale è il possesso di una fondamentale saggezza pratica.
Socrate è assurto nella storia a simbolo della filosofia, per essere stato condannato a morte proprio in
ragione della sua professione di libero indagatore e critico della società del suo tempo. In un tempo in cui
Atene tentava di ristabilire le istituzioni tradizionali e di rafforzare i culti religiosi dei padri, il domandare
socratico, volto a minare ogni presunta certezza attraverso la ricerca della verità. appariva pericoloso per la
stabilità politica cittadina. Venne accusato di empietà e avrebbe potuto sfuggire alla condanna scegliendo
l’esilio; ma egli ritenne che il suo dovere morale fosse quello di rimanere fedele alla sua condizione di
cittadino ateniese e accettò serenamente la morte. La sua figura è stata poi esaltata da Platone, che ne ha fatto
il protagonista pressoché unico dei suoi dialoghi. Socrate è, da allora, il filosofo per eccellenza, convinto che
la verità sta al fondo dello spirito e che bisogna indagare, cercare insieme, dialogare ininterrottamente, per
portarla alla luce. Socrate stesso paragonava la sua attività a quella della madre, Fenarete, che era levatrice:
anch’egli, infatti, aiutava le menti a partorire i concetti, cioè i termini della conoscenza vera e universale, che
dovevano sostituire le opinioni mutevoli e molteplici degli uomini.
La sua attività consisteva nel guidare i suoi interlocutori (per lo più giovani) a trovare i concetti relativi
alle varie cose. Un concetto fondamentale era quello di “virtù”. “Che cos’è la virtù?” e per le risposte che
venivano date rilevava le insufficienze e i limiti. Così via via si procedeva insieme fino a scoprire il termine
universale, per cui, ad esempio, non si definiva più la virtù in rapporto a un particolare punto di vista (quale
poteva essere quello della fedeltà alla patria), bensì, appunto, si dava quella definizione che riguardava la
virtù in sé, sotto ogni punto di vista e in rapporto a ogni circostanza o situazione possibile. Perciò Aristotele
attribuisce a Socrate la scoperta del concetto universale, come termine della conoscenza vera.
111
Apologia di Socrate, 18 b: “Ma quelli [tra gli accusatori] sono più terribili che […] tentano di persuadervi […] che
c’è un certo Socrate, un saggio, che investiga sulle cose celesti e compie ricerche su tutte quelle sotterranee e che rende
più forte il ragionamento più debole”.
La principale scienza, per Socrate, riguarda il complesso delle virtù, dunque ciò che meglio per l’uomo,
cioè il bene. Il Bene diventa la suprema categoria metafisica, che Socrate pone al posto dell’essere parmenideo,
come principio della realtà, oltre che fattore della felicità umana. Esso si configura come l’area stessa
dell’attività umana e politica, il principio e la legge dell’agire, che così si connota come agire morale.
Condizione per agire secondo questo principio è, secondo Socrate, la conoscenza della natura umana e delle
modalità della sua realizzazione e manifestazione. Compito dell’individuo è conoscere e fare il bene: infatti
chi conosce il bene, è consapevole della sua natura di principio morale e dunque agisce conseguentemente in
conformità di tale principio. E’ stato chiamato intellettualismo etico questo orientamento teorico socratico,
secondo cui per fare il bene è necessario e sufficiente avere la conoscenza di esso. Si tratta di una profonda
connessione di conoscenza e morale, invece, e non di una posizione solamente intellettualistica. La
conoscenza si risolve nell’azione morale e politica, sulla base della originaria e costitutiva unità dell’uomo.
Non è vera conoscenza quella che non si tramuta in regola dell’agire; né vi può essere vera moralità senza la
consapevolezza della natura e del fine propri dell’uomo. Socrate intendeva fondare una cultura in cui la
conoscenza si compenetrasse nella vita politica, nella forma della stessa vita di cittadino. Si trattava
dell’ideale proprio della grecità: della cultura come “paideia”, educazione dello spirito e norma della vita
pratica. In termini attuali, si potrebbe dire che così viene messo in rilievo il ruolo che assume la formazione
nello sviluppo di una società bene ordinata in funzione del massimo bene comune.
Il significato storico e politico del pensiero di Socrate
L’intero pensiero di Socrate si riassume nella questione del rapporto tra il filosofo e la città. Socrate
intende porre la riflessione filosofica, fino allora specialmente rivolta alla elaborazione di un modello
“scientifico” generale di interpretazione dell’universo reale (o della realtà universale), al servizio della
comunità e del suo ordinamento. Questo, del resto, era il significato più proprio che la filosofia assumeva ad
Atene, che si può considerare la città emblematica di tutta la concezione politica greca e nella quale la cultura
aveva espresso il massimo sforzo, relativamente alla impostazione e alla soluzione del problema politico.
La cultura greca tendeva alla ricerca di una soddisfacente scientificità: essa si caratterizzava per lo spirito
scientifico che la animava e ne improntava tutte le manifestazioni. Era inevitabile, perciò, che anche la vita
politica rientrasse in questa prospettiva, cioè si ponesse sul piano del punto di vista scientifico. E ciò avviene
proprio con Socrate. Per questo motivo si è rilevato anche l’eccessivo razionalismo e intellettualismo
socratico. Infatti, allorché lo spirito scientifico (necessariamente razionalistico) invade la sfera politica, cioè
una sfera ampiamente attraversata da tensioni di varia natura e provenienza (sentimenti, passioni, interessi,
opportunità, equilibri e opposizioni diverse), la cultura greca raggiunge il massimo livello nel processo di
razionalizzazione del reale. Ai Sofisti tale sfera sembrava più naturalmente consegnata al dibattito oratorio,
all’arte del persuadere: la retorica, infatti, secondo quanto efficacemente rilevato da Gorgia, domina gli
animi, e gli uomini politici tiranneggiano i cittadini con la potenza della parola, con l’enfasi dei loro discorsi.
Socrate intende sottrarre la sfera politica al dominio della retorica, per portarla nell’ambito della scienza.
La città doveva essere rifondata sulla scienza della giustizia. Ma perciò occorreva procedere a un’ampia,
radicale opera di rieducazione dell’intera comunità: occorreva liberare i cittadini dalla soggezione al discorso
retorico, disponendo lo spirito di ciascuno alla ricerca della verità, instaurando così il dominio della ragione,
del “logos”. E indubbiamente, di questa tendenza il massimo responsabile e protagonista è Socrate: il quale
ha testimoniato con la morte la sua fede nella scienza e ha espresso la convinzione che la città giusta va
costruita sulle fondamenta del sapere, sulla certezza della verità. Egli, a differenza dei Sofisti, si dichiarava
non-sapiente, proprio per mettere in rilievo l’importanza dell’atteggiamento di ricerca nel processo di
formazione politica della persona. Gli ateniesi dovevano, in primo luogo, acquistare la consapevolezza di
non essere pervenuti ancora alla scienza del bene, dunque di orientarsi ancora, nello sviluppo dei rapporti
intersoggettivi, in base a opinioni approssimative e in gran parte errate. La cultura politica dei greci risaliva,
infatti, in massima parte alla tradizione poetica, specialmente a Omero, il quale giustamente era considerato
“il grande educatore dell’Ellade” e costituiva la massima autorità in rapporto al giudizio sull’uomo: i suoi
“eroi” erano modelli di comportamento, di umanità, di intelligenza, di equilibrio e di saggezza pratica. Ma
Socrate non era d’accordo con tale convinzione: i poeti non sono portatori di un’attendibile scienza razionale,
piuttosto sono gli interpreti di un’opinione dettata dal sentimento, dall’intuizione confusa, dell’esperienza
contraddittoria; essi, come è rilevato nel dialogo “Ione”, si esprimevano in quanto ispirati da qualche
divinità, in uno stato di “divina insania”, di un invasamento che li rendeva inconsapevoli di quanto essi
stessi andavano dicendo. I poeti erano incompetenti in arti intorno alle quali pure discutevano; dunque
divulgavano opinioni false e contribuivano a fondare la città sulle passioni e sul loro controllo mediante la
retorica. Socrate dimostra come la retorica sia del tutto inadatta a fondare i rapporti tra i cittadini. La retorica
è nemica della verità: essa, piuttosto che richiedere la rigorosa rispondenza del discorso alla realtà, pretende
risolvere tutti i problemi attraverso la persuasione, proclamando che è vero ciò che la maggioranza dei
cittadini approva e ciò che il discorso riesce a dimostrare tale.
Socrate apporta una rivoluzione nell’intera cultura greca: egli intende sottomettere tutti gli aspetti della
vita umana e civile al sapere scientifico, alla rigorosa indagine concettuale. Egli instaura il metodo della
ricerca della verità, del sapere concettuale, di quel sapere, cioè, che è rigorosamente costruito attraverso l’uso
dell’intelletto, mediante un procedimento interamente razionale. Il sapere non può essere il frutto
dell’intuizione vaga , dell’intuizione soggettiva, dell’esperienza molteplice: esso non può essere costruito
attraverso l’arte della retorica. Questa ha una semplice funzione esortatoria e persuasiva, incide sul
sentimento, sulle passioni, magari indirizzandole a fini vantaggiosi, frenandone gli eccessi e riportandole a
fini nobili e a criteri di misura e di armonia. Ma il criterio della retorica è assolutamente arbitrario e non
consente nessuna certezza.
Il sapere, secondo Socrate, è fornito di una fondamentale evidenza razionale: esso è espressione del
“logos”, frutto del ragionamento, e ha la sua base nel concetto. Come è noto, il concetto è una nozione
universale, valida per tutti i soggetti umani, dunque che va oltre l’esperienza soggettiva; esso instaura, per
ogni ente o situazione reale, una nozione che riguarda la natura stessa dell’ente (ciò per cui esso è se stesso e
si differenzia da ogni altro). Non, dunque, il concetto è vero perché è accettato da una comunità di persone,
bensì è accettato da tutti in quanto è vero. Socrate è ritenuto (sulla base dell’autorità di Aristotele) l’inventore
del metodo di costruzione del sapere concettuale: il concetto comprende (da “cum capio”, prendo insieme)
l’insieme dei caratteri comuni che appartengono a una molteplicità di enti (ad esempio, ciò che è comune a
tutti i tavoli esistenti, nonostante la molteplice varietà di tavoli). Si considerano gli enti per il loro “essere”
proprio e non per i caratteri accidentali che li differenziano.
Questo tipo di sapere concettuale e universale è perseguito da Socrate nel campo della morale. L’indagine
socratica verte intorno all’essenza della virtù: essa intende fondare, infatti, una scienza del comportamento
umano, come presupposto e base della rifondazione della città su criteri scientifici e razionali. Occorreva
cogliere con la ragione la nozione di quel principio che è il fondamento dell’agire umano. Tale principio è il
Bene: un principio universale, una specie di “arké” del mondo umano (e forse non solo di questo, bensì
dell’intera realtà). Socrate perciò non fa che proseguire sulla via tracciata dai primi filosofi; solo che questi
avevano rivolto la loro indagine intorno all’arké dell’universo fisico, al principio di tutti i processi naturali
(compresi quelli umani), mentre egli si rivolge al mondo umano e politico e si chiede, pertanto, qual è il
principio, l’arké, della vita politica, il principio fondamentale che deve ispirare e dare significato a tutta
l’attività umana. Questo principio è il Bene. E gli uomini devono conseguire questa scienza fondamentale, se
vuole veramente attuare la sua natura e conseguire la felicità (quella condizione che è connessa alla
realizzazione del suo essere). Questo sapere costituisce il presupposto dell’agire morale. Socrate muove da
questa esigenza di fondazione di un sapere che riguardi il principio dell’agire umano. Il Bene è il principio in
base al quale gli uomini devono comportarsi e al quale devono conformare ogni loro atteggiamento e ogni
manifestazione del loro spirito. Sia che si tratti di vita politica o di indagine scientifica o di esperienza
religiosa o di attività materiale, sempre tale principio deve essere tenuto presente e seguito come motivo
ispiratore di ogni attività. Nell’ambito di questa ricerca fondamentale si deve articolare l’intera indagine
filosofica. Questa deve riguardare il mondo dell’uomo, il significato dell’attività umana, il senso della
complessa opera attraverso la quale gli uomini progrediscono nella storia.
Il sapere socratico ha una finalità essenzialmente pratica. In ciò sta il significato dell’intellettualismo etico,
che è stato generalmente considerato come il limite del pensiero di Socrate. La scienza del Bene e della virtù
si converte, per la sua stessa costituzione, in comportamento morale; e ogni attività moralmente significata si
basa sulla consapevolezza intorno al Bene. Per Socrate il nesso di scienza e morale è inscindibile: tanto da
pervenire alla conclusione che il malvagio compie il male per l’ignoranza del Bene e il buono agisce
rettamente in quanto possiede la scienza del Bene. Si tratta di cercare di comprendere la sintesi che è
espressa e attuata nella connessione socratica di sapere e virtù, di essere e bene. Si può dire che l’essere che
Socrate assume come oggetto della riflessione filosofica è l’uomo. L’uomo, infatti, è l’ente il cui essere
coincide col bene e questo non si configura come una realtà data bensì, piuttosto, come un compito da
attuare. L’essere che non è tanto realtà data ma dover-esere è il bene stesso, inteso come dimensione etica, che
ha il suo fondamento nel Bene assoluto, considerato l’arké (in senso ontologico). La morale umana non
esaurisce la realtà cosmica, ma s’iscrive in essa e in sé la rispecchia significativamente (simbolicamente).
Platone riconoscerebbe in questa situazione costituita come nesso di morale e metafisica una dimensione
mitologica. Il mito, infatti, può ragionevolmente accostarsi a una situazione che il discorso non chiarisce
interamente. E probabilmente l’intera filosofia di Platone non è altro che lo sviluppo di un tale mito sul
complesso intreccio di pensiero e prassi, di scienza e morale (di etica e sapere).
Le scuole socratiche
L’attività filosofica di Socrate diede luogo a un ampio dibattito che riguardò specialmente i principi dell’etica. In un
periodo di crisi della città greca, con l’emergere di tendenze individualistiche, si sviluppò la riflessione intorno alle
condizioni e alle possibilità per l’uomo di conseguire la felicità e di raggiungere il vero. Oltre alla grande riflessione di
Platone, incentrata sulla rifondazione della città su basi filosofiche, abbiamo tre tendenze di sviluppo del socratismo: 1)
il “naturalismo” individualistico e antiedonistico dei cinici; 2) il sensismo fenomenistico ed edonistico dei pirenaici; 3)
l’eleatismo dei megarici.
La scuola cinica fu fondata da Antistene di Atene, che frequentò Socrate nella maturità, dopo essere stato
discepolo di Gorgia; ma la figura più famosa è quella di Diogene di Sinope, intorno al quale si tramandano
alcuni celebri aneddoti: che vivesse in una botte; che avesse gettato il bicchiere allorché vide un bambino che
beveva nel cavo della mano; che cercasse l’uomo con la lanterna.
Intorno al problema della conoscenza, i cinici professano un sensismo radicale: l’unica fonte di conoscenza è
la percezione; dunque sono valide solo le immagini sensibili, relative alla presenza di oggetti particolari; i
concetti (o idee) sono semplici nomi o termini astratti (famosa l’obbiezione di Antistene a Platone: “vedo il
cavallo, ma non la cavallinità”), per cui di ogni cosa si può dire solo il suo nome proprio, cioè “un solo nome
di ogni singola cosa”.112 Ne derivava come conseguenza l’impossibilità della predicazione: infatti questa implica
l’unione di un nome con un altro che funga da attributo rispetto al primo; così, parlando dell’uomo, vi si
attribuiscono caratteri diversi e diciamo che l’uomo è buono, saggio e così via: “pur supponendo che una
cosa sia una, viceversa la diciamo molteplice e con molti nomi” (invece, a rigore, si dovrebbe solo dire, ad
esempio, che l’uomo è uomo, che il buono è buono, e così via). Insomma i cinici non ammettevano che i
molti potessero essere uno e l’uno potesse in sé accogliere la molteplicità. Ne derivava anche che è
impossibile contraddire e dire il falso: infatti ogni parola esprime il vero e chi dice qualcosa dice l’essere (non
è possibile, cioè, che dica anche il contrario di ciò che dice).
Poiché la definizione implica l’uso di diversi nomi secondo il rapporto soggetto/predicato e si consegue
attraverso un lungo ragionamento, non è possibile definire l’essenza di una cosa, ma si può semplicemente
instaurare un paragone tra cose diverse, mettendo in rilievo l’analogia (ad es. non si può dire “il latte è
bianco”, perché così si stabilirebbe una identità tra i due termini; invece è legittimo dire “il latte e il bianco”,
esprimendo una analogia tra i termini stessi). I composti sno definibili attraverso l’enumerazione degli
elementi semplici, mentre questi sono indefinibili (dovendosi enunciare qualcos’altro di ciascuno di essi).113
Per quanto riguarda la concezione etica della vita, secondo Antistene il fine dell’uomo è vivere secondo
virtù: il modello è Ercole, le cui celebri “fatiche” hanno il significato di testimoniare la forza della volontà nel
dominio dei desideri e dei piaceri. Bene per l’uomo è la libertà dai falsi obiettivi di felicità.114 L’ideale del
saggio è l’autarchia, il bastare a se stesso, il non essere schiavo dei bisogni.115
I cinici, perciò, contestavano le convenzioni sociali e sostenevano la necessità di un ritorno alla natura.116 Ne
derivava il rifiuto delle leggi positive, dei vincoli sociali, della famiglia, delle istituzioni politiche e dello
stato. Inoltre i cinici ammettevano la comunione delle donne e dei figli, l’abolizione della schiavitù e di tutte
le barriere tra gli individui, le classi e i popoli.117 E, secondo il principio della fratellanza umana, i cinici non
disdegnavano, anzi cercavano e prediligevano, la compagnia dei reietti e degli emarginati.
112
Aristotele, Metafisica, V, 29, 1024.
Questa tesi di Antistene è riportata da Platone nel Teeteto: “Io credo di aver sentito da qualcuno che dei primi
elementi non si può dar ragione. Può essere nominato ognuno per sé, ma nient’altro si può aggiungere, né com’è né
come non è; perché si dovrebbe attribuirgli essenza e non essenza; e nulla invece deve aggiungere uno che voglia dire
soltanto una data cosa per se stessa” (201-202).
114
A Diogene si fa dire: “A somiglianza di Ercole, protettore della mia scuola, ho domato atleti fortissimi e bestie
ferocissime: la povertà, l’ignominia, l’ira, il timore, il desiderio e la più ingannevole e crudele di tutte, il piacere”
(Dione Crisostomo, Orazioni, IX, I, 105).
115
“Il sapiente basta a se stesso “ (Diogene Laerzio, VI, 11).
116
“Giove punì Prometeo non già, come dice la leggenda, per odio che egli avesse verso gli uomini o per invidia di
qualche loro bene, ma perché, scoprendo per loro e dando loro il fuoco, quegli diede loro insieme il principio e la
cagione della mollezza, del fasto e della corruzione” (Dione Crisostomo, Orazioni, VI, I, 88).
117
“Richiesto Diogene onde fosse, “cittadino del mondo” rispose” (Diogene Laerzio, VI, 63). “Il solo vero stato è il
mondo intero” (Ib., 72).
113
Il fondatore della scuola cirenaica fu Aristippo di Cirene. Dopo di lui, la scuola si divise in tre indirizzi con
Teodoro l’ateo, Eresia il “persuasor di morte” e Anniceris.
Nella teoria della conoscenza, i pirenaici sostenevano il sensismo e il fenomenismo.118 Ne deriva che non
si può parlare di nozioni comuni per i diversi soggetti, in quanto per ognuno sono valide le proprie
sensazioni. I nomi indicano solo sensazioni simili.
La sensazione, oltre che criterio di verità, è anche criterio di comportamento e di valutazione etica e pratica.119
Aristippo distingueva tre stati del soggetto: 1) lo stato di dolore, simile alla tempesta del mare (l’animo è
agitato e scosso); 2) il piacere (che è un movimento lieve, simile a un venticello favorevole); 3) l’assenza di
piacere e dolore, simile alla calma del mare. Egli quindi diceva che la sensazione piacevole è il fine della vita
e che in essa consiste la felicità. Il piacere sarebbe la condizione naturale degli uomini: infatti sempre noi
istintivamente tendiamo ad esso, mentre fuggiamo il dolore. Inoltre, a quanto riferisce Diogene Laerzio, il
piacere particolare è per se stesso desiderabile, mentre la felicità, che consiste in un sistema di piaceri
particolari, è desiderabile non per se stessa ma per quei piaceri.120 Né ha valore il ricordo dei piaceri passati
oppure l’anticipazione di quelli futuri: ma solo il piacere attuale può considerarsi vero. Ne deriva che non
bisogna tormentarsi col rimpianto (del passato) né con la speranza (del futuro), ma occorre cogliere l’“attimo
fuggente” (carpe diem).
Connesso all’edonismo risulta un fondamentale utilitarismo: la ricerca del piacere, infatti, implica il
riconoscimento della previdenza calcolatrice e dei mezzi atti al suo conseguimento. Asd esempio, è errore
avversare le cause spiacevoli di eventi piacevoli: così la ricchezza, che per se stessa non è desiderabile, è
positiva in quanto può produrre piacere.
I cirenaici ammettevano che nella mente è il fondamento dei piaceri spirituali (ad esempio ascoltiamo con
piacere i lamenti degli attori).
La regola della vita consiste nel “dominare il piacere e non lasciarsene dominare”121; con l’avvertenza che
“domina il piacere non chi se ne astenga, ma chi ne usa, senza lasciarsene trascinare”,122
La scuola pirenaica, dopo Aristippo e i suoi immediati successori (suo figlio Arete e suo nipote Aristippo il
Giovane), ebbe tre diramazioni diverse. La prima è quella rappresentata da Deodoro l’ateo, secondo il quale
il fine è la felicità e non il piacere. E la felicità consisterebbe nella prudenza e nella giustizia, nella saggezza
che consente l’indipendenza, il bastare a se stessi senza avere bisogno di amici. Teodoro affermava, inoltre, il
cosmopolitismo.123 Egli professava anche un ateismo integrale, sostenendo che le varie credenze religiose
non sono altro che espedienti cui ricorrono gli uomini incapaci di realizzare il dominio di se stessi.124
Una seconda diramazione è quella rappresentata da Eresia “il persuaso di morte”, detto così per la
concezione pessimistica della vita. La felicità sarebbe assolutamente impossibile, perché è impossibile evitare
118
“Dicono dunque i cirenaici che criterio di verità sono le sensazioni, e che solo queste si colgono e sono vere; ma
degli oggetti che producono le sensazioni nessuno ce n’è che si possa cogliere [nel senso di comprendere, afferrare con
l’intelligenza, tradurre in concetto] e che sia esente da inganno” (Sesto Empirico, Adv. Mathem., VII, 191-95). Perciò
“se per fenomeni (ciò che appare) intendiamo le nostre impressioni, tutti i fenomeni si devono considerare veri in quanto
percepiti; ma se chiamiamo fenomeni le cause produttrici delle impressioni, tutti i fenomeni sono fallaci e impossibili a
cogliere” (Ib.). Secondo questa teoria, gli oggetti sono ridotti a gruppi di sensazioni. In ultima analisi, la realtà consiste
in una molteplicità di relazioni, secondo l’insegnamento di Protagora e dei suoi discepoli, i quali già avvertivano che
ogni cosa è sempre in relazione con qualche altra, giacché “nulla è per se steso una cosa, ma sempre si genera in
relazione a qualcosa” (Platone, Teeteto, 156-57). In questo senso, né l’agente è qualcosa prima d’incontrasi col
paziente, né questo prima d’incontrarsi con quello; analogamente si dice che un ente è in movimento in relazione a un
altro che sta fermo, e così via. Tutto è movimento e relatività e fenomeno.
119
“Le sensazioni sono dunque criteri e fini di tutte le cose: viviamo seguendole, cercando l’evidenza e il
soddisfacimento: l’evidenza nelle altre sensazioni, il soddisfacimento nel piacere” (Sesto Empirico, Adv. Mathem., VII,
199).
120
Diogene Laerzio, II, 87-88.
121
Diogene Laerzio, II, 75.
122
Stobeo, Flor., 17, 18. Perciò Orazio dice: “Ora torno ai precetti di Aristippo, e mi sforzo di sottomettere le cose a
me, non me alle cose” (Epistulae, I, 1, 18). Condizione prima è il dominio delle circostanze esteriori, cioè la libertà del
soggetto rispetto agli altri individui e alle cose (e che – come riferisce Senofonte, Memor., II, 1 – consiste in una via di
mezzo tra il comandare e l’ubbidire). Ma Platone obiettava: “Codesti temperanti non si trovano forse in questa
condizione: che sono temperanti per intemperanza? Giacché per paura di privarsi di altri piaceri e per desiderio di
averli, si astengono da taluni, dominanti come sono da quegli altri. E mentre chiamano intemperanza il lasciarsi
dominare dai piaceri, in realtà accade che dominano alcuni piaceri perché sono dominati da altri” (Fedone, 68-69).
123
Diogene Laerzio, II, 98, 99.
124
Discepolo di Teodoro è stato Evemero, famoso per la tesi secondo cui le religioni avrebbero avuto origine da
uomini illustri e potenti che si sarebbero attribuiti natura e prerogative divine.
i mali fisici e i turbamenti dello spirito. Ne deriva un atteggiamento di indifferenza rispetto alla vita stessa:
sicché vita e morte possono essere ugualmente desiderate; né rispetto alla felicità sono influenti le condizioni
di ricchezza o povertà, di libertà o schiavitù, di nobiltà o di oscurità di nascita, di gloria o di infamia e così
via. Pertanto Eresia invitava a non ricercare beni ma solo a evitare i mali, scegliendo l’indifferenza rispetto a
ogni “valore”.125 Ne derivava un fondamentale egocentrismo, sia pure accompagnato da indulgenza e
benevolenza per gli altri.126
Infine troviamo la posizione di Anniceris, secondo il quale “non c’è un fine determinato per tutta la vita,
ma ce n’è uno proprio per ogni azione, cioè il piacere che nasce dall’azione stessa”.127 In contrapposizione al
radicale individualismo degli altri pirenaici, Anniceris ammetteva il valore della simpatia verso gli altri, e
dunque l’amicizia e l’amore per la famiglia e la patria. Il piacere deriverebbe anche dall’incontro tra gli
uomini e dalla reciproca esperienza del piacere stesso.
La scuola megarica fu fondata da Euclide di megera ed ebbe come suoi altri rappresentanti Eubulide,
Diodoro Crono, Alexinos e Stilpone. Quest’ultimo anticipò le tesi scettiche di Pirrone.
Euclide fuse la dottrina di Socrate con l’eleatismo, cioè la tesi dell’unicità del bene e della virtù con quella
dell’unità fondamentale dell’essere. Egli, pertanto, trasferì sul piano etico la metafisica eleatica, dando un
fondamento ontologico all’etica socratica. Come conseguenza ne derivava la negazione del male, identificato
col non-essere.
In conformità col pensiero aleatico, Euclide considera come del tutto ingannevoli i dati sensibili e afferma
che la verità è conseguita dalla sola ragione. Le cose sensibili, dunque, non sono altro che apparenze, che si
risolvono nello stesso flusso delle sensazioni (in modo che non può dirsi che abbiano una qualche realtà
all’infuori di queste). Invece le idee della ragione, in quanto dotate di stabilità, sono le uniche veramente
reali. Il divenire sarebbe passaggio continuo da un opposto all’altro, da una qualità a un’altra, da una certa
dimensione a una certa altra. Per comprendere questo passaggio, bisognerebbe trovare il punto preciso in
cui esso si compie; ma ciò è impossibile, poiché, per quanta si vada avanti nello sminuzzamento (analisi), non
si riesce a trovare il punto in cui avviene il passaggio da una condizione reale e un’altra (poiché, in realtà,
tale passaggio avviene in modo graduale e continuo). Ne deriva l’impossibilità di concepire il divenire.128
Una conseguenza dell’antitesi tra essere e divenire è il problema dello stato di potenzialità e dell’esistenza
del movimento. I megarici tendono a negare sia la potenza che il movimento. In primo luogo, la potenzialità
è esclusa dall’essere e ammessa solo per il divenire. Questa tesi suppone la realtà del solo essere assoluto.129
Ancora più radicalmente, la potenzialità è ammessa nel mondo fenomenico solo come realtà in atto (e
dunque in una condizione diversa da quella che sarebbe la sua propria).130
Dalla riduzione del possibile al reale si passa, quindi, alla sua riduzione al necessario. Diodoro sostiene
che sia possibile solo ciò che sia reale, per cui nulla accade che non sia necessario: qualsiasi possibile o è già o
sarà; il possibile in quanto puramente tale è impossibile.131
125
“La vita è un bene agli occhi dello sciocco; per l’uomo sapiente essa è indifferente” (Diogene Laerzio, II, 91-95).
“Il sapiente non opera alcuna cosa che per se stesso: perché nessuno degli altri stima degno al pari di sé” (Ib.).
127
Clemente Alessandrino, Stremata, II, 130, 7).
128
Sono diventati famosi alcuni esempi di “sminuzzamento” (coi quali si intendeva ottenere la riduzione all’assurdo
della molteplicità e del divenire): a) il sorite di Eubulide: quando si può dire di avere un mucchio, aggiungendo un
grano alla volta (e quando non si ha più il mucchio, quando si procede all’inverso, sottraendo un grano alla volta)?; b)
l’impossibilità di distinguere il poco dal molto: quando si può dire che una certa quantità è “molta” e quando che è
“poca”?; c) l’impossibilità di demolire un muro (argomento sviluppato da Diodoro Crono): si può dire che si demolisce
un muro, allorché il muro è ancora in piedi, ma in tal caso si ha ancora il muro; d’altra parte, se si ammette che si
demolisce un muro quando esso è già disfatto, non si può ammettere la demolizione: ne consegue che né quando i
mattoni sono ancora uniti si demolisce il muro, né quando sono staccati (Sesto Empirico, Adv. Mathem., X, 347); d) il
calvo: quando si può dire che uno sia “calvo”, ammesso che vengano tolti i capelli ad uno ad uno? In tal modo i
megarici mettevano in rilievo le difficoltà connesse alla comprensione del divenire.
129
Contro tale tesi polemizza Platone nel Sofista (248).
130
Come riferisce Aristotele, infatti, “chi sta in piedi starà sempre in piedi, e chi sta seduto sempre seduto, poiché non
potrà alzarsi se è seduto, in quanto sarebbe impossibile alzarsi a chi non ha la potenza di alzarsi” (Metafisica, IX,3,
1047). Dunque quando c’è l’atto non c’è la potenza; e questa stessa si risolve nell’atto (non potrebbe dirsi potenza una
potenza che non fosse in atto).
131
Il discorso “dominatore” di Diodoro muove dal contrasto tra questi tre principi: 1) è necessario che ogni fatto
compiuto sia vero; 2) dal possibile non può derivare l’impossibile; 3) è possibile anche ciò che non è né sarà vero.
Infatti con tali principi si intende affermare: 1) che post eventum ogni fatto è necessariamente vero; 2) se ante eventum
fosse esistita la possibilità del contrario, ne deriverebbe l’impossibilità della possibilità precedente (il che è assurdo); 3)
se è impossibile il contrario di ciò che si ammette come possibile, si deve ammettere solo il possibile come vero. E tale
possibile si identifica col necessario (in quanto non ammette il proprio contrario).
126
Analoga è la negazione della concepibilità e possibilità del movimento.132
Da tutte queste argomentazioni i megarici deducono la tesi fondamentale della unità e immobilità dell’essere
e della negazione del diverso e molteplice e del divenire.
In logica deriva la negazione della possibilità di predicare un concetto di un altro.133
Come tesi conclusiva, i megarici affermano l’identità dell’Essere uno e immobile col Bene. Particolari aspetti di
questa tesi fondamentale sono: 1) l’ottimismo logico (l’Essere è il bene; il male è il non-essere); 2) il monismo
assoluto (il molteplice è irreale; la conoscenza del Bene è l’univa virtù: perciò Euclide chiama l’unità
Essere/Bene anche “saggezza”, “divinità”, “intelletto”); 3) l’etica della inazione (immobilità del Bene, che così
diventa solo oggetto di contemplazione).
132
Per negare il movimento, Diodoro si serve di argomentazioni connesse alla sua ipotesi delle particelle indivisibili
(atomi): 1) un corpo indivisibile (atomo) deve essere contenuto in uno spazio indivisibile; dunque non può muoversi in
esso (coincidendo esattamente con esso); né può muoversi in altro luogo (dove non sia); 2) ciò che è in un luogo,
dunque, non si muove.
133
Su questo punto i megarici appaiono concordare con Antistene.
CAPITOLO VI
Platone
L’intera riflessione di Platone muove dall’interrogativo sulla tragica morte di Socrate: com’era stato possibile che
l’uomo considerato “più buono e più giusto” avesse subito una tale condanna da parte di una città che invece avrebbe
dovuto onorarlo per la sua opera educativa e per essere esempio di saggezza e di virtù. La risposta a questa domanda è
anche il senso di quella riflessione: solo lo stato giusto non avrebbe commesso il fatale errore; ma un tale stato non esiste,
si può solo ipotizzare e delineare come un’utopia. Platone giunse presto alla convinzione che il problema politico si
risolve solo ponendo i filosofi al governo della città o educando i governanti alla filosofia. Dunque la chiave del problema
che riguarda la costruzione dell’esistenza giusta sta nella conoscenza. Platone ipotizza la filosofia come grado di
conoscenza superiore (che si colloca dopo la sensazione, l’esperienza e la matematica), configurata come “dialettica”,
scienza dei rapporti tra le idee, che esprimono le essenze intelligibili dei termini reali e la cui acquisizione è tratta
attraverso una ricerca interiore (per cui la loro conoscenza è considerata una “reminiscenza”), di tipo intellettuale. Le
idee sono anche le realtà vere e immutabili, principi della costituzione e dell’identità delle cose. Perciò, in rapporto alla
concezione di un “mondo delle idee” per sé sussistente e fondamento del mondo fisico, si parla di “dualismo” metafisico.
Ma bisogna ricordare che i due piani costituiscono gli aspetti di una medesima realtà. Innanzitutto la realtà ideale,
puramente intelligibile, è molteplice, sia pure fondata su principi che si riportano all’unità (l’idea di Bene); e in secondo
luogo essa sta sempre in rapporto dialettico di reciproca partecipazione con la realtà sensibile. Platone ha creato il
dialogo filosofico come modello di stile adatto allo svolgimento del pensiero: attraverso il giuoco dialettico delle domande
e delle risposte (che sono ancora, a loro volta, questioni) si riproduce il metodo della ricerca per cui l’intelletto si eleva,
in virtù di un esercizio di approfondimento interiore, dall’esperienza e dall’opinione, alla scienza delle idee, cioè alla
piena intelligenza dell’essere proprio degli enti.
Sintesi su Platone
Platone intende superare la relatività della conoscenza, professata dai sofisti. Nel Teeteto troviamo la più serrata
confutazione del sensismo e del relativsmo. Il relativismo ha la sua radice nell’eraclitismo, cioè nella concezione
dell’universale divenire: di ogni cosa si hanno diverse sensazioni da parte dei diversi soggetti e nei diversi
tempi; e così ogni cosa, producendo sempre effetti diversi, sarà sempre diversa essa medesima. Così il
mutevole, oggetto di sensazioni sempre diverse, non può mai diventare oggetto di conoscenza: infatti, nel
momento stesso in cui si crede di aver colto una qualche qualità e di averla fissata, già essa è mutata in
qualcosa d’altro. La mobilità sensibile esclude anche che si possano indicare con gli stessi termini ciò che
invece non è mai identico a se stesso.134
Bisogna, dunque, cercare di cogliere l’ente al di là delle apparenze: infatti, non il fenomeno mutevole, ma
l’ente (l’idea relativa all’essere dell’ente) è oggetto di conoscenza. Se l’ente si risolve nell’apparenza mutevole, esso
non può mai diventare conoscibile: infatti, nel momento in cui il soggetto tenta di conoscerlo, esso diventa
altro e diverso (consistendo nella stessa mutabilità fenomenica) e non si può dire che abbia una qualche
consistenza. Perciò “non si può dire che vi sia conoscenza, se tutto si tramuta e nulla sta”.135 Nella
prospettiva eraclitea del totale divenire, la conoscenza diventa un’assurda contraddizione: lo stesso rapporto
conoscitivo (il rapporto gnoseologico) si dissolve e svaniscono sia il conoscente che il conosciuto.136 Il
sensibile in quanto tale esclude, dunque, la conoscenza; ciò che indichiamo come “concetto”, e che
intendiamo esprimere con una definizione, non può riferirsi al sensibile, perché, come nota Aristotele, “è
impossibile una definizione di alcuno dei sensibili, che sono sempre in mutazione”.137
Platone chiama “idea” l’ente in quanto non sensibile, dunque in quanto può essere oggetto di conoscenza. Così noi
indichiamo come “bianco” o “nero” non questo bianco o questo nero, che possono d’un tratto mutare in altro
134
Teeteto, 183 a-b. Aristotele esprime in modo conciso questo concetto: “Di ciò che si muta interamente e sotto ogni
aspetto non è possibile dire nulla di vero. Da questa teoria infatti germinò l’estrema opinione di quelli chiamati o
chiamantesi eraclitei, quale professò anche Cratilo, che da ultimo credeva non doversi dir parola, ma faceva solo cenni
col dito, e biasimava Eraclito d’aver detto che non si possa entrare due volte nello stesso fiume; egli credeva neppure
una volta” (Metafisica, IV, 5, 1010).
135
Cratilo, 440 a-b.
136
Ibid.
137
Metafisica, I, 6, 987.
colore, ma qualcosa che cogliamo con l’intelletto e che permane sempre identico a sé, nonostante il variare
dell’esperienza sensibile.
Ne consegue che la fonte della conoscenza non può essere l’esperienza. Né si può dire che la conoscenza derivi
dall’insegnamento, perché chi insegna deve pure averla appresa in qualche modo. Perciò Platone nel Menone
ricorre alla dottrina (ipotesi) della reminiscenza. In che modo, infatti, il soggetto può trovare ciò che ignora
completamente e, trovandolo, come può riconoscerlo? Il soggetto non può cercare (senza una qualche
conoscenza preesistente) l’oggetto della conoscenza in una dimensione esterna bensì deve ricercare in se
stesso, nella dimensione della sua mente. Bisogna, dunque, ammettere che il soggetto cerca qualcosa che pure
già conosce, ma della cui conoscenza non ha consapevolezza.
Si deve porre una certa affinità dell’intelletto con le cose, dunque una condizione d’essere delle cose che è
conoscenza presente nell’intelletto. Nel Menone Platone espone la teoria della conoscenza come reminiscenza e
intende dimostrare che ognuno è capace, opportunamente stimolato e guidato, di trovare una nozione
relativa all’ente non sensibile (cioè all’idea).138
La conoscenza si configura come una specie di consapevolezza del sapere che già si possiede: e in tale
consapevolezza consiste il pensiero.139
La conoscenza consiste nel riconoscimento di ciò che è identico (al di là della mutevole apparenza) e che
per le cose molteplici (che cadono nell’ambito dell’esperienza sensibile) costituisce il modello.
Nella Repubblica Platone traccia il percorso che conduce alla conoscenza. Infatti non si pone un taglio netto tra
la conoscenza e l’ignoranza, ma si hanno diverse forme di conoscenza. Se la conoscenza riguarda l’ente
identico a se stesso, dunque l’“essere”, e se la non-conoscenza, in senso assoluto, riguarda l’assoluto nonessere (poiché solo del non-essere non si può dire nulla, in assoluto), si deve porre qualcosa di intermedio,
che, insieme, non è né completa conoscenza (dunque “essere”) né assoluta ignoranza (dunque “non-essere”).
Ciò che è intermedio tra scienza e ignoranza è l’opinione, che è “più oscura della scienza e più chiara
dell’ignoranza”.140
Si possono, perciò, distinguere diversi gradi della conoscenza.141 Al livello più basso si colloca
l’immaginazione, che è una specie di opinione falsa: si assumono come vere tutte le immagini, senza un criterio
di confronto, dunque incorrendo nell’errore di confondere le immagini tra loro e di riferirle a oggetti
diversi.142 Al secondo posto si pone l’opinione vera, che si può distinguere in esperienza e in arte.143 Si ha
“esperienza” allorché “non si dà ragione alcuna dei mezzi che usa, quali siano per natura, sicché non sa dire
la causa di ciascuno”.144 Invece si ha “arte” “allorché si ha consapevolezza delle ragioni o cause per cui
avviene qualcosa”. Ad esempio, esperienza è quella del cuoco, arte quella del medico. L’esperienza procede
irrazionalmente e senza calcolo, è piuttosto pratica e conserva solo la memoria di ciò che è consueto”.145 Si
tratta di una scienza empirica basata sull’opinione, che ha come suo oggetto il mondo dei fenomeni. Il
dominio dell’opinione, infatti, è l’ambito delle cose sensibili. D’altra parte, è da riconoscere che per la vita
quotidiana ha una funzione positiva la scienza inferiore, che ha uno scopo essenzialmente pratico.146
Diverso è il valore della conoscenza intellettuale, che riguarda oggetti intelligibili, cioè tali che si risolvono
nella completa comprensione razionale. Tale è la matematica, considerata come conoscenza razionale pura,
cioè non nella sua applicazione al mondo sensibile ma in quanto riguarda i puri enti e rapporti aritmetici e
geometrici. Resta fermo, però, che la contemplazione della verità, la pura conoscenza dialettica delle idee, la
filosofia, rappresenta il valore più alto.147 La filosofia è conoscenza delle idee, che sono strutture immutabili.
Le idee si colgono con l’intelletto e la conoscenza di esse è interamente razionale, poiché consiste nel
138
Menone, 81-82 sgg. Lo schiavo di Menone, interrogato da Socrate, riesce a risolvere un problema di geometria
(come costruire il quadrato di superficie doppia di un quadrato dato). La reminiscenza è risveglio di conoscenza
intellettiva di idee; essa, perciò, va distinta dalla memoria, che è conservazione di immagini sensibili (cfr. Filebo, 34).
139
“Così anche le cose, di cui già da tempo aveva conoscenza chi le aveva apprese e le sapeva, queste stesse egli può
di nuovo apprenderle, riprendendo e tenendovi presente la conoscenza di ciascuna, che possedeva, sì, da tempo, ma non
aveva a mano nel pensiero” (Teeteto, 198).
140
Rep., V, 478.
141
L’itinerario che conduce alla conoscenza vera è esposto nella Repubblica (517 a-518 b) attraverso l’allegoria della
caverna.
142
Cfr. anche Teet., 194-95.
143
Gorgia, 465.
144
L’osservazione è riferita alla medicina empirica. Gorgia, 465.
145
Ibid.
146
Cfr. Filebo, 62.
147
Teet., 173-75.
ragionamento.148 Mentre il sensibile si spiega e si comprende attraverso immagini, l’intelligibile si
comprende solo attraverso la dialettica.
Le idee sono modelli degli enti sensibili; esse esprimono l’essere degli enti; sono strutture reali, dunque, e
non semplici entità mentali, fondamento degli enti e non semplici segni convenzionali coi quali si indicano le
cose.149
Sul rapporto tra le idee e gli enti, Platone parla della partecipazione (“metessi”) delle cose alle idee;150 e della
presenza (“parousìa”) delle idee nelle cose;151 inoltre afferma che le cose sono imitazione (“mimesi”) delle
idee.152
Sul rapporto tra le idee e gli enti sensibili, Platone affrontò alcune questioni. Una prima questione
considera se ci sia idea d’ogni specie di cose.153 Platone conclude che delle cose di cui risulta pressoché
impossibile avere una nozione puramente intellettuale, separatamente da ogni immagine sensibile, ad
esempio del fango, non esiste una corrispondente idea (per cui tali cose hanno una realtà solamente
sensibile). Un’altra questione riguarda la possibilità, per l’idea, di moltiplicarsi, partecipandosi alle varie cose, pur
rimanendo una.154 Infine si ha la difficoltà che costituisce l’argomento del terzo uomo, al quale fa riferimento
Aristotele.155 Nel processo di idealizzazione dell’ente, infatti, si procederebbe fino a identificarlo con l’ideale
corrispondente.
Le idee, peraltro, in quanto diventano oggetto di conoscenza, non possono considerarsi perfettamente
immobili: esse, in qualche modo, ammettono in sé un qualche movimento. Infatti, “l’essenza conosciuta della
conoscenza, in tanto per tal patire si muove, il che neghiamo avvenga di ciò che è immobile”.156 E se le idee
fossero immobili, “non ci sarebbe intelletto per nessuno di nessuna cosa in nessun luogo”.157
Le idee stanno in relazione tra loro: e i modi di tale relazione sono razionali e vengono conosciuti attraverso la
dialettica. La dialettica, infatti, che è scienza delle relazioni tra le idee, si basa sulla comunione reciproca
delle idee stesse. Ad esempio, l’idea di “uomo” comunica con le idee di “buono”, “giusto”, e così via.158
Platone qui compie un primo tentativo di determinazione delle categorie. Infatti, si chiede “se ve ne siano
di quelli (tra i termini del discorso) che fan da collegamento tra tutti, in modo che siano capaci di
commistione; e viceversa nelle divisioni, e, fra tutti, altri sian causa di divisione”.159
In primo luogo emerge la funzione collegatrice delle idee di “essere” e di “uno” (totalità). Platone esamina “in
che le singole specie possano comunicarsi tra loro e in che no”, dunque se “vi è un’idea che si distende in
ogni senso per molte, restando ciascuna separata”, e se “ce n’è una d’altra parte congiunta con tutti i
molteplici a unificarli”.160 Infatti, “solo per mezzo dell’intreccio reciproco delle specie ha potuto generarsi fra
noi il ragionamento”.161
Così Platone perviene a identificare le idee più comprensive, quelle che si estendono a tutte le altre o a un
gran numero di esse. “Le maggiori fra le specie sono quelle che ora abbiamo enumerato, l’essere stesso, la
quiete e il moto”.162 Analogamente idee generali sono l’identico e il diverso, il simile e il dissimile, l’unità e la
pluralità, e poi anche generazione e corruzione e anche la relazione, il dove e il quando, l’agire e il patire.
148
Timeo, 27-28.
Parm., 132-33.
150
Conv., 211 b.
151
Fed., 100: “Nessun’altra ragione fa essere bella (la cosa) se non la presenza o la comunione di quella bellezza
(ideale)”.
152
Parm., 132. Nel Cratilo (389) Platone dice che i nomi sono immagini delle idee e che l’artefice che le li ha
elaborati ha tenuto presenti le idee e non gli enti sensibili. Nel Timeo il demiurgo, artefice dell’universo, ha tenuto
presente il modello delle idee eterne, per cui le cose create sono dette “immagine viva degli eterni dèi” (X, 37 c).
153
Parm., 130.
154
Parm., 131; Fil., 15.
155
Met., 990.
156
Sof., 248-49.
157
Ib.
158
Così, “una volta convenuto che anche le specie sono nella stessa condizione quanto all’unirsi tra loro, non
bisognerà forse procedere con qualche scienza nel discorso, per mostrare rettamente quali dei generi con quali
s’accordino e quali si escludano tra loro?” (Sof., 251-53).
159
Ib.
160
Sof., 253.
161
Sof., 259.
162
Sof., 254.
149
Platone ammette la realtà del non-essere. “Ma quando diciamo non-essere – avverte – non diciamo il
contrario dell’essere ma solo il diverso”.163
Nella metafisica platonica l’idea suprema è al di là della stessa distinzione di essere e non-essere, è, cioè, il Bene,
come principio di tutte le idee.164
Nella fase finale del suo pensiero, Platone elaborò la dottrina delle idee-numeri o numeri ideali.165 Egli non
crede che i numeri si generino per via di operazioni aritmetiche, ma pensa che essi partecipino di archetipi
ideali. Così egli ammette: 1) i numeri ideali; 2) i numeri matematici; 3) le cose sensibili numerabili.
Da Aristotele sappiamo che Platone limitava la serie delle idee-numeri alla prima decade. Tutti i numeri,
ad eccezione dei primi dieci, deriverebbero dalla dualità infinita (che comprende le idee del grande e del piccolo,
del più e del meno). Uno/molti, limite/infinito sono, dunque, i costituenti primari delle idee. Ogni idea e una e
insieme partecipa di una molteplicità: essa è una modalità di limitazione dell’indefinita diade.166 Il numero è una
determinazione dell’infinità: e tale determinazione è possibile sulla base dell’unità. In tal modo il molteplice
indefinito diventa uno (pur restando costituito da una molteplicità, che l’unità definisce e determina).167
Di fronte all’unità, che si identifica col limite, la natura dell’infinito viene definita come dualità o diade del
più e del meno. Da questi due elementi o princìpi (l’unità e la dualità infinita) vengono a costituirsi i numeri
ideali.
L’anima cosmica comprende originariamente in sé tutti i rapporti di numero e di misura: perciò essa è
archetipo di tutte le determinazioni numeriche. Il cosmo è ordinato in base a questo archetipo.
Così l’armonia musicale e il sistema dei corpi celesti rappresentano, secondo Platone, le primarie
manifestazioni delle determinazioni numeriche. Su tali determinazioni si modellano tutte le manifestazioni
reali: così gli archetipi di ogni realtà corporea e spirituale sono determinazioni numeriche, rapporti
matematici. Il numero è fondamento dell’ordine dell’universo e, nello stesso tempo, di ogni scienza e della stessa virtù;
perciò è anche via di salvazione e beatificazione dell’anima.168
Secondo questa fase matura della metafisica platonica, si avrebbe una triplice gerarchia di esseri: le ideenumeri, gli enti matematici, le cose sensibili. I princìpi generatori delle idee-numeri sarebbero l’Uno e la
Diade indeterminata.169
Principio dell’ordine dell’universo è, dunque, l’anima cosmica. Questa comprende, come abbiamo visto,
tutti i rapporti di numero e di misura. Essa è stata formata originariamente da Dio dall’unione dell’essenza
indivisibile e di quella divisibile. In tal modo sono state stabilite le modalità archetipe della determinazione.
Il mondo fisico risulta costituito dalla proporzione (rapporti armonici) tra i principali elementi materiali, che
sono acqua, aria, fuoco e terra. Ogni elemento ha una sua costituzione geometrica: la terra ha forma cubica, il
fuoco è modellato sulla figura della piramide (tetraedro), l’aria su quella dell’ottaedro e l’acqua su quella
dell’icosaedro.170
L’intero universo è racchiuso in una sfera. Fuori del cielo vi è la sfera iperurania, che è anche sede delle
anime beate (Empireo).
La Terra è collocata al centro dell’universo.171 Essa è sostenuta dall’equilibrio dato dall’equidistanza da
ogni parte del cielo.
Anche l’uomo è costituito secondo un modello di armonia. L’anima è principio di determinazione: essa informa
il corpo e in sé trova le idee, cioè i modelli/archetipi secondo cui la dualità indefinita (la materia) è
determinata (le idee-numeri). La conoscenza è reminiscenza di questo sapere originario.
163
Sof., 256-57.
Rep., VI, 508: “E anche per le (idee) conoscibili di’ che dal Bene viene non solo l’essere conosciute ma viene
anche l’essere e l’essenza, senza che il bene sia l’essenza anzi restando superiore all’essenza per dignità e potenza”.
165
Nei dialoghi si possono rintracciare elementi e motivi preparatori di questa dottrina. Nel Fedone (96 e-97 b) si
parla della necessità dell’esistenza di numeri-idee, come archetipi dei numeri matematici (la “dualità” come
idea/archetipo del 2).
166
“Ma gli antichi, che valevano più di noi e stavano più vicini agli dèi, ci hanno tramandato questo oracolo, che gli
enti, dei quali si dice che sono eternamente (le idee) constano di uno e di molti, ed hanno in se stessi congenito il limite
e l'infinito” (Fil., 16 c).
167
“L’uno, dunque, essendo uno, è in qualche modo uno e molti, e tutto e parti, e finito e infinito di moltitudine”
(Parm., 145 a). “Ma bisogna non applicare l’idea dell’infinito alla pluralità, prima d’averne riconosciuto il numero che
sta di mezzo tra l’infinità e l’unità” (Fil., 16 c).
168
Cfr. l’Epinomis.
169
Aristotele, Met., 987 b.
170
Nell’Epinomis a questi quattro elementi si aggiunge l’etere, con la forma del dodecaedro.
171
In una seconda fase della sua concezione astronomica, Platone avrebbe posto il sole/fuoco al centro dell’universo.
Tuttavia sembra che il fuoco centrale non debba identificarsi col sole.
164
Nel Fedro è esposto il mito della biga alata, in cui l’auriga rappresenta la facoltà razionale dell’anima e i due
cavalli la facoltà passionale (irascibile) e quella appetitiva (concupiscibile, principio del desiderio).
Nel Fedone troviamo le famose prove dell’immortalità dell’anima: 1) la generazione reciproca infinita dei contrari:
occorre che ogni opposto si generi dal suo contrario, per cui “i vivi nascono dai morti”e vi sono “le anime dei
morti” (72); 2) la reminiscenza e la vita anteriore dell’anima (72-73); 3) la semplicità dell’anima: essendo semplice,
l’anima non si può decomporre nelle sue parti; 4) l’affinità tra l’anima e le idee: in quanto l’anima conosce le
idee, la sua natura è affine a queste, cioè è semplice, invisibile, immutabile; 5) l’anima, in quanto principio di
vita e di movimento, non può accogliere in sé il proprio contrario.172 L’anima è tale che nessun male, né
proprio né proveniente da altro, può distruggerla.173
Platone ci ragguaglia anche intorno alla sua concezione escatologica.174
Il bene è, dunque, armonia. Nell’uomo l’armonia genera anche piacere; così come dalla disarmonia si genera
il dolore.
Nel Filebo Platone dimostra che il bene è unione di piacere puro e scienza. Egli sostiene che né il piacere né la
pura intelligenza costituiscono il bene per l’uomo, ma che dalla sintesi di essi deriva questo bene. Infatti
piacere e intelligenza rappresentano per sé due opposti, che nell’uomo devono trovare la loro
conciliazione.175
Primo bene, dunque, è la stessa misura, cioè la condizione della mescolanza; viene poi il risultato della
misura, il misurato che risulta anche bello; e quindi gli elementi che vi concorrono: la mente (intelligenza) e le
scienze e arti e opinioni rette, e infine i piaceri puri delle scienze e delle sensazioni.
Nel Convito la vita dell’uomo è presentata come tensione continua verso la bellezza del mondo ideale, come
desiderio di immortalità e progressiva ascesa dal mondo delle forme belle alle realtà ideali e archetipe.
La struttura dell’anima, attuata secondo le virtù proprie di ciascuna facoltà (la temperanza, il coraggio o
fortezza, la sapienza) e la giustizia, che è la struttura unificante delle virtù, costituisce la stessa natura umana.
Lo stato non è che la proiezione ingrandita della costituzione dell’uomo ed è la dimensione in cui l’uomo
stesso si attua. Perciò lo stato comprende tre classi (produttori, guerrieri, reggitori), corrispondenti alle tre
funzioni dell’anima.
La giustizia è condizione della felicità. Nello stato si attua il bene di tutti, mentre l’interesse privato è
motivo di disgregazione della compagine politica.
Nella concezione politica di Platone si distinguono due fasi: a) il governo è superiore alla legge (fonte di
legislazione); 2) la legge esercita la sua supremazia sui governanti (nelle Leggi).
Nella Repubblica Platone esamina le forme di governo, le loro derivazioni e le progressive degenerazioni.
Vi sono cinque forme di governo, corrispondenti a cinque tipi di anima. La prima forma è quella che prende
il nome di monarchia se a governare è uno solo, di aristocrazia se sono i migliori.176 Allorché nei governanti
prevale la sete di potere si ha la timocrazia: questa forma di governo corrisponde allo stato dell’anima in cui si
ha il dominio della facoltà passionale, cioè predominano la volontà di potere, le ambizioni, le invidie, la
megalomania.177
Quindi viene l’oligarchia, il governo basato sul censo, in cui i ricchi comandano. In tal caso si ha una
contrapposizione tra i ricchi e potenti e i poveri: si ha che “siffatto stato sarà per forza non uno, ma due:
quello dei poveri e quello dei ricchi, coabitanti in esso, ma sempre tendentisi reciproche insidie”.178 In tal
caso si ha un predominio della funzione appetitiva dell’anima (rivolta ai beni materiali). Viene quindi la
democrazia, nella quale il principio della ricchezza e della ricerca dei beni materiali investe tutta la
cittadinanza.179 Dalla democrazia si genera la tirannide. Il tiranno si erge a difensore degli interessi del
172
Nel Fedro e nella Repubblica si aggiunge l’argomento che l’anima è principio di moto che muove se stesso.
Rep., X, 608-11.
174
Cfr.: Gorgia, 523-26, dove è riportato il mito del giudizio delle anime nude davanti a Minosse, Eaco e Radamante;
Fedro, 248, dove è fissato in diecimila anni il ciclo delle trasmigrazioni per l’anima che non si sia liberata attraverso la
vita filosofica; Fedone, 81, dove si parla della beatitudine che tocca all’anima del filosofo.
175
“E ora come a coppieri ci stanno dinanzi le fonti: quella del piacere somiglia a fonte di miele, quella
dell’intelligenza, sobria e priva di vino, a fonte d’acqua austera e salutare: dobbiamo studiarci di mescolarle nel modo
migliore” (Filebo, 61).
176
“Buono e retto chiamo tale stato e governo e l’uomo di tale tipo; cattivi e sbagliati gli altri […] e li includo nelle
quattro specie di vizio” (Rep., IV, 449).
177
Rep., VII, 546-48.
178
Rep., VIII, 550-51.
179
Questa forma di governo si genera dalla oligarchia, allorché i poveri si rivoltano contro i loro governanti e
intendono così esercitare il potere. “I capipopolo, spogliando gli abbienti delle ricchezze, ne distribuiscono al popolo,
173
popolo: in nome del popolo esercita un potere assoluto, in realtà assecondando i propri impulsi e per
affermare la sua volontà di potenza per lo più attua una politica bellicosa, provocando continue guerre.
Infine il tiranno finisce per attirare su di sé l’odio dei cittadini; e così ha bisogno di circondarsi sempre di più
di guardie del corpo, basando il suo potere sulla violenza. Il tiranno finisce per vivere una vita piena di
tormenti e di paure, di sospetti e ansie continue. E questa è la peggiore condizione per la comunità.
Infine (nelle Leggi) Platone mostra di preferire una forma mista di monarchia e democrazia.180
Il secondo Platone
Come è noto, Platone, nei dialoghi dialettici, sottopose a revisione critica il suo “sistema” filosofico,
elaborato nei grandi dialoghi della prima maturità. Attraverso tale processo di revisione, egli finì per
elaborare un pensiero del tutto nuovo, tale da poterci consentire di parlare di un secondo Platone, diverso da
quello che generalmente conosciamo come il Platone classico, il cui pensiero sta alla base di una lunga e
consolidata tradizione.181
Richiamiamo brevemente i temi fondamentali di questo pensiero, in cui tradizionalmente si identifica il
platonismo. Alla base di questa filosofia vi è la dottrina delle idee: le idee sono concepite come entità metafisiche,
modelli eterni degli enti sensibili e oggetto della conoscenza filosofica. Le idee, infatti, che non mutano e non
appartengono all’universo fisico, ma hanno una pura consistenza logica e ideale (costituiscono il mondo delle
idee), non possono essere conosciute attraverso l’esperienza, bensì costituiscono il termine di una conoscenza
che non è altro che reminiscenza di un possesso originario, di cui è dotata l’intelligenza (l’anima razionale).
Le idee, che sono l’impalcatura logico-razionale dell’essere nelle sue determinazioni, hanno, secondo questa
dottrina, una realtà propria, separata da quella degli enti sensibili, dei quali costituiscono i modelli perfetti (il
ma ne tengono il più per sé […]. Or dunque un capopopolo che mandi in esilio o metta a morte […] è ben fatale
necessità che o sia ucciso dai nemici o si faccia tiranno e, da uomo, lupo […]” (Rep., VIII, 563-67).
180
“Non bisogna costituire poteri grandi e non misti […]. Dunque bisogna che (lo stato) partecipi di ambedue questi
(poteri, quello monarchico e quello democratico), se vi deve essere libertà e concordia con saggezza. Lo stato che abbia
amato il principio monarchico e quello di libertà più che l’uno o l’altro da solo non ha temuto né l’uno né l’altro, con
giusta misura” (Leggi, III, 693).
181
Cfr. Giovanni Reale, Per una nuova interpretazione di Platone, Vita e Pensiero, Milano 1991. Reale si propone
di presentare il pensiero di Platone come un sistema organico, utilizzando anche le dottrine non scritte. Egli, in primo
luogo, cerca di uscire dal paradigma dominante, che è quello canonizzato dallo Schleiermacher e che si basa
sull’enucleazione del pensiero platonico esclusivamente dai dialoghi, senza tenere conto della tradizione indiretta.
Questo paradigma, in effetti, risulta ora inadeguato, dato che si è venuto sempre meglio definendo l’importanza di
questa tradizione. In questo senso, oggi risulta maggiormente rispondente all’esigenza di una ricostruzione totale del
pensiero di Platone il paradigma elaborato dalla Scuola di Tubinga, che, appunto, ha il pregio di consentire di
inquadrare nella complessiva filosofia platonica anche gli elementi propri della tradizione non scritta.
Questo paradigma, precisato dal Gadamer, si collega alla tradizione dell’Antica Accademia, quale ci è attestata dai
discepoli diretti di Platone, cioè da Aristotele, Speusippo e Senocrate.
Spetta ad Aristotele la testimonianza intorno a quella forma di metafisica platonica che si basa sui “princìpi” primi,
l’Uno e la Diade illimitata, e secondo cui le Idee deriverebbero da questi princìpi, assunti come la causa formale e la
causa materiale di esse. Scrive, infatti, Aristotele: “Risulta chiaro che Platone ha fatto uso di due sole cause: di quella
formale e di quella materiale. Infatti le Idee sono cause formali delle altre cose, e l’Uno è causa formale delle Idee. E
alla domanda quale sia la materia avente funzione di sostrato, di cui si predicano le Idee nell’ambito dei sensibili, e di
cui si predica l’Uno nell’ambito delle Idee, egli risponde che è la Diade, cioè il grande-e-piccolo” (Metafisica, A 6, 988
a 9-14). Aristotele ci testimonia, inoltre, che Platone ammetteva, come realtà intermedie tra le Idee e gli enti sensibili,
gli enti matematici, e che considerava i numeri ideali come causa e sostanza di tutte le cose, ponendoli come diretta
espressione dei princìpi. Il sistema platonico, in questo modo, si reggerebbe essenzialmente sulla tradizione non scritta.
Speusippo sposta al primo posto (immediatamente dopo i princìpi) gli enti matematici e colloca le Idee e i numeri
ideali dopo di essi. I princìpi assumevano la configurazione di Uno e Molti (Unità e Molteplicità). In questo modo, la
metafisica di Platone sarebbe quella fondata sulla dottrina dei princìpi, che non troviamo nei dialoghi, ma è attestata da
Aristotele e dagli altri discepoli diretti di Platone.
I neoplatonici hanno elaborato un altro paradigma, in gran parte ispirato a una interpretazione teologica del
platonismo. Qui l’accento è posto sulla struttura gerarchica della realtà sovrasensibile, che è articolata nei tre momenti
del Primo Intelletto, del Secondo Intelletto, dell’Anima del Mondo; e il fine dell’uomo è identificato con l’ascesa e
l’assimilazione al Primo Intelletto (a Dio stesso).
loro “essere” immutabile). Il percorso interiore della reminiscenza (la lotta dello spirito per liberarsi dai
vincoli della sensibilità e conseguire una visione puramente intellettiva), anche se muove dall’esperienza
delle cose sensibili, conduce, infine, attraverso un adeguato esercizio (che comprende, in particolare, lo
sviluppo del pensiero matematico), all’intuizione delle idee.
La conoscenza filosofica riguarda, dunque, i modelli perfetti degli enti sensibili. Così si ha, tra l’altro, la
conoscenza dello Stato ideale, basato sull’idea della giustizia in sé.
Ma com’è possibile che il percorso della conoscenza dal piano della sensibilità e dell’esperienza compia il
salto qualitativo al piano della pura intelligibilità? Com’è possibile, ad esempio, oltrepassare l’immagine
sensibile dell’uomo, ossia tutto ciò che intorno all’uomo si riesce a conoscere mediante l’esperienza, per
attingere una comprensione puramente intellettuale (come se l’uomo fosse un puro ens rationis)?
A una riflessione più approfondita, sembra che la conoscenza di un ente che ha una realtà sensibile non
possa prescindere dal piano dell’esperienza, ma che debba rimanere comunque legata ad esso, sia pure nella
forma di un percorso circolare (come Platone precisa nell’excursus teorico della VII Lettera).
L’esigenza di una circolarità nell’ambito della conoscenza implica un analogo percorso circolare sul piano
reale. Perciò Platone sottopone a revisione critica la concezione del rapporto tra le idee e gli enti sensibili. Egli
esamina le aporie alle quali va incontro la dottrina delle idee come entità reali perfette, immutabili,
intelligibili, separate dagli enti sensibili e, nello stesso tempo, modelli di essi. Nel Parmenide, così, mette in
rilievo le difficoltà derivanti da entrambi i modi in cui si può concepire quel rapporto: la partecipazione e
l’imitazione.
Se le idee sono separate dagli enti sensibili e questi, tuttavia, partecipano di esse, si ha che le idee vengono
coinvolte nel processo di generazione e corruzione degli enti, e così perdono la loro unità e immutabilità.
Se le idee hanno in comune qualcosa con gli enti sensibili (appunto ciò che questi prendono da esse
imitandole), si deve ammettere che ogni volta che si stabilisce questa comunanza, si rimanda a un’altra idea
che contiene ciò che è comune all’idea e all’ente sensibile (ad esempio, dall’idea di “uomo” a quella di
“uomo saggio”), e poi a un’altra idea ancora che abbia in comune quel carattere con un altro ente sensibile
(all’idea di “uomo saggio e buono”) e così via all’infinito (argomento del “terzo uomo”, ripreso da
Aristotele).
D’altra parte, le idee concepite come entità immutabili, che fanno parte di un mondo interamente altro
rispetto a quello sensibile, risultano del tutto inconoscibili, in quanto il pensiero è movimento, processo
dialettico, e può riguardare, dunque, ciò che appartiene all’ordine di un simile processo. Le idee sono
conoscibili se anch’esse appartengono a un ordine dialettico, basato sul movimento.
Platone modifica la sua dottrina delle idee in questo senso, dimostrando che anche le idee fanno parte di un
ordine dialettico, che non è basato semplicemente sull’unità, sull’essere, sull’identità, sulla immobilità e
immutabilità, bensì anche sulla molteplicità, sul non-essere, sulla differenza (o diversità), sul moto e sul divenire.
Nella seconda parte del Parmenide, Platone dimostra l’implicazione reciproca di unità e molteplicità. Se l’uno è,
egli argomenta, se cioè si ammette la posizione eleatica, consegue che l’identità assoluta implica
l’impossibilità che essa sia pensata ed espressa in un giudizio (poiché il giudizio implica già la distinzione tra
il pensante e il pensato). Perciò l’uno deve essere posto in rapporto dialettico col molteplice. Il nesso uno/molti
costituisce una struttura metafisica fondamentale. Non è concepibile una sostanza immutabile e
assolutamente identica, separata dalla molteplicità degli enti. Invece tale nesso rende l’uno conoscibile e
determinabile, così come rende determinati e intelligibili i molti (che non sono altro che determinazioni
dell’uno).
Nel Sofista, Platone spiega la funzione positiva del non-essere. Poiché l’essere non può rimanere
assolutamente indifferenziato, ma deve determinarsi, il non-essere (in quanto si riferisce alle determinazioni
che non sono realizzate) non può essere inteso come l’assoluto contrario dell’essere, cioè come ciò che
assolutamente non-è (e in modo che si debba escludere qualsiasi sua appartenenza alla sfera dell’essere),
bensì deve essere concepito come il diverso, cioè come un altro modo di essere (il modo d’essere della
negazione e della privazione). Il non-essere concorre alla determinazione, nella stessa misura in cui vi concorre
l’essere.
L’essere, in quanto processo di determinazione di sé col concorso del non-essere, è moto; ma nello stesso
tempo non perde mai la sua identità, dunque è anche quiete. Esso è, insieme, identico e diverso.
Il pensiero segue l’intrinseco movimento della realtà: esso coglie il reale nel suo duplice carattere di
identità e diversità: perciò è dialettico. Esso ha il compito di comprendere il reale nella sua identità ma anche
in quanto è generatore di altra realtà.
Essere/non essere, quiete/moto, identico/diverso sono le condizioni universali del prodursi della realtà; e sono,
nello stesso tempo, le categorie fondamentali del pensiero. Questo, d’altra parte, è concepito come intrinseco
alla struttura del reale. Il reale, infatti, è tutt’uno con la sua struttura logico-razionale, cioè con la sua verità.
La dialettica del pensiero riproduce la dialettica delle idee, cioè le modalità secondo cui le idee
comunicano fra loro e stabiliscono rapporti di comunanza e di differenza. La conoscenza filosofica consiste
nello sviluppo di una tale dialettica: essa riguarda le modalità secondo cui le idee comunicano fra loro,
avendo qualcosa in comune e, nello stesso tempo, caratteri diversi.
Nel Sofista, Platone precisa che la dialettica consiste nel sapere analizzare un’idea, al fine di scoprire quali
idee comunicano fra loro e quali non comunicano, qual è l’unità che le accomuna e quali sono le differenze
che le diversificano. L’esempio riportato riguarda la definizione del pescatore con la lenza. Anzitutto si
distinguono le arti produttive e le arti acquisitive, e si stabilisce che quella indagata è del secondo tipo. Poi si
distinguono le arti acquisitive in fondate sul contratto e fondate sulla forza; poi queste ultime in palesi e
occulte; e queste in acquisitivi di esseri viventi e non viventi; si stabilisce che la pesca con la lenza appartiene
alle prime; e così via, finché è possibile procedere in ulteriori divisioni (dicotomie). Per definire l’idea di
“pesca con la lenza” bisogna, cioè, suddividerla, col procedimento dicotomico, nelle idee di cui risulta
composta, e dire, quindi, quali sono le idee che la compongono. Si ha, ad esempio, la seguente definizione:
“La pesca con la lenza è un’arte acquisitiva di esseri viventi, fondata sulla forza e sul procedimento occulto”.
In questo modo si perviene a stabilire l’identità propria di un’idea, distinguendola da ogni altra. Un altro
esempio riguarda, nel Politico, la definizione della scienza politica.
Nel Filebo, Platone, sulla base della scoperta della composizione numerica delle idee, cioè del fatto che ogni
idea ne comprende altre, afferma che la dialettica consiste nel cercare la caratteristica unitaria comune a una
molteplicità di cose, cioè l’idea, e poi nel vedere se questa caratteristica unitaria (idea) ne comprende, a sua
volta, due o tre o un altro qualsiasi numero. Nell’esempio citato sopra, l’idea della pesca con la lenza è
emersa nelle idee componenti. La dialettica si configura come l’arte di risalire alle idee componenti e, in
particolare, alla determinazione del loro numero. La costituzione numerica dell’idea dipende, appunto, dal
numero di idee di cui essa è costituita. In definitiva, ogni idea è una determinazione dell’illimitato attraverso
il numero.
Platone riprende la tesi pitagorica, secondo cui i princìpi di ogni realtà sono il limite e l’illimitato, e la
applica alle idee, dichiarando che esse sono composte di entrambi questi princìpi e perciò ciascuna è
costituita da una molteplicità che, di per sé tendenzialmente illimitata, viene definita dal limite (dall’unità o
dal numero). L’illimitato così definito costituisce il genere misto, che, in definitiva, costituisce il reale, l’ente
determinato. Il genere misto appartiene al reale concreto, alla instabile realtà del divenire, che è continuo
processo di generazione, cioè di determinazione dell’illimitato. In particolare, la vita consiste in tale processo
continuo. Gli impulsi vitali sono continuamente disciplinati. Nell’uomo questo processo si configura come
misura, che la facoltà che è espressione del limite, l’intelletto (la ragione), impone alla vitalità, che si esprime
nella passione. Il piacere vero dipende dall’esperienza di questa misura, cioè dall’attuazione della forma
propria dell’esistenza umana. L’arte e la scienza riguardano, a loro volta, le forme del genere misto, attuate
ai diversi livelli del reale. Perciò l’arte è rappresentazione delle forme armoniche che in tal modo si
producono. Il bene, nel suo triplice aspetto di bellezza, proporzione e verità, entra nel misto e fa sì che esso
sia anche un valore, cioè abbia un significato etico.
Secondo l’esposizione del Timeo, la causa della mescolanza, cioè dell’unione del limite/idea con
l’illimitato/materia, è costituita dall’Anima del mondo, forgiata dal Demiurgo, costituente una specie di mente
divina, che è principio di ogni ordinamento della realtà.
Il Demiurgo forma l’Anima del mondo mescolando insieme l’identico, il diverso e una realtà intermedia tra
questi (il misto), secondo rigorose proporzioni matematiche. L’Anima perciò possiede una natura affine alle
idee: le idee stesse nella loro costituzione matematica sono presenti in essa nella forma di princìpi operativi
che modellano la materia secondo quelle medesime proporzioni. La forma dell’universo deriva da quelle
strutture matematiche. Così, in primo luogo, l’universo ha una forma sferica e ruota su se stesso. Il cielo è la
sfera che contiene in sé gli astri e ruota con essi intorno alla Terra, posta al centro dell’universo e dotata
anch’essa di forma sferica. Il moto del cielo e degli astri dà la misura del tempo, che è l’immagine mobile
dell’eternità.
Anche i singoli corpi esistenti nell’universo hanno una struttura matematica. Platone attribuisce a ciascuno
dei quattro elementi la forma di un solido geometrico (tetraedro, cubo, ottaedro, icosaedro) e suppone che
tutte le cose siano costituite da forme riconducibili a solidi geometrici, scomponibili in superfici piane, a loro
volta scomponibili in triangoli: tutto si riduce, quindi, a triangoli, cioè a superfici regolari, linee e punti.
Anche gli aspetti sensibili delle cose (sapori, odori, sensazioni di caldo e di freddo) sono riconducibili a
strutture e a rapporti di tipo matematico. In tal modo Platone ha dato un primo esempio di analisi
matematica della materia (e di tutti i fenomeni fisici).
Sulla base dei medesimi presupposti, Platone elabora, secondo la testimonianza di Aristotele, la teoria delle
idee/numeri, basata sulla compresenza di due princìpi opposti, l’Uno e la Dualità indefinita.
Nel Timeo, Platone, parlando del mondo delle idee, come dell’esemplare eterno, sul quale è modellato
l’universo, rileva che esso deve essere concepito come vivente e animato, e non immobile, come il vivente
perfetto, che comprende tutti i viventi intelligibili (come l’universo fisico comprende tutti i viventi sensibili).
D’altra parte, la Diade (il grande/piccolo, cioè l’illimitato che può estendersi verso l’infinitamente grande e
verso l’infinitamente piccolo, sulla base della divisibilità e della moltiplicabilità infinita) viene avvicinata da
Aristotele alla materia/ricettacolo del Timeo.
Nelle Leggi, Platone abbandona l’utopia dello stato ideale: egli dichiara esplicitamente di non voler
delineare la città perfetta, ma che intende esaminare la forma migliore di città-stato, realizzabile nel mondo e
nella storia. La città seconda dovrà essere governata sulla base di una costituzione e mediante un corpo
definito di leggi. La costituzione migliore è identificata nella forma mista, che riassume i vantaggi della
monarchia (l’unità e la concordia), dell’aristocrazia (la saggezza) e della democrazia (la libertà dei cittadini).
Il governo è esercitato, pertanto, da un re, coadiuvato da un senato o consiglio, che a sua volta fa riferimento
all’assemblea del popolo (potere democratico). La maggior parte dei poteri è attribuita a un Consiglio
notturno di saggi (così chiamato perché i saggi che lo costituiscono si riuniscono e deliberano di notte, per
sottrarsi a qualsiasi influenza esterna).
Anche per quanto riguarda il problema della conoscenza, Platone procede a una revisione della sua
dottrina. Nel Teeteto, egli cerca di definire la conoscenza come retta opinione. Nella VII Lettera, poi, propone
un percorso circolare nel processo conoscitivo, procedente dall’immagine (dunque dall’esperienza sensibile) e
confluente nella identificazione della verità, attraverso i passaggi costituiti dalla definizione e dal nome. Questi
diversi elementi sono considerati nel loro reciproco trapassare l’uno nell’altro, cioè nel reciproco integrarsi in
un movimento ininterrotto, che concorre al progressivo perfezionamento della conoscenza stessa, intesa
come progressivo disvelamento della costituzione dell’ente, cioè come avvicinamento alla verità.
In tal modo la filosofia si configura come scienza della verità del mondo, non più come scienza di un
mondo ideale separato da quello sensibile. La scienza ha il compito di esplicitare il significato degli enti
sensibili, in quanto facenti parte dell’ordine dell’universo. Tale ordine, disposto da una mente divina, è il
significato complessivo della realtà, dal quale tutte le cose ricevono senso (verità). L’intelligibilità riguarda la
stessa realtà sensibile e il compito della filosofia consiste nel rivelare progressivamente tale costituzione
razionale e intelligibile.
I principali dialoghi
I Dialoghi di Platone, in quanto rivolti a mettere in evidenza le condizioni di pensabilità (intelligibilità) del reale
considerato nella sua fondamentale struttura unitaria, costituiscono, nel loro insieme e nella loro articolazione, un
sistema organico, in modo che nella problematica di ciascuno si riflette l’unità dell’insieme e in questa medesima si
ripropone l’articolazione di ogni tematica particolare.
I dialoghi socratici
I dialoghi del primo gruppo offrono dei modelli del metodo socratico di indagine filosofica e per lo più si concludono
senza una soluzione positiva dei problemi che in essi si propongono. Ciò forse perché in tal modo emerga la figura di
Socrate maieuta del sapere e non “maestro” alla maniera dei sofisti: Socrate afferma, preliminarmente, di non sapere e di
non potere insegnare nulla; egli si attribuisce la sola facoltà di suscitare l’interesse per il sapere, nella consapevolezza
che ognuno deve percorrere autonomamente la via della ricerca, perché il sapere è una conquista e un possesso interiore
che, come fiamma viva, si alimenta da sé. Dunque questi dialoghi non sono socratici solo perché probabilmente sono i
primi in senso cronologico ma principalmente perché sono dedicati a illustrare il metodo della ricerca filosofica.
L’impostazione della domanda è, infatti, la premessa per filosofare: il filosofo è colui che pone radicalmente la domanda
che avvia e conduce lungo la via della ricerca; egli non cessa mai di domandare e la sua vita stessa diventa un chiedere,
interrogarsi e cercare continuo. Non importa qui la risposta; è, invece, importante l’interrogarsi. Perciò questi dialoghi
sono detti anche “aporetici”.
“Ione”. Ione è un rapsodo che pretende di possedere la divina sapienza poetica. Egli recita versi di Omero,
suggestionando i suoi ascoltatori, ma sa che quella emozione è un artificio cui egli non partecipa. E’ quella
“sapienza”, “scienza”? E’ tecnica d’artista, “techne”? Non può essere sapienza, perché questa semmai
appartiene al poeta, che attinge la poesia delle cose in uno stato di entusiastica unione con l’essere. E non
può essere neppure “arte” (“techne”). L’una e l’altra, infatti, appartengono al poeta, perché innanzitutto
costui, immedesimandosi col dio, riesce a possedere la conoscenza della suprema unità del cosmo (questa
conoscenza della totalità è l’”epistéme”) ed esercitando il particolare mestiere di poeta (comporre versi, fare
poesia, ossia tradurre in attività particolare l’universale sapienza) svolge una “techne” particolare). In questo
dialogo Platone non si limita a porre gli elementi per problematizzare la definizione del rapsodo (mettendo
in rilievo la differenza rispetto al poeta), bensì dà una profonda nozione intorno alla natura della poesia,
indicandola come “divina mania”, esperienza di partecipazione alla sapienza divina e di rivelazione nel
mondo. In questo senso qui troviamo la risposta alla autentica valutazione platonica della poesia e della
funzione del poeta nella città. Indubbiamente nella poesia concorrono i due momenti dell’ispirazione e della
tecnica, dell’intuizione lirica e dell’arte, in una esperienza di sintesi, che è la stessa espressione poetica (le
immagini fantastiche, la musicalità, la riproduzione del ritmo cosmico).182
Ippia minore. Ippia disputa in Olimpia una gara come retore e si dichiara disposto a rispondere a qualsiasi
domanda di Socrate. Perciò costui lo esorta a dimostrare le sue vere conoscenze. “Ora però parlerai di
Achille e di Odisseo: chi dei due è migliore e in quale senso intendi ciò?”. Ippia dichiara Achille migliore id
Odisseo, perché veritiero e semplice. Socrate obietta che anche Achille può dire il falso; ma Ippia rileva che la
falsità di Achille non è immorale, perché è involontaria. Socrate incalza: Odisseo sa anche la verità se
volontariamente dice il falso, Achille invece non sa la verità e perciò è il meno valente. Odisseo sarebbe più
valente. Ma a questa affermazione che implica essere colui che erra volontariamente più buono, Socrate
aggiunge: “se pure un tale esiste”. Infatti per Socrate non può esserci qualcuno che faccia il male
volontariamente: la sapienza si manifesta nel fatto che il saggio non soltanto conosce il bene ma anche lo fa.
Involontariamente infatti non può dire il falso, altrimenti non sarebbe sapiente; e neppure volontariamente,
altrimenti non sarebbe buono e cioè, ancora, sapiente. In questo dialogo Platone espone la dottrina socratica
dell’identità di sapienza e virtù. La sapienza è una condizione totale dell’esistenza, che non riguarda un
sapere teorico ma anche l’agire pratico. La sapienza è condizione di vita morale. Anche se non nella sua
forma pienamente dispiegata di “epistéme”, la sapienza investe l’agire morale e si identifica con esso. La
virtù implica la consapevolezza intorno a ciò che è bene per l’uomo. Odisseo, se dice il falso
volontariamente, cioè se commette azione immorale, non conosce la natura del bene e della virtù.
Critone, Gli amici di Socrate hanno preparato la fuga, ma Socrate decide di obbedire alle leggi, di accettare
la morte, perché non si può disobbedire senza tentare di sovvertire e sgretolare l’ordine dello stato. Mentre è
ancora notte, Critone è riuscito a entrare nella cella di Socrate, poiché gli è stato annunciato l’arrivo della
nave sacra ed è l’ora estrema per la salvezza. Si siede sulla sponda del letto, non vendo il coraggio di
interrompere il sonno sereno dell’amico. All’alba Socrate si sveglia. Il dialogo culmina nell’immaginario
intervento delle Leggi, che rimproverano a Socrate la sua disubbidienza. I “Nomoi”, in questa visione di
Socrate, sono l’anima dello stato, non sono semplicemente le leggi particolari; rappresentano il fondamento
dei costumi, qualcosa come un legame sacro tra i cittadini, che salda gli uomini al passato e li fa vivere
ordinati in comunità. Essi sono il legame della tradizione, appartengono alle origini della comunità, sono
come il “fondamento”, le “aitiai”, perciò in qualche modo sacre, i numi della patria. In realtà Socrate intende
rinnovare la vita di Atene rinnovando nell’intimo la coscienza degli Ateniesi: fuggire non vorrebbe dire
nulla, nessun valore avrebbe quella fuga, sarebbe un comportamento banale, che per di più minerebbe la
saldezza delle leggi. Socrate invece accetta la morte per mostrare la saldezza formidabile della sua fede e
della sua visione del mondo. Come dice Eraclito, infatti, “il popolo deve lottare per il suo ‘nomos’ come per
le sue maura” (fr. 44), e “tutti i ‘nomoi’ traggono il loro fondamento da un unico principio divino” (fr. 143).183
182
Troviamo qui, pertanto, una significativa anticipazione della nozione elaborata da Benedetto Croce della poesia
come “intuizione lirica”, sintesi di intuizione ed espressione. Forse Platone va al di là dello stesso Croce, in quanto
rivaluta il momento “tecnico”, ossia il possesso di quelle competenze specifiche che consentono di intrecciare valori
musicali e fantastici, profondità di senso e rimando simbolico, e così via, sulla base del possesso di ciò che si può
indicare in breve come “arte della parola”. Platone mostra di avere presenti i molteplici elementi che concorrono
nell’attività poetica e di conoscere le modalità del loro fondersi nello sviluppo della poesia.
183
Come è stato osservato, “i ‘nomoi’ significano qui non la rigida forma della costituzione, accidentalmente vigente,
ma la durevole forma della vita dello Stato, che può manifestarsi in mutevoli costituzioni” (K. Hindebrandt, Platone, tr.
it., Einaudi, p. 87). Il Critone esprime dunque un concetto dinamico della legge: la legge è la costituzione come
fondamento dello Stato, ma è la costituzione vivente, che si trasforma assieme alla realizzazione della vita morale, al
farsi della realtà umana. Socrate ha la consapevolezza di vivere nell’ordine delle leggi, ma sente l’esigenza di porre nel
cuore delle leggi stesse una spinta alla trasformazione e al rinnovamento attraverso la persuasione. Sottrarsi alla legge
significherebbe negare la realtà della legge stessa, abbandonare la legge a se stessa, trascurando l’esigenza della sua
trasformazione per la costituzione di un nuovo modello di comunità, maggiormente conforme a giustizia. Socrate,
accettando la morte, intende porsi all’interno della legge, per fare emergere i suoi limiti e per accendere in essa una
prepotente esigenza di rinnovamento. Dopo quella morte la città sarebbe uscita nuova e vivificata da uno straordinario
bisogno di giustizia. La città ideale si profilava all’orizzonte e l’erede di Socrate, Platone, avrebbe dedicato tutta la sua
riflessione a disegnarne il profilo, ponendolo come modello utopico per ogni forma di umana “koinonia”.
Lachete. Socrate è il maestro impareggiabile: ma in quale senso egli è “maestro”? I personaggi di questo
dialogo sono Nicia (che allora aveva il potere politico nella città) e il suo amico Lachete. Essi si lamentano
che i loro padri (Aristide, Tucidide) non abbiano saputo educarli. Ora cercano un educatore per i loro figli e
parlano a questo proposito di un maestro di scherma che pensano potrebbe essere adatto. Interviene Socrate
osservando che non si deve fare consistere l’educazione con l’insegnamento di particolari tecniche, poiché la
formazione della persona implica l’impegno di un processo totale, per cui l’educatore deve essere un vero
conoscitore dell’anima. L’educazione è specialmente svolgimento interiore nel senso dell’acquisizione della
virtù. Bisogna dunque vedere in che consiste la virtù. Ammesso che l’educatore sia uomo d’arme, egli
conoscerà una parte della virtù, il coraggio. Ma bisogna chiedersi cos’è il coraggio. Interviene Nicia, dicendo
che, come la virtù consiste nella conoscenza, anche il coraggio sarà conoscenza, precisamente la conoscenza
di ciò che si deve temere e di ciò che non si deve temere. E’ una conoscenza parziale, dunque, che non
abbraccia una totalità; non è vera conoscenza. Il dialogo si conclude con l’osservazione socratica che
l’educazione riguarda la totalità dell’individuo e che il presupposto per poterla mettere in atto è la conoscenza della
virtù nella sua unità e totalità.
Carmide. Socrate ritorna ad Atene dall’assedio invernale di Potidea (431-430) e va ai luoghi consueti ove
soleva intrecciare le sue conversazioni; entra in una palestra e gli viene incontro Cherefonte, che lo conduce
dinnanzi a Crizia e altri amici, i quali lo interrogano sulle vicende dell’ultima sanguinosa battaglia. Socrate
risponde e poi domanda “quale sia attualmente la condizione della filosofia e dei giovani: se alcuni tra loro
si siano distinti particolarmente per sapienza e per bellezza o per entrambe le cose insieme”. Questa
connessione di sapienza e bellezza è il motivo intorno al quale si svolge il dialogo. Per la bellezza si
distingue, ad esempio, Carmide (zio di Platone), il quale sembra anche “cresciuto nell’anima”. In lui, cioè, la
bellezza del corpo si fonde con la virtù. La bellezza corporea è qui inserita nel processo del filosofare. Che
rapporto ha essa con la ricerca della verità? Bisogna considerare la verità come calata nella forma delle cose.
In quanto belle, le cose sono manifestazioni corporee della verità. Dalla contemplazione della bellezza,
l’anima spicca il suo volo dialettico verso le idee e attua la conoscenza. Ma l’oggetto della conoscenza (in
quanto saggezza, assennatezza) è il bene. Così è chiarito il nesso tra bellezza e virtù. Carmide è in qualche
modo il simbolo dell’unità di bellezza e verità, di forma e realtà, di saggezza e virtù.
Liside. Questo dialogo è dedicato all’amicizia e si svolge tra quattro interlocutori e Socrate: Ctesippo e
Ippotale sono i giovani innamorati, Liside e Menesseno i due fanciulli. Socrate, partendo da quella passione
erotica, spiega il significato dell’amicizia. Il fondamento dell’amicizia è posto qui nell’avvertimento di una
mancanza che si tende a colmare. Poiché l’anima è aspirazione al bene, essa è spinta da Eros verso ciò che
ancora non possiede. E questa spinta si rivolge in primo luogo verso qualcuno in cui si cerca ciò che non si
ha. L’amicizia, dunque, è il completamento di una deficienza, l’appagamento di un’aspirazione: colui che
cerca il bene e ne scorge i riflessi in un altro allora tende verso di questo con un trasporto di amore/amicizia,
per partecipare egli stesso a quel bene che vede nell’altro. Infatti l’amicizia instaura un rapporto di
comunione, per cui ciò che è dell’altro chi ama sente come proprio. E’ preannunciato qui il mito di
Aristofane nel Convito.
Eutifrone. Eutifrone è sacerdote e indovino, che però predice una cosa che si mostrerà falsa: il buon esito
del processo contro Socrate. Qui si ricerca l’essenza della religiosità. La religiosità, spiega Socrate, non è una
virtù autonoma, perché fa parte della giustizia. Virtù autonome rimangono le quattro classiche virtù
platoniche: sapienza, giustizia, temperanza, coraggio. Eutifrone afferma che è religioso ciò che è caro agli
dèi. Ma prima bisogna vedere se ciò che è caro agli dèi è giusto; se è giusto si può dire che è caro agli dèi. La
religiosità non è il culto esteriore, l’offerta delle vittime, ma la conoscenza del bene e l’esercizio della virtù.
Contro la religione tradizionale e il vecchio culto degli dèi, Socrate propugna qui un nuovo ordine della fede
religiosa, compreso nell’unità della giustizia che coincide con lo stesso ordine cosmico. Religioso è solo ciò
che si accorda con tale ordine, ciò che rientra nei confini della giustizia.
Protagora. Ippocrate si reca da Socrate perché vuole essere presentato a Protagora, che intende scegliere
come maestro di sofistica. Socrate invece vuole accendere in Ippocrate un’ansia nuova e lo fa discutendo con
Protagora, in modo da fare risaltare l’inutilità dell’insegnamento dei sofisti. Socrate e Ippocrate vanno a
trovare il celebre sofista nella casa del ricco Callia, dove Protagora tiene i suoi discorsi a una schiera di
ammiratori. Il dialogo è interessante in quanto espone alcune tesi fondamentali del sofista e concorre a
chiarire punti altrimenti problematici. Un primo chiarimento riguarda la concezione protagorea del
“discorso migliore”, che va perseguito in confronto dell’opposto “discorso peggiore”. Dunque si conferma il
relativismo (espresso nella celebre proposizione dell’uomo misura di tutte le cose), con l’esclusione di un
discorso (“logos”) proprio della conoscenza vera. Non esiste una via per raggiungere e per esporre la verità:
esistono discorsi più o meno persuasivi; e quelli che meglio persuadono e convincono sono quelli preferibili,
poiché si tratta di esercitare un influsso nella vita della città, convincendo i cittadini a scegliere ciò che risulta
più vantaggioso e conveniente. Il discorso migliore è quello che può essere adottato da un maggior numero
di persone: dunque l’educazione sofistica è utile specialmente nei regimi democratici, dove le maggioranze
concorrono al governo delle città. Un altro celebre motivo riguarda lo sviluppo della civiltà. Protagora
espone a questo proposito un celebre mito, riguardante la fondazione dell’ordine civile da parte di Zeus. Il
sovrano degli dèi, sollecito del bene dell’umanità, ha mandato tra gli uomini divini artefici che insegnassero
le arti e le tecniche proprie dello sviluppo della civiltà. Ma, nonostante il progresso tecnico, gli uomini non
riuscivano a fondare comunità stabili e pacifiche. Zeus allora mandò tra gli uomini le principali virtù: il
timore degli dèi, principio della religiosità, e la saggezza, basata sul riconoscimento di ciò che è utile alla
concordia civile. Questo mito serviva a mettere in rilievo che l’insegnamento delle tecniche non costituisce il
nucleo dell’educazione, poiché questa deve comprendere specialmente l’esercizio delle virtù; ed è, pertanto,
la saggezza che va principalmente insegnata (a patto che si possa insegnare; e il sofista sostiene che è
possibile tale insegnamento, mentre Socrate tende a rilevare come l’acquisizione della virtù consista in un
processo interiore, di formazione dell’anima e della coscienza).
Eutidemo. Socrate/Platone condanna il metodo dialettico quando viene esercitato come fine a se stesso con
lo scopo di confondere e stupire l’interlocutore, allorché la distinzione dei concetti diventa un puro giuoco
sofistico. Questa è l’eristica, puro giuoco verbale, senza serio contenuto.
Il “Fedro”
Schleiermacher vedeva nel Fedro l’enunciazione programmatica di una “paideia” che Platone avrebbe
perseguito in tutta la sua opera. In realtà, il dialogo contiene “la più rapida sintesi delle idee di Platone sul
rapporto di scrittura, parola e pensiero”.184 Il che, certo, non consente di considerare il dialogo come
giovanile: anzi il posto che in essa occupa la discussione sulla dialettica lo avvicina a quelli del periodo
“critico” del pensiero platonico.
Il Fedro comprende due motivi fondamentali: i discorsi su Eros nella prima parte e l’elogio del metodo
platonico della dialettica nella seconda. La sua unità tematica consiste nel fatto che esso discute, in entrambe
le parti, il problema della retorica.
Nella prima parte, questo problema è affrontato attraverso alcune esemplificazioni: la lettura e la critica di
un discorso di Lisia, allora considerato il capo della più seguita scuola ateniese di oratoria; lo sviluppo di
altri due discorsi sulla stesso tema (la virtù di Eros), da parte di Socrate, il quale intende dimostrare come
veramente si dovrebbe parlare del dio, una volta conosciutane la vera natura.
Nella seconda parte, sono messi in rilievo i limiti della retorica e i pregi del metodo dialettico, come mezzo
di una vera retorica.
Sia la prima che la seconda parte si aprono con una critica di Lisia, mentre il dialogo si conclude con
l’augurio che il giovane Isocrate possa apportare un rinnovamento nella retorica. Platone appare qui
impegnato a inquadrare il problema della retorica e dei suoi rapporti con la filosofia e a tracciare le linee
programmatiche di una nuova retorica, non più aliena dalla filosofia, ma strettamente congiunta e alleata di essa. La
svolta che Isocrate stava imprimendo nello svolgimento della retorica appariva come un segno promettente.
In questo senso il Fedro sta a indicare un nuovo atteggiamento di Platone nei confronti della retorica: mentre
nel Gorgia questa è condannata e la filosofia è radicalmente opposta ad essa, qui il problema della componente retorica
del discorso filosofico è affrontato esplicitamente. Platone, cioè, perviene a riconoscere che la retorica riguarda la
tecnica di ogni discorso, cioè i requisiti di eleganza, di concisione e di armonia che devono essere presenti
anche nelle esposizioni di filosofia. Se da una parte il discorso va costruito sulla base di sicuri e chiari
elementi concettuali, d’altra parte esso non può prescindere da alcune regole del metodo compositivo. La
vera paideia è vista come sintesi di retorica e dialettica.
La presentazione del discorso di Lisia su Eros e la relativa discussione stanno a indicare come lo stesso
contenuto del discorso risulta inadeguato, allorché manca l’apporto della dialettica. La tesi di Lisia è che per l’amato
è meglio acconsentire a un amico che non sia soggiogato da Eros, ma conservi sangue freddo e padronanza
di sé. Un tale amico, infatti, non è agitato dalla tempesta della passione e rimane immune da sentimenti che
potrebbero provocare danno, come la gelosia, in conseguenza di cui l’amante esige isolare l’amato da ogni
rapporto con altri.
Socrate porta il discorso preliminarmente sulla distinzione logica tra i vari generi di desiderio, avanzando
così la definizione dell’amante come di un uomo che preferisce il piacere dei sensi al Bene e che, quindi, è
tutto proteso a soddisfare il suo desiderio, senza curarsi del perfezionamento fisico e spirituale dell’amato.
Un tale amante è egoista, geloso, invidioso, dispotico. Poiché all’amante non interessa nulla del bene
184
W. Jaeger, Paideia, III, p. 315.
spirituale dell’amato, egli, non curandosi dell’anima di costui, lo tiene il più possibile lontano dalla filosofia.
Invece l’amore, come Platone ha dimostrato nel Simposio, è spirito educativo, che innalza l’anima verso la
contemplazione della verità.
Perciò di questo Eros educatore bisogna parlare: ed è proprio ciò che Socrate fa nel secondo discorso, dove
si parla della vera natura del dio, che è capace di possedere l’anima con l’entusiasmo, che è unicamente
ricerca del vero, del bello, del buono. Eros è il dio che innalza l’anima, riportandola alla sua sede originaria.
L’anima, simbolicamente raffigurata nella biga alata, così diventa capace di spiccare il volo verso il mondo delle idee.
Eros è, dunque, colui che dà le ali all’anima (o che dà vigore alle ali dell’anima), che così si innalza sopra il cielo, dove
torna a contemplare l’essere immutabile.
Nella seconda parte, si ha la discussione vera e propria sulla natura della retorica e sui rapporti tra la retorica e la
filosofia. Platone mette in rilievo la fondamentale dipendenza della retorica dalla dialettica. Il metodo dialettico,
basato sulla partizione concettuale e sulla sintesi, costituisce la condizione di ogni discorso bene organizzato come un
tutto sistematico e coerente.
Platone mette, poi, in rilievo un atro aspetto dell’oratoria: il compito di persuadere, dunque di agire sulle
anime, la funzione psicagogica. E come il buon medico deve conoscere la struttura del corpo (che è modellato
sulla struttura cosmica dell’universo), così il buon oratore deve considerare la natura dell’anima nella sua
completezza, nell’insieme dei suoi moti e delle forze che urgono in essa. Infatti determinati moduli retorici
corrispondono a determinati atteggiamenti e moti dell’anima. Il tema della retorica, così, viene riportato a
quello più generale della paideia politica.
Lo stesso tema rimanda al problema dell’opera letteraria, che, a sua volta, implica l’esame del valore che è
da attribuire, in generale, a ogni discorso scritto. La scrittura è indubbiamente il dono di un dio, l’egizio
Teuth; ma essa non per questo è aliena da pericoli, poiché, come già obiettava il re di Tebe, Thamus, al quale
quel dio venne a offrire la sua meravigliosa invenzione, in essa si nasconde un’insidia, il progressivo
indebolimento della memoria. Gli uomini, affidandosi alla parola scritta, via via avrebbero perduto la memoria viva
delle cose e avrebbero posto un’apparenza di sapere al posto del sapere vero, alimentato dall’esercizio dell’intelletto e
della memoria. La funzione della scrittura, conclude Platone, è quella di aiutare a ricordare ciò che già si sa.
Il “Gorgia”
Nel Gorgia la discussione sulla retorica è sostenuta da quattro personaggi: Gorgia, Callicle, Polo, da una
parte, e Socrate, che controbatte le loro argomentazioni.185
Il dialogo si articola in quattro momenti: 1) Socrate e Gorgia: si ricerca una definizione della retorica, attraverso
la determinazione del compito e della funzione propri di questa disciplina; una conclusione provvisoria è
che la retorica è un’attività volta alla persuasione, che non ha obiettivi scientifici e dunque è indifferente riguardo
al problema della distinzione tra vero e falso; la retorica, cioè, ha lo scopo di produrre opinione e credenza,
secondo criteri che non sono quelli della scienza, ma che rispondono a condizioni di opportunità pratica e
politica; 2) Socrate e Polo: si conclude che la retorica non è un’arte fondata sulla conoscenza del vero; 3) Socrate
e Callicle: si deduce che la retorica rientrerebbe nelle finalità positive dell’uomo se il piacere fosse il vero
bene; ma Socrate dimostra che il piacere è ingannatore nella vita presente e in quella futura; 4) Socrate
sviluppa le sue argomentazioni sulla vita futura.
Dunque vi si intrecciano tre argomenti: la retorica, la morale, la dottrina intorno alla vita futura e al
destino dell’anima dopo la morte. Il motivo fondamentale (che è anche il legame tra questi argomenti) è
quello che riguarda la natura e la funzione della retorica: questa è considerata nel suo valore per la felicità
dell’uomo; e questo valore dipende essenzialmente, secondo Platone, dalla soluzione del problema del
destino dell’anima, cioè della vera natura e del vero fine dell’uomo.
Se la retorica produce unicamente persuasione e non scienza e se essa è indifferente intorno al problema
del vero e del falso, bisogna d’altra parte considerare le circostanze in cui una tale espressione culturale
risulta giustificata: vi sono, infatti, circostanze in cui occorre prendere una decisione immediata e necessaria,
e in tal caso la persuasione gioca un ruolo importante, in quanto non c’è il tempo per accertare il vero e
bisogna accontentarsi del verosimile; e lo stesso filosofo, allorché deve agire, per non rinunciare all’azione,
185
Sulla base di alcuni riferimenti storici, la scena del Gorgia si può fare risalire intorno al 405. Infatti, nel dialogo si allude alla
morte di Pericle, avvenuta nel 429; e Gorgia venne ad Atene la prima volta nel 427 come ambasciatore di Lentini; Archelao, tiranno
di Macedonia, di cui Polo vanta la felicità nonostante l’ingiustizia, prese il potere nel 413; infine, l’Antiope di Euripide, alla quale si
fa allusione, fu rappresentata negli ultimi anni della guerra del Peloponneso. Per la data di composizione, si ritiene che questo dialogo
sia pressoché contemporaneo del Protagora e che entrambi appartengano agli anni che seguirono il ritorno di Platone ad Atene dopo
i suoi grandi viaggi, cioè nel periodo compreso tra il 395 e il 390 circa.
deve pur prendere una decisione e correre qualche rischio. La persuasione, in tal caso, può riuscire
opportuna, così come, in molti casi, l’opinione vera, ispirata o no da una qualche specie di intuizione divina,
è il solo strumento di cui dispone l’intelligenza pratica, impegnata nell’azione. Queste sono le
argomentazioni condotte da Gorgia e Polo.
Callicle, da parte sua, in coerenza con l’indirizzo della politica ateniese del tempo, considera la retorica
come lo strumento di cui si servono legittimamente gli individui che, per capacità e doti personali, sono
destinati a governare; ed egli individua tali doti nell’intelligenza e nel coraggio: i più intelligenti e i più
coraggiosi è giusto che comandino e si servano della retorica per imporre il loro punto di vista alla
moltitudine. E’ questa una tesi che prescinde da ogni preoccupazione morale.
Invece è proprio per quest’uso politico che Socrate condanna la retorica: essa non aiuta gli uomini a ricercare il
vero scopo della loro vita e a vivere secondo questo fine. Invece la filosofia si propone di definire ciò che all’uomo
assicura la felicità in questa vita e dopo la morte. Essa è una specie di religione: non un insieme di riti e
credenze, legato alla tradizione di un popolo e perciò relativo, ma lo stesso legame dell’uomo con la verità.
La retorica, che prescinde dall’accertamento del vero, è l’opposto della filosofia. Platone combatte la retorica
specialmente sul terreno politico, in rapporto alle conseguenze che ha sulla vita della città una dottrina che
non si propone come suo scopo la scoperta del vero, ma si presenta come uno strumento che assicura il
potere ai “più forti”, sia pure intesi come più intelligenti e più coraggiosi.
Platone tiene presente la situazione politica di Atene e trae tutte le conseguenze intorno al giudizio da
esprimere sugli uomini politici che ne hanno retto le sorti. Questi hanno in realtà alimentato gli istinti
bellicisti del popolo, perseguendo disegni di espansione imperialistica; invece avrebbero dovuto “educare” il
popolo alla giustizia e alla temperanza.
L’obiettivo del filosofo è la definizione della giustizia. Infatti il compito dell’uomo, in assoluto, è di cercare
di attuare la vita giusta nella dimensione del suo essere e in quella della società.186 Questo compito è
qualcosa che riguarda l’uomo nel suo essere proprio. Perciò Socrate qui parla della vita dell’uomo giusto in
questa vita e, poi, mediante un mito, del destino riservato dopo la morte.187 L’indagine filosofica qui si unisce
alla fede religiosa e l’unica retorica che viene giustificata è quella messa al servizio della verità: poiché la
retorica ha il compito di rendere accessibili a tutti le verità più ardue e profonde. Solo il filosofo, ovviamente, può
fare un tale uso della retorica. Negli altri casi, la retorica serve ad assecondare le basse passioni.
Il “Menone”
Il Menone è una pietra miliare nello svolgimento del pensiero di Platone: in esso è posto il problema
metafisico dell’essere dell’ente e della sua conoscibilità. Dunque è posto il problema della verità.
Il pretesto del dialogo è il problema della virtù, ripetutamente ricorrente nei dialoghi socratici. Menone
vuole vedere se la virtù possa essere insegnata: se nasca naturalmente nell’uomo o se è il risultato di un
lungo esercizio, in ogni modo come possa essere raggiunta.
L’esordio di Socrate è una confessione di estrema difficoltà: “sono povero” egli dice, alludendo a una
situazione d’esistenza particolare, caratterizzata non solo dall’assenza di un determinato sapere bensì da una
mancanza più radicale che riguarda il modo d’essere. Socrate dice d’essere povero non tanto nel senso che
egli “non ha” ma soprattutto nel senso che egli “non è”. L’essere povero è una condizione di non
partecipazione alla verità: indica il non essere (o trovarsi) nella luce della verità, nella trasparenza dell’essere.
Socrate non sa nulla della virtù e si tratta di vedere come si possa passare al possesso di qualcosa di cui si è
mancanti. Egli, tuttavia, gioca quella carta della consapevolezza di non sapere che è il tratto distintivo della
sua condizione di filosofo. Bisogna partire da quella consapevolezza per potere conseguire qualsiasi
conoscenza. Socrate non solo non sa “che cosa” (l’essere dell’ente) è la virtù, ma non ha mai incontrato
qualcuno che lo sapesse. Menone invece crede di essere al sicuro per quanto riguarda il “che cosa”; il suo
problema è un altro, se la virtù (già per lui determinata) sia insegnabile e come. Ma quella presunta sicurezza
si basa su un equivoco: egli infatti distingue la virtù dell’uomo, della donna, del fanciullo, del vecchio e così
via. Di quale virtù intende parlare Socrate? Di quella dell’uomo? Essa è la capacità di fare vita politica,
beneficando gli amici, danneggiando i nemici, procurando in ogni modo di non averne danno. Socrate mette
in rilievo l’equivoco. Supponiamo che si ponga il problema di “che cosa sia” l’ape. Si dice qualcosa intorno
alla “essenza” dell’ape, dicendo che le api sono molte e di molte specie?Bisogna porre il problema di ciò per
186
La giustizia è il fondamento della legalità secondo cui è ordinata la vita umana. “Chi se ne intende dice, o Callicle, che cielo,
terra, dèi, uomini, sono collegati in un tutto grazie all’unione, all’amicizia, all’armonia, alla temperanza, alla giustizia, e che per tale
ragione questo tutto è chiamato cosmo (ordine), e non acosmia (disordine) e dissolutezza” (Gorgia, 507 e).
187
Secondo il mito esposto da Socrate, le anime si presentano nude al giudizio finale, coi segni delle malattie che le hanno
contaminate, in modo che nessuna possa sfuggire alla pena.
cui le api sono tutte uguali, del loro essere identico. Analogamente la salute dell’uomo è diversa da quella
della donna, oppure esiste una medesima salute per l’uomo e la donna? Appare chiaro che la salute è sempre
“la stessa”, che, dunque, c’è sempre e in ogni caso un medesimo aspetto, una “idea”, della salute, per cui
essa si distingue dalla malattia. Il problema è quello dell’essenza, dell’”eidos” delle cose. Che cos’è l’”eidos”
(idea)? E’ ciò per cui le cose sono quelle che sono, ciò per cui tante cose sono identiche, cioè hanno un solo
determinato modo d’essere complessivo.
Menone non ha ancora compreso il senso dell’eidos: interrogato ancora da Socrate sul “che cosa” della
virtù, risponde che il carattere comune delle virtù si può indicare come la “capacità di dominare gli uomini”
(73 d). Allora forse è questo il carattere della virtù dello schiavo? Menone non ha afferrato ancora
quell’identità, quell’uno, per cui la virtù è una sola cosa in ogni circostanza in cui essa si riscontra. Così infine
egli si arrende, confessa di essere assolutamente fuori strada. Che cos’è dunque l’idea? Come possiamo
coglierla? Il sofista è turbato: abituato a tenere discorsi su ogni argomento, ora non riesce a definire la virtù.
Egli “non sa più nulla” ed è “pieno di perplessità” (80 a). Infine crede di mettere Socrate con le spalle al
muro, domandando: in che modo ricercherai ciò che non conosci affatto? Quale delle cose ignorate ti
proporrai di ricercare? E se ti capitasse di incontrarla come “saprai”, come riconoscerai che è ciò che tu non
conosci? Qui Platone si trova dinnanzi a un problema di straordinaria portata: egli deve mostrare la
fondamentale “parentela” dell’anima e dell’essere, dell’anima e della verità, deve spiegare un fatto
primordiale (dunque appartenente alla sfera del mito), una situazione originaria dell’anima, per cui questa
reca in se stessa la verità. Si tratta di una condizione cosmica originaria, di qualcosa che più che alla ragione
appartiene al mistero e che perciò Socrate espone con un mito. Dice Socrate: “Ho sentito da uomini e donne
sapienti delle cose più alte, divine […]. Costoro erano sacerdoti e sacerdotesse: “di quelli ai quali stava a
cuore di dare ragione delle cose e del loro mistero” (81 a). Essi dicono che l’anima è immortale, che muore e
rinasce eternamente. Platone ha preso contatto nel suo viaggio in Sicilia con i pitagorici, rafforzando il suo
sentimento religioso e la sua tendenza a valutare gli elementi dell’orfismo, soprattutto la dottrina della
trasmigrazione delle anime. Quegli elementi Platone rifonde nel suo pensiero, in quella unità del filosofare
che comprende anche il sentimento e la fede religiosa. Poiché l’anima è immortale, continua Socrate,ed è più
volte rinata, avendo visto il mondo di qua e quello degli inferi, non vi è nulla che non abbia imparato (81 c).
L’anima, avendo visto tutto, ha in sé la conoscenza di tutte le cose: una conoscenza che essa deve
semplicemente riscoprire, cercandola in se stessa. Ne consegue che conoscere è ricordare. E ciò è possibile in
virtù della fondamentale affinità e connessione tra l’anima e il cosmo.
Per dimostrare che il sapere è un possesso originario dell’anima e che è il frutto di un processo di
rimemorazione (reminiscenza), attraverso il quale viene riportato alla luce ciò che era sepolto nell’oblìo,
Platone introduce un colloquio tra Socrate e lo schiavo di Menone, in cui costui deve dimostrare onde deriva
il suo sapere, se gli è comunicato dall’esterno o se egli lo trova all’interno di sé, ossia se egli impara o ricorda.
Si tratta di risolvere un problema di geometria, di trovare il quadrato la cui superficie sia doppia di un
quadrato dato. Lo schiavo risponde che questo quadrato che si cerca è quello che ha il lato doppio del
quadrato dato. Ma si vede subito dalla figura che così si ottiene un quadrato quadruplo. Lo schiavo intuisce
quindi di colpo che il quadrato che si cerca è quello costruito sulla diagonale del primo quadrato. Egli
“vede” la verità sorgere nella sua mente, perché in realtà in sé reca, dimenticato, quel sapere che ora
recupera in presenza di condizioni favorevoli alla ricerca.
Il “Fedone”
Nel Menone è già interamente enunciata l’idea dell’essere: l’essere è la totalità originaria e
immutabile che nella sua struttura formale (eidetica, ideale) si rivela all’anima che di quella
struttura fa parte e perciò è immortale. Perché l’anima è immortale? Perché essa è la facoltà delle
idee e queste indicano le essenze delle cose, immutabili ed eterne. Il Fedone svolge il tema
dell’immortalità dell’anima, approfondendolo nell’orizzonte della problematica della manifestazione
dell’essere. Il dialogo si svolge al termine della vita di Socrate, poco prima che questi beva il veleno
mortale nella cella del carcere. Com’era Socrate, chiede Echecrate all’amico Fedone, il giorno in
cui bevve il farmaco e come morì? E Fedone racconta. Quando Socrate venne sciolto dalla catena,
si sedè sul lettuccio e, stropicciandosi la gamba indolenzita, pensò come quel dolore fosse
accompagnato da uno strano piacere, come se due esseri così dissimili stessero sempre l’uno
accanto all’altro, dando luogo a una situazione curiosa che avrebbe dato ad Esopo lo spunto per
qualche favola. A proposito, chiede Cebète, perché in questi ultimi tempi ti sei dedicato a
musicare favole di Esopo e un canto ad Apollo?Socrate spiega che una volta, anzi più volte, gli è
apparso un sogno in cui qualcuno lo esortava a comporre musica. Egli pensava che filosofare
equivalesse a poetare e a far musica, ma infine preso dal dubbio si è messo a musicare in modo
vero e proprio. Infatti poetare e far musica è esortare e persuadere, è incantare l’anima (77 e),
filosofare. Incomincia ad apparire l’immagine dell’anima come qualcosa che ha in sé una facoltà
divina, la facoltà dell’incanto e della persuasione: e Socrate ne è la figura vivente, l’immagine
dell’anima che distende il suo canto, e quel canto è una manifestazione di gioia, come il canto dei
cigni che prima di morire elevano, appunto, il loro canto più lungo e più bello.188 Socrate è sereno
davanti alla morte, anzi proprio al punto di morire coglie l’occasione per il suo canto più bello.
L’anima sa che è giunto il momento di sciogliersi dalle catene del corpo: chiusa, infatti, essa è nel
carcere corporeo e, in mancanza della luce, non vede l’essenza delle cose, la trasparenza
dell’essere (la verità). Bisogna perciò considerare la morte come una liberazione, per cui l’anima,
senza gli impedimenti corporei, potrà tornare a contemplare l’essere degli enti, recuperando quella
conoscenza originaria che essa ha perduto incarnandosi e facendo esperienza del mondo per via
dei sensi. L’anima, in realtà, durante la permanenza nella condizione mondana conserva un vago
ricordo di quella conoscenza e tende a riconquistarla attraverso la ricerca e la riflessione filosofica;
ma non riuscirà a recuperare interamente quella trasparenza che era propria della condizione
originaria e solo col suo ritorno alla libertà potrà dirsi pienamente consapevole di ciò che è la
realtà di tutte le cose. Perciò il filosofo attende la morte e saluta con gioia il suo arrivo.
Il discorso di Socrate suppone l’immortalità dell’anima. Bisogna dimostrare questa
immortalità, osserva Cebète. Due punti devono essere dimostrati: che l’anima, staccandosi dal
corpo, non si disperde e vanisce come soffio o fumo; e che conserva potere e intelligenza. Per
dimostrare il primo punto è introdotto l’argomento dei “contrari” (antapodosis), secondo cui esiste
un eterno ricorso di elementi contrari, il dolore e la gioia, il caldo e il freddo, il sonno e la veglia, la
vita e la morte. Dalla morte si genera la vita, e la vita non può generarsi se non da una condizione
che sia anch’essa vita, perché l’essere non può scaturire dal non-essere; l’anima perciò è sempre
vita. Questo argomento si concilia con un certo “antico discorso” (palaios logos), un’antica
credenza orfica, per cui “nell’Ade sono le anime degli uomini morti” (70 e). Dunque l’anima è
immortale: Ma non solo: essa reca in sé la conoscenza vera che riguarda le essenze immutabili.
Infatti noi diciamo delle cose che in sé sono belle, buone: pensiamo perciò la bellezza, la bontà, e
così via tutte le idee. Né queste cose vediamo con gli occhi. Allora come abbiamo di esse nozione?
Perché la conoscenza è per l’anima un ricordare: conosciamo quelle essenze perché le ricordiamo.
Per esempio, noi vediamo due pietre uguali, due legni uguali: come noi potremmo dire che sono
uguali se non avessimo in noi la nozione dell’eguaglianza, dell’eguale in sé. Questa nozione noi
non ricaviamo dai sensi, perciò la possediamo da sempre, da prima che cominciamo a vedere e
sentire, cioè prima di nascere. Libera dal corpo, l’anima ha quella conoscenza; quando s’incarna
perde il possesso della verità, per riconquistarlo di nuovo, in un processo che ha fine solo con la
definitiva liberazione dal circolo della morte e della rinascita. Le anime libere da ogni impurità,
infatti, ritornano al luogo originario dal quale sono partite per intraprendere il viaggio nel mondo.
Tuttavia l’argomento della reminiscenza non rende compiuta la dimostrazione dell’immortalità
dell’anima. Il fatto che l’anima abbia conosciuto le idee prima della nascita corporea non dimostra
che essa debba continuare a conoscerle dopo la morte. Occorre perciò una dimostrazione che
segua dalla natura stessa dell’anima. Ritorniamo, dice Socrate, alle idee, alla bellezza in sé, alla
bontà in sé, e così via. E’ chiaro che le idee sono immutabili e indivenibili, non soggette a
trasformazione alcuna, mentre sono le cose soggette a mutamento: queste ultime noi percepiamo
coi sensi, mentre le idee sono oggetto dell’intelletto. Esiste dunque un mondo sensibile delle cose,
soggetto al divenire, e un mondo intelligibile delle idee, non divenibile. A quale di questi due
mondi appartiene l’anima? E’ evidente che essa appartiene al mondo immutabile delle essenze:
dunque è immutabile ed eterna al pari delle idee. Con questo terzo argomento, della somiglianza,
può dirsi conclusa la serie delle prove dell’immortalità dell’anima.
Così termina la prima parte del dialogo.Ora nella stanzetta c’è un silenzio stupito. In un angolo
Scimmia e Cebète parlano tra loro. - Che c’è?- chiede allora Socrate – Esponete liberamente i
vostri dubbi. - Scimmia paragona il rapporto tra anima e corpo a quello tra armonia e lira:
quando le corde della lira si spezzano, anche l’armonia si dissolve: così sembra doversi dire
188
“E gli uomini, per la paura che hanno della morte, dicono il falso anche dei cigni; e dicono che, cantando essi il
loro canto di morte, così cantano appunto per il dolore della morte: e non pensano che nessun uccello canta quando ha
fame o freddo o altro male patisce; neanche l’usignolo né la rondine né l’upupa, che pur sono gli uccelli dei quali si dice
che cantino per dolore, né i cigni; e anzi questi, credo, come sacri ad Apollo, sono indovini, e presentendo quali beni
troveranno nell’Ade, cantano in quel giorno e fanno allegrezza assai più che negli altri giorni. Ora anch’io credo di
essere compagno di servizio coi cigni e sacro al medesimo dio, e di avere avuto dal dio signore non meno di loro l’arte
della divinazione; e perciò anche credo di potermi partire dalla vita con non minore letizia” (84 sgg.).
dell’anima. Socrate osserva che l’anima non può essere considerata come un accordo di elementi
diversi di cui si compone il corpo, perché un tale accordo non potrebbe esistere prima degli
elementi stessi. Inoltre, è accordo anche l’anima malvagia? Non possiamo dire che l’anima trista è
scordata, se l’anima per se stessa è accordo. Cebète solleva un’obiezione più profonda: per il fatto
che l’anima conosce le idee non deriva che debba esse necessariamente simile (o della stessa
natura) ad esse. Le idee sono le essenze, i fondamenti per cui le cose sono, diverse dalle “cause” o
dai principi naturali di cui parlavano i fisici antichi. Se l’anima ha in sé le idee, partecipa della
natura di esse. Ms se una cosa esiste in quanto partecipa della sua idea, s’intende che non può
continuare ad essere quando cessa di aderire a quell’idea e in sé accoglie un’idea contraria. Il pari
non può accogliere il dispari, restando pari; il tre non può accogliere il pari, restando tre; la neve
non può accogliere il caldo, senza cessare di essere neve. E allora che fa il tre, che fa la neve,
quando si avvicinino loro il pari e il caldo? Due casi sono possibili: o ritirarsi o accogliere l’idea
contraria, cessando di essere. Così, un corpo perché sia vivo, occorre che contenga il principio
della vita che è l’anima. L’anima non può accogliere l’idea della morte, senza cessare di essere
anima. L’ani,a, dunque, in quanto principio di vita, non può partecipare mai dell’idea della morte,
senza cessare di essere anima. L’anima, dunque, in quanto principio di vita, è immortale.
Accertata l’immortalità dell’anima, Socrate introduce il mito del destino delle anime dopo la
morte (107 d-114 c).
“La Repubblica”
Eros è anche la forza generatrice dello Stato: esso congiunge l’attività dell’uomo nel mondo al
modello ideale: così lo Stato può essere l’immagine vivente di quell’Uno che è il Bene. Il Convito
parla di questa forza che congiunge la città al cosmo nella sua totalità; la Repubblica indica la
maniera in cui questa congiunzione si attua nel mondo, attraverso la fondazione dello Stato
ideale. E’ questo un problema politico, ma è anche un problema metafisico, tanto unitario e
vivente come un organismo è il cosmo di Platone. Il problema politico investe tutti gli altri
problemi del pensiero platonico (il problema dell’anima e della conoscenza, della virtù e
dell’educazione) e ne costituisce la sintesi unitaria e significativa. Il motivo centrale della
Repubblica è questo: “Se i filosofi non diventano re negli Stati, oppure coloro che sono chiamati
oggi re e governanti non cominciano a filosofare nobilmente e in misura sufficiente, in modo che la
potenza politica e la filosofia coincidano, e se non vengono esclusi a viva forza i molti individui che
ora percorrono una delle due strade senza curarsi dell’altra, non finiranno mai i mali dello Stato, e
anzi, a quanto credo, della stirpe umana in generale”. La filosofia non è astratta attività mentale
ma è concreta costruzione della società umana e del mondo; e chi si accinge a condurre le cose
umane deve mettersi a filosofare. Platone tiene lo sguardo fisso all’unità: è unità è il cosmo, unità
l’anima, unità lo Stato. L’unità cosmica è una condizione originaria che bisogna conoscere; l’unità
dell’anima e dello Stato deve essere fondata sulla base della scienza e della volontà ordinatrice.
L’anima e lo Stato sono unità parallele: come l’anima è viva connessione delle virtù (sapienza,
coraggio, temperanza), così lo Stato è connessione organica delle tre classi sociali (i governanti, i
difensori, i produttori). Nell’anima Platone distingue tre elementi: uno spirituale, che comprende
la giustizia e la sapienza; uno medio di collegamento, che comprende il coraggio e la passione
entusiastica; infine un elemento concupiscente, relativo ai bisogni materiali e alla vita sensibile.
L’unità dell’anima è la connessione di questi elementi: la giustizia è appunto questa connessione
per opera della ragione. Così anche l’unità dello Stato è data dalla giustizia: la quale esige che ogni
cittadino stia al suo posto e adempia la sua funzione, relativa alla classe cui appartiene. Ognuno
deve occuparsi di quel lavoro per cui è nato (al quale lo dispongono le attitudini naturali).189 In
ognuno si attua lo spirito della comunità e il ruolo specifico è stabilito dall’appartenenza a una
classe. Tuttavia non c’è ordine di classi chiuse: succede che alcuni della nobiltà scendano al
popolo e altri percorrano il cammino opposto.
Ma come è possibile che lo Stato sia l’immagine dell’idea, che in esso viva la suprema unità del
Bene? Noi già conosciamo l’opinione di Platone: che è necessario che a governare siano chiamati i
filosofi, che dunque i governanti diventino filosofi. Giungiamo così al punto centrale del dialogo,
che riguarda la formazione del filosofo.
189
“Quale contrasto con la moderna ‘divisione del lavoro’! Platone desidera l’unità della perfezione perfino nei
contadini e negli artigiani, affinché essi rimangano uomini completi. Quanto più alto è il valore dell’uomo, tanto meno
‘specializzata’ è la sua perfezione. I guerrieri sono le immagini dello Stato, i filosofi governanti invece portano nel loro
spirito l’intero universo, secondo il quale essi ordinano e guidano lo Stato” (K. Hindebrandt, Platone, cit., p. 290).
Il filosofo è il fondatore dello Stato, come l’idea del Bene è la fondatrice del mondo. Platone
attribuisce all’opera del filosofo un respiro cosmico e una portata mitologica. Si tratta, infatti, di
un’opera che si colloca nell’ordine dell’attività plasmatrice originaria: la fondazione e
l’ordinamento dello Stato è simile alla fondazione dell’ordine universale. Platone interpreta un tale
evento secondo lo spirito dell’antica mitologia. Egli riporta i grandi eventi della storia all’origine dei
tempi, quando il mondo stesso venne formato e si avviò il corso della storia. Un evento come la
fondazione dello Stato è riportato all’origine, a quel tempo “aionico” (eternità) in cui è stato posto il
fondamento di ogni evento che riproduce l’evento originario della fondazione del mondo. Platone
aderisce alla visione mitologica propria della cultura greca e attribuisce alla fondazione e
all’ordinamento dello Stato un carattere quasi religioso. Il “divino” circonda da ogni parte il cosmo
e l’unità cosmica permea ogni evento che abbia il carattere della fondazione originaria. Il cosmo
permea l’uomo e questo irradia se stesso nel cosmo in un’unità mistica e primordiale. La storia
come attuarsi di eventi il cui fondamento è stato posto alle origini dell’ordine cosmico è fatta
coincidere col mito, il quale, come sappiamo, si svolge nell’incontro di tempo aionico e di tempo
cronico, cioè in quel tempo che si configura come simbolico. Bisogna dunque avere chiara l’idea di
quel processo originario per cui è stato posto l’ordine dell’universo. Autore di questo processo è
l’idea del Bene, che, pertanto, bisogna accingersi a conoscere. Tale idea è posta come principio di
fondazione cosmica. Platone parla di questo principio come di ciò che irradia la sua natura per
tutte le cose, in modo da costituirle e renderle intelligibili, come il Sole nutre gli organismi e rende
le cose visibili.190 Il Bene è principio dell’essere di tutte le idee e costituisce queste come
intelligibili. Esso è cioè principio di essere e di intelligibilità: per esso non solo gli enti sono posti
ma sono resi intelligibili. Su questa costituzione metafisica della realtà si fonda la conoscenza.
Platone illustra il processo della conoscenza mediante la famosa similitudine della caverna. La
conoscenza si compie per gradi: chi è chiuso nella caverna e incomincia a uscire vede prima
ombre e immagini riflesse, poi vede cose ed esseri viventi, quindi riconosce e individua forme
geometriche regolari e incomincia a elaborare concetti scientifici, infine intuisce le idee, che lo
conducono fino all’idea suprema (l’idea del Bene). Con questa allegoria è indicato il cammino
spirituale dell’uomo, il percorso che ciascuno deve compiere dentro di sé per giungere alla
suprema intuizione del Bene. Tale percorso investe l’individuo nella sua totalità: indica la stessa
autoconsapevolezza, la conoscenza che l’uomo acquista di se stesso, per cui egli riconosce la sua
natura, il senso della sua esistenza, ciò che egli deve fare per adempiere al suo compito e
conseguire la felicità. Dapprima la conoscenza è limitata alla percezione sensibile: e in tale stadio
neppure si può dire quali sono immagini illusorie e cose reali. In un secondo momento si ha la
prima organizzazione dell’esperienza: le immagini sono elaborati sinteticamente in modo da aversi
concetti e si pongono le prime domande intorno alle cause, riuscendo a dare le prime spiegazioni
scientifiche dei fenomeni. Il passaggio alla scienza delle forme geometriche consente la fondazione
di un sapere razionale, dimostrativo, costituito da elementi certi. La conoscenza filosofica
comprende la comprensione delle idee e dei loro rapporti (dialettica). Comprendere come tutte le
idee derivano da quella suprema del Bene è il compito della filosofia.
L’educazione riproduce questo percorso conoscitivo. I fanciulli sono educati attraverso la
poesia e l’esperienza delle cose sensibili e sono avviati alla comprensione delle forme geometriche,
all’aritmetica, all’astronomia e alla musica. Dopo i diciott’anni incomincia l’addestramento fisico e
verso il trentesimo anno incomincia l’educazione filosofica quinquennale, dopo la quale i giovani
meritevoli prestano servizio effettivo in guerra o nell’amministrazione; e soltanto dopo i
cinquant’anni i pochi individui che si sono distinti vengono dichiarati filosofi e chiamati al governo
dello Stato.
Platone analizza nel libro VIII la decadenza, la perdita, l’allontanamento dall’idea del Bene, il
ritorno al caos dell’ingiustizia. Quando incomincia la decadenza? Quando incominciano ad essere
violate le sacre leggi che presiedono al mantenimento dello Stato, le misteriose leggi che
presiedono alla generazione. Allora incomincia a regnare la confusione: la comunità dei nobili si
corrompe, poiché questi tendono alla proprietà privata e spogliano il popolo, rendendolo schiavo;
la nobiltà dell’anima diventa nobiltà della ricchezza e si ha lo stato timocratico, quindi quello
oligarchico. Questa ingiustizia spinge il popolo a sollevarsi, cacciare i ricchi, spogliandoli dei loro
privilegi; s’instaura allora la democrazia, stato della libertà illimitata, dell’individualismo. Si ha
così l’anarchia, la disgregazione dell’ordine, l’abbandono di ognuno ai desideri sfrenati, la
190
“Il sole dà alle cose sensibili non solo la possibilità di essere viste, ma anche il nascere, il crescere e la capacità di
nutrirsi, per quanto esso stesso non sia né nascita né crescita né nutrimento. Allo stesso modo per le cose conosciute
dall’intelletto si deve dire che dal Bene viene ad esse non solo l’essere conosciute, ma anche l’esistenza e l’essenza, pur
non essendo esso stesso essere, ma qualche cosa che è al di là dell’essere per dignità e potenza”(509 b).
diffusione dell’ingiustizia. Segue il rovesciamento delle istituzioni. Il popolo si affida a un capo, il
quale diventa il tiranno. La tirannide è l’ultimo gradino di decadimento. Platone rileva la generale
infelicità che investe tutti nell’ambito di un tale regime politico. A questo punto solo un elemento
divino potrà restaurare l’ordine civile.191
Il libro X è dedicato ad argomenti apparentemente lontani dal problema fondamentale, che è
quello politico: il problema dell’arte e il mito del destino delle anime. Ma in realtà si tratta di
problemi inerenti allo spirito del platonismo. Per quanto riguarda l’arte, Platone si chiede se essa
concorre al processo della conoscenza e conclude che essa rimane piuttosto legata al mondo delle
immagini e, piuttosto che avvicinare, allontana dal mondo delle idee, contrastando così con la
conoscenza filosofica. Perciò condanna l’arte mimetica, imitatrice del sensibile e dell’apparente; e
condanna Omero, per avere sviluppato un’immagine distorta della divinità.
Per quanto riguarda il discorso sull’anima, ripreso nella parte finale del dialogo, è da dire che l’argomento
sull’immortalità che viene aggiunto a quelli del Fedone appare piuttosto debole: si dimostra che ogni organo può essere
distrutto dalla propria malattia, ma l’anima non è intaccata dalla propria malattia che è la malvagità. Di un significativo
rilievo è il mito sul destino delle anime: si riporta nel mito di Er (un guerriero tornato in vita dopo la morte), secondo il
quale, dopo avere espiato la propria colpa oppure goduto il premio, l’anima si accinge a tornare nel mondo e proprio in
quel momento viene chiamata a scegliere la condizione d’esistenza preferita.192
Il “Convito”
Nel Convito Platone fa discutere a Socrate, nel corso della discussione conviviale sulla natura di Eros, la
questione intorno all’”utilità” dell’amore per gli uomini, cioè egli affronta il problema della funzione di
questa forza fondamentale della vita nell’ambito dell’esistenza umana. Un primo elemento che concorre a
definire la questione è l’identificazione dell’amore con l’inclinazione alla bellezza e al bene. “Chi ama il bello,
ama”, afferma Diotima, la sacerdotessa (depositaria del mistero e della sapienza ad esso connessa) che inizia
il filosofo ai misteri d’amore: dunque l’inclinazione al bello è presupposto e condizione dell’amare. L’uomo è
attratto dalla bellezza e cerca di fare in modo che essa diventa una componente della sua esistenza, si
adopera, perciò, affinché egli, nella sua opera, nel suo fare quotidiano, possa fare trasparire tale qualità e
valore essenziale dell’essere, compiendo azioni belle. La bellezza qui è la qualità che rende il bene
immediatamente riconoscibile: essa, cioè, è l’aspetto visibile del bene. Così l’esistenza muove da una forza
interiore, che è quella di Eros, e approda a risultati che, a loro volta, sono oggetto di attrazione. L’opera
umana, alimentata da Eros, suscita ancora, a sua volta, amore. In questo modo, si può dire, Eros diventa la
forza spirituale che attraversa l’intero ritmo dell’attività creativa. Che si tratti di un circolo, di una
condizione in cui il punto di partenza coincide con quello di arrivo, è dimostrato dalla affermazione
seguente, che chi possiede il bene (il bello) è felice e che “non occorre più chiedersi a qual fine intenda essere
felice chi così desideri” (205 a). A questo punto sorge una prima difficoltà (aporia): bisogna, dunque,
distinguere tra azioni buone e belle, ispirate da Eros, e azioni brutte e cattive, non determinate dalla forza
dell’amore. La risposta (provvisoria) è che si devono considerare opere belle (e buone) unicamente quelle
che non hanno altre finalità oltre quella di attestare l’amore del bello (e del buono): non è propriamente
amore, ad esempio, il desiderio di ricchezza e neppure lo stesso desiderio di conoscenza. In primo luogo, si
tratta di riconoscere se qualcuno di questi desideri sia o no un bene per l’uomo. E soltanto nel primo caso
bisogna ammettere che si tratta di desideri ispirati da Eros. La ragione di ciò è cercata nella natura di Eros,
che è forza generativa nell’ambito della bellezza. L’azione propria in cui l’amore si esprime è la creazione di
cose belle, “la procreazione nel bello, secondo il corpo e secondo l’anima” (206 b). L’uomo si configura, così,
in base alla forza fondamentale che lo anima, come “creatore”. E in questo ambito rientra la stessa
generazione corporea, la procreazione fisica, attraverso la quale si perpetua la specie. In questo processo si
esprime l’inclinazione all’immortalità: Eros consente, in qualche modo, agli uomini di conseguire una specie
di immortalità, quella attraverso la procreazione. Platone esalta, perciò, l’amore fisico che conduce alla
procreazione, poiché esso è un aspetto della generale inclinazione degli esseri viventi a conservare se stessi,
pur nella vicenda del continuo mutamento (per cui, ad esempio, ognuno di noi non può dirsi che sia sempre
191
“Affinché ogni uomo sia dominato dalla stessa cosa da cui è dominato il migliore che dentro di sé si fa guidare
dall’elemento divino […] soprattutto quando si possiede tutto ciò come cosa propria, altrimenti che il divino giunga dal
di fuori per comandare, in modo che noi tutti diventiamo per quanto possibile simili e amici, dominati da un elemento
comune” (590 cd).
192
“Non è il demone che sceglierà la vostra sorte, ma siete voi che sceglierete il vostro demone. La virtù è libera per
tutti: ognuno ne parteciperà più o meno a seconda che la stima o la disprezza. Ognuno è responsabile del proprio
destino, la divinità non è responsabile” (617 e).
“lo stesso”, poiché via via perde alcuni caratteri per acquistarne altri). “Ché in questo modo si salva ogni
esistenza mortale, pur non rimanendo come quella divina, sempre assolutamente uguale a se stessa, ma in
quanto ciò che invecchia e se ne va lascia al suo posto un’altra esistenza giovane, identica a quella di prima”
(208 b). L’amore dell’uomo per la donna (e viceversa) è determinato da questo fondamentale desiderio
d’immortalità; e riguarda, nello stesso tempo, il corpo e l’anima (poiché dall’unione di queste componenti è
formato l’uomo), la bellezza dell’uno e dell’altra. Come diranno gli stilnovisti: Al cor gentile repara sempre
Amore. Così qualcuno, che sia spinto da questa forza a generare, cerca, in primo luogo, un’altra bellezza
corporea, ma anche “un’anima bella, nobile e di alta natura” (209 b). In questo modo si sviluppa una vera e
propria comunione di sentimenti, di propositi, di azioni: gli amanti procedono insieme in ogni occasione e
anche se stanno lontani operano pensando l’uno all’altra, in modo che sulla base di un pensiero comune si
svolga qualcosa come un’unica esperienza d’amore.193 Così si stabilisce una sostanziale identità tra la
procreazione fisica e quella spirituale. Platone vuol dire che anche i prodotti dello spirito, le opere di poesia,
ad esempio, oppure le leggi di una città, sono generate in virtù della forza dell’amore. Qui l’amore riguarda
la più profonda comunione spirituale che si stabilisce tra più persone. In questo ambito si acquista
un’immortalità anche più duratura e significativa.194 L’amore, dunque, è fattore di generazione e di
creazione, nell’ambito del bello e del buono, sia sul piano corporeo sia su quello spirituale; comunque esso
assicura all’uomo una specie di immortalità, da una parte attraverso la successione delle generazioni e
dall’altra attraverso la memoria delle opere umane nelle diverse sfere dell’arte, della poesia, della tecnica,
della politica, della religione. A un grado più elevato, l’amore riguarda la Bellezza in sé, l’idea del Bello, e a
questo livello si esplica attraverso la filosofia e come forma suprema di conoscenza, cioè come conoscenza
delle strutture immutabili dell’essere, come metafisica e dialettica. Né, secondo Platone, l’amore approda a
esiti individualistici e egoistici: lo stesso amore fisico, che considera specialmente la bellezza corporea ed è
attrazione verso il corpo bello, va al di là della sfera della singola altra persona e si estende alla bellezza che
risplende in tutte le altre. Una educazione all’amore deve tenere conto di questa esigenza. Più universale,
però, è l’amore spirituale, che può indirizzarsi anche verso chi non possiede un corpo interamente
aggraziato ma ha un’anima nobile e pura. Infatti, una tale educazione deve “rendere migliori i giovani per
essere poi spinti a contemplare la bellezza nelle attività umane e nelle leggi” (210 c). Così, infine, il soggetto è
portato a considerare tutti gli aspetti della bellezza e a riconoscerla nei vari modi in cui risplende, per
ascendere, da ultimo, alla contemplazione della “bellezza eterna”, che fa parte dell’essere stesso ed è
principio della costituzione del cosmo.195
Platone ha mostrato, così, la connessione dialettica tra le diverse forme o figure dell’amore, mettendo in
rilievo come l’amore stesso, per sua natura, spinge l’uomo a oltrepassare via via i gradini che egli raggiunge
nella sua inclinazione a realizzare la sua natura e a conseguire la felicità, operando nell’ambito del bene e del
bello. Un primo grado è l’amore per la bellezza corporea e un primo risultato di questo operare in virtù di
tale forza è quella forma di immortalità che si consegue con l’eredità che ognuno lascia alle generazioni
future. Ma la figura dell’amore fisico non appare mai disgiunta da quella dell’amore spirituale, che infiamma
le anime e fa compiere ad esse esperienze comuni, spingendole a creare quei frutti più duraturi che si
presentano come opere d’arte e di poesia e come istituzioni civile e religiose. Tutte le grandi opere che
assicurano fama ai loro autori sono, in realtà, prodotti della forza dell’amore, che consente, appunto, di
generare nella sfera del bene, assicurando all’umanità un patrimonio che è fattore di vita felice. Infine, al
gradino più alto, si colloca la filosofia, che nasce e si alimenta dall’amore per l’essere come principio di tutta
la realtà e che si configura, in primo luogo, come bene e come bellezza in sé.
In primo luogo, l’amore si manifesta attraverso la via dei sensi, come attrazione verso le belle forme delle
cose e, principalmente, per la bellezza del corpo umano. Questo, infatti, secondo il canone classico,
193
“E così venendo a contatto della bella persona ed accompagnandosi a lei dà alla luce e procrea le cose da tempo
concepite; e sempre la tiene nella memoria, vicino o lontano che sia, ed insieme a lei coltiva ciò che ha creato” (209 c).
194
“Chiunque preferirebbe tali figli a quelli umani, se solo guardi Omero e Esiodo e tutti gli altri grandi poeti, ed
invidi le progeniture che hanno lasciato di sé, e che garantiscono loro fama e memoria immortale essendo tali esse
stesse; o se vuoi, figli quali lasciò Licurgo a Sparta, salvatori di Sparta, e vorrei dire dell’Ellade. Onorato è da voi anche
Solone per le leggi che dette alla luce; e così altri uomini, altrove e dappertutto, fra i Greci e fra i barbari, che hanno
prodotto alla luce molte opere stupende, fecondi in ogni genere di virtù. Molti altari sono stati dedicati per tali figli, ma
non ancora per i figli umani di alcuno” (209 d-e).
195
“Perché questo è proprio il modo giusto di avanzare o di essere da altri guidato nelle questioni d’amore:
cominciando dalle bellezze di questo mondo, in vista di quella ultima bellezza salire sempre, come per gradini, da uno a
due e da due a tutti i bei corpi e dai bei corpi a tutte le belle occupazioni, e da queste alle belle scienze e dalle scienze
giungere infine a quella scienza che è la scienza di questa stessa bellezza, e conoscere all’ultimo gradino ciò che sia
questa bellezza in sé” (211 c).
rappresenta in modo più compiuto la bellezza in sé come armonia perfetta e proporzione tra le parti di un
intero. L’essere, che è uno e identico a sé, è anche la bellezza stessa; in esso, infatti, non vi sono neppure
distinzioni di parti, per cui si ponga il problema della ricostituzione di un’armonia originaria. Esso è già
costitutivamente armonia assoluta. Il cosmo nella sua unità riflette questa armonia in quanto ricostituzione
della sua forma originaria (quella che è connessa all’essere) mediante la perfetta corrispondenza armonica
tra le parti. Il cosmo comprende la totalità delle parti nelle modalità della loro connessione armonica,
secondo numero, ritmo e misura. E il corpo umano è riproduzione del cosmo: dunque esso reca in sé, in
modo riflesso, la bellezza cosmica, che a sua volta riproduce la bellezza in sé.
Il “Teeteto”
Dopo la confutazione della tesi protagorea della relatività della conoscenza e della verità, Socrate pone
una questione di fondamentale importanza: è più esatto dire che gli occhi sono ciò con cui oppure ciò per
mezzo di cui noi vediamo? (184 c). In tale questione è compreso tutto il problema della funzione da attribuire
ai sensi nel processo della conoscenza. Se si ritiene che i sensi costituiscono il principio attivo della conoscenza (e
della stessa conoscenza sensibile, come il sentire e il vedere), allora ha ragione Teeteto di ritenere che la conoscenza
coincide con la sensazione. Se bisogna ammettere che i sensi siano semplici veicoli secondari (ausiliari) e che il principio
attivo sia oltre i sensi (nell’intelletto), bisogna superare la prospettiva sensistica. Teeteto stesso deve convenire su
quest’ultima ipotesi. Socrate, allora, sottolinea l’esigenza di ammettere un principio sensibile attivo unico,
che si serve dei diversi sensi per produrre le diverse sensazioni: tale principio potrà essere concepito come
l’anima stessa o in altro modo. Infatti, com’è possibile avere nello stesso tempo percezioni diverse, se non
rapportandole a una facoltà unica, la quale determina quelle stesse in una unità di forma? E poi come
sarebbe possibile avere, attraverso i sensi, la percezione di idee come quelle di “uguale”, “diseguale” e così
via? Teeteto deve convenire che è l’anima la facoltà di tali idee, così come essa è il principio della percezione
dell’unità del molteplice sensibile. Bisogna concludere, quindi, che l’anima compie alcune osservazioni da
sola e altre con l’aiuto delle percezioni specifiche dei sensi. Tra le idee che l’anima concepisce da sé
medesima Teeteto deve porre in primo luogo l’idea di essere, che è quella più universale. Analogamente si
deve dire di altre idee, come quelle di identico, diverso, simile, dissimile, bello, brutto, bene, male. E, osserva
Socrate, sebbene il duro e il molle vengano percepiti attraverso i sensi, è l’anima che fonda l’idea della loro
opposizione e diversità. E proprio da questa idea è data la conoscenza del loro “essere”: dunque dalla funzione
intelligibile dell’anima. Dunque, “non è nelle impressioni che risiede la scienza, ma nei ragionamenti sulle
impressioni; infatti l’essere e la verità si possono attingere in codesto modo e non mediante le sensazioni” (186 d). Si
conclude che la scienza non coincide con la sensazione (186 e). La scienza è fondata dall’atto attraverso il quale
l’anima si rivolge solo e unicamente allo studio dell’essere delle cose (187 a).
Teeteto avanza, allora, l’ipotesi che la scienza possa intendersi come l’opinione vera. Socrate esamina perciò
il problema dell’essere connesso all’opinione falsa. Egli osserva che in questa si assumono alcuni elementi di
conoscenza (alcune cose che si sanno) per altri, con la conseguenza di non conoscere più né gli uni né gli
altri. L’errore è spiegato qui come confusione (non correttezza) nel rapporto della sensazione con l’idea. Non può
aversi opinione falsa nell’ambito dei rapporti tra sole idee o tra sole sensazioni.
L’opinione vera consiste, allora, nella corrispondenza della percezione attuale all’idea che si ha
dell’oggetto corrispondente. La scienza, invece, non consiste nella sensazione e non può essere definita in
base alla ortothés, alla correttezza del rapporto della percezione all’idea. Essa, infatti, riguarda l’essenza
intelligibile delle cose.
Teeteto introduce la terza definizione, della scienza come opinione vera accompagnata da ragione (201 c). Così
le nozioni prive di base razionale non sarebbero elementi di scienza, mentre lo sarebbero quelle inserite in un
contesto razionalmente ordinato (in un discorso filosofico). A questo proposito sorgono altre difficoltà.
Infatti, come può la ragione stabilire una connessione tra elementi se non sulla base di una adeguata
conoscenza di tali elementi medesimi? Bisogna ammettere che gli elementi stessi sono razionali e conoscibili,
perché non potremmo spiegarci, ad esempio, come possiamo leggere o ascoltare una musica, se non
ammettessimo che sono conoscibili gli elementi di cui si compongono le parole e i suoni.
Nessuna delle definizioni che riconducono la scienza all’esperienza sensibile appare, dunque, plausibile; e,
per definire la scienza, bisogna percorrere altre vie.
Il Teeteto si conclude in modo aporetico.
Il “Filebo”
La discussione sul tema del piacere nel “Filebo” offre a Platone l’occasione per sviluppare una organica
riflessione sull’uomo e, nello stesso tempo, focalizzare il nucleo concettuale intorno al quale ruota il suo
pensiero. Si può dire, infatti, che l’intera riflessione platonica si svolga intorno a un motivo fondamentale che
può essere definito come “plesso onto-antropologico”. E a questo proposito il “Filebo” costituisce un
significativo punto d’arrivo, in quanto esso offre una sintesi dei molteplici elementi che confluiscono nello
sviluppo della dottrina platonica dell’uomo. La natura etica dell’uomo (in virtù della quale l’uomo progetta
e costruisce se stesso), dice in conclusione il filosofo, risulta costituita come “mescolanza” di piacere puro e
di conoscenza della verità, cioè riposa sulla compiuta attuazione della sfera sensibile (nella forma
dell’esperienza estetica) e di quella intellettuale e sull’armomica fusione di entrambe.
La tematica del “Filebo” relativa alla definizione del “piacere puro” presenta, poi, significative analogie
con alcune teorie recenti intorno al ruolo della “dimensione estetica” nel superamento di aspetti culturali
connessi alla configurazione del soggetto moderno, tra i quali principalmente la tendenza alla “divisione”
nell’ambito della realtà umana, con la costituzione di sfere separate e autonome di funzioni spirituali
specifiche, e lo sviluppo della tecnica come strumento della pianificazione del mondo, in rapporto
all’espansione illimitata della sfera del bisogno e alla proiezione “oggettiva” di questa medesima.
La dottrina platonica s’inquadra nella generale concezione ontologica dei “princìpi”.
Platone, secondo la configurazione più sistematica del suo pensiero, pone alla base di ogni processo reale i
princìpi dell’Uno e del Due (che nel “Filebo” appaiono come “limite” e “illimitato”): il primo come principio
della determinazione, il secondo come principio della divisibilità infinita e, dunque, della “materia” (nel
senso di potenzialità d’essere) indeterminata. Il “mondo delle idee” costituisce, secondo questa prospettiva,
la sfera delle modalità della determinazione: l’idea del Bene è la modalità più generale, che indica la forma
complessiva e primaria della totalità reale (nella sua determinazione in atto), e in diretta connessione con
essa sono le idee del Vero e del Bello. Si tratta di princìpi generali della determinazione, che presiedono,
pertanto, alla costituzione di ogni ente. L’azione limitante dell’Uno si esplica secondo queste fondamentali
esigenze ideali e ogni idea, che costituisce il modello immutabile del determinato ente sensibile, risulta
costituita sulla base della sua “partecipazione” a tali princìpi fondamentali e ad altri più particolari (ma tutti
subordinati ai primi). Così ogni idea partecipa del Bello e ogni ente sensibile presenta una qualche bellezza
che si rivela nel suo aspetto, nella sua forma fenomenica.
La sfera “estetica” ha il suo fondamento in questa partecipazione: essa comprende i modi in cui la
struttura intelligibile in base alla quale ogni ente è costituito si manifesta sensibilmente e viene ad alimentare
una tipica esperienza dell’uomo. Si può dire che la bellezza appartiene a ogni ente nella misura in cui esso è
“vero”, cioè costituito in conformità al modello ideale e, dunque, intelligibile. In realtà, poiché ogni idea
risulta dall’unificazione di una molteplicità, è questa stessa composizione armonica di elementi e parti che si
manifesta sensibilmente e produce, in chi la contempla, un piacere disinteressato.
Platone distingue il piacere estetico da quelle forme di piacere che sono da considerare imperfette o false e
impure e che sono generate dalla dinamica dei desideri, coincidono, cioè, con le situazioni soggettive in cui
una mancanza viene colmata, un bisogno è soddisfatto, un equilibrio ristabilito. I “piaceri puri”, egli dice,
sono “quelli che riguardano i colori che si dicono belli, e le figure, e la maggior parte dei piaceri che
riguardano odori e suoni, e tutto ciò che, rendendoci insensibili al bisogno e indifferenti al dolore, ci offre
una soddisfazione coinvolgente e piacevole” (“Filebo”, 51 b, tr. di Enrico Pegone). Sono, dunque, le idee
stesse che, manifestandosi sul piano sensibile, producono il piacere puro: ad esempio, il rosso in sé, il
triangolo in sé, l’armonico in sé (il suono in quanto rivela l’essenza dell’armonia), il profumo in sé (l’odore in
quanto rivela, a sua volta, un accordo, una straordinaria e quasi divina mescolanza). Si tratta di
un’esperienza che ci avvicina alla natura del limite e ci conduce sul piano in cui i princìpi e le forme, che
esercitano l’azione limitante, raggiungono il loro scopo, attuando mescolanze perfette, che si rivelano
sensibilmente sotto l’aspetto della bellezza. Le mescolanze, così, di cui sono costituiti tutti gli enti, risultano
tanto più idonee a produrre forme di piacere vicine ai piaceri puri quanto più l’accordo tra gli elementi in
essi confluenti risulta armonico e perfetto.
In rapporto alla tematica relativa a genere di vita proprio dell’uomo, cioè il genere “misto” di piacere puro
e di intelligenza della verità, si può dire che dal conseguimento di tale mescolanza deriva la più significativa
esperienza estetica. In questo senso, nelle forme prodotte dall’arte l’uomo contempla la sua stessa bellezza,
riuscendo a comprendere come la sua realtà risulti dall’accordo di diverse componenti e consista
specialmente nel modo in cui queste sono condotte a un’unità. Il grande problema etico di Platone appare,
così, quello del conseguimento dell’unità all’interno di ogni individuo e di ogni società. Il piacere estetico è
connesso con questo fine etico: esso risulta da uno stato di equilibrata fusione fra le molteplici inclinazioni
umane, fra le diverse facoltà ed esigenze dell’anima; dipende, dunque, dalla sapiente mescolanza che
l’individuo riesce a conseguire all’interno di sé tra le diverse componenti del suo essere e che una società
realizza attraverso il concorso dei singoli.
La valutazione platonica del piacere puro è connessa all’esigenza di attuazione di una vita basata sul
superamento di ogni indeterminatezza. E la principale condizione di tale superamento è il livello su cui
infine si è attestata la sfera sensibile, mediante l’oltrepassamento della dinamica del desiderio illimitato e il
conseguimento di quella forma di piacere che è data dalla contemplazione della bellezza in cui si rivela ogni
compiuta mescolanza. Tale piacere riguarda la vita che ha trovato la propria forma o essenza, dunque la
natura umana divenuta esistenza. Le figure regolari e le composizioni armoniche che si percepiscono coi
sensi indicano come la mobile indeterminatezza del flusso vitale si è trasfigurata nelle forme dell’esistenza e
come la materia indefinita è stata plasmata nelle grandi strutture cosmiche che sono espressioni della
mescolanza attuata dall’intelletto sovrano di Zeus (30 d). Dal lato del desiderio, invece, c’è ancora una vita
che non ha trovato la sua forma e perciò si dibatte nell’inquietudine, passando dalla dolce eccitazione del
piacere all’amarezza del dolore. E’ evidente che una tale condizione d’esistenza non coincide con quella
mescolanza che riguarda la compiuta umanità. Infatti questa deve essere una mescolanza scevra di fattori di
degenerazione, di malattia e dissoluzione, non può presentarsi come qualcuno di quei guazzabugli confusi
che non hanno in sé nessuna misura e portano a corruzione gli elementi stessi li compongono (64 d).
Le implicazioni antropologiche, culturali, morali, estetiche, della dottrina platonica del piacere puro sono
molteplici e non ci soffermeremo. Qui ci preme, piuttosto, rilevare qualche modo in cui essa può costituire
un efficace strumento interpretativo di quell’evento che stiamo vivendo e che si può indicare sinteticamente
come “compimento e crisi della modernità”.
La questione del superamento della temperie moderna è estremamente complessa, per cui risulta
impossibile anche solo sfiorane i dettagli. Notiamo semplicemente che lo sviluppo del mondo moderno
corrisponde, in generale, all’espansione e all’“oggettivazione” di quella forma di desiderio che corrisponde
al tipo di piacere che Platone riporta all’instabilità delle mescolanze imperfette, cioè a quella sfera sensibile
che sta dalla parte dell’illimitato. Potremmo avanzare l’ipotesi che tutte le contraddizioni, le interne
lacerazioni e divisioni dell’uomo moderno siano da ricondurre a questa forma di sensibilità, basata sul
desiderio illimitato (e sul corrispondente piacere) che distrugge ininterrottamente le figure reali che esso
stesso di volta in volta richiede e sollecita.
Hegel ha efficacemente illustrato la dialettica del piacere che caratterizza il momento storico in cui
“l’autocoscienza si getta nella vita, e conduce a perfezione quella pura individualità nella quale essa sorge”
(“Fenomenologia dello Spirito”, tr. De Negri, Firenze 1973, p. 302), e che si conclude con l’apparizione di una
“necessità” o di un oscuro “destino”, come di “un alcunché di cui non si sa dire ‘che cosa’ operi, quali siano
le sue leggi determinate e quale il suo contenuto positivo” (p. 304). Marx, poi, ha messo in rilievo il processo
attraverso il quale l’oggettivazione si risolve in alienazione e reificazione del soggetto medesimo e riduzione
di esso a “merce”.
Perciò la questione del ristabilimento dei caratteri propri della soggettività è venuta alla ribalta nel nostro
tempo e occupa, si può dire, l’intera area del dibattito filosofico lungo un asse che va da Marx a Heidegger e
che comprende Nietzsche, Freud e i rappresentanti del marx-freudismo. Il tema principale è costituito dalla
ricerca di un diverso modello di razionalità e dall’esigenza di superare la tipica progettualità moderna,
consistente nel processo di continua trasformazione della realtà a partire dall’interna dinamica pulsionale
del soggetto.
E’ significativo, infatti, che nel mondo moderno il piacere sia impersonato da due figure che sono
emblematiche anche di due forme di allontanamento dalla “comune” natura umana, Don Giovanni e Faust,
l’uno simbolo dell’illimitato erotico, l’altro dell’indefinito etico, spirituale e tecnico. Don Giovanni
rappresenta il principio del piacere come moltiplicazione infinita del desiderio: egli, infatti, annulla tutte le
determinazioni e tutte le figure dell’“eros”, in odo da poterle comprendere insieme, al di là di ogni
esperienza definita; e perciò vive in una condizione di estrema fuggevolezza, in cui è distrutta ogni
permanenza. Questa tendenza porta il soggetto a cancellare ogni determinata immagine della realtà e ad
assumere il movimento come unica dimensione dell’esistenza. Faust, da parte sua, considera la libertà come
la possibilità di non porsi uno scopo definitivo e di riuscire a dominare l’infinito. Il “consumismo” è la
manifestazione quotidiana (la più diffusa e banale) di questa tendenza a cercare la felicità nella rinascita di
un desiderio che continuamente divora il suo “oggetto” (il mondo stesso pianificato e strumentalizzato).
Il superamento della modernità è perciò legato essenzialmente a questo problema: come uscire da questa
strategia del movimento che ha assunto la forma dell’estrema accelerazione. I “grandi movimenti di
trasformazione”, osserva Platone, sono smisurati: essi appaiono come preferibili, in quanto procurano i
piaceri più intensi; invece essi sono fonte di insoddisfazione e di dolore, poiché, quando svaniscono, lasciano
una brama inappagata, un’irrequietezza che spinge a desiderare altre cose (43 c). Invece i “piccoli
movimenti” sono misurati e corrispondono ai piaceri puri. Si tratta, perciò, di attuare forme di movimento
misurate e mescolanze armoniche. Il criterio della buona mescolanza è il presupposto di ogni umana felicità.
All’uomo moderno, secondo la prospettiva platonica che riteniamo attuale, è venuta a mancare la
sapienza (e l’arte) della giusta mescolanza. Vi sono, osserva Platone, delle mescolanze eccellenti e ve ne sono
delle deplorevoli; e si tratta di trovare la mescolanza più bella, più stabile e meno discorde, quella mistura
che è valida “sia per l’uomo che per l’intero universo” (64 b). In tale forma di mescolanza si può rinvenire la
presenza delle stesse idee del Bene (il principio della determinazione del Tutto) e del Bello (il principio per
cui la forma della compiuta e perfetta determinazione attraverso l’accordo del molteplice in unità si rivela
sensibilmente e diventa oggetto di contemplazione). La “dimensione estetica” è, perciò, anch’essa una via di
conoscenza: essa riguarda la percezione di figure e di strutture sensibili che ci dicono qualcosa intorno ai
princìpi della costituzione cosmica e all’inserzione dell’uomo nella totalità dell’universo. Se negli aspetti
della sua vita, in ciò che egli è e in ciò che fa, nei modi in cui esiste e opera, l’uomo riconosce un termine
della sua capacità estetica, egli può anche pervenire a sapere qualcosa sullo spessore etico della sua
esistenza. Se, invece, egli vive in una continua tensione di termini inconciliabili, se si trova immerso in
un’incompiutezza mai risolta (perché il termine della “risoluzione” è sempre rimandato), allora l’esperienza
della dissoluzione di tutte le forme (come in certe tendenze dell’arte contemporanea) costituisce il segno di
una fondamentale mancanza di senso, di un’assenza che investe il modo di esistere e che, in definitiva, si
configura come assenza dell’uomo a se stesso (come quell’“errare” di cui oggi si parla).
Tutto ciò trova un singolare riscontro nel pensiero contemporaneo. E’ molto significativo che Heidegger e
Marcuse, ad esempio, abbiano richiamato l’attenzione su questo nodo problematico, insistendo, il primo,
sulla questione della verità e, l’altro, sull’importanza della funzione estetica. Heidegger, infatti, ha rilevato
l’emergere del “nulla” nell’orizzonte di una concezione dell’essere come “semplice presenza” dell’ente e ha
lascitao intendere che una comprensione dell’essere come radice della “verità”, come “non nascondimento”
dell’essenza dell’uomo, aprirebbe nuovi orizzonti alla storia. Marcuse, poi, ha evidenziato il ruolo della
dimensione estetica nel processo di ricostituzione dell’unità umana. Il soggetto autentico, secondo tale
prospettiva, è quello che è capace di afferrare la bellezza delle cose e che riscontra nell’ordine cosmico lo
specchio della sua esistenza. Un tale soggetto supera il “principio d’investimento”, su cui è basato il progetto
moderno della pianificazione oggettiva del mondo; esso riconcilia l’uomo e la natura e riporta ogni parte
all’intero. Le figure che impersonano questo tipo di umanità sono Orfeo e Narciso. Orfeo restituisce alle cose
la loro identità e così fa in modo che sse siano “libere di essere ciò che sono” (H. Marcuse, “Eros e civiltà”, tr.
it., Torino 1967, p. 188). Narciso è il simbolo dell’uomo che scopre e contempla se stesso, in quanto è attirato
dalla sua bellezza. Così liberati, l’uomo e la natura, tornano a fare parte del grande giuoco della vita, di quel
giuoco che è, nella sua purezza, la fonte primaria del piacere, e che non è solo il giuoco degli uomini, ma
anche (e soprattutto) il “giuoco del mondo” (K. Axelos). In una prospettiva di superamento della modernità
la dimensione etica e la dimensione estetica sono destinate a coincidere.
Il “Parmenide”
Antifonte, su richiesta di Cefalo, racconta l’incontro di Socrate con Parmenide e Zenone e fa un resoconto
della discussione che ebbe luogo fra i tre filosofi. Parmenide, già vecchio, in occasione delle Grandi
Panatenee era venuto ad Atene, accompagnato dal suo discepolo Zenone. Appunto costui, in
quell’occasione, lesse il suo libro sulle difficoltà di ammettere il molteplice. Zenone, infatti, cerca di
dimostrare che, se si ammette l’esistenza del molteplice, la stessa cosa si trova a dover presentare
determinazioni opposte, in quanto le cose devono essere tutte simili e, nello stesso tempo, dissimili: il che è
assurdo. Socrate rileva che l’antinomia di Zenone appare solubile alla luce della teoria delle idee e della
partecipazione ad esse delle cose: infatti, le cose partecipano, insieme, dell’idea del simile e di quella del
dissimile, essendo ogni ente simile (per certi aspetti) agli altri e (per certi altri aspetti) dissimile. A questo
punto Parmenide mette in rilievo alcune difficoltà della partecipazione delle cose alle idee. In primo luogo:
la cosa partecipa di tutta l’idea o di una sua parte? Socrate è dell’avviso che l’ente determinato partecipa di
tutta l’idea: allo stesso modo che “il giorno che è uno, identico, è presente simultaneamente in più luoghi
senza che ciò comporti per nulla che sia separato da se stesso, analogamente anche ciascuno dei generi sarà
compresente nella sua unità e nella sua identità in tutte le cose che ne partecipano” (131 b). Parmenide,
invece, riscontra una certa disinvoltura nella soluzione socratica: Socrate ritiene che una stessa unità possa
trovarsi simultaneamente in più luoghi, come se, egli, coprendo d’un velo molti uomini, affermasse poi che
esso è uno e nella sua totalità copre i molti, in modo da essere tutto su ciascuno; il che, invece, appare
impossibile, perché solo una parte del velo copre ciascun uomo. Ne deriva che “anche i generi come tali sono
divisibili e ciò che ne partecipa, partecipa d’una parte di essi e non più il genere sarà tutto in ciascuno, ma
una parte per ciascuno” (131 c). Se la partecipazione investe la totalità dell’idea, questa, pur essendo una e
semplice, risulta immanente a una molteplicità di cose diverse. Se, invece, la cosa non assorbe che una parte
dell’idea, questa perde la sua semplicità assoluta. In tal modo è sviluppata la prima critica della dottrina della
partecipazione delle cose alle idee. La partecipazione non può essere intesa né come partecipazione della
cosa all’idea nella sua totalità, né a una parte dell’idea. Se diciamo che l’idea, ad esempio, è la forma unica
sotto la quale si raggruppano più uomini simili, occorre che per riunire una determinata qualità vi sia una
determinata idea, e così via per riunire le varie qualità. In tal modo incorreremo in quella difficoltà del “terzo
uomo”, che Aristotele poi considererà come il motivo fondamentale di critica dell’intera dottrina delle idee.
Questa è la seconda difficoltà messa in rilievo da Parmenide. Come terza difficoltà abbiamo che le idee non
possono essere intese come pensieri. Se consideriamo l’idea come semplice concetto (noèhma), esistente soltanto
nelle nostre menti, ci imbatteremmo in nuove difficoltà: o, per effetto della partecipazione al concetto, tutto
diventa pensiero oppure, al contrario, nulla è pensiero, non essendo il concetto stesso. Una quarta difficoltà si
ha allorché si introducono le idee come modelli da imitare. Infatti, se l’idea è un “modello” e la cosa sensibile
una “copia”, in modo che la partecipazione sia intesa come “imitazione”, allora si ha che o l’idea cessa di
essere un assoluto o si ricade nelle difficoltà dell’argomento del “terzo uomo”. Una quinta difficoltà si ha
allorché le idee e le cose sensibili sono poste su due piani paralleli e fra loro non comunicanti. Le idee sarebbero del
tutto in conoscibili per l’uomo e le cose sensibili sarebbero del tutto in conoscibili per la divinità. Se le idee
sono oggetti di conoscenza, sono relative a noi, non sono più in sé. E se sono in sé e relative solo le une alle
altre, allora il mondo delle idee appare come un doppione superfluo del mondo sensibile; e la scienza delle
idee, sola adeguata a una realtà in sé, apparterrebbe solo a Dio, il quale, chiuso così in una sfera eterogenea
alla natura, sarebbe altrettanto inconoscibile per noi quanto noi per lui.196 La dottrina eleatica dell’uno e dei
molti serve a Platone a sviluppare, sul piano dialettico, il problema del rapporto tra il mondo delle idee
(“l’Uno”) e il mondo sensibile (i “molti”). Viene, perciò, sviluppata una rigorosa analisi dialettica, condotta
secondo il metodo per ipotesi: fatta, cioè, una ipotesi, si esaminano le conseguenze non solo in rapporto alla
sua affermazione ma anche in rapporto alla sua negazione, e non solo rispetto a se stessa ma anche rispetto
agli altri elementi della realtà, presi per sé e presi in relazione tra loro. I ipotesi: “se l’uno è uno”. Se l’uno è
assolutamente uno, esso non ha parti e non è, di conseguenza, un tutto; inoltre non ha né principio né mezzo
né fine; è senza figura: dunque non è in nessun luogo. Infine, non si muove, né modificandosi né
guastandosi; e neppure sta fermo; esso non è identico né a se stesso né ad altri; e neppure diverso da se
stesso o da altro; esso non è né simile né dissimile, né rispetto a se stesso né rispetto ad altro; non è né eguale
né diseguale, allo stesso modo; e neppure più grande e più piccolo. Se l’uno è uno, non partecipa
assolutamente del tempo e di esso non si può dire né che è, né che era, né che sarà; di esso non si potrà dire
nome né ragione, né sarà possibile avere opinione o scienza (137 c-142 a). II ipotesi: “se l’uno è”. Se l’uno è,
esso partecipa all’essere: cioè l’essere e l’uno non sono la medesima realtà; l’essere e l’uno sono solo “parti”
di quella realtà che è l’“uno che è”. Dunque, in tal caso, si deve ammettere che l’uno consta di parti.
Abbiamo di conseguenza una “dualità” all’interno dell’uno che è. Ciò che è uno (l’uno che è) è un tutto ed ha
parti: ma queste due parti fondamentali, l’uno e l’essere, non possono essere intese come assolutamente
separate l’una dall’altra; dobbiamo ammettere, invece, che “ciascuna delle due parti involge sia l’uno sia ciò
che è, e la parte risulta a sua volta almeno di due parti e per lo stesso discorso sempre così, qualsiasi parte ne
venga ad essere include in sé sempre queste due parti; l’uno infatti sempre ha con sé ciò che è, ciò che è,
sempre, ha con sé l’uno; ed è pertanto necessità che, infinitamente sdoppiandosi, non sia mai uno” (142 e-143
a). L’uno che è, dunque, sarà “infinito quanto al numero”. Dalla dualità, infatti, può essere dedotta tutta la
serie numerica. Dunque l’uno che è è nello stesso tempo uno e molti, tutto e parti, limitato, finito; esso avrà
pertanto principio, mezzo e fine; avrà anche figura; sarà sia in se stesso che in altro da sé; si muoverà e starà
fermo; sarà identico e diverso, sia rispetto a se stesso che rispetto ad altro; sarà anche simile e dissimile sia
196
“Non c’è traccia, tuttavia, di questa separazione totale nei precedenti dialoghi di Platone: anzi due dottrine
fondamentali la escludono. In primo luogo la dottrina dell’anamnesi la quale implica che l’anima è in rapporto con la
totalità dell’essere, con la quale è congenere. In secondo luogo, la dottrina delle idee come causa del mondo naturale.
Platone quindi non combatte nel Parmenide un caposaldo della sua dottrina delle idee, come abitualmente si ritiene; ma
esclude una interpretazione che la renderebbe impossibile. Egli tuttavia è consapevole a questo punto, che un ulteriore
approfondimento della dottrina è indispensabile per ciò che riguarda il rapporto del mondo oggettivo delle idee col
soggetto umano e col mondo umano in generale (uomo e mondo sensibile). E nel Parmenide prospetta tutte le possibili
soluzioni di questo problema, sviluppando ciascuna di desse fino alle estreme conseguenze, in modo che ne risulti la
consistenza logica o la contraddittorietà” (N. Abbagnano, pp. 97-98).
rispetto a se stesso che alle altre cose; sarà in contatto e in distacco da sé e da altri; e, ancora, sarà eguale e
diseguale, nello stesso senso; parteciperà del tempo; e di esso si potrà dare nome e ragione e sarà possibile
avere opinione e scienza (142 b – 155 e). La conclusione è che è impossibile negare che l’uno è: “se l’uno non
è, nulla è” (166 e). Infatti, se l’uno non è, non può esistere neppure il molteplice, cioè il mondo
dell’esperienza umana; infatti il molteplice è costituito da unità e nel suo insieme costituisce una totalità
unitaria. “Ma c’è tuttavia un senso in cui l’uno non è (e in cui, quindi, neanche il molteplice è): l’uno non è
nel senso che non è assolutamente uno, che non sussiste fuori del suo rapporto col molteplice, che non
esclude il proprio moltiplicarsi e articolarsi in un molteplice che, pur soggetto al divenire e al tempo,
costituisce sempre un ordine numerico, cioè un’unità. E i molti non sono nel senso che non sono puramente e
assolutamente molti, cioè privi di qualsiasi unità, poiché in tal caso si disperderebbero e polverizzerebbero
nel nulla, non potendo costruire un molteplice. L’uno dunque è (c’è) ma nello stesso tempo non è
assolutamente uno; i molti sono (ci sono) ma nello stesso tempo non sono assolutamente molti. Il dialogo
prospetta nella forma di una soluzione puramente logica una connessione vitale tra l’uno e i molti, quindi tra
il mondo dell’essere e il mondo dell’uomo. E questo sembra il motivo fondamentale della concezione
dialettica della realtà: il reale è dato dalla relazione di unità (identità, immutabilità, permanenza) e di
molteplicità (differenza, divenire). Platone ha dimostrato che nessuno di questi due termini preso in sé è
immune da contraddizioni e che la soluzione consiste nella coesistenza o nel nesso indissolubile di entrambi.
Il “Timeo”
Timeo, 27d-28a: “A mio avviso si devono innanzitutto distinguere queste cose: che cos’è ciò che sempre è e
non ha nascita, e che cos’è ciò che sempre si genera, e che mai non è? L’uno si apprende con l’intelligenza e
mediante il ragionamento, poiché è sempre allo stesso modo, l’altro si congettura con l’opinione mediante la
sensazione irrazionale, poiché si genera e muore, e in realtà non è mai”. Così allora si deve distinguere
l’immagine dal suo modello, come se i discorsi fossero parenti di quelle cose di cui sono interpreti: i discorsi,
dunque, intorno a ciò che è saldo e fisso ed evidente all’intelletto sono saldi e sicuri, e per quanto è possibile,
conviene che siano inconfutabili e invincibili e nulla di ciò deve mancare. Quanto allora a quei discorsi che si
riferiscono a ciò che raffigura quel modello, ed è a sua immagine, essi sono verosimili e in proporzione a
quegli altri: perché come l’essenza sta alla generazione, così la verità sta alla fede”.
Intorno all’universo Timeo dice di potere esporre solo “un mito verosimile”, dato che si tratta di
quell’aspetto della realtà che non è perfettamente intelligibile e intorno al quale non si possono sviluppare
discorsi assolutamente inconfutabili e logicamente fondati. Il che vuol dire che la scienza dell’universo è solo
ipotetica: essa rappresenta solo un modello di spiegazione possibile, che tiene conto dell’esperienza e non
deve essere difforme o in contraddizione con essa. In questo campo, dunque, l’esperienza costituisce ancora
un certo criterio, o, se si vuole, fa parte del “canone” o del metodo dell’indagine scientifica e
dell’esposizione. Intorno agli aspetti fisici dell’universo si possono elaborare rappresentazioni verosimili,
non si può avere una scienza puramente concettuale. E ciò fa parte anche della natura umana, che è limitata.
In questa distinzione platonica è stabilita la differenza tra una scienza speculativa, puramente logica e
concettuale, e una scienza empirica, ipotetica e congetturale. Nel Timeo viene esposta la più verosimile
congettura intorno alla formazione e alla struttura dell’universo.
L’universo, in primo luogo, è un modello di ordine e di regolarità. Esso è il prodotto di un dio buono,
quale è, appunto, il dio artefice. 30a-b: “Volendo infatti il dio che tutte le cose fossero buone, e nessuna, per
quanto possibile, cattiva, prendendo così quanto vi era di visibile e non stava in quiete, ma si muoveva
sregolatamente e disordinatamente, dallo stato di disordine lo riportò all’ordine, avendo considerato che
l’ordine fosse assolutamente migliore del disordine”. Il dio artefice ha formato l’universo imprimendo
ordine e misura alla materia configurata prima come una massa informe e disordinata. Egli, pertanto, ha
costituito, dapprima, il modello di tale ordine: il “cosmo” è, appunto, l’ordine dell’universo. La scienza
dell’universo riguarda essenzialmente questo ordine, l’intreccio dei rapporti matematici che costituisce la
trama della struttura razionale della realtà fenomenica. La scienza ha una base matematica in quanto
riguarda rapporti esatti: essa non riguarda tanto i fenomeni quanto, piuttosto, la struttura matematica di cui
i fenomeni sono espressione e sulla cui costituzione matematica essi si basano. L’oggetto della scienza è il
cosmo in quanto ordine dell’universo.
La struttura dell’ordine cosmico non è altro che l’“anima del mondo”. Il demiurgo ha foggiato dapprima
quest’anima, per inserirla, quindi, nella materia informe, in modo che essa prendesse la forma dell’ordine
stabilito mediante il sapiente calcolo delle proporzioni tra le parti. La materia, così, è costituita secondo
rapporti matematici esatti: in qualche modo si può dire che proprio tale costituzione matematica è la
struttura interna della materia ordinata. 30b: “In virtù di questo ragionamento, ordinando insieme
l’intelligenza nell’anima e l’anima nel corpo realizzò l’universo.
34c-35a: “Il dio prima del corpo formò l’anima e la generò più vecchia per generazione e per virtù, in
modo che fosse padrona del corpo e questi obbedisse. La generò formata di tali elementi e in base a tale
criterio. Dell’essenza indivisibile e che è sempre allo stesso modo e di quella divisibile che si genera nei
corpi, da tutte e due, dopo averle mescolate, formò una terza specie di essenza intermedia, che prende parte
della natura del medesimo e dell’altro, e così la pose in mezzo tra l’essenza indivisibile e quella divisibile
secondo i corpi: e dopo averle prese tutte e tre, le mescolò in una sola specie collegando a forza la natura
dell’altro, che rifiutava di mescolarsi, con quella del medesimo”.
L’anima unisce in sé le due nature fondamentali, quella dell’idea immutabile e quella della materia
corruttibile, e, inoltre, una terza natura, data dal rapporto delle prime due. Essa ha la funzione di mantenere
unite le due realtà e di dare luogo a una terza realtà, che è quella dell’universo ordinato. Il cosmo è l’ordine
possibile dato alla materia: non è, cioè, il puro ordine intelligibile, bensì tale ordine in quanto calato nella
materia e costituito in ordine cosmico. La costituzione matematica della materia riflette questo tipo di ordine.
Non bisogna dimenticare, infatti, che si tratta di un ordine matematico che è supportato dalla materia:
Questa impone, comunque, un limite all’ordine puramente intelligibile. La struttura fondamentale
dell’ordine cosmico, dunque, è derivata da una modificazione dell’ordine intelligibile mediante il suo
adattamento e la sua unione con la materia informe. Il risultato di questa unione può essere identificato nella
“misura”, nella materia stessa che ha accolto in sé il principio dell’ordine e che, pertanto, risulta misurabile.
Sono le modalità matematiche della misura che costituiscono l’ordine cosmico: in tale ordine la materia è
connotata secondo rapporti quantitativi e questi si configurano, quindi, come le qualità stesse. Abbiamo, in
primo luogo, la costituzione dei rapporti quantitativi che configurano le qualità materiali fondamentali:
l’essere leggero e pesante, in quiete e in movimento, freddo e caldo, aereo e solido, umido e secco, e così via.
Tali qualità sono costituenti essenziali delle varie sostanze; l’aria è formata dalla prevalente struttura
corrispondente alla qualità dell’aereo, leggero e sempre in movimento, e così le diverse sostanze dalle qualità
che essenzialmente le caratterizzano. Attraverso la costituzione dell’anima del mondo mediante una serie di
determinazioni matematiche espresse da proporzioni, il demiurgo ha posto le basi per la formazione delle
varie sostanze. Queste sono tali da costituire l’ordine fisico dell’universo. Poiché, quindi, tale ordine è
espressione di armonia, i rapporti matematici sono anche strutture armoniche. Così abbiamo che i rapporti
matematici secondo i quali è costituita l’anima corrispondono agli intervalli dell’ottacordo diatonico dorico.
In questa struttura matematica e armonica è racchiuso il corpo dell’universo, ordinato secondo le varie
sostanze (principalmente cielo, aria, fuoco, terra). Ed è questa struttura che governa ogni fenomeno. Le leggi
dei fenomeni sono le leggi della matematica e dell’armonia musicale.
36d-37b: “Dopo che l’intera struttura dell’anima fu generata secondo il pensiero del suo artefice, compose
allora dentro di essa tutta la parte corporea, e unì anima e corpo armonizzando insieme i due centri: e
l’anima, estendendosi dal centro in ogni direzione sino all’estremità del cielo e avvolgendolo esternamente
tutt’intorno, per poi rivolgersi essa stessa in se stessa, diede origine ad un principio divino di incessante e
intelligente vita per tutta la durata del tempo. E il corpo del cielo fu generato visibile, e l’anima invisibile; ma
l’anima, prendendo parte della ragione e dell’armonia, è la migliore fra le cose generate dal migliore degli
esseri intelligibili ed eterni. Poiché essa risulta dalla mescolanza di queste tre parti, ovvero la natura del
medesimo, quella dell’altro e quella dell’essenza, ed essendo divisa e collegata in modo ben proporzionato, e
rivolgendosi in se stessa, quando viene a contatto con un qualcosa che abbia natura corruttibile o
indivisibile, muovendosi tutta quanta in sé dice a che cosa quel qualcosa sia uguale, e fa che cosa sia diverso,
e soprattutto e perché, dove, come, e quando, avviene alle cose generate di essere o di subire, sia fra di loro,
sia in relazione a quelle che sono sempre le stesse”.
L’anima presiede a tutti i processi che avvengono nell’universo, in modo che l’intera vita dell’universo è
regolata da un principio intelligente, che ordina ogni cosa e fa sì che tutto avvenga secondo misura. Di ogni
cosa essa stabilisce la natura, determinando identità e differenze e rapporti tra le cose. E’ essa che regola ogni
produzione e ogni fenomeno, ogni mutamento e ogni processo fisico. Qualsiasi azione ogni ente possa
compiere o patire, tutto è stabilito dall’anima cosmica.
Gli elementi fondamentali nei quali è strutturata la materia sono il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra. Tutte le
sostanze fisiche sono costituite da mescolanze di particelle di questi elementi. Dunque alla base di ogni realtà
corporea vi sono particelle di queste sostanze fondamentali. Queste particelle hanno una configurazione
regolare e forma di figure geometriche: le particelle di fuoco hanno forma di tetraedro, quelle di aria di
ottaedro, quelle di acqua di icosaedro, quelle di terra di cubo.
La figura fondamentale secondo cui è ordinato lo spazio materiale è il triangolo. Ogni figura che
corrisponde agli elementi fisici è costituita da triangoli posti tra loro in relazione. La superficie triangolare
sembra, dunque, costituire la forma di organizzazione primaria della materia. Le unità di organizzazione
della materia sarebbero, cioè, superfici triangolari minime, ovviamente invisibili, se invisibili sono le
particelle delle sostanze fondamentali.197 Le superfici triangolari sono organizzate, quindi, in modo da
formare le figure corrispondenti agli elementi. La scienza della natura rimane, pertanto, impiantata su basi
matematiche: la matematica è la chiave per interpretare e comprendere la struttura dei corpi e tutti i processi
fisici.
Poiché il demiurgo ha posto l’anima del mondo a base della struttura del cosmo (l’universo ordinato, il
tutto fisico costituito secondo ordine e misura), si deve supporre che in essa è fissato, per così dire, il
“codice” secondo cui avviene ogni processo fisico. Alla base di tutti i processi di formazione e di
trasformazione vi deve essere una legge unica, che stabilisce, essenzialmente, le condizioni di un equilibrio.
Vi è, cioè, un’equazione fondamentale, che regge l’intero divenire della natura. Il processo dal caos al cosmo
è passaggio da uno stato di squilibrio a uno stato di equilibrio. Il primo dato fondamentale relativo
all’universo è che esso costituisce una situazione di equilibrio: il che vuol dire che l’insieme dei rapporti
matematici che lo costituisce rimane sostanzialmente stabile; che, cioè, esso consiste una serie di
combinazioni possibili, che, però, nonostante le molteplici forme in cui possono essere articolate, esprimono
tutte il medesimo rapporto, l’identica equazione. Ciò vuol dire che la somma, per così dire, di tutte le
possibili determinazioni matematiche rimane costante, nonostante il continuo variare dei termini e delle
combinazioni. Il mutevole è continuamente ricondotto all’identico. E tutto si risolve in espressioni
dell’“essenza”, cioè in determinazioni fisiche, in entità esistenti. L’ordinamento della materia informe
mediante la misura matematica dà luogo a strutture fisiche corrispondenti a modi d’essere. I possibili modi
d’essere non sono altro che espressioni dell’unica equazione fondamentale che è quella posta nella
costituzione dell’anima del mondo.
Platone, in primo luogo, ci dice che la struttura dell’universo è tale per cui essa è immodificabile e
indistruttibile: essa è fondata sull’“identico”, sull’essere immodificabile. D’altra parte, l’universo comprende
una molteplicità indefinita di forme: infatti l’anima del mondo è costituita anche da una parte che si richiama
all’“altro”. L’altro è ciò in cui passa l’identico attraverso l’essenza; e in virtù dell’essenza l’altro diventa ente
che esiste. La struttura matematica si compenetra nella materia e così ha luogo un ordine corrispondente a
un cosmo coerentemente formato.
Ciò che deriva dalla cosmologia platonica è, in primo luogo, che l’ordine dell’universo è irreversibile:
questo ordine ritorna continuamente su stesso, in una infinita ripetizione temporale. Il tempo, infatti, è
immagine mobile dell’eternità. Esso riproduce l’eternità nel movimento stesso del cosmo; non porta a
distruzione l’ordine così fondato. Nell’universo, così, non può aversi che la riproduzione sempre diversa
dell’identico. La scienza tende a identificare l’equazione fondamentale che esprime questa identità.
Il problema ora riguarda la possibile identificazione di questa equazione. Oggi indubbiamente la scienza è
proiettata verso modelli unificanti. Le varie scienze tendono verso un’identità fondamentale, verso l’unica
legge che spiega tutti i processi fisici. E ciò è un passo verso l’interpretazione scientifica dell’ipotesi platonica
dell’equazione fondamentale simboleggiata nella struttura dell’anima del mondo. Già si possono indicare
alcuni risultati parziali.
197
Cfr. L. Robin, Storia del pensiero greco, Milano 1962, pp. 395-96: “Le prime determinazioni fisiche si formano,
geometricamente, nell’estensione pura. Invero, se si rinuncia a risalire sino a ‘principi superiori’ (53d) – e cioè, a quanto
sembra, sino alle Figure ideali -, gli elementi delle cose non sono quel che siamo soliti chiamare con questo nome. I
veri elementi di ogni corpo, ossia d’ogni solido, non possono essere che superfici: e precisamente, le più semplici delle
superfici piane rettilinee. Sono dunque triangoli rettangoli, sia isosceli che scaleni, di un’estrema varietà e suscettibili di
raggrupparsi in triangoli equilateri. Dalla composizione di tali triangoli in ogni specie risultano le sillabe delle cose:
ossia, dei poliedri regolari, ciascuno dei quali rappresenta la molecola elementare di uno dei corpi primi e ne determina
con la propria figura le proprietà fisiche e chimiche: così il fuoco è il più mobile e il più penetrante di tutti i corpi,
perché è costituito di tetraedri regolari o piramidi, simili a punte di frecce. Il corpo dell’aria è l’ottaedro: due piramidi
dallae basi quadrate, riunite per mezzo delle basi. Quello dell’acqua è l’icosaedro; quello della terra, il cubo (donde la
sua mancanza di mobilità). Siccome, d’altra parte, il cubo è il solido costituito di triangoli isosceli, è il solo che si
mescoli esclusivamente e sia refrattario alle incessanti trasformazioni degli altri. Questi ultimi, per effetto delle loro
reazioni e per mezzo di spostamenti di parti facilmente concepibili, producono le più svariate combinazioni, di
composizione omogenea o no e di proporzioni variabili. Sul tema del quinto poliedro regolare, il dodecaedro – che si
avvicina più di tutti alla sfera -, Platone è estremamente misterioso: Dio (egli dice) se ne servì per ‘dipingere il quadro
dell’universo’. Esso, quindi, non appartiene più all’ordine della Necessità, bensì a quello dell’Intelletto. Il numero delle
sue superfici (dei pentagoni) richiama alla mente i dodici segni dello Zodiaco, che sono come lo ‘scenario’ del cielo:
esso costituisce dunque, forse, il corpo nel quale si muovono gli astri, l’etere”.
Così, per quanto riguarda ogni possibile evoluzione dell’universo, si stabilisce che essa non potrà avvenire
che nell’ambito di quella equazione. Questa rappresenta l’immutabile nel cui ambito può avvenire ogni
mutamento.
Le “Leggi”
Le Leggi comprendono più di un quinto dell’intera produzione filosofica di Platone e sviluppano una
visione complessiva dell’esistenza, allo stesso modo della Repubblica, solo che ora il filosofo non tratta più
dello stato ideale, fatto solo per dèi o figli di dèi,198 ma di uno stato adattato alle condizioni di paideia proprie
del tempo, dunque di uno stato storicamente configurato e attuabile nel particolare contesto esistente. Nella
Repubblica, infatti, le leggi, sulle quali si basavano gli stati del tempo, erano rese superflue dalla tipo di paideia
acquisito dai cittadini (configurati come veri soggetti politici) e dalla superiore sapienza politica dei
governanti. Ancora nel Politico Platone aveva messo in rilievo il limite delle leggi, osservando come esse non
consentono di adattare la politica allo sviluppo della situazione storica e con la loro rigidità costituiscono un
ostacolo al buon governo, che deve essere adattato alle circostanze e messo in grado di operare via via ciò
che si rende necessario e opportuno.199
Il personaggio principale, l’ospite Ateniese, è intrattenuto, a Creta, dagli altri, due dori e filospartani, in una
discussione sulle leggi migliori, dato che i cretesi sono in procinto di fondare una colonia e intendono dare
alla nuova città la costituzione migliore che sia consentita dalle circostanze.
Si muove dal problema dell’areté e si discute intorno al fondamento dello stato spartano, a quell’ethos, cioè,
espresso da Tirteo, che fa consistere il supremo criterio di virtù e di perfezione umana nel dovere verso la
patria. L’antico poeta è assurto a modello di legislatore e a fondatore dell’ethos politico considerato come
proprio della natura dell’uomo. Secondo il concetto dorico dell’areté, la disposizione a morire per la patria è
l’essenza della vita e tutti i valori sono subordinati a questo principio supremo.
Platone si propone di mettere in rilievo l’unilateralità di questo ideale, secondo il quale il significato
dell’esistenza è fatto consistere nell’eroismo guerriero e il coraggio costituisce l’unica fondamentale virtù. Egli
riprende il vecchio problema e, tra i due ideali che nel passato si sono maggiormente confrontati, quello
esaltato da Tirteo, del coraggio guerresco, e quello sostenuto da Teognide, della giustizia, fa pendere il suo
giudizio a favore di quest’ultimo. L’antico ideale dorico, infatti, sembra non tenere conto ancora della
distinzione tra coraggio nella lotta giusta e nell’ingiusta, non riesce a considerare, cioè, il coraggio nel contesto
delle altre virtù (giustizia, temperanza e pietà verso gli dèi):200 esso è espressione di una polis che non attua
ancora lo stato di diritto. Platone osserva che solo la virtù intera (pasa areté) costituisce il vero scopo di ogni
attività politica e deve, pertanto, stare alla base dell’opera del legislatore.
Secondo Platone, bisogna richiamarsi alle quattro virtù dell’anima, che egli chiama i “beni divini”201 e ai
quali vanno subordinati i “beni umani” (la salute, la forza, la bellezza, la ricchezza). Là dove i beni divini
sono ricercati e attuati, là è anche possibile la giusta attuazione dei beni umani; ma dove si tende solo a
questi ultimi, si perdono a un tempo gli uni e gli altri.202 Come aveva detto Teognide, la virtù maggiore, la
giustizia, comprende i beni e le virtù minori. E la condizione umana che comprende tutti i beni, umani e
divini, è la phronesis, la virtù della mente, che costituisce il criterio di ogni comportamento conforme alla
natura razionale dell’uomo.203
Platone fa notare che l’educazione spartana riguarda unicamente la resistenza fisica contro la paura e il
dolore e consiste essenzialmente in esercizi intesi a irrobustire il corpo, ma non a educarlo alla moderazione
e alla temperanza. Le lusinghe del piacere continuano a esercitare il loro influsso e la mancata educazione
alla temperanza è causa di fiacchezza e cedevolezza di fronte alle passioni. Il sistema dorico appare del tutto
inadatto a educare alla moderazione e alla giustizia.
L’Ateniese critica, ad esempio, il costume dorico della pederastia, come degenerazione della naturale vita
sessuale, e, allo stesso modo, la licenza delle donne spartane.204 E’ vero che gli spartani evitano i simposi e
l’uso del vino; ma ciò che sembra opportuno, in un regime di regolata vita comune, non è la totale astensione
da queste pratiche, ma è piuttosto il loro svolgimento controllato, in modo che esse non diventino occasione
198
Leggi, 739 a.
Politico, 294 a-297 c.
200
Leggi, 630 b.
199
201
202
Ib., 631 b.
Ib, 638 d-640 d.
203
Ib., 631 c; 632 c. “Con questa affermazione Platone supera tutti i concetti di virtù che via via erano stati fissati dagli antichi
poeti greci” (W. Jaeger, Paideia, tr. it., vol. III, p. 385).
204
Ib., 636 c; 637 c.
del disordinato scatenarsi degli istinti caotici.205 Platone, così, può mettere in rilievo il vantaggio di un
simposio “bene educato” per i singoli e per la polis.206
Un’indagine intorno all’astinenza dalle bevande alcoliche, che si estende attraverso i primi due libri,
fornisce a Platone l’occasione per affrontare il problema della paideia nel suo complesso, con particolare
riguardo all’educazione della dinamica degli istinti. In particolare, il filosofo mette in rilievo il valore
educativo del simposio. Egli osserva che certamente l’abitudine a stare insieme educa a perseguire scopi
comuni e a mettere in atto le pratiche più opportune per conseguirli. Ad esempio, la vittoria in guerra si
consegue meglio se i cittadini sono stati educati ad agire insieme. Ma bisogna notare che il semplice
conseguimento di una vittoria non costituisce di per sé un fattore di cultura (paideia), poiché spesso dalla
vittoria si produce incultura (apaideysìa).207 Una vittoria che alimenta hybris è una vittoria effimera. Platone
ribadisce, quindi, che il simposio è un mezzo di educazione e lo collega alla formazione musicale e poetica.208
Platone concentra la sua attenzione sulla dinamica della vita psichica ai suoi livelli più bassi, per vedere
come già a tali livelli si possa radicare la paideia.209 Un buon allevamento (trophé) costituisce il primo gradino
della formazione: esso deve suscitare nell’animo del fanciullo, come in un giuoco, il desiderio delle cose che
poi dovranno costituire il compito del cittadino.210 Perciò Platone può affermare che “il punto essenziale
dell’educazione consiste in un corretto allevamento che, tramite il giuoco, diriga il più possibile l’anima del
fanciullo d amare quello che, divenuto uomo, dovrà renderlo perfetto nella virtù propria della sua
professione”.211
La vera educazione, dunque, è il più alto valore (proton ton kalliston), che occorre restaurare, allorché si è in
presenza di una crisi e in un periodo di decadenza della cultura e della vita politica.212 Platone vede il limite
della paideia allora dominante nell’unilateralità della virtù, nella perdita di vista dell’areté intera, nel tendere,
cioè, allo sviluppo di capacità particolari, senza la visione dell’uomo nella sua essenza razionale e nella sua
fondamentale unità. Egli contrappone la vera paideia alla mera formazione professionale, chiamandola
“educazione della perfezione umana” (o “educazione all’areté intera). Nella sua epoca egli ravvisa i segni di
una grave decadenza dell’ideale umano, per cui individua il problema principale del suo tempo
nell’esigenza di una ricostruzione della paideia, nel senso di un recupero della dimensione totale e unitaria
dell’areté, contro la tendenza a ottenere una formazione speciale e professionale.213
Riprendendo più avanti il motivo della funzione educativa dei simposi, Platone mette in rilievo come,
dato l’ideale della paideia come autodominio, occorra promuovere il rafforzamento dei poteri inibitori che
sono capaci di fungere da autoregolatori degli istinti. L’uso del vino, provocando l’ebbrezza, provoca lo
sviluppo di questi poteri, allo stesso modo in cui, per esempio, il fatto di esporre l’individuo a pericoli e
impressioni di spavento può determinare in lui forze e sentimenti capaci di educarlo all’impavidità. In
qualche modo, l’ebbrezza riporta l’adulto alla condizione di fanciullo e, quindi, lo rende soggetto di
educazione, disponendo il suo animo all’educazione dei moti istintivi.
Nella prima fanciullezza, quando la vita è regolata dai sentimenti di piacere e di dolore, occorre
intervenire per disciplinare questa sfera psichica, in modo che l’individuo si orienti verso quelle cose che
costituiscono un bene per l’uomo e che, in un secondo momento, vengono riconosciute e scelte come tali
mediante l’intervento della ragione. L’educazione, in sintesi, consiste nel “corretto orientamento verso i
205
Ib
Ib., 640 b.
207
Ib., 651 c.
208
Ib, 641 c.
209
Platone, come osserva Jaeger, intende “radicare la forma consapevole, razionale della paideia – si vorrebbe dire, il suo
elemento propriamente filosofico – nello stato prerazionale, inconscio o semiconscio, della vita psichica” (Paideia, IV, cit., pp. 38889).
210
Già nella Repubblica troviamo il concetto che la perfetta areté è insita nella costituzione umana e, pertanto, si viene
sviluppando attraverso lo sviluppo stesso del corpo, che deve avvenire in modo armonioso, come avviene quello di ogni essere
vivente. Del resto, Platone poneva il principio dell’educazione dei fanciulli nel giuoco, che è un’attività ordinata secondo un impulso
spontaneo, di carattere biologico.
211
Leggi, 643 c-d.
212
Platone accosta il problema della decadenza dello stato a quella dell’oscuramento della cultura e dell’occultamento delle virtù.
Egli è consapevole che la paideia è un bene storico, soggetto al tempo, e che, pertanto, va continuamente curata e alimentata.
213
Dice l’Atensiese: “Non lasciamo allora nel vago ciò che chiamiamo educazione. Ora infatti, criticando ed elogiando
l’educazione di ciascuno, diciamo che quello, fra noi, è ben educato e quell’altro privo di educazione, e anche, talvolta, ci riferiamo a
chi è ben addestrato nei commerci e nei traffici marittimi, e ad altri uomini esperti in altre attività. Ma il nostro ragionamento, a
quanto pare, non è proprio di chi pensa che l’educazione consista in queste cose, ma di chi piuttosto crede che l’educazione formi sin
da giovani alla virtù, suscitando l’amore e il desiderio di realizzarsi come cittadini, in modo da saper governare ed essere governati
secondo giustizia” (Leggi, 643 d-e).
206
piaceri e i dolori”.214 Platone rileva come la stessa sfera delle passioni costituisce la base della vita psichica e
che proprio essa, opportunamente educata nel senso della capacità di orientamento verso ciò che è bene,
rappresenta la condizione primaria della virtù. Il fanciullo deve imparare giocando ad amare il bene e a
odiare il male. La paideia incomincia, dunque, con la corretta formazione dei sentimenti di piacere e di
dolore: il piacere vero, infatti, è connesso al possesso del bene, mentre il dolore deriva dalla presenza del
male nell’anima.
Qui emerge in modo esplicito il problema dell’educazione delle forze irrazionali dell’anima; e tale
educazione è vista come il presupposto di ogni altra, cioè come la condizione per l’instaurazione del
dominio della ragione nell’intero comportamento, al fine dell’attuazione della giustizia.
L’educazione al moto ritmico e alla danza ha la stessa funzione: essa concorre a formare il senso del bello,
dell’armonico, dell’ordinato. Qui Platone sottolinea la sostanziale unità tra il bello e il buono. Le melodie canore
e i ritmi della danza sono fattori formativi di ethos: perciò essi non possono essere lasciati al gusto soggettivo
e al capriccio individuale dei poeti. Platone, a questo proposito, ammira quelle forme d’arte che gli sembrano
sottratte al gusto unilaterale e come ricondotte a criteri ideali di misura, come, ad esempio, le figure e le
forme artistiche egiziane, quasi ieraticamente composte. Poesia e musica sono vera paideia solo se sono
strutturate in base alla chiara visione della gerarchia dei beni. I canti del poeta sono “incanti” (epodai) per gli
ascoltatori: perciò è necessario che essi agiscano sull’anima in senso educativo e nella direzione della vera
paideia. Il legislatore, che vigila sull’educazione, ha anche il compito di curare che si dispongano strumenti
educativi efficaci e adatti allo scopo: perciò egli deve decidere anche in merito alle opere di musica e di
poesia che possono essere accostati ai fanciulli. Egli, disponendo un insieme di strumenti atti a incidere
piacevolmente sullo spirito, diventa formatore e modellatore (plastes) di buoni cittadini e uomini completi.
Nelle Leggi la paideia costituisce la questione fondamentale. Platone dice che l’educazione consiste
essenzialmente in un accordo profondo di passione (educata nel senso dell’amore verso il bene) e intelletto
(come consapevolezza di ciò che è bene) e che “proprio questo accordo rappresenta la più completa virtù”.215
A questo problema sono dedicati ben tre libri: il I, il II e il VII. Al legislatore è attribuito il compito di
disporre la paideia come condizione fondamentale della costituzione dello stato. Il buon legislatore, infatti,
non è colui che semplicemente impone le leggi, ma colui che educa i cittadini a comportarsi secondo le norme
più adatte alla civile convivenza: egli è come il buon medico, che discute col paziente intorno al metodo
migliore per tenersi in ottima salute e non si limita a prescrivere le medicine.216 E come il medico ha la
funzione di curare il mantenimento della buona salute, più che quella di intervenire quando sono insorte le
malattie, così il buon legislatore non ha tanto la funzione di punire i delitti, una volta che sono stati compiuti,
quanto piuttosto quella di vigilare affinché le condizioni dei rapporti tra i cittadini siano le migliori possibili,
in modo che non siano prodotte offese reciproche.217 Come la sanità è l’obiettivo del buon medico, così la
pacifica convivenza è lo scopo del buon legislatore.
Nella Repubblica ogni opera legislativa è resa superflua dall’educazione dei governanti e dei custodi, in
modo che lo stato perfetto si regge sulla sapienza dei filosofi che modellano la loro attività di governo
sull’idea di giustizia e attuano sempre, nelle concrete situazioni storiche, l’ordine armonico della vita umana.
Nelle Leggi, invece, i governanti hanno come fondamentale punto di riferimento, per la loro opera, le norme
scritte: ad essi, pertanto, non è necessaria la formazione prospettata nella Repubblica. Ora è la legislazione che
viene sottoposta al principio educativo, in modo da essere, essa stessa, strumento di paideia, allo stesso modo
che nella Repubblica lo erano i filosofi/reggitori.
La funzione educativa delle leggi è affidata specialmente ai proemi, che hanno un carattere persuasivo (a
differenza delle leggi vere e proprie, che hanno un carattere imperativo). I cittadini, così, sono riportati ai
princìpi del retto agire. Platone segue, del resto, la tradizione greca, secondo la quale la legislazione
promuove lo sviluppo delle virtù civiche. Egli ora si propone di investire di tutta la carica educativa il corpo
delle leggi, che, con la sua duplice funzione, persuasiva e prescrittiva, assicura la paideia come ethos della
società civile.
214
Leggi, 653 c.
Leggi, 653 b: aυτη σθ η συµφωνια συµπασα µεν
αρετη (aute ‘sth’e symfonia sympasa men areté).
216
Si limita a prescrivere le medicine un medico di schiavi, cioè di individui che, non partecipando a una comunità di uomini
liberi, non contemplano una vera e propria forma di educazione. E i legislatori attuali, osserva Platone, non essendo veri educatori e
limitandosi a imporre leggi delle quali i cittadini non assumono consapevolezza, somigliano a tali medici, che, in modo autoritario e
sbrigativo, prescrivono le medicine (Leggi, 720 a; 757 d-e).
217
“Il proposito di Platone, nei suoi Nomoi, è di trarre le conclusioni dal parallelismo posto già nel Gorgia fra cura del corpo e cura
dell’anima, azione medica e azione politica, e di condurre alla vittoria l’idea della paideia nel campo della legislazione” (W. Jaeger,
Paideia, III, cit., p. 375).
215
Se la questione fondamentale è la paideia, se questa rappresenta la stessa forma essenziale dello stato e se la
mancanza di paideia, l’incultura, è la causa di decadenza di ogni stato, per cui bisogna sottrarre agli incolti la
facoltà di stabilire le leggi e di influire sul governo, come si ha la figura del giusto legislatore?
Platone deve attribuire a una fonte divina l’ispirazione del legislatore: tanta alta, infatti, questa deve
essere, se detta le condizioni e i modi per i quali si compie la perfezione umana e si attua la virtù completa. Il
legislatore deve apparire come il tramite attraverso il quale il logos divino riesce a giungere agli uomini e si
muta in corpo legislativo e, quindi, in istituzione politica. Egli è, perciò, un uomo che conosce Dio. La stessa
tradizione greca chiamava tali uomini “divini”: così, il leggendario Minosse, mitica figura esemplare di
legislatore, era considerato figlio di Zeus e si diceva che egli si recasse periodicamente dal padre per
attingere indicazioni sul modo di governare; e la sapienza del legislatore era riportata a una specie di
rivelazione.218
Il problema fondamentale che si pone alla base di ogni opera legislativa consiste nella individuazione
dello stesso principio che regge l’ordine cosmico e che è al di sopra della volontà umana.
Nella Repubblica, questo principio è individuato nell’idea del Bene; ora il fondamento è posto in Dio, come
principio, mezzo e fine di tutte le cose.219 Il cosmo è ordinato teleologicamente e la polis è inserita nell’ordine
cosmico. Il legislatore, dunque, assume a principio e fondamento della sua opera lo stesso principio stabilito
dal dio per l’ordine dell’universo. Così la paideia che costituisce la sostanza dello stato giusto si riporta al
fondamento primo di tutte le cose e Dio appare come il pedagogo del mondo, che “dirige tutto verso la giustizia
e la felicità”.220 Nel Timeo Platone dimostra come l’ordine delle idee è inserito dal Demiurgo nell’universo
fisico; nelle Leggi dimostra come il filosofo si fa demiurgo della città e come la paideia si dispiega nell’ordine
dello stato, in modo da attuare la giustizia e la perfezione umana. L’opera di Dio, dunque, si completa
attraverso l’opera del legislatore, che modella la città in relazione al cosmo.221
Il legislatore svolge la sua azione educativa specialmente attraverso i proemi preposti alle leggi. Dopo il
proemio riguardante la natura della famiglia e il fondamento divino che questa istituzione assume,222 Platone
si sofferma sulla struttura dell’anima. Quindi incomincia la trattazione più specifica intorno alle istituzioni
dello stato, sugli uffici e sulle varie competenze.
Tutti coloro che sono chiamati a svolgere un ruolo nel governo dello stato devono possedere un’areté
eminente e, dunque, ricevono un’educazione adeguata. Si fa distinzione, perciò, tra la “paideia” elementare,
propria di tutti i cittadini, e quella approfondita e completa, riservata a chi svolge funzioni di governo.223
218
Per Platone, la filosofia non è altro che lo sviluppo dell’antica sapienza oracolare e ha preso il posto della rivelazione divina già
raccolta dai poeti. In realtà, il sapere dialettico, basato sul potere della ragione, rappresenta la piena conquista umana della capacità di
conoscere. Perciò il legislatore è il filosofo.
219
“Il dio è per noi misura di tutte le cose” (Leggi, 716 c).
220
Leggi, 897 b.
221
“Qui si esprime chiaramente la consapevolezza legislatrice di Platone. Il legislatore è, alla fine, Dio stesso; il legislatore umano
parla in virtù della propria conoscenza di Dio; da Dio ricevono autorità le leggi che egli emana. Questo era stato il fondamento su cui
anche l’antica polis greca aveva elevato la propria legislazione. Platone ricostruisce questo edificio, ma nuova è la sua idea di Dio, e
di essa è compenetrata la totalità delle sue leggi” (W. Jaeger, Paideia, III, cit., p. 393, nota 78).
222
Ecco, a proposito della famiglia, un esempio della doppia formulazione della legge, cioè di quella prescrittiva e di quella
persuasiva, posta a modo di proemio: “Formuliamo in primo luogo la forma semplice della legge, che può suonare così: ‘Ognuno si
deve sposare, tra i trenta e i trentacinque anni; in caso contrario, sia punito con una multa o con la privazione dei diritti civili, e la
multa ammonti a tanto e a tanto, e in questo e in quel modo avvenga la privazione dei diritti civili’. Sia tale la formulazione semplice
della legge riguardante i matrimoni, mentre quella doppia sia così: ‘Ognuno si deve sposare, tra i trenta e i trentacinque anni,
considerando che in certo modo il genere umano per una certa sua natura prende parte dell’immortalità, di cui ognuno ha innato e
profondo desiderio; e questo desiderio consiste nel diventare celebri, evitando di rimanere senza nome una volta che si è morti. La
stirpe degli uomini è connaturata con il tempo nella sua totalità, perché lo accompagna e lo accompagnerà sino alla fine, e in tal
modo è immortale, per cui, lasciando i figli e i figli dei figli e restando sempre identica ed una, mediante la generazione dei figli
prende parte dell’immortalità: privarsi allora volontariamente di ciò non è cosa affatto pia, e deliberatamente agisce così chi trascura
moglie e figli. Chi dunque rispetta la legge non sarà oppresso dalla punizione, chi al contrario non obbedisce, e non si è ancora
sposato pur avendo raggiunto l’età di trentacinque anni, sia punito ogni anno con una multa che ammonta a tanto e a tanto, in modo
che non pensi che il celibato gli porti qualche guadagno o sollievo, e non prenda parte di quegli onori che in uno stato i più giovani
rendono ogni volta ai più anziani’” (Leggi, 721 b-d).
223
“In realtà la creazione di un sistema completo di istruzione elementare che costituisce la paideia del popolo e la base
dell’istruzione superiore, che era stata argomento delle opere anteriori, fu una delle più audaci innovazioni di Platone, ben degna del
suo genio pedagogico. […] Fu questo l’ultimo passo compiuto sulla linea del movimento socratico, per attuarne il programma, un
passo che doveva avere a distanza i più vasti effetti, sebbene allora nessun legislatore si sentisse tentato a tradurre nei fatti l’ideale
platonico di un’educazione generale delle masse” (W. Jaeger, Paideia, III, cit., p. 433). In realtà, l’antico ideale aristocratico di una
formazione della personalità umana nella sua completezza, cioè della complessa areté, ora diventava ideale di formazione dell’uomo
come cittadino. Come osserva ancora lo Jaeger: “L’ideale dell’areté fu trasferito all’educazione dei cittadini tutti, che, nelle mutate
condizioni sociali e politiche della città-stato dell’età classica, aspiravano ormai a partecipare alla kalokagathia dei gruppi più colti.
Nella maggior parte delle città greche mancavano regolamenti legali sull’ordine familiare e
sull’educazione dei fanciulli.
Platone prevede una commissione di donne, con sede ufficiale nel tempio di Eylethya (la dea delle
nascite), col compito di sovrintendere alla maternità, fornendo assistenza e consigli alle giovani coppie ed
esercitando la dovuta sorveglianza per il periodo assegnato alla procreazione (i dieci anni dopo le nozze). Il
filosofo si sofferma a lungo sui princìpi dell’eugenetica e, poi, sull’educazione dei bambini, a partire dalla
nascita e per tutta la prima infanzia.
Particolarmente notevoli, per la profondità dell’intelligenza psicologica, appaiono le osservazioni
sull’educazione del fanciullo dal 3° al 6° anno, periodo in cui prevale il giuoco. L’educazione di maschi e
femmine è curata da educatrici e avviene in forma di coeducazione. In questo periodo è curata specialmente
l’attività ginnica e il principio dominante è quello dell’imparare giocando. Nel giuoco liberamente scelto e
praticato, i bambini rivelano le loro inclinazioni: perciò il giuoco deve essere lasciato alla inventiva dei
fanciulli.
D’altra parte, Platone ritiene che lo spirito umano, in quanto dotato di una natura stabile, si esprime, in
quest’età, in forme spontanee pressoché immutabili. I fanciulli colgono con particolare forza l’immutabilità
delle forme fondamentali della realtà: perciò essi vanno educati sulla base di ritmi, di canti, di figure che
abbiano una identità che li faccia apparire perfetti. Le forme delle cose appaiono quasi come sacre, tali da
contenere in sé qualcosa di divino e di eterno.
Così anche il giuoco appare in una prospettiva teologica, secondo il concetto che l’uomo è una marionetta
nelle mani del dio.224 In realtà, Dio dirige le inclinazioni umane verso le forme più alte di umanità; e proprio
questo moto bisogna assecondare e rafforzare con l’educazione, in modo che il giuoco umano sia il più
possibile rispondente a ciò che Dio vuole che noi facciamo. Giocare nel modo in cui è voluto da Dio vuol dire
lasciare che la ragione guidi le nostre inclinazioni e che la nostra vita si realizzi nella virtù. E tutto ciò rientra
nella paideia.
Platone rileva che la lotta e la guerra non corrispondono a ciò che di veramente serio ha la vita, giacché
non contengono alcuna forma di giuoco e di educazione.225
All’intero sistema educativo sovrintenderà un funzionario supremo, scelto tra i membri del Consiglio
Notturno dei “custodi delle leggi”.
Un altro problema trattato in modo particolareggiato riguarda lo studio dei poeti. Questo comprende,
secondo Platone, passi significativi di opere poetiche e la lettura del testo stesso delle Leggi, presentate come
opera di vera poesia, in quanto imitazione della vita più bella e migliore.226
L’educazione popolare comprende anche gli elementi della matematica e dell’astronomia, che sono visti
nella loro funzione teologica, cioè in quanto aiutano a comprendere la struttura armonica dell’universo.
[…] Il passo, di portata rivoluzionaria, fatto da Platone nelle Leggi, l’ultima sua parola in fatto di educazione e politica, è la proposta
istituzione di un autentico sistema di istruzione popolare ad opera dello stato” (Ib.).
224
“Dobbiamo pensare che ciascuno di noi, esseri viventi, è come una macchina prodigiosa realizzata dagli dèi, vuoi per loro
divertimento, vuoi per uno scopo serio; questo non lo sappiamo. Ciò che invece sappiamo è che queste passioni, che sono in noi
come corde o funicelle, ci tirano, ed essendo opposte tra loro, ci tirano in senso contrario, trascinandoci verso azioni opposte, ed è
così che si stabilisce la differenza tra la virtù e il vizio. La ragione ci consiglia di seguire sempre uno solo di questi stimoli, di non
abbandonarlo affatto, e di resistere a tutti gli altri fili: questa è la regola d’oro della ragione, quella sacra condotta che viene chiamata
la pubblica legge dello stato […]. Bisogna collaborare sempre con la splendida guida della legge: poiché la ragione è bella, mite, e
priva di violenza, la sua guida ha bisogno di collaboratori affinché in noi la stirpe d’oro vinca sulle altre stirpi. E così il mito della
virtù, secondo cui noi siamo come macchine prodigiose, verrà salvaguardato, e in un certo senso comprenderemo più chiaramente il
senso dell’espressione: ‘essere superiori o inferiori a se stessi’. E per quanto riguarda lo stato e il privato cittadino, bisogna che il
privato cittadino accolga dentro di sé la vera ragion d’essere di questi stimoli e ad essa conformi la propria vita, mentre lo stato,
ricevendo da un dio o da quel cittadino che abbia conosciuto tale ragione, deve stabilirla come legge sia nelle relazioni con se stesso,
sia in quelle con gli altri stati” (Leggi, 644 d-645 b).
225
“Io dico che dobbiamo occuparci di ciò che è serie, e non di ciò che serio non è: e per natura ciò che è divino è degno di ogni
interesse, come un essere beato, mentre l’uomo, come dicevamo prima, è soltanto un giocattolo fabbricato dagli dèi, ed in effetti
questa è la sua parte migliore. In conseguenza di questa concezione, ogni uomo e ogni donna devono vivere giocando al meglio
possibile questo gioco, pensando il contrario di ciò che oggi si pensa. […] Oggi si pensa che le cose serie siano in funzione dei
divertimenti: si ritiene, ad esempio, che le questioni riguardanti la guerra, che sono appunto cose serie, debbano essere bene stabilite
in funzione della pace. Ma ciò che accade in guerra non è per natura un divertimento, e non ha e non avrà mai una funzione educativa
che meriti la nostra attenzione, mentre questa diciamo che secondo noi è la cosa più impegnativa: ognuno deve trascorrere il più
possibile la propria esistenza in pace. Quale sarà allora un retto criterio per vivere? Bisogna vivere giocando i propri giochi, facendo
sacrifici, cantando e danzando, in modo da poter rendere benevoli a se stessi gli dèi” (Leggi, 803 c-e).
226
Ai poeti tragici che domandano ospitalità, così rispondono i legislatori: “Ospiti nobilissimi, noi stessi siamo poeti di una
tragedia che, nei limiti del possibile, è la più bella e la più nobile: tutta la nostra costituzione politica si è formata sull’imitazione
della vita più bella e più nobile, e in questo noi diciamo che consiste in realtà la tragedia più vera. Poeti siete voi, poeti lo siamo
anche noi, poeti della stessa materia, vostri rivali nell’arte, vostri antagonisti nel comporre il dramma più bello che soltanto la vera
legge può per natura compiere, come noi ora speriamo” (Leggi, 817 b).
Perciò anche qui la paideia assume la forma di accostamento alla comprensione del divino. E l’esigenza di
un’istruzione matematica e astronomica si collega con quella particolare teologia astrale, che costituisce uno
dei temi fondamentali delle Leggi.227
Il Consiglio notturno è l’organo fondamentale dello stato, quello a cui è noto il fine di ogni azione umana
nell’ambito della polis. I componenti di questo supremo organo devono possedere la virtù intera e la
conoscenza filosofica della dialettica uno/molteplice.228 Perciò la suprema conoscenza è quella dell’unità del
Fondamento (che anche qui, come nella Repubblica, coincide col Bene). E i reggitori devono possedere questa
conoscenza dialettica del Bene: essi devono essere filosofi e teologi. In modo analogo all’opera del Demiurgo,
che imprime all’universo la forma del mondo delle idee, così i reggitori hanno il compito di imprimere allo
stato la forma divina dell’unita del cosmo.
La “VII Lettera”
Nella VII Lettera Platone ci ragguaglia intorno al suo itinerario spirituale, fino al suo primo viaggio nella
Magna Grecia e a Siracusa. Dal racconto emerge che l’interesse per la riforma dello stato greco rappresenta il
motivo dominante della sua giovinezza, tutta presa da viva passione politica. Lo stesso Socrate appare come
il grande iniziatore alla politica, colui che ha messo in rilievo la stretta connessione tra formazione filosofica
e riforma dello stato. E la morte di Socrate non era che la prova che uno stato nuovo sarebbe potuto sorgere
solo da un’educazione filosofica, che avesse trasformato la stessa esistenza degli individui. La convinzione
che non ci sarebbe stata una vera riforma dello stato se prima i governanti non avessero ricevuto una
formazione filosofica costituirà il principio fondamentale della concezione platonica dello stato. E con tale
convinzione Platone intorno al 388 (cioè circa a 40 anni) si recò a Siracusa, dove attrasse alle sue idee Dione,
parente e amico del tiranno Dionisio il Vecchio. Attraverso la mediazione di Dione il tiranno sarebbe dovuto
essere guadagnato al programma platonico di una riforma dello stato attraverso l’educazione filosofica.
Dione si fece interprete, presso il tiranno, dell’esigenza platonica di una costituzione secondo i princìpi dello
stato giusto.
Il piano fallì e Platone tornò ad Atene. Ma Dione mantenne quell’idea di riforma politica, attendendo il
momento più favorevole per la sua attuazione. L’occasione si presentò alla morte di Dionisio I, nel 367,
allorché gli successe il giovane figlio Dionisio II. Intorno al 370, intanto, era apparsa la Repubblica e l’ideale
politico di Platone era chiaramente delineato. Platone allora pensò di potere attuare, con l’aiuto di Dione,
l’educazione filosofica del giovane principe. Del resto, lo stato ideale appariva come un modello non
trasferibile nella concreta realtà storica; mentre più accessibile appariva la riforma di uno stato esistente.
Nella Repubblica Platone aveva detto che un “figlio di re” educato alla filosofia avrebbe potuto realizzare
qualcosa di simile allo stato ideale. Ed è possibile che, già al tempo in cui scriveva quell’opera, egli avesse in
mente il progetto di educare il giovane Dionisio. Dione stesso sollecitò il filosofo con lettere e messaggi a
tornare in Sicilia, per realizzare le due idee intorno allo stato perfetto.
Ma, appena arrivato a Siracusa, Platone poté constatare che l’ambiente non era il più propizio per
l’attuazione del suo progetto. Dionisio II si convinse che Dione cercava di approfittare dell’appoggio del
filosofo per sostituirlo nel potere e, perciò, lo mandò in esilio, cercando di conservare l’amicizia di Platone.
Costui allora rientrò ad Atene, ma qualche anno dopo accettò nuovamente l’invito di Dionisio, forse
incoraggiato dall’insistenza dei suoi amici siracusani e dai pitagorici dell’Italia meridionale, specialmente dal
grande matematico Archita, reggitore di Taranto. Dionisio mandò ad Atene un vascello da guerra, per
facilitargli il viaggio e promise che avrebbe richiamato Dione dall’esilio.
Platone si sofferma a descrivere la situazione in cui si trovò come educatore di Dionisio. Costui appariva
come tutt’altro che il tipo di discepolo ideale, piuttosto convinto com’era di potere facilmente e in breve
tempo appropriarsi dei princìpi della filosofia e, pertanto, tutt’altro che disposto ad affrontare ostacoli e a
impegnare tutte le sue energie intellettuali per l’acquisizione di quel sapere che doveva rappresentare un
227
“L’antico umanesimo, nella forma raggiunta nella paideia platonica, trova il suo centro in Dio. Lo Stato è la forma sociale che
la tradizione storica del popolo greco offriva a Platone, per imprimervi questa idea. Ma nell’atto in cui egli investiva questa forma
della sua nuova idea di Dio, come misura di tutte le misure, la trasformava da organizzazione terrena, fissata nel tempo e nello
spazio, in un ideale regno divino, universale come il suo simbolo, gli animati astri divini. Quei corpi raggianti sono le immagini degli
dèi, gli agalmata [ornamenti], che il platonismo solleva al posto delle immagini degli umani dèi d’Olimpo. Non esiliati nella
strettezza d’un tempio costruito da mano umana, essi irraggiano una luce che annunzia l’unico, supremo, invisibile Dio a tutti i
popoli della terra” (W. Jaeger, Paideia, III, cit., p. 466).
228
“E non dicevamo che l’artigiano che è valente in ogni cosa, e così il custode, non solo dev’essere in grado di mirare a tutti i
molti e vari aspetti di una cosa, ma deve aspirare all’uno e conoscerlo, e una volta che ne ha preso conoscenza, deve ordinare tutto
quanto in vista di quell’uno in modo che si possa abbracciare con uno sguardo d’insieme?” (Leggi, 965 b).
modo di vita, conforme all’ideale paideia delineata nella Repubblica. Il giovane tiranno già si atteggiava a
dotto e sfoggiava un sapere appreso superficialmente, come se si trattasse di una profonda filosofia. La
prova che egli si era fatta un’idea interamente errata della filosofia è costituita dal fatto che successivamente
pretese addirittura esporre in un trattato, come sua personale dottrina, quel che aveva appreso in materia
filosofica.
A questo proposito, Platone trae l’occasione per ribadire e precisare il suo concetto di filosofia, come
ricerca che si alimenta continuamente come fuoco vivo e che non può essere affidata all’esposizione scritta.
Egli qui si riferisce all’oggetto più alto della filosofia, al principio o fondamento, che costituisce il nucleo di
ogni conoscenza filosofica e che completa la vera paideia. Di questo oggetto, dello stesso Bene/Uno come
principio Platone dice di non averne trattato per iscritto e che, piuttosto, ne ha fatto il tema di una continua
discussione ed esercitazione dialettica nell’ambito della scuola. Lo spirito, infatti, appare pronto a
soffermarsi su tali questioni dopo che si è lungamente esercitato nella dialettica e ha riflettuto su altri temi,
riguardanti oggetti di livello e dignità inferiori. Allorché la “paideia” filosofica ha compiuto il suo maggiore
percorso, è possibile accingersi ad affrontare le cose divine. Ciò implica la catarsi dello spirito dagli elementi
sensibili. Ma si tratta di un percorso di lunga durata e solo chi ha profondamente familiarizzato con la
dialettica può, ad un certo punto, essere pronto per un tipo di riflessione superiore. Platone ricorre
all’immagine della scintilla che si accende nella coscienza e si alimenta da sé (341 d). Chi ha percorso il lungo
cammino della “paideia” filosofica può assistere a questo miracolo all’interno di sé, può, cioè, vedere
crescere e svilupparsi la conoscenza dei primi princìpi.
Platone ripercorre, a questo proposito, le tappe del processo conoscitivo che porta alla comprensione
dell’essere, servendosi di un esempio tratto dalla matematica, la conoscenza del cerchio. Egli, pertanto,
intende mostrare come la conoscenza filosofica, che riguarda l’essere (l’essere dell’ente, l’idea o l’essenza
immutabile e una), si differenzia dalle altre forme di conoscenza.
Platone dice che la scienza si raggiunge attraverso tre mezzi: la parola, la definizione e l’immagine; e che il
sapere filosofico sta al di là di questi mezzi (ai quali corrispondono anche particolari forme di conoscenza), e
al di là del sapere c’è l’oggetto stesso, l’essere come tale. Così, nell’esempio riportato, “cerchio” è in primo
luogo la parola che noi abbiamo a disposizione (e nella quale è depositata, si può dire, una certa conoscenza);
in secondo luogo abbiamo la definizione che noi diamo attraverso altre parole (cerchio è ciò che ha le parti
equidistanti dal centro); in terzo luogo noi tracciamo la figura del cerchio, che è l’immagine visibile del
concetto relativo; quindi, come quarto momento, abbiamo la conoscenza che riassume gli elementi costituiti
dai primi tre momenti del processo conoscitivo: e si tratta di una conoscenza che vive nell’intelligenza che la
attua; il cerchio in sé, infine, rappresenta l’essere come oggetto del sapere filosofico: esso è indicato nel I
momento (il nome), definito nel II (la definizione), raffigurato nel III (l’immagine), pensato e compreso nel IV
(l’essere).
Platone mette in rilievo, ancora, il carattere problematico e provvisorio di ogni sapere. Infatti, allorché si
sono percorse tutte le tappe che conducono all’intelligenza dell’oggetto, la conoscenza così acquisita non è
definitiva; occorre ritornare indietro e ripercorrere ancora una volta quel cammino, in quanto i singoli
elementi sono instabili e approssimativi. Infatti il nome è variabile, la definizione è fatta di nomi, la
raffigurazione o immagine è sempre imperfetta (in quanto, ad esempio, la figura del cerchio si avvicina alla
linea retta, mentre dovrebbe escluderla). Si tratta, perciò, di controllare continuamente l’uno con l’altro
questi elementi, andando continuamente dall’uno all’altro e ripercorrendo il cammino già percorso.
In questo modo Platone ci dà un’idea comprensiva e unitaria del sapere. Il sapere filosofico implica un
rapporto continuo con le altre forme di conoscenza: esso si rende possibile sulla base di queste e, a sua volta,
ritorna ad esse, per stimolarle a ulteriori approfondimenti. La filosofia è un dialogare continuo dello spirito
con se stesso e con le altre coscienze. Essa è un esercizio che insieme riguarda la ricerca della verità e il vivere
e l’agire perseguendo ciò che è bene per l’uomo.229
229
Come osserva Nicola Abbagnano, qui la saggezza pratica e l’intelligenza della realtà si coniugano insieme e coincidono:
“Senza l’intelligenza l’uomo non può assurgere a quella virtù che si rivela nell’azione, come senza questa virtù l’uomo non può
assurgere all’intelligenza. Questa condizionalità reciproca della saggezza e dell’intelligenza è espressa da Platone con due concetti: la
parentela dell’uomo che ricerca con l’essere che è oggetto della ricerca; e la comunità della libera educazione. In primo luogo,
l’uomo raggiunge quel rapporto con l’essere in cui consiste il grado più alto della scienza, l’intelligenza, se non in virtù di una intima
e profonda parentela con l’essere” (Storia della filosofia, I, p. 108). Questo vincolo dell’uomo con l’essere si riflette, quindi, sul
piano della comunicazione e della realtà politica, come sforzo comune di ricerca e comune esercizio della virtù. Come osserva ancora
opportunamente l’Abbagnano: “Il rapporto originario con l’essere nel suo più alto valore (la giustizia e il bello) condiziona e stimola
l’efficacia e la riuscita della ricerca. Ma dall’altro lato la ricerca non può svolgersi nel chiuso mondo dell’individualità. Essa è opera
di uomini che ‘vivono insieme’ e ‘discutono con benevolenza’ e senza lasciarsi suggerire dall’invidia le domande e le risposte.
Suppone cioè la solidarietà dell’individuo con gli altri, l’abbandono della pretesa di credersi in possesso della verità e di non volere
apprendere nulla dagli altri, la sincerità su se steso e con gli altri e lo sforzo solidale” (ib.). “Così il concetto platonico del filosofare
L’ultima parte della lettera racconta gli eventi drammatici della rottura di Platone con Dionisio II. Il
tiranno attua quella politica della violenza che il filosofo ha tratteggiato con chiarezza nel Gorgia: egli
confisca il patrimonio di Dione e trattiene lo stesso Platone nella caserma delle guardie del corpo. Quando
poi ottiene di ritornare ad Atene, egli rifiuta di partecipare alla congiura che intanto Dione e i suoi seguaci
stavano organizzando contro il tiranno e durante la quale caddero entrambi i membri della famiglia
principesca.
Il fallimento del tentativo siciliano non cambiava l’ideale platonico, della cui convinzione è documento e
testimonianza la stessa Lettera VII. Pur tuttavia, anche se Platone non venne indotto a deflettere dai suoi
concetti sulla comunità umana e sull’essenza della “paideia”, “è pur vero che l’esperienza siracusana fu
tragedia anche per lui”.230
Per quanto riguarda la metafisica che Platone sviluppa sommariamente nel famoso excursus, qui si possono
rintracciare alcuni motivi della concezione del principio come unità dialettica di essere/bene/bello/ vero. La
filosofia coglie la realtà in rapporto al rapporto ontologico che la costituisce fondamentalmente. Essa riguarda
specialmente la consapevolezza che l’uomo consegue della sua appartenenza a questa costituzione
essenziale del reale; e la “paideia” filosofica riguarda i modi in cui questa consapevolezza si traduce in
comportamento pratico e in vita politica.
In realtà, qui Platone sembra parlarci della massima espressione alla quale perviene l’ideale socratico della
filosofia come esercizio della virtù politica. Egli, d’altra parte, espone il caso della sua esperienza,
mostrandoci come non vi sia, per l’uomo che aspira alla realizzazione della sua essenza, possibilità di
successo, finché non sia attuato lo stato giusto, nel cui ambito sia realizzata la libera comunità della
“paideia” filosofica.
La VII Lettera, in questo senso, è un vero e proprio testamento spirituale, in cui è sintetizzato il senso della
riflessione platonica: “Vidi dunque che mai sarebbero cessate le sciagure delle generazioni umane, se prima
al potere politico non fossero pervenuti uomini veramente e schiettamente filosofi, o i capi politici delle città
non fossero divenuti, per qualche sorte divina, veri filosofi” (326 b).
Breve storia delle interpretazioni platoniche
Platone è il più letto e conosciuto di tutti i filosofi. Non c’è pensatore o corrente filosofica che non abbia
dovuto fare, in primo luogo, i conti con Platone. La fortuna di questo filosofo ha attraversato si può dire
immutata i secoli, dalla costante presenza nello svolgimento del pensiero greco alla grande rinascita
attraverso Plotino, alla integrale trasmigrazione nella cultura cristiana e nella filosofia medievale, dal
vittorioso confronto con l’aristotelismo nell’età del Rinascimento al contributo decisivo allo sviluppo della
scienza matematica della natura, dall’affermazione della filosofia trascendentale e idealistica fino alle recenti
forme dell’indagine emerse nella fenomenologia e nell’ermeneutica. Tutti i filosofi hanno attinto da Platone
idee, motivi di interrogazione problematica, elementi di soluzione e di impostazione delle questioni. Platone,
in particolare, ha tramandato il concetto della filosofia come ricerca razionale, rivolta a “dar ragione” degli
aspetti della realtà. Egli ha insegnato a generazioni di pensatori come riuscire a rendere il reale intelligibile e
come fondare una scienza razionale (dunque universale), come evitare il dogmatismo e lo scetticismo
insieme, come, pertanto, mantenere viva la fiducia nella possibilità di spingere la domanda fino a una
sempre più adeguata scoperta della verità. Le forme e i modi in cui i Dialoghi sono stati letti, in rapporto alle
istanze culturali delle diverse epoche storiche, attestano l’efficacia di un pensiero aperto, sempre vivo, in
grado di costituire la base per ogni esigenza interpretativa.
Vediamo qualche esempio più significativo di questa singolare forma di pensiero, idonea a rappresentare
un modello per ogni problematica e impostazione culturale, propria di ogni momento storico e di ogni
istanza teoretica.
è il più alto e più ampio che sia mai stato affermato nella storia della filosofia. Nessuna attività umana cade fuori di esso. […] La
ricerca in cui il filosofare si realizza non consiste nella formulazione di una dottrina: qualsiasi compito umano offre all’uomo la
possibilità di raggiungere la verità e di congiungersi all’essere” (op. cit., p. 109). La filosofia è qui intesa nell’autentico significato
socratico di modo d’essere dell’uomo in conformità del suo essere proprio, ricerca di tale modalità essenziale e sforzo per attuarla
nella comunità politica alla quale si appartiene. Essa, pertanto, non può essere identificata con una semplice attività intellettuale
rivolta alla costruzione di un sapere oggettivo (cioè riguardante l’essere come oggetto della riflessione e non anche come possesso
dell’essere proprio).
230
W. Jaeger, Paideia, III, p. 367.
Su alcune recenti interpretazioni platoniche.
Per un’interpretazione “sistematica” del pensiero di Platone.
Gadamer ha osservato che non si possono leggere i dialoghi platonici senza tenere conto della tradizione indiretta
(che comprende le “dottrine non scritte”).231 E in ciò egli si riferiva alla sua ermeneutica, per la quale
l’interpretazione di un testo (ma anche la sua composizione e scrittura) avviene nell’ambito di un contesto di
pensiero che è già, in qualche modo, una concezione del mondo. Già lo stesso Platone nel Fedro aveva
rilevato l’insufficienza del discorso scritto e la funzione del pensiero vivo, solo traducibile nel corso del
dialogo e della discussione orale (in cui si dà una dinamica di interrogare e rispondere). Solo in funzione di
un pensiero interpretante un testo può avere significato. Platone, dunque, supponeva l’esistenza di un
pensiero non scritto, come strumento in virtù del quale i testi scritti potessero essere compresi nei loro
significasti. Gli scritti avrebbero, in questo senso, la funzione di richiamare alla memoria ciò che già si sa,
non quella di elaborare nuove conoscenze. Prima che nel discorso scritto, il pensiero e la conoscenza
prendono corpo nella mente del soggetto che indaga. Perciò Gadamer ha parlato del “circolo ermeneutico”
come del contesto culturale complessivo in cui ogni opera “vive”. Se in tale contesto non si pongono
domande che in un testo possono trovare risposte, questo testo può dirsi “inutile”. Ogni opera si iscrive in
un discorso aperto e “corrente”. Platone scrisse i dialoghi per fissare quelle domande e quelle risposte che
scaturivano dal generale contesto di pensiero del suo tempo: la morte di Socrate era, ad esempio, la grande
componente problematica di quel pensiero in cui interrogativi pressanti urgevano con particolare vivacità.
Giovanni Reale ha rilevato che in funzione delle “dottrine non scritte” le teorie di Platone acquistano una
significativa unità e sistematicità. Gadamer rifiuta una interpretazione “sistematica” di Platone, ma ciò nel
senso del “sistema” come costruzione artificiale, in cui ogni sviluppo e ogni parte hanno la loro ragion
d’essere nell’insieme già progettato. Sappiamo, invece, che il pensiero di Platone è come un fuoco vivo, un
corso di pensiero che di volta in volta accoglie ciò che vi si presenta nel suo cammino. Kramer ha precisato
che il progetto filosofico di Platone “era mantenuto piuttosto elastico e flessibile”; Gaiser ha osservato che “il
sistema platonico comporta un costante sviluppo”; Reale ha inteso sottolineare l’interna coerenza di quel
pensiero.
231
Cfr. G. Girgenti (a cura di), La nuova interpretazione di Platone. Un dialogo tra H. G. Gadamer e la Scuola di
Tubinga-Milano, Rusconi, Milano 1998.
CAPITOLO VII
Aristotele
Aristotele porta a compimento il progetto di un sistema enciclopedico delle scienze, avente a fondamento la “scienza
prima”, la filosofia o metafisica e, come introduzione, la teoria del metodo scientifico, la “logica”. La filosofia, in quanto
totalità del sistema, si articola, quindi, in rapporto alle sfere di cui si occupa, in “logica”, “filosofia prima”, “fisica”
(comprendente anche la “psicologia”), “etica”, “poetica” e “retorica”. La metafisica (o scienza prima) riguarda
principalmente l’essere e l’ente primo (Dio). Si distinguono diverse modalità dell’essere: fondamentale è l’essere
“sostanza”, cioè l’ente reale, che è sintesi di “forma” e “materia”. L’esistenza reale è, dunque, un modo d’essere. Un
altro modo d’essere può essere, infatti, quello della potenzialità (il legno è carbone in potenza). Ogni sostanza
comprende diverse qualità e queste sono modi dell’essere (essere qualità vuol dire essere attributi di una sostanza). I
modi d’essere che caratterizzano la sostanza sono le dieci “categorie”. I modi d’essere sono, dunque, i modi stessi della
predicazione (secondo cui si può dire qualcosa di un soggetto): perciò logica e metafisica s’intrecciano. Aristotele è
considerato il fondatore della teologia razionale: Dio è concepito come Atto puro, dunque come l’intera realtà
interamente dispiegata nella sua attualità e tale, dunque, da non contenere nessuna traccia di poter-essere; Dio
assolutamente è. Aristotele ha concorso alla elaborazione del sistema cosmologico antico, denominato, appunto,
“aristotelico-tolemaico”, secondo cui l’universo è distinto in due grandi sfere, quella sublunare in cui i quattro elementi
(terra, acqua, aria, fuoco), mescolandosi, danno luogo alla vicenda delle trasformazioni fisiche, e quella sovralunare,
costituita di un quinto elemento, l’etere, incorruttibile. L’anima è considerata come il principio formale proprio
dell’essere vivente.
Il sistema della scienza di Aristotele
Quando Raffaello nel celebre dipinto La Scuola d’Atene raffigurò Aristotele con l’indice rivolto a indicare la terra e
Platone nell’atteggiamento di indicare il cielo, esprimeva l’interpretazione corrente e, certo, non si proponeva problemi
di confronto critico. Ad ogni modo, egli rendeva efficacemente la notevole differenza tra i due filosofi: Platone
rappresenta la filosofia come ricerca, interrogazione intorno ai grandi problemi della realtà e dell’esistenza, mentre
Aristotele rappresenta lo spirito scientifico nel momento della sua maturità, allorché si dedica alla costruzione di
un’enciclopedia del sapere sistematica e completa; perciò l’uno sottolinea l’impossibilità per il filosofo di esporre i
risultati della sua indagine in qualsiasi forma sistematica, cioè in un qualche trattato, mentre l’altro adotta questa forma
come via di esposizione sistematica di conoscenze scientifiche ritenute pressoché definitive.
In Aristotele troviamo la prima vera e propria elaborazione di un metodo “organico” di indagine scientifica
intorno ai vari settori della realtà. Infatti il filosofo ha discusso sul metodo negli scritti di logica, riuniti
appunto in un insieme unitario al quale è stata data la denominazione di Organon, cioè strumento. Si tratta
della via unica e sicura di elaborazione del sapere scientifico, cioè di un sapere che non si configura come
ricerca in corso, pensiero in movimento, bensì come una vera e propria epistéme, cioè un insieme di conoscenze
certe, coordinate in un sistema idoneo a fornire una coerente rappresentazione delle cause dei fatti relativi ai
diversi campi della realtà (naturale e umana).
Vediamo, dunque, i princìpi fondamentali del metodo aristotelico. Alla base del metodo c’è la convinzione
che, seguendo una via ben delineata, il nostro intelletto può pervenire a una comprensione dei processi
causali che presiedono all’assetto dell’universo e alla produzione dei fenomeni. In primo luogo si tratta di
individuare le ragioni per cui si ha un ordine universale definito, al quale va ricondotto ogni esistere e ogni
accadere. La scienza riguarda non certo i vari accadimenti, ma l’ordine immutabile e universale, in base al
quale gli enti esistono e i fatti accadono. Dunque, si tratta, in primo luogo, di andare verso l’universale, pur
movendo dall’esperienza, cioè dalla constatazione dell’esistenza delle cose e della produzione dei fenomeni.
La scienza è possibile in virtù di questa capacità fondamentale dell’intelletto.
L’intelletto è la facoltà di comprendere l’universale. Infatti l’uomo si eleva senza difficoltà al piano della
comprensione concettuale: ad esempio, dalla constatazione di questo o quel tavolo perveniamo al concetto di
tavolo, che non indica questo o quell’oggetto particolare bensì ogni oggetto che ha le caratteristiche del
tavolo.
La base della scienza è, dunque, l’elaborazione dei concetti. I concetti sono già termini scientifici, in quanto
sono universali, indicano, cioè, non oggetti singoli ma, in qualche modo, l’essere di tanti oggetti particolari che
nell’esperienza si presentano in modi differenti. Perciò la prima guida metodica riguarda la sistemazione dei
concetti in un grande albero, in cui sono collocati in base al loro diverso grado di universalità. La prima
distinzione logica, in virtù della quale avviene tale collocazione, è quella tra genere e specie: il primo indica
una maggiore universalità rispetto al secondo (ad esempio, “albero” rispetto a “castagno”, “animale”
rispetto a “cavallo”). Ogni concetto va esattamente classificato; e questa classificazione è già la prima
operazione scientifica: così la prima nozione che ho riguardo alla natura del cavallo è il fatto che esso è un
animale.
Ma ciò ovviamente non basta. Infatti, si tratta, quindi, di determinare i caratteri specifici che appartengono a
tutti i cavalli, cioè i caratteri della specie “cavallo”. Si tratta ancora di caratteri universali: essi sono comuni a
tutti i cavalli esistenti. La scienza non si occupa dei caratteri particolari, che sono propri di questo cavallo,
bensì solo dei caratteri universali della specie.
Il concetto, dunque, corrisponde a una nozione scientifica: esso è uno strumento per conoscere (o riconoscere) gli enti che esistono. La conoscenza realizzata attraverso il concetto riguarda non tanto questo o
quell’ente, quanto, invece, come abbiamo visto, la specie e il genere a cui i vari enti appartengono. E il genere e
la specie non sono reali in sé; si può dire che sono modi e determinazioni d’essere, modalità secondo cui il reale
può concretamente configurarsi ed esistere. Tutto ciò che esiste appartiene a una specie, che, a sua volta,
appartiene a un genere.
Ogni scienza muove dalla definizione, che comprende il riferimento al genere e alle differenze specifiche: ad
esempio, l’uomo è definito “animale razionale”, intendendo la ragione come ciò che essenzialmente
differenzia l’uomo da tutti gli altri animali. Ma ovviamente la definizione non basta; e bisogna procedere a
precisare tutto ciò che è caratteristico di questa specie, ossia tutti i modi d’essere che le appartengono.
Questi modi d’essere sono le categorie. Come è noto, Aristotele enumera dieci categorie: sostanza, qualità,
quantità, relazione, luogo, tempo, situazione, avere, agire, patire. Di ogni specie si tratta di precisare tutto ciò che le
appartiene sotto il profilo di ciascuna categoria: tutte le qualità, ciò che le proprio dal punto di vista della
quantità (ad esempio, se può variare per la sua estensione), in che relazione si pone con altre specie (ad
esempio una stella rispetto a un pianeta), come si definisce nello spazio e nel tempo, che cosa può possedere
e sotto quali aspetti può presentarsi, che cosa può fare e subire. Una volta esaurito il discorso sotto questi
diversi punti di vista, si può dire che si ha una scienza completa di quella determinata specie.
Ciò per quanto riguarda gli enti che esistono nel loro modo d’essere. Poi vi sono i fatti che accadono. La
scienza dell’accadere riguarda le cause dell’accadere medesimo. Se un fiore sboccia, ad esempio, dobbiamo
individuare qual è la forza o il fattore che lo fa sbocciare. Aristotele individua quattro tipi di causa: materiale,
formale, agente, finale. Così, nel caso del fiore che sboccia, si ha, in primo luogo, il fiore non ancora sbocciato,
quindi la forma che il fiore assume dopo che è sbocciato, il fattore che determina il passaggio dalla prima alla
seconda situazione, il fatto che la forma compiuta del fiore è quella che esso assume dopo essere sbocciato,
dunque il fine dell’intero processo, che è sempre una certa perfezione d’essere.
Dunque, tra i fattori del divenire, cioè della produzione dei fatti, ci sono anche la potenza e l’atto (la
condizione del fiore non ancora sbocciato e quella del fiore nella sua forma compiuta). L’atto indica la
compiutezza relativa a un determinato modo d’essere (così il fiore può dirsi tale nell’atto del suo essere
sbocciato).
Nella descrizione di ogni fenomeno, è necessario fare riferimento a queste quattro cause. Tuttavia, la
causa agente assume un ruolo centrale: del cadere di una foglia, bisogna principalmente dire quali sono i
fattori che determinano prima l’ingiallirsi e poi il cadere.
Dobbiamo considerare anche quale funzione ha l’osservazione empirica nel processo della conoscenza. Per
Aristotele, ogni conoscenza muove dall’esperienza e ciò che costituisce il sapere scientifico è proprio
l’elaborazione dei dati empirici secondo i procedimenti logici che abbiamo esaminato. Perciò la via
fondamentale della conoscenza è l’induzione, cioè il passaggio dal particolare all’universale. Però un’altra via
è quella opposta, che da alcune conoscenze generali deduce conoscenze più specifiche: ad esempio, sapendo
che tutti i mammiferi respirano coi polmoni si deduce che la balena respira coi polmoni anche se vive per lo
più in acqua. La deduzione di ulteriori conoscenze da nozioni date avviene, secondo Aristotele, attraverso
forme di ragionamento che collegano alcune proposizioni con altre che hanno con esse un termine comune
(ad esempio, “Gli uomini sono intelligenti” e “Gli esseri intelligenti conseguono la conoscenza”, da queste
proposizioni si deduce che “Gli uomini conseguono la conoscenza”). Questo tipo di ragionamento è il
sillogismo. Aristotele individua tre figure principali del sillogismo: 1) il termine medio funge da soggetto
nella premessa maggiore e da predicato in quella minore; 2) il termine medio funge da predicato in entrambe
le premesse; 3) il termine medio funge da soggetto in entrambe le premesse. Le proposizioni, poi, sono o
affermative o negative e o universali o particolari, per cui si hanno di fatto proposizioni universali affermative,
particolari affermative, universali negative, particolari negative. Ciò vuol dire che per Aristotele tertium non datur:
o si afferma o si nega; non si può, ad esempio, attribuire a un soggetto un determinato predicato e poi
negarlo, perché ciò sarebbe contraddittorio. Il principio d’identità è anche principio di non contraddizione.
Come si vede, c’è un fondamentale intreccio di logica e metafisica. I princìpi logici non sono altro che gli
stessi princìpi in base ai quali è ordinata la realtà. Le categorie, così, non sono soltanto modi secondo cui
qualcosa può essere predicato di un soggetto, ma indicano modi generali dell’essere. Le categorie, perciò, nella
metafisica aristotelica, appartengono all’essere. La qualità in generale non appartiene a un qualche ente
determinato, per esempio al sole, al quale appartengono, invece, qualità determinate, come la luminosità; e
così il tempo: ogni ente estende la sua esistenza per un certo tempo, ma esso non è il tempo. L’essere cavallo,
ad esempio, appartiene all’ente; all’essere appartiene l’essere sostanza in generale. E così l’essere causa o
l’essere effetto appartengono all’essere.
La metafisica si occupa dell’essere in generale. Per Aristotele, la filosofia prima è, in primo luogo, scienza
dell’essere in quanto essere (cioè non in quanto ente); ma è anche scienza dell’Ente assoluto, cioè di Dio, di
quell’ente che è fuori del divenire e che ha un modo d’essere diverso da quello degli altri enti; infine è anche
scienza dei princìpi in base ai quali è costituita la realtà, ad esempio la potenza e l’atto, la materia e la forma, la
privazione, e così via.
Invece la fisica riguarda l’universo nella sua costituzione generale. Possiamo dire che essa riguarda la
realtà in quanto è dotata di movimento, cioè la natura. Il movimento, infatti, è il carattere fondamentale
dell’universo. Da Dio, che è motore immobile, deriva il movimento, che dal primo mobile si comunica,
attraverso motori secondari, alle diverse sfere dell’universo. E così le grandi regioni dell’universo, quella
sovralunare e quella sublunare, sono caratterizzate da due tipi di movimento diversi: il movimento circolare,
proprio degli astri, che sono corpi incorruttibili; e il movimento rettilineo, proprio dei corpi corruttibili,
costituiti dai quattro elementi (fuoco, aria, acqua, terra). Come è noto, Aristotele attribuisce un luogo naturale a
ciascuno di questi elementi: per questa ragione, ad esempio, il fuoco tende a salire, come animato da una
inclinazione a tornare alla sua sede naturale. La costituzione dei corpi dipende dal modo in cui questi
elementi vi fanno parte: vi sono corpi più aerei e leggeri e corpi più terrestri e pesanti. E così l’insieme delle
qualità dei corpi e delle sostanze dipende da tale costituzione, cioè dalla misura in cui sono presenti i quattro
elementi e dal modo in cui essi vi sono mescolati.
L’anima fa parte della natura. Aristotele considera l’anima come un principio attivo che informa una
determinata materia. Essa ha una consistenza materiale. Si tratta di una specie di fuoco che, dotato di una
determinata forma, è capace di espandersi per una certa materia e di avvolgerla in sé, imprimendo ad essa la
sua forma medesima, che in tal modo appare nella figura del corpo vivente. Si tratta di un’ipotesi suggestiva,
che costituisce un superamento del dualismo tra spirito e corpo. Tuttavia, l’anima intellettiva (che è propria
dell’uomo e che in sé comprende anche quella vegetativa e quella sensitiva), contiene, per Aristotele, una
parte, definita come intelletto attivo, che ha una derivazione divina, cioè è, in qualche modo, una parte
dell’intelletto di Dio.
Dio, in effetti, non può essere concepito come assolutamente trascendente l’universo. Per Aristotele, Dio
rappresenta l’ente perfetto, quella condizione reale che è già da sempre attuata nella forma dell’ente
determinato. Dio ha la determinazione dell’ente e, nello stesso tempo, ha la perfezione di ciò che è solo atto.
Il reale, cioè, deve avere anche questa forma, di ente interamente attuato nella sua perfezione. Si tratta,
dunque, di una condizione della realtà e di un principio.
Vediamo ora che posto occupa la morale nel sistema aristotelico. La morale è una scienza pratica, cioè
riguarda l’agire umano che tende verso uno scopo; e lo scopo generale è l’attuazione della realtà umana, che
è di natura razionale. L’uomo consegue la felicità allorché attua la sua natura, cioè consegue la sua
perfezione, allorché agisce secondo princìpi razionali. E tali princìpi dell’agire secondo ragione sono le virtù,
che, per Aristotele, non sono innate bensì vanno acquisite con l’esercizio e l’abitudine.
Aristotele distingue le virtù etiche e quelle dianoetiche. Si può dire che le une sono vie dell’azione, mentre le
altre corrispondono a situazioni di per sé perfette: la giustizia, ad esempio, serve all’individuo per
comportarsi in modo equo nei confronti degli altri, invece la sapienza è una condizione umana, non
subordinata a un comportamento determinato. La sapienza, cioè, è un valore in sé e non è subordinata al
comportamento saggio.
Nonostante, poi, nella trattazione del problema dello stato Aristotele segua una linea scientifica e
descrittiva, si può dire che egli segua un certo ideale politico: egli, infatti, considera come migliore forma di
stato la politeia, in cui tutti i cittadini partecipano al governo, in una condizione media tra il comandare e
l’ubbidire.
Infine Aristotele ha scritto uno dei primi trattati organici di poetica, discutendo, in particolare, intorno alla
funzione dell’arte. L’arte è rappresentazione non del reale ma del possibile, dunque di ciò che può accadere; e
il campo del possibile è quello della storia umana. Si tratta, perciò, di vedere quali sono i tipici atteggiamenti
dell’uomo. L’arte rappresenta accadimenti esemplari, riconducibili a questi caratteri universali. E lo scopo
principale dell’arte è l’educazione dell’uomo attraverso la catarsi: la rappresentazione di vicende negative,
come guerre e conflitti passionali, ha lo scopo di liberare gli animi dai germi di tali comportamenti,
esercitando su essi un’azione sublimante.
Il periodo giovanile. Il platonismo mistico.
“Dai frammenti delle opere giovanili risulta con sicurezza che due (Eudemo e Protreptico) appartengono a
una prima fase, di platonismo mistico, e un’altra (Sulla filosofia) a una seconda fase, di transizione verso la
formazione del sistema indipendente”.232
Nell’Eudemo e nel Protreptico domina il problema dell’anima, secondo la visione platonica: la vera natura
dell’uomo è fatta consistere nell’anima razionale, dunque nella vita dedita alla contemplazione della verità,
nella fuga da ogni impulso corporeo e nella aspirazione alla liberazione finale. Aristotele riprende il motivo
platonico della reminescenza: l’anima, cadendo nel mondo, dimentica le visioni che hanno costituito la sua
esperienza nella sede divina; perciò la vita nel mondo è imperfetta, una specie di “decadenza” (o “caduta”)
dalla condizione originaria, un allontanamento dall’essenza incorporea, dunque una specie di “malattia”.233
Riguardo alla costituzione dell’anima, Aristotele ne sostiene la semplicità: l’anima non può essere concepita
come “armonia” di parti, poiché, mentre l’armonia ha il suo contrario nella disarmonia, dell’anima non c’è
contrario, perché è sostanza. Ne consegue una svalutazione della vita terrena e dei beni materiali: le cose
nelle quali gli uomini ripongono generalmente la loro fiducia sono vane apparenze: forza, grandezza,
bellezza, potere sono illusioni e apparenze ingannevoli.234 La vita terrena è concepita come espiazione di una
colpa, dunque come pena. Perciò la cosa migliore per l’anima sarebbe non incarnarsi; e così la vita corporea è
vista, pessimisticamente, come male, in quanto ingresso di ciò che è per sua natura immortale nel regno del
divenire.235 Il compito dell’uomo è, dunque, quello di attuare quella forma di vita che maggiormente si
avvicina alla condizione originaria di beatitudine dell’anima. Di tale condizione rimane nell’uomo
l’intelletto, la ragione conoscitiva: l’intelletto fa sembrare l’uomo un dio in confronto di tutti i viventi; per
esso “la vita mortale ha una parte eterna di un dio”. Il filosofare è l’esercizio dell’intelletto: occorre
investigare e cercare la verità, come se ciò fosse l’unico scopo della nostra vita.236 E’ naturale per l’uomo
perseguire il conoscere fondato sull’attività della ragione; è la contemplazione della verità è il suo fine
supremo, quello che gli consente di conseguire felicità e perfezione.
La fase di transizione: critica delle idee e teologia astrale
La fase di transizione è rappresentata dal dialogo Sulla filosofia. In primo luogo Aristotele vi svolgeva la
sua critica delle idee e delle idee-numeri (numeri ideali). Tra l’altro osservava: “Se le idee sono un’altra
specie di numero, diversa da quella matematica, non potremmo averne nessuna comprensione. Chi infatti,
almeno dei più fra noi, può capire un numero diverso da quello matematico?” (fr. 11).
Tale critica era svolta nel II libro del dialogo. Nel III libro Aristotele sviluppava alcuni fondamentali
motivi di teologia razionale e di cosmologia. Dalla constatazione dell’ordine dell’universo egli risaliva a una
suprema Mente ordinatrice, che finiva con l’identificare poi con la stessa essenza divina del mondo.
L’esistenza di Dio è dimostrata sulla base della scala dei valori, che implica una perfezione somma. Si
232
R. Mondolfo, Il pensiero antico, p. 279.
“Ora la vita dell’anima libera dal corpo, essendo secondo sua natura, somiglia alla salute; quella entro i corpi,
essendo contro la sua natura, alla malattia” (Eudemo, fr. 5 Walzer, cit. Mondolfo, p. 280).
234
Protreptico, fr. 10, cit. ib.).
235
“Per gli uomini non è possibile quella che l’ottima di tutte le cose, cioè che partecipino alla natura del migliore:
perché la miglior cosa per tutti gli uomini e per tutte le donne sarebbe in non avere avuto nascimento (ingresso nel
divenire). Il bene preferibile poi dopo questo, e il primo fra quelli raggiungibili agli uomini, che è però il secondo
(nell’ordine totale), sta nel potere, una volta che son nati, morire al più presto” (Eudemo, fr. 6, cit. ib., p. 281).
236
“Se abbiamo anime immortali e divine, si deve credere che quanto più esse siano state sempre nel loro proprio
corso, cioè nella ragione e nel desiderio di investigare, e quanto meno si sian mescolate e implicate nei vizi ed errori
degli uomini, tanto più facile abbiano l’ascensione e il ritorno al cielo” (Protreptico, fr. 10, cit. ib.). “La ragione
conoscitiva è per noi il fine secondo natura, e il conoscere è l’ultimo fine per il quale siamo nati. Dunque se siamo nati,
è evidente che esistiamo per conoscere e imparare. Bene dunque, secondo questo ragionamento, disse Pitagora, che a
conoscere e contemplare ogni uomo è creato sotto il comando di Dio” (Ib.).
233
argomenta che l’essere primo e sommo deve coincidere con Dio, immutabile ed eterno, che non può avere un
ente superiore a sé, da cui sia mosso, perché questo sarebbe più perfetto e divino, e non può subire l’azione
di un ente inferiore, infine in muta in altro, in quanto per sé perfetto e tale da non tendere a nessuna
perfezione diversa dal suo essere stesso. Inoltre: poiché il cosmo è ordinato, ordinato dev’essere anche il suo
principio (che sia principio di qualsiasi ordine). Aristotele diceva che da due fonti deriva l’idea di Dio agli
uomini: dall’anima stessa, per le ispirazioni divine e i presagi che si hanno nei sogni (“Ché quando nel sogno
l’anima si trova in se stessa, allora, ripigliando la sua natura propria, può vaticinare e preannunciare il
futuro”, fr. 12) e dagli accadimenti astronomici (“ché contemplando di giorno il sole che compie il suo giro e
di notte il moto bene ordinato degli astri, si credé esservi un Dio, causa di siffatto movimento ed ordine”,
ib.). Aristotele concorda con l’opinione comune del suo tempo, che gli astri abbiano una natura divina e che
“si muovono spontaneamente per propria coscienza e divinità”. Infatti, “ciò che si muove per natura è
portato in giù dal peso ed in su dalla leggerezza”, ma né l’uno né l’altra tocca agli astri, il cui moto avviene
in un’orbita circolare, per cui si deve ammettere che esso sia volontario.237
La concezione aristotelica del sapere e il sistema delle scienze.
Le leggi del pensiero e della conoscenza: la logica
La conoscenza riguarda le cause e i principi delle cose e degli accadimenti.238 La scienza riguarda ciò che
è necessario, cioè ciò che non potrebbe essere (o accadere) diversamente da come è (o accade). Del contingente
e del particolare non si dà scienza. Il contingente è ciò che accade per caso e in modo irregolare (ad esempio, che
d’estate possa sopraggiungere il freddo); di esso c’è solo “descrizione” (“storia”); infatti possiamo accertare
ciò che è accaduto, senza potere stabilire nessuna legge o principio causale di tale accadere.239 La conoscenza
riguarda perciò l’universale. E le nozioni universali riguardano (ancora come per Platone) la costituzione
essenziale degli enti, le “forme” o “essenze”.240 Aristotele distingue, perciò, la scienza dalla semplice
esperienza: la scienza è conoscenza delle cause, l’esperienza riguarda la semplice constatazione dell’esistenza
delle cose; l’una riguarda il perché, l’altra è limitata solo al che. Nelle sensazioni non può esservi nessuna
scienza; esse, cioè, possono essere solo fonte di esperienza.241
La scienza perviene fino alla comprensione dei principi e delle cause. Essa va dal particolare
all’universale; in un primo tempo si procede per induzione e successivamente per deduzione. Infatti solo la
conoscenza degli universali consente di conoscere i particolari. Gli universali, infatti, sono immutabili; e la
scienza suprema riguarda ciò che esiste al disopra di tutti gli enti, come “eterno, immobile e separato”. .Tale
scienza è la teologia. Poi ci sono gli altri rami della filosofia prima. Infatti anche le cause sono eterne, come sono
eterni i principi. Vengono poi le scienze speculative che riguardano gli non separati dalla materia né
immobili: la fisica e la matematica. Così si hanno le tre scienze speculative: la matematica, la fisica e la
teologia.242
Come ha mostrato W. Jaeger, Aristotele ha elaborato due concetti diversi dell’oggetto della metafisica, in
corrispondenza alle due fasi fondamentali del suo pensiero. Nella prima fase, dominata ancora da
suggestioni platoniche, Aristoetele tende a considerare la metafisica come scienza del “soprasensibile” e
identifica questo con Dio stesso, principio di ogni realtà, causa prima e motore immobile. Nella seconda fase,
237
Nella sua astronomia posteriore, Aristotele attribuisce all’etere il moto circolare per natura, e fa muovere gli astri
incastonati nelle sfere celesti per l’azione delle intelligenze motrici, alle quali il movimento è comunicato dal Motore
immobile.
238
“Noi crediamo di sapere ciascuna cosa interamente […] quando crediamo di conoscere la causa per la quale la
cosa è, [e conosciamo] che è appunto la causa di essa e che non c’è possibilità che essa sia altrimenti” (Anal. post., I, 2,
71).
239
“E’ evidente dunque che del contingente non c’è scienza: poiché ogni scienza è di ciò che è sempre o è per lo più.
Altrimenti infatti come si potrebbe apprenderla e insegnarla” (Met., XI, 8, 1064).
240
“Anche delle sostanze sensibili particolari non è possibile né definizione né dimostrazione, perché hanno una
materia, la cui natura è cosiffatta, da potere essere e non essere: perciò tutte singolarmente sono corruttibili” (Met., VII,
15, 1040).
241
“Dalle sensazioni non crediamo che possa derivare alcuna sapienza; per quanto siano esse le conoscenze più
proprie del particolare, non dicono di alcuna cosa il perché, come ad esempio perché il fuoco sia caldo, ma solo che è
caldo” (Met., I, 1, 981).
242
“Se dunque esiste una sostanza immobile, questa è anteriore [alle altre] e v’è una filosofia prima, che è anche
universale in quanto è prima; a questa spetta di studiare l’essere in quanto essere, e l’essenza e gli attributi suoi in
quanto essere” (Met., VI, 1, 1026).
egli fa consistere l’oggetto della metafisica nell’essere in quanto essere, cioè nel principio e fondamento di ogni
ente determinato (considerando Dio stesso come ente, sia pure fornito di ogni perfezione). Dunque, da una
parte l’oggetto della metafisica è l’essere immobile trascendente, tale che per la sua perfezione è al di là di
ogni altro ente, ma tuttavia anch’esso determinato (sicché la metafisica risulta una scienza particolare,
specificandosi come “teologia”). Dall’altra parte, la metafisica riguarda l’essere in quanto essere, che, cioè,
non si identifica con nessun ente particolare e non contiene nessuna determinazione (sicché la metafisica si
configura come scienza veramente universale).
In Aristotele stesso si riscontra un tentativo di conciliare queste due accezioni del concetto relativo
all’oggetto della metafisica: egli, infatti, osserva che l’ente trascendente (Dio) è da considerarsi come il
fondamento di ogni altro ente (possedendo tutte le perfezioni e contenendo, perciò, tutte le realtà e
determinazioni possibili). Ma, in definitiva, il filosofo si sofferma sul secondo concetto, cioè sulla metafisica
come scienza universale dell’essere.243
Riguardo, poi, alla costruzione del discorso scientifico, Aristotele ha tracciato le regole specifiche nei suoi
libri di logica.
Ogni scienza (ogni discorso) rispetta alcune verità fondamentali ed evidenti (ad esempio, che è necessario
che ogni singola cosa o si affermi o si neghi, che è impossibile che ogni cosa sia e non sia nello stesso tempo,
e così via), cioè alcuni principi comuni. E, poiché si tratta di verità comuni a tutte le scienze, esse sono
oggetto d’indagine della filosofia.244
Il principio fondamentale, che deve essere tenuto presente da chiunque intenda indagare intorno a un
qualsiasi campo della realtà, è il principio di non-contraddizione, che si esprime in questo modo: “E’
impossibile che una stessa cosa convenga e non convenga insieme a una stessa cosa e sotto lo stesso
rapporto”.245 Si tratta di un principio evidente, che non ha bisogno di alcuna dimostrazione e che è anche “il
principio di tutti gli altri assiomi”. Sul principio di non-contraddizione poggia ogni pensiero, discorso e
ragionamento.
Aristotele precisa quindi le forme logiche del pensiero scientifico. Discorso scientifico è quello in cui si
enuncia il vero (o si rileva il falso), cioè è il discorso enunciativo (e non ogni discorso che sia generalmente
significativo). Ad esempio, la preghiera non è un discorso enunciativo, in quanto è un discorso che non è né
vero né falso. Una prima forma di discorso enunciativo è il giudizio affermativo; analogo è quello negativo.246 Il
giudizio è un discorso che afferma o nega alcunché di qualcosa (un predicato di un soggetto). Il giudizio è
universale o particolare, o indefinito.247
Le modalità generali secondo cui qualcosa si predica di qualcosa sono dette da Aristotele categorie. Le
categorie indicano le modalità generali dell’essere stesso, cioè i “generi sommi”, che non possono essere
ulteriormente compresi in concetti più generali (ad esempio, la “sostanza”,la “qualità”. Ogni termine nel
discorso esprime una modalità d’essere in rapporto a una categoria: cioè ogni termine esprime o la sostanza
o la qualità o la quantità o la relazione o il dove o il quando o la situazione o l’abito o l’attività o la passività.248 Le
categorie esprimono, dunque, le modalità di determinazione dell’ente reale; esse indicano ciò che un
discorso deve enunciare intorno a un qualche ente su cui s’intende raggiungere una conoscenza completa.
Esse sono condizioni, insieme, della determinabilità dell’ente e della sua pensabilità e conoscibilità (e
dell’espressione della conoscenza nel discorso).
243
Questo concetto è espresso con grande chiarezza specialmente nel IV libro della Metafisica. “V’è una scienza che
considera l’essere in quanto essere e le condizioni che gli sono intrinseche per se stesso. Essa non s’identifica con
alcuna di quelle che hanno un oggetto particolare; perché nessuna delle altre guarda in universale all’essere in quanto
essere, ma, ritagliandone una certa parte, di questa considerano gli accidenti, come, per esempio, fra le altre scienze, la
matematica (IV, 1, 1003). Cfr. anche VI, 1, 1025 e, sulla distinzione tra metafisica e scienze particolari, XI, 4, 1064.
244
E’ evidente che ad una sola scienza, cioè a quella del filosofo, appartiene anche l’indagine degli assiomi; poiché
si applicano a tutti gli esseri in quanto esseri, e non a un genere particolare separatamente dagli altri” (Met., VI, 3,
1005).
245
Met., IV, 3, 1005.
246
De int., 4-5.
247
Anal. pr., I, 24.
248
“Sostanza è per esempio uomo, cavallo; quantità: di due o tre cubiti; qualità: bianco, grammatico; relazione:
doppio, mezzo, maggiore; dove (luogo): nel circo, in piazza; quando (tempo): ieri, l’anno scorso; situazione: giace,
siede; abito: è calzato, è ornato; attività: taglia, brucia; passività: è tagliato, è bruciato (Categ., 4, 1.
Si dà, infatti, una perfetta corrispondenza tra pensiero, linguaggio (discorso) e realtà. L’ordine del
discorso riproduce, perciò, l’ordine della realtà; e l’analisi del linguaggio ci dà l’analisi del pensabile e del
conoscibile.249
Il procedimento seguito per formulare giudizi scientifici partendo dall’esperienza, cioè dalla
constatazione della realtà, è l’induzione. L’induzione è il passaggio dal particolare all’universale, cioè dalla
constatazione degli aspetti empirici delle cose alla conoscenza della natura degli enti e degli aspetti generali
della realtà: per esempio se si constata che il nocchiero abile è il migliore, e così l’auriga; così si trae in ogni
cosa che chi è abile è il migliore.
L’altro procedimento è la deduzione. La deduzione avviene generalmente attraverso quella forma tipica di
ragionamento che è il sillogismo. Questo è un discorso in cui, poste alcune premesse, ne derivano alcune
conseguenze. Aristotele distingue tre principali “figure” di sillogismo: nella prima, il termine medio
(“uomo” nelle premesse “Tutti gli uomini sono mortali”, “Socrate è uomo”) funge da soggetto nella
premessa maggiore e da predicato nella minore; nella II il termine medio (“volatile” nelle premesse “Alcuni
animali sono volatili”, “Gli uccelli sono volatili”; conclusione “Alcuni animali sono uccelli”) funge da
predicato in entrambe le premesse; nella III figura il termine medio (“filosofo” nelle premesse “I filosofi sono
pensatori”, “I filosofi sono saggi”; conclusione: “I pensatori sono saggi”) funge da soggetto in entrambe le
premesse. Si hanno conclusioni affermative o negative, particolari o universali, a seconda che le premesse
siano, a loro volta, universali affermative o universali negative, particolari affermative o particolari negative.
La definizione indica quel che una cosa è, esprime, cioè, l’essenza o la forma di un ente: essa comprende
l’indicazione del genere (prossimo) e delle differenze specifiche: ad esempio, “L’uomo è animale
ragionevole” (Top., 1, 8, 103).
La dimostrazione dichiara perché una data cosa appartiene (o non appartiene) a un’altra (Anal. post., II, 3,
90).
I generi sono ordinati in una scala che va da quello più universale (il concetto di “essere”) a quelli più
particolari.
La metafisica
La metafisica riguarda i principi costitutivi della realtà. La realtà nella sua compiuta espressione è attuata
negli enti determinati e concreti. L’ente reale è, per Aristotele, “sostanza” in senso eminente.250
Aristotele chiama, invece, sostanze seconde “le specie in cui sussistono le sostanze prime” (es. l’uomo,
l’animale, ecc.).251
La parola “sostanza”, perciò, comprende almeno quattro significati: essa indica l’essenza di ciascuna
specie (l’umanità, l’essere uomo, come essenza dell’uomo in generale), la specie (l’uomo in generale), il genere
(l’animale come “genere”, di cui l’uomo è specificazione), l’ente individuo (Socrate).
Gli individui, pure essendo la realtà prima (gli enti veramente reali), a causa della loro contingenza e
mutevolezza, non possono essere oggetto di scienza, ma rimangono entro i confini dell’esperienza e
dell’opinione (della descrizione empirica o “istoria”) 252.
La realtà, comunque, consta di enti individui.253 Gli elementi costitutivi dell’ente individuo(che è sostanza
in senso eminente) sono la materia e la forma: l’ente, cioè, è sintesi (unità. “sinolo”) di materia e forma. Per materia
Aristotele intende “ciò che non è qualcosa di determinato in atto, ma solo in potenza”.254 Così, rispetto alla
“casa” la materia è costituita da “pietre, mattoni e legname” (insieme di materiali che contengono in sé la
casa in modo potenziale). La forma è la specie secondo la quale un ente viene a costituirsi. Ma veramente
reale è la sintesi di materia e forma, cioè l’ente realmente esistente sulla base di uno specifico “essere”. E’
249
“Se le parole non avessero un significato, sarebbe tolta la possibilità di discorrere con altri, anzi, a dire il vero,
anche con se stesso: perché non può pensare affatto chi non pensi una cosa determinata” (Met., IV, 4, 1006).
250
“La sostanza, detta nel senso più proprio, in primo luogo e per eccellenza, è quella che non si predica di alcun
soggetto né si trova in alcun soggetto; per esempio, un dato uomo, un dato cavallo […]” (Categ., V, 2-3). “Ogni
sostanza sembra designare un dato essere reale. Per le sostanze prime è fuori di discussione è vero che designano un
dato essere reale, perché ciò che designano è sempre un essere individuale e un essere di numero” (Ib.). “Delle sostanze
prime nessuna è più sostanza dell’altra; così un dato uomo non è più sostanza che un dato bue [..]” (Ib.)..
251
“Delle sostanze seconde, poi, è più sostanza la specie che il genere, perché è più vicina alla sostanza prima” (Ib.).
252
Cfr. Met., VII, 15, 1040.
253
Fisica, I, 3, 186.
254
Met., VIII, 1, 1042.
chiaro che ciò che si dice “materia” in un altro senso è già “forma” e sostanza in atto: così il bronzo è materia
rispetto alla statua, ma è “forma” rispetto a se stesso.255 L’ente, in ciò che esso è, è definito, dunque, non tanto
in rapporto alla materia, quanto, invece, in rapporto alla forma: ad esempio, la casa è un ricovero di persone
e di beni ed è indifferente la materia di cui è costituita. L’ente determinato, infine, è descritto nella sua
costituzione particolare con riferimento anche alla materia.256
L’ente, in quanto in sé può comprendere qualità diverse, è soggetto al mutamento: così un uomo che
prima è ignorante e poi diventa sapiente, una foglia che prima è verde e poi diventa gialla.257 Ma nonostante
il cambiamento, l’ente conserva la sua identità, rimanendo se stesso: esso costituisce, appunto, la “sostanza”,
ciò che permane nel passaggio da uno stato all’altro.258
Aristotele chiama materia ciò che è assenza di determinazione d’essere, che non ha forma alcuna e che
può assumere una qualsiasi forma.259 La materia, essendo priva di forma, non è conoscibile (non essendovi
elementi di determinazione.260 La materia può essere intesa nel senso di “materia prima” e in quello di
“materia seconda”, cioè come l’”elemento primitivo” da cui derivano tutte le cose (“una stessa materia che è
principio a tutte le cose generate”) o come quella propria di ciascuna cosa. E’ evidente, inoltre, che “di una
stessa cosa ci possono essere più materie, quando l’una sia materia dell’altra”.261 Aristotele parla anche di
una “materia intelligibile”, come, ad esempio, le proprietà matematiche che pure ineriscono ai corpi sensibili
(in quanto relative alla quantità).262 La materia si configura anche come “potenza”: il bronzo è la statua allo
stato primordiale. Si può dire che “tutto nasce dall’essere,beninteso dall’essere in potenza, anzi dal non
essere in atto”.263 Dal punto di vista della materia, si deve dire che tutto è possibile e che nulla è
impossibile.264 Ed è evidente che la potenza riguarda il fare altrettanto che il patire.265 Nella costituzione
dell’ente concorrono, dunque, tre principi: la coppia dei contrari (forma e privazione di essa) e la materia
(che è il “sostrato”).266 Aristotele ammette, perciò, “i contrari come principi”: ad esempio, “il bianco viene dal
non bianco, il musico dal non musico, l’armonia dalla privazione di armonia e il disarmonico dall’armonico,
e l’armonico si perde nel disarmonico, non in qualsivoglia, ma nell’opposto”.267 Rispetto alla forma come
principio dell’ente, il contrario è la privazione (che è altrettanto principio, in quanto ogni forma è
strettamente legata al proprio contrario). Ogni materia è disposta ad accogliere una determinata forma (e
non l’opposto di questa); la materia, infatti, è “non essere in quanto relativo”; essa, cioè, aspira a diventare
qualcosa (che essa è in potenza). Infatti, “non può darsi che la forma aspiri a se stessa, perché non è priva di
se stessa; né [può aspirarvi] il suo contrario, perché i contrari si distruggono a vicenda”.268 In ogni processo
di divenire (e di generazione) c’è sempre qualcosa che lo sostiene (ad esempio, il bronzo che diviene statua).
E ciò che diviene nasce o per modificazione (come la stata dal bronzo) o per addizione (come ciò che nasce) o
per riduzione (come dalla pietra un Ermes) o per composizione (come una casa) o per trasformazione (come
le cose che mutano nella materia).269
Ogni ente implica, inoltre, la presenza di una causa che determini la modificazione (il passaggio della
materia dalla potenza all’atto). 270 “Atto” (ente in atto) è ciò che risulta dall’unione della materia con la
forma. “L’atto è l’esistenza della realtà.271 Se una materia contiene in potenza ciò che poi essa stessa può
diventare (in atto), vuol dire che l’atto idealmente preesiste alla materia stessa (la statua preesiste come
255
Met., VII, 3, 1028.
Met., VIII, 2, 1043.
257
Cat., 5, 4.
258
Met., XII, 2, 1069.
259
“Chiamo materia quella che in se stessa non si può dire né un qualcosa né una qualità né alcun’altra tra le
determinazioni dell’essere” (Met., VII, 3, 1029.
260
“La materia per se stessa è in conoscibile” (Met., VII, 10, 1036).
261
Met., VII, 3, 1044.
262
Met., VII, 10, 1036.
263
Met., XII, 2, 1069.
264
Met., IX, 4, 1047.
265
“La potenza è sotto un certo rispetto nel paziente […], sotto un altro rispetto nell’agente” (Met., IX, 1, 1046).
266
Met., XII, 2, 1069.
267
Fisica, I, 5, 188.
268
Fisica, I, 9, 192.
269
Fisica, I, 7, 190.
270
“A ricercare dunque quali siano i principi e gli elementi delle sostanze, delle relazioni e delle qualità, è evidente
che sono gli stessi per tutte le cose: materia, forma, privazione e causa motrice” (Met., XII, 5, 1071). “Tutto ciò che
diviene, diviene per opera di qualcosa, viene da qualcosa, diventa qualcosa” (Met., VII, 7, 1032).
271
Met., IX, 6, 1048.
256
possibilità al bronzo). Perciò Aristotele dice che “l’atto è anteriore alla potenza”: è anteriore, in primo luogo,
“quanto al concetto”, “perché ciò che ha originariamente la potenza è fornito di potenza in quanto è capace
di passare all’atto: per esempio costruttore dico chi ha la potenza di costruire, veggente chi può vedere,
visibile chi può essere visto”;272 è anteriore per il tempo, poiché l’ente in atto preesiste nella sua specie e,
inoltre, ogni ente in atto presuppone l’esistenza di altri enti della stessa specie in un tempo anteriore, “poiché
sempre l’essere in atto deriva da quello in potenza per opera di un altro essere in atto: ad esempio, l’uomo
per opera dell’uomo, il musico del musico, sempre insomma per opera di un motore precedente; e questo
motore è già in atto”; infine è anteriore per la sostanza, “in primo luogo perché ciò che è posteriore nella
generazione è anteriore nella specie e nella sostanza” e poi perché ogni cosa procede verso un fine, e il fine è
l’atto (in virtù del quale si pone la potenza).
Aristotele polemizza contro la dottrina platonica della separazione e trascendenza delle forme (idee). Le forme non
hanno altra funzione che quella di essere componenti (assieme alla materia) degli enti concreti (gli unici
realmente esistenti). Ecco le argomentazioni che egli sviluppa: 1) le idee platoniche non possono essere cause
degli enti reali, né spiegare il divenire e la realtà degli enti stessi;273 2) le idee sono un duplicato inutile degli
enti reali;274 3) le idee non giovano né alla conoscenza delle cose né al loro essere; 4) non ha senso parlare
delle idee come di modelli, cui le cose partecipano; 5) le idee, in quanto sostanza delle cose, non potrebbero
essere separate da queste; 6) le idee non contribuiscono a risolvere il problema delle cause delle cose: dunque
con la teoria delle idee non è possibile spiegare i fenomeni e la realtà naturale.275 Infatti la scienza riguarda le
cause; ed è necessario perciò conoscere in primo luogo le cause prime (“poiché allora diciamo di sapere
ciascuna cosa, quando crediamo di conoscere la causa prima”).276
Aristotele distingue quattro cause prime: formale (la forma o essenza), materiale (il sostrato), efficiente (ciò
che provoca il passaggio della materia dalla potenza all’atto), finale (il “bene” stesso cui ogni cosa è
rivolta).277
Il motore immobile e la teologia aristotelica
Nella serie delle cause non si può procedere all’infinito: occorre che ci sia una causa assolutamente prima
(una prima causa efficiente e finale, così come anche formale e materiale). Tale causa assolutamente prima si
deve configurare, in primo luogo, come il primo motore (poiché l’universo si presenta caratterizzato dal
movimento e dal divenire). Bisogna, dunque, risalire a una causa prima del movimento.278 Il motore
immobile deve essere atto puro. Infatti altrimenti potrebbe essere mosso da un altro motore e diventare
qualcosa d’altro. Così, essendo atto puro, esso è unico (in esso materia e forma coincidono, anzi si deve dire
che in esso non c’è materia, essendo puro atto). Tale ente è anche causa finale assoluta, verso cui tendono
tutti i processi relativi alla produzione degli enti. Il motore immobile non ha grandezza, dunque non ha
estensione: infatti, altrimenti, dovrebbe avere una estensione finita o infinita; ma non può esistere grandezza
infinita e dal finito non può essere mosso alcunché per un tempo infinito. Esso, inoltre, è intelligenza pura,
che ha per oggetto se stessa: intelletto che pensa se stesso, mutandosi in intelligibile, in modo che si
identificano l’intelletto e l’intelligibile. Tale è Dio.279 Aristotele mette in rilievo, così, l’infinità della potenza
divina, che “muove per un tempo infinito” l’universo. In realtà qui il concetto di “infinito” assume una
connotazione positiva: infinito è tutto ciò che oltrepassa ogni finito; e viene così riconosciuta una realtà
272
Met., IX, 8, 1049-50.
Met., VII, 8, 1033.
274
Met., I, 9, 990.
275
Met., I, 9, 991-92.
276
Met., I, 3, 985.
277
“Delle quattro cause, due, la formale e la finale, sono dichiarate identificabili e riducibili a una. Ma sotto un certo
rispetto anche la causa efficiente appare nella generazione identificata con la formale, giacché causa della generazione
del figlio è il padre come forma in atto. Quindi le cause fondamentali sono queste due: materia e forma, la cui unità
(sinolo) costituisce la sostanza reale o individuo” (R. Mondolfo, Il pensiero antico, cit., p. 304).
278
Fisica, VII, 2, 242. “Posto, dunque, che ogni mobile è mosso da un motore e che questo è immobile o mosso, e
mosso sempre o da sé o da un altro, si arriva a stabilire che c’è un principio dei movimenti, e che per i mobili è ciò che
si muove da sé, e per la totalità dell’universo è l’immobile” (Fisica, VIII, 8, 259). “E poiché il moto dev’essere eterno e
mai cessare, è necessario che vi sia un primo motore […] e che il primo motore sia immobile”.(Fiisca, VIII, 7, 258).
279
“Pensa dunque se stesso, uns volta che esso è l’ottimo; e il suo pensiero è pensiero del pensiero […]. E così sta
esso, atto di pensiero che pensa se stesso, per tutta l’eternità” (Met., XII, 9, 1074-75).
273
infinita in atto (che è forma operante infinita) come condizione dell’infinità in potenza (durata infinita
dell’azione). Così l’infinità riconosciuta a Dio è concepita come perfezione e non come difetto.280
La fisica
La fisica riguarda l’universo naturale, il cui carattere principale è il movimento. “Considerare se l’essere
sia uno e immobile non appartiene alla fisica”.281 Questa considera gli enti materiali, che sono in movimento
o in quiete.282
Aristotele chiama “natura” “la materia prima sottostante a ciascuno degli esseri, che in sé hanno il
principio del moto e del mangiamento”283, cioè proprio l’essenza che caratterizza tutti gli enti in quanto
rientranti nel dominio del movimento e del divenire. La natura, dunque, è lo stesso principio del divenire,
del movimento e della trasformazione degli enti. Essa è piuttosto “forma” che “materia”: si può dire la forma
propria di ogni ente che diviene e che si muove (il cui “essere”, cioè, è intrinsecamente legato al movimento
e al divenire). Perciò Aristotele dice che “la natura è principio del movimento e del mangiamento”.284
L’intera natura, in quanto processo di produzione di enti e di movimento, ha un’intrinseca finalità: tutto ciò
che in essa avviene è in rapporto al fine. Il fine è “causa della materia, e non la materia è causa del fine”.285
Dato il fine, l‘intero processo naturale cade nell’ambito della necessità. Aristotele sottolinea la finalità
dell’accadere naturale. Tutto ciò che accade in natura acca in rapporto a un motivo, cioè in vista di un fine.
Così il vapore acqueo si eleva dalla terra per poi ricadervi in forma di pioggia: che poi la pioggia faccia
andare in rovina il grano ammucchiato nell’aia, questo è un fatto accidentale (che non accade per necessità e
dunque non rientra nella finalità del processo naturale). La necessità appare, pertanto, collegata al fine; E si
deve dire che i processi naturali sono regolati dal fine e non dalla pura necessità. Non si può così dire che
l’effetto è una semplice conseguenza della necessità naturale, ad esempio che i denti davanti spuntino aguzzi
e atti a strappare e i molari larghi e adatti a ridurre in poltiglia, soltanto per necessità, in modo che l’effetto
(lo strappare, il ridurre in poltiglia) sia soltanto un effetto contingente.286 Nella natura, così, le condizioni per
la produzione di un fenomeno (di un certo effetto) sono altrettanto necessarie: e dati certi fini da
raggiungere, si pongono determinate condizioni (che, rispetto al fine, che è “forma”, possono dirsi
“materia”): ad esempio, nella casa le pietre e i mattoni sono condizioni e “materia” (condizioni
indispensabili): e per la conservazione della salute, nell’uomo, si pongono determinate condizioni, che sono
altrettanto necessarie.287
SE le condizioni di produzione delle cose e dei fenomeni sono necessarie, non è altrettanto necessario che
si producano determinati fenomeni e cose in determinati tempi e luoghi. Bisogna, cioè, ammettere anche la
realtà della contingenza. Peraltro la contingenza cade nel campo dell’indeterminato: pertanto essa non è
conoscibile per l’uomo.288 La scienza riguarda l’ordine necessario, cioè come da certe condizioni derivano
certe conseguenze (certi effetti da certe cause). Ciò vuol dire scoprire la “ragione” stessa per cui qualcosa
280
Cfr. R. Mondolfo, Il pensiero antico, cit., p. 300.
Fisica, I, 2, 184.
282
“Gli esseri naturali appaiono tutti quanti avere in se stessi un principio di movimento e di quiete, sia riguardo al
luogo, sia riguardo all’accrescimento e alla diminuzione, sia riguardo alla mutazione: in quanto la natura è un principio
e una causa di moto e di quiete, in ciò in cui essa inerisce primieramente, per sé e non accidentalmente” (Fisica, II, 1,
192).
283
Fisica, II, 1, 193.
284
Fisica, III, 1, 201.
285
Fisica, II, 9, 200.
286
“Sicché per natura e per un fine la rondine fa il nido e il ragno la tela, e le piante producono le foglie per
(proteggere) i frutti, e le radici non all’insù ma in giù per la nutrizione: è evidente che siffatta causa è presente in tutte le
cose che si producono e sono per natura” (Fisica, II, 8, 199).
287
Fisica, II, 8, 199.
288
Aristotele precisa la differenza tra contingenza e caso: “La differenza è che il caso è più esteso; giacché ogni
contingenza è casuale, ma questo non sempre è contingente[…]. Soprattutto esso è distinto dal contingente nei fatti
naturali; perché quando un fenomeno avviene contro natura, allora non diciamo che è contingente, ma piuttosto che
avviene a caso. E’ differente anche per questo: perché la causa dell’uno è esterna, dell’altro interna” (Fisica, II, 6, 197).
Il contingente, cioè, rientra interamente nella normalità naturale, invece il caso e il fortuito rappresentano una
deviazione dall’ordine regolare (come quando, date certe condizioni, ne deriva un effetto diverso da quello che
normalmente si ha).
281
accade; scoprire i nessi necessari tra diversi termini, come, cioè,”da questo viene di necessità quest’altro”, e
“se questa cosa sta per accadere, mostrare come dalle premesse discenda la conclusione”, “e perché questa
sia l’essenza, e perché è meglio così, non in modo assoluto, ma relativo alla sostanza di ogni cosa”.289 In ciò
consiste la conoscenza fisica.
Dopo l’enunciazione di questi principi generali, Aristotele passa ad esaminare la struttura dell’universo
fisico. Tale struttura deve essere conforme all’intera “forma” della processualità naturale.
In primo luogo troviamo il problema dell’infinito: cioè, si deve ammettere l’infinità della realtà naturale,
oppure si deve ammettere che tale realtà è circoscritta, limitata?
Coloro che ammettono l’infinito riportano cinque argomenti fondamentali: 1) il tempo è infinito; 2) le
grandezze sono divisibili all’infinito; 3) infinito è il processo del divenire, per cui si hanno sempre la nascita e
la morte, la formazione e la dissoluzione degli enti; 4) poiché ogni cosa è limitata da qualos’altro, si deve
ammettere l’infinito nello stesso processo della limitazione (“è necessario che non vi sia nessun termine, se
ogni termine sempre deve terminarsi ad altro”);290 5) infine (e questo sembra l’argomento principale), “non
essendovi limite al pensiero, anche il numero sembra essere infinito e le grandezze matematiche e lo spazio
fuori dell’universo”. Ma Aristotele mette in rilievo le varie aporie connesse alla teoria dell’infinito. 1) In
primo luogo, l’impossibilità dell’infinito deriverebbe dalla stessa definizione di ciò che è corporeo (e si deve
ammettere l’universo come corporeo): si definisce “corpo” “ciò che è limitato da superficie”; dunque non
può darsi corpo che non sia limitato, cioè corpo infinito, “né intelligibile né sensibile”. 2) “L’infinito non può
essere né composto né semplice”:291 il corpo infinito non sarà composto, poiché gli elementi sono finiti di
numero (se il corpo infinito fosse composto, dovrebbe essere composto da elementi di numero infinito; né è
possibile che vi siano più infiniti, in quanto “il corpo infinito dovrebbe estendersi in ogni direzione
all’infinito”. Il corpo infinito non può essere neppure unico e semplice: infatti semplici sono solo gli elementi,
e questi non sono infiniti. Non è possibile ammettere un corpo infinito e, nello stesso tempo, un “luogo
naturale” per i corpi. Dunque “non può darsi corpo infinito in atto”.
D’altra parte, Aristotele ammette che l’infinito in un certo senso deve esistere: se non esistesse l’infinito, ci
sarebbe un inizio e una fine nel tempo, le grandezze non sarebbero divisibili (ci sarebbe un limite nella
divisibilità delle grandezze), e anche il numero avrebbe un qualche limite (invece non c’è limite nella
progressione numerica). Si deve dire che l’infinito esiste in un certo senso e in un altro senso no. Così, “non è
infinita in atto la grandezza, ma è tale quanto alla divisibilità” e “resta, dunque, che l’infinito esiste in
potenza”.292 Nell’addizione, l’infinito esiste in potenza, e così nella divisione (in modo che ci sarà sempre un
più piccolo, anche se in realtà esistono grandezze determinate e l’universo stesso nella sua interezza è
limitato). Nell’infinito, quindi, si danno due concetti opposti: uno negativo e uno positivo. Da una parte si
rileva l’imperfezione dell’infinito: “l’infinito non è quello fuori del quale non c’è nulla; ma quello fuori del
quale c’è sempre qualcosa”; infatti “quel che non ha nulla fuori di sé, questo è perfetto e intiero”.293 L’infinito
è “la materia della perfezione della grandezza, è l’intero in potenza, non in atto”. Perciò l’infinito è una
componente dell’intero, non è l’intero in atto; esso “rientra piuttosto nel concetto della parte che del tutto:
perché la materia è parte del tutto, come il bronzo della statua”.294
Per quanto riguarda il numero, Aristotele ammette che “è razionale che vi sia un limite nel senso del
minimo”, ma che “nel senso del più sempre si possa oltrepassare ogni moltitudine”.295 In questo senso
l’infinito è in potenza e non in atto. In realtà, in questo senso, l’infinito è solo pensato.
Invece nel tempo e nel movimento (e anche nel pensiero) l’infinito deve intendersi come reale.296 Nel
mangiamento non si dà infinito; infatti ogni mutamento è passaggio dall’uno all’altro opposto(es. nascita e
distruzione). Il mutamento avviene in virtù del limite che è dato dall’affermazione o dalla negazione (o dalla
presenza di uno dei contrari). Nel movimento si può ammettere l’infinito solo nel senso della circolarità. Una
distanza infinita non può essere percorsa (non è percorribile, per definizione); è percorribile solo una
distanza finita, tale che può essere coperta da un mobile in un determinato tempo.297
289
Fisica, II, 7, 198.
Fisica, III, 5, 205.
291
Fisica, III, 7, 205.
292
Fisica, III, 8, 206.
293
Fisica, III, 9, 207.
294
Fisica, III, 10, 207.
295
Fisica, III, 11, 207.
296
Cfr. Fisica, III, 13, 298.
297
“Cosicché dato che vi sia un movimento unico, non può essere infinito nel tempo fuori che in una forma, che è la
traslazione circolare” (Fisica, VI, 16, 241).
290
L’infinito si configura come divisibilità infinita nel continuo. Un “continuo” non può essere costituito da
elementi indivisibili. Così se il punto si considera come indivisibile, non si può neppure dire che la linea
consta di punti, ammesso che la linea sia continua. Nel continuo non possono esserci elementi distinti,
poiché tra tali elementi non dovrebbe esserci frapposto nulla, nessun altro elemento intermedio. Il continuo,
perciò, è divisibile all’infinito. Ciò vale per la grandezza, per il tempo e per il movimento.298
Nei rapporti di grandezza, movimento e tempo si dà incompatibilità di finito e infinito. Ogni movimento
finito si compie in un tempo finito e in uno spazio finito; è impossibile che un movimento infinito si compia
in un tempo e in uno spazio finiti.299
L’infinito si deve attribuire, in senso positivo, a Dio.300
Aristotele dedica un’ampia trattazione ai concetti di spazio e di tempo. Lo spazio è il “luogo”
dell’esistenza degli enti e della realizzazione dei processi di mutamento. E’ impossibile che un ente sia in nessun
luogo. E il movimento, nella sua forma più semplice, croniste nel fatto che un ente ora occupa un luogo e ora
un altro, “trasferendosi” da una parte all’altra dello spazio. Lo stesso luogo può essere occupato
successivamente da corpi diversi: esso non si identifica coi corpi, ma permane come qualcosa di identico a se
steso, nonostante il mutare dei corpi che lo occupano via via.301 Lo spazio non è corpo: esso, tuttavia,,, ha le tre
dimensioni della lunghezza, larghezza e profondità (anzi coincide con tali dimensioni).302 Lo spazio non può
essere né materia né forma: esso, infatti, non è un componente dell’ente; e, mentre materia e forma non possono
separarsi dall’ente, lo spazio, invece, può farlo.303 Lo spazio rende possibile lo spostamento di un corpo
mobile: esso è come un contenente immobile (al contrario, ad esempio, di un vaso, che è un contenete
mobile), capace di limitarsi in rapporto al contenuto (all’ente). Anzi, lo spazio è lo stesso limite immobile del
contenente.304 Lo spazio, perciò, è il contenente in senso assoluto e primario: in rapporto alla totalità spaziale,
si deve ammettere che lo spazio coincida (per grandezza) con lo stesso universo contenuto.
Ogni spazio ha un “alto” e un “basso”; e ogni corpo si dispone in esso secondo la propria natura (cioè in
modo che appartiene alla natura del corpo se esso si dispone in alto o in basso).305 L’”alto” e il “basso” sono
determinati dalla natura degli elementi materiali, precisamente dal fuoco e dalla terra.306 Lo spazio coincide,
per la sua estensione, con l’universo stesso. Fuori dell’universo non c’è spazio.307 L’universo si muove
circolarmente nello spazio, ma come totalità non cambia di luogo, in quanto occupa sempre tutto intero lo
spazio (l’unico spazio nella sua totalità). 308
298
“Di necessità sono le stesse le divisioni del tempo e del moto e dello spazio in cui il moto si compie” (Fisica, VI,
5, 235). “Né infatti il tempo consta di istanti, né la linea di punti, né il moto di unità indivisibili di movimento” (VI, 15,
240).
299
Tra finito e infinito non c’è compatibilità: ad esempio, “poiché il finito non può percorrere l’infinito in tempo
finito, è evidente che neppure l’infinito può percorrere il finito; ché se quello percorre questo, di necessità questo
percorre quello”. Così, “neppure l’infinito può percorrere l’infinito in un tempo finito” (Fisica, VI, 11, 238). Un
movimento infinito può avvenire solo in un tempo e in uno spazio infiniti; e così un movimento finito si compie in un
tempo e in uno spazio finiti.
300
“Dio muove un tempo infinito; e nulla, che sia limitato, può avere una potenza infinita” (Metafisica, 1075 a).
Infinita è ogni potenza, come ogni numero e ogni grandezza, che sorpassi qualsiasi finito” (Fisica, 267). In Aristotele
troviamo, pertanto, la base del concetto dell’infinità divina, come della realtà che tutto ha in sé e sorpassa ogni altra in
ogni senso.
301
Fisica, IV, 2, 208.
302
Se si ammettesse che lo spazio sia corporeo, si dovrebbe supporre uno “spazio nello spazio”, secondo quanto già
rilevato da Zenone (Fisica, IV, 3, 209).
303
Fisica, IV, 4, 209.
304
Fisica, IV, 6, 211.
305
Fisica, IV, 6, 211.
306
“L’alto non è infatti un luogo qualsiasi, ma dove tende il fuoco e il leggero; e così il basso non è quale che sia, ma
dove tendono i corpi pesanti e composti di terra: in quanto questi non differiscono solo per posizione, ma anche per
potenza” (Fisica, IV, 2, 208). Dal punto di vista della posizione “astronomica”, il basso per eccellenza è dato dal centro
dell’universo (il centro della Terra) e l’alto è rappresentato, invece, dall’estremo confine della rivoluzione circolare”
(IV, 7, 212).
307
“Lo spazio coesiste con la realtà: poiché il limite coesiste col limitato” (Fisica, IV, 7, 212).
308
Si può dire chel’universo “in quanto tutto, non è in alcuno spazio, non essendovi corpo che lo contenga”; ma che
“in quanto si muove, c’è uno spazio per le sue parti”. Nulla c’è fuori dell’universo. Lo spazio è il limite immobile
dell’universo stesso. Il cielo è la sfera estrema dell’universo; esso comprende l’etere, e questo comprende l’aria, questa
l’acqua e questa, infine, la terra. Il cielo non è contenuto da nessun altro corpo o elemento.
Aristotele nega l’esistenza del vuoto. Il vuoto, infatti, dovrebbe essere la negazione dello spazio o, meglio,
“uno spazio che non contenga nulla”.309 Ma “non sarebbe possibile il movimento se vi fosse il vuoto”: infatti
il vuoto dovrebbe essere una specie di spazio separato dai corpi, tale da essere incompatibile con la presenza
dei corpi stessi.310 Invece lo spazio è tale in quanto sempre contiene qualche corpo; e il movimento è possibile
proprio perché lo spazio ora può contenere un corpo e ora un altro; ma non sarebbe possibile se lo spazio
non contenesse nessun corpo. Nello spazio i corpi subentrano gli uni agli altri, “senza che vi sia intervallo di
sorta separato dai corpi in moto”.311
Aristotele si chiede: “che cos’è il tempo e quale ne è la misura?”.312 E’ evidente, in primo luogo, la connessione
del tempo col movimento e col mutamento. Ma il cambiamento è proprio della cosa che muta, dunque è
sempre qualificato in rapporto a ciò che avviene nella cosa; e analogamente il movimento è proprio dell’ente
che si muove. Invece il tempo è qualcosa che in sé ha caratteri propri, indipendenti dalle cose. Inoltre il
movimento (e il mutamento) è più veloce o più lento; il tempo, invece, è sempre uguale e identico a se stesso.
Perciò il tempo non può semplicemente identificarsi col movimento.313
D’altra parte, il tempo è strettamente legato al movimento e al mutamento. Infatti, “quando noi non
proviamo mangiamento nel pensiero o non ce ne accorgiamo, non ci sembra che ci sia stato scorrimento di
tempo”.314 Aristotele, così, coglie anche la connessione tra il tempo e la nostra esperienza del mutamento.
Non c’è tempo, dunque, senza movimento. E come il movimento è continuo, così lo è il tempo. Il
movimento implica un “prima” e un “dopo”, un “anteriore” e un “posteriore”; e il tempo è precisamente “il
numero del movimento in rapporto al prima e al dopo”.315 Noi diciamo che c’è il tempo, allorché avvertiamo la
relazione tra il prima e il dopo; e tale relazione è espressa da un numero, cioè da un intervallo misurabile. Il
tempo, pertanto, è il “movimento in quanto ha numero”.316 Il tempo e il movimento si misurano
reciprocamente, cioè insieme costituiscono l’uno misura dell’altro.317
Il modello unitario di misura del tempo è dato dal movimento degli astri, cioè dalla rotazione celeste. Infatti, “ogni
cosa si misura con un’unità ad essa congenere”; e così il tempo va misurato mediante un tempo determinato,
che sia “prima” rispetto ad ogni altro (originario e fondamentale). Il moto circolare è il moto di traslazione
fondamentale: così, dunque, “nella sua uniformità, è la misura per eccellenza, poiché il numero di esso è il
più facile a conoscere”.318
L’ente limitato si estende nel tempo; ed “essere nel tempo è come essere nel numero”; in modo che c’è
sempre un numero maggiore rispetto a qualsiasi altro che sia nel tempo. Tutti gli enti che sono nel tempo si
estendono per un tempo determinato. Invece “gli esseri eterni, in quanto eterni, non sono nel tempo; ché non
sono contenuti nel tempo, né la loro esistenza è misurata dal tempo”.319
Il tempo, in quanto è misura del moto, è anche misura della quiete. Nel tempo ogni movimento cessa.
“Dunque quante cose sono mortali e generate, e in genere ora esistenti e ora no, di necessità sono nel
tempo”.
309
Fisica, IV, 9, 214.
Fisica, IV, 11, 216.
311
Fisica, IV, 10, 214.
312
Fisica, IV, 16, 218. Si può immaginare il tempo come una dimensione infinita e insieme delimitata in forma di
circolo continuamente ritornate su se stesso o di sfera ruotante su se stessa. Tale dimensione è l’eternità: una
dimensione che va verso l’infinitamente grande e verso l’infinitamente piccolo (non c’è limite nel senso dell’inizio e
della fine). Perciò l’eternità coincide con l’istante. Infatti noi ci chiediamo: dove va il tempo che è passato e da dove
viene il tempo futuro? Non si può ammettere che il tempo derivi da qualcos’altro che non da stesso; bisogna, cioè,
ammettere che sempre proviene da se stesso e si dissolve in se stesso. In questo senso il tempo è continuo ritorno di sé a
sé, eterno rigenerarsi. E se si domanda se sia qualcosa di diverso dalla realtà, si deve rispondere che è identico alla
realtà, che è la realtà medesima. Così non ci può essere nulla senza il tempo, mentre ogni cosa che esiste è costituita da
tempo e ha la temporalità come sua dimensione fondamentale e costitutiva. Ogni cosa ha la forma del tempo. Dal tempo
deriva, quindi, la limitazione che caratterizza ogni cosa.
313
Fisica, IV, 15, 218.
314
Fisica, IV, 16, 218.
315
Fisica, IV, 17, 219.
316
Fisica, IV. 17, 219.
317
“Ma non solo noi misuriamo il movimento col tempo, ma anche il tempo col movimento, poiché si determinano
reciprocamente” (Fisica, IV, 18, 220).
318
Fisica, IV, 20, 223. L’evento fondamentale relativo al movimento è il moto della sfera celeste. Perciò tale moto è
il modello di ogni misura temporale.
319
Fisica, IV, 19, 221.
310
Il tempo, in quanto misura del movimento, implica una quantità che sia assunta a unità di misura. Tale
unità è l’istante. L’istante deve essere inteso come tale da consentire, insieme, la continuità del tempo e
misura di esso attraverso il numero. Il tempo è, perciò, divisibile secondo tale unità di misura.320
La natura comprende i processi di movimento e di mutamento. Occorre considerare, perciò, in primo
luogo, il movimento, perché la conoscenza dei processi naturali è basata sulla conoscenza della natura del
movimento e dei modi in cui esso si esplica. Il movimento, come abbiamo visto, è connesso allo spazio e al
tempo. Ma, d’altra parte, esso è relativo agli enti stessi (che si muovono e che mutano). Il movimento e il
mutamento ci sono perché ci sono gli enti mobili e mutevoli. E il mutevole muta sempre o nella sostanza o
nella quantità o nella qualità o nel luogo:321 per esempio, un ente è caratterizzato dalla sua forma (e
privazione), dalle sue qualità, dal suo essere grande o piccolo, completo o incompleto, dal suo trovarsi in un
dato luogo (fondamentalmente in virtù del suo essere leggero o pesante). In virtù del movimento l’ente si
realizza in atto; ciò che è in potenza realizza così le sue possibilità. Perciò Aristotele dice che “il movimento è
l’atto (entelechia) del possibile in quanto possibile”,322 cioè “del mobile in quanto mobile”.323
Aristotele si chiede se il movimento debba concepirsi come tale che abbia un cominciamento e una fine
(in modo da potersi pensare a una realtà caratterizzata dal movimento e a una realtà in cui vi sia assoluta
assenza di movimento), oppure come tale che non abbia inizio né fine e che sia stato sempre e sempre sia,
“immortale e inesauribile”, e costituivo di ogni ente naturale. Ma se il movimento non esistesse dall’eternità,
occorrerebbe che pure si fosse verificata una condizione del passaggio dall’assenza di movimento al
movimento. Analogo ragionamento si pone per l’indistruttibilità del movimento: infatti bisogna supporre
una condizione di passaggio dal movimento all’assoluta mancanza di movimento, Ma è evidente che ciò è
impossibile; non potrebbe aversi un mangiamento posteriore all’ultimo (come passaggio dal mutamento al
suo contrario). Ne deriva che il moto è eterno.324 Bisogna ammettere, dunque, l’eternità del movimento. Il
movimento, in quanto ha come dimensione l’eternità, ha come suo principio e fondamento la stessa
immobilità. Fondamento del movimento è, pertanto, un principio che sia motore immobile ed eterno.
Connesso a tale principio è il primo mobile, che deve concepirsi anch’esso eterno. Il motore immobile, infatti,
deve muovere qualcosa; e questo è il primo mobile, una realtà che, a sua volta, è principio di ogni
movimento determinato e finito.325
Aristotele distingue tre specie di movimento: della qualità, della quantità, del luogo.326 Il primo è il
mangiamento, il secondo è l’aumento e la diminuzione,327 il terzo è il moto locale (di traslazione).328 Il
movimento originario e fondamentale è la traslazione circolare (che riguarda il cielo e gli astri). Infatti non può
darsi, ad esempio, aumento senza spostamenti locali (un corpo aumentando di volume occupa un maggiore
spazio).329 Che la traslazione sia il movimento originario è confermato dal fatto che essa sola costituisce un
320
“E’ chiaro che l’istante non è una porzione del tempo, come la divisione non è una porzione del movimento, né il
punto è porzione della linea” (Fisica, IV, 17, 220). L’istante è il limite del tempo: non è tempo (o parte del tempo), ma
è il numero che serve a misurare il tempo. L’istante fa sì che il tempo sia sempre diverso e, insieme, sempre uguale a
se stesso. In virtù di esso, il tempo si configura come passato e come futuro: infatti l’istante segna sempre la fine del
passato e il principio del futuro; esso è, perciò, come una sintesi di entrambi (come il punto nel circolo è sintesi di
convesso e di concavo) (Fisica, IV, 19, 222). L’istante è indivisibile (esso è principio della divisione del tempo) e in
esso non si dà né movimento né quiete. Se nell’istante vi fosse movimento, esso si caratterizzerebbe in rapporto al più
veloce e al più lento, e dunque sarebbe divisibile. Analogamente, nell’istante non si dà neppure quiete (VI, 2, 234).
321
Fisica, III, 1, 201.
322
Fisica, III, 1, 201.
323
Fisica, VIII; 1, 250.
324
Fisica, VIII, 1, 250-51. “E sarà necessario o che il movimento sia eterno o che non esista mai, non potendo
nascere dal nulla” (VIII, 2, 252).
325
“Giacché l’immobile muoverà sempre di uno stesso ed unico moto nella stessa maniera, una volta che non muta
affatto il suo rapporto col mobile; ma poi il mobile, mosso da questo mobile, che è mosso dall’immobile, per la varietà
dei suoi rapporti con le cose, sarà causa di movimenti diversi” (Fisica, VIII, 9, 269).
326
Fisica, V, 3, 225.
327
“Aumento quel che tende alla grandezza perfetta, diminuzione quel che parte da questa”.
328
Fisica, V, 3, 225-26. “E poiché tre sono le specie di movimento […], è necessario che anche i mobili siano di tre
specie” (VII, 3, 243). Cioè i mobili sono di tre tipi: che si muovo di moto locale, che si muovono nel senso
dell’aumento e della diminuzione, che si muovono nel senso del mutamento della sostanza.
329
Fisica, VIII, 10, 260.
movimento continuo.330 Gli altri movimenti non sono continui: essi, infatti, avvengono da contrario a
contrario, cioè non possono avere omogeneità e continuità.331
Aristotele dimostra come si dà un moto infinito, unico e continuo e che questo è il moto circolare. Il corpo,
che percorre una retta finita, non ha movimento continuo, perché, tornando sulla stessa retta, si muove di
moti contrari (prima in un senso e poi in un altro).332
Il moto circolare, dunque, è quello perfetto ed è misura (modello) degli altri; esso solo può dirsi
uniforme.333 Tale è il moto del cielo: il cielo, infatti, è un corpo perfetto (ha una perfezione divina) e, per sua
natura, è tale che si muove di moto circolare. Ma questo moto non riguarda tutto il corpo dell’universo.
Infatti questo si muove intorno a un centro; e il centro è rappresentato dalla Terra, che sta ferma. E poiché c’è
la terra, si dà necessariamente il suo contrario, che è il fuoco.334 Inoltre, bisogna che ci siano i corpi intermedi
(l’aria e l’acqua). Poiché i contrari stanno in rapporto continuo di azione e passione reciproca, essi si
distruggono a vicenda; e da qui il processo della trasformazione continua e della generazione. Dall’incontro
e dalla relazione tra gli elementi contrari, infatti, si producono corpi che hanno per proprio carattere
fondamentale il mutamento. Il moto che riguarda questi corpi è, pertanto, relativo e finito, imperfetto.
Tutti i corpi esistenti sono costituiti da elementi.335 E poiché le differenze tra i corpi non sono infinite, è
evidente che neppure infiniti sono gli elementi.336 Gli elementi che per primi emergono sono il fuoco e la terra:
infatti, data la costituzione dell’universo, occorre che vi siano corpi costituiti prevalentemente da un
elemento pesante e altri da un elemento leggero. Così, “grave in senso assoluto è ciò che sta sotto a tutti”
(l’elemento “terra”), mentre “leggero è ciò che a tutti sormonta” (il “fuoco”).337 Gli altri elementi (l’aria e
l’acqua) sono intermedi.338 Tali elementi non sono eterni.339
Il quinto elemento è l’etere.340 Di tale elemento devono essere costituiti i corpi che si muovono solo di moto
circolare: infatti il moto circolare non ha in sé moto contrario; e ciò che è sottratto alla opposizione dei
contrari è ingenerato e indistruttibile (infatti solo nell’ambito dei contrari si hanno la nascita e la distruzione).
Così anche l’accrescimento e la diminuzione appartengono a ogni corpo che sia nell’ambito dei contrari; e il
corpo che è esente da questo rapporto ed è fuori di questo ambito non è generato da altro ed è razionale che
sia indistruttibile e immutabile.341
330
“Nessun altro movimento può essere continuo, fuor che la traslazione; quindi essa dev’essere il primo
movimento”.
331
Fisica, VIII, 11, 261.
332
“Solo il moto circolare sarà unico e continuo [...], poiché è un moto da se stesso a se stesso, mentre il rettilineo è
da se stesso ad altro […], non congiunge il termine col principio” (Fisica, VIII, 12, 263-65). “E’ evidente dunque che la
traslazione circolare è la prima fra le traslazioni […], anteriore alla rettilinea, perché semplice e più perfetta […]… e il
perfetto è anteriore all’imperfetto,l’eterno al mortale per natura, per ragione e per tempo” (VIII, 15, 265). “Nel moto
rettilineo si distinguono principio, fine e mezzo […], nel circolare no […], ché ogni punto è ugualmente principio,
mezzo e fine, sicché è sempre in principio e in fine” (VIII, 13, 265).
333
Fisica, VIII, 13, 265.
334
“Ché dei contrari, se uno esiste, per natura, anche l’altro bisogna che esista per natura” (De coelo, II, 3, 286).
335
Fisica, III, 3, 302.
336
Fisica, III, 4, 303.
337
Fisica, IV, 4, 311.
338
“Ma sono gravi e leggeri in senso diverso (relativo) quelli che partecipano di entrambi; poiché taluni sormontano
e altri soggiacciono, come l’aria e l’acqua. In senso assoluto né l’uno né l’altro sono leggero e grave; perché entrambi
più leggeri della terra […] e più pesanti del fuoco […], ma in rapporto l’uno all’altro sono assolutamente l’uno grave e
l’altro leggero; ché l’aria, quanta ve ne sia, sormonta all’acqua, e l’acqua, quanta ve ne sia, soggiace all’aria”. Per
Aristotele, dunque, il fuoco è assolutamente leggero, mentre la terra è assolutamente pesante; l’acqua e l’aria, invece,
hanno insieme leggerezza e gravità, in modo che l’acqua sia più pesante degli altri elementi, tranne che della terra, e
l’aria più leggera degli altri, tranne che del fuoco (IV, 5, 312).
339
“Sicché [bisogna ritenere] che gli elementi dei corpi siano corruttibili e generabili”, “e non potendo nascere né
dall’incorporeo, né da altro corpo, resta che nascano gli uni dagli altri” (Fisica, III, 6, 504-5).
340
L’esistenza dell’etere è dimostrata dal fatto che ci deve essere un “corpo semplice che per sua propria natura si
muova di moto circolare” (De coelo, I, 3, 268). Poiché ogni corpo che va verso il centro è pesante, e leggero ogni corpo
che se ne allontana, risulta che il corpo che si muove circolarmente non può avere né gravità né leggerezza (I, 3, 269).
“Similmente è ragionevole pensare che sia ingenerato e indistruttibile e non suscettibile di accrescimento e variazione;
perché ogni essere generato viene da un contrario e da un sostrato, e si dissolve similmente, essendovi un sostrato e
passando da un contrario all’altro […]” (I, 3, 270).
341
Il nome “etere” (aeì thein,“che corre sempre”) indica il carattere essenziale di questo elemento che costituisce i
corpi celesti.
Poiché ciò che è mosso spazialmente è necessario che si tocchi e sia continuo col motore, ne deriva che
tutti i corpi mobili costituiscano insieme “un sistema totale unico e continuo”.342
Il motore originario è più vicino a ciò che si muove di moto più rapido; e poiché tale è il moto del cielo, ivi
è il motore primitivo (che, peraltro, deve essere insieme col mosso, cioè tale che tra il motore e il mosso non
vi sia nella di intermedio).343 Oltre alla traslazione del cielo, ci sono altre traslazioni eterne: quelle dei pianeti.
Ognuna di esse ha bisogno di essere mossa da una sostanza immobile per se stessa ed eterna.344
La natura nel suo insieme costituisce un sistema caratterizzato da continuità, in modo che da un ambito a
un altro si passa attraverso un processo graduale. Così le specie viventi differiscono tra loro di un grado
minimo e le differenze vanno via via crescendo in misura graduale.345 E il passaggio dalle specie vegetali a
quelle animali è continuo.346
La psicologia
Per quanto riguarda l’anima, Aristotele tratta, innanzitutto, dei rapporti tra questa e il corpo. L’anima è il
principio delle funzioni proprie dell’essere vivente (nutrizione, sensibilità, pensiero, movimento).347 L’anima è
“ragione” o “forma”, non materia o sostrato; dunque, poiché la materia è potenza e la forma è atto
(“entelechia”), e l’essere vivente risulta da entrambe, l’anima si configura come atto del corpo vivente (e non il
corpo atto dell’anima). E’ il corpo, dunque, che assume la forma dell’anima e ciò che è in potenza nella
materia sua propria diventa essere vivente in atto.348
L’anima è principio dell’organismo vivente in tre sensi: come principio di moto, come fine e come
sostanza. Poiché il vivere è l’essere del vivente, e l’anima è principio del vivere, essa è la sostanza generale
dell’essere vivente. L’anima è anche la causa finale dei processi naturali. Infine l’anima è principio del moto
locale dei viventi.349 Aristotele osserva che la struttura complessiva del corpo umano riflette la finalità
dell’intero ordine degli organismi viventi, configurata come intelligenza e pensiero. La statura eretta è la
principale caratteristica che riflette tale finalità.350 Tuttavia l’anima opera in connessione col corpo e con
l’ausilio degli strumenti corporei.351
La più semplice funzione dell’anima è la facoltà nutritiva: per essa i viventi hanno la vita e svolgono le
funzioni vitali, che sono il generare e il nutrirsi. Tutte le altre facoltà sono possibili sulla base della capacità
di generare esseri della stessa specie.352 Poi viene la facoltà sensitiva. Questa è in potenza e la sensazione in
atto si ha in rapporto all’azione esercitata dalla realtà esterna, cioè dalle cose che costituiscono il sensibile, il
visibile, l’udibile, l’odorabile, il tangibile, e così via (le forme, i colori, i rumori, i suoni, e così via). La
sensazione ha, perciò, per oggetto entità particolari (al contrario della scienza, che riguarda l’universale):
l’intendere, infatti, riguarda i concetti, che non appartengono al mondo esterno ma dipendono da noi stessi
342
Fisica, VII, 2, 242.
Fisica, VII, 3, 243; VIII, 15, 267.
344
“E’ evidente dunque che bisogna ci siano altrettante sostanze, eterne per natura e immobili in sé e senza
estensione” (Met., XII, 8, 1073-74). Aristotele fornisce precisazioni dettagliate intorno al moto dei pianeti. Per ogni
pianeta occorre che vi siano altrettante sfere, meno una, di quante sono tutte le sfere; infatti occorre che tali sfere “girino
inversamente e riconducano allo stesso punto di posizione la prima sfera dell’astro sottostante”. “Il numero di tutte le
sfere, che li muovano nell’uno e nell’altro senso, sarà 55; ma se per la luna e il sole non si aggiungano i sopra detti
movimenti, tutte le sfere saranno 47”.
345
De partibus animalium, IV, 5, 681.
346
“Sicché per talune specie marine è un problema se siano animali o piante; perché sono attaccate al suolo e molte
di esse se strappate periscono […]. E sempre per piccola differenza appare che l’una avanti l’altra abbia più vita e
movimento” (Historia animalium, VIII; 1, 588).
347
De anima, II, 2, 413.
348
De anima, II, 2, 414. “Perciò l’anima è l’atto primo di un corpo materiale avente la vita in potenza” (II, 1, 412).
349
De anima, II, 4, 415.
350
“Anassagora dice che l’uomo è il più saggio degli animali perché ha le mani […]; perché le mani sono strumenti,
e la natura sempre distribuisce ogni cosa a chi sia in grado di ser, II, 5, 417.virsene” (De partibus animalium, IV, 10,
686-87).”L’uomo, solo tra gli animali, è a statura eretta, perché la sua natura e sostanza è divina; e funzione del divino è
intendere e pensare: ciò che non sarebbe facile se non sovrastasse la gran mole del corpo”.
351
“Nella maggior parte dei casi, essa nulla sembra poter patire né fare senza il corpo: per esempio adirarsi, aver
coraggio, desiderare e in genere sentire. Sua funzione propria per eccellenza sembra il pensare; ma anche questo, sia
esso immaginazione o senza l’immaginazione, non potrebbe aversi senza il corpo” (De anima, I, 1, 403).
352
De anima, II, 4, 413.
343
(mentre per la sensazione è necessaria la presenza del sensibile).353 L’oggetto sensibile può essere quello
proprio di ciascun senso e quello comune di tutti.354 Il senso riceve le forme sensibili senza la materia (come
la cera riceve l’impronta dell’anello senza il ferro o l’oro).355 Il sistema dei sensi è atto a cogliere le
caratteristiche della realtà e ogni senso corrisponde alle specifiche modalità in cui la realtà si manifesta.
Aristoetele ammette un sensorio comune, oltre ai cinque sensi. L’uomo, così, vede, sente, ecc. , ma anche sente
di vedere e di udire e giudica, ad esempio, che sono diversi il dolce e il bianco: non potrebbe giudicare con
un qualche senso specifico (perché ogni senso avverte solo ciò che è proprio alla sua attitudine, riconosce il
dolce e l’amaro ma non può comparare il dolce al bianco; queste diverse qualità, invece, sono percepite e
distinte da un senso unico, che sia capace di sentirle entrambe e di avvertirle come diverse).356
Aristotele si sofferma, quindi, sul passaggio dal senso al pensiero. E’ evidente che sentire e pensare
(riflettere) sono attività diverse e, dunque, si riconducono a facoltà differenti. Di sentire sono capaci tutti gli
animali; invece solo pochi hanno la facoltà di riflettere (pensare e ragionare). La sensazione è sempre vera e
appartiene a tutti gli animali; invece il pensare è passibile anche di errore e appartiene solo a chi è fornito di
ragione.357 Il passaggio dalla sensazione al pensiero avviene attraverso l’immaginazione. Questa non può
aversi senza quella, e così la concezione (il pensare attraverso concetti) non può aversi senza l’immaginazione.
Essa può aversi solo delle cose di cui si dà sensazione.358
Aristotele mette in rilievo l’autocoscienza come propria dell’uomo, in modo che l’esistere umano significa
fondamentalmente sentire e pensare di esistere. L’uomo, cioè, vede e sente che vede, ode e avverte di udire,
cammina ed è cosciente (consapevole) di camminare; di ogni atto che egli compie ha immediata coscienza:
sicché “sentiamo di sentire e pensiamo di pensare”.359 L’autocoscienza è condizione di sintesi conoscitiva, di
confronto tra atti diversi, dunque di unità sintetica di questi atti.360
Si esaminano, quindi, i caratteri della facoltà intellettiva. Come il senso riceve un’azione da parte
dell’oggetto sensibile, così l’intelletto deve ricevere un influsso da parte dell’oggetto intelligibile (o di
alcunché di simile). Occorre, cioè, che l’intelletto sia capace di ricevere l’azione da parte della “forma” o
“idea” e che la sua natura sia proprio quella di essere in potenza intellezione, cioè comprensione delle idee.361
Si può dire che “l’intelletto è in certo modo gli intelligibili in potenza” (e che “non ne è nessuno in atto,
prima di pensarlo”). Perciò l’intelletto è simile alla tavoletta, in cui nulla si trova già scritto in atto (prima che
vi sia scritto); e da questo paragone aristotelico è venuta poi la definizione dell’intelletto come “tabula rasa”.
Ciò induce Aristotele ad ammettere un “intelletto passivo” (fatto per ricevere le idee, l’azione dell’oggetto
intelligibile) e un “intelletto attivo” (fatto per produrre le idee). Questo intelletto è lo stesso intelligibile in atto.
Esso deve essere inteso come sempre in atto, pensiero delle idee. Ma in tale condizione esso è “separato”,
cioè sussistente per sé: quindi deve essere concepito come “immortale ed eterno”, principio di ogni pensiero
e luogo degli intelligibili in atto. Invece l’intelletto passivo è quello finito e mortale, proprio degli
individui.362
353
De anima, II, 5, 417.
“Dico ‘proprio’ quello che non può sentirsi con altro senso, e su cui il senso non può ingannarsi, come la vista
per il colore, l’udito per il suono, il gusto per il sapore […]. Comuni sono il moto e la quiete, il numero, la figura, la
grandezza” (De anima, II, 6, 418). Aristotele dimostra perché non vi possono essere che cinque sensi. Gli oggetti sono
sentiti o attraverso il tatto, cioè per contatto, oppure tramite gli elementi fondamentali (l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco).
Poiché tutti i corpi terrestri sono costituiti da questi elementi, i cinque sensi sono sufficienti a soddisfare ogni esigenza
della sensazione, cioè a rendere tutti i corpi percepibili rispetto alle loro qualità. Cfr. De anima, III, 1, 425.
355
De anima, II, 12, 424.
356
De anima, III, 2, 426.
357
De anima, III, 3, 427.
358
“Sarà dunque l’immaginazione un moto generato dalla sensazione che è in atto” (De anima, III, 3, 428-29). “E
per la sua persistenza e somiglianza alla sensazione, molte azioni compiono per essa gli animali: gli uni perché non
hanno intelletto, come le bestie, gli altri perché il loro intelletto è talora ottenebrato da passione, o malattie, o sonno,
come gli uomini”.
359
Cfr. Etica Nicomachea, IX, 9, 1170.
360
In tal modo Aristotele scopre e rileva un’importante funzione della coscienza (quale sarà poi sottolineata dalla
filosofia moderna e specialmente da Kant).
361
Perciò, “ha ragione chi dice che l’anima è il luogo delle idee, purché s’intenda non l’anima intiera, ma solo
l’intellettiva; e non di idee in atto, ma in potenza” (De anima, III, 4, 429).
362
“Resta dunque che solo l’intelletto (attivo) venga dal di fuori e solo esso sia divino; perché l’atto corporeo non
partecipa affatto dell’atto di esso” (DE gen. animal., III, 3, 736).
354
L’intelletto come tale è impassibile, cioè tale da non essere corruttibile. Il pensare si esaurisce non per la
corruzione dell’intelletto, ma per la decadenza dell’organismo al quale esso si appoggia.363
Rimane da esaminare la facoltà motrice. Il principio motore si identifica con l’appetito e con l’intelletto
pratico. L’appetito è il movimento dell’anima verso ciò che è vantaggioso alla vita e allo sviluppo dell’attività
dell’anima stessa. In rapporto alla sensazione piacevole o dolorosa, l’anima si rivolge verso l’oggetto che
provoca il piacere e fugge da quello che provoca il dolore. A ciò concorre anche l’intelletto pratico, che
calcola e valuta in vista di qualche fine. L’intelletto considera (in rapporto al fine) l’oggetto dell’appetito, in
modo che si abbia l’azione (determinata dall’impulso dell’appetito e dalla valutazione dell’intelletto pratico).
L’appetibile è il principio del movimento; anche la fantasia e il pensiero sono accompagnati dall’appetito (ad
esempio, dall’appetito di sapere).364 Negli uomini, che hanno il senso del tempo, la ragione e il desiderio
(appetito) possono essere anche in contrasto, in quanto “l’intelletto comanda di resistere in vista del futuro, il
desiderio in vista del presente”.365 In tal modo si ha l’azione volontaria. Questa è l’azione che “uno fa tra quelle
che sono in suo potere” e che, perciò, può fare e non fare.366 La libertà è connessa con la responsabilità: le
azioni conformi a valutazione e deliberazione sono libere e responsabili. Le azioni sono compiute anche in
virtù di abitudini acquisite (di cui, tuttavia, abbiamo la responsabilità).367
L’etica
L’uomo persegue scopi diversi e svolge attività connesse a tali fini. Ma c’è un fine che riassume il senso di
tutti i fini particolari e costituisce il senso dell’intera attività umana. Questo fine, che noi vogliamo per se stesso (e
che, quindi, costituisce un valore per sé), deve configurarsi, perciò, come “il sommo fra tutti i fini pratici”.368
Questo bene è la felicità.
Per poter definire in che consiste la felicità come sommo bene per l’uomo, occorre considerare la natura
propria dell’uomo. Infatti per ogni essere la perfezione consiste nell’attuazione della propria natura. E la
natura dell’uomo è quella di “ente dotato di ragione”. “L’opera propria dell’uomo è (dunque) l’attività
dell’anima conforme a ragione e non contrastante con essa”.369
L’attività dell’intelletto è quella più alta nell’uomo e più propria (quella che propriamente definisce
l’identità dell’uomo e lo distingue dagli altri enti): essa è di carattere contemplativo e contende ad altro fine
esterno, in sé trova il suo stesso piacere, è sufficiente a se stessa e illimitata (per quanto è nei limiti
dell’uomo). Tale attività rimanda a una condizione superiore all’umana, ché non altra può essere l’attività
propria dell’essere divino. Così si può dire che “simile vita sarà superiore all’umana, ché non altra può
essere l’attività propria dell’essere divino. Così si può dire che “simile vita sarà superiore all’umana; ché
363
“Il pensare discorsivo e l’amare e l’odiare non sono affezioni di esso, ma di colui che lo ha, in quanto lo ha;
perciò anche, distruggendo costui, esso non ricorda e non ama; perché ciò non apparteneva a lui, ma alla comunione
che si è distrutta; l’intelletto invece è forse qualcosa di divino e impassibile” (De anima, I, 4. 408). La dottrina
dell’intelletto attivo ha dato luogo a controverse interpretazioni. Per Alessandro d’Afrodisia, l’intelletto attivo si
identifica col primo motore, mentre l’intelletto passivo è il più alto grado di sviluppo dell’anima individuale (e dunque
mortale); per Averroé anche l’intelletto passivo è parte dell’unico intelletto, che è separato e unico per tutti gli individui.
In entrambi questi commentatori si ha la negazione dell’immortalità dell’anima individuale (immortale è l’intelletto
unico e separato).
364
De anima, III, 10, 433.
365
Ib.
366
Et. Nicom., III, 8, 1110; 1112; V, 8, 1133 : « Delle azioni volontarie talune facciamo per scelta, altre no :per
scelta quelle che abbiamo deliberato, senza scelta quelle che non abbiamo deliberato”. La deliberazione si ha allorché si
valutano le componenti dell’azione, cioè i fini, le condizioni e così via. Più propriamente, essa riguarda non tanto i fini
bensì le cose che consentono il conseguimento di essi (ad esempio, il medico non delibera se deve guarire o no, ma
come guarire). Invece la volontà riguarda il fine (Et. Nicom., III, 3, 1112-13; III, 4, 1113).
367
Et. Nicom., III, 5, 1113-14.
368
Et. Nicom., I, 4, 1095.
369
Et. Nicom., I, 8, 1098. « Ciò infatti che è proprio a ciascuno per natura è per ciascuno la migliore e più dolce cosa.
E per l’uomo dunque [è tale] la vita conforme all’intelletto, poiché questo è soprattutto l’uomo. Questa dunque è la vita
più felice” (Et. Nicom., X, 6, 1177).
l’uomo non la vivrà in quanto uomo, ma in quanto un che di divino è presente in lui”.370 Così l’uomo trova la
condizione della felicità nella sua natura stessa e non in qualche bene esterno.
Tuttavia, se la virtù propria dell’uomo è quella dell’anima e non quella del corpo, bisogna ammettere che
l’anima umana ha una triplice funzione, che cioè essa non è solo ragione ma comprende anche la funzione
vegetativa, che in nessun modo partecipa alla ragione, e la funzione appetitiva, che in qualche modo ne
partecipa e ad essa si sottomette. Perciò si deve intendere in due sensi la stessa facoltà razionale: come attività
puramente razionale, cioè come attività dell’intelletto, e come attività appetitiva sotto la guida della ragione
(in tal caso la ragione guida e orienta l’attività pratica dell’uomo). Da una parte abbiamo l’attività intellettiva
propria della conoscenza e dall’altra parte l’attività pratica, etica e politica. Perciò Aristotele distingue le
virtù dianoetiche e le virtù etiche.371
Comunque, la virtù attua la perfezione dell’uomo; e l’uomo, agendo secondo ragione, attua il proprio
essere, realizza la sua natura. A ciò concorrono entrambe le serie di virtù.372
Le virtù etiche si formano attraverso l’abitudine: esse, infatti, sono abiti di comportamento ed “etica” deriva
da “ethos”, che vuol dire “costume”, comportamento seguito normalmente. Nell’individuo vi sno i germi
naturali delle virtù; ma questi non si sviluppano spontaneamente. Perciò non possiamo dire che le virtù si
generano dalla natura.373
La virtù è anche “giusto mezzo” tra due stremi, che sono vizi.374
La virtù etica per eccellenza è la giustizia. Questa può essere considerata non già come una particolare
virtù tra le altre, bensì come “la virtù intiera”, così come l’ingiustizia “non è più forte del vizio, ma tutto
intiero il vizio”.375 Così si può dire giusto ogni atto che sia conforme alla virtù.
Aristotele distingue due specie di giustizia: la distributiva e la commutativa. Per quanto riguarda il primo
aspetto, la giustizia attua il “giusto mezzo” nei rapporti tra le persone. Medierà e uguaglianza devono
caratterizzare i rapporti umani e quelli degli uomini con le cose. La giustizia distributiva riguarda
l’uguaglianza che deve sussistere nei rapporti tra le persone attraverso le cose, con particolare riguardo al
possesso dei beni materiali da parte dei membri di una società. In una società di eguali un individuo (A) che
possiede determinati beni (B) deve avere la stessa condizione di qualsiasi altro individuo (C) che possiede
altri beni (D).
La giustizia commutativa si ha negli scambi volontari e involontari. Nello scambio, cioè, occorre che gli
individui abbiano sempre beni di eguale valore (sia prima che dopo lo scambio), cioè che essi non abbiano né
perdita né guadagno.376
Altra virtù fondamentale è l’amicizia, che Aristotele non esita a definire come “la cosa più necessaria alla
vita.377 L’amicizia si esprime specialmente nell’aiutarsi e beneficiarsi reciprocamente.378 La motivazione
dell’amicizia è nell’attitudine dell’uomo a compiere azioni disinteressate e tali per cui il solo compierle è
370
Et. Nicom., X, 7, 1177. Perciò « non bisogna, come alcuni esortano, che l’uomo, perché tale, concepisca solo cose
umane, e, perché mortale, solo cose mortali; ma per quanto può si faccia immortale, e faccia di tutto per vivere secondo
ciò che vi è di più eccellente in lui” (Et. Nicom., X, 7, 1178).
371
“Si distinguono pertanto anche le virtù secondo tale differenza: abbiamo infatti le une, dianoetiche (intellettuali),
e le altre, etiche (morali): dianoetiche la sapienza, l’intelligenza, la prudenza; etiche la liberalità, la temperanza e così
via” (Et. Nicom., I, 13, 1102).
372
“E’ evidente dunque […] che non vi può essere veramente buono senza saggezza, né saggio senza virtù etica” (Et.
Nicom., VI, 13, 1145). E insieme alla saggezza si danno tutte le altre virtù, poiché la saggezza dà all’uomo l’abito della
virtù secondo cui ogni comportamento è guidato dalla ragione.
373
Infatti, “di quanto s’ingenera di natura, prima rechiamo in noi la potenza, poi da questa produciamo l’atto” (Et.
Nicom., II, 1, 1103). “Le virtù invece le conseguiamo operando prima, come nelle altre arti; perché ciò che si deve avere
appreso per farlo, questo l’impariamo facendo, come si diventa costruttori costruendo e suonatori di cetra suonando.
Così anche, operando atti giusti e saggi e forti, diventiamo giusti e saggi e forti”.
374
Et. Nicom., V, 1, 1130.
375
Et. Nicom., V, 1, 1130.
376
Et. Nicom., V, 4, 1132. « Perciò bisogna che le cose, di cui v’è scambio, siano in qualche modo comparabili: al
qual fine fu inventata la moneta, che è come un mezzo: perché tutto misura, quindi anche il più e il meno […]. Ci sarà
dunque reciprocità quando sia ristabilita l’uguaglianza” (V, 5, 1133),
377
Et. Nicom., VIII, 1, 1155. Anche l’amicizia è basata sulla natura umana ed è espressione della originaria bontà e
positiva disposizione dell’uomo a compiere il bene. “L’amicizia perfetta è dei buoni e simili per virtù […]: essi sono di
tal animo per se stessi e non per circostanze esterne: permane dunque la loro amicizia finché restano buoni; e la virtù è
duratura” (V, 3, 1156).
378
Et. Nicom., VIII, 13, 1162. « Amico è chi vuole e fa il bene (o quel che tale gli sembri) per amore dell’amico, e
vuole che l’amico si conservi per lui stesso: che è il sentimento delle madri verso i figli e degli amici anche nelle
divergenze” (IX, 4, 1166).
gratificante. Così è anche, ad esempio, dell’operare artistico: l’artista ama le proprie opere, anche se non
recano alcun particolare vantaggio. “Causa di ciò è che per tutti l’essere è oggetto di desiderio e d’amore, e
noi siamo nell’atto: nel vivere e operare. Nell’atto esiste in certo modo chi compie l’opera: ed ama l’opera
perché ama anche l’essere. “Ciò è naturale: perché ciò che è in potenza, questo l’opera lo esprime in atto”.379
L’attività, l’essere attivo, è propria dell’uomo; e tale condizione si realizza essenzialmente nella vita
sociale, nei rapporti con gli altri. La vita solitaria, invece, essenzialmente inattiva ed è, perciò, contraria alla
natura umana. Nella vita attiva si realizza, dunque, la felicità dell’uomo.
La politica
La politica riguarda quel bene che è ricercato non da un solo individuo (o dall’individuo isolatamente) ma
da società, nazioni e stati. Un tale bene è definito da Aristotele come “più bello e divino”.380 L’uomo è, infatti,
“per natura animale sociale”.381 Egli è capace di vivere in società, in quanto può discernere il bene dal male,
l’utile e il dannoso, il giusto e l’ingiusto, ed è fornito di linguaggio, per cui comunica in modo completo e al
livello superiore del pensiero. Nella società l’uomo realizza anche il suo interesse e riesce non solo a
sopravvivere ma a vivere bene.382 Così, tutte le forme di associazione concorrono a tale fine, più di tutte,
“quella che si chiama stato e società politica”.383 Non solo lo stato consente agli uomini di trarre vantaggio
dagli scambi reciproci e di non recarsi offesa, ma assicura loro anche il “viver bene, cioè vivere felici e
virtuosi”.384 Nello stato, quindi, l’uomo realizza pienamente le sue potenzialità e raggiunge “una vita
perfetta e sufficiente a sé”.
Aristotele mette in rilievo la continuità tra la forma storica dello stato e le condizioni del suo permanere.
Attraverso il flusso continuo delle vicende, il trapassare delle generazioni e il volgere dei tempi, lo stato
mantiene la sua forma permanente (come un fiume che è sempre lo stesso, “pur nel flusso perenne delle
acque che sopraggiungono e se ne vanno”385). La forma dello stato è la sua costituzione; e se questa permane
invariata, si può dire che lo stato mantiene la sua identità. La costituzione, infatti, fissa e regola i rapporti tra
i cittadini e i ruoli delle parti e delle classi. Importante è la stabilità delle leggi.386 Ciò che è importante, nella
sfera politica, è che una costituzione si mantenga e che nella sua struttura sia fatta per assicurare la
continuità dello stato.387
I cittadini sono gli uomini liberi che, in uno stato, hanno il diritto di “partecipare al potere deliberativo e
giudiziario” e che sono capaci di bastare a se stessi (nel senso economico). Virtù del buon cittadino è il
sapere, insieme, ubbidire e comandare, cioè possedere “l’autorità degli uomini liberi sotto ambo gli aspetti”.388 Il
cittadino, cioè, esercita il potere e, insieme, si sottomette alla legge. I cittadini liberi sono quelli che
dispongono del tempo necessario per dedicarsi agli affari pubblici, cioè al governo dello stato e alle varie
incombenze dell’amministrazione pubblica. Perciò non possono essere quelli che sono impegnati in un
lavoro continuativo. Cittadini, in questo senso, sono quelli “politicamente attivi” (diremmo oggi), cioè (dice
Aristotele) “quanti sono affrancati dai lavori necessari”.389 Dunque sono esclusi i lavoratori, sia quelli
379
Et. Nicom., IX, 7, 1167.
Et. Nicom., I, 2, 1094.
381
Politica, I, 1, 1253.
382
Pol., III, 5, 1280.
383
Pol., I, 1, 1252.
384
Pol., III, 6, 1280.
385
Pol., III, 1, 1276.
386
“E’ evidente che tra le leggi alcune e talora vanno mutate […]. Ma è male abituare [i cittadini] a mutar facilmente
le leggi […]. Poiché la legge non ha alcuna forza per essere ubbidita fuor che nell’abitudine; e questa non si forma se
non con l’ampiezza del tempo; sicché il facile mutare delle leggi esistenti con altre nuove è indebolire il potere della
legge” (Pol., II, 5, 1269).
387
Pol., VI, 6, 1037. Condizioni di stabilità sono: la vigilanza sull’osservanza delle leggi e sulle ancor piccole
violazioni, affinché non si insinui la benché minima irregolarità; la vigilanza sulle spese, affinché lo sperpero non mandi
a poco a poco in rovina le sostanze pubbliche; il divieto ai magistrati di trarre profitti personali dalla gestioni dei propri
uffici (V,m 7, 1308); il consenso della maggioranza verso la costituzione (V, 7, 1309); infine lo sviluppo di una
educazione appropriata alla costituzione (V, 8, 1310).
388
Pol., II, 2, 1277.
389
Pol., II, II, 3, 1278.
380
soggetti sia quelli liberi, cioè sia quelli che sono alle dipendenze di altri (gli schiavi) sia quelli che sono alle
dipendenze della società, cioè gli artigiani e i mercanti.390
Aristotele rifiuta la tesi che sostiene la condizione degli schiavi essere contraria alla natura della
condizione umana e ritiene la disuguaglianza come un dato naturale, basato sul fatto che “fin dalla nascita
alcuni son fatti per essere comandati e altri per comandare”, per cui “è evidente che per natura alcuni sono
liberi, altri schiavi, cui anzi giova ed è giusto servire”.391 Invece contro natura è la “disuguaglianza tra uguali
e la disparità tra pari”.392
Il popolo deve conservare il potere di “scegliere i magistrati e chiedere loro conto della loro gestione
[della cosa pubblica]: ché, privo di tale potere, il popolo sarà schiavo e nemico”.393
Aristotele enumera, quindi, le diverse forme di governo, cioè le diverse modalità in cui si esprime la
sovranità (il potere sovrano). E’ da osservare, preliminarmente, che le costituzioni sono rette (basate sulla
giustizia), allorché “l’uno [monarchia, regno* o i pochi [aristocrazia, governo dei “migliori”] o i molti
[repubblica, “politeia”) governano per l’utile pubblico”. Ad ogni forma di retto governo corrisponde una
determinata degenerazione (tirannide, oligarchia, democrazia).394 Ogni popolo è adatto a una particolare
costituzione; ma le forme degenerate sono contro natura, dunque non rispondenti a nessuna disposizione di
qualche popolo.395 La repubblica è la forma mista di governo, basata sulla presenza di una condizione sociale
media.396 Si tratta, secondo Aristotele, della forma migliore di costituzione.397 Così, tra l’oligarchia
(degenerazione dell’aristocrazia) e la democrazia (degenerazione della repubblica), Aristotele ritiene
migliore la seconda, poiché “si ha democrazia quando son sovrani gli uomini liberi, oligarchia quando sono i
ricchi”.398
Le tre funzioni fondamentali dello stato sono quella deliberativa, quella amministrativa e quella
giudiziaria.399
In definitiva, Aristotele conclude che la bontà di uno stato è basata sulla virtù dei cittadini.400 Perciò lo sttao
deve provvedere all’educazione dei cittadini. Infatti, “per tre fattori divengono buoni o virtuosi gli uomini: e
questi sono la natura, l’abitudine e la ragione.401 E accade che “ogni arte o educazione si sforza di completare
ciò che manca alla natura”.402 E “poiché unico è il fine dello stato, è evidente che una sola e stessa educazione
390
L’attività politica si profila come una funzione che comprende l’intero impegno del cittadino e si qualifica come
condizione di piena libertà, come “ozio” nel senso di indipendenza da lavori costrittivi.
391
Pol., I, 2, 1254.
392
Pol., VII, 3, 1325. L’uguaglianza è giusta allorché riguarda individui uguali. In definitiva, l’uguaglianza è una
condizione naturale, cioè riguarda le disposizioni degli individui. Così, ad esempio, la disuguaglianza e l’uguaglianza
non riposano su singoli elementi accidentali, come la ricchezza e la povertà. Coloro che sono diseguali per qualche
aspetto (per esempio per la ricchezza) non sono diseguali in tutto; e così non tutti quelli che sono uguali in qualcosa (ad
esempio nella libertà) sono uguali in tutto (ad esempio nei diritti politici) (Pol., III, 5, 1280). Tenendo presente tale
condizione di uguaglianza e disuguaglianza tra i cittadini, “ciò che è ugualmente retto è ciò che giova a tutto lo stato e
alla comunità dei cittadini.
393
Pol., II, 9, 1274. Così, “l’esenzione da ogni responsabilità e il potere a vita sono privilegi troppo grandi […]; e il
potere non regolato da leggi ma fondato sul proprio arbitrio[il potere assoluto] è pericoloso” (II, 7, 1272).
394
Pol., III, 5, 1279.
395
Pol., III, 11, 1287.
396
Pol., V, 6, 1294.
397
“Vuol dunque lo stato esser composto di uguali e di simili al massimo; e questo si ha soprattutto nella condizione
media; sicché bisogna che ottimamente sia governato questo stato, formato degli elementi di cui dicemmo per natura
risultare la stessa formazione dello stato” (Pol., IV, 9, 1295).
398
Pol., IV, 3, 1290. La democrazia è più stabile e meno agitata dell’oligarchia (V, 1, 1302): essa assicura un
giudizio più equilibrato, quale è quello espresso da una moltitudine (rispetto a quello espresso da uno solo); e così è
meno corruttibile la moltitudine rispetto a un solo individuo, che più facilmente lascia che il suo giudizio sia inquinato
da fattori estranei (come le stesse passioni individuali o le pressioni esterne) (III; 10, 1286). Nella democrazia
fondamento della costituzione rimane la libertà. In essa la giustizia consiste nell’uguaglianza secondo il numero (e non
secondo il merito) ed è assicurato l’avvicendarsi dei cittadini nell’ubbidienza e nel comando (VI, 1, 1317). Nella
democrazia, tutti i cittadini concorrono all’elezione dei magistrati, si fanno rendere conto della loro gestione e li
giudicano; sicché i governanti risultano essere i migliori (i peggiori non vengono eletti).
399
Pol., IV, 11, 1298.
400
Pol., VII; 1, 1223.
401
Pol., VII, 12, 1332.
402
Pol., VII, 15, 1336.
dev’esservi per tutti, e che la cura di questa dev’essere pubblica e non privata […]. E’ evidente dunque che
spetta alle leggi regolare l’educazione e farla pubblica”.403
Il sistema delle virtù.
L’evoluzione del problema morale e la questione delle tre “Etiche”.
Aristotele distingue la sfera pratica da quella teoretica: questa riguarda le modalità della conoscenza e comprende
rappresentazioni mentali, opinioni e dati scientifici, che non hanno lo scopo di incidere sull’essere delle cose, ma si
limitano a una pura contemplazione di esse; il loro fine è perciò ad esse intrinseco; quella, invece, riguarda l’attività
mediante la quale gli uomini modificano il sistema dell’esistenza delle cose, introducono formazioni e nuove e
modificano quelle esistenti; pertanto hanno il loro fine in ciò che producono nel mondo, in una realtà esteriore, in
quell’alterità che è costituita però da “pragmata”, fatti prodotti dall’uomo (oggetti, comportamenti, istituzioni
politiche). A un livello superiore si pone, poi, l’attività poetica, caratterizzata come creazione di opere specifiche (in cui
dunque l’attività pratica si fonde con quella teoretica). “Etica” e “poetica” sono le parti della filosofia che riguardano
l’attività pratica, relativa ai comportamenti comuni, e quella poetica, più propriamente creativa.
Aristotele segue, nella fondazione della morale, un criterio naturalistico, per cui all’ordine stabilito dalla
volontà razionale (dalla tensione dell’anima che, secondo Platone, spinta da Eros, perviene all’attuazione, nel
mondo, di strutture etiche e politiche che sono un’imitazione dei modelli eterni costituiti sulla base dell’idea
del Bene) sostituisce l’originario ordine “naturale”, che si estrinseca attraverso una serie necessaria di
“cause”. Mentre per Platone la morale e la politica comprendono costruzioni umane, per Aristotele
riguardano una sfera della natura, cioè quella propriamente umana. “La città appartiene ai fatti naturali”,
dichiara Aristotele nella Politica (I, 1, 1253): la città, infatti, è basata su un carattere fondamentale dell’uomo,
l’inclinazione alla società (“L’uomo è animale più socievole […] di ogni specie e di ogni altro animale che
vive in greggi”, ib.). La stessa “differenza” tra gli uomini è radicata nella physis, per cui “per natura alcuni
uomini sono liberi e altri schiavi” (I, 2, 1255). Poiché riconosce nello stato una determinazione della physis,
Aristotele può considerarlo come un oggetto di indagine e di “scienza”: descrittivamente, lo esamina nelle
sue forme possibili, con rigido criterio classificatorio. Così l’”eudaimonia” consiste nella piena attuazione
della “natura umana”, in ciò che essa ha di proprio, la ragione; e le “virtù” non sono altro che aspetti
dell’appetito naturale regolato dalla ragione. E’ stabilito nella natura dell’uomo che egli debba agire secondo
virtù. Platone vede nell’ordine politico il fine dell’attività umana; per Aristotele, tale fine è dato
dall’esplicazione di un’attività improntata alla ragione: così la scienza, la morale, la politica costituiscono
sfere separate e ognuna fornita di una dignità propria, e tutte legittime e rispondenti al fine proprio
dell’uomo. Siamo, cioè, nell’ambito di un’etica non necessariamente connessa a una prospettiva politica:
l’esplicazione delle virtù costituisce già di per sé un bene per l’uomo.
Lo Jaeger (1923) distingue tre fasi nello sviluppo dell’etica di Aristotele: 1) una fase platonica,
rappresentata dal Protrettico; 2) una fase di riforma del platonismo, rappresentata dall’Etica Eudemea; 3) una
fase propriamente aristotelica, rappresentata dall’Etica Nicomachea. La Grande Morale sarebbe, invece, soltanto
un compendio privo di interesse, compilato da un peripatetico sulla base delle due etiche aristoteliche.
Secondo W. Theiler (1934), quest’ultima opera sarebbe sì di stesura post-aristotelica, però effettuata sulla
base di appunti di un corso di lezioni che il maestro avrebbe tenuto nel periodo intercorso tra la
composizione delle due “Etiche”: perciò essa rappresenterebbe uno stadio di mezzo dello sviluppo dell’etica
aristotelica.
Aristotele ricerca, come oggetto dell’etica, quell’attività che realizza, in modo eminente, la natura umana:
tale realizzazione (il conseguimento, da parte dell’uomo, di ciò che gli è di più proprio) è il fine dell’uomo,
cioè ciò che per lui è il bene. Il “bene” non è qui inteso, alla maniera platonica, come lo stesso fondamento
della realtà, il principio metafisico in base al quale il reale ha un senso (una “ragione”, un “logos”: e perciò è
intelligibile), bensì in relazione all’uomo e alla sua attività, come ciò che mediante questa attività egli può (e
deve) conseguire. Si tratta di un praktòn agathòn, cioè di un bene di valore e di carattere “pratico”. Questo è,
tuttavia, un bene sommo, in quanto conferisce alla vita umana il massimo valore (costituendo il massimo
grado di attuazione della natura umana). Tale bene coincide, dunque, anche con la felicità, poiché questa
consiste nella piena attuazione, da parte di ogni ente, della propria perfezione.
403
Pol., VIII, 1, 1337.
Poiché la natura propria dell’uomo consiste nella ragione (l’uomo è definito come l’”animale fornito di
ragione”), l’attività umana più propria (quella in cui l’uomo raggiunge la perfezione) è quella esercitata dalla
ragione stessa di per sé (e tale è l’attività conoscitiva, il pensare, il ragionare, il conoscere): perciò, per
Aristotele, al primo posto dobbiamo collocare l’attività teoretica, come quella nella quale l’uomo attua
interamente la sua essenza e, quindi, consegue la felicità. Al secondo posto è da porre ogni altra attività
umana che sia svolta con l’ausilio della ragione, cioè l’attività pratica condotta secondo quei princìpi
dell’agire pratico razionale che sono le virtù etiche. Il pensiero, dunque, essendo espressione dell’intelletto,
rappresenta la forma più alta e più pura di vita umana: Aristotele mantiene come massima espressione e
attuazione della natura umana l’attività intellettuale, la vita filosofica, la conoscenza che non ha altro fine che
se stessa, la scienza pura, il sapere contemplativo (che si attua e si risolve in sé, come pura teoria).404
Aristotele considera, dunque, come sommo bene per l’uomo l’esercizio della ragione, come attività di
pensiero che permette la contemplazione della verità; e, d’altra parte, considera l’attività pratica guidata
dalla ragione come una forma subordinata, si valore inferiore e di carattere essenzialmente umano (mentre
l’attività teoretica avvicina l’uomo alla divinità). Nell’abito di questa concezione è possibile seguire
l’evoluzione dell’etica aristotelica, secondo la linea evolutiva messa in rilievo dallo Jaeger. Aristotele
continua a considerare l’attività teoretica come la suprema espressione della vita dell’uomo, addirittura
come ciò che fa somigliare l’uomo al dio, inteso come principio intelligente e struttura razionale della realtà;
d’altra parte, egli tende a rivalutare sempre di più la vita dell4’uomo nei suoi caratteri e nei suoi fini pratici.
Il nucleo del pensiero etico di Aristotele si ha, per lo Jaeger, già nel Protrettico, allorché il filosofo distingue
le tre forme di vita connesse ai tre princìpi della “phronesis”, dell’areté” e dell’”edonè”. Nel capitolo IV della
“Eudemea”, troviamo la medesima distinzione tra la vita dedita alla ricerca della verità e all’attuazione della
conoscenza, quella politicamente attiva, quella dedicata ai piaceri. Anche qui la felicità è fatta consistere nella
contemplazione della verità. Nella “Nicomachea”, come osserva lo Jaeger, Aristotele non collega più le tre
forme di vita ai tre princìpi su ricordati. “Nel Protrettico la ‘phronesis’ serbava ancora il pieno senso
platonico del ‘nous’, attingente per via teoretica l’essere eterno e con ciò insieme il valore supremo. Solo il
filosofo vive la vita della ‘phronesis’. La ‘Nicomachea’ non fa più dipendere il retto giudizio morale dalla
conoscenza del trascendente, e cerca invece una giustificazione ‘naturale’ nella consapevolezza pratica
dell’uomo e nel suo costume etico. Perciò nel primo libro della ‘Nicomachea’, Aristotele ha logicamente
cancellato la ‘phronesis’, insieme con la tripartizione del ‘Protrettico’. L’’Eudemea’ invece non soltanto l’ha
mantenuta nell’antico senso, ma da essa anzi deduce il disegno e il piano dell’intero sistema etico”.405 Ancora
di più, nella “Nicomachea” Aristotele non adotta più la bipartizione delle virtù in “etiche” e “dianoetiche” e
identifica la trattazione delle prime con la teoria sulla virtù e quella delle seconde con la teoria sulla felicità.
Nell’”Eudemea”, Aristotele considera la “phronesis” l’espressione più propria dell’intelletto, che, nello
stesso tempo, coglie il principio divino, come oggetto della scienza contemplativa, e il criterio fondamentale
dell’agire morale. La conoscenza metafisica del bene è considerata il presupposto della consapevolezza
dell’agire pratico. Invece, nella “Nicomachea”, la “phronesis” è intesa come la fondamentale attitudine alla
“pratica” razionale, per il cui sviluppo non è più ritenuta indispensabile la conoscenza contemplativa del
bene come principio ontologico. Questa conoscenza superiore, che è attinta solo da pochi, non riguarda,
dunque, la vita pratica, alla quale viene riconosciuta, dunque, una sua autonomia, basata anche su un
principio che è inteso come proprio della “ragione pratica” (in un senso simile a quello kantiano), e che è
identificato proprio con la “phronesis”. Questa, perciò, non è intesa più come la contemplazione del
404
Lo Zeller così riassume efficacemente il pensiero di Aristotele a questo riguardo: “In senso proprio, la felicità
dell’uomo consiste nell’attività virtuosa, ovvero, dato che sono numerose le attività di questo genere, nella più alta e
nella più perfetta di esse. E questa è l’attività della pura mente, il pensiero. Quest’ultimo, infatti, è l’espressione della
più nobile facoltà dello spirito, ed è diretto a ciò che è più alto; può essere interrotto meno di ogni altra attività, e
garantisce il godimento più alto; è il meno dipendente di aiuti di altro genere e da sussidi esterni; ha il suo fine e il suo
oggetto in se stesso, e viene valutato puramente per se stesso; in esso l’uomo trova la pace, mentre quando è occupato
nella guerra o nella politica, come in generale nella vita pratica, insegue incessantemente dei fini che sono estranei alla
sfera d’attività d’esso. La ragione è il divino in noi, è la vera essenza dell’uomo: solo la pura attività della ragione può
corrispondere perfettamente alla natura dell’uomo, ed essa soltanto può dargli una soddisfazione illimitata, e sollevare
la sua natura oltre i confini dell’umanità, fino alla divinità. Ad essa segue immediatamente l’attività morale, che
rappresenta quindi il secondo elemento essenziale della felicità; mentre però ciò che è agente nel pensiero è l’elemento
divino dell’uomo, che può esser detto sovrumano, la virtù etica va considerata invece il bene profondamente umano”
(La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, II, VI, tr. it., pp. 8-12).
405
W. Jaeger, Aristotele, pp. 317-18.
principio divino o come la filosofia stessa, bensì viene trasferita sul piano della vita pratica e ne costituisce il
presupposto razionale.406
La concezione del primato della vita contemplativa appare anche nel libro X della “Nicomachea”. A tale
proposito, M. L. Tatarkiewicz (1931) ha sostenuto che la “Nicomachea” contiene tre diverse etiche: una della
vita contemplativa, fondata sull’intelligenza ed espressa dal libro X, una della vita attiva secondo il principio
del “giusto ezzo”, fondata sulla volontà ed espressa dai libri I-IV, una morale, infine, dell’amicizia, fondata
sul sentimento ed espressa dai libri VIII-IX. A. Gauthier e J. Y. Jolif hanno sostenuto, invece, che per
Aristotele la vita ideale non è tanto la contemplazione della verità, quanto “una vita mista, che unisce
inseparabilmente azione morale e contemplazione”.
In ogni modo, Aristotele considera come attività propriamente umana quella razionale. Il grado massimo
di tale attività si ha nello svolgimento del puro pensiero; ma è meritevole di attenta valutazione anche
l’attività pratica dominata dalla ragione. 407
La “Poetica” di Aristotele e la sua fortuna nella storia dell’estetica
La “Poetica” di Aristotele rappresenta una delle opere più ampiamente conosciute e che hanno ispirato la gran parte
delle riflessioni sull’arte. L’arte rappresenta il “verosimile”, a differenza della “storia”, che rappresenta il “vero”. Nella
rappresentazione artistica si distingue il genere “epico”, in cui i personaggi intervengono direttamente coi oro discorsi,
intercalandoli tra le parti narrative. La “tragedia”, invece, introduce solo dialoghi tra i personaggi; essa perciò è adatta
alla rappresentazione teatrale, per cui deve rispettare alcune regole che riguardano appunto la tecnica della
rappresentazione. Tali regole riguardano, in particolare, le linee unitarie alle quali devono sottostare le vicende, per la
difficoltà di cambiare le scene: Le famose “unità di tempo, di luogo e d’azione” furono teorizzate specialmente nel
Cinquecento, in rapporto alle esigenze avanzate da Aristotele. L’opera aristotelica conteneva probabilmente anche la
trattazione relativa alla poesia lirica.
La formazione del pensiero di Aristotele
Nella formazione della personalità di Aristotele è fondamentale il periodo in cui egli rimase alla scuola di
Platone, dove giunse diciassettenne nel 367 e si trattenne un ventennio, fino al 347 (l’anno stesso della morte
di Platone). In quel periodo Platone stesso procede a un ampio ripensamento critico della sua dottrina,
specialmente della teoria delle idee. Infatti, a cominciare dal Parmenide, questa teoria è sottoposta a una serie
3 Come osserva lo Jaeger, nell’”Eudemea” Aristotele “è assai lontano da questo atteggiameto conciliante rispetto a
ciò che Platone chiama morale borghese (‘demosìa areté’). “In essa la ‘phronesis’ è ancora, in forma del tutto esclusiva,
la contemplazione dell’’arché’ divina, e senza di essa non è possibile azione morale. […] Il valore assoluto, o bene
supremo, che la ragione conosce, è Dio; e questi non è da concepire come legislatore e ordinatore, come dover essere e
volontà, ma come supremo essere riposante in se stesso. La volontà e il ‘comando’ sorgono solo nella ragione in quanto
essa si immerge nella contemplazione di questo essere. Sommo dovere morale è perciò la scelta di tutte quelle
occupazioni e azioni, e l’acquisizione di tutti quei beni, che promuovono la conoscenza di Dio: la filosofia teoretica è la
via per l’educazione morale dell’uomo” (Aristotele, pp. 318 sgg.). In questo senso, Aristotele sarebbe ancora
essenzialmente “platonico”, ponendo il fine dell’uomo nella conoscenza del Bene sommo, cioè di Dio stesso.
“Moralmente cattivo e riprovevole è invece tutto ciò, possesso e attività che sia, che impedisce all’uomo di servire e
conoscere Dio. La conclusione dell’‘Eudemea’ è il documento classico della moralità teonoma, nel senso datole dal
vecchio Platone. Dio è la ‘misura’ di tutte le cose. Salvandola dal naufragio della dottrina delle idee mercé il
trasferimento nella sua etica, Aristotele ha la coscienza di conservare il nucleo duraturo della moralità platonica: cioè il
concetto della norma assoluta e la trascendenza metafisica del bene” (Ibid., p. 327).
407
Come osserva lo Zeller, “Aristotele dice che gli dèi amano soprattutto chi vive razionalmente, poiché si rallegrano
di ciò che ad essi è affine; se gli dèi si occuperanno degli uomini lo faranno soprattutto di chi vive razionalmente, e se
mai faranno un dono, sarà quello della felicità” (Op. cit., p. 14, nota 28). Riguardo, poi, al piacere come componente
della vita etica, lo Zeller osserva: “Aristotele ritiene che il piacere sia un elemento della felicità, e lo difende dalle
accuse che gli avevano rivolto Speusippo e Platone. Ed il suo atteggiamento ha radice in una diversa concezione della
natura del piacere. Platone lo aveva inserito nell’ambito del divenire, dell’essere indeterminato ed aconcettuale; per
Aristotele esso è invece il compimento naturale di ogni attività, il risultato che è legato ad ogni attività giunta a
conclusione, con la stessa necessità con cui la bellezza e la salute sono poste nel concetto di un corpo che abbia tutte le
sue caratteristiche naturali; non è insomma un divenire di un movimento, ma il fine nel quale ogni movimento vitale
trova conclusione. Quanto più nobile è una attività, tanto più alto è il piacere, e la beatitudine di Dio non è altro che il
piacere che scaturisce dall’attività più perfetta” (Op. cit., pp. 14-16).
di revisioni, che sono testimoniate dai dialoghi successivi e che, infine, conducono il filosofo a modificare il
complessivo quadro teorico del suo pensiero, secondo quanto è attestato da Aristotele. Platone avrebbe ora
elaborato la “dottrina dei principi”, secondo la quale si avrebbe la deduzione delle idee dai due principi
fondamentali, l’Uno e la Diade, dai quali deriverebbe la serie delle idee-numeri (prodotte dalla
determinazione dell’Indeterminato da parte dell’Uno), e da queste deriverebbero le idee-modelli, sulle quali
sarebbero costituiti gli enti reali. Questo orientamento riflette una nuova esigenza teorica, dominata
ampiamente dall’istanza matematica: infatti, mentre precedentemente il mondo delle idee è organizzato a
partire dall’idea del Bene(e dunque in rapporto a un significato essenzialmente morale e a un’esigenza eticopoliitca), ora il principio dell’organizzazione è ricercato nella direzione pitagorica che propone l’ordine
dell’universo come area dell’investigazione scientifica esatta. E’ indicativo che in questo periodo
un’importanza sempre maggiore è assunta dall’astronomia, tanto che nelle Leggi questa è considerata come
un presupposto indispensabile per la realizzazione del nuovo più realistico progetto politico, in rapporto al
quale l’architettura dell’universo appare sempre di più come il modello di ogni ordinamento (e di ogni
legislazione).
Questo orientamento verso il problema della spiegazione della struttura dell’universo trova Aristotele
particolarmente disposto a ricercare una via propria di sviluppo dello stesso platonismo. Noi oggi sappiamo
che la forma attuale del sistema delle opere aristoteliche è in gran parte il risultato dell’intervento degli
editori antichi, principalmente del famoso Andronico di Rodi, che operò poco dopo la metà del I secolo a. C.
Costui inserì nel “corpus aristotelicum” anche appunti di lezioni su argomenti trattati nei libri già scritti con
una originaria struttura sistematica e in modo da ottenere trattazioni complete intorno alle grandi aree della
filosofia secondo la ripartizione ellenistica (logica, fisica, etica). Così i trattati aristotelici che noi possiamo
leggere probabilmente non furono scritti da Aristotele in quella forma e in quell’estensione che essi ora
presentano. Questo intervento editoriale dovette essere più o meno rilevante per le diverse opere; comunque
un esempio tipico è costituito dalla Metafisica.
Il distacco dall’ontologia platonica è compiuto da Aristotele attraverso un lavoro di riflessione nell’ambito
più propriamente logico-dialettico. Aristotele si occupa probabilmente di problemi dialettici: ne è
testimonianza proprio un manuale di dialettica, i Topici, risalente agli ultimi anni dell’Accademia (dunque la
più antica tra le opere esoteriche). In quest’opera vediamo che la dottrina delle categorie nasce sul piano
della “diairesis”, dell’analisi dei concetti e dall’esame delle modalità di connessione dei concetti nei diversi
possibili tipi di discorso. Aristotele scopre che alcuni termini non possono fungere da predicati nelle
proposizioni; perciò tali termini, che possono avere solo la funzione di soggetto, sono le sostanze,
corrispondenti a entità che sussistono per sé. D’altra parte, l’esame delle modalità della predicazione
conduce Aristotele a scoprire che vi sono termini generalissimi, che non possono essere ulteriormente
compresi in concetti più vasti, e che essi indicano le modalità generali della predicazione: perciò egli chiama
tali termini categorie. Aristotele scopre, quindi, che le “specie” e i “generi” possono avere la funzione sia di
soggetti che di predicati: e questi termini egli indica come “sostanze seconde”. Appare evidente che le
“sostanze prime” sono gli individui, gli enti forniti di esistenza e realtà proprie, mentre “sostanze seconde”
sono i generi e le specie. Queste ultime non hanno realtà indipendente, ma concorrono a costituire la realtà
delle prime: esse, cioè, esprimono modalità d’essere e non l’essere sostanziale vero e proprio, la cui
caratteristica è l’esistenza.
In tal modo Aristotele perviene alla conclusione che l’essere assume diverse modalità, tra cui quelle della
“sostanza prima”, della “sostanza seconda” e della “categoria” costituiscono le principali. In particolare, egli
può sviluppare la critica radicale delle idee platoniche, concepite come sostanze, essenze reali. Le idee
esprimono modalità dell’essere, non costituiscono entità concrete; sono “universali” (come i generi e le
specie; oggetto di comprensione concettuale) ma non hanno realtà
CAPITOLO VIII
La filosofia nell’età ellenistica. L’epicureismo
La tradizione delle antiche scuole filosofiche
Le scuole socratiche minori. Le scuole cirenaica, megarica, cinica continuarono la loro attività nell’età
ellenistica: le prime due hanno i loro ultimi sviluppi e i loro rappresentanti sono in rapporto coi fondatori
delle scuole scettica e stoica ; la scuola cinica esercita il suo influsso sulla formazione della dottrina stoica e
dall’inizio dell’era volgare fino al VI secolo d. C. prosegue la sua attività proponendo la sua predicazione
morale e il suo modello di pratica di vita.
L’antica Accademia. A) Speusippo successe a Platone nella guida della scuola, accentuando la tendenza
pitagorizzante e matematizzante: con lui operarono: Filippo di Opunte, che curò la pubblicazione delle Leggi e
scrisse l’appendice a quest’opera, l’Epinomis, in cui troviamo lo sviluppo di una mistica del numero e di una
teologia astrale; Eudosso di Cnido, che fu un eccellente astronomo e in etica sostenne l’edonismo; Eraclide
Pontico, figura di scienziato e mistico, ritenuto da alcuni il primo sostenitore dell’eliocentrismo. Speusippo e i
suoi seguaci, secondo quanto riferisce Aristotele,408 posero solo gli enti matematici, oltre i sensibili,
rinunciando al numero ideale (e affermando solo i numeri matematici, addizionabili e ricavabili gli uni dagli
altri per via di operazioni aritmetiche). Speusippo mise, però, in rilievo la perfezione della decade.409
B) Senocrate di Calcedonia successe a Speusippo nella direzione dell’Accademia (339-314 a. C.) e continuò
nella tendenza pitagorizzante, ammettendo, però, a differenza del suo predecessore, i numeri ideali, coi quali
identificava gli stessi numeri matematici.410 Egli ammise, dunque, tre sostanze: quella sensibile, che
appartiene alle cose del mondo, quella intelligibile, che è propria degli enti che sono oltre la sfera celeste,
quella opinabile, che riguarda gli enti situati in questa sfera e che sono visibili per il senso e intelligibili per
l’astrologia.411 Inoltre insisté sulla dottrina platonica dei principi, sviluppandola in senso astrologico e
teologico.412 Per Sencrate l’essenza dell’anima è il numero stesso, che si muove da sé.413
Il successore di Senocrate, Polemone (314-270 a. C.) si rivolse particolarmente a problemi etici; dopo di lui
Cratere fu l’ultimo scolarca della vecchia Accademia; con Arcesilao, che gli successe, cominciò la nuova, nella
quale si affermò una tendenza scettica.
La scuola peripatetica. A) Teofrasto (di Lesbo, che diresse il Liceo dal 322 al 287 a. C.) promosse un’intensa
attività scientifica, approfondendo motivi nuovi specialmente nel campo della logica, della storia naturale,
della psicologia (fondamentale è la sua opera Sui caratteri). A Teofrasto va il merito di avere sviluppato
l’esposizione sistematica delle opinioni dei filosofi naturalisti, da Talete a Platone e Senocrate. I doxografi
posteriori attinsero tutti dall’opera teofrastea (sicché dai resti di quelle raccolte – ordinati da Diels,
Doxographi graeci - si può ricostruire in parte la fonte originaria).
Di storia delle scienze si occuparono anche Eudemo di Rodi (per le matematiche e l’astronoia) e Menone
(per la medicina).
B) Aristosseno (di Taranto) e Dicearco (di Messina) sono ricordati da Cicerone per essere negatori di
un’anima immortale.414
408
Metafisica, 1086 a.
Cfr. Speusippo, fr. 4.
410
Cfr. Aristotele, Met., 1086 a.
411
Cfr. Sesto Empirico, Adv. math., VII, 147.
412
Cfr. Stobeo, Ecl., I, 29: “La monade e la diade chiama divinità, l’una avente, per la sua natura maschile, l’ufficio
di padre [degli dèi], imperante ne cielo, e lo chiama anche Giove e dispari e Marte,ed è per lui il primo; l’altra per la
natura femminile avente l’ufficio di madre degli dèi, governante la regione subceleste, ed è per lui l’anima
dell’universo; dio è per lui anche il cielo, e dèi olimpici gli astri luminosi e altri demoni invisibili sublunari; e crede
anche di estenderli agli elementi della materia”.
413
Plutarco, De an. Procr,, I, 5, 1012.
414
Cicerone, Tusc. disp., I, 19, 21: “Aristosseno, musico e anche filosofo, disse che le tensioni del corpo stesso sono
una specie di anima, come nel canto e nel suono della cetra quella che si dice armonia; così dalla natura e
configurazione di tutto il corpo sono suscitati i vari moti, siccome i suoni nel canto. Dicearco poi fa sostenere dal suo
409
C) Stratone (di Lampsaco, discepolo e successore di Teofrasto nella direzione del Liceo) accentuò la
tendenza al naturalismo materialistico.415
I successivi rappresentanti della scuola hanno scarso rilievo e infine il lavoro che vi si svolse riguardò
specialmente l’ordinamento e la pubblicazione delle opere di Aristotele: in questo campo fondamentale è
stata l’opera di Andronico di Rodi (tra il 70 e il 50 a. C.). Nel I e II secolo d. C. si sviluppò l’opera dei
commentatori: il più notevole commento è quello di Alessandro d’Afrodisia:
L’epicureismo
Il compito della filosofia, per Epicuro,416 è quello di condurre l’uomo alla felicità, liberandolo, in primo luogo, dalla
paura degli dèi della morte, nonché dalle passioni e dalle cure della vita, riportandolo, così, a una condizione d’esistenza
serena, confortata dai piaceri stabili e dalle gioie dell’amicizia. Tutti i fenomeni e gli accadimenti sono processi di
aggregazione e disgregazione degli atomi, che sono l’unica realtà esistente. Gli dèi hanno una natura propria, tale da
escluderli interamente dalle vicende di continua trasformazione della materia e da assicurare ad essi una condizione di
beatitudine e di indifferenza, in zone che si estendono tra gli universi fisici e che non interferiscono con essi.
Il compito della filosofia
La filosofia è la via che conduce alla felicità: infatti, per Epicuro, prima condizione per conseguire una vita
felice è la liberazione dalle paure indotte dalle false credenze negli dèi avversi e nelle pene riservate dopo la
morte. La conoscenza è vista nella sua portata liberatrice: essa concorre a liberare l’uomo dalle passioni, dai
turbamenti e dalle paure.417 La conoscenza si presenta, dunque, come il quadrifarmaco che guarisce dai
quattro fondamentali tipi di errori, che sono fonte di inquietudine e di angoscia. In primo luogo, essa
insegna che non bisogna avere nessun timore degli dèi: la divinità, infatti, è “incorruttibile e beata”,418 estranea
a “faccende, cure, ire e benevolenze”419; in secondo luogo non bisogna avere nessuna paura della morte.420
oratore che non esiste affatto l’anima e che questo è un nome del tutto vuoto, e che è vano parlare d’animali, perché non
esiste animo o anima né nell’uomo né nelle bestie. Tutta quella forza, per cui operiamo e sentiamo alcunché, è
ugualmente diffusa in tutti i corpi viventi, e non è separabile dal corpo, come quella che non esiste e non è altro che il
corpo unico e semplice, configurato per modo, da aver forza e sensibilità per temperamento naturale”.
415
“Stratone, detto il fisico, crede che tutta la forza divina sia collocata nella natura e ha in sé le cause della
generazione, dell’accrescimento e della diminuzione, ma sia priva di ogni coscienza e figura” (Cicerone, De natura
deorum, I, 35). “Egli rifiuta di servirsi dell’opera degli dèi per fabbricare il mondo […]. Qualsiasi cosa esista o nasca
insegna che è o è stata fatta dai pesi e moti naturali” (Cicerone, Acad., II, 121).
Anche gli atti dell’anima
(dell’intelletto) per Stratone sono movimenti, poiché “sempre nell’atto del pensare come del vedere e udire e operare si
ha un movimento” (Simplicio, Phys., 965, 7). L’anima si muove da sé e i suoi atti sono forme di movimento.
416
Epicuro, di Samo, scolaro del democriteo Nausifone e del platonico Panfilo, fondò la sua scuola ad Atene nel 306
a. C., esercitando, quindi, un grande ascendente sui discepoli, specialmente per il modello di vita serena e di saggezza
che egli riuscì a incarnare. Dei circa 300 scritti che gli sono attribuiti a noi restano le Lettere, il Testamento e le
Massime capitali (conservate da Diogene Laerzio), frammenti dell’opera Sulla natura, estratti dai papiri di Ercolano, le
sentenze del “Florilegio vaticano” e pochi altri frammenti. Alla scuola epicurea, che si protrasse fino al IV secolo d.
C..; appartennero Filodemo di Gadara (I secolo a. C.) e Diogene di Encanda (200 d. C.). Ma tra i seguaci di Epicureo il
più famoso è indubbiamente Lucrezio, che nel suo poema De rerum natura ha dato a quella dottrina una sublime veste
poetica. Per Lucrezio, Epicureo è il grande scopritore dei miseri della natura, colui che con la sua mente è riuscito a
“infrangere per primo i serrati baluardi delle porte della natura” e “riuscì a percorrere lontano le fiammanti mura del
mondo e tutto l’infinito con la mente e con l’animo; onde a noi vittorioso egli riporta che cosa possa nascere e che cosa
non possa, e per quale ragione a ciascun essere spetti infine limitato potere e un termine piantano nella profondità delle
cose” (De rerum natura, I, 56-79).
417
Cfr. Epistola a Pitocce, 85, 87. “Se non ci turbasse il pensiero delle cose celesti e quello che la morte sia qualcosa
per noi e il non conoscere i limiti dei dolori e dei desideri, non avremmo bisogno della scienza della natura” (Massime
capitali, 11). “Non può sciogliere la paura per ciò che ci sta più a cuore chi non sappia qual è la natura del tutto e stia
coll’ansia delle favole mitiche. Sicché non si può senza la scienza della natura godere piaceri schietti” (b., 12).
418
Epistola a Meneceo, 123.
419
Epistola a Erodoto, 177. “L’essere beato e immobile non ha per sé né porta ad altri molestie, né è posseduto da ire
e benevolenze; ché ogni cosa di tal genere appartiene al debole” (Massime capitali, 1).
420
“Avvezzati a pensare che nulla è per noi la morte; perché ogni bene e molestia è nel senso, e la morte è privazione
di senso […[. Il più orrendo dei mali, dunque, la morte, è nulla per noi; e quando la morte c’è, allora non eistiamo noi
[…]. Sicché è sciocco chi dice di temere la morte, non perché sopraggiungendo gli porterà dolore, ma perché la
Inoltre è da considerare che il piacere, come assenza di dolore, è facile a procurarsi e il limite di esso può essere
agevolmente colmato; il che vuol dire che facilmente, in ogni situazione di dolore, si può ristabilire una
situazione di piacere.421 Infine è da considerare che il dolore è di breve durata.422 Il sapiente, che è consapevole
di queste fondamentali verità, non si lascia turbare dai fattori esterni e dagli accidentali momenti di dolore e
raggiunge una condizione di piena autonomia, che gli consente di bastare a se stesso. La conoscenza ha una
funzione etica decisiva: il sapiente è veramente libero.
Il metodo empirico
Nel “Canone” Epicureo tratta del criterio di verità e del metodo della scienza. Egli ammette come criteri
del vero ed elementi certi della conoscenza le sensazioni, le “prenozioni” e ciò che da esse si deduce. La
sensazione è assunta a fonte di ogni conoscenza. Non c’è nulla che possa confutare le sensazioni.423 La teoria
fisica atomistica spiega il processo delle sensazioni con la teoria degli effusivi.424 E’ l’effluvio di atomi che
forma le immagini degli oggetti, attraverso l’incontro (e la sintesi) con l’analogo effluvio che proviene
dall’organo di senso.425 Dalle sensazioni si formano le prenozioni, che sono concetti o nozioni universali (ad
esempio, il concetto di “uomo”). In base a queste ci orientiamo nelle successive sensazioni, distinguendo le
cose le une dalle altre.426 Si formano quindi le opinioni, che sono conoscenze che gli epicurei chiamano anche
“presunzioni” e che hanno bisogno di essere confermate (verificate rispetto alla loro validità conoscitiva).427
Dalla constatazione dei fenomeni si può passare a fare congetture intorno a ciò che sfugge alla sensazione,
“purché si sappia dal ragionamento trarre conclusioni in accordo coi fenomeni”.428 Comunque la sensazione
deve costituire il fondamento per procedere all’induzione di verità intorno a ciò che non cade nell’orbita
della percezione. Le verità indotte in conformità con l’esperienza sono certe.429 La conoscenza, comunque, è
limitata alla sfera della natura ed è da escludersi qualsiasi conoscenza intorno al divino e al soprannaturale.
E intorno alle cose naturali si possono dare spiegazioni molteplici (nell’ambito del verosimile), cioè possono
essere formulate ipotesi di spiegazione provvisorie (da considerare valide finché non siano provate come
erronee).430
Il modello epicureo dell’esistenza umana.
semplice previsione di essa è causa di dolore: giacché ciò che non turba quando è presente, ci duole nell’attesa” (Ep. A
Men., 135).
421
“Limite della grandezza dei piaceri è la detrazione di ogni dolore. E dove sia il piacere, fintanto che c’è, non c’è
dolore del corpo o dell’animo o di entrambi” (Massime cap., 4; cfr. Ep. a Men., 135).
422
“Non ha durata continua il dolore nel corpo; ma il massimo resta per minimo tempo, e quello che appena supera il
piacere nella carne non vi rimane molti giorni. E le lunghe malattie hanno più abbondanza di piacere che di dolore nel
corpo” (Massime cap., 4; cfr. Ep. a Men., 153).
423
“Né infatti la sensazione omogenea confuta l’omogenea, essendo di pari valore; né l’eterogenea l’eterogenea, non
essendo giudici delle stesse cose; né una confuta un’altra, perché a tutte ci atteniamo; né la ragione, ché ogni ragione
dipende dai sensi” (Diogene L., X, 31-32).
424
“Dalla superficie dei corpi parte un effluvio continuo, che non si manifesta con una diminuzione [degli atomi] in
quanto è compensato da un afflusso, e conserva per molto tempo la posizione e l’ordine degli atomi del corpo solido”
(Ep. a Er., 48).
425
“Queste immagini chiamiamo simulacri […] e da oggetti uguali ad esse in colore e in forme, secondo la rispettiva
grandezza ci entrano negli occhi e nella mente [..]. E la rappresentazione che cogliamo […] è questa forma del corpo
solido. E la somiglianza delle immagini […] con le cose che diciamo reali e vere non ci sarebbe, se non ci fossero
emanazioni così fatte” (Ib.,, 49-51). Data l’infallibilità della percezione, la possibilità dell’errore non sta in essa, bensì
nel giudizio (cfr. ib., 52).
426
“E non potremmo cercare quel che cerchiamo se non lo conoscessimo già, per esempio chiedendo se quello laggiù
è un cavallo o un bue; e non potremmo nominare alcunché non sapendone già prima per prenzione il tipo. Le prenozioni
sono dunque di per sé evidenti” (Diogene L., X, 34).
427
Così, se l’opinione “è confermata e non smentita da testimonianza, è vera; se non è confermata ed è smentita, è
falsa” (Diogene L., X, 54).
428
Ep. a Pit., 104, 112.
429
“E’ vero tanto ciò che vediamo con gli occhi, quanto ciò che cogliamo con l’intuizione mentale” (Ep. a Er,, 62).
430
“Si acquista dunque tranquillità su tutti i problemi risolti col metodo della molteplicità (delle cause possibili) in
accordo coi fenomeni, quando si lascino sussistere doverosamente le spiegazioni convincenti; quando invece si ammetta
una e si escluda l’altra, ugualmente consona al fenomeno, è evidente che si esce da ogni ricerca naturalistica e si scivola
nel mito” (Ep. a Pit., 87).
La filosofia di Epicuro costituisce un sistema organico e coerente, in cui la canonica (teoria della
conoscenza), la fisica e l’etica si intrecciano insieme in un’unità di pensiero, il cui scopo è quello di delineare
un modello di vita pratica. La ricerca della verità è vista come la condizione essenziale per la realizzazione di
una forma di vita conforme al fine dell’uomo e la conoscenza rispondente a questo fine è quella il più
possibile aderente ai dati dell’esperienza e libera da elementi immaginari e da arbitrarie deduzioni. Perciò
Epicuro si è proposto, in primo luogo, di liberare la scienza della natura dai numerosi motivi mitologici, che
finivano per ricondurre la struttura dell’universo e la stessa spiegazione dei fenomeni a cause soprannaturali
e divine, con ripercussioni notevoli sul comportamento quotidiano degli uomini. Una corretta
interpretazione della natura è la premessa fondamentale per una giusta valutazione dei compiti e delle scelte
da parte dell’individuo, che deve, innanzitutto, conseguire una adeguata consapevolezza intorno al posto
dell’uomo nell’universo. La consapevolezza che tutto, nella natura, procede secondo un corso che è
essenzialmente determinato dal movimento degli atomi e dal quale è escluso qualsiasi intervento estraneo,
rappresenta la condizione imprescindibile per lo sviluppo di un atteggiamento di serena accettazione degli
eventi naturali. Nessun imprevedibile elemento soprannaturale può mutare il naturale processo di
produzione dei fenomeni; e dal corso della natura è esclusa ogni provvidenza che sia orientata verso un fine
a noi oscuro. Perciò le cause vanno ricercate nella stessa dinamica dei processi fisici, che, a sua volta, va
ricondotta alle mutazioni che intervengono nel movimento degli atomi e, dunque, all’interno dei complessi
in cui questi sono intrecciati. L’intero divenire è costituito dal continuo mutare delle forme in cui gli atomi
sono aggregati. Perciò la scienza della natura non deve essere costruita sulla base di supposte cause finali o
di strutture disposte da una intelligenza ordinatrice, bensì deve essere sviluppata attraverso l’osservazione
accurata dei fenomeni e la formulazione di ipotesi esplicative di volta in volta verificate attraverso il
confronto coi dati empirici. In questo modo, si può dire che Epicuro abbia contribuito decisamente alla
definizione del concetto di scienza empirica (o positiva). Come sappiamo, infatti, questo concetto qualifica
ancora questo tipo di conoscenza, distinguendolo da ogni altro.
Un altro fondamentale elemento è costituito, secondo Epicuro, dalla consapevolezza del potere che è dato
all’uomo di definire il proprio comportamento e di delineare il proprio stile di vita. In questo senso,
acquistano un notevole rilievo le riflessioni sulla libertà umana, sviluppate sulla base della stessa
interpretazione scientifica della natura. I movimenti degli atomi che costituiscono l’anima sono in gran parte
in nostro dominio e sono orientati dalla volontà. La stessa costruzione dell’io libero dipende dalle scelte del
soggetto. Secondo Epicuro, infatti, ad ogni moto dell’anima si accompagna un atto di scelta volontaria: sia
che il soggetto riceva un’impressione dal mondo esterno, sia che elabori una rappresentazione, sia che si
trovi mosso da una passione, egli si pone di fronte all’evento che lo coinvolge con un atteggiamento che è il
risultato della sua scelta: egli, cioè, accetta o si oppone o cerca di modificare la situazione in cui si trova.
Un terzo elemento importante per la definizione del modello epicureo della vita felice è costituito dalla
corretta rappresentazione della divinità. Epicuro, a questo proposito, sollecita una vera e propria riforma
nell’ambito dell’esperienza religiosa tradizionale. Egli arriva a dire che “empietà” non è non venerare gli dèi
della tradizione ma, anzi, credere in quelle divinità che presentano caratteri simili a quelli degli uomini e che
sono dispensatori di beni e di mali. La religione basata sulla credenza in quelle divinità era considerata da
Epicuro una semplice superstizione.431
Questi elementi non solo rappresentano un complesso di conoscenze rettamente elaborato ma anche le
condizioni per un’esistenza appropriata e conforme alla naturale inclinazione dell’uomo. Si tratta
dell’apporto della filosofia a quella vita che Epicuro non esita a definire “beata”, allorché la indica come lo
scopo proprio del sapere filosofico.432 Il “quadrifarmaco” esprime sinteticamente questo scopo della filosofia,
che è un vero mezzo di liberazione dell’uomo dalla cure vane e dalle false opinioni e di attuazione della sua
essenza più propria.433 Lo scopo è l’attuazione della vita felice, che è quella “saggia, bella e giusta”, tanto che
non si può concepire la felicità senza sapienza e giustizia e bellezza.434
431
Perciò si giustifica l’esaltazione lucreziana di Epicuro come liberatore dalla falsa religione che ancora divinizzava
aspetti della natura come gli astri.
432
Sesto Empirico, Adv. Math, XI 169 (fr. 204 Arr.): “Epicuro diceva: ‘La filosofia è un’attività che con argomenti e
discussioni rende la vita beata”. Cfr. anche Porfirio, Ad Marcellam (fr. 247 Arr.): “E’ vano il discorso di quel filosofo
che non guarisce le passioni umane. Come infatti la medicina non giova a nulla se non guarisce il corpo dalle malattie,
così anche la filosofia non giova a niente, se non caccia la passione dall’anima”. Cicerone, De finibus, I 21, 71: “Se
[Epicuro] ti sembra poco colto, questo è il motivo: egli ritenne che nessuna cultura esiste, tranne quella che giova ad
apprendere a vivere beatamente”.
433
Ratae Sententiae, I-IV: “L’Essere beato e indistruttibile, non ha egli, né reca ad altri, affanni; non l’occupa dunque
ira, né benevolenza, perché tali turbamenti non sono nel debole. / Nulla è per noi la morte; infatti ciò che è disciolto è
L’ideale epicureo della vita felice comprende, dunque, come sue componenti essenziali, in primo luogo la
conoscenza vera della natura, dell’uomo e della divinità,435 quindi le virtù,436 e in particolare la giustizia
come retto atteggiamento nei confronti degli altri e delle cose,437 e, perciò, la bellezza, in quanto ciò che è
buono e anche bello, secondo una convinzione radicata nello spirito greco.438 Non è, perciò, assolutamente
fondata ogni interpretazione dell’epicureismo come teoria del godimento materiale e sensuale.439 Si può dire,
piuttosto, come nota ancora il Bignone, che l’etica epicurea sia una delle più severe nella condanna del
semplice piacere effimero: in questo senso, siamo, ad esempio, agli antipodi rispetto all’etica del godimento
immediato, qual è quella esemplificata, in epoca più vicina a noi, nella figura del Don Giovanni.440 Il motivo
dominante della dottrina di Epicuro, infatti, non è la ricerca del godimento, ma quella della serenità dello
spirito, della pace interiore e dell’amicizia concorde.441 La polemica più vivace è condotta proprio contro la
insensibile, e l’insensibile è nulla per noi. / estremo limite, in grandezza, dei piaceri è la detrazione di tutto il dolore. E
ovunque è piacere, e finché perdura, non v’è dolore dell’animo o del corpo o d’entrambi. / non perdura continuamente
nella carne il dolore, ma il massimo permane minimo tempo, e non persiste molti giorni quel soffrire che appena si
sovrappone al piacere corporeo: anzi le lunghe malattie più hanno abbondevole il piacere del corpo che la doglia” (tr.
Bignone). Cfr. Cicerone, De finibus, I, 19, 62: “In tal modo Epicuro rappresenta il sapiente sempre felice, quel sapiente
che pone limiti ai suoi desideri, non si cura della morte, scorge la verità circa gli dèi immortali senza timore alcuno, non
esita, se sia miglior partito, ad uscir di vita. Dotato di queste qualità, vive in perpetuo piacere. Invero, non vi è momento
in cui il sapiente non provi più piacere che dolore: giacché, mentre ha grato ricordo del passato, si rende padrone del
presente, sì da intendere quanto importante e piacevole esso sia; né vive in funzione del futuro ma lo attende, godendo
del presente” (Cfr. L. Massa Positano, Epicurea, cit., pp. 281-82).
434
Ratae Sententiae, V. Cfr. Cicerone, De finibus, I, 18: “Epicuro proclama che non si può vivere beatamente senza
vivere in sapienza, onestà e giustizia”.
435
Ib., I 14, 46: “Se noi vediamo che tutta la vita è sconvolta dall’errore e dall’ignoranza e che la spienza è la sola che
ci difenda dall’impeto delle brame e dal timore delle cose paurose che ci sovrastano, la sola che insegni a sopportare
con calma le offese della stessa sorte, mostrando tutte le vie che conducono alla quiete e alla tranquillità, quale motivo
ci tratterrà dall’ammettere che la sapienza va ricercata per i piaceri che procura e l’insipienza fuggita per gli affanni che
arreca?” (Cfr. L. Massa Positano, Epicurea, cit., p. 277).
436
Epicuro segue sostanzialmente la definizione aristotelica della virtù come abito di comportamento improntato ai
princìpi della ragione. Così, per la temperanza, cfr. Cicerone, ib., I, 14, 47: “La temperanza è la virtù che ci ammonisce
a seguire la ragione nei riguardi ciò che dobbiamo ricercare o rifuggire. […] Gli uomini, infatti, nella grande
maggioranza, non sanno restar saldi e tener fede alle proprie decisioni e, vinti e fiaccati dall’immagine di quel piacere
che loro si offra, si danno in preda alle passioni senza prevederne le conseguenze […]”. Ib., 15, 49: “Circa la fortezza si
ritroveranno valide le stesse considerazioni. […] Come, infatti, nella vita umana il timore della morte dissolve ogni
stato di serenità, e come è cosa ben misera subire il dolore, lasciandosi ridurre ad una condizione di avvilimento e di
debolezza […], così l’animo forte e superiore è invece libero da inquietudini e da angustie […]” (Ib., pp. 277-78).
437
Cfr. Cicerone, De finibus, 16, 52-53: “Le azioni ingiuste non giovano all’uomo che non sa moderare né le parole
né gli atti: questi non riesce facilmente ad ottenere ciò che si sforza di conseguire, e, se vi riesca, non sa mantenerlo, ché
le risorse della fortuna e dell’ingegno presuppongono piuttosto la liberalità. Chi ne usa si concilia la benevolenza e
l’affetto altrui, che è quanto vi è di più idoneo alla tranquillità della vita specialmente perché viene a mancare del tutto
ogni motivo di peccare. Infatti i desideri che muovono dalla natura si soddisfano facilmente, senza che si commetta
ingiustizia alcuna; […]. E dal commettere ingiustizia nasce più danno di quanto vantaggio non si tragga da ciò che
mediante l’ingiustizia stessa si è ottenuto. Pertanto bene si potrebbe dire che neppure la giustizia è desiderabile per se
stesa, ma perché arreca la massima letizia: giacché è cosa che allieta l’essere oggetto di affetto e di amore, in quanto la
vita ne è resa più sicura e più colma di piaceri” (Ib., p. 279).
438
“L’etica di Epicuro – ha osservato opportunamente il Bignone – formatasi attraverso alla polemica contro le
teorie dell’Accademia del primo Aristotele, dovette trasformare l’antico edonismo in una dottrina di severa ascesi
spirituale, pur nella ricerca del piacere, che viene così prendendo in essa un carattere ben diverso dall’edonismo
cirenaico”.438
439
E’ significativo che ancora l’aggettivo “epicureo” venga largamente usato come sinonimo di “gaudente” e di
“libertino”. Questo significato ampiamente corrente è riportato nel Grande dizionario della lingua italiana di S.
Battaglia (vol. V, Torino 1968), dove alla voce epicureo è detto, tra l’altro: “Che persegue esclusivamente i piaceri
materiali, senza darsi affatto pensiero della vita futura; che è dedito ai godimenti sensuali, specie ai piaceri della mensa;
gaudente, edonista, libertino”.
440
Questa figura rappresenta il principio del piacere come moltiplicazione infinita del desiderio: Don Giovanni è
colui che annulla ogni determinata forma del desiderio e perciò vive in una condizione di estrema fuggevolezza,
assumendo il movimento e il mutamento continuo come unica dimensione dell’esistenza. L’etica epicurea, invece,
riporta il piacere sul piano del permanente, congiungendolo a quei valori che sono elementi e segni di vita perfetta, quali
la verità, la giustizia, la bellezza. Per il giudizio del Bignone, cfr. l. cit.
441
Cfr. Cicerone, De finibus, I, 18, 58: “Invero una città non può essere felice nelle discordie civili, né una casa
quando vi è disaccordo tra i padroni; tanto meno un animo in preda ad intimo dissidio e in disaccordo con se stesso può
concezione del piacere come naturale fonte di inquietudine. La forma di vita che maggiormente occorre
evitare è, in questo senso, quella basata sull’espansione continua del desiderio e sulla ricerca di piaceri più
grandi e più intensi. Epicuro condanna tutte le forme in cui si esprime questo desiderio senza misura, sia
quelle che riguardano i godimenti dei sensi sia quelle che esprimono l’aspirazione alla ricchezza o al potere;
e la ragione di questa condanna sta nel fatto che tali forme di desiderio non consentono all’individuo di
pervenire a uno stato di impertubabilità, poiché esse alimentano quella continua inquietudine che getta
sempre di nuovo l’uomo nell’incertezza e nell’angoscia. L’etica epicurea richiede una certa fuga dal mondo.
Il mondo preme continuamente coi suoi stimoli imprevedibili, desta impressioni nuove, destabilizza ogni
situazione di equilibrio; perciò si tratta di munirsi, per quanto è possibile, di una “medicina” che metta al
riparo da questi assalti inquietanti, che, col miraggio di piaceri inediti, gettano scompiglio e insoddisfazione
in ogni spirito. Il piacere catastematico è quello che deriva da una condizione di stabilità esistenziale, di
dominio del mondo e delle circostanze. Il saggio sa che nessun fattore esterno può intervenire a turbare la
sua calma interiore: egli, infatti, sa che non ha da aggiungere nulla alla sua felicità e che il suo compito è
quello di contemplare l’equilibrio dell’universo e la serena concordia della comunità umana.
Epicuro intende dimostrare che la vita spirituale, in quanto condizione non turbata dalle vicende del
divenire, rappresenta la più alta e pura fonte di piacere. Il piacere vero, cioè, non è quello legato all’effimero,
bensì quello che proviene dalla certezza e dalla sicurezza di trovarsi in una situazione d’esistenza umana
piena e intera. Quando lo stesso ricordo del passato concorre a rafforzare questa sensazione di pienezza
umana e quando l’attesa del futuro è sgombra da preoccupazioni, quando, cioè, l’inquietudine dell’attesa e
la nostalgia del passato si cancellano nella pienezza del presente, si ha il vero piacere.442
L’etica di Epicuro esige una severa disciplina spirituale: essa, in particolare, richiede che non si conceda
nulla all’impressione momentanea, alla passione dell’istante o al godimento immediato, e che, invece, in
ogni circostanza, l’individuo esamini quale bene stabile può derivare dalla sua scelta. E il bene è ciò che
mette lo spirito al riparo dall’inquietudine, dall’ansia e dalla paura. Perciò l’etica epicurea appare come un
rimedio contro alcune malattie dello spirito.443
Per Epicuro, tutto lo sforzo dell’individuo va rivolto verso l’interiorità, verso una “paideia” dello spirito:
l’ideale eudemonistico si trasferisce, ora, dalla vita politica alla realtà della coscienza, la cui condizione è
considerata il solo fattore di vita felice; ma, nello stesso tempo, si delinea un nuovo modello di vita politica,
basato sulla formazione di libere comunità.444
gustare parte alcuna di un piacere limpido e libero: senza dubbio, se preso da passioni, da propositi opposti e in lotta tra
loro, non scorgerà barlume di tranquillità e di pace” (Cfr. L. Massa Positano, Epicurea, cit., p. 281).
442
Cfr. Cicerone, De finibus, I, 18, 60: “Gli stolti non ricordano i beni passati, non godono di quelli presenti: soltanto
i beni futuri aspettano! Ma poiché tali beni sono tutt’altro che sicuri, essi si macerano nell’angoscia e soprattutto si
tormentano nel timore […]”.
443
Cfr. Cicerone, De finibus, I, 18, 59: “Malattie dell’animo sono i desideri smodati e vani delle ricchezze, della
gloria, del potere ed anche dei piaceri dissoluti”.
444
Cfr. E. Bignone, L’Aristotele perduto, II, pp. 233-34: “Non più, come nell’antico ideale greco, la persona umana si
estendeva fino a porsi in armonia con la vita cittadina e politica, foggiando sul proprio carattere l’impronta larga e
comprensiva della città […]. Con Epicuro invece questa bella ed ardua unità dell’ideale antico si veniva sciogliendo. La
vita socievole per lui è un patto necessario ed utile, ma affatto esterno, che risponde a bisogni di sicurezza; ma la vita
ideale del saggio epicureo, non diversamente da quella dei primi cristiani, s’appunta ad una società più ristretta ed
intima, quasi un ricetto in mezzo al mondo, un sodalizio volontario di spiriti che si restringono fra loro, come in un
ritiro, contro ciò che può offendere la tranquillità dell’anima. Così si spiega la fortuna e l’estendersi dell’epicureismo in
un’età che veniva rimutandosi profondamente, ed in cui l’antico cedeva al moderno”. Le ragioni del ripiegamento del
sapiente in se stesso sono da ricercarsi specialmente nel nuovo sistema politico caratterizzato dal tramonto del sistema
delle “poleis” e dalla formazione di stati monarchici caratterizzati dalla concentrazione del potere e dalla netta
separazione tra governanti e cittadini ridotti al rango di sudditi. Come, a questo proposito, rileva M. Isnardi Parente:
“Gli anni dell’Ellenismo nascente sono anni tempestosi e turbinosi, di rapida scesa di monarchi improvvisati e
altrettanto rapido cadere delle loro fortune, di instabilità e insicurezza continua di dominio sui paesi ad essi soggetti; sì
che la politica appare all’uomo di pensiero sotto una luce di particolare tempestosità e precarietà, la vita politica una
situazione di estrema illusorietà e incertezza, il tendere al successo politico una fonte di infiniti e procellosi affanni”
(Introduzione, in Epicuro, Opere, cit., p. 50). Ma l’allontanamento dalla politica attiva non vuol dire, per l’ideale
epicureo della vita, isolamento e rifiuto di ogni società: “Epicuro respinge nettamente la vita del filosofo mendicante ed
errante, lo πτωχεbειν cinico, implicante l’isolamento. Il sapiente vive in una sua società ch’è anch’essa fondata
sull’utilità reciproca, afferma Epicuro contro la concezione platonico-aristotelica dell’amicizia perfetta contrapposta a
quella utilitaristica e volgare; ma su un’utilità di natura superiore. Egli non ammette che vi possa esser un fatto positivo
di ordine sociale che prescinda dall’utile, che non scaturisca dalla matrice dell’utilità; il gruppo dei filosofi raccolti nella
comunità della scuola, ove si dedica insieme allo studio della natura, si gode di serenità imperturbata, si medita sulla
La fisica atomistica
Il principio fondamentale della fisica epicurea è quello dell’eternità e immutabilità della realtà naturale nel
suo complesso: che, cioè, niente viene dal nulla e niente si dissolve nel nulla; che alla base di tutte le
trasformazioni naturali sussistono gli atomi eterni e indistruttibili.445 L’universo fisico è costituito da corpi e
da spazio vuoto. Questo è necessario per il movimento e la stessa sussistenza dei corpi.446 I corpi sono alcuni
composti e altri semplici, cioè alcuni sono aggregati e altri elementi degli aggregati. Questi ultimi sono
indivisibili (atomi) e immutabili: essi costituiscono ciò che sussiste nella dissoluzione degli aggregati; sono,
pertanto, compatti e non si dissolvono.447 Epicureo esclude la “divisione all’infinito in parti sempre minori”,
che porterebbe alla riduzione al nulla. La grandezza deve pure avere un limite, cioè una qualche dimensione
definita.448 Gli atomi hanno una varietà illimitata di forme: infatti non potrebbero derivare tante varietà di
corpi, se le forme degli atomi fossero limitate. Poi, è da pensare che per ogni forma si danno infiniti atomi
(sicché infiniti sono gli atomi della stessa forma, mentre le forme non sono infinite, ma di numero
indeterminato e inconcepibile.449 Gli atomi non hanno le qualità che si riscontrano nei corpi composti (le
qualità sensibili), ma hanno solo forma, peso, grandezza.450
Epicuro ammette l’infinità degli atomi e dello spazio, cioè dell’universo fisico. L’universo, infatti, che è il
“tutto” fisico, non può avere confini (il confine esiste in rapporto ad altro), “sicché non avendo estremo non
ha limite, e non avendo limite è infinito e non limitato”.451 E l’infinità è da intendersi anche in relazione alla
moltitudine dei corpi e alla dimensione del vuoto.452 Di conseguenza, sono infiniti i mondi, “sia simili a
questo, sia dissimili”.453 Infatti gli atomi infiniti sono portati nei più lontani spazi. Tutti i mondi, comunque,
così come si formano, così si dissolvono, “quale più rapidamente e quale più lentamente”, essendo ognuno
sottoposto agli influssi più vari e venendo a subire i più diversi contraccolpi. Un nuovo mondo può formarsi
in uno spazio interposto tra altri preesistenti, “in uno spazio che abbia molto vuoto, ma non nel grande
gioia trascorsa per continuamente riviverla nel ricordo rasserenante, obbedisce alle stesse leggi cui obbedisce la società
nella sua formazione e nella sua essenza. […] Per Epicuro, la scuola compie ciò cui la società politica è impotente: il
corpo dei filosofi riuniti nella scuola è un modello di comunità, è una società riuscita, perché fondata sulla conoscenza
della natura delle cose e unita dai vincoli di quella vera e costante amicizia ch’è possibile solo in quell’ambito ristretto.
La scuola di Epicuro non è aperta alla società come, nei primi tempi della sua attività almeno, era stata la scuola di
Platone, che si poneva non solo come centro di ricerca filosofica comune e di amicizia eletta ma anche come possibile
scuola di riformatori, di legislatori di città, di ispiratori e consiglieri politici di monarchi; non vede alcun suo
prlungamento di attività nella vita della società politica; considera la sua ϕιλ\α perfetta proprio perché contenuta entro
l’ambito di rapporti comunitari metapolitici e non proiettata verso la comune partecipazione alla vita politica. La scuola
di Epicuro contesta la società con la creazione contrapposta di una piccola società di eletti che trova in sé la sua
completezza di rapporti” (ib., pp. 54-55). In questo senso, si può dire, tuttavia, che l’ideale epicureo comprende anche
un nuovo modello di vita politica, quello caratterizzato dalla formazione di ristrette comunità di individui (e di famiglie)
che professano gli stessi ideali, perseguono scopi omogenei, sono uniti da una concezione del mondo. Così il legame va
al di là del semplice interesse costituito dalla divisione dei compiti, in vista del vantaggio reciproco; esso, infatti, tocca
le radici del sentimento e si configura anche come vincolo affettivo, compartecipazione reciproca, vero e proprio
desiderio da parte di ognuno della felicità dell’altro. L’amicizia diventa, in questo modo, lo stesso ambito della vita
politica. Ogni comunità tende all’autosufficienza, in quanto, dal punto di vista delle risorse materiali, si basa sulla
riduzione della sfera dei bisogni e sul rifiuto di tutto ciò che non appare strettamente necessario al soddisfacimento delle
necessità naturali. Si tratta di un modello di vita comunitaria, in cui non è da trascurare la componente scientifica, cioè
lo sviluppo di una conoscenza della natura e dell’uomo libera dai pregiudizi correnti, così come fondamentale è la
formazione di una coscienza che sappia dominare le circostanze esterne e ponga se stessa al centro dell’intera vicenda
umana e storica.
445
“Il tutto fu sempre quale ora è e sempre così sarà: ché nulla c’è in cui possa mutarsi. Oltre il tutto infatti non c’è
nulla, che penetrando in esso ne produca il mangiamento” (Ep. a Er., 38-39).
446
“E se non ci fosse lo spazio, che chiamiamo vuoto e luogo e natura impalpabile, non avrebbero i corpi dove stare
né per dove muoversi” (Ep. a Er., 39-40).
447
Ib., 41.
448
Ib., 56-57.
449
Ib., 42.
450
Ib., 54-55.
451
Ib., 41.
452
“Ché se fosse infinito il vuoto ma limitati i corpi, non resterebbero essi in nessun luogo, ma sarebbero portati a
disperdersi per il vuoto infinito, non avendo sostegni né frenate di contraccolpi. E se fosse limitato il vuoto, non
avrebbero dove stare i corpi infiniti” (Ib., 41-42).
453
Ib., 45.
spazio puro e vuoto, come alcuni dicono, affluendovi adatti principi da un mondo e intermundio o da più,
formando a poco a poco accumuli e connessioni e trasposizioni da latro luogo, se capiti, e affluenze da nuclei
acconci al compimento e all’arresto”.454
Gli atomi sono in moto continuo e stanno tra di loro in rapporti diversi di vicinanza e lontananza. Il moto
degli atomi è equiveloce (ha una velocità costante), allorché esso avviene nel vuoto e non incontra nessuna
resistenza; perciò gi atomi più grandi e pesanti nn si muovono più velocemente dei più piccoli e leggeri.455 E,
poiché se il moto degli atomi fosse interamente rettilineo, essi non si incontrerebbero (procedendo ciascuno
per una propria traiettoria rigidamente parallela a ogni altra), Epicuro introdusse “una novità, e disse che
l’atomo può deviare di una quantità minima, di cui non si dà la minore; e così si formano aggregati ed union e
adesioni degli atomi da cui nascono i mondi”.456 Questa deviazione rende possibile l‘incontro fortuito degli
atomi e, insieme, “questo potere libero, avulso dai fati, per cui andiamo ognuno dove ci conduce la nostra
propria volontà”.457
Ogni mondo e l’intero ordine cosmico sono dovuti al caso ed è da escludere ogni disegno teleologico. Il
meccanicismo materialistico esclude qualsiasi “provvidenza” o “mente ordinatrice”. L’unica legge che regola
lo sviluppo dell’ordine cosmico è la persistenza per un tempo maggiore degli stati di aggregazione che
presentino maggiori condizioni di equilibrio e di stabilità. E così, nelle specie viventi, sono destinate a
sopravvivere quelle che meglio si adattano alle condizioni esterne dell’ambiente.458
Anche l’anima, ovviamente, è “corporea, composta di particelle sottili, diffuse per tutto il complesso
corporeo, assai simili a un soffio avente mescolanza di calore e simile un po’ all’uno un po’ all’altro, e in
parte assumente gran differenza anche da essi per la sottigliezza delle particele, e per questa parte più
consenziente anche col resto dell’organismo”.459 Perciò l’anima compie ogni funzione in stretta connessione col
corpo. Questo, peraltro, soltanto in sua presenza partecipa allo sviluppo di quei processi che implicano il
concorso di entrambi: così, ad esempio, staccandosene l’anima, il corpo non ha più la sensibilità. E,
“dissolvendosi tutto l’organismo, l’anima si dissipa, e non ha più le sue facoltà”.
Piacere, virtù, felicità. L’etica epicurea
Epicureo definisce il piacere “principio e fine del vivere felice”.460 E il piacere consiste non tanto in
condizioni e fattori esterni che procurino il soddisfacimento di bisogni e di impulsi, quanto, invece, nella
conservazione di uno stato di serenità, reso possibile dal fatto che si evitano fattori esterni che inducono
dolore e turbamento. Si tratta di evitare che il nostro stato d‘animo dipenda dalle circostanze esterne e di far
sì che il nostro spirito sia autonomo e da sé si determini come stato di sereno appagamento.461 Epicuro è il
teorico del piacere stabile (“catastematico”). Questo piacere non consiste in una certa gioia passeggera, cioè
in sentimenti che siano soggetti a una casuale comparsa e scomparsa, bensì consiste in uno stato continuo di
serenità, senza turbamenti ed emozioni mutevoli.462 Bisogna, perciò, scegliere quei piaceri che non siano, a
loro volta, causa di passioni e quindi anche di dolori; così è meglio accettare alcuni dolori, allorché da essi
derivano piaceri più duraturi.463 Così occorre sempre valutare i desideri in rapporto ai loro esiti possibili.
Infatti può darsi che il soddisfacimento di un desiderio comporti non solo piacere ma anche dolore.464
454
Ep. a Pit., 89.
Ep. a Er., 61.
456
Cicerone, De finibus, I, 6, 18.
457
Lucrezio, De rerum natura, II, 252. “Sicché bisogna riconoscere che anche negli elementi primi ci sia un’altra
causa di moto, oltre gli urti e il peso, onde a noi viene questo potere innato” (Ib., 283).
458
Cfr. Lucrezio, De rerum natura, V, 419-31.
459
Ep. a Er., 63.
460
Ep. a Men., 129. “Piacere e dolore sono le due affezioni che si ritrovano in ogni animale: l’una favorevole, l’altra
contraria; e ciò è criterio della scelta e dell’avversione” (Diogene L., X, 34).
461
“Felicità e beatitudine non dipendono dalla quantità di ricchezze né sono procurate dal possesso di tante cose, né
da cariche o potere, bensì sono determinate dall’assenza di dolore, dalla mitezza degli affetti e da una disposizione di
spirito che si mantenga nei limiti voluti dalla natura” (Fr. 548 Usener).
462
“Quando dunque diciamo che il piacere è fine, non vogliamo alludere ai piaceri degli intemperanti e che sono
posti nel godimento, come credono certi ignoranti o dissenzienti o fraintendenti, ma il non soffrie nel corpo e non essere
turbati nell’anima” (Ep. a Men., 131).
463
“Secondo la misura e il criterio dei vantaggi e dei danni, bisogna valutare tutte queste cose; ché a seconda dei
momenti il bene ci riesce male e il male invece bene” (Ib., 130).
464
Cfr. Sent. Vat., 71.
455
Epicuro distingue i desideri in naturali e necessari, maturali ma non necessari, né naturali né necessari.465 I
desideri che non recano dolore se non vengono appagati sono non necessari e derivano da un’errata opinione.
I bisogni corporei (la fame, la sete, il freddo) sono naturali e necessari. E i piaceri corporei sono gli elementi
formativi del bene per l’uomo.466 Essi però vanno contenuti entro i limiti stabiliti dalla natura. Non si tratta
di aumentare artificialmente i desideri e i piaceri corrispondenti; infatti chi non segue la norma naturale
nello sviluppo dei desideri si troverà sempre a desiderare ciò che non ha e a inventarsi bisogni nuovi e non
naturali.467 Così è saggio godere serenamente i beni presenti e non affliggersi nel pensiero di ciò che
manca.468 Solo lo stolto vive con la continua ansia del futuro.469 Piuttosto occorre alleviare la sventura e il
dolore con la memoria del bene passato e la consapevolezza “che non si può fare che non sia ciò che
avvenne”.470 Non sono i lussi e i godimenti sfrenati che rendono dolce la vita. La prudenza, perciò, è la
fondamentale virtù: essa, infatti, ci insegna che “non c’è dolcezza di vita senza saggezza e bellezza e
giustizia”.471 Pur mettendo in rilievo il fondamentale significato delle virtù civili, di cui la giustizia è il
fondamento, Epicuro osserva che è saggio evitare gli obblighi derivanti dalle cariche pubbliche.472 Infatti
“massimo frutto di giustizia è la serenità spirituale”.473 L’area in cui si sviluppano rapporti interoggettivi
rispondenti al fine della vita felice è quella dell’amicizia. L’amicizia, anche se ha la sua origine nell’utile
reciproco, è un bene per sé ed è perseguibile in quanto tale, per i piaceri che la comunanza di sentire
comporta. Essa si misura in rapporto all’altruismo e alla disponibilità di sacrificarsi per gli altri. E fare il bene
è più dolce che riceverlo.
L’uomo, che pure è dotato di disposizioni naturali, è artefice della sua felicità e della sua condizione
morale.474 Dobbiamo, tuttavia, supporre che ci sia un ipotetico spettatore come giudice della nostra
condotta.475 Ed è comunque il bene spirituale da ritenersi superiore e preferibile (così, ad esempio, non la
giovinezza ma la saggezza). Ciò che consente all’uomo di superare in certo modo la “sorte mortale e il tempo
finito di vita” è la conoscenza, l’”indagine della natura”, in virtù della quale il sapiente è assunto “all’infinito
e all’eterno”, in quanto ha contemplato”quello che è ora e sarà e fu nel tempo trascorso”.476
L’esistenza del male dimostra, poi, che la divinità non provvede alle cose del mondo.477
465
Sent. Vat., 29.
“E non so davvero concepire quel bene, se sopprimo quei piaceri che si percepiscono col gusto, e sopprimo queli
di Venere, e quelli dell’udito e dei canti, e sopprimo anche quei soavi moti che dalle forme traggono gli occhi o quali
altri piaceri nascono da qualsivoglia senso in tutto l’uomo. Né è vero che solo la letizia spirituale stia nell’ordine dei
beni; perché anche la mente so che si allieta così: nella speranza di quanto ho detto, cioè nel godimento di piaceri la cui
natura è di rimanere esenti da dolore” (Fr. 67 Usener). Questa difesa della naturalità dei piaceri dei sensi è diretta
contro le polemiche antiedonistiche dei platonici e di Aristotele. “Chi dunque segue la natura e non le varie opinioni in
ogni caso basta a se stesso” (Fr. 202 Usener).
467
“Come i febbricitanti che a causa del male hanno sempre sete, così i malati dell’anima mancano sempre di tutto e
sono spinti ai più vari desideri dalla loro avidità” (Fr. 471 Usener).
468
Cfr. Sent. Vat., 35.
469
Fr. 491 Usener.
470
Sent. Vat., 55.
471
Ep. a Men., 132. Epicuro ammette che la giustizia deve improntare i rapporti intersoggettivi. Così, “fra gli animali
che non poterono fare patti per non apportare né subire danni, non si dà giusto né ingiusto; e così fra i popoli che non
poterono o non vollero stabilire patti per non danneggiare né essere danneggiati” (Mass. Cap., 32). Ogni legge ha senso
in quanto risulta conforme all’utile della reciproca convivenza. “Ciò che è attestato come utile nei bisogni della
convivenza reciproca ha il carattere del giusto” (Ib. 37). Così, nonostante l’identità formale, vi è varietà di contenuto del
giusto e del diritto secondo l’utile sociale. “Perciò quando sono intervenuti mutamenti nelle condizioni, per cui non
giovano più le medesime norme prescritte come giuste, allora si deve dire che erano giuste prima, quando giovavano
alla convivenza civile; dopo, quando non giovarono più, non furono più giuste” (Ib., 38).
472
Da cui la massima per cui “è meglio vivere ignorato” (Fr. 55 Usener).
473
Fr. 519 Usener. “Il giusto è quanto mai sereno, l’ingiusto pieno del più grande turbamento” (Mass. Cap., 17).
474
“Non la natura, unica per tutti gli esseri, fece gli uomini nobili o ignobili, ma le azioni loro e le disposizioni
spirituali” (Fr. 58 di Diogene En.).
475
Fr. 210 Usener.
476
Sent. Vat., 10.
477
Infatti, se Dio vuole impedire il male e non può, allora è impotente (il che è contraddittorio col concetto stesso
della divinità); se può e non vuole, è invidioso (il che non si addice a Dio, che, essendo perfetto, non può invidiare ciò
che è imperfetto e limitato); se insieme non può e non vuole, è del pari imperfetto e invidioso; se, infine, vuole e può,
non si capisce perché effettivamente non lo fa e lascia che il male si diffonda nel mondo. Rimane la conclusione che la
divinità non provvede alle cose del mondo (Fr. 374 Usener); invece “nulla essa fa, da nessuna occupazione è presa, a
nessuna opera lavora, ma solo gode della sua sapienza e virtù” (Cicerone, De natura deorum, I, 19, 51).
466
Tuttavia Epicuro crede che esistano gli dèi, “perché è necessario che esista una natura eccellente, della
quale nulla possa essere migliore”.478 E alla divinità va attribuito l’onore degli uomini, non per i benefici che
essa può recare, ma per la stessa somma maestà e la sua natura straordinaria.479
CAPITOLO IX
Lo stoicismo
A differenza dell’epicureismo, che rappresenta una concezione materialistica del mondo, in quanto riporta
ogni aspetto della realtà al movimento degli atomi, lo stoicismo esprime una concezione di tipo
spiritualistico, poiché pone a fondamento dell’intera vicenda cosmica il “logos” o la “ragione” e considera la
stessa realtà fisica come espressione di questo principio intelligente e spirituale. Ogni ente, dunque, ha un
senso razionale e fa parte di un ordine unitario. La vicenda cosmica segue un ciclo eternamente ritornate, che
ha il suo inizio e il suo termine nel punto in cui avviene il “rinnovamento” del Tutto nella forma di una
“conflagrazione universale”, cioè di un ritorno delle cose all’unità della sostanza ignea fondamentale (il
“fuoco” è la stessa espressione materiale del “logos”). L’uomo ha il compito di vivere in conformità della
ragione che è lo strumento e il fine stesso della vita felice. In questo senso egli deve il più possibile liberarsi
dalle passioni e dai pregiudizi, perseguendo la costruzione di un sistema razionale di conoscenza e anche un
tipo di vita basato su principi morali universalmente riconosciuti. Perciò gli stoici professavano il
cosmopolitismo, la dottrina per cui tutti gli uomini appartengono alla medesima comunità, al di là di ogni
distinzione di appartenenza politica. Gli stoici perseguono un ideale di libertà e affrontano la morte con
eroica disposizione, con la convinzione che l’anima individuale è destinata a tornare alla “ragione”
universale e originaria come principio e sostanza del Tutto.
Zenone fondò la sua scuola verso il 300 a. C. presso il portico (stoa) dipinto da Polignòto.480 Suo discepolo e
successore fu Cleante di Asso481; il terzo scolarca fu Crisippo di Soli, il quale, in una vasta serie di scritti (705
libri) diede sistematicità e compiutezza alla dottrina stoica482. Successivamente, Zenone di Tarso, Diogene di
Babilonia e Antipatro di Tarso rappresentano ancora lo stoicismo antico; quello “medio” confluì
nell’eclettismo,483 mentre lo stoicismo dell’età imperiale romana (rappresentato specialmente da Marco
Aurelio) ebbe un carattere più spiccatamente religioso.
478
Cicerone, op. cit., II, 17, 46.
Cfr. Seneca, De benef., IV, 19.
480
Zenone, nato da una famiglia di origini semitiche a Cizio nell’isola di Cipro, aveva manifestato da giovanissimo
l’inclinazione per la filosofia e il padre, che esercitava il commercio, gli aveva portato da Atene molti libri di socratici;
perciò quanto prima decise di trasferirsi ad Atene intorno al 312 a. C. e così ebbe modo di frequentare i rappresentanti
delle varie scuole e approfondire la lettura dei filosofi naturalisti. Poiché non aveva la cittadinanza di Atene, non poté
acquistare un edificio nella città e, pertanto, si adattò a insegnare nella Stoà (il Portico, adornato di dipinti di Polignòto).
481
Cleante diresse la Scuola dal 262 al 232.
482
Crisippo diresse la Scuola fin verso la fine del III secolo a. C. Con la serie sterminata delle sue opere, scritte in
stile raffinato e con grande forza dialettica, egli elaborò i concetti fondamentali della filosofia storica e li impose
definitivamente, eliminando quelle intepretazioni che apparivano lontane dalla dottrina originaria di Zenone (come
quelle di Aristone di Chio e di Erillo di Cartagine). “Zenone e Crisippo – osserva il Pohlenz – erano dei semiti e già a
priori sarebbe inconcepibile che la loro origine non abbia esercitato alcuna influenza sulla loro visione del mondo.
Eppure quanto profondamente Zenone fosse penetrato dallo spirito della grecità, basta a dimostrarlo un fatto solo: che
fu un filosofo. Ellenico è il logos che è al centro di tutto il suo pensiero, ellenico quel concetto della physis che
costituisce la base non solo della cosmologia, ma anche dell’etica stoica. Nell’Ellade affonda le radici la sua fede
nell’autonomia dell’uomo […]. Senonché lo sforzo di affermare questa assoluta preminenza del logos impedisce alla
Stoa di pervenire a una concezione integrale dell’uomo […]” (La Stoa. Storia di un movimento spirituale, 1959, tr. it.,
Firenze 1967, vol. I, pp. 328 sgg.).
483
Posidonio (vissuto tra il 130 e il 50 a. C. e discepolo di Panezio, che inaugurò il medio stoicismo di orientamento
eclettico, ad esempio, cercò di conciliare il platonismo con il materialismo stoico, introducendo quella forma di
dualismo di spirito e materia, che doveva avere un’influenza notevole sul misticismo dell’età successiva. Altri elementi
introdotti nel sistema stoico furono la convinzione che lo spirito perviene alla conoscenza, oltre che per la via
dell’esperienza, attraverso la pratica divinatoria, per la quale esso, liberatosi dal corpo, guarda al futuro, sia in virtù del
suo potere sia con l’aiuto di demoni che popolano lo spazio o della divinità stessa. Infine va ricordato il tentativo di
479
La filosofia è ripartita dagli stoici in fisica, etica e logica. Crisippo mette in rilievo la connessione di fisica e
etica, poiché vivere secondo virtù è vivere secondo la consapevolezza della natura delle cose, essendo la
nostra realtà parte della natura universale (Diogene Laerzio, VII, 87). Unico criterio del bene e del corretto
comportamento, infatti, non può essere che la natura comune e la legge dell’universo.484
La logica (o “dialettica”, teoria della conoscenza), secondo Crisippo, verte sulle verità, in quanto sono
espresse, dunque sulle cose significate e sui segni medesimi (le parole e l’insieme del discorso).485
La facoltà della conoscenza è la ragione, che è la “parte dominante dell’anima” (“egemonico”) e che è come
“una carta adatta alla registrazione” e sulla quale si iscrivono e si fissano le idee. Fonte primaria della
conoscenza è l’esperienza sensibile. Dalla memoria di diverse percezioni relative a oggetti della stessa specie si
forma l’esperienza, la quale comprende un insieme di concetti e di anticipazioni. Queste ultime permettono di
riconoscere gli oggetti di cui si è avuta una percezione anteriore, ma la vera e propria comprensione delle
cose (per ciò che esse “sono”) avviene per mezzo dei concetti, la cui formazione avviene seguendo un preciso
metodo logico. L’immagine (“fantasma”) sensibile per mezzo della ragione diventa intellezione (l’oggetto
percepito diventa un “intelligibile”) e quindi rappresentazione dell’oggetto; questa, se è riconosciuta, cioè se è
confermata dall’attività giudicante la corrispondenza tra di essa e la cosa, si ha la comprensione (così si giunge
al “concetto”, che rappresenta il termine della conoscenza della “verità”, cioè dei modi stessi in cui le cose
sono). Il pensiero esprime, attraverso il discorso, la nostra conoscenza degli aspetti della realtà. La scienza è
data da un sistema ordinato di dati concettuali forniti di certezza sicura, in quanto verificati
accogliere motivi pitagorici, come la speculazione sui numeri e la connessione di essa con la dottrina platonica delle
idee.
484
“Il concetto fondamentale dell’antica dottrina stoica era un postulato etico: il dominio sovrano spettava alla
ragione nell’ambito etico. Si argomentava: nella legge morale deve essere ragione; di conseguenza la legge morale deve
essere l’unico valore, […] come inversamente la ragione, che fonda e postula questa legge, deve essere l’unico
fondamento di spiegazione, l’essenza e la misura di ogni cosa. Così la ragione nell’ambito morale gettò il ponte tra
uomo e tutto. Il tutto divenne razionale, cioè umano, rinalizzato, ordinato e determinato da una provvidenza; in breve,
eso fu spiegato. E allo stesso modo, dal canto suo, fu spiegato, cioè universalmente fondato, l’umano, la legge morale,
in quanto divenne cosmica. […] Questa sintesi mantiene il suo fondamento materiale mediante l’equazione: anima,
spirito, ragione uguale fuoco; ogni materia, il mondo intero uguale fuoco; di conseguenza il fuoco originario è uguale
alla ragione originaria e da esso provengono il cosmo come l’anima umana, la legge morale, la felicità” (Karl Reinhardt,
Poseidonios, Munchen 1921, p. 9).
485
Gli stoici liberano, per così dire, la logica dai presupposti ontologici aristotelici, nell’intento di attribuire ad essa
una dignità di disciplina autonoma, riguardante l’ordine coerente delle rappresentazioni e delle proposizioni nell’ambito
del discorso. Per Aristotele, la logica ha una stretta connessione con la metafisica: essa è costituita sulla base della
convinzione che il discorso rispecchia l’ordine della realtà; così, in primo luogo, essa riguarda la definizione che
esprime l’essenza di un determinato ente, oppure le modalità della predicazione che non sono altro che le modalità
stesse secondo cui una sostanza può assumere qualità e determinazioni particolari. La logica rispecchia la metafisica
dell’essere dell’ente. Invece, per gli stoici, la logica riguarda unicamente quei termini mentali e “incorporei” secondo i
quali noi pensiamo e ci rappresentiamo le cose e i fatti che cadono nell’ambito della nostra esperienza. Infatti si muove
dal presupposto empiristico che ogni conoscenza deriva dalla rappresentazione sensibile e che il “criterio” della verità
consiste nell’evidenza secondo la quale i dati empirici si imprimono nella nostra mente. La logica riguarda la coerenza e
l’ordine che questi dati evidenti assumono nello sviluppo del discorso. Si tratta, in primo luogo, di fare in modo che in
tale sviluppo non vengano a inserirsi elementi che manchino di fondamentale evidenza; quindi la logica riguarda il
coordinamento coerente delle rappresentazioni; perciò essa si qualifica principalmente come una logica del giudizio
ipotetico: se si hanno alcuni dati certi, si possono desumere alcune conseguenze. Il discorso non riguarda la
rappresentazione della struttura del reale, bensì la descrizione dei dati dell’esperienza. Questi dati sono affidati ai
“significati” delle parole: sono degli “esprimibili” e, in quanto tali, cadono nell’ambito della logica o “dialettica”, che,
appunto, è quella parte della filosofia, che, per gli storici, ha un posto fondamentale, in quanto insegna come
l’esperienza umana può dare luogo a un sistema di affermazioni coerenti, cioè, in definitiva, a una conoscenza. E la
conoscenza, per gli stoici, non può riguardare i concetti medesimi, che sono universali e rientrano nell’ambito della
logica stessa, bensì gli individui e i fatti che li riguardano (ad esempio, dire “l’uomo è libero” ha poca valenza
conoscitiva, in quanto “uomo” è un termine astratto che ha la funzione di indicare un insieme di individui e che, quindi,
può assumere quei predicati che si riferiscono a tutti questi). “Agli occhi del puro dialettico – ha osservato perciò il
Bréhier - che raccoglie gli avvenimenti isolati, non c’è legame possibile, o piuttosto non c’è altro legame se non quello
di identità. La dialettica resta alla superficie dell’essere. […] La dialettica degli Stoici è troppo legata ai fatti, per essere
feconda. Essa non è in grado di uscire dal fatto bruto e dal dato né mediante l’idea [l’essenza] che essa nega, né
mediante la legge, che essa non conosce ancora: essa deve accontentarsi di ripetere indefinitamente il dato di fatto” (La
théorie des incorporels dans l’ancien stoicisme, Paris 1908, p. 35). La conoscenza certa, in definitiva, per gli stoici, è
data dalla rappresentazione catalettica, fornita di evidenza immediata.
nell’esperienza.486 La verità consiste nella corrispondenza tra il significato, il segno e la cosa. Il sensibile,
perciò, è vero solo in rapporto all’intelligibile (in quanto è compreso).
Per gli stoici, tutti gli enti sono corporei, ed è proprio di questi enti fare e subire azione. L’anima è corporea
e, nella sua costituzione pura (cioè separata dall’organismo), permane dopo la morte. Anche la parola è
corporea: infatti, essa agisce sull’udito e noi la udiamo; e così ogni suono, poiché tutto ciò che commuove e
turba è corpo. Sono corporei anche il bene, gli affetti e i vizi.487
I due princìpi causali di tutte le cose sono la materia (principio passivo) e la ragione (principio attivo); ma si
può dire solo quest’ultima vera causa.488 La causa, d’altra parte, è inseparabile dalla materia: perciò questa si
presenta sempre in una data forma e qualità. Nella sua totalità, la materia prima è invariabile ed eterna, tale
da non ammettere in sé aumento o diminuzione, ma solo divisione e mescolanza delle parti.489
486
Zenone ricorreva alla famosa immagine della mano che via via si chiude per indicare sinteticamente il processo
della conoscenza: “Zenone […] presentando innanzi la mano aperta, con le dita stese, ‘Ecco, diceva, così è la
rappresentazione’. Poi, contraendo un po’ le dita, ‘e così è l’assenso’. E quando le aveva strette del tutto e fatto il
pugno, quelle diceva essere la comprensione: Quando poi aveva accostata la mano sinistra [alla destra stretta in ougno],
e compresso quel pugno ad arte e con gran forza, così diceva esser la scienza, della quale nessuno ha il possesso,
fuorché il sapiente” (Cicerone, Acad. pr., II, 144).
487
Infatti anche il bene opera e in qualche modo forma r contiene il corpo; così gli affetti producono modificazioni
nel volto (mutano i lineamenti, dilatano la faccia, corrugano la fronte, suscitano il rossore, rendono pallidi, e così via); e
sono corporei anche i mali spirituali (i vizi).
488
“La causa, cioè la ragione, forma la materia e la volge ovunque voglia, e ne produce le varie creazioni: Ci
dev’essere dunque un che donde una cosa nasca e un che da cui sia fatta. Questo è la causa, quello la materia” (Seneca,
Ep., 65, 2). La Ragione è attività formatrice e fondazione di senso di tutte le cose, “Logos” che pervade l’universo,
Fuoco divino che plasma la materia con la sua forza attiva, secondo le “ragioni seminali” che sono contenute in questo
principio medesimo. In questo senso, gli Stoici hanno costruito un vero e proprio sistema (organico e coerente) a
carattere monistico e panteistico: Dio, che è “Logos”, si esplica nell’universo, il quale, appunto, non è qualcosa di
diverso e di separato da lui. La costituzione del “Logos” è tale per cui esso è inseparabile dall’universo al quale esso dà
luogo, o, meglio, nel quale esso si dispiega. L’universo è l’ambito immanente in cui Dio si attua e si manifesta; la natura
di Dio si esprime nella vicenda del mondo e non è separata da essa. Tutte le cose non sono altro che aspetti del Principio
divino: esse, pertanto, non possono essere diversamente da come sono; il loro senso è quello originariamente stabilito
all’interno del “Logos”; né può esserci qualche circostanza che ostacoli l’attuazione di ciò che rientra nell’ordine col
quale esso coincide. Le cose, in questo modo, sono giustificate dal Tutto che le comprende e in questo conseguono la
loro perfezione. La “Provvidenza” degli Stoici rientra in questo ambito concettuale: essa riguarda il senso di ciò che
accade, in quanto esso trascende le singole cose e i singoli accadimenti e rientra nel senso del Tutto; perciò riguarda,
propriamente, l’immanente finalismo universale, di cui le singole cose fanno parte. Nel “Logos” ogni cosa acquista
senso e trova il suo compimento. La Provvidenza, in realtà, viene a coincidere col Fato, che è l’ordine necessario della
realtà.
489
Apollodoro sosteneva che la materia è divisibile all’infinito; Crisippo che essa non è infinita, anche se divisibile
all’infinito (perché non è infinito ciò che è divisibile, mentre la divisione non ha fine: cfr. Diogene L., VII, 150). La
concezione stoica è, considerata, perciò come un monismo rigoroso, cioè come fondata sull’idea di una sola realtà che
comprende ogni cosa e ogni accadimento e, pertanto, anche lo stesso processo conoscitivo. La natura è, insieme,
materia indifferenziata, fuoco originario e ragione eterna. Essa è “materia priva di qualità” (αποιοH υλη), sostanza
sempre identica a se stessa, immutabile ed eterna: in questo senso, costituisce il “principio” di tutto ciò che esiste e
accade, il fondamento di tutti gli eventi; ed è principio di tutte le forme, che in sé contiene le ragioni di ogni processo e
le leggi di ogni accadere (λογοH, νοµοH, δια παντοH διηκων). La natura costituisce, dunque, l’unica sostanza; e
perciò non vi sono sostanze individuali nel senso aristotelico: tutti gli enti fanno parte o sono aspetti e modi della natura.
Uno solo è così anche il principio causale; e le quattro cause aristoteliche non sono altro che differenti modalità di esso.
Così ogni bene deriva ed è aspetto della natura stessa che s’identifica col bene assoluto. Analogamente ogni sapere è
espressione della conoscenza che la natura ha di sé e realizza attraverso il “logos” che le è costitutivo. In realtà, la
conoscenza umana è un riflesso della conoscenza fondamentale che appartiene alla sostanza unica. Su questa visione
monistica (che può essere paragonata a quella di Spinoza) ha insistito specialmente Johnny Christensen nello studio An
Essay on the Unity of Stoic Philosophy (Copenhagen 1962). In questa visione unitaria s’inquadra anche l’etica stoica,
fondata sul principio “vivi secondo natura”, cioè sulla necessità, per l’uomo, di conformarsi alla natura universale che in
sé contiene le leggi di ogni accadere e quindi anche quelle che regolano l’agire umano. In questo senso, il saggio stoico
cerca di riportare il suo volere alla ragione universale, liberandosi il più possibile dall’influsso di fattori contingenti ed
elevandosi a una specie di amore o simpatia universale per tutti gli aspetti della realtà. Ciò che appare come destino,
fato ineluttabile, in realtà, per gli stoici, è provvidenza del tutto, principio unitario di governo del mondo. La stessa
logica, come strumento del pensare e discorrere correttamente (in conformità del “logos”), s’inserisce nella medesima
visione unitaria. Come interpreta opportunamente l’Adorno: “In altri termini il saper vivere consiste nel saper ragionare.
Il disordine, la passione, il vizio, sono errori logici. Non esiste una ragione per sé e una realtà per sé, ma un centro di
Il principio attivo è fuoco vivificante: un’energia che si esprime attraverso un’attività creatrice di forme di
vita.490 La natura, nel suo principio e nella sua sostanza fondamentale, è questo stesso fuoco “artefice”, che
contiene i princìpi di generazione di tutte le cose e che, in quanto soffio e spirito animatore e unificatore, fa sì
che tutta la natura costituisca una totalità organica, in cui un legame indissolubile tiene unite tutte le cose
durevolmente.491 Questo stesso principio è mente e ragione reggitrice.492 Infatti l’universo è regolato da una
mente divina che ovunque penetra e modella ogni cosa, secondo un piano provvidenziale. In questo senso,
esso è “la ragione seminale del mondo” (Diogene L., VII, 156), contiene, cioè, tutte le forme secondo cui si
sviluppano tutti gli enti e si verificano tutti i processi di trasformazione.493
Dal fuoco originario l’universo si forma secondo una eterna vicenda ciclica. L’universo, così, si rigenera
continuamente, dopo essersi dissolto nel fuoco originario, per ogni periodo che costituisce il “grande anno”
cosmico.494 La formazione dell’universo avviene attraverso la distinzione die due princìpi dell’anima e del
coscienza attivo (l’eghemonicon), che si esplica ed è in quanto costituisce un tutto con la realtà del discorso, per cui la
ragione non è né prima né dopo, ma è discorso. Se il discorso è retto, razionale, esso non presuppone passioni e vizi, ma
le passioni e i vizi risolve in sé in quanto retto e ordinato discorso, onde passioni e vizi sono, presi a sé, irrazionalità,
sono dovuti, appunto, al non sapere pensar bene. Vi è a tale proposito un testo che possiamo far risalire a Zenone
[Cicerone, Ac. Post., I, 38] e che chiaramente precisa il significato logico dell’etica zenoniana, per la quale spetta
all’uomo saper pensare, e per la quale, in conclusione, socraticamente la virtù umana non dipende affatto da ordini
precostituiti, ma dallo sforzo umano d’essere se stesso, cioè ragionevole e quindi coerente a sé, donde scaturisce la virtù
come coerenza (homologhia) e atto conveniente (cathécon). […] Il vizio, dunque, è passione nel senso che è mancanza
di ragione, o meglio è non capacità (non virtù) di ben pensare in cui consiste il ragionare, per cui errare, l’errato
giudizio, è un farsi prendere, un patire ler rappresentazioni stesse che vanno in libertà (“Zenone, paragonando al cieco
volo di uccelli spauriti la mobilità del passionale […], sostiene che la passione è un correre sbigottito dell’anima”:
Stobeo, Ecl., II, 7, 1, 2); mentre il ragionare è un porre ordine (ηγεοµαι), un confederare, legandole secondo la loro
misura e implicazione, quelle medesime rappresentazioni” (La filosofia antica, II, pp. 218-219).
490
Il fuoco è una forza vitale, che si diffonde per tutto l’universo. “Tutte dunque le parti del mondo […] si
mantengono sostenute dal calore […]; e il mondo stesso da una simile ed ugual natura è conservato in tanto lunga
durata, e si deve intendere che quel calore e quel fuoco è così compenetrato con tutta la natura, che in esso sta la forza
di ogni procreazione e la causa di ogni nascita” ; si tratta, cioè, di un principio vitale che “tutto conserva, alimenta,
accresce, sostiene e fornisce di senso” (Cicerone, De natura deorum, II, 25, 28, 41).
491
La natura, così, costituisce un ordine, in cui tutti gli enti sono insieme concatenati e ogni fatto è causa di altri ,
secondo l’ordine stabilito. Così nell’universo nulla è casuale, ma ogni cosa ha una funzione ed è fatta in rapporto al
tutto (ad esempio, le messi e i frutti sono per gli animali, questi per l’uomo, il quale, a sua volta, esiste per
“contemplare e imitare il mondo” (Cicerone, De natura deorum, II, 37). “Nulla infatti esiste né accade senza causa nel
mondo, perché non c’è nulla in esso di sciolto e separato da tutti i precedenti. Si dividirebbe infatti e si spezzerebbe e
non resterebbe mai uno il mondo, che è sempre governato da un solo ordine e disegno, se insorgesse un movimento
senza causa” (Alessandro d’Afrodisia, De fato, 22, 191, 30). Così ogni fatto è segno di ogni altro: e su ciò si basa la
divinazione, che è, secondo Crisippo, “la forza di conoscere, vedere e spiegare i segni che gli dèi offrono agli uomini”
(Cicerone, De divinatione, II, 63, 130).
492
“A quelli maggiormente inclini alla scienza pura, alla vita teoretica com’è intesa da Aristotele, lo stoicismo offriva
un bell’oggetto di contemplazione: ritrovare, fin nello spezzettamento delle cose e nei particolari più minuti degli
eventi, l’Ordine manifestato dal corso degli astri del cielo; scoprire ovunque il dito di Dio, prendere coscienza
dell’armonia, dell’unità del Tutto, comprendere come ogni oggetto, ogni fatto di quaggiù, si congiunga in un insieme
che, nonostante i dolori umani, deve apparire, in fondo, saggio e buono” (A. J. Festugière, Le Dieu cosmique, Paris
1949, p. 331).
493
Questo principio intelligente e attivo è anche Dio stesso, che presiede alla generazione del mondo, da sé genera e
in è raccoglie tutte le cose. Questa concezione è essenzialmente panteistica: Dio e il mondo si identificano. Dio coincide
con lo stesso ordinamento del mondo. “Ed è Dio un animale immortale, razionale, perfetto e intelligente nella sua
beatitudine, lontano da ogni male, provvidenza governante l’universo e tutto quanto è nell’universo: non avente forma
umana. E’ creatore di tutte le cose e quasi padre di tutte, tutto pervadendo in comune […]” (Diogene L., VII, 147-148).
Le divinità della mitologia politeista non sono altro che modi diversi in cui è chiamato lo stesso Dio, in rapporto alle sue
varie funzioni nell’universo (Cfr. ib.). Nella concezione teologica degli stoici può essere ravvisata, tuttavia, una forma
di teismo.
494
Così, dopo la conflagrazione universale si ha la riproduzione identica del tutto, “e di nuovo dal principio si ritorna
allo stesso ordine cosmico; e di nuovo muovendosi ugualmente gli astri, ogni avvenimento accaduto nel precedente
ciclo senza alcuna differenza torna a compiersi” (Nemesio, De natura hominum, 38). Nella concezione stoica, la
conflagrazione è interpretata anche come purificazione del mondo dal male (catarsi cosmica). Come è noto, Nietzsche
ha ripreso questo motivo dell’“eterno ritorno” di una medesima grande vicenda cosmica, mettendo in rilievo, in
particolare, il senso di angoscia che accompagna il pensiero di questo che appare come “il peso più grande
dell’esistenza”. In un paragrafo (341) de La gaia scienza così egli si esprime: “Che cosa accadrebbe se un giorno o una
corpo e la generazione successiva dei quattro elementi.495 Mentre questi, poi, si dissolvono nella
conflagrazione e si ricostituiscono, i princìpi sono indistruttibili. Nella formazione dell’universo, dapprima è
nata la sfera degli astri immobili, poi quella dei mobili (costituiti da fuoco/etere), quindi si è costituita la
sfera dell’aria, poi quella dell’acqua e infine la terra, che sta al centro dell’universo. L’universo è unico, finito,
di forma sferica. Fuori di esso vi è il vuoto infinito, incorporeo. Incorporei sono, dunque, il tempo e lo spazio,
entrambi infiniti. Nell’universo, invece, non c’è vuoto, ma esso è tutto unito e compatto.
La presenza del male e dell’imperfezione nel mondo è giustificata dagli stoici in base al principio della
contemporanea sussistenza dei contrari. 496
Negli animali il principio d’unione delle parti nel tutto organico è l’anima. Questa è, come abbiamo visto,
corporea ed è costituita come un soffio vitale o un’energia che ha la funzione di plasmare il corpo; essa
sopravvive, ma non è eterna, poiché propriamente eterna e immortale è l’anima universale (di cui le anime
degli animali sono parti). Nell’anima la funzione direttiva è svolta dall’”egemonico”, che produce le
rappresentazioni e i concetti ed è funzione del giudicare: perciò è principio della conoscenza e della vita
etica. Dall’egemonico si dipartono sette altre parti (con le relative funzioni), che sono i cinque sensi, il mezzo
che trasmette gli ordini dell’”egemonico” alle diverse parti del corpo e la parola.
Anche per gli stoici, come per Aristotele, il fine dell’uomo è la vita razionale. Mentre per gli animali in
generale, il fine è la continuità della specie, ed essi vivono guidati dall’impulso fondamentale alla
conservazione del proprio essere, negli uomini la ragione interviene a regolare l’impulso, sicché, per essi, “il
vivere secondo ragione giustamente diventa vivere secondo natura” (Gellio, XII, 5, 7). E poiché la ragione
umana è parte della ragione universale, consegue che il compito dell’uomo è di vivere secondo questa
ragione unica, che è fondamento dell’armonia e dell’ordine del cosmo.497
La vita razionale è principalmente una condizione libera da turbamenti e passioni. Secondo Zenone, la
passione è un turbamento dell’anima, provocato dalla volontà che asseconda il desiderio eccitato in modo
eccessivo e non, invece, la ragione. Perciò, solo la cancellazione della falsa opinione intorno ai beni e ai mali
può liberare l’uomo dalle passioni. La virtù è la disposizione interna dell’anima a vivere secondo ragione:
notte nella più solitaria delle tue solitudini si insinuasse un demone e ti dicesse: ‘Questa vita che vivi adesso e che hai
vissuto, dovrai viverla ancora innumerevoli volte; e non ci sarà niente di nuovo, in essa, ma ogni dolore e ogni piacere e
ogni pensiero e sospiro e tutto quello che in essa c’è di indicibilmente piccolo e grande deve tornare, e tutto nella stessa
sequenza e successione – persino questo ragno e questo chiaro di luna tra gli alberi, e persino questo istante e io stesso.
L’eterna clessidra dell’esistenza viene girata di continuo -, e tu con essa, infimo granello di polvere!’. Non ti getteresti a
terra e digrigneresti i denti e malediresti il demone che parla così? O hai già vissuto un attimo di immensità in cui gli
risponderesti: ‘Tu sei un dio, e mai ho udito parole più divine!’. Se quel pensiero si impadronisse di te, come sei adesso,
ti trasformerebbe, forse stritolandoti; la domanda ‘vuoi che tutto ciò accada ancora una volta, innumerevoli volte?’
sarebbe il più grande peso mai gravato sul tuo agire! Oppure, quanto dovresti essere ben disposto nei confronti di te
stesso e della vita, per non desiderare nient’altro che quest’ultima, eterna conferma, questo sigillo?”. In realtà, la
dottrina dell’”eterno ritorno” costituisce un corollario essenziale della concezione relativa alla completa appartenenza
dell’uomo alla realtà totale, per cui ogni esistenza è già decisa. Il “peso più grande” è proprio questa totale assenza di
libertà, questa negazione assoluta del libero arbitrio. Si tratta della più coerente concezione della vita come “necessità” e
“destino”.
495
“Si genera il mondo quando da fuoco la sostanza si sia mutata in umidità, passando per lo stato di aria; quindi da
un lato, fatta di parti più pesanti e coagulata, sia diventata terra, dall’altro, fatta di parti più sottili, sia passata in aria e
questa ancor più assottigliata sia divenuta fuoco; quindi dalla mescolanza di questi elemti sian nate le piante, gli animali
e le altre specie” (Diogene L., VII, 142).
496
“Giacché, essendo i beni contrari ai mali, è necessario che entrambi gli opposti si mantengano fra loro e quasi da
mutuo e contrario sforzo sostenuti: ché non si dà contrario (per contrario che sia) senza l’altro contrario” (Gellio, Noctes
atticae, VII, 1). Perciò Cleante dice che Dio ha “armonizzato ad unità tutti i beni coi mali” (Inno a Giove, 20).
497
Allorché diventa impossibile, per circostanze esterne, seguire la norma della ragione universale e la vita si profila
in senso contrario al suo fine proprio, allora, per gli stoici, si dà come unica alternativa la morte volontaria. “Colui
infatti, in cui prevalgano le condizioni conformi a natura, ha il compito di rimanere in vita; colui, nel quale appaia
presente o futura la preponderanza delle condizioni contrarie, ha il compito di uscire dalla vita” (Cicerone, De finibus,
III, 60). Per gli Stoici, infatti, la libertà consiste nell’uniformare la propria volontà all’ordine universale delle cose,
quale è stabilito dalla Ragione (che si configura, come abbiamo visto, anche come “Destino”). L’individuo è libero in
quanto accetta la “parte” che gli è originariamente assegnata nell’ordine universale, cioè in quanto rimane fedele al
“Fato” che originariamente attribuisce senso e valore alla sua vita. Ciò che nella concezione più antica (ad esempio in
Omero e, ancora, nei poeti tragici) si configurava come l’“ineluttabile”, il destino al quale è impossibile sfuggire, per gli
Stoici è ciò che è veramente razionale, ciò che ha senso per l’uomo, e che, dunque, si identifica col “bene”, con ciò che
rappresenta la perfezione dell’individuo, la sua stessa felicità (se per felicità s’intende lo stato di compimento della vita
individuale, la perfezione stessa di ogni ente).
essa è sostenuta da una fondamentale sapienza, per cui chi ne è dotato “sa intendere e fare quel che va fatto”
(Plutarco). Il saggio si comporta sempre secondo virtù e perciò ogni sua azione è perfetta. Inoltre, la virtù è
condizione di felicità. Gli uomini sono più o meno felici in quanto si avvicinano più o meno alla perfezione
della vita razionale: i primi sono i sapienti; poi vi sono coloro che si sono liberati dai maggiori mali spirituali
e dalle passioni; quindi troviamo coloro che si sono liberati da alcuni gravi vizi (come, ad esempio,
l’avarizia) ma rimangono soggetti ad altri (come l’ira).
Per gli stoici, è giusto ciò che risulta conforme alla ragione e alla legge universale. E per natura gli uomini
sono socievoli, dunque disposti a seguire la giustizia come regola della vita in comune. Si ha, pertanto, una
specie di diritto naturale, sul quale si basa il criterio del giusto e del conveniente nel comportamento sociale e
politico. Poiché, poi, l’umanità costituisce come una sola grande realtà, essa è anche come una sola famiglia o
comunità: così il mondo intero è “quasi comune città e stato degli uomini e degli dèi, o ognuno di noi parte
di un mondo” (Cicerone, De finibus, III, 19, 64).498 L’uomo saggio, perciò, antepone il bene comune a quello
individuale. La fratellanza umana e il cosmopolitismo sono i fondamentali princìpi della politica stoica.499
498
“Zenone salvò, consegnandola alla nuova età, la convinzione che era stata propria della civiltà ellenica in genere e
di quella ateniese in particolare, che cioè l’uomo diventa veramente uomo solo in seno alla comunità, e la adattò al
mutato sentimento della vita, mettendo al posto della polis la grande associazione formata da tutti gli esseri razionali.
Così, per la prima volta nella storia, al posto dell’antico ideale ellenico del cittadino fu proclamata l’idea dell’umanità.
[…] Il mondo intero egli [Zenone] sottopose poi alla legge razionale, e introdusse così nel pensiero occidentale l’idea
del diritto di natura, che, senza distinzione di nazione o di stato, vincola tutti gli uomini” (Max Pohlenz, La Stoa, l. cit.).
499
Nell’ambito dello stoicismo romano, Seneca infonde a questa filosofia uno spirito religioso, molto vicino al
cristianesimo, specialmente per il sentimento di fratellanza tra tutti gli uomini e tra gli uomini e tutti gli esseri del
mondo. La vita razionale e la perfezione si conseguono specialmente attraverso l’adempimento dei doveri verso gli altri:
“Trattieniti - egli dice – con chi ti può fare migliore. Accogli chi puoi tu fare migliore. Questo beneficio è vicendevole,
e gli uomini nell’insegnare imparano” (Ep., 7, 8-9). L’uomo è sacro all’uomo e la solidarietà umana è il principale
dovere di ciascuno. E tutti gli uomini hanno uguale natura e pari dignità: “La virtù non è preclusa a nessuno, è aperta a
tutti […] liberi, schiavi, liberti, re, esuli. Non sceglie casa né censo; si contenta dell’uomo nudo” (De ben., III, 20). Il
saggio riconosce, in primo luogo, la fragilità umana, per cui nessuno è senza peccato: “Se vogliamo essere equi giudici,
persuadiamoci anzitutto che nessuno di noi è senza colpa” (De ira, 28). “Quanti accusatori sono esenti da colpe? […]
Tutti abbiam peccato […] e peccheremo fino all’estremo della vita. Se anche taluno ha purificata l’anima sua tanto
bene, che nulla più possa turbarlo e farlo errare, tuttavia solo attraverso il peccato è giunto all’innocenza” (De clem., I,
6). In realtà, secondo gli stoici, la vera perfezione è raggiunta dall’anima attraverso il suo ricongiungimento con lanima
cosmica: perciò il saggio considera la morte come la liberazione dell’anima da uno stato provvisorio di decadenza e
imperfezione. “Quando verrà il giorno, che disgiunga questa mescolanza di divino e di umano, lascerò il corpo qui dove
l’ho trovato, ed io mi ricongiungerò con Dio” (Ep., 102, 22). Dio, infatti, è la mente dell’universo: egli è tutto ragione, è
anima e spirito del mondo, signore e artefice di tutto, provvidenza che presiede all’ordine universale. Né occorre uscire
fuori di noi per trovare Dio, poiché egli è presente nella nostra anima e questa vive in lui (Ep., 40, 1-2).
Gli altri due notevoli esponenti dello stoicismo romano sono, come è noto, Epitteto e l’imperatore Marco Aurelio.
Epitteto fu a Roma discepolo di Musonio Rufo e il suo insegnamento venne raccolto negli otto libri delle
“Dissertazioni” e, in sintesi, nel famoso “Manuale” dal suo discepolo Arriano di Nicomedia. Il compito dell’uomo,
secondo Epitteto, è di intendere l’ordine dell’universo e di farsi suo interprete e custode, e, inoltre, di proclamare il
principio della libertà spirituale, emancipandosi da ogni condizionamento esterno e ricercando nelle profondità della
coscienza l’essenza del bene. “Poiché quando avete chiuse le porte e fatto il buio in casa, ricordatevi che non potete mai
dire che siete soli, poiché tali non siete; ma Dio è dentro noi ed è l’anima nostra” (Diss., I, 14, 13-14). Secondo Marco
Aurelio, che espose le sue riflessioni nei “Pensieri”, l’uomo deve vivere nella continua meditazione intorno a se stesso e
al modo in cui poter diventare migliore e avvicinarsi alla perfezione della sua natura (che sta nella ragione o nella
coscienza). L’uomo deve ricercare dentro di sé le condizioni della felicità e non affidarsi al mutevole corso delle cose
esterne. Occorre, infatti, raggiungere l’indipendenza dalle cose esterne e, nelle azioni, tenere presente che “unico frutto
della vita terrena è una santa disposizione di spirito e le azioni utili alla comunità” (VI, 30). Infatti, “gli uomini sono
nati l’uno per l’altro” (VIII, 59); e ognuno è membro dell’unico sistema dell’universo, nel quale “tutte le cose sono
legate tra loro, ed è sacro vincolo, e quasi nessuna è estranea all’altra: ché sono coordinate e concorrenti a formare uno
stesso mondo” (VII, 9). E’ dovere dell’uomo vivere con la divinità, uniformandosi all’ordine da essa stabilito. Così
“vive con gli dèi chi continuamente mostra loro la sua anima contenta di quel che le tocca, che fa quel che vuole il
demone che ad ognuno Giove ha dato come rettore e guida, emanante da lui: cioè l’intelletto e la ragione d’ognuno” (V,
27). Gli stoici ripongono ogni valore positivo nella vita interiore, mentre considerano moralmente indifferenti
(“adiaphora”) tutte quelle circostanze che non dipendono dalla disposizione interna del soggetto, ma appartengono alla
natura o alla storia. Pertanto, il saggio non deve curarsi di ciò che accade nell’ambito della natura o che è un elemento
della vita politica: “indifferenti” sono, infatti, la stessa salute o la malattia (in quanto accidenti relativi al corpo, che fa
parte dell’esteriorità naturale, oppure la ricchezza e la povertà o la libertà e la schiavitù (in quanto connesse con la
condizione sociale e con le circostanze esterne). Bene e male riguardano l’interiorità, cioè l’adesione o meno alla
La filosofia di Cicerone
Cicerone ha elaborato una sua filosofia? Generalmente egli è considerato un eclettico, tutt’al più un
espositore delle filosofie ellenistiche, specialmente dell’epicureismo e dello stoicismo; alle cui opere si può
attingere per conoscere meglio quelle correnti. Questa è sicuramente una visione riduttiva, che non tiene
conto del fatto che Cicerone in realtà procedeva col metodo del confronto; e in tal modo contribuiva a
diffondere la cultura filosofica nel mondo romano, dato che la filosofia era considerata una prerogativa
propria dei Greci.500
Cicerone si attribuiva il merito di avere adattato la lingua dei Romani all’esposizione del pensiero
filosofico, di avere cioè, insieme a Lucrezio, prestato la lingua latina alla filosofia, che si considerava
pressoché impossibile fuori della lingua originaria nella quale si era sviluppata. Cicerone è l’interprete
principale della civiltà e della cultura latina; egli si attribuisce il ruolo di massimo difensore delle istituzioni
romane, come di colui che più di ogni altro ha riportato il mondo romano alla dimensione della humanitas.
L’esercizio di traduzione di ampi brani dei testi filosofici greci gli sembrava essenziale per portare a
compimento l’operazione di totale inserimento del mondo romano nell’ambito e nella sfera della grande
cultura greca, che aveva la sua nota caratteristica nell’essere il luogo dello sviluppo della filosofia. Tramite
Cicerone e in virtù della sua opera, il mondo romano si impadroniva del patrimonio del pensiero filosofico
greco, tanto da potere a buon diritto aspirare ad avere una filosofia originale, basata specialmente sulla
connessione tra speculazione e pratica civile e politica.
Cicerone intendeva la filosofia come compenetrazione delle istituzioni e dell’agire pratico nell’ordine
logico della razionalità e nella consapevolezza intorno a ciò che meglio per l’uomo. La filosofia è
specialmente riflessione etica. Essa è elaborazione di una concezione del mondo e della vita, in ordine al fine
da attribuire alle cose e alle azioni umane. Cicerone propende per quelle filosofie che si coniugano più
facilmente con l’ordine civile e assicurano i buoni cittadini intorno alla considerazione delle istituzioni
pubbliche come i vertici della vita e dell’attività degli uomini. Lo stesso Platone aveva concepito come scopo
essenziale della filosofia il disegno dello stato ideale. Cicerone è convinto che la cultura greca e quella
romana in realtà costituiscono un’unità fondamentale, un plesso unitario, dominato dall’idea della
fondazione della vita secondo virtù. La filosofia è parte dell’uomo, fonda l’umanità stessa. La forma di
cultura migliore è quella che assicura una vita politica di alto livello civile. In tale sforzo di fondazione della
migliore vita politica la cultura greca e quella romana si incontravano e armonizzavano. Cicerone è convinto
che in tal modo si possa conseguire e realizzare la migliore forma di vita politica e che da tale sintesi possano
uscire le istituzioni pubbliche idonee ad assicurare il migliore governo dell’umanità.
Cicerone si preoccupa in primo luogo di acquisire i fondamenti della cultura filosofica al mondo romano.
La filosofia è fonte di umanità. Nell’Ortensio egli dimostra l’indispensabilità del filosofare. Nella Consolazione
mette in rilievo la funzione della filosofia di fronte alle sventure e alla morte stessa. Ne risalta tutto il potere,
se la filosofia può consolare e lenire il dolore per la morte delle persone più care. Negli Academica controbatte
lo scetticismo mediante il probabilismo della nuova Accademia.501 Alla mente umana è riconosciuta la
capacità di avvicinarsi alla verità. Nel De finibus confuta la dottrina epicurea che pone il fine dell’uomo nel
piacere e non nella virtù. Nelle Tusculanae Cicerone discute argomenti essenziali dell’etica: se la morte e il
dolore siano mali; come la saggezza mette al riparo dai turbamenti; se la virtù da sola dia la felicità. Intorno
Ragione; invece non riguardano le cose “indifferenti”. In questo senso, ciò che ricade nell’ambito di queste ultime
(come, per esempio, una circostanza avversa o una sventura) non incide sulla felicità (sulla base del principio che
“nessuno degli eventi esterni può ostacolare la felicità”).
500
Sulla filosofia di Cicerone, cfr.: L. Alfonsi, Cicerone filosofo, in “Studi Romani” 1961, pp. 127-34; A. Michel,
Ciceron et le grands courants de la philosophie antique, in “Lustrum”, 1971-72, pp. 81-198; G. D’Anna, Alcuni aspetti
della polemica antiepicurea di Cicerone, Ateneo, Roma 1965; F. Giancotti, Profilo interiore del “De finibus”, Ateneo,
Roma 1975; M. Pohlenz, L’ideale della vita attiva secondo Panezio nel “De officiis” di Cicerone, Paideia, Brescia
1970; A. Grilli, I proemi del “De repubblica” di Cicerone, Paideia, Brescia 1970. Fra le edizioni delle opere
filosofiche: Hortensius (Grilli, Milano 1962); De finibus e Tusculanae (Marinone, UTET 1972); De divinatione
(Timpnaro, Milano 1988). Nella BUR: L’amicizia (Narducci, pp. 176); Bruto (Narducci, 428); I doveri (Giussani, 432);
Il fato (Antonimi, 102); La natura divina (Calcante, 410); Dell’oratore (Narducci, 746); Tuscolane (Narducci, 560); La
vecchiezza, Narducci, 240). Negli Oscar: Bruto (Malcovati, pp. 320); Dei doveri (Arfelli, 370); Dello stato (Resta
Barrile, 300); De senectute, De amcitia (Pacitti, 220); L’oratore (Barone, 210); La retorica a Erennio (Cancelli, 650);
Sulla natura degli dei (Pizzani, 440); Le Tusculane (Di Virginio, 550).
501
Cicerone intende evitare sia il dogmatismo degli accademici ortodossi sia lo scetticismo, optando per un
probabilismo critico. Egli, pertanto,
alla conoscenza del divino, nel De natura deorum, esprime la sua convinzione nei limiti umani e mette in
rilievo le difficoltà che s’incontrano allorché s’intenda conseguire una chiara nozione in materia religiosa e
teologica.
Cicerone fondatore di “humanitas”. Cicerone si attribuisce giustamente il merito di avere tradotto in elemento
della romanità il concetto greco di “educazione e cultura dell’uomo”, di quella concezione della cultura che è
basata sul famoso imperativo che impone la ricerca intorno alla realtà umana (“Conosci te stesso”). Questa
cultura assume in primo luogo il carattere di consapevolezza dei limiti della conoscenza umana. Perciò
Cicerone propende per il probabilismo della Nuova Accademia (quello di Filone di Larissa e di Antioco di
Ascalona).502 Non si può parlare di certezza o di verità assoluta; si può solo conseguire una conoscenza
basata specialmente sulla testimonianza dei sensi, per cui l’esperienza rappresenta l’ambito stesso della
conoscenza e assume il carattere di criterio della verità in relazione alla sua costituzione universale. Così la
ricerca dell’universalità è ricerca dell’umanità stessa e di quell’esperienza che è riconosciuta da tutti i
soggetti. Cicerone ammette qualcosa come una dimensione trascendentale dello spirito umano, la presenza
in tutti gli individui di un patrimonio di “semina innata” (disposizioni naturali)503 delle virtù e di una
fondamentale capacità di produrre alcune conoscenze fondamentali, “sine doctrina notitias parvas rerum
maximarum”.504 Qui in qualche modo si riprende il motivo protagoreo del consenso umano come criterio di
verità. Ciò che all’uomo è possibile costruire è un “discorso migliore”, idoneo a consentire una più ampia
vita civile. Che sia insuperabile il relativismo è provato, secondo Cicerone, dalla diversità delle tesi proposte
come soluzioni dei problemi e dal dissenso che regna tra i filosofi.505 Cicerone assume come criterio di
saggezza lo stesso principio della verosimiglianza e della probabilità, ritenendo segno di insipienza la
pretesa di conoscere il vero e di conseguire nozioni definitive e complete.506
Egli rifiuta ogni dogmatismo e, pertanto, avverte che non è possibile abbracciare in modo definitivo una
particolare dottrina e bisogna rimanere disponibili a mutare la propria opinione, se nuovi elementi
intervengono a delineare meglio il campo della nostra conoscenza. D’altra parte, nessuno potrà mai dire che
una data dottrina è errata, almeno che ciò non sia attestato da un consenso generale.507 L’eclettismo di
Cicerone, più che una raccolta di opinioni attinte a scuole diverse, è un modo di seguire la libertà di
pensiero, in modo da non essere obbligato a una linea particolare espressa da una scuola.508
Il criterio del probabile non impedisce a Cicerone di affrontare i massimi problemi, che egli ritiene propri
della filosofia. Il principale problema, al quale tutti gli altri si connettono e rinviano, riguarda la definizione
del sommo bene, cioè di ciò gli uomini devono perseguire come costitutivo della propria natura, dunque il
fine, il “telos” fondamentale, che coincide con l’attuazione dell’umanità stessa. Il “sommo bene” è il fine
ultimo per l’uomo. Si può dire conoscenza quella che riguarda questo termine fondamentale. Se si ha tale
502
La formazione filosofica di Cicerone passa attraverso il pensiero di Panezio e di Posidonio, l’influenza di Filone e
le lezioni di Antioco, nonché la lettura di Platone, Senofonte e dell’Aristotele essoterico; essa appare costituita
dall’incontro di motivi neoaccademici e stoici. In questa sintesi un dato certo è la ferma avversione verso l’epicureismo.
Intorno al metodo del confronto tra tesi diverse, Cicerone stesso osserva: “A me è sempre piaciuta la consuetudine dei
Peripatetici e degli Accademici di discutere in ogni problema il pro e il contro: non soltanto perché questo sistema è
l’unico adatto per scoprire in questione l’elemento di verosimiglianza, ma anche per l’ottimo esercizio che ciò
costituisce per la parola” (Tusc. disput., II, 3, 9).
503
Tusc. disp., III, 1, 2.
504
De finibus, V, 21, 59.
505
Cfr. De natura deorum, I, 5, 12 : “Non siamo di quelli che negano in assoluto l’esistenza della verità; ci limitiamo
a sostenere che ad ogni verità è unito qualcosa che vero non è, ma tanto simile ad essa che quest’ultima non può offrirci
alcun segno distintivo che ci permetta di formulare un giudizio e di dare il nostro assenso. Ne deriva che ci sono delle
conoscenze probabili le quali, benché non possano essere compiutamente accertate, appaiono così nobili ed elevate da
poter fungere da guida per il saggio”.
506
Cfr. De officiis, II, 2, 7-8: “Come gli altri affermano la certezza di alcune e l’incertezza di altre cose, noi invece,
dissentendo da loro, sosteniamo la probabilità e l’improbabilità di altre. Che cosa, dunque, i può impedire di seguire ciò
che mi sembra probabile e di disapprovare ciò che mi sembra improbabile, e di fuggire così, evitando la presunzione di
recise affermazioni, la temerarietà, che è lontanissima dalla vera sapienza?”.
507
Cfr. Tusc. disp., IV, 4, 7: “Esiste libertà di pensiero, e ognuno può sostenere ciò che gli pare; per me io mi atterrò
al mio principio, e cercherò sempre in ogni questione la probabilità massima, senza essere legato alle leggi di nessuna
scuola particolare che debba per forza seguire nella mia speculazione”.
508
Come avverte il Reale: “Il probabilismo di Cicerone è in tal modo strutturalmente congiunto col suo eclettismo:
l’uno sta a fondamento dell’altro e viceversa ed ambedue hanno radice, più che teoretica, culturale e storica. Il che ben
spiega, tra l’altro, come, a seconda dei problemi che Cicerone tratta, il probabile si assottigli fino a diventare dubbio,
oppure, per contro, si consolidi fino a diventare quasi certezza” (Giovanni Reale, Storia della filosofia antica, Vita e
Pensiero, Milano 1980, III, p. 548).
conoscenza si può presumere di possedere la verità (sia pure nella forma del probabile e del verosimile).
“Come si vede, è sempre in chiave etica e antropologica che Cicerone affronta i problemi”.509 In primo luogo,
Cicerone afferma la certezza di un fine unitario dell’intero sistema della realtà, nel quale l’uomo è inserito.
L’intera natura gli sembra ordinata in funzione del bene umano. Perciò egli non ha dubbi sull’esistenza di Dio.
Questa esistenza gli sembra attestata da un consenso universale degli uomini. Tutti i popoli, infatti, hanno
una qualche credenza nella divinità.510 L’universo è ordinato in vista di un fine generale, dunque reca in sé le
impronte di una Provvidenza che dispone ogni cosa in vista di uno scopo. Il finalismo della natura è visibile,
poi, specialmente nella struttura dell’essere umano; e ciò fa pensare che l’uomo sia il fine dell’intera
organizzazione della natura.511 Perciò Cicerone respinge il meccanicismo degli epicurei, che esclude ogni
finalismo e riconduce tutte le vicende cosmiche al moto degli atomi.
Le opere filosofiche di Cicerone
Paradoxa stoicorum. In questa operetta, scritta nel 46, Cicerone esamina sei proposizioni paradossali
relative alla dottrina stoica.
Accademica. Gli Academica priora comprendevano due dialoghi, scritti nel 45, il Catulus e il Lucullus, dei
quali ci rimane questo secondo. E’ esaminato il problema della conoscenza secondo i neoaccademici che a
quel tempo avevano abbracciato lo scetticismo moderato (probabilismo). Gli Academica posteriora
comprendono i due dialoghi intitolati Attico e Varrone (ci è rimasto il primo). E’ possibile ricostruire il
problema della conoscenza in Cicerone, il quale tende a dimostrare la sostanziale continuità tra la nuova
Accademia e quella di Platone: convinzione comune a tutti gli accademici è che la verità non è accessibile
attraverso i sensi e che la conoscenza umana non può mai ritenersi assoluta. Nel Lucullo sono esposte le
teorie di Antioco di Ascalona, che aveva inteso restaurare il platonismo. Secondo Cicerone il verosimile è
l’unico criterio di verità accessibile all’uomo: esso è sufficiente a consentire il superamento del dubbio e la
scelta dell’opinione che presenta la maggiore utilità e ottiene il maggiore consenso.
De finibus bonorum et malorum (« I limiti dei beni e dei mali »). Il trattato, dedicato e Bruto e composto nel 45,
comprende tre dialoghi sulla definizione di ciò che è il sommo bene e di ciò che è l’estremo male per
l’uomo.512 L’argomento era configurato in rapporto alla definizione del compito proprio della filosofia, cioè
di quel fundamentum philosophiae positum in finibus bonorum et malorum.513 Il primo dialogo comprende i
libri I e II e s’immagina avvenuto nella villa cumana di Cicerone. L. Manlio Torquato espone la dottrina
epicurea, secondo la quale il bene consiste nel piacere;514 quindi Cicerone confuta tale dottrina ed espone
quella sua, che si collega a quella neoaccademica di Antioco di Ascalona e che si configura come una sintesi
di motivi platonici, aristotelici e stoici. Il secondo dialogo comprende i libri III e IV e s’immagina avvenuto
nella villa tusculana di Lucullo. M. Catone espone la dottrina stoica, alla quale Cicerone oppone a confronto
quella degli accademici. Nel terzo dialogo, che s’immagina avvenuto presso la sede dell’Accademia ad
Atene, M. Pupio Pisone espone le teorie accademiche, che trovano il generale assenso di Cicerone, il quale,
tuttavia, rileva l’esigenza di una loro revisione, per essere pienamente rispondenti alla sua concezione della
vita umana. Compito dell’uomo è differenziarsi (secondo la sua struttura e costituzione stessa) dai bruti e
perciò persegue virtù e conoscenza. Sommo bene è vivere secondo ragione.
Tusculanae disputationes. E’ un trattato in cinque libri composti tra il 45 e il 44 a. C. Cinque questioni sono
discusse attraverso un dialogo che si svolge in forma prevalentemente espositiva, tra un interlocutore che
generalmente ascolta e approva (A., “Auditor”) e il filosofo che assume la funzione di “magister” (M.). Le
questioni riguardano principalmente quei fattori che impediscono agli uomini di essere felici. Il primo libro
(De contemnenda morte) riguarda il principale di questi fattori: la paura della morte. Si dimostra che la morte
509
G. Reale, op. cit., p. 550.
Cfr. Tusc. disp., I, 13, 30: “Quanto all’esistenza degli dei, la prova più solida che se ne possa addurre è questa, a
quel che pare: non c’è popolo, per quanto barbaro, non esiste uomo al mondo, per selvaggio che sia, che non abbia nella
mente almeno un’idea della divinità. Sugli dei molti hanno convinzioni errate, e questo fatto normalmente è dovuto
all’influenza corruttrice dell’abitudine: ma tutti quanti credono nell’esistenza di una forza e di una natura divina, e
questa convinzione non è effetto di un precedente scambio di idee fra gli uomini e di un accordo generale, né ha trovato
appoggio in istituzioni o leggi: ora, in ogni questione, il consenso dei popoli si deve considerare legge di natura”.
511
Cfr. De natura deorum.
512
« La nostra indagine dunque verte su questo punto : quale sia l’estremo ed ultimo bene; ed esso, secondo il parere
di tutti i filosofi, dev’essere tale a cui convenga riferire ogni cosa ed esso a sua volta a null’altro si riferisca” (I, 29).
513
De divinat., II, 1.
514
“Epicuro definisce il piacere come sommo bene, e come supremo male il dolore” (I, 29).
510
non deve considerarsi come un male; male è invece il timore della morte, che turba la serenità della vita.515 Il
II libro (De tolerando dolore) dimostra che la ragione è la facoltà capace di vincere ogni dolore, diminuendolo
almeno di intensità. Nel III libro (De aegritudine lenenda) si dimostra che la filosofia agisce come medicina
dell’anima, vincendo le passioni e infondendo serenità. Il IV libro (De reliquis animi perturbationibus) mostra
come l’uomo ha il compito di vivere libero da affanni e timori. Il V libro (Virtutem ad beate vivendum se ipsa
esse contentam) dimostra che per la felicità la virtù basta a se stessa.
De natura deorum. E’ un trattato in tre libri, scritto nel 45 e dedicato a Bruto (come il De finibus, le
Tuscolanae, i Paradoxa, il Brutus, l’Orator).516 I tre interlocutori sostengono tre dottrine diverse intorno
all’esistenza degli dei e ai caratteri della divinità. C. Velleio espone la dottrina epicurea, secondo cui gli dèi
hanno natura interamente diversa rispetto a quella dell’universo fisico e dunque non hanno nessuna
interferenza col mondo. Alla fine del I libro Aurelio Cotta riassume i difetti e le contraddizioni della
concezione epicurea. Nel II libro Q. Lucio Balbo espone la teoria storica sul governo divino del mondo. Nel
III libro Cotta interviene per mettere in rilievo i limiti di ogni concezione antropomorfa della divinità e
avanza, perciò, l’esigenza di una concezione razionalistica e naturalistica, da contrapporre specialmente al
politeismo della religione popolare. Cicerone non avanza una soluzione propria ed esprime la sua
propensione per l’ipotesi stoica sostenuta da Balbo.
De divinatione. Il trattato, in due libri, è stato scritto a complemento dell’opera sul divino. Nel I libro il
fratello di Cicerone, Quinto, difende la credenza nella divinazione e nella mantica, ritenendole
manifestazioni della divinità. Nel II libro lo stesso Cicerone compie una vera e propria demolizione di quelle
attività, ritenendole interamente frutto della superstizione. Egli afferma la causa naturale di tutti i fenomeni.
De fato. Anche questo libro è stato composto a complemento della trattazione sul divino. Cicerone cerca di
difendere il principio del libero arbitrio dell’uomo contro ogni concezione fatalistica dell’esistenza. Ma la
trattazione rimane problematica, anche perché lo scritto è pervenuto frammentario.
De officiis. Il trattato (che è il capolavoro filosofico di Cicerone) in tre libri, scritto tra il 44 e il 43 e dedicato
al figlio Marco, riassume la riflessione ciceroniana sui problemi dell’etica e della politica. Cicerone si attiene
generalmente alla dottrina stoica di Panezio (neostoicismo), secondo cui un principio razionale governa il
mondo ed esso costituisce il motivo ispiratore dell’azione umana. L’uomo deve conformarsi all’ordine
razionale dell’universo. Nei primi due libri, sulle orme di Panezio, si parla dei principi della morale, l’utile e
l’onesto, ciò che è vantaggioso per l’individuo e la società e ciò che risponde ai criteri di giustizia e di
armonia. Nel II libro emerge specialmente il tentativo (brillantemente riuscito) di Cicerone di fondare, sulle
basi della cultura greca, l’umanesimo etico romano.
De re publica. Il dialogo (scritto tra il 54 e il 52 e pubblicato nel 51) è articolato in sei libri e introduce nella
discussione i personaggi più autorevoli in materia politica (Scipione Emiliano, Lelio, Manilio e altri), che in
tre giorni (ogni giorno comprende due libri) dipanano la complessa materia relativa alla costituzione dello
stato romano. Nel I libro Scipione dimostra che lo stato romano costituiva un modello di perfezione in
quanto derivato dal contemperamento delle tre principali forme di governo (monarchia, aristocrazia,
democrazia).517 Nel II libro si svolge l’osservazione che la costituzione romana era il frutto e il risultato di un
processo storico durato parecchi anni. Il III libro riguarda la questione della giustizia. I libri IV e V sono
quasi interamente perduti: si esaminavano le istituzioni dell’antica repubblica. Nel VI libro, sotto la finzione
di un sogno raccontato da Scipione, si parla delle connessioni delle buone istituzioni e dell’ordinata vita
civile con l’ordine cosmico e divino.518 Nel proemio si rileva che la politica è l’esercizio in atto della virtù
515
Cicerone ripropone le classiche prove intorno all’immortalità dell’anima e alla sua irriducibilità alla vita corporea.
Cfr. I, 56-59: “Ma nell’anima umana ci sono certe attività che sono divine. Non solo c’è la vita: questa è anche nella
pianta. Non solo c’è la sensibilità e l’appetito: questo è anche negli animali. L’uomo ha anche la memoria, che per
Platone è il ricordo della vita anteriore; c’è insomma il pensiero” (riassunto).
516
Bruto era considerato come il grande difensore della libertà repubblicana, contro il tentativo di instaurazione di
una monarchia dispotica.
517
“Lo stesso, un secolo prima, aveva affermato il grande storico greco Polibio il quale, esaminando la costituzione
romana, trovava che la sua forza e originalità era riposta nelle diverse forme di governo, e interpretando le forze
politiche contrastanti e coesistenti della repubblica come forze consociate di un unico Stato, riponeva il potere
monarchico nei consoli, il potere oligarchico nel senato e quello democratico nel popolo” (C. Marchesi, Storia della
letteratura latina, Principato, Milano 1950, I, p. 301).
518
Fin dall’antichità questo libro ha avuto vita autonoma, come una vera e propria opera ciceroniana (Somnium
Scipionis).
De legibus. Il dialogo in tre libri, composto verosimilmente nel 44, si svolge tra Attico, Cicerone e il fratello
Quinto. E’ un trattato di filosofia del diritto.519 Nel I libro si tratta dell’origine del diritto e dei fondamenti
naturali della legge e dell’obbligazione giuridica. Negli altri due si richiamano le principali norme che fanno
dello stato romano un modello di ordine politico fondato sulla legge e si ricordano i doveri e le funzioni dei
magistrati rispetto al mantenimento e al governo dell’ordinata vita comune.
La personalità di Cicerone. La personalità di Cicerone occupa tutta la prima metà del I secolo a. C. (dal 106 al
43). Cicerone si trovò giovanissimo nell’orbita della nobiltà più illuminata che si era formata nell’atmosfera
del “circolo degli Scipioni”; seguì, infatti, gli Scevola, “tutti e due aperti a quella filosofia stoica di Panezio,
che, una generazione prima di loro, si era trovata così in consonanza con gli ideali che veniva perseguendo la
parte illuminata del partito senatorio”.520 Al momento dell’assunzione della toga virile, scrisse i Retorici libri
(De invenzione). Cicerone prendeva posizione contro gli “audaces” che intendevano mettere l’oratoria nelle
mani dei “populares”, togliendola all’esclusivo uso dei “sapientes” (in realtà i maestri greci ai quali
attingevano i rappresentanti dell’ordine senatorio). A Roma egli quindi subì il fascino di Filone di Larissa, un
accademico che aveva riformato lo scetticismo di Carneade in senso moderato e che aveva riproposto il
metodo della dialettica, con l’esame parallela delle tesi sostenute intorno alle varie questioni. Fin da
giovanissimo, dunque, Cicerone venne attratto dalla filosofia. In particolare, si orientò verso le posizioni
accademiche di Filone e poi verso quelle platoniche di Antioco di Ascalona, ma anche verso quelle stoiche di
Panezio. L’interesse per la filosofia dovette aumentare in occasione del viaggio ad Atene, dove, insieme al
fratello Quinto e all’amico Pomponio Attico, ascoltò le lezioni dei capiscuola, specialmente quelle di Antioco
e dell’epicureo Fedro (ma convincendosi allora della scarsa affinità con una filosofia materialistica che
sosteneva l’opportunità di mantenersi estranei alla vita politica).
La retorica: il “De oratore”. Il De oratore, in tre libri, scritto nel 55, è un dialogo che s’immagina avvenuto nel
91 tra i maggiori rappresentanti dell’oratoria, Antonio e Crasso, considerati come gli esponenti dell’autentica
oratoria “politica”, cioè di quell’attività che costituiva la forma più consapevole di assunzione di
responsabilità pubbliche e di difesa del bene comune. Successivamente (nell’epoca in cui Cicerone scriveva)
l’oratoria era degenerata a strumento di lotta per il potere. Dopo un’esaltazione dell’eloquenza. Nel I libro
Licinio Crasso parla della formazione dell’oratore, che deve soprattutto alimentarsi di filosofia, come
consapevolezza della natura umana e dei doveri del cittadino. Nel II libro Antonio tratta dell’inventio, cioè
dei problemi relativi alla disposizione del discorso in rapporto allo sviluppo dell’argomento. Nel III libro
Crasso illustra il problema della forma, rilevando che essa è strettamente congiunta al contenuto, e discute
intorno a questioni specifiche di stile (elocutio).521
Nel marzo del 46 Cicerone terminava di scrivere un’altra opera retorica, il Brutus, in cui si traccia un
profilo della storia dell’oratoria in quanto riflesso della stessa evoluzione della vita politica a Roma. Gli
interlocutori sono Bruto e Attico.
Nell’Orator, scritto nel 46, Cicerone tracciò, quindi, un profilo del perfetto oratore.
Tuscolane, libro I.
Cicerone torna alla filosofia, agli “studi prediletti”, interrotti per tanto tempo. Egli si sofferma a illustrare,
nei paragrafi introduttivi, le caratteristiche della cultura romana, mettendo in evidenza come lo spirito
pratico e interamente rivolto all’espansione del dominio politico abbia determinato un notevole ritardo nello
sviluppo di quelle esperienze culturali, come ad esempio la poesia, che sono state precoci presso i Greci. Nel
confronto tra le due civiltà, egli mette in luce le differenze. Non manca perciò di rilevare una certa
519
“Si presenta così un diritto nuovo, nato ex intima philosophia, ma che trova le radici nel ius naturale e attraverso il
mos maiorum arriva a un ius civile. Vale a dire che il fondamento del diritto precede ogni legge concreta (I 6, 19); in
realtà siamo di fronte a una trattazione profondamente filosofica che parte dalle origini dell’essere umano e dalla sua
posizione finalistica nell’universo. E’ difficile oggi dire quanto è di origine medio-stoica (Panezio), quanto deriva
dall’insegnamento di Antioco d’Ascalona (certo i tocchi mistici e platonici); ancor più difficile quantificare il contributo
originale di Cicerone stesso” (A. Grilli, in Storia della civiltà letteraria greca e latina, UTET, Torino 1998, vol. II, p.
527)
520
Alberto Grilli, l. cit., p. 507. Quinto Mucio Scevola augure e il suo omonimo pontefice massimo erano tra i più
famosi giuristi. Cicerone venne anche introdotto alla scuola dei maggiori oratori, Licinio Crasso e Marco Antonio.
521
“Se il trattato è un capolavoro, lo si deve certo all’inarrivabile competenza dell’autore, l’unico a Roma che avesse
studiato a fondo la retorica dei Greci, che avesse affrontato la cultura filosofica attraverso le varie scuole, cogliendone il
valore; ma soprattutto lo si deve alla sua sovrana capacità di rendere (o saper creare) il linguaggio e lo stile d’una
conversazione dell’alta società politica e culturale” (A. Grilli, l, cit., p. 521).
superiorità dei Romani nell’organizzazione della vita civile, senza considerare, poi, l’arte della guerra.522 Per
quanto riguarda l’arte e la scienza ricorda l’indubbia superiorità dei Greci.523 Ad esempio, presso i Greci era
diffusa tra tutti la cultura musicale ed era considerato ignorante chi non sapesse suonare uno strumento. I
Romani, però, in rapporto allo sviluppo delle istituzioni civili, primeggiarono nell’eloquenza, che presto
ebbe una sua base dottrinale e teorica.524 Cicerone dichiara, quindi, il suo assunto, che è quello di contribuire
a introdurre la filosofia a Roma e di dare alla cultura latina basi teoriche solide. La filosofia, infatti, era stata
fino allora trascurata.525 E per compiere adeguatamente una tale opera era necessario unire l’eloquenza alla
filosofia, giacché era necessario non solo conoscere le dottrine dei filosofi e idee proprie, ma bisognava
esporle con proprietà e ordine. In questo senso maestro è stato Aristotele. Ed è un modello che Cicerone
intende seguire.526 In filosofia il metodo migliore è quello socratico, in cui un maestro discute con un
discepolo. Ed è il metodo che Cicerone ha seguito nello sviluppo degli argomenti che ora costituiscono la
materia di quest’opera e di cui il primo riguarda la rimozione della paura della morte e del pregiudizio che
la morte sia un male (il male estremo).527
M. e A. discutono de contemnenda morte. A. osserva che la morte è male (il male estremo) sia per chi è vivo
sia per chi è già morto. M. rileva che in modo si afferma che la morte è fattore di infelicità e che, secondo
l’opinione espressa da A., tutti gli uomini dovrebbero essere infelici. Si dovrebbe, cioè, ammettere una
infelicità generale, alla quale nessuno potrebbe sottrarsi. Ma come si può dire infelice chi è morto e che
praticamente non esiste più? Si può dire infelice uno che nemmeno esiste? A. ribatte che in tal modo si deve
intendere piuttosto che chi è morto è infelice proprio perché non esiste: un evidente paradosso. M. rileva che
la paura della morte è connessa piuttosto alla credenza nell’Ade e negli eventi che si dicono doversi
affrontare in quella sede sotterranea. Ma sulla opportunità di non credere a tutto ciò che si racconta intorno
all’Ade concordano sia A. che M. Bisogna dunque stabilire razionalmente quali ipotesi verosimili possono
ammettersi intorno alla morte, con riguardo alla concezione dell’anima. Si tratta, infatti, di considerare la
natura dell’anima, per potere stabilire anche se essa sia immortale, come hanno cercato di dimostrare filosofi
come Platone, e quale sia il suo destino dopo la separazione dal corpo. Quanto alla costituzione dell’anima,
Cicerone riporta le varie dottrine antiche e si sofferma sulla osservazione di Aristotele, per il quale è
inverosimile che sia costituita dei quattro elementi materiali un organo qual è l’anima, che svolge funzioni
che nessun essere vivente è in grado di svolgere.528 E che l’anima sia immortale è attestato dai culti dei morti
diffusi nell’antichità presso diversi popoli. Cicerone mette in rilievo come il culto dei morti, presente presso
tutti i popoli, sia un’espressione della credenza nell’immortalità dello spirito. Se le anime dei defunti si
disperdessero e di esse non rimanesse nulla, non si avrebbe tanta cura da parte dei parenti e dei concittadini
nell’onorare i sepolcri e nell’evocare la presenza dei defunti. In qualche modo gli spiriti dei defunti devono
avere una forma di vita che permette loro di partecipare alle vicende cittadine e alla stessa vita dei posteri.529
Ma quale struttura si dovrà ipotizzare come propria dell’anima? E’ verosimile che l’anima, in quanto
costituita di una sostanza che non si identifica con quelle che costituiscono i corpo, sia dotata di una naturale
tendenza a innalzarsi alla sfera celeste e che colà sia la sua sede propria. Si deve supporre che l’anima abbia
522
“Nam mores et instituta vitae resque domesticas ac familiaris nos profecto et melius et lautius, rem vero publicam
nostri maiores certe melioribus temperaverunt et institutis et legibus » (1, 2).
523
“Doctrina Grascia nos et omni litterarum genere superabat” (1, 3).
524
“At contra eratorem celeriter completi sumus, nec eum primum eruditum, aptum tamen ad dicendum, post autem
eruditum” (3, 1).
525
“Philosophia iacuit usque ad hanc aetatem nec ullum habuit lumen litterarum Latinarum; quae inlustranda et
excitanda nobis est” (3, 5).
526
“Hanc enim perfectam philosophiam sempre indicavi, quae de maximis quaestionibus copiose posset ornateque
dicere” (4, 7).
527
Le Tuscolane, infatti, seguono il trattato De finibus bonorum et malorum.
528
“Aristoteles, longe omnibus – Platonem sempre excipio – praestans et ingenio et diligentia, cum quattuor nota illa
genera principiorum esset complexus, e quibus omnia orerentur, quintam quondam naturam censet esse, e qua sit mens;
cogitare enim et providere et discere et docere et invenire aliquid et tam multa [alia] meminisse, amare, odisse, cupere
timere, angi laetari, haec et similia eorum in horum quattuor generum intesse nullo putat; quintum genus adhibet vacans
nomine et sic ipsum animum eèndele@ceian appellat novo nomine quasi quondam continuatam motionem et
perennem” (10, 22).
529
“Idque cum multis aliis rebus, tum e pontificio iure et e cerimoniis sepulcrorum intelligi licet, quas maxumis
ingeniis praediti nec tanta cura coluisset nec violatas tam inexpiabili religione senxissent, nisi haereret in eorum
mentibus mortem non interitum esse omnia tollentem atque delentem, sed quondam quasi migrationem
comutationemque vitae, quae in claris viris et feminis dux in coelum soleret esse, in ceteris humi retineretur et
permaneret tamen” (12, 27).
una natura divina. Cicerone riporta, in particolare, la concezione di Platone su questa origine divina e sulla
necessità che essa riacquisti la sua natura originaria, una volta che abbia completato il ciclo delle
incarnazioni. Infatti senza una qualche affinità con la natura divina non potrebbero aversi quelle attività che
sono proprie dello spirito.530
Tuscolane, libro II.
Cicerone dichiara che la filosofia è per lui uno studio necessario, che debba riguardare la totalità degli
aspetti della vita e della realtà; ricorda di avere già nell’Ortensio ampiamente replicato ai detrattori della
filosofia e di avere affermato l’opportunità di trasferire questi studi a Roma, dopo che essi hanno avuto il
loro straordinario sviluppo in Grecia.531 Roma dovrebbe diventare, secondo il programma di Cicerone, la
nuova capitale degli studi filosofici e in essa dovrebbe fiorire una filosofia latina.532
Nella seconda giornata A. e M. discutono sui modi in cui può essere mitigato il dolore. A. esordisce
affermando che il dolore è il più grande di tutti i mali.533 Dunque, per evitare il dolore, replica M., ognuno
dovrebbe accettare di vivere non onestamente e adattarsi a ogni condizione disdicevole sotto il profilo
morale. Cosa evidentemente assurda e inaccettabile. Inoltre, nessuno potrebbe essere felice, dato che
chiunque potrebbe essere raggiunto dal dolore. A. stesso spontaneamente riconosce che il disonore è male
peggiore del dolore. Bisogna tenere presente che “non esiste bene all’infuori di ciò che è morale, e non esiste
male all’infuori dell’immorale”.534 Oppure, più propriamente, bisogna dire che “male è tutto ciò che alla
natura ripugna, bene è tutto ciò che essa accetta”. In questo modo, sono beni la moralità, la giustizia, la
dignità e le altre virtù. E se male è ciò che è contrario a ciò che conviene all’uomo, bisogna ammettere che
male è anche ciò che fa apparire l’uomo debole e vile, privo di quella forza d’animo che gli fa sopportare il
dolore.535 Il principio che il dolore è il male peggiore ci impedirebbe di agire moralmente: infatti per evitare
il dolore si compirebbero azioni riprovevoli. Bisogna, dunque, che la virtù abbia ragione del dolore. I Greci
identificano, nella loro lingua (per questo insufficiente), fatica e dolore: la fatica è lo sforzo del corpo nel
raggiungimento di uno scopo; dolore è un movimento ripugnante dei sensi. Ma bisogna ammettere che
l’abitudine alle fatiche agevola la resistenza al dolore. Cicerone richiama i numerosi casi e costumi in cui
l’esercizio della fatica diventa un allenamento a sopportare il dolore. Basta pensare alla vita che conducono i
soldati, costretti a passare le notti al freddo e ad affrontare fatiche d’ogni genere. Bisogna, dunque,
ridimensionare il giudizio comune contro il dolore e abituarsi ad affrontarlo con serenità.536 Chi è
magnanimo, dunque, sopporta il dolore. Bisogna tenere presente che la parola virtù deriva da vir che è
l’uomo coraggioso, che sprezza la morte e il dolore. Se si vuole essere uomini, bisogna possedere la virtù,
dato che virtù ed essenza dell’uomo si identificano. Contraddittoria appare la posizione degli epicurei, che
affermano che il dolore è il male peggiore e poi raccomandano di sopportarlo. Inoltre. L’uomo è l’essere
fornito di ragione; e la ragione ci consente il dominio di noi stessi. Perciò dobbiamo accogliere l’opinione di
chi ci esorta a seguire la ragione e a far sì che la ragione eserciti il suo dominio sull’impulso. Cicerone riporta
alcuni esempi di uomini che hanno sopportato i dolori più atroci pur di rimanere fedeli alla virtù: Zenone di
Elea, che sopportò tutte le torture ma non svelò al tiranno i nomi dei congiurati; Anassarco, il seguace di
Democrito, che, quando a Cipro cadde prigioniero del re Timocreonte, affrontò tormenti d’ogni specie.
530
“Mihi vero ne haec quidam notiora et industriora carare vi divina videntur, ut ego aut poetam grave plenumque
carmen sine celesti aliquo mentis instinctu putem fundere, aut eloquentiam sine maiore quadam vi fluire abundantem
sonantibus verbis uberibusque snetentiis. Philosophia vero, omnium mater artium, quid est aliud nisi, ut Plato, donum,
ut ego, inventum deorum? Haec nos primum ad ilorum cultum, deinde ad ius hominum, quod situm est in generis umani
societate, tum ad modestiam magnitudinmque animi erudivit, eademque ab animo tamquam ab oculis caliginem
dispulit, ut omnia supera infera prima ultima media videremus. Prorsus haec divina mihi videtur vis, quae tot res efficiat
et tantas” (26, 64).
531
Secondo il disegno di Cicerone, Roma sarebbe dovuta essere la capitale della cultura e della filosofia. “Quam ob
rem hortor omnis, qui facere id possunt, ut huius quoque generis laudem iam languenti Graeciae eripiant et trasferant in
hanc urbem” (2, 5).
532
“Philosophia nascatur Latinis quidam litteris ex his temporibus” (2, 5).
533
“Dolorem existimo maxumum malorum omnium” (5, 14).
534
“Nihil bonum nisi quid honestum, nihil malum nisi quod turpe” (13, 30).
535
“Dum honestas, dum dignitas, dum decus aderit, tuque in ea intuens te continebis, cedet profeto virtuti dolor et
animi inductione languescet » (13, 31).
536
“Ego illud, quicquid sit, tantum esse, quantum videatur, non puto, falsaque eius visione et specie moveri homines
dico vehementius, doloremque [eius] omnem esse tolerabilem » (18, 43).
Tuscolane, libro III.
Cicerone affronta ora il problema della medicina dell’anima. Sembra strano che gli dèi abbiano provveduto a
fornire agli uomini una medicina per il corpo e non abbiano loro fornito una medicina per i mali dell’anima.
Eppure le malattie dello spirito non sono meno gravi di quelle del corpo e noi siamo esposti ad esse, dato
che, vivendo in società, ci troviamo a dovere assimilare un insieme di pregiudizi e di errori. Una medicina
dell’anima è la filosofia. Ma qui piuttosto la medicina va cercata all’interno di se stessi.537 Cicerone ricorda
che sulla filosofia come medicina dell’anima ha già parlato nell’Ortensio. Egli riporta ora la discussione che
s’immagina avvenuta nella sua “Accademia”,538 installata nella villa di Muscolo. A. esprime l’opinione che
neppure il saggio può sottrarsi all’afflizione e alle passioni in generale. M. osserva che i Greci chiamavano
“passioni” i movimenti dell’animo non controllati dalla ragione, dunque la paura, il desiderio, l’ira, la pietà,
l’invidia, la gioia, l’esultanza, e che non è esatto classificarle tutte come “malattie” dell’anima. Comunque, se
il saggio ha la prerogativa di distinguersi per misurare con la ragione ogni comportamento, egli sapere
dominare queste manifestazioni dell’anima, che, incontrollate, potrebbero degenerare in malattie vere e
proprie, tanto da toccare la pazzia. Si può definire come insania lo stato della mente che è incapace di
controllare le passioni attraverso la ragione; e giustamente un tale stato è stato giudicato morboso. Cicerone
esamina quindi i termini di amentia e di dementia, che indicano analogamente lo stato di chi è incapace di
controllare razionalmente le passioni e che, pertanto, è esposto all’eventualità di abbandonarsi senza misura
alla paura, al desiderio, all’ira e così via.
537
“Est profeto animi medicina, philosophia; cuius auxilium non ut in corporis morbis petendum est foris,
omnibusque opibus viribus, ut nosmet ipsi nobis mederi possimus, elaborandum est » (3, 6).
538
E’ significativo che Cicerone si attribuisca il merito di avere dato vita a una seconda Accademia, cioè a una vera e
propria scuola filosofica d’indirizzo platonico.
CAPITOLO X
Il significato storico dello scetticismo
Lo scetticismo è la scuola del dubbio, la consapevolezza che la rappresentazione della realtà che noi ci costruiamo con
la nostra intelligenza, mediante la percezione e l’elaborazione dei dati sensibili in concetti che supponiamo universali,
cioè validi per tutti i soggetti, in realtà è un’illusione, e che le forme del pensiero, piuttosto che avvicinarci alla natura
delle cose, ci allontanano da essa in modo drammatico e irrimediabile. Gli scettici insegnano che nessuna verità è a
portata di mano e che, invece di credere di poter dedurre coi nostri ragionamenti le affermazioni relative all’ordine
dell’universo, dobbiamo sempre astenerci dal formulare giudizi ritenuti certi. Dobbiamo, cioè, dimorare nel dubbio e
radicare la nostra esistenza in esso: ciò sarebbe veramente saggio e utile. L’uomo si riconosce meglio in questa situazione
di disincanto, in una serena consapevolezza che la realtà continua a essere per noi ignota e oscura, nonostante tutti gli
sforzi per ridurla alle condizioni della nostra intelligenza e del nostro pensiero. Il saggio vive libero da falsi giudizi, da
illusorie rappresentazioni della realtà: egli sa i limiti dell’esistenza sono insuperabili. Come più tardi dirà Montale:
“questo sappiamo, ciò che non siamo”.
Lo scetticismo rappresenta l’acme della coscienza critica della grecità. Questa si era posta come la grande
protagonista del mondo antico, in modo particolare come la cultura che aveva approfondito (portandola
verso i suoi confini estremi) la coscienza dell’uomo. Assumere e sviluppare la consapevolezza intorno alla
condizione dell’uomo: ciò appariva come il punto fondamentale del programma che i Greci si avevano dato
come compito storico. Questo programma comprendeva non solo la conquista del sapere, ma anche
l’esperienza di una perfetta forma di vita politica. Nel mondo greco, a un certo punto, si era diffusa la
convinzione che tale programma fosse stato in massima parte attuato. I sistemi metafisici di Platone e di
Aristotele sembravano l’espressione di una acquisita conoscenza intorno alla struttura e ai princìpi della
realtà. L’universo appariva svelato non tanto nei suoi aspetti fenomenici, dominio dell’apparenza mutevole,
bensì nella sua struttura permanente ed essenziale. In tal modo il mistero della realtà appariva svelato: i
Greci erano venuti ad abitare nella dimora stessa della Verità. Il divino non era più qualcosa di lontano e di
irraggiungibile, ma era, invece, a portata di mano. Aristotele considera il più alto grado del’esperienza
umana, la vita teoretica, puramente intellettuale, come il godimento stesso delle cose divine.
Lo scetticismo è la coscienza che tutto ciò non era altro che un’illusione umana. La verità è irraggiungibile,
l’intelletto è limitato; la pretesa di conoscere la struttura immutabile delle cose è soltanto illusoria; la realtà è
inafferrabile e l'esistenza è condannata a dibattersi in un groviglio di contraddizioni. Gli uomini sono portati
inevitabilmente a credere ora in alcune e ora in altre cose: altro che cogliere le essenze immutabili!
Lo scetticismo rappresenta il ritorno del grande tema tragico dell’esistenza come limite e contraddizione.
Mario Untersteiner ha interpretato i sofisti come espressione della consapevolezza a cui è giunta la coscienza
greca intorno alle contraddizioni dell’esistenza. I sofisti, in realtà, avevano indicato una via per potere
operare “politicamente” nell’ambito della condizione tragica: Protagora intendeva insegnare come
sviluppare il “discorso migliore” per la città, dunque come riuscire a mediare le opposizioni tra i punti di
vista e capovolgere la contrapposizione di tesi e opinioni in concordia unanime intorno a ciò che fosse
meglio per tutti. Liberare, dunque, la città dalle contraddizioni, dalle opposte opinioni, e, di volta in volta,
ricomporre l’equilibrio politico: questo era il compito dell’intellettuale consapevole dei limiti della
condizione umana.
Gli scettici riprendono il programma dei sofisti; ma indicano una via diversa: la via del disimpegno,
dell’”esonero”. Si trattava di evitare gli spazi umani in cui maggiormente si esprimeva la contraddittorietà,
dunque le controversie sui grandi problemi e la stessa vita politica.
La convinzione di potere giungere alla verità intorno ai princìpi e alla struttura della realtà induce il
filosofo a costruire complicati sistemi metafisici, che finiscono per dare un’idea falsata delle cose,
allontanano dalle cose stesse, inducono a riflettere sui concetti piuttosto che sulle cose stesse. L’idea che la
realtà sia un sistema razionale induce a riporre una eccessiva fiducia nella ragione, considerata, infine, come
la facoltà capace di dedurre e delineare il sistema dell’ordine delle cose. Così all’universo reale il filosofo
sostituisce un universo elaborato razionalmente e in questo egli quindi si sofferma, finendo per perdere
qualsiasi contatto o rapporto con il mondo effettivamente esistente.
I “dogmatici”, osservano gli scettici, si chiudono nei loro discorsi e, ritenendo di avere conseguito la verità,
smettono di investigare, negando, in tal modo, la natura stessa della filosofia, che è proprio di carattere
investigativo. La “scepsi”, infatti, è la vera filosofia. L’uomo, non potendo raggiungere la verità, è destinato a
rimanere sempre nel dubbio . Lo scetticismo, in questo senso, rappresenta l’estrema consapevolezza del
limite della condizione umana, che è una condizione di continua ricerca. La “sospensione del giudizio” è
l’atto per cui ogni giudizio è ritenuto sempre provvisorio e suscettibile di revisione. Ciò vuol dire, cioè,
revocare in dubbio ogni opinione e ogni giudizio.
Questo atteggiamento critico contribuisce a trovare un modo di vivere meno esposto alle contraddizioni.
Perciò gli scettici ritenevano che la loro “filosofia” li aiutasse a vivere più saggiamente, conseguendo,
specialmente, l’imperturbabilità che è propria del saggio.
Lo scetticismo metteva in rilievo il carattere provvisorio e relativo di ogni scienza e di ogni esperienza. Ciò
costituiva un elemento propulsore per la ricerca stessa. L’intero campo del sapere si profilava come uno
spazio aperto, nel quale non sono date certezze e dove, pertanto, si tratta di mettere sempre in discussione
gli elementi acquisiti. Ciò, in qualche modo, era coerente con un’epoca che abbandonava la costruzione dei
grandi sistemi metafisici e imboccava la via della scienza. A un sapere organico subentrava un sapere critico.
Lo scetticismo mette in luce, inoltre, i dinamismi attraverso i quali si formano le opinioni: essi ricordano
che ogni dato culturale è il risultato di un processo storico e che la sua validità è circoscritta a un ambito
determinato.
Gli scettici riportano, come del resto i sofisti, ogni dato all’esperienza, alla prassi: non vi è altro che la
prassi umana, come “misura di ogni cosa”. Gli uomini sono indotti a pensare il mondo in determinati modi
perché percepiscono e elaborano i dati dell’esperienza in base a certe categorie, e sono, di volta in volta, le
categorie impiegate a determinare la complessiva visione del mondo. Si può essere indotti anche a
considerare le cose “sub specie aeternitatis”, se l’”eternità” è la categoria (modalità) temporale dal cui punto
di vista si ragiona e si sviluppa il discorso.
Lo scetticismo rappresenta il momento di estrema radicalizzazione del dubbio. Il dubbio radicale sarà
anche il dubbio iperbolico di Cartesio: il dubbio che mette tra parentesi ogni opinione, per ricominciare da
capo. Gli scettici antichi invitano a mettere in discussione il sapere sistematico, per ricominciare di nuovo
l’opera di edificazione del sistema scientifico. Il dubbio, nello stesso tempo, aveva la funzione di liberare la
cultura del tempo dal dogmatismo, dalla chiusura, in modo che essa potesse confrontarsi anche con altre
culture e con altri modi di vedere le cose. Gli scettici invitano a uscire dal chiuso mondo della grecità e di
considerare la multiforme esperienza dell’uomo nel tempo.
Sviluppo dello scetticismo nell’antichità
“Skéosis” in senso originario vuol dire “riflessione”, “ricerca” di ordine razionale, dunque anche “esame
critico”, “verifica” di validità scientifica e conoscitiva, e anche “dubbio” (“sképtomai”, ricerco con un senso
di radicale atteggiamento di dubbio e sfiducia nei poteri conoscitivi della mente umana). In senso specifico e
con riferimento a un determinato orientamento filosofico, il termine venne quindi usato per indicare il
pirronismo, cioè la dottrina critica intorno alla possibilità umana di dar luogo a una conoscenza positiva della
realtà, elaborata da Pirrone tra il IV e il III secolo a. C. e ripresa dai suoi discepoli, successivamente accolta e
sviluppata, con modificazioni in senso probabilistico, dall’Accademia tra il III e il II secolo, infine
approfondita specialmente da Enesidemo e da Sesto Empirico, che ne fu il principale sistematore, con i
fondamentali Schizzi pirroniani e l’ampia rassegna storica Contro i matematici e Contro i logici.539
539
Sesto Empirico, Hypotyposes Pirronianae, tr di O. Tescari, poi riveduta da A. Russo, Laterza, Bari 1926 e 1988;
Contro i matematici e Contro i logici, a cura di A. Russo e G. Indelli, Laterza, Bari 1990.
Nel corso storico del suo sviluppo nell’antichità, il termine “scepsi” andò, quindi, assumendo significati
particolari: dapprima significò “la negazione totale in ordine alla possibilità di conoscere”,540 perciò la
demolizione stessa di ogni presunta verità e di ogni dimensione logica e conoscitiva del reale (per cui,
dunque, il reale sarebbe inintelligibile, inafferrabile e incomprensibile, tale da non potere essere trasferito sul
piano logico e concettuale), con la conseguente negazione di qualsiasi validità dell’esperienza e del pensiero;
quindi indicò l’atteggiamento di sospensione di ogni giudizio intorno alla realtà delle cose (attribuendo “alla
stessa sospensione non una intenzionalità ontologica, bensì un valore provvisorio e di evasione”541); infine
significò l’esigenza di sottolineare il carattere relativistico di ogni conoscenza e specialmente l’impossibilità
di riferire i dati dell’esperienza e del pensiero a una realtà assoluta. In questo senso lo scetticismo assume il
carattere di antidogmatismo, pensiero critico, che attribuisce alla conoscenza un valore ipotetico, provvisorio,
“falsificabile”. 542
Pirrone di Elide (nel Peloponneso) visse tra il 360 e il 270 a. C., partecipò alla spedizione di Alessandro
Magno in Asia e in India conobbe i fachiri e i gimnosofisti, i quali praticavano una vita sostanzialmente
ascetica, caratterizzata dall’indifferenza verso la scienza e i bei derivati dalla civiltà, e ne rimase influenzato a
tal punto che cercò poi di riportarne i motivi dominanti nella sua dottrina e nella sua stessa condotta pratica
(rifuggendo dagli onori che s’intendeva tributargli e dagli impegni della vita sociae, professando un certo
ascetismo e, specialmente, ricercando la tranquillità interiore); fondò quindi una scuola nella sua stessa città
natale. Il suo principale discepolo fu Timone di Fliunte, il quale nei suoi Silli (poesie satiriche) ha lasciato le
prime fondamentali testimonianze sull’indirizzo scettico, dato che Pirrone non scrisse nulla.
Sulla questione della natura delle cose, Pirrone avrebbe dichiarato che essa è del tutto inafferrabile e che,
pertanto, le cose si presentano “ugualmente indifferenti e indiscernibili”. Da questo punto di vista, le
distinzioni che noi operiamo nella comprensione della realtà sono arbitrarie e non hanno nessuna
corrispondenza nelle cose: così noi distinguiamo l’essere e il non-essere, il soggetto e i predicati, il
sostanziale e l’accidentale, e così via, e procediamo alla identificazione di oggetti, presumendo stabilire
l’ordine immutabile dell’universo e conoscere le cose nella loro natura propria. E’, pertanto, illusorio
pretendere di distinguere il vero dal falso: la “verità” corrisponde a una nostra (del tutto arbitraria e
soggettiva) modalità di interpretare la nostra esperienza, facendo corrispondere ad essa presunti aspetti
reali. Noi possiamo dire come la nostra esperienza si viene articolando, come le nostre impressioni si
svolgono, in mood che noi abbiamo via via l’apparenza di forme diverse (che noi identifichiamo con le cose);
possiamo, dunque, cogliere la dimensione fenomenica in cui siamo immersi (e che si identifica con la nostra
stessa esistenza) e descrivere la nostra esperienza delle cose, non dire qualcosa delle cose stesse.
Analogamente accade per i valori morali. Non c’è un bene e un male per natura; non ci sono criteri uniformi
per valutare il comportamento umano e non possiamo dire che un’azione è giusta o ingiusta. I “valori” sono
relativi e molteplici; per cui la stessa cosa da alcuni è considerata utile e da altri dannosa.543
L’atteggiamento scettico, dunque, è caratterizzato dal disimpegno di fronte a ogni verità e a ogni valore
obbiettivo. Si tratta di seguire i fenomeni e sospendere il giudizio sulle cose in sé. Lo scettico rifugge da ogni
dogmatismo, non attribuisce valore di verità a ciò su cui è sempre possibile dubitare; egli rifiuta una tesi o
l’altra, senza inclinare né da una parte né dall’altra, e rimanendo impassibile di fronte a ogni situazione. Ciò
tuttavia non vuol dire rimanere inattivi, quando le circostanze impongono di agire.544
540
M. Dal Pra, Lo scetticismo greco, Bocca, Milano 1950, p. 8.
M. Dal Pra, op. cit., p. 9.
542
Sesto Empirico così intese riassumere i motivi propri dello scetticismo: “Lo scetticismo esplica il suo valore nel
contrapporre i fenomeni e le percezioni intellettive in qualsivoglia maniera, per cui, in seguito all’egual forza dei fatti e
delle ragioni contrapposte, arriviamo alla sospensione del giudizio, quindi all’impertubabilità” (Hyp., I, 4, 8); e più
precisamente: “L’indirizzo indagativo (scettico) si chiama anche investigativo, dall’azione di investigare e di indagare;
sospensivo, dallo stato d’animo che nasce dopo la ricerca sull’oggetto dell’indagine; dubitativo, sia per il dubitare di
tutto e l’investigare, come taluni dicono, sia per l’esitazione a dare e negare l’assenso; pirroniano, per l’apparirci
Pirrone pervenuto alla scepsi in modo più pieno e manifesto rispetto a coloro che lo precedettero” (Hyp., I, 3).
543
“Nulla infatti Pirrone diceva bello né brutto, né giusto né ingiusto; e similmente in ogni cosa nulla esiste in verità,
ma per convenzione e per abitudine gli uomini fan tutto, giacché ciascuna cosa non è in quel dato modo più che in quel
dato altro” (Diogene L., IX, 61).
544
“Diciamo dunque che criterio dell’indirizzo scettico è il fenomeno, chiamando così la rappresentazione che ne
abbiamo. Giacché esso, consistendo nella persuasione e affezione involontaria, non può essere oggetto d’indagine. Per
ciò sul fatto che l’oggetto ci appaia così o così, nessuno forse soleva dubbi; ma sul problema se sia tale quale appaia si
ndaga. Attenendoci ai fenomeni, dunque, secondo la comune pratica della vita, viviamo senza dogmi: poiché non
possiamo vivere del tutto inerti” (Sesto Empirico, Hyp. P., I, 22-22).
541
Per quanto riguarda le cose per ciò che esse obbiettivamente sono, lo scettico si colloca in una posizione
di “non pronunciamento” (“afasia”).545
L’astensione dal giudizio conduce a una condizione più generale di imperturbabilità (“atarassia”).546
Il probabilismo dei neo-accademici
Con Arcesilao di Pitane (315-241 a. C.), l’Accademia assunse un indirizzo scettico; e questo orientamento
venne portato a un considerevole livello teorico da Carneade di Cirene (214-129 a. C.), che nel 155 fece parte
dell’ambasceria dei tre filosofi, inviata da Atene a Roma.
Arcesilao afferma che non si dà mai una condizione di assoluta certezza e rifiuta il criterio stoico della
comprensione basata sulla rappresentazione “catalettica” (tale, cioè, che per la sua evidenza ci costringe a
considerarla come vera), obiettando che non si dà nessuna rappresentazione sulla quale non sia possibile
dubitare: la rappresentazione non è mai vera per se stessa e l’assenso non può essere sostenuto e
determinato dall’evidenza implicita in essa; essa evidenzia soltanto se stessa e non qualcosa di reale a cui sia
riferita: dunque non può essere considerata vera o falsa (nel senso della corrispondenza o meno all’oggetto).
Né la ragione può costituire criterio di verità: infatti essa è guidata dalla rappresentazione, che mostra
l’oggetto su cui verte il giudizio. E così detto giudizio non può essere fornito dalla dialettica, la quale non
può definire l’affermazione vera, eliminando gli elementi di dubbio e di ambiguità che essa reca in sé (ad
esempio, non si può stabilire se sia vera o falsa neppure una proposizione di questo tipo “se dici di sentire, e
lo dici con verità, menti o dici il vero?”).547 Così, “non essendoci comprensione, tutte le cose resteranno
incomprese (acatalette)” in modo che “il saggio sospenderà il suo assenso”.548
Connessa all’epoché è anche qui l’impertubabilità.
Se non si dà un criterio di verità, è tuttavia necessario seguire un criterio di condotta. Secondo Arcesilao,
tale criterio è il “plausibile” (eulogon): l’azione retta, cioè, è quella che ha una plausibile giustificazione.549
Carneade polemizzò specialmente contro lo stoico Crisippo e sviluppò alcune celebri confutazioni sui
concetti di libertà e necessità, sulla divinità e la provvidenza, sul problema del male, cercando di demolire
specialmente la teologia stoica, basata sull’idea della razionalità del mondo. As esempio, egli contrapponeva
la presenza del male all’idea dell’ordinamento teleologico dell’universo e metteva in rilievo la stessa
contraddizione implicita nella concezione stoica della divinità (che deve avere i caratteri dell’infinità, eternità
e perfezione), come un essere vivente razionale.
Secondo Carneade, il criterio dell’azione è dato dalla rappresentazione persuasiva (“pithanon”), cioè da
quella rappresentazione che appare vera e che è sostenuta dalla regolarità del suo verificarsi e dal fatto che
non sia contraddetta.550
Enesidemo e Sesto Empirico
La scuola pirroniana risorse per opera di Tolomeo di Cirene ed ebbe come suoi notevoli rappresentanti
Enesidemo e Sesto Empirico. Il primo visse nel periodo dell’inizio dell’era volgare e scrisse i Discorsi pirroniani;
l’altro visse tra il II e il III secolo d. C. e apparteneva alla scuola dei medici “empirici” (i quali ritenevano
inutile nella medicina la ricerca delle cause e ai attenevano all’accertamento delle condizioni del malato e dei
sintomi delle malattie). Le opere di Sesto Empirico (Ipotiposi pirrroniane, in 3 libri; Contro i matematici, in 11
libri, distinti in due gruppi che possono essere considerati anche come opere a sé, cioè 6 libri Contro i
matematici e 5 Contro i logici, cioè contro i sostenitori della scienza e i dogmatici)presentano una trattazione
545
“L’afasia è l’astensione dal pronunciarci” (Ib., I, 192).
“Diciamo che il fine dello scettico è l’imperturbabilità nelle cose che riguardano l’opinione e la moderazione nelle
affezioni derivanti da necessità” (Ib., I, 25). Chi crede che vi siano beni o mali per natura, si turba di tutto: ad esempio,
allorché teme di perdere i beni che possiede a allorché insegue quelli che non ha e che desidera. Invece chi è incerto
sulla natura del bene e del male, modera le sue affezioni e dunque evita il turbamento. Lo scettico, rinunciando a
credere che vi siano mali per natura, riduce e modera la sofferenza; gli stesi mali “naturali”, come il dolore, sono
ricondotti, infatti, all’impressione (l’unica che rimane) e ad essi non è attribuita una valutazione negativa.
547
Cfr. Cicerone, Ac., II, 95.
548
Sesto Empirico, Ad. Math., VII, 155.
549
Ib., VII, 158.
550
Cfr. op. cit., VII, 166-189.
546
sistematica dell’intera dottrina scettica, con riferimenti puntuali alle varie argomentazioni e polemiche svolte
dai vari rappresentanti di essa contro le diverse filosofie e ipotesi scientifiche fino allora succedutesi nella
storia del pensiero.
Sono famosi i dieci motivi (tropi) della sospensione del giudizio, formulati da Enesidemo: 1) le
rappresentazioni delle cose sono relative alla costituzione fisica dei diversi animali (il cane vede il mondo in
rapporto agli stimoli che riceve dall’ambiente e alla costituzione dei suoi organi); 2) anche la differenza tra
gli individui umani determina una varietà di rappresentazioni, di affezioni, di giudizi;551 3) la relatività delle
opnioni è inevitabile, data la differenza e relatività delle sensazioni;552 4) bisogna tenere conto anche delle
varie circostanze in cui si svolge l’esperienza, ad esempio lo stato della veglia e quello del sonno, le varie età,
la condizione dell’essere in moto e dello stare fermo, dell’amare e dell’odiare, del desiderio e bisogno e della
sazietà e soddisfazione, dell’avere coraggio e paura, e così via; 5) le cose appaiono differenti anche in
rapporto alla loro posizione, agli intervalli e a luoghi diversi: per esempio, lo stesso portico visto da
un’estremità pare restringersi, da un punto mediano appare uguale; i colli delle colonne diversamente
inclinati paiono di diverso colore, e così di seguito;553 6) ogni oggetto è colto sempre insieme con altri, cioè
noi cogliamo sempre mescolanze dell’oggetto con ciò che è percepito insieme: ad esempio i profumi nel bagno
o al sole sono più forti che nell’aria;554 7) sulla rappresentazione influiscono, inoltre, le quantità e costituzioni
degli oggetti: per esempio, i grani di sabbia a uno a uno sembrano ruvidi, messi in mucchio danno
l’impressione di morbidezza;555 8) le modalità delle relazioni degli oggetti tra loro fanno apparire gli oggetti
stessi di volta in volta diversi;556 9) tale condizione si verifica anche in rapporto alla continuità o rarità del
presentarsi degli oggetti stesi: ad esempio, il sole è più impressionante di una cometa, ma poiché lo vediamo
sempre, esso ci è familiare, mentre la cometa ci appare come un evento straordinario, in modo che la
crediamo un segno divino; così le cose rare appaiono preziose, al contrario di quelle abituali e abbondanti;557
10) infine si deve considerare l’influsso dell’educazione, dei costumi, delle leggi, delle credenze mitologiche
e delle opinioni dogmatiche.558
551
“E dalla grande, anzi infinita, differenza tra le menti degli uomini è massima prova la discrepanza fra le asserzioni
dei dogmatici” (Sesto Empirico, Ad. Math., I, 85).
552
“E non riuscendo i sensi a comprendere gli oggetti, neppure la mente ci riesce” (Ib., 99).
553
Ib., 118-20.
554
Ib., 124-27.
555
Ib., 129-30.
556
Ib., 135-36.
557
Ib., 141-44.
558
Ib., 145-46.
CAPITOLO XI
Plotino
Plotino riassume il senso della cultura e della filosofia antica e trasmette all’Occidente l’eredità di quel mondo e di
quella saggezza. La sua opera è una meravigliosa “summa” della spiritualità e del pensiero greci, dunque una guida al
cammino e una fonte alla quale attingere per adeguare, di volta in volta, la realtà dei concetti al corso della storia.
Plotino è stato il grande intermediario tra cultura antica e cristianesimo e ha fornito l’apparato concettuale per
definire la nuova concezione del mondo, che, nonostante le complesse vicende di millenni di storia, rappresenta ancora
il punto di riferimento per ogni seria operazione di aggiornamento e di riforma. Perciò questo filosofo ricorre in ogni
discorso che ancora oggi si fa intorno ai grandi temi dell’esistenza, dell’uomo, del tempo e della storia: non si dà
argomentazione attuale in cui il suo nome non sia citato e rimesso in causa come imprescindibile autorità e fonte
d’insegnamento. La paideia greco-cristiana reca in gran parte la sua impronta. Plotino esprime la fiducia che l’uomo è
radicato nell’essere e la sua storia si compie all’interno di una vicenda cosmica che è il mistero ma anche la certezza
con cui ancora ci misuriamo e confrontiamo. L’uomo è il protagonista del cammino verso L’Uno/Dio che coinvolge
l’intero universo. Plotino segue questo itinerario attraverso le diverse tappe che sono quelle della vita spirituale nelle
sue manifestazioni pratiche e conoscitive, che vanno dalla politica alla virtù morale, dall’amore alla religiosità, dalla
scienza alla mistica unità del Tutto. Le linee di una “fenomenologia dello spirito” sono state tracciate dapprima da
Plotino.
Plotino559 rappresenta, in un certo senso, un momento di rottura rispetto al mondo antico: perciò può considerarsi
come il filosofo che ha avvertito il dischiudersi di un’era nuova, per la quale, tuttavia, il pensiero antico avrebbe ancora
costituito la base fondamentale di sviluppo.560
559
Plotino appartiene all’epoca in cui già il grande filone della speculazione antica si è esaurito e la filosofia è ridotta
ormai a un lavoro esegetico, di interpretazione e di sistemazione dei testi classici. Plotino stesso dichiara di appartenere
a questa schiera di interpreti: “Noi dobbiamo credere che antichi e fortunati filosofi hanno scoperto la verità; e conviene
soltanto ricercare chi sono quelli che l’hanno trovata, e come noi ne possiamo avere l’intelligenza. […] le nostre teorie
non hanno nulla di nuovo e non sono di oggi; esse sono state enunciate, molto tempo fa, ma non sono state sviluppate, e
noi non siamo che gli esegeti di quelle vecchie dottrine, di cui l’antichità ci è testimoniata dagli scritti di Platone”
(Enneadi, III, VII, 13; V, I, 9).
560
Plotino nacque a Licopoli in Egitto nel 204 e frequentò la scuola di Ammonio Sacca, il fondatore della scuola
neoplatonica, per undici anni; al seguito di una spedizione militare dell’imperatore Gallieno in Persia ebbe modo di
conoscere le fonti della sapienza indiana e persiana; trasferitosi a Roma nel 244, fondò una scuola, che ebbe molto
successo e fu frequentata da numerosi discepoli; con l’aiuto dello stesso imperatore, tentò di fondare una città ideale di
modello platonico (Platonopoli, in Campania). Il suo biografo e scolaro Porfirio racconta che in virtù del suo intenso
spirito religioso, Plotino raggiunse quattro volte l’esperienza dell’estasi mistica. I suoi scritti furono ordinati e pubblicati
dallo stesso Porfirio in sei Enneadi, ossia in gruppi di nove libri ciascuno. I libri sono ordinati secondo un criterio
sistematico, cioè in rapporto alle tematiche trattate. I libri raccolti nella I Enneade riguardano l’uomo (1), le virtù (2), la
dialettica (cioè il pensiero argomentativo, proprio dell’intelligenza umana) (3), la felicità (4) e il suo conseguimento nel
tempo (5), la bellezza (6), il primo bene (7), i mali e la loro origine (8), l’opportunità del suicidio (9). I libri della II
Enneade riguardano: l’universo e il cielo (1), il movimento del cielo (2), l’influsso degli astri (3), la materia (4), la
Il mondo antico è dominato dall’idea dell’equilibrio, dell’armonia e della compiutezza. L’universo, nella
sua finitezza, è un tutto compiuto, pienamente realizzato; e gli enti finiti, ognuno nella sua natura, hanno
tutti una propria perfezione. Ogni ente tende a realizzare se stesso, a conseguire quella perfezione che è
intrinseca alla propria natura ed essenza. Così l’uomo, in quanto ente razionale, tende ad attuare la sua
natura, costruendo il solido edificio della conoscenza e instaurando in sé medesimo il dominio del bene
morale; e se egli guarda alla divinità è perché avverte di avere in sé qualcosa della natura divina e si sente, in
qualche modo, partecipe di essa. La tensione è diretta verso ciò che essenzialmente si è, e non tanto verso un
altro essere. Tutti gli enti concorrono insieme a costituire l’ordine dell’universo, e ognuno di essi è, si può
dire, soddisfatto del posto che occupa nel tutto, né desidera cambiare condizione o “sito”.
Plotino introduce il motivo della tensione verso un livello superiore di realtà. Ogni ente aspira a
oltrepassare se stesso, ad accogliere e realizzare in sé qualcosa della natura di ciò che è collocato in una sfera
più alta nell’ordine gerarchico della realtà universale. L’universo stesso, nella sua totalità, tende all’Uno; e
ogni ente è animato da una interna tensione che lo spinge all’oltrepassamento di sé.561 E’ chiaro, poi, che
questa tensione è particolarmente acuta nell’uomo, che è consapevole della sua condizione e in tutte le
manifestazioni di sé non fa che esprimere questo impulso costitutivo. In qualche modo, vi è in ogni ente la
tendenza all’immortalità, al superamento della finitezza. L’universo tende all’Uno, all’assoluto: cioè tende ad
una perfezione compiuta, ad una condizione totalmente perfetta. E l’Uno stesso, eternamente, riassorbe in sé
ciò che da esso proviene ed emana.562
potenza e l’atto (5), la qualità e la forma (6), il mescolamento totale (7), i modi in cui appaiono gli oggetti più lontani
(8), la bontà del demiurgo. La III Enneade prosegue il discorso sul mondo e sul governo provvidenziale di esso e perciò
toccano i seguenti argomenti: il Destino (1), la Provvidenza (2 e 3), il Demone che abbiamo avuto in sorte (4), l’amore
(5), l’impassibilità delle cose incorporee (6), l’eternità e il tempo (7), la natura e l’Uno (8), altre questioni (9). I libri
della IV Enneade sono dedicati all’anima e riguardano: l’essenza dell’anima (1 e 2), difficoltà relative alla trattazione
sull’anima (3, 4, 5), la sensazione e la memoria (6), l’immortalità dell’anima (7), la discesa dell’anima nel corpo (8), se
tutte le anime formano un’anima sola (9). La V Enneade è dedicata all’Intelligenza e i nove libri riguardano i seguenti
argomenti: le tre ipostasi (1), la generazione e l’ordine delle cose che provengono dalla prima ipostasi (2), le ipostasi
intelligibili (3), l’Uno (4), gli intelligibili che sono compresi nell’Intelligenza e il Bene (5), pensiero ed essere (6), le
idee delle cose particolari (7), la bellezza intelligibile (8), l’intelligenza, le idee e l’essere (9). La VI Enneade tratta
dell’Uno e i nove libri toccano le seguenti tematiche: i generi dell’essere (1, 2, 3), l’Uno e la sua identità (4 e 5), i
numeri (6), l’origine delle idee (7), la libertà e la volontà dell’Uno (8), il Bene (9).
561
Hegel ha individuato in questo nuovo modo di concepire l’ente determinato l’autentico significato speculativo del
neoplatonismo: “Plotino non si preoccupa, - egli scrive – come Aristotele, di cogliere gli oggetti nella loro
determinatezza, ma di riportarli alla loro unità e di far valere, contro la loro apparenza, il loro elemento sostanziale. […]
[La metafisica di Plotino] consiste nel ricondurre l’anima degli oggetti particolari alla intuizione dell’Uno […]”.
562
In quanto infinito, l’Uno non ha figura né parti né forma (V, 5, 11); esso è al di là di ogni determinazione: “non
dunque alcunché, né qualità, né quantità, né intelletto, né anima, né mobile, né immobile, né in luogo, né in tempo, ma
in se stesso uniforme, anzi informe, anteriore a ogni forma, movimento o quiete” (VI, 9, 3); non ha specie o essenza,
trascende l’essere ed è al di là di ogni comprensione: “Di lui è falso anche predicare l’unità: di lui non c’è discorso né
scienza; egli va detto anche trascendente l’essenza” (V, 4,1). Esso è potenza illimitata che si esprime in un processo di
autocreazione: “Per virtù di lui stesso, a lui stesso e da lui stesso viene l’essere; non è tale, dunque, quale gli toccò di
essere, ma quale egli volle, tale è” (VI, 8, 6). L’Uno è superiore al pensiero: la conoscenza che egli ha di sé, infatti, è
immediata e diretta: “non essendoci alcuna specie di intervallo né di differenza rispetto a se stesso, l’intuire se stesso
che sarà se non lui stesso?” (VI, 7, 39). Dunque dell’Uno non si può predicare nessun attributo: perciò “possiamo dire
quel che non è, non ciò che è” (V, 3,14). Dall’Uno tutto procede per emanazione, cioè per un irraggiamento della sua
potenza: “Un raggiare di luce da esso, ma che resta in sé, come dal sole il fulgore s’irradia tutt’intorno” (V, 1, 6). Tutte
le cose sono nell’Uno, ma esso non si identifica con nessuna di esse (III, 3, 7; V, 2, 1).
Lo Zeller ha sostenuto, in particolare, l’interpretazione panteistica del neoplatonismo: “Il sistema di Plotino è
panteistico perché afferma un tale rapporto tra il finito e la divinità, per cui al finito non spetta nessuna realtà
indipendente: tutto il finito è semplice accidente, manifestazione del divino. Secondo Plotino tutto ciò che è derivato è
sorretto soltanto dalle forze fluenti dell’essere originario; e queste forze non sono separate dalla loro origine, ma,
piuttosto, c’è una sola energia in atto che tutto comprende, compenetra e determina. […] In quanto l’essere originario
produce tutto, in questo suo produrre è presente a tutto, tutto partecipa di lui, tutto è in lui. Questa presenza di Dio non è
però sostanziale, come nel sistema stoico, ma soltanto una presenza di azione. […] Questa presenza del divino, poi, nei
gradi inferiori dell’essere è sempre mediata da quelli superiori. Sulla parte agisce anzitutto la parte, e soltanto attraverso
la parte agisce il tutto. Tutto il mondo dei corpi è nell’anima, e l’anima nell’intelletto, e questo nell’Uno: O, in un’altra
formula: La più interna delle sfere concentriche (l’intelletto) viene illuminata dal centro, la seconda (l’anima)
dall’intelletto, la terza (il mondo corporeo) dall’anima” (La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, parte III,
sezione II). In questo modo, ogni essere inferiore stabilisce il suo rapporto con le ipostasi superiori e con l’Uno stesso
attraverso la mediazione degli esseri superiori ad esso: il sistema di Plotino presuppone, per ogni ente, una funzione
Così nel reale si instaura la dialettica tra infinito e finito. L’universo, che è finito, è, nello stesso tempo,
specchio dell’Uno infinito e ad esso tende come termine del suo infinito processo. Mentre l’Uno è l’infinito
compiutamente attuato, l’universo è l’infinito nel processo del suo compimento. Questa infinità si esprime,
ad esempio, nella serie illimitata dei numeri, oppure nel progressivo avvicinamento dell’intelletto alla verità.
Il sistema gerarchico del reale implica questa tensione di un livello verso l’altro: della materia informe verso
l’universo delle forme, degli enti verso i modelli ideali, della mente verso la conoscenza. In quanto ogni ente
è realizzato nell’ambito di questo rapporto dialettico, l’intera realtà non si configura mai in un sistema chiuso
e definito, bensì si presenta nel segno del perfezionamento continuo. In ciò consiste la prospettiva
rivoluzionaria rispetto al pensiero antico: il reale non è un sistema perfetto nella sua compiuta attuazione,
ma è una totalità che si va sempre attuando. Così nessuna forma è definitiva e ogni ente è sempre
un’immagine approssimativa del suo modello ideale. La stessa molteplicità delle idee è attraversata da una
tensione che la rivolge alla ricerca dell’unità fondamentale nella quale sta la ragione di ognuna di esse. Ogni
reale, perciò, non ha un modo d’attuazione definito una volta per sempre, poiché il reale comprende non
solo l’esistente, ma anche il possibile. Per il pensiero antico era praticamente impensabile un universo diverso:
l’universo è uno e non potrebbe essere diverso da quello che è. Invece per Plotino sono molteplici le
modalità di attuazione dell’essere dell’ente e l’universo assume sempre una configurazione nuova e diversa.
La realtà di ogni ente dipende specialmente dalla tensione all’oltrepassamento di sé: essa può configurarsi in
molteplici modi. La realtà di ogni ente è sempre nuova: può avvicinarsi o allontanarsi rispetto alla
perfezione; essa dipende, infatti, dai rapporti che si instaurano con gli altri enti, dalla dialettica complessiva
che risulta dall’influsso reciproco della tensione da cui ogni ente è animato.563 L’uomo, in particolare,
attribuisce realtà alle cose, dà ad esse spiritualità e consistenza in altro da ciò che esse in un certo momento
sono. Le cose vivono diversamente nell’intelletto umano, assumono significati vari, si rivestono di aspetti e
forme nuovi in virtù della luce intellettuale che le fa apparire.
Ecco perché Plotino appare come il vero scopritore dello spirito. Egli è il filosofo che maggiormente ha
meditato sulla vita spirituale, come condizione dell’uomo e dell’universo. E’ spirituale, appunto, il potere di
attribuire nuova realtà alle cose: il potere dello spirito è essenzialmente creativo. La realtà è continuamente
creata dallo spirito e l’emanazione plotiniana è una metafora per indicare questo processo di creazione
continua. L’universo non è stabilito una volta per sempre, non ha una realtà definita e immutabile: esso,
piuttosto, assume quella realtà che via via gli è attribuita dal pensiero e dall'attività dell’uomo. Lo spirito
appare per la prima volta come il vero soggetto della storia dell’universo.564
attiva di mediazione. Dalla esposizione dello Zeller emerge con chiarezza la mirabile unità di questo sistema, capace di
rispecchiare lo spirito dei tempi, cioè di una temperie adatta ad assimilare i più vari e complessi motivi
dell’articolazione culturale del mondo antico.
563
In questo senso, per Plotino, il reale assume la configurazione del soggetto. Come ha osservato E. Bréhier, Plotino
è il vero fondatore dell’idealismo. “Il carattere originale di questo idealismo, - osserva il grande storico della filosofia
antica – per cui esso è qualcosa di nuovo e di fecondo, sta nel fatto che non considera, come l’idealismo ellenico, gli
oggetti, bensì i rapporti del soggetto e dell’oggetto. Quest’idealismo non consiste, come in Platone e in Aristotele, nel
sostituire agli oggetti sensibili oggetti pensabili, e nel fare di questi oggeti pensabili, forme o idee, l’essenza degli
oggetti sensibili. Questi oggetti pensabili rimarrebbero effettivamente oggetti, e il soggetto propriamente detto non
potrebbe che essere uno specchio che li riflette, o un ricettacolo che li contiene. Non hanno detto anche gli stoici che la
ragione è semplicemente un conglomerato di idee? Al contrario, ciò che Plotino pone alla base delle cose, ciò in cui fa
consistere la vera realtà, sono soggetti attivi, attività spirituali. […] Ciò che vi era di nuovo […] consisteva
nell’eliminare dalle realtà esterne gli oggetti fissi, e cioè le idee, o, almeno, nel farne dei modi o delle maniere di essere
dell’intelligenza, e non più delle cose; consisteva nel far entrare nel mondo intelligibile il soggetto individuale stesso,
con la ricchezza concreta e l’infinità di tutte le sue determinazioni; consisteva, infine, nel considerare le ipostasi stesse
non come cose, ma come attitudini spirituali” (La philosophie de Plotin, Paris 1928, pp. 181-182).
564
Come ha osservato W. Inge: “Per Plotino la realtà è il mondo spirituale in quanto conosciuto dallo spirito, o lo
spirito in quanto conoscente il mondo spirituale. Qui soltanto troviamo ciò che è veramente e completamente vero. La
maggior parte degli studiosi di Plotino non ha accentuato abbastanza questo punto. Essi sono partiti dall’assoluto, o
dall’anima, e hanno preso uno di questi termini come cardine del sistema; oppure hanno contrapposto il mondo
sensibile a quello spirituale, come se Plotino li avesse intesi quali due mondi tra loro contrapposti”. Plotino ha cercato,
invece, il nesso tra i diversi livelli di realtà e specialmente come la luce dell’intelligibile si riflette in quello sensibile.
L’ente inferiore è attratto da quello superiore e tende ad esso: in questo senso, non è avvertita la potenza del male,
poiché ciò che è inferiore, sia pure resistendo talvolta alla forza di penetrazione di ciò che è superiore, non può opporsi
ad esso in modo da sovvertire l’ordine gerarchico, per cui il livello più basso è compreso in quello più alto. La filosofia
di Plotino rafforza la fiducia nella capacità dell’uomo di dominare le cose sensibili con la luce dell’intelligenza. “Si
deve pure notare – scrive ancora W. Inge – che in Plotino non c’ è traccia della ‘notte oscura dell’anima’,
dell’esperienza della derelizione, a cui ha prestato tanta attenzione la psicologia moderna. La lotta del cristiano per la
L’Uno, in quanto fondamento, si costituisce, in primo luogo, come intelligibilità del reale, dunque come
pensiero in atto.565 L’Intelletto comprende il reale in quanto pensabile e intelligibile. La pensabilità è la
condizione di ogni realtà. Il sistema delle idee comprende ogni ente possibile e ogni possibile modo
dell’ente.
L’Intelletto, che costituisce la struttura razionale di ogni reale possibile, si riflette nella mente umana, che
è espressione dell’Anima.566 Questa ha il compito di animare la materia e di modellare l’universo; essa
corrisponde a un modello determinato di universo e, precisamente, a quell’universo che ha come sua base la
materia.567 L’intelletto umano è costituito per pensare questo universo determinato, il reale esistente.
La materia è l’indefinito, dunque un aspetto dell’Uno, il non-essere come totale indeterminatezza e che è
espressione dell’essere.568 Nell’Uno i contrari coincidono: il massimo di perfezione coincide col massimo di
vittoria dello spirito è più intensa di quella del platonico, perché l’oscurità contrastata del male è sentita in modo molto
più vivido. Plotino non conosce il demonio, né una malvagità operante nella natura delle cose. In tutta la sua filosofia
non c’è il senso dell’orrore. Il tono del santo neoplatonico è quieto e sereno, nella fiducia che la verità ultima del ondo
sta dalla sua parte, e che soltanto nuvole ‘nate dalla terra’ possono interporsi tra lui e il sole” (The Philosophy of
Plotinus, London 1918, vol. II, pp. 38-39; 152).
565
Le ipostasi che derivano dall’Uno sono l’Intelletto e l’Anima universale. L’Intelletto è la stessa visione dell’Uno
e che sussiste in virtù di questo suo essere visione essenziale: “L’Intelletto guarda a lui [l’Uno] per potere essere
intelletto; e lo vede non standone separato, ma in quanto è dopo di lui, e non c’è intermediario tra loro” (V, 1, 6). In
questa ipostasi si dà l’articolazione del reale in essere e pensiero. Questa articolazione costituisce la condizione primaria
della determinazione dell’essere, cioè della costituzione stessa del reale come determinazione onto/logica. Così,
“essendo due, quest’uno è insieme intelletto ed ente, pensante e pensato: intelletto in quanto pensa, ente in quanto è
pensato”; e insieme si profilano le condizioni primarie della determinazione logica e reale: l’identità e la diversità, il
moto e la quiete, il numero e la quantità, la qualità e la proprietà (V, 1, 4). L’Intelletto è la totalità del reale in quanto
intelligibile: “Sono dunque una sola cosa tutte queste: l’intelletto, l’intellezione, l’intelligibile” (V, 3, 5); tuttavia tale
identità è anche differenza (VI, 7, 41).
566
L’Anima universale è “Verbo e atto dell’Intelletto” (V, 1, 6). Essa agisce in conformità del modello ideale, dando
vita all’universo: “guardando a ciò che è prima di lei pensa, guardando a se stessa si conserva, guardando a ciò che è
dopo di lei l’ordina e governa e regge; giacché non era possibile che tutto restasse nell’intelligibile, mentre poteva in
seguito nascere altro ed altro, di esistenza inferiore, sì, ma necessaria, data l’esistenza del superiore” (IV, 8, 3).
L’Anima ha una natura duplice, in quanto da una parte è rivolta all’Intelletto e dall’altra al mondo. Essa, infatti, è
produttrice del mondo corporeo, e, in quanto essa informa l’universo, si deve dire che il mondo è nell’anima e non
viceversa: “giacché non è il corpo luogo dell’anima, ma l’anima è nell’Intelletto” (III, 6, 18).
567
L’universo è un grande sistema unitario, “che contiene tutti i viventi entro di Sé, ed ha anche un’anima unica per
tutte le sue parti, in quanto ognuna è parte di esso” (IV, 4, 32). Così come si ha l’animazione universale del mondo, così
si ha la simpatia universale delle cose: tutti gli enti sono, cioè, insieme collegati, in modo che ciò che si verifica in una
parte dell’universo si ripercuote in ogni altra parte (IV, 4, 41). L’universo nella sua totalità è armonioso e perfetto; e
anche quelli che appaiono mali o difetti non sono “inutili del tutto all’ordine e alla pienezza dell’universo” (III, 2, 5).
568
La materia è intesa come l’assoluta privazione della potenza emanativa dell’Uno, ciò che si colloca al termine
dello stesso processo di emanazione e che, in qualche modo, deve essere riassorbito in esso. Essa è da intendersi come
una condizione di indifferenza, dovuta specialmente al fatto che in essa non è più operante la potenza del Bene (o
dell’Essere). Così Plotino deduce la necessità della materia: “Ma si può cogliere la necessità del male anche per questa
via: poiché non c’è solo il Bene, di qui sorge la necessità che nella processione da lui o, se diversamente si preferisca
esprimersi, in quel perenne digradare e allontanarsi, si abbia l’‘ultimo’, dopo il quale non è più possibile che venga
all’esistenza una qualsiasi cosa: ed ecco il male. Che esista il termine successivo al primo risulta da una necessità; di
conseguenza ci sarà pure il termine estremo: la materia, cioè, che ormai non ha più nulla di lui” (I, VIII, 7). Plotino
avverte che sul piano dell’intelligibile la materia corrisponde all’indefinito, all’illimitato, all’assenza assoluta di
determinazione; dunque la connotazione della materia come “male” si ha sul piano del reale, e indica, in qualche modo,
il fatto che il processo emanativo si sia esaurito, dando luogo, così, al dominio dell’assenza stessa di ogni qualsiasi reale
(dato che ogni reale appartiene al processo emanativo). In realtà, la materia sensibile è una immagine di quella
intelligibile. Laddove, infatti, non vi è realtà di qualsiasi tipo, vi è assoluta indifferenza. Ciò che è chiaro è che anche la
materia s’inserisce nel processo dell’emanazione e, in definitiva, rientra nell’ordine delle modalità d’essere che sono
connesse a tale processo. Come dice Plotino in un altro passo: “Così, anche la materia, se essa esiste dall’eternità, non
può, appunto per questo suo esistere, non partecipare di quella potenza che elargisce a tutti il bene, con l’unico limite
della possibilità di ciascuno; ma se anche la sua nascita è solo una necessaria conseguenza di cause anteriori, neppure in
tal caso ella dev’essere scissa dal suo principio, come se questo, che pure le diede in grazia, per così dire, l’esistere,
dovesse poi di botto arrestarsi per impotenza, prima di giungere ad essa.” (IV, VIII, 6). Plotino dice, inoltre, che la
materia “nacque proprio dalla mancanza di tutto ciò che dicesi essere”; che essa, per la sua indeterminatezza, è quasi
“un’ombra e una parvenza di massa”, “una pura ansia a far da substrato”, qualcosa che “invisibile a se stesso, sfugge a
ciò che vorrebbe vederlo; e qualora uno non veda, gli sorge dinanzi, ma se quegli scruta attentamente, ritorna
invisibile”; perciò “quasi gioco fuggente”, per cui le cose che appaiono in essa sono “vere ombre nell’aombra, come in
imperfezione, cioè con l’indefinito stesso. L’Uno contiene in sé la possibilità di dare luogo a infiniti universi,
proprio a partire dalla sua indefinitezza. Esso conserva la sua natura illimitata, anche quando diviene
fondamento di un ordine definito di realtà. Perciò possibilità e necessità coesistono in esso: in quanto infinità
e indefinitezza, l’Uno è fonte di possibilità infinite; in quanto principio dell’universo definito, è principio di
necessità. Si può dire che l’universo risulta dall’assunzione di una forma definita da parte di quell’indefinito
essere che è l’Uno stesso. Nulla è fuori dell’Uno e tutto proviene da esso. Questa verità fondamentale trova
una conferma nella derivazione dell’universo dall’Uno anche dal lato negativo, cioè per la materia. L’Uno
dispone se stesso come materia per l’universo.
Se l’Intelletto rappresenta il reale intelligibile e pensabile, l’Anima è il modello del reale configurato come
esistente, cioè come tale da avere una consistenza materiale e temporale. Essa rappresenta quel modo
d’essere che corrisponde all’universo derivato dall’assunzione di una forma dalla materia indefinita.
L’universo è razionale in quanto è fondato sull’ordine delle idee: questo, infatti, in virtù della sua
trasposizione nell’Anima, diventa principio attivo di formazione degli enti che lo costituiscono.569
L’uomo riporta, in qualche modo, gli enti dell’universo sul piano del pensiero, cioè a quella condizione di
intelligibilità originaria che precede la trasmutazione delle idee in princìpi attivi della formazione degli enti.
Il pensiero riguarda l’ordine intelligibile delle idee e i modi in cui l’ordine degli enti è riportato al suo
modello.
uno specchio l’oggetto appare in un punto mentre è situato altrove”, “ombre che cadono su una ombra informe e che in
essa si rendon visibili per tramite della sua stessa mancanza di forma”; dunque, un vuoto che sembra avere tutto, dunque
un inganno, una menzogna (perciò è male) (III, VI, 7). La materia è prodotta dall’Anima che si volge verso il nonessere, che, come abbiamo visto, si situa al termine dell’emanazione. E dalla forza con cui l’Anima è riuscita a trarre di
nuovo un essere dalla materia è nato il cosmo fisico, si è prodotta, cioè, la stessa realtà corporea. L’Anima ha dato una
forma alla materia informe: “Perché non sarebbe stato giusto che a un vicino dell’Anima fosse negata la forma
razionale” (IV, III, 9). Per Plotino la materia è uno stato del reale, lo stato dell’infinitità in se stessa, come assenza di
qualsiasi limite e definizione. Come ha osservato il Carbonara: “Bisogna innanzitutto mettersi in guardia contro una
possibile interpretazione della materia secondo Plotino, che ne faccia qualche cosa di simile a ciò che in generale
intende per materia la fisica moderna. Plotino chiama materia ciò che noi diremmo piuttosto immateriale. Ciò che è
senza qualità, infatti, non può essere un corpo. La materia non è un corpo e non ha nulla di corporeo, se nel corpo si
deve pensare realizzata già una certa forma, mentre la materia è ciò che sussiste ancora informe, assolutamente privo di
qualità positive” (La filosofia di Plotino, pp. 17-18). In questo senso, la materia è presente ovunque vi sia una possibilità
d’essere, cioè ovunque qualcosa non sia atto per sé ma concorra, in qualche modo, all’attualità di qualcos’altro. La
materia non è per sé principio di determinazione, essendo, anzi, proprio l’opposto, cioè totale indeterminazione. D’altra
parte, essa, costituendo l’indeterminato, concorre alla formazione degli enti determinati, assumendo in sé quella
determinazione che le viene dalle strutture reali che provengono dall’Uno. Una materia, pertanto, riguarda anche le
realtà intelligibili: infatti anche in tale sfera si hanno processi di determinazione, che presuppongono stati di
indeterminazione. L’Intelletto, ad esempio, è la determinazione del reale in quanto intelligibile; esso presuppone uno
stato dell’intelligibile anch’esso indeterminato. Invece, è da tenere presente la differenza della materia nella sfera
dell’intelligibile e quella propria dei corpi sensibili: l’universo corporeo trae il suo essere da quella materia che si trova,
come abbiamo visto, al confine estremo del processo emanativo; esso, perciò, conserva quella natura che le deriva
anche dal non-essere: ed è, questa, la natura dell’ente corruttibile e mutevole. “Lo stesso mondo intelligibile è divisibile
in un senso, indivisibile in un altro, perché consta di una molteplicità di forme, ma queste trovano la loro unità in un
comune sostrato: se col pensiero togli da quel mondo ogni diversità o forma determinata, ciò che resta sarà informe e
indefinito, sarà cioè la materia. Nella realtà la forma non si trova mai separata dalla materia. La materia intelligibile di
Plotino trae la sua origine non già da un divenire simile a quello che vediamo quaggiù, ma da un certo processo
dialettico, il cui movimento si svolge immutabilmente nell’eterno” (C. Carbonara, La filosofia di Plotino, cit., p. 20).
Sul piano dell’intelligibile non vi è imperfezione, mentre questa è propria delle cose corporee, che, appunto, partecipano
del non-essere (della materia come non-essere). In questo modo, si può dire che mentre la materia sul piano
dell’intelligibile è solo indeterminazione, quella che concorre alla formazione dei corpi è essenzialmente non-essere,
collocandosi, appunto, al termine del processo emanativo. “Nel mondo intelligibile non trova posto la materia come
puro non-essere: colà tutto è atto e perciò anche la materia è una forma. Lassù materia e forma sono una stessa cosa e
solo per un’esigenza puramente logica (λογω) si distinguono l’una dall’altra” (C. Carbonara, op. cit., pp. 37-38).
569
La materia concorre alla formazione degli enti corporei per ciò che essi hanno di corruttibile, cioè in quanto essi
partecipano del non-essere. “La materia come povertà e privazione non è altro che la condizione negativa pel realizzarsi
del mondo della natura, poiché tutto quello che v’ha di positivo in quest’ultimo deriva dalle ragioni seminali che,
scendendo dall’anima, penetrano in essa materia e vi producono, come in un vasto ricettacolo, le forme della realtà
sensibile. La materia non ha una sua figura, non può essere circoscritta nei limiti dello spazio, non è qui o colà, e, per
conseguenza, non può essere intesa come corporeità. […] Plotino intende la corporeità come un λογοH ποιων πραγµα
ossia come una forma attiva, produttrice dell’oggetto, che non comprende in sé la materia, ma viene nella materia e in
essa appunto produce il corpo” (C. Carbonara, op. cit., pp. 55, 58).
Due sono i momenti di articolazione della realtà: quello dell’emanazione e quello dell’ascesi. Il primo è
rigidamente necessario, il secondo è affidato alla libertà dell’uomo, coincide con la storia di ogni individuo e
dell’umanità ed è dominato dalla possibilità e dalla contingenza.570
L’etica coincide con l’ascesi e riguarda il modo in cui l’uomo si eleva all’Uno e in questa elevazione reca
con sé il mondo, che, così, appare sempre di più investito della luce dell’intelligibile. La manifestazione delle
cose in una luce rivelatrice avviene in virtù di un atto spirituale. 571
L’etica riguarda, in primo luogo, la vita dell’uomo nel mondo, il modo in cui gli uomini vivono nel tempo.
Essa riguarda, quindi, la stessa vicenda temporale del ritorno dell’Uno a se stesso. Il tempo, in quanto
dimensione del mondo, indica il percorso del ritorno. L’Uno stesso si è fatto temporale, per potere, nel
tempo, tornare a sé. Insieme, l’etica è la disciplina dell’anima e in virtù della quale è compiuta l’ascesi.
Etica e politica sono connesse. L’uomo, dapprima, deve assumere consapevolezza del suo posto nel
mondo, del ruolo che svolge anche nei confronti di tutti gli altri enti. Egli sa che le cose sono espressione di
una razionalità profonda, che tocca a lui in massima parte svelare. Il significato delle cose si rivela a mano a
mano che esse vengono a fare parte del mondo umano.
In Plotino vi sono aspetti notevoli di rivalutazione della vita pubblica. Dobbiamo, tuttavia, tenere presente
che siamo in un’epoca di esaltazione dell’individualità. Il soggetto dell’ascesi è sempre l’individuo; ma la
città costituisce un momento imprescindibile nel processo dell’ascesi. L’individuo deve passare per
570
Che nel sistema plotiniano l’accento sia posto sul processo ascendente è attestato dallo stesso ordine con cui sono
stati disposti i vari trattati. In realtà, anche se nello studio del pensiero di Plotino tutti i motivi devono essere tenuti
presenti per ogni tematica specifica, poiché, appunto, si tratta di una visione organica della realtà, risulta maggiormente
rispondente allo spirito di questa filosofia una trattazione che muova dal mondo e dall’uomo e segua il processo di
elevazione all’Uno. Tale criterio, ad esempio, è quello seguito dal Carbonara: “Il metodo che intendiamo seguire –
avvertiva lo studioso – per la ricostruzione speculativa della filosofia di Plotino è quella ascendente. Considereremo
prima il mondo della natura sensibile e poiché questo sembra condizionato nel suo sorgere, oltre che dalle forme
dell’intelligibile, dalla presenza del nulla come semplice privazione e possibilità dell’essere, il vero inizio della nostra
trattazione sarà segnato dai problemi riguardanti la materia, come privazione e non-essere. Indubbiamente noi vedremo
già nel mondo dei sensi risplendere in un certo modo la luce dell’intelligibile, la cui continua presenza fa esistere tutto
ciò che v’ha di positivo nel mondo. Seguendo nell’ascesa la stessa via percorsa da questa luce nel discendere,
giungeremo alla fine alla Prima Sorgente dell’Essere, passando via via dalla natura sensibile alla sfera delle ragioni
seminali e dell’Anima, da questa al Cosmo Noetico e infine dalla Mente all’Uno. In verità l’Uno dal punto di vista
ontologico è anche il Primo cosicché si può bene affermare che nell’universo la vita discende, giungendo fino ad
esaurirsi nel nulla, sul cui oceano di tenebre galleggiano gli ultimi bagliori dell’essere” (La filosofia di Plotino, Roma
1938, p. 9). Infatti, come osserva ancora il Carbonara, “lo spirito della filosofia ploniniana non è, a considerare le cose
con acutezza e con spirito di verità, quello della discesa” (op. cit., p. 10). La filosofia di Plotino vuole essere, in primo
luogo, una dottrina della salvezza, l’indicazione della via attraverso la quale l’uomo può attuare interamente la sua
natura che è quella dell’ente somigliante a Dio. Qui troviamo, cioè, la più radicale connessione di metafisica e di
morale: la vita morale, consistente nella spiritualizzazione del mondo, si caratterizza come la stessa vicenda metafisica,
che consiste nella circolarità del processo attraverso il quale la realtà si costituisce prima attraverso un allontanamento
da Dio e, in un secondo momento, ripercorre, in senso contrario, lo stesso cammino e si ricongiunge all’Uno. Ciò che
appare come importante è il modo in cui avviene questo ricongiungimento dell’universo all’Uno. Tutte le cose hanno
senso in quanto esse sono inserite in questo processo di elevazione e di ritorno all’unità. Soltanto la luce
dell’intelligibile, nella quale le cose via via tornano a immergersi, attribuisce valore e senso alle cose stesse. Perciò
nell’intera vicenda universale emerge la presenza dell’uomo, che è il grande protagonista del ritorno all’unità del
Principio. Emerge, in particolare, la consapevolezza dell’imperfezione, del limite e del “male” che accompagnano ogni
vicenda del reale, e l’accento viene posto sui modi in cui questi elementi di negatività possono essere superati
progressivamente. La storia dell’umanità acquista, in questo senso, una dimensione metafisica: essa è la stessa vicenda
del ritorno dell’universo al Bene e, dunque, della eliminazione da esso dei motivi di male e di imperfezione.
571
“Il plotinismo è, quindi, una dottrina e un metodo delle metamorfosi dell’io. L’universo non è altro che l’aspetto
oggettivo delle diverse forme mentali. La vita noetica non è nel mondo né il mondo in essa, perché esse sono identiche.
[…] Ogni essere è per se stesso una prospettiva dispiegata su parecchi livelli. E’ questa pluralità interna quella che ci dà
la capacità di interiorizzarci sempre di più, fino a ritrovare ogni esistenza dall’interno. Ben lungi dall’irrigidire il
platonismo, il neoplatonismo dà all’essere un’estrema plasticità, un’interiorità a dimensioni multiple. Non è una
filosofia della natura, ma una filosofia dello spirito. Il punto di vista della purificazione le ridà il suo vero significato”
(J. Trouillard, La purification plotinienne, Paris 1955, pp. 208-209). Le cose assumono la loro dimensione
dall’interiorità, dal modo in cui sono pensate e dalla vita del soggetto: perciò esse hanno dimensioni molteplici, in
relazione alla molteplicità degli atteggiamenti spirituali.
l’esperienza del dispiegamento delle virtù civili, deve vivere la vita della sua comunità, per elevarsi a un
livello di approfondimento interiore della vita spirituale.572
Plotino pone l’amore per la bellezza, cioè l’atteggiamento contemplativo verso gli aspetti dell’universo,
come il primo gradino di esperienza interiore che incomincia a liberare lo spirito dai legami col mondo,
inducendolo a riguardare le cose sub specie aeternitatis. L’arte consente questo tipo di contemplazione. Il
soggetto ha l’esperienza della rivelazione delle idee nelle forme sensibili. Il mondo immutabile risplende
nella luce delle forme create dall’arte.
La conoscenza filosofica rappresenta, poi, il momento culminante dell’elevazione spirituale. La filosofia è
conoscenza delle idee non più attraverso le immagini sensibili, ma sul piano della comprensione logica e
concettuale. L’estasi, infine, rappresenta l’oltrepassamento del sapere concettuale, l’esperienza intellettuale in
cui la visione delle idee si converte nella visione del Tutto. Ma si tratta di un’esperienza inesprimibile, che
solo è vissuta e non ammette mediazioni di sorta. La visione, il pensiero, la vita stessa si fondono,
trasfigurandosi: l’individuo si congiunge all’infinito Uno e così supera la finitezza e colma il distacco che lo
separa dal Tutto.
Plotino, nel momento in cui riassume i principali motivi della filosofia greca, dà luogo a una concezione
nuova, a una prospettiva ontologica in cui è superato il tradizionale realismo ed è adottato il vero e proprio
punto di vista della fenomenologia della vita spirituale. L’intera realtà si risolve in un processo spirituale, di
cui protagonista è l’Uno, in quanto principio del reale, che si esplica essenzialmente come intelligenza e
razionalità. In quanto espressione di attività intelligente, il reale è razionale e costituisce un ordine logico
perfettamente coerente. In questo senso, il pensiero e l’essere coincidono e il reale non è altro rispetto al suo
manifestarsi: il reale, cioè, coincide col processo di manifestazione di sé. Tutto ciò che esiste corrisponde a
modalità di manifestarsi del principio, cioè a modalità dell’attività spirituale. L’uomo vive all’interno di
questo processo di manifestazione; e la sua attività di soggetto consiste nel fatto che egli è parte attiva di
questo processo. La prospettiva di considerazione della realtà muta rispetto alla tradizione: non si tratta di
considerare gli enti già costituiti in un mondo dato, bensì i processi spirituali attraverso i quali essi si
manifestano e così anche vengono alla realtà. Il piano della costituzione (attraverso la dinamica spirituale) e
quello della manifestazione (sul piano del pensiero) coincidono. Comprendendo le cose, l’uomo restituisce
572
L’acquisizione delle virtù civili costituisce il primo gradino nel processo di ritorno all’Uno; e la fuga dal mondo
di cui parla Plotino ha questo significato, di manifestare lo stato dello spirito che intende farsi “simile a Dio”. D’altra
parte, questa stessa somiglianza va intesa nel modo proprio dell’uomo, dunque dal punto di vista delle virtù, di
quell’“ordine, proporzione e accordo” che caratterizza la vita nel mondo e di cui, invece, Dio non ha bisogno, essendo
egli stesso fonte e principio di ogni ordine. Dice Plotino: “[Poiché] necessariamente i mali esistono quaggiù e
s’aggirano intorno a questi luoghi terreni, [e poiché l’anima vuole fuggire i mali], bisogna figgire di qui. Che cos’è
questa fuga? ‘Diventare simili a Dio’ dice [Platone, Teet., 176 a-b]. E noi otterremo questo, se mediante la prudenza e in
generale con la virtù, diventeremo giusti e pii. E’ chiaro che Dio possiede delle virtù, anche se non le stesse [che noi].
Se dunque si concede che possiamo rassomigliare a Dio, avendo noi, pur essendo altrimenti riguardo alle altre virtù,
quelle civili, che non sono simili a quelle di Dio, nulla impedisce che noi diventiamo uguali a lui con le nostre virtù
proprie, anche se egli non ne possiede. In che modo? Così: se qualche cosa è riscaldata dalla presenza del calore, è
necessario che anche ciò da cui viene il calore sia riscaldato? E se qualche cosa è riscaldata dalla presenza del fuoco, è
necessario che il fuoco sia riscaldato dalla presenza del fuoco? Si potrà rispondere che anche nel fuoco c’è un calore,
ma un calore inerente: così possiamo dire, per analogia, che la virtù nell’anima è qualche cosa di acquisito, mentre è
inerente nell’essere dal quale [l’anima], imitandolo, lo trae in suo possesso. Ma come nell’argomento del fuoco, si dirà
che quest’essere è la virtù stessa; lo giudichiamo infatti superiore alla virtù. E se [la virtù] della quale l’anima partecipa
fosse identica al suo principio, si potrebbe anche dire così; ma la virtù è una cosa e quel principio è un’altra. La cosa
sensibile non è uguale a quella ideale, benché le assomigli; La cosa sensibile partecipa di ordine e di proporzione,
mentre nel pensiero non c’è ordine né proporzione né simmetria. E così noi partecipiamo dell’ordine, della proporzione
e dell’accordo dal mondo intelligibile, da cui pur deriva la virtù di quaggiù; ma gli esseri intelligibili non hanno bisogno
di accordo, di ordine, di proporzione, né la virtù ha per lo alcuna utilità; nondimeno noi rassomigliamo ad essi per la
presenza della virtù. Se noi, dunque, ci rendiamo simili ad essi, non è necessario che la virtù risieda in questi” (I, II, 19).
Le virtù civili ci rendono simili a Dio in quanto “instaurano veramente un ordine in noi e ci fanno migliori, perché
impongono limite e misura ai nostri desideri e a tutte le passioni e ci liberano dagli errori: un essere infatti diventa
migliore perché, sottomesso alla misura, esce dal dominio dell’indefinito e dell’illimitato”. Le virtù concorrono a
definire la forma propria dell’uomo, che, in quanto essere corporeo, sta unito anche con la materia, che è principio di
illimitatezza. "Difatti ciò che è del tutto privo di misura è la materia che in nessun modo diventa simile [a Dio]; ma più
[un ente] partecipa della forma, più assomiglia [a Dio]” (ib.). Le virtù civili sono un primo gradino nel processo di
attuazione della vera natura umana (che è somigliante a quella divina); ma le virtù che attuano pienamente questa natura
sono quelle che portano l’anima a una completa liberazione dai legami corporei, cioè quelle che possono chiamarsi
“purificazioni” (καθαρσειH) e che dispongono lo spirito alla contemplazione dell’intelligibile.
alle cose la loro vera realtà. L’etica è un momento dell’intelligenza del reale; non vi è etica, dunque,
separatamente dall’intelligenza del senso dell’essere degli enti reali. Solo conoscendo le cose con le quali ha a
che fare, l’uomo riesce ad assumere consapevolezza del suo posto nel mondo.
Il motivo centrale della filosofia di Plotino è l’elevazione dell’uomo al Principio, la sua capacità di
ascendere, di grado in grado, fino alla contemplazione dell’Uno, che è possibile in base alla completa
purificazione dal peccato. Questo consiste essenzialmente nella rivendicazione, da parte di ogni ente, di una
autonomia dal Tutto, cioè nel volere attribuire a sé un senso indipendentemente dal senso della totalità
universale, cioè dell’Essere stesso.573 Il mondo della cultura è lo stesso cammino di riconquista del punto di
vista unitario, il processo di purificazione dal peccato e di riscatto dal male e dal limite dell’esistenza
individuale. La vita dell’individuo, infatti, tanto più è piena e compiuta in quanto essa supera la condizione
dell’isolamento individuale e acquista la dimensione della totalità cosmica. Il punto di vista che si tratta di
conseguire, per l’uomo che vive nel mondo, è quello dell’Anima cosmica: qui, infatti, sta il senso di tutte le
cose considerate nella loro unità, poiché il senso e il fine appartengono all’universo nella sua interezza e da
qui deriva ogni significato particolare. La ricerca del senso del Tutto deve animare, secondo Plotino, ogni
atto o comportamento umano. La vera spiritualità consiste nella capacità di vivere la vita del Tutto. Si tratta,
come è chiaro, di una forma di esperienza spirituale che implica una specie di metamorfosi interiore, che
ogni individuo deve compiere, ricercando continuamente se stesso.574 Ovviamente, questa ricerca si
identifica, in gran parte, con la purificazione dagli influssi corporei e con la sempre più completa attuazione
della forma spirituale dell’esistenza. Il ritorno all’Uno si compie attraverso un progressivo trascendersi della
coscienza, che è, però, conquista della consapevolezza del senso della realtà, della dimensione spirituale
dell’universo. Il cammino interiore dell’anima coincide con la rivelazione metafisica della realtà nelle
dimensioni della bontà, della bellezza e della verità. Un primo gradino è la rivelazione del Bene nel mondo,
dunque l’acquisizione della consapevolezza che la realtà è positiva, se in essa si riesce a intravedere la luce
del Principio, che le stesse cose materiali sono beni, se vengono considerate nell’unità del Tutto e non
vengono semplicemente riferite agli impulsi individuali e ai desideri e bisogni corporei. In questo senso,
occorre superare, dapprima, quel livello di vita umana, che è caratterizzato dall’utile e dal piacere, il mondo
dell’utilità e del possesso (il mondo economico). Le virtù civili rappresentano un fattore decisivo in questo
superamento: esse consentono l’instaurazione di un ordine umano fondato sull’armonia e sulla concordia e
fanno in modo che gli interessi individuali si trasfigurino in motivi di bene comune. Si tratta, quindi, di
considerare il sensibile non come un valore reale in sé ma come immagine dell’intelligibile. E’ questo il
momento dell’ascesi caratterizzato dalla contemplazione della bellezza: la bellezza è il valore che consente la
prima visione dell’intelligibile. Il bello sensibile rimanda al suo fondamento ideale, al mondo delle pure
forme; e l’arte è la prima fondamentale rivelazione dell’intelligibile. Si può dire che qui siano compendiati i
due momenti della vita universale, quello ascendente della visione delle forme ideali e quello discendente
dell’espressione sensibile. L’artista è colui che dà un’apparenza sensibile alla sua intuizione noetica delle
idee. Le cose sensibili, rivelate nella luce della bellezza, suscitano l’amore per le idee stesse, alle quali,
appunto, esse ormai rimandano. Così la ricerca si rivolge alla comprensione dell’intelligibile: si ha, cioè, il
completo rivolgimento alla vita teoretica. La dialettica si svolge interamente sul piano dell’intelligibile: essa
perciò implica l’affrancamento dello spirito da ogni influsso sensibile.575
Per Plotino, la stessa realtà ha una struttura dialettica. L’Uno, infatti, non solo è il reale nella sua completa
e perfetta attuazione (l’Atto puro di Aristotele), ma è anche l’unità che in sé risolve ogni differenza e ogni
opposizione. In quanto l’Uno si riflette nell’universo, questo è un grande organismo unitario, di cui tutti i
viventi sono espressioni e parti.576 Come si ha l’animazione universale del mondo, così si ha la simpatia
573
Le anime individuali dimenticano, cioè, di avere come loro principio e origine l’Uno e di non avere una
consistenza propria. “Origine prima di questo male è per esse l’arroganza del nascere: costituirsi nella propria
individualità con l’intento di appartenersi in modo esclusivo. Come poi hanno conseguito un simulacro di autonomia,
compiacendosene, esse si avvalgono dell’ampia capacità di muoversi liberamente; e, messesi a correre per la via
opposta, si allontanano da Dio per grandissimo tratto e perdono coscienza di discendere da lassù” (V, I, 1).
574
“Poiché chi ricerca è l’anima, la quale deve riconoscere qual fondamento abbia nella sua medesima essenza il
ricercare, al fine di sapere prima di tutto che essa ha la capacità di compiere una tale indagine, se il suo occhio è da
tanto, che prometta di vedere” (V, I, 1).
575
“Il soggetto dei sentimenti e degli appetiti inferiori è l’uomo in quanto composto di anima e corpo; va però tenuto
presente che l’anima immateriale, di per sé, rimane esente da ogni patire. L’‘eudaimonia’ dell’uomo consiste nel vivere
secondo lo spirito. La filosofia per Plotino non era, come per la Stoa, una pratica arte del vivere, ma la realizzazione del
‘bios theoretikòs’” (Max Polhenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, tr. it., Firenze 1967, p. 252).
576
Cfr. IV, 4, 32.
universale delle cose: tutti gli enti sono insieme collegati gli uni agli altri, in modo che ciò che si verifica in una
parte dell’universo si ripercuote in ogni altra.577
L’universo è, così, anche armonia di contrasti e di opposizioni.578 Nel suo complesso, l’universo è dotato di
una sua armonia e di una sua perfezione; e, se in esso non tutto è perfetto e si riscontrano limiti e difetti,
occorre sempre “guardare le parti in relazione al tutto”.579 E così, neppure quelli che appaiono come mali
sono inutili rispetto alla pienezza e all’ordine universale.580
CAPITOLO XII
Proclo e la sintesi culturale e filosofica dell’antichità
Proclo è l’ultimo grande filosofo greco e il suo pensiero rappresenta il più grande sforzo di comprendere in
una visione sistematica e organica il reale nella sua costituzione intelligibile e nella fondamentale unità della
forma naturale e di quella divina, alla cui conoscenza concorrono l’analisi razionale e la sapienza teologica.
Una sola scienza della realtà, infatti, si dispiega attraverso la storia dell’esperienza religiosa e attraverso
l’indagine fisica (così attraverso la matematica e l’astronomia); e le figure della mitologia sono
rappresentazioni simboliche delle strutture ontologiche; mentre il pensiero riporta ogni momento della
dialettica universale sul piano della chiara comprensione concettuale. In ogni parte (sia pur minima) della
realtà palpita la vita del Tutto. La filosofia greca si conclude con l’idea della struttura compiuta del reale,
ancora, dunque, con un’attestazione di meraviglia.
Proclo, nato a Costantinopoli nel 410, studiò ad Alessandria con il matematico Erone e con Olimpiodoro e
quindi ad Atene con i neoplatonici Plutarco e Siriano. Nel 438 successe a Domnino nella direzione della
scuola di Atene; morì nel 485. La Vita Procli del suo discepolo Marino è tutta un’esaltazione delle virtù di
questo filosofo, presentato come esempio di bontà, sapienza e purezza spirituale.
Egli costituisce veramente, come ha rilevato lo Zeller, non solo la sintesi conclusiva della cultura e della
filosofia greca, “ma anche l’anello che segna il suo passaggio alla scienza medievale, la quale infatti, per
tramite dello Pseudo-Dionisio, di Giovanni Damasceno e degli altri teologi greci, ha attinto alla sua scuola i
più notevoli stimoli”.581
Piuttosto lungo è l’elenco delle sue opere. Abbiamo i commenti ad alcuni dialoghi di Platone (Alcibiade,
Cratilo, Timeo, Repubblica, Parmenide) e agli Elementi di Euclide, alcune opere pervenuteci solo nella
traduzione latina del Moerbeke (De decem dubitationibus circa providentiam, De providentia ed fato et eo quod in
nobis, De malorum subsistentia), la monumentale In Platonis theologiam (in sei libri), gli Elementa theologiae
(compendio della precedente), gli Inni, opere di argomento fisico e astronomico (Institutio physica, sive de
motu; Hypotyposis astronomicarum positionum; Paraphrasis in Ptolomaei Tetrabiblon, un frammento delle opere
sulla teurgia tradotto in latino dal Ficino con il titolo De sacrificio ed magia.
577
IV, 4, 41: “E avviene […], data la simpatia d’una parte con l’altra, come in un’unica corda tesa, che toccata a un
capo anche l’altro riceve il movimento. E spesso, anche toccata un’altra corda, ha quasi un risentimento di consonanza,
anche per essere accordate secondo una stessa armonia. E se la vibrazione passa dall’una all’altra lira per simpatia,
anche nell’universo c’è una sola armonia”.
578
Cfr. III, 2, 2.
579
III, 2, 3.
580
In questo senso, “anche il vizio ha una funzione utile al tutto, diventando esempio della legge e arrecando molte
utili conseguenze”; anzi “questo è proprio della più grande potenza, di poter giovarsi in bene anche dei mali” (III, 2, 5).
581
E. Zeller, R. Mondolfo, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, p. III, vol. VI, a cura di G. Martano, Firenze 1961, p.
134. Tutti i motivi della cultura greca confluiscono, opportunamente intrecciati in una serie di rimandi reciproci, nel pensiero di
Proclo. Come osserva G. Martano: “Quella di Proclo è una filosofia integrale, si può dire, perché accoglie in sé la descrizione e la
problematica di tutte le esigenze umane: scienza e fede, intelletto e sentimento, filosofia e poesia, deduzione logica e credenza
superstiziosa, si fondono armonicamente nella dottrina di Proclo; miti, formule magiche, misteriosofia valgono non meno della
deduzione logica. Esaltattore dell’eros e del sapere discorsivo, come dell’arte enteastica e della noesi ad un tempo, egli opera tra i
contrasti della vita spirituale una sintesi, ancora oggi suggestiva” (op. cit., p. 134, n. 47).
Per Proclo la conoscenza del reale è il frutto di una ricerca interiore.582 La mente, concentrandosi su se
stessa, può riuscire a ripercorrere il processo in cui si articola lo sviluppo dell’intera realtà, attraverso la
duplice via dall’Uno al mondo e dal mondo all’Uno, riconoscendo il legame causale che unisce ogni ente a
ogni altro e la radice razionale di ogni connessione e conversione reciproca della causa e dell’effetto.
Questo aspetto conoscitivo si coniuga, poi, con l’aspetto religioso, che si configura come una
pratica
rivolta a recuperare la natura divina, mediante una opportuna ricomposizione dei caratteri divini le cui
tracce sono sparse negli elementi dell’universo materiale. Così si dispiega l’arte ieratica, che consiste nel
riconoscere le tracce divine nella materia e nel ricomporle in modo da avere l’immagine più verosimile
possibile della divinità.583
Il Principio della realtà, della stessa esistenza di un qualsiasi ente, è l’Uno. Senza un tale principio, non
potrebbe esserci realtà ed esistenza di alcunché. Infatti il reale sarebbe del tutto indefinito, cioè nullo. L’Uno,
quindi, è condizione fondamentale dell’Essere. Esso è la Causa prima. In quanto principio positivo di ogni
realtà, l’Uno si identifica col Bene.
Proclo mette in rilievo la natura triadica dell’Uno: l’Uno, infatti, è sempre identico a sé, ma è anche radice
di ogni molteplicità e di ogni differenza ed è, dunque, in sintesi, tensione di identità e differenza, di unità e
molteplicità, di infinità e di determinazione. In quanto fondamento di tutte le determinazioni, l’Uno non ha
figura (corporeità) né materia (estensione), non si identifica con nessun ente; è causa che produce tutte le
infinite possibilità dell’essere, ma non assume nessuna forma: perciò dell’Uno non si danno affermazioni di
qualità e, invece, si negano tutte le qualità e tutti gli attributi.
In tutto ciò che proviene dall’Uno si ripete la circolarità dialettica del principio primo. Ogni ente proviene
da una causa che si estrinseca in esso e ha il suo compimento sul piano della causa che l’ha prodotto, in
quanto realizza quella natura che la causa gli ha trasmesso. L’essenza si estrinseca nell’ente, ma questo non
fa altro che realizzare in modo determinato l’essenza stessa. Un uno/identico si viene esprimendo e
realizzando nella molteplicità del diverso.
Questa è l’articolazione dialettica del reale: permanenza nell’uno/identico (monè), processione causante
(proodos), ritorno a sé (epistrofé).
L’Uno contiene in sé la legge di ogni processo reale ed è causa di ogni produzione: da esso derivano,
dunque, i piani strutturali del reale stesso, a cominciare da quelli intelligenti e spirituali, che racchiudono le
leggi e le forme dell’ordine dell’universo.
L’universo fisico e apparente, infatti, non è che l’ultima manifestazione dell’Uno, quel piano da cui, poi,
riprende il processo del ritorno al principio.
Una prima forma in cui si viene articolando l’Uno nel suo processo produttivo è quella delle enadi, infinite
ipostatizzazioni degli aspetti dell’Uno. Se, così, ad esempio, l’Uno è buono, si ha l’enade della Bontà; in
quanto è sapiente, si ha l’enade della Sapienza, e così via. L’Uno così diventa intelligibile, pensiero di sé o,
meglio, se stesso nella forma del pensiero. Si può dire che a questo livello siamo ancora sul piano dell’in-sé.
L’Uno è ancora nella sua compatta unità logico-formale e deve incominciare il processo della discesa verso
l’universo delle determinazioni.
582
Ecco, a questo proposito, la sua interpretazione del “conosci te stesso” socratico: “L’anima, guardando alle cose che le tengono
dietro vede solamente ombre e i simulacri degli enti. Se invece si rivolge a se stessa, dispiega allora la propria esseita e le sue ragioni.
E dapprima, intanto, potrà soltanto contemplare quasi se stessa; poi, approfondendo l’immagine con la conoscenza di sé, trova in sé
anche la mente e gli ordini degli enti. Ma, ritirandosi nell’interiore recesso di se stessa, quasi inaccessibile luogo santo dell’anima,
essa potrà contemplare, con pupille chiuse, la stirpe degli dèi e le enadi degli enti. Infatti, tutte le cose sono anche in noi sotto una
forma che l’anima comporta in sé; ragione per cui la nostra natura può conoscere tutte le cose; basta ridestare le potenze celate in noi
e le immagini di ogni cosa. Anzi il segno più nobile dell’atto umano è appunto questo potersi tendere, nella profonda pace di ogni
potenza, verso il divino […]. E conviene gettare via ogni cosa, le cose tutte posteriori all’Uno, e prendere dimora presso di lui e, con
lui, ineffabile, congiungersi; con lui, al di là degli enti tutti […]. Là pervenuta, […] l’anima potrà quindi di là discendere per
compiere il suo cammino nel regno dell’essere, attraverso gli enti. Allora potrà esplorare, sfogliando quasi pagine di un libro, la
pienezza delle specie, trascorrendone le monadi e i numeri inerenti, potrà riconoscere mentalmente in quale modo ciascuna ha una
relazione di dipendenza con le singole enadi […]. Tale il teologo, tale l’abito della Teologia […]” (Teologia platonica, I, 2-3).
583
“I maestri dell’arte ieratica hanno scoperto, in base a quello che avevano sott’occhio, il modo di onorare le potenze superiori,
mescolando taluni elementi, ed altri togliendone in misura appropriata. Se mescolano, è perché hanno osservato che ognuno degli
elementi separati possiede qualche proprietà del dio, ma non basta per evocarlo; così mescolando un gran numero di elementi diversi,
uniscono le influenze ricordate sopra, e con tale somma di elementi compongono un corpo unico, simile all’unità precedente la
dispersione dei termini. Così fabbricano spesso, con tali mescolanze, delle immagini e degli aromi, impastando in un medesimo
corpo i simboli prima divisi, e producendo artificialmente tutto quello che la divinità comprende in sé per essenza, riunendo la
molteplicità delle potenze che, separate, perdono ognuna la propria efficacia, e che, invece, riunite, si combinano per riprodurre la
forma del modello” (Arte ieratica, cit. da F. Adorno, La filosofia antica, IV, p. 397).
Proclo ammette, come prima triade di ipostasi derivata dalla sfera delle enadi, l’infinito, il limite e il misto:
cioè i princìpi in virtù dei quali si passa alle determinazioni reali.584 A questa triade segue la seconda,
costituita da essere, vita, intelletto. Così appare definito l’universo reale.585
L’essere, la vita, l’intelletto si articolano, a loro volta, in altre ipostasi, che sono tre rispettive triadi per le
prime due (e corrispondono agli dèi intelligibili e agli dèi intelligibili-intellettuali)586 e ebdomadi per la terza
(corrispondenti agli dèi intellettuali).587
L’ipostasi successiva è l’Anima, in cui le idee divine si fanno princìpi della formazione degli enti
dell’universo fisico. Tutto si forma, nell’universo, per virtù dell’azione delle anime, che sono, pertanto,
princìpi attivi della formazione e dell’esistenza degli enti, nonché dei processi delle loro trasformazioni. In
virtù di tali princìpi attivi, gli enti compiono anche i loro processi di riconversione all’Uno.
Proclo distingue le anime divine, quelle demoniache (degli angeli, dei demoni e degli eroi) e quelle parziali
(che sono le più imperfette e, tra di esse, vi sono anche quelle degli uomini).
L’Anima si pone come intermediaria tra il piano dell’intelligibile e l’universo sensibile e corporeo. Essa
contiene un riflesso dell’intelligibile/intellettuale e perciò è capace di conoscenza.
L’incarnazione delle anime in corpi viventi avviene attraverso l’assunzione di una serie di rivestimenti,
che sono, progressivamente, “tuniche più materiali”. Liberate da queste stratificazioni materiali, le anime
recuperano la loro natura originaria, consistente in una specie di “veicolo” etereo, incorporeo e incorruttibile.
In particolare, Proclo sottolinea la presenza del divino nell’anima, per cui l’anima, in qualche modo, riflette
la natura stessa dell’Uno e, in questo senso, si pone come principio della connessione tra gli enti.
L’anima, nello sforzo di recuperare la sua natura divina, si rivolge verso la contemplazione dell’Uno. Il
processo della conoscenza, andando oltre l’opinione (che è ancora un’ipotesi che riguarda l’orientamento
umano nel mondo delle cose), la scienza discorsiva (diànoia) e la intellezione (nòesis), si conclude nell’unione
estatica con l’Uno, che avviene attraverso un atto che è oltre la conoscenza stessa e che riguarda la
comunione religiosa con la divinità (fede).588
Nota critica su Proclo
L’eclettismo culturale, filosofico e religioso, che costituisce una tendenza dominante dell’ultima fase del
pensiero antico, raggiunge il suo culmine con Proclo. Ciò è stato rilevato già dagli studiosi della scuola di
Cousin, J. Simon, A. Berger, E. Vacherot. “Lo spirito dell’eclettismo – osserva il Simon – non consiste nel non
appartenere a nessuna scuola, ma piuttosto nel non escluderne nessuna”589. Proclo è riuscito ad assimilare
nel suo sistema tutta la sapienza orientale, oltre che tutta la filosofia greca. Per questo filosofo è lo stesso
platonismo che contiene ogni aspetto della verità; e se l’intera antica sapienza comprende le più varie forme
584
Infinito, limite e misto sono le ipostasi della prima triade intelligibile e, insieme, princìpi generali della produzione reale.
“Poiché ciò che è causa di più effetti ha una precedenza su ciò che è causa di meno, in quelli il primo sarà l’essere, perché è
presente a tutte le cose che hanno vita e mente. Infatti, ogni vivente partecipa anche, e necessariamente, d’intelligenza; ma non
viceversa. Poiché non tutti gli esseri vivono e intendono. Seconda poi è la vita. Poiché a tutti quelli a cui appartiene la mente,
appartiene anche la vita; e non viceversa. Infatti, molte cose vivono, ma son lasciate prive di conoscenza. Terza poi è la mente.
Infatti, ogni ente, che in qualche modo è fornito di conoscenza, vive anche ed esiste. Se dunque l’essere è cagione di più effetti, la
vita di meno, e di meno ancora la mente: dunque al primo posto vi è l’essere, quindi la vita e infine la mente.” (Elementi di teologia,
101, tr. di M. Losacco).
586
Il carattere universale di questa serie di dèi è la vita, cioè la forza generante, in virtù della quale l’essere si costituisce come un
unico organismo vivente. La prima triade in cui si articola la vita è costituita dai numeri primordiali (uno, altro, ente); la seconda
triade comprende tre coppie di concetti: uno/molti, intero/parti, limitato/illimitato; la terza triade è detta da Proclo degli dèi
completanti.
587
Proclo individua in alcune di queste ipostasi le tradizionali divinità greche. Si tratta di ipostasi che rappresentano il passaggio
dell’intelligibile all’essere diviso. Esse sono suddivise in base al numero dei sette pianeti. La prima ebdomade corrisponde al puro
intelletto e ha il suo simbolo in Crono; la seconda è la forza vivificante ed è rappresentata da Rhea; la terza corrisponde all’intelletto
creatore del mondo e, quindi, a Zeus, il demiurgo ordinatore dell’universo.
588
“La seduzione che esercita il misticismo neoplatonico è proprio in questo suo sbocciare sul tronco dell’intellettualismo
tradizionale. Dio non è attinto direttamente con l’intuizione mistica, ma questa conclude, con un’improvvisa fulgurazione di verità,
tutto il tenace processo dell’attività logica” (G. Martano, L’uomo e Dio in Proclo, p. 74, n. 118). Proclo ci propone, in questo senso,
un esempio di reciproca integrazione di scienza intellettuale e fede mistica. In particolare, la scienza spiega la proodos, mentre
l’aspirazione mistica attesta l’epistrophé.
589
J. Simon, Histoire de l’école d’Alexandrie, 2 voll., Paris 1845, vol. II, p. 397.
585
di accostamento alla verità, ciò vuol dire che essa ha trovato la sua espressione più completa nel pensiero di
Platone. La stessa inclinazione alla vita politica trova posto nella sintesi di Proclo, come osserva A. Berger, e
la contemplazione non annulla l’azione: “La grande accusa con cui di solito si sconfigge il misticismo è
quella di soffocare la scienza: Proclo, invece, non condanna la scienza, ma la esige. Il misticismo è contrario
alla vita attiva: Proclo la consiglia e la pratica. E neppure si può dire che distolga dalla vita politica. Proclo
descrive le condizioni di un buon governo, si occupa degli affari della sua patria, in qualche modo li dirige,
essendo consigliere del più alto magistrato, e subisce le conseguenze della sua partecipazione agli affari della
città: è costretto a sottrarsi alla persecuzione andando in esilio”590. E il Vacherot giustamente conclude:
“Anzitutto l’intera filosofia alessandrina, ed inoltre l’intera scienza del passato, vengono a riassumersi in
questo sistema, che si potrebbe definire a buon diritto la sintesi universale dei numerosi elementi della
saggezza antica, elaborata sotto l’influenza del platonismo. Proclo esprimeva efficacemente il carattere della
sua missione quando chiamava se stesso pontefice di tutte le religioni. Avrebbe potuto aggiungere: e il
filosofo di tutte le scuole”591.
Certo, lo sforzo di ricondurre a una sola verità tutte le forme sapienziali e le figure della religiosità
popolare qualche volta paga lo scotto alla coerenza concettuale e all’autonomia del pensiero. Come osserva
lo Zeller, in questo modo, è venuta meno la consapevolezza della specificità propria del metodo della ricerca:
“Il pensiero trova davanti a sé una materia enorme bell’e preparata, e, data la sua fiducia nell’autorità, si
sente troppo legato a questa materia per poterla plasmare liberamente e dominarla interiormente” (La
filosofia dei Greci, parte III, sez. II, tr. it., p. 190).
Proclo tenne conto del vasto panorama delle correnti letterarie, filosofiche e scientifiche dell’antichità, più
di quanto abbia fatto Plotino. Egli, inoltre, aveva una maggiore attitudine alla sistemazione e mirava alla
realizzazione di un sistema rigoroso e completo. La sua originalità consiste, appunto, nell’avere elaborato un
sistema filosofico di questo tipo e nell’avere ricondotto, pertanto, alla forma del pensiero logico le
espressioni più varie della cultura e prima di tutto il patrimonio religioso dell’età alessandrina. Il metodo
dialettico triadico corrisponde a questa esigenza. Come osserva W. Beierwaltes (Proclos. Grundzuge seiner
Melaphysik, Frankfurt 1965), infatti: “Perché nel problema dell’essenza del metodo si parla della sua
struttura? Proprio perché il metodo che cerca di pensare l’Uno è, sì, uno, ma come unità è costituito da
molteplici momenti, corrispondenti all’unità in sé molteplice del sistema, ciascuno dei quali cerca di
muovere in un modo determinato il pensiero verso la sua meta. […] Il metodo è necessariamente tale da
poter comprendere la cosa necessariamente e completamente, come essa è, in conformità al suo essere” (pp.
18-19).
In rapporto a questa esigenza metodica, è l’esatta visione scientifica della proodos che consente lo sviluppo
dei momenti dell’epistrophé; ma ciò non toglie che in questi si esprimano le forme della religiosità popolare.
Come avverte lo Zeller: “Proclo richiede un’elevazione metodica e graduale al superiore, poiché il ritorno del
derivato alla sua causa avviene, secondo i criteri del suo sistema, allo stesso modo come il suo procedere da
essa”592. E come opportunamente commenta G. Martano: “Lo sforzo di comporre le due esigenze che
costituiscono la duplice faccia della realtà della persona, l’esigenza intellettuale (scientifica) e quella emotivosentimentale della volontà nei confronti dell’intelletto (esigenza mistico-religiosa), anima tutta la dottrina
che mentre scientificamente spiega il passaggio dalla causa all’effetto, volontaristicamente e misticamente
vuole ugualmente postulare la validità del principio che riconduce l’effetto alla causa”593.
Per il Martano, la conquista più significativa di Proclo è l’idea del soggetto come microcosmo, che realizza
la conoscenza dell’essere nella sua articolazione metafisica e, quindi, il ricongiungimento con esso nella più
alta forma di esperienza spirituale. In questo senso, Proclo avrebbe fondato il monismo spiritualistico, una
concezione in cui la realtà mondana e sensibile trova la sua possibilità di intero riscatto e di trasfigurazione.
Anzi, proprio questo sarebbe il motivo caratteristico: tutto si risolve nello spirito e il soggetto ha la capacità
di cogliere e vivere questa risoluzione, nella quale si attua il senso dell’intera realtà. In particolare, in questa
sintesi la virtù etica e l’esperienza religiosa, il sapere e l’illuminazione mistica si compenetrano
reciprocamente. Come è osservato in un passo della Teologia platonica (I, 25), la Bontà, la Sapienza, la
Bellezza, realtà cosmiche primarie, si riflettono nell’anima umana, che le coglie attraverso la fede, la verità,
l’amore (pistis, alétheia, eros).
L’uomo, inserito nella realtà cosmica, partecipa di queste potenzialità per rimanere aderente a questa
realtà e poterla vivere nel modo più completo. La storia dell’uomo è inserita nel duplice processo della
A. Berger, Proclus. Exposition de sa doctrine, Paris 1840, p. 115.
E. Vacherot, Histoire critique de l’école d’Alexandrie, 3 voll., Paris 1846-51, vol. III, p. 214.
592
E. Zeller, La filosofia dei Greci, tr. it., cit., p. 179.
593
Ib., p. 179, n. 211.
590
591
“derivazione” e del “ritorno”, dell’allontanamento e del riavvicinamento. Questa natura dialettica dello
spirito circoscrive l’intera sfera della realtà.
CAPITOLO XIII
Problemi e interpretazioni
La filosofia greca secondo Heidegger in un corso universitario del 1926
L’interesse di Heidegger per il pensiero greco si articola in tre fasi: nella fase che pressappoco coincide con la
fondazione dell’ontologia fondamentale a partire dalla questione dell’essere dell’uomo (corrispondente a “Essere e
tempo”), egli considera specialmente la metafisica di Aristotele e il concetto di “essere” sul quale essa si basa (l’essere
come semplice presenza del reale, identificato con l’ente); nella seconda fase, egli ricerca specialmente le radici della
concezione metafisica occidentale, caratterizzata dalla inadeguata nozione dell’essere, e individua tali radici, in
particolare, nel pensiero di Platone, incentrato sulla dottrina delle idee, nella cui articolazione e nella cui struttura di
essenze immutabili si identificherebbe l’essere stesso; nella terza fase, che coincide con il perseguimento di nuove vie del
pensiero, oltre gli schemi della metafisica, il cui estremo sviluppo coinciderebbe con l’età della tecnica, egli si rivolge ai
primi filosofi, ad Anassimandro, Eraclito e Parmenide, con l’intento di rintracciare in essi spunti di pensiero
alternativo, essenzialmente poetante e, dunque, tale da essere espressione più diretta della manifestazione dell’essere
come verità (“non-nascondimento”, rivelazione). Per quanto riguarda Aristotele, l’attenzione di Heidegger va dal
periodo immediatamente precedente l’opera maggiore (1927) al famoso saggio sul concetto di “natura” (1949); le
riflessioni su Platone risalgono agli anni che seguono la stessa opera e trovano la loro esposizione sintetica nello scritto
su “La dottrina platonica della verità” (1940); successive alla “svolta” sono le ricorrenti analisi del pensiero dei primi
filosofi.
Il confronto con Aristotele riguarda principalmente tre punti: la critica della concezione aristotelica della
verità come “adaequatio intellectus et rei”; la critica dell’assunzione tradizionale del giudizio a nucleo
fondamentale del pensiero; la critica della nozione aristotelica dell’essere come semplice presenza dell’ente.
Heidegger giunge alla definizione della verità come fondamentale svelamento dell’ente nell’orizzonte del
fenomeno originario della comprensione che appartiene all’esistenza stessa nella sua costituzione ontologica.
Il discorso predicativo e logico non sarebbe altro che uno sviluppo che ha le sue condizioni nel fenomeno
ontologico dello scoprimento, per cui l’ente si dà al soggetto umano e questo, a sua volta, è caratterizzato da
un atteggiamento “scoprente”. Heidegger perviene anche a una prima connessione tra “essere” e “tempo”,
sulla base della nozione di “presenza”: infatti, se la concezione tradizionale dell’essere muove dalla
constatazione dell’essere “presente”, ciò vuol dire che essa privilegia una particolare determinazione
temporale, cioè, appunto, il “presente”.
Questa concezione avrebbe avuto la sua espressione tipica nella dottrina platonica delle idee: le idee,
infatti, altro non sarebbero che le ipostatizzazioni corrispondenti all’essere degli enti nel senso
dell’immutabile presenza (le idee sono, in qualche modo, fuori del tempo, sono essenze immutabili). L’uomo
padroneggerebbe queste strutture immutabili della realtà mediante l’intelletto. In questo senso nella nozione
platonica di “scienza” sarebbero implicite le premesse della successiva connessione di scienza e tecnica.
L’interesse per i primi filosofi è collegato allo sforzo compiuto da Heidegger già a partire
dall’“Introduzione alla metafisica” (1935) per superare la prospettiva del pensiero occidentale basata sulla
metafisica come concezione dell’essere disponibile all’attività umana e perciò campo del reale manipolabile.
Come è noto, il filosofo è partito dalla lettura di Holderlin per sviluppare la sua riflessione sui caratteri della
nostra epoca, segnata da una estrema “povertà” relativa alla comprensione del senso dell’essere, per risalire
all’età felice in cui gli uomini vivevano l’esperienza di una sacra unione con tutte le cose della natura e con la
stessa divinità.
In conclusione, quali che possano essere le interpretazioni complessive del pensiero heideggeriano e, in
particolare, della lettura heideggeriana dei filosofi greci, appare notevole l’orientamento del filosofo che
maggiormente riflette sulla crisi del nostro tempo a individuare le coordinate di una svolta radicale, intesa a
restituire all’uomo la percezione del senso della sua vita e quella del senso dell’essere in generale. Heidegger
ha compiuto un grande sforzo interpretativo attraverso il quale è riuscito a restituire ai filosofi greci più
antichi lo spessore di una “verità” più profonda, radicata nelle dimensioni rivelative della parola. In questo
modo, egli ci ha messo nella condizione di sviluppare un dialogo problematico con quei filosofi e attraverso
il quale noi vediamo emergere interrogativi e questioni che investono il nostro destino attuale. Così Eschilo
e Parmenide, Anassimandro ed Eraclito, Sofocle e Pindaro, e i tanti altri filosofi/poeti ci parlano con un
linguaggio che via via noi avvertiamo di scoprire e che ci rivela dimensioni sempre nuove e più profonde e
misteriose dell’esistenza.
Hedegger tenne il corso sulla filosofia antica (che ora viene pubblicato da Adelphi nella traduzione di G. Gurisatti e a
cura di Franco Volpi) presso l’Università di Marburg nel 1926, cioè quando non aveva maturato ancora
l’interpretazione della filosofia antica, da Platone in poi, come “metafisica”, basata sulla sostanziale messa da parte del
problema dell’essere e sulla concentrazione dell’indagine intorno all’ente, una volta assunto l’essere come “semplice
presenza” dell’ente medesimo. Si tratta di una trattazione completa e sistematica, dunque di un vero e proprio saggio di
storia della filosofia antica da Talete ad Aristotele, con la sola assenza dei Pitagorici e dei Socratici minori. Il limite
dell’edizione consiste nel fatto che essa non è condotta sulla trascrizione delle lezioni bensì sul manoscritto, che spesso
contiene solo gli schemi della trattazione e, pertanto, non assicura quei caratteri di comprensibilità e di continuità
espositiva che le lezioni indubbiamente avevano. D’altra parte, è da rilevare che le lezioni di Heidegger erano condotte
con notevole ricchezza di strumenti ermeneutici ed erano improntate a uno stile brillante, che affascinava e trascinava
gli uditori nel processo interpretativo delle problematiche storiche e teoriche. Peccato, dunque, che non si sia conservata
la trascrizione delle lezioni da parte di qualcuno degli autorevoli uditori e allievi. A questa lacuna ha cercato di
sopperire Franco Volpi nella sua bella introduzione.
Heidegger va subito alla questione essenziale, quella che riguarda la specificità della filosofia rispetto alle altre scienze
e agli altri discorsi intorno alla realtà. La filosofia si distingue (egli subito precisa) in quanto essa va oltre la
considerazione dell’ente e assume a oggetto della sua indagine l’essere. “In effetti – egli avverte – il senso comune e
l’esperienza comune comprendono e cercano solo l’ente. Ma vedere in esso l’essere, comprenderlo e differenziarlo
dall’ente, questo è appunto il compito della scienza che differenzia, la filosofia. […] La filosofia scientifica ha inizio
quando si arriva a raffigurarsi qualcosa con il termine ‘essere’ e ci si pone in grado di capire la differenza e di
compierla realmente”. E’ da osservare che Heidegger qui non separa l’essere dall’ente e considera la filosofia come
indagine intorno all’essere dell’ente, cioè per come essa realmente si è venuta sviluppando nella sua storia. Egli perciò
giustamente rileva l’importanza che nella fondazione del discorso filosofico assume Socrate con la definizione del
concetto come espressione dell’intelligenza dell’essere dell’ente. In questo senso Socrate avrebbe posto le premesse per la
costruzione della filosofia come scienza generale della realtà, configurata come scienza dell’essere di ogni possibile ente.
Heidegger può cogliere così il senso autentico delle idee di Platone: le idee riguarderebbero l’intelligenza dell’ente resa
possibile dal riferimento dell’ente stesso al suo essere. L’essere dell’ente risulta qualcosa che si differenzia da ogni
particolare ente che sia riferito a tale essere. Come sappiamo, successivamente Heidegger imputerà a Platone la
responsabilità dell’“oblio dell’essere”, con una evidente modificazione del suo approccio ermeneutico al più grande
filosofo di tutti i tempi.
Particolarmente significativa è la proposta interpretativa dell’allegoria della caverna, della quale si dà una lettura
ontologica, cioè non tanto come rappresentazione della progressiva conquista della conoscenza e neppure come
allegoria del processo di formazione spirituale del filosofo, bensì piuttosto come “mito” inteso a presentare l’essere come
rivelazione. E’ l’essere stesso nel suo progressivo disvelarsi che investe il prigioniero che si libera e si pone, infine, nella
condizione di guardare il sole. “Solo in base a una superiore comprensione dell’essere – avverte Heidegger – ciò che
prima era ritenuto unicamente essente diventa concepibile nel suo essere. Ciò significa che per poter abbracciare con lo
sguardo e comprendere tutto l’ente e i suoi modi di essere c’è bisogno della suprema comprensione dell’essere, ovvero di
sapere che cosa significa propriamente ‘essere’”. Si può forse intravedere già in questo punto una qualche anticipazione
della successiva posizione di Heidegger rispetto a Platone.
Intanto molto puntuali e significative appaiono le pagine dedicate alla metafisica di Aristotele. Questo filosofo
avrebbe, in modo inequivocabile, stabilito la differenza tra l’ente e l’essere e avrebbe precisato i sensi in cui l’essere va
inteso. In questo modo sarebbero emerse le diverse modalità secondo cui si struttura l’essere dell’ente. Queste modalità
sono le categorie (con riferimento alle modalità d’essere dell’ente sul piano dell’esistenza), l’accidentalità (con
riferimento al divenire), il vero/falso (con riferimento alla conoscibilità), la potenza/atto (con riferimento alle
modalità della potenzialità e dell’attualità). Sarebbero, in questo modo, poste le condizioni della scienza generale
dell’essere dell’ente, con riguardo alle stesse modalità in cui l’ente si presenta. La scienza dell’ente si configura sulla
base delle diverse modalità d’essere (essere presente) dell’ente. Si potrebbe obiettare che, veramente, a questo punto si
delinea un radicale spostamento della questione dell’essere sul piano dell’ente. Ciò che interessa ad Aristotele è la
scienza dell’ente, per cui la comprensione dell’essere ha una funzione ermeneutica: l’ontologia non è che uno strumento
per pervenire a una totale conoscenza dell’ente. La fondazione di un’enciclopedia che riguardi le diverse regioni del
reale costituisce l’obiettivo fondamentale della scuola aristotelica.
Rimane, perciò, il senso della grande lezione heideggeriana sulla filosofia greca. Heidegger, al di là di ogni particolare
approccio interpretativo, ha voluto mettere in luce tutta la portata del pensiero antico rispetto allo sforzo compiuto per
rendere intelligibile il reale sulla base dell’originario nesso di essere e pensiero, rilevato con grande determinazione da
Parmenide.
Heidegger qui tocca lo spirito greco e riesce a pensare “in modo più greco dei Greci”, come opportunamente osserva
il curatore di questa edizione.
M. Heidegger, I concetti fondamentali della filosofia antica, ed. italiana a cura di C. Volpi, tr. di G. Gurisatti,
Adelphi, Milano 2000, pp. 448.
Il divieto di Parmenide e la filosofia moderna. Come, secondo Severino, la filosofia moderna ha infranto il
divieto di Parmenide di separare l’ente e il pensiero dall’essere
Proseguiamo il discorso su Parmenide e la metafisica. Abbiamo visto come la concezione metafisica della
realtà come totalità abbia sostanzialmente sviluppato la tesi parmenidea e come la filosofia antica si sia
mantenuta aderente ad essa, con particolare riguardo al divieto perentorio di separare l’ente dall’essere e di
concepire come distinti princìpi l’essere e il pensiero. Questa fondamentale linea di matrice eleatica è anche
quella nella quale prosegue la filosofia cristiana e medievale, per la quale, anzi, il principio o il fondamento
di ogni realtà, l’essere parmenideo, è concepito come il creatore dell’ente, Dio, che vuole l’esistenza
dell’universo degli enti. Dio è il custode dell’ente ed è garanzia di senso, di ragion d’essere. L’ente, in quanto
creato da Dio, è investito di un significato, ha una funzione, una finalità, una costituzione connessa a un
ordine. La metafisica si lega strettamente alla teologia, che è la scienza, basata essenzialmente sulla
rivelazione, della creazione e del rapporto tra l’ente e Dio. E’ la teologia che può rispondere alle domande sul
senso della realtà, sul destino dell’uomo e delle cose. L’ente viene, così, ancora doppiamente legato
all’essere: senza un riferimento a Dio, non è possibile dire nulla intorno al mistero della creazione e al senso
del mondo; non solo non è possibile separare l’ente dall’essere, ma non è neppure possibile attribuire un
senso all’ente fuori del rapporto con l’essere. L’ente trova nell’essere che lo fonda non solo il suo principio
ma anche il suo destino. E il pensiero ha lo stesso fondamento: esso ha senso in quanto coglie le ragioni della
creazione e, in qualche modo, comprende il senso dell’ente, in quanto questo è depositato nel “logos”, che è
Dio stesso in quanto principio del pensiero. In quanto l’ente ha senso e si sviluppa secondo un ordine, esso è
incardinato in un pensiero; e il discorso che noi facciamo è in qualche modo una “imitazione” di tale
pensiero (che appartiene all’ente, come sua “ragione”). Il pensiero, anzi, è condizione della creazione del
mondo; e questo non è altro che come un immenso libro scritto coi caratteri del pensiero divino. Le vie e gli
strumenti della filosofia cristiana sono, infatti, la ragione e la fede: l’interpretazione dei caratteri in cui è
scritto il libro dell’universo non è possibile soltanto sulla base dell’esperienza sensibile e intellettuale, ma
implica una spiegazione data direttamente da Dio e consegnata a una “scrittura”. Ma tutto ciò è possibile
sulla base e nell’ambito del pensiero. Non solo il pensiero non è separato dall’essere, ma esso è l’essere nella
forma in cui si rivela e nel modo in cui costituisce la scrittura fondamentale.
Il pensiero moderno, invece, opera la frattura che consiste essenzialmente nell’infrazione del divieto
parmenideo. Esso distingue nettamente ciò che è dell’essere e ciò che è dell’ente e, inoltre, ciò che è pensiero
e ciò che è realtà. L’essere è il fondamento trascendente, per il quale nessuna analogia con l’ente è possibile
stabilire; ed è al di là del pensiero. Ecco, dunque, la separazione dell’essere dall’ente. Dell’essere non è
possibile nessuna scienza; né il rapporto tra l’essere e l’ente è pensabile, poiché esso è di intera pertinenza
dell’essere. In questo modo vengono meno le ragioni della metafisica, poiché questa si basa sulla
comprensione di quel rapporto, cioè del modo in cui l’essere tiene in sé l’ente e in cui l’ente appartiene
all’essere (o secondo cui l’essere e l’ente si appartengono reciprocamente).
Così anche il pensiero viene separato dall’essere. Esso viene inteso come lo strumento per pensare (o
comprendere) l’ente; e questo viene considerato come un “intelligibile”, come un termine del pensiero, come
il cartesiano “cogitatum” (“pensato”), correlativo all’atto del “cogito” (“io penso”). La filosofia moderna è
principalmente una filosofia del soggetto. La soggettività costituisce il campo d’indagine dell’intera
riflessione. I razionalisti intendono il soggetto come razionalità, capace di operare l’analisi della costituzione
del reale, per comprenderne la costituzione matematica. L’universo fisico può essere scomposto e
ricomposto attraverso i procedimenti dell’analisi matematica. Gli empiristi mettono in rilievo i limiti
dell’esperienza e, sempre di più, sottolineano il carattere soggettivo di ogni rappresentazione del reale. Noi,
più che con le cose, abbiamo a che fare con le nostre rappresentazioni. Kant ha specialmente rilevato il
carattere trascendentale (relativo alla costituzione universale del soggetto) della scienza del mondo
fenomenico.
Gli idealisti hanno tentato di ricostituire l’unità dell’essere e del pensiero, ma in realtà hanno risolto le
strutture ontologiche nelle categorie logiche, proclamando, inevitabilmente, l’assunzione della logica (in
quanto scienza della razionalità del reale) a metafisica. Analogamente, il tentativo di ristabilire la
connessione dell’ente con l’essere si è risolto quasi generalmente nell’affermazione di un Assoluto nel quale
l’ente finito perde la sua stessa ragion d’essere.
La rivendicazione quasi violenta dell’autonomia del finito operata dalle filosofie post-hegeliane ha
praticamente portato a quella crisi generale della metafisica, che ha in Nietzsche il suo interprete più
conseguente. Nietzsche ha riassunto questa condizione del pensiero (e dell’intera temperie culturale) con la
famosa constatazione che “Dio è morto”, cioè che si sono dissolte tutte le concezioni metafisiche relative al
fondamento, ai princìpi e ai valori ontologici, a ogni ipotesi di rapporto tra l’essere e l’ente e a ogni idea di
“ragion d’essere” o di senso del mondo e dell’esistenza. In questo modo siamo giunti all’epoca che ormai
concordemente è chiamata come “età del nichilismo”.
Il “ritorno a Parmenide”, invocato recentemente da Emanuele Severino, appare come il rimedio per la crisi
profonda che il mondo occidentale sta attraversando. Ma in che modo potrebbe oggi configurarsi la
ricostituzione dell’unità di essere ed ente e di essere e pensiero? Quali potrebbero essere le linee di una
filosofia neoeleatica? La via indicata e in gran parte percorsa da Heidegger ci sembra ancora quella più
verosimile. In particolare, la riproposizione dell’analitica esistenziale come indagine intorno al senso
dell’essere avrebbe il vantaggio di muoversi in un ambito, si può dire, di ricongiunzione dell’essere e
dell’ente (anche se questo è emblematicamente assunto nell’esistenza dell’uomo). L’analisi della condizione
umana dovrebbe costituire il presupposto per un discorso, che sia insieme “ontico” e “ontologico”, cioè che
riguardi il senso degli enti e il senso dell’essere in generale. Il discorso sulle cose, su tutto ciò che appartiene
al dominio della natura e a quello della tecnica, va approfondito, secondo punti di vista che significhino il
più possibile un superamento della prospettiva antropocentrica. Si può, ad esempio, sviluppare un discorso
sulla natura, in modo che questa emerga come una sfera dotata di prerogative e caratteri propri, anche
indipendentemente da tutto ciò che può apparire legato alla condizione dell’uomo? Si può, cioè, parlare
ancora di un “essere” della natura? In primo luogo, ci sembra che il divieto parmenideo riguardi, appunto, la
separazione dell’essere dall’ente e che, pertanto, lo sviluppo della metafisica vada perseguito nella forma
dell’indagine intorno all’essere dell’ente. La costituzione di un complesso di “ontologie regionali” (secondo
il progetto fenomenologico delineato già da Husserl) potrebbe essere presa in considerazione come possibile
compito della filosofia (come rinnovata metafisica) nel contesto attuale. Se si dà un essere dell’ente, allora
risulterà anche improbabile un destino dell’ente nel senso (tanto enfatizzato da Severino) del continuo venire
di esso dal nulla e dissolversi in questo medesimo. L’ente che viene dall’essere a ad esso ritorna ha la
consistenza dell’essere stesso.
Questioni platoniche. Giovanni Reale, Per una nuova interpretazione di Platone, Vita e Pensiero, Milano
1991.
Reale si propone di presentare il pensiero di Platone come un sistema organico, utilizzando anche le
dottrine non scritte. Egli, in primo luogo, cerca di uscire dal paradigma dominante, che è quello canonizzato
dallo Schleiermacher e che si basa sull’enucleazione del pensiero platonico esclusivamente dai dialoghi,
senza tenere conto della tradizione indiretta. Questo paradigma, in effetti, risulta ora inadeguato, dato che si
è venuto sempre meglio definendo l’importanza di questa tradizione. In questo senso, oggi risulta
maggiormente rispondente all’esigenza di una ricostruzione totale del pensiero di Platone il paradigma
elaborato dalla Scuola di Tubinga, che, appunto, ha il pregio di consentire di inquadrare nella complessiva
filosofia platonica anche gli elementi propri della tradizione non scritta.
Questo paradigma, precisato dal Gadamer, si collega alla tradizione dell’Antica Accademia, quale ci è
attestata dai discepoli diretti di Platone, cioè da Aristotele, Speusippo e Senocrate.
Spetta ad Aristotele la testimonianza intorno a quella forma di metafisica platonica che si basa sui
“princìpi” primi, l’Uno e la Diade illimitata, e secondo cui le Idee deriverebbero da questi princìpi, assunti
come la causa formale e la causa materiale di esse. Scrive, infatti, Aristotele: “Risulta chiaro che Platone ha
fatto uso di due sole cause: di quella formale e di quella materiale. Infatti le Idee sono cause formali delle
altre cose, e l’Uno è causa formale delle Idee. E alla domanda quale sia la materia avente funzione di
sostrato, di cui si predicano le Idee nell’ambito dei sensibili, e di cui si predica l’Uno nell’ambito delle Idee,
egli risponde che è la Diade, cioè il grande-e-piccolo” (Metafisica, A 6, 988 a 9-14). Aristotele ci testimonia,
inoltre, che Platone ammetteva, come realtà intermedie tra le Idee e gli enti sensibili, gli enti matematici, e
che considerava i numeri ideali come causa e sostanza di tutte le cose, ponendoli come diretta espressione
dei princìpi. Il sistema platonico, in questo modo, si reggerebbe essenzialmente sulla tradizione non scritta.
Speusippo sposta al primo posto (immediatamente dopo i princìpi) gli enti matematici e colloca le Idee e i
numeri ideali dopo di essi. I princìpi assumevano la configurazione di Uno e Molti (Unità e Molteplicità). In
questo modo, la metafisica di Platone sarebbe quella fondata sulla dottrina dei princìpi, che non troviamo
nei dialoghi, ma è attestata da Aristotele e dagli altri discepoli diretti di Platone.
I neoplatonici hanno elaborato un altro paradigma, in gran parte ispirato a una interpretazione teologica
del platonismo. Qui l’accento è posto sulla struttura gerarchica della realtà sovrasensibile, che è articolata nei
tre momenti del Primo Intelletto, del Secondo Intelletto, dell’Anima del Mondo; e il fine dell’uomo è
identificato con l’ascesa e l’assimilazione al Primo Intelletto (a Dio stesso).
La filosofia di Aristotele nel periodo platonico e gli scritti essoterici
Per la formazione filosofica di Aristotele è fondamentale il periodo in cui egli rimase alla scuola di Platone,
dove giunse diciassettenne nel 367 e si trattenne un ventennio fino al 347 (l’anno stesso della morte del
maestro). In quel periodo Platone stesso procede a un ampio ripensamento critico della sua dottrina
fondamentale, la teoria delle idee. Infatti, a cominciare dal Parmenide, questa teoria è sottoposta a una serie di
revisioni, che sono testimoniate dai dialoghi successivi e che, infine, conducono il filosofo a modificare il
complessivo quadro teorico del suo pensiero. Secondo quanto è attestato da Aristotele, Platone avrebbe ora
elaborato la “dottrina dei princìpi”, secondo la quale si avrebbe la deduzione delle idee dai due princìpi
fondamentali, l’Uno e la Diade, dai quali deriverebbe la serie delle idee-numeri (per la determinazione della
Diade indefinita da parte dell’Uno), dalle quali deriverebbero le idee-modelli e su queste, infine, sarebbero
modellati gli enti sensibili. Questo orientamento riflette una nuova esigenza teorica, dominata ampiamente
dall’istanza matematica: infatti, mentre prima il mondo delle idee è organizzato a partire dall’idea del Bene
(e dunque in rapporto a un significato essenzialmente morale e a un’esigenza etico-politica), ora il principio
dell’organizzazione è ricercato nella direzione pitagorica delle strutture matematiche (da una parte più
rispondenti all’esigenza di una determinazione esatta e d’altra parte più vicine alla visione pitagorica
dell’universo fisico, disposto secondo rapporti matematici e le forme regolari delle figure geometriche). E’
indicativo che in questo periodo un’importanza sempre maggiore assume l’astronomia, tanto che nelle Leggi
questa è considerata come un presupposto indispensabile per la realizzazione del nuovo più realistico
progetto di società politica, sia perché l’architettura dell’universo appare sempre di più come il modello di
ogni ordinamento (e di ogni legislazione), sia perché gli astri sono assimilati alle divinità, il cui culto è
garanzia della coesione della società.
L’Accademia frequentata da Aristotele era, dunque, dominata da questa nuova tendenza della ricerca
platonica, rivolta a individuare le grandi componenti metafisiche e matematiche dell’universo. Secondo
questo orientamento l’ideale della vita filosofica andava coincidendo sempre di più con un modello di vita
contemplativa, interamente dedita alla scienza delle strutture immutabili dell’universo.
L’adesione completa del giovane Aristotele all’orientamento dell’Accademia è attestato dalle opere scritte
in quel periodo e che, come è noto, sono chiamate “essoteriche” e, nella forma stessa, riproducono il modello
dialogico.
Il primo dialogo aristotelico, l’Eudemo (che assieme al Protreptico riprenderebbe motivi propri del
platonismo), riguarda il problema dell’anima, secondo la trattazione platonica. La vera natura dell’uomo è
fatta consistere nell’anima razionale, dunque nella vita dedita alla ricerca e alla contemplazione della verità,
nella fuga da ogni interesse corporeo e nella aspirazione alla liberazione finale.594 Aristotele riprende il
motivo platonico della reminiscenza: l’anima, cadendo nel mondo, dimentica le visioni che hanno costituito
la sua esperienza nella sede divina; perciò la vita nel mondo è imperfetta, una specie di “decadenza” (o
“caduta”) dalla condizione originaria, un allontanamento dall’essenza incorporea, dunque una specie di
“malattia”.
Nota critica su Aristotele
594
Il contenuto del dialogo Eudemo è possibile in base a un racconto di Cicerone (De div., I, 25, 53; Arist., fr. 37, Rose): Eudemo,
scolaro di Platone, durante un viaggio in Tessaglia, aveva sognato che presto sarebbe guarito dalla malattia che lo aveva colpito e che
dopo cinque anni sarebbe tornato in patria; in realtà, egli morì allo scadere di quel lasso di tempo: dunque la divinità nel sogno gli
aveva annunciato il ritorno alla patria celeste.
Werner Jaeger nel suo Aristotele (1923, tr. it. 1935) introdusse per primo il criterio della interpretazione
genetica, distinguendo tre fasi evolutive nello sviluppo del pensiero aristotelico: una fase platonica; una fase
intermedia, dominata da un orientamento metafisico teologizzante; una fase finale, corrispondente agli anni
del Liceo e caratterizzata dalla eliminazione completa delle residue influenze platonizzanti e orientata verso
la ricerca scientifica. Questa evoluzione avrebbe riguardato specialmente la metafisica (col passaggio dalla
trattazione di Dio a quella dell’essere in quanto tale), l’etica (con la progressiva rivalutazione delle virtù
etiche nella Nicomachea) e la politica (con l’abbandono di un primo nucleo riguardante la forma migliore di
governo, cioè la “politeia”) di Aristotele. Intorno alla discussione su tale interpretazione si sono in massima
parte incentrati gli studi successivi.
Ripresero lo schema di Jaeger studiosi importanti come Bréhier, Werner, Robin. Altri hanno apportato ad
esso alcune modifiche: H. von Armin (1927) ha assegnato al terzo periodo l’intera “Metafisica”, negando che
l’evoluzione aristotelica sia consistita in un progressivo allontanamento da Platone; J Zuercher (1952) ha
affermato la sostanziale aderenza di Aristotele a Platone, attribuendo le posizioni antiplatoniche espresse
nelle opere a Teofrasto (al quale, pertanto, dovrebbe essere attribuito l’indirizzo naturalistico); W. D. Ross e
E. Oggioni hanno spostato la dottrina del Motore immobile alla terza fase.
Secondo P. Merlan (1953), la metafisica coincide in toto con la teologia, poiché l’essere in quanto essere non
è altro che il principio della realtà e, dunque, Dio. Invece A. Mansion (1954) distingue ontologia e teologia
come scienze metafisiche complementari. Il carattere autonomo dell’ontologia è affermato anche da G. Di
Napoli (1953). Secondo gli studiosi che si sono posti sulla scia di Heidegger (tra cui L. Lugarini), la metafisica
si configura originariamente come una ontologia, ma quindi scade in una teologia (per alcuni, in una
teologia negativa).
F. Solmsen (1929) ha rilevato lo sviluppo evolutivo della logica aristotelica: secondo questo schema, la
posizione platonica sarebbe rappresentata dalla dottrina del sillogismo dialettico (Topici), la seconda fase
comprenderebbe la dottrina del sillogismo apodittico (Analiti Posteriori) e la posizione antiplatonica finale
sarebbe caratterizzata dalla dottrina del sillogismo analitico (Analitici Primi). L. Lugarini (1955) ha attribuito
le Categorie alla fase accademica. Secondo l’interpretazione formalistica (sostenuta da H. Scholz, A. Plebe, J.
Lukasiewicz), la logica aristotelica sarebbe un sistema di regole riguardanti i rapporti tra le proposizioni e
indipendenti dai significati dei termini; in questo senso verrebbe meno ogni nesso tra logica e metafisica.
Invece proprio questo nesso è affermato da altri studiosi, come C. A. Viano (1955), M. Mignucci (1965), C.
Negro (1967), P. Cosenza (1972).
F. Nuyens (1939) ha esaminato l’evoluzione della psicologia aristotelica, individuando tre momenti,
caratterizzati da modi diversi di intendere il rapporto tra l’anima e il corpo: 1) un rapporto di opposizione
(periodo accademico); 2) rapporto strumentalistico (periodo di transizione, con la produzione della maggior
parte delle opere biologiche); 3) rapporto ilemorfistico (periodo dell’insegnamento ateniese, con la stesura
del De anima).
Nell’ambito dell’interpretazione genetica dell’etica aristotelica, il von Armin (1924) ha affermato
l’autenticità dei Magna Moralia, che rappresenterebbero il primo stadio di tale etica. A. Plebe (1961) ha
assegnato a questi libri una posizione intermedia tra l’Eudemea e la Nicomachea. H. G. Gadamer (1928) ha
negato l’autenticità dell’Eudemea, attribuendola a un periodo posteriore alla morte di Aristotele.
Il von Armin è intervenuto anche nella questione relativa all’evoluzione del pensiero politico di
Aristotele: a questo riguardo, ha capovolto i risultati ai quali era pervenuto lo Jaeger, sostenendo la priorità
dei libri della Politica che illustrano la genesi storica delle costituzioni (libri IV, V, VI) rispetto a quelli (VII,
VIII) che illustrano la costituzione migliore.
Il Solmsen (1929) ha sostenuto anche una duplice redazione della Retorica, anche sulla base della notizia
secondo cui Aristotele nel periodo accademico avrebbe tenuto un corso di retorica.
La questione relativa agli scritti andati perduti è stata esaminata dettagliatamente specialmente da E.
Bignone (1936). Alle opere esaminate dallo Jaeger (Eudemo, Protreptico, Sulla filosofia) se ne sono aggiunte
altre: il dialogo Sulla giustizia (di evidente impronta platonica), studiato da P. Moraux (1957) e il trattato Sul
bene. Quest’ultimo è stato messo in relazione con le dottrine non scritte di Platone, studiate specialmente da H.
J. Kraemer (1959) e K. Gaiser (1962). Secondo I. During (1956) le opere giovanili di Aristotele conterrebbero
idee non dissimili da quelle proprie del filosofo maturo.
Appendice sulla filosofia a Roma e in Occidente
“Si dice che ai Romani mancò la tendenza naturale a essere filosofi: e non lo furono infatti né quanto né
come i Greci: ché alla speculazione filosofica il loro ingegno fu certamente negato; ma curiosissimi595 essi
furono delle concezioni filosiche e nessun sistema di filosofia greca fu ignoto in Roma o restò senza seguaci.
L’ingegno romano, istintivamente politico e giuridico, cercò dapprima, oltre che nella esperienza, negli scritti
degli uomini le norme e i precetti morali della vita. Filosofare ai tempi di Ennio si reputava già cosa
necessaria; anche se non sono invenzione di Ennio quelle parole del suo Neottolemo: Philosophari … nocesse
esse, sed paucis, nam omnino haud placere. E un poco di filosofia era necessario ai dotti romani: quel poco che si
riferiva soprattutto alla morale, cioè particolarmente all’uomo: ché filosofare in generale (omnino), cioè
seguire la filosofia in tutte le sue parti, non piacque quasi a nessuno in Roma e in nessun tempo. Nella
letteratura romana apparì presto, subito anzi, questa tenenza ad accogliere le voci della filosofia greca, se
pure nel carmen di Appio Claudio erano quegli influssi pitagorici che vi trovava Cicerone (Tusc., IV, 2, 4).
Argomenti filosofici trattò Ennio nell’Epicarmo e forse anche nelle satire; e di filosofia accademica, stoica e
peripatetica avevano largamente e piacevolmente discusso quei tre ambasciatori filosofi, Carneade, Diogene
e Critolao, che il vecchio Catone sollecitava nell’a. 155 a partire presto da Roma. Ma poco dopo i filosofi greci
saranno, nonché tollerati, ricercati: e nel circolo di Scipione Emiliano e di Lelio Sapiens fu in grande onore
Panezio, il massimo propagatore della dottrina stoica presso i Romani”.596
“Nell’età di Giulio Cesare la cultura greca investe in pieno il mondo intellettuale romano e lo feconda
dovunque: nella dottrina grammaticale e retorica, nell’eloquenza, nella filosofia, nella poesia. Filosofia e
poesia si congiungono anzi, ora, in Roma, come non si congiunsero mai in nessun tempo e in nessun luogo;
perché il poema di Lucrezio è rimasto unico monumento di quel che possa il genio poetico anche nella
espressione e nella significazione della scienza. Le dottrine filosofiche, pure accomodate e ridotte, erano
penetrate per via dei libri e dei doti greci che venivano e dimoravano in Roma: e le persone colte ne erano
tutte, più o meno leggermente, imbevute. I problemi filosofici che potevano interessare i Romani erano quelli
più propriamente politici e morali, quelli che meglio si prestavano alle facili discussioni e a una superficiale
esperienza e osservazione della natura e delle costumanze umane: esclusi i problemi che riguardavano
l’essenza delle cose e il grado e il modo della conoscenza, i quali avevano esercitato l’indagine greca, ma
restarono intentati dagli ingegni romani”.597
La società romana già nei primi decenni del I secolo a. C. è profondamente mutata. Le guerre sostenute
per espandere il dominio in Asia e in Africa hanno determinato il successo di capi militari che esercitano il
loro potere a Roma, per cui emergono gruppi e classi sui quali essi appoggiano i loro progetti politici.
L’esempio del conflitto tra Mario e Silla, rappresentanti dei partiti democratico e aristocratico, è eloquente. Il
popolo emerge in primo piano attraverso i capi che aspirano a occupare il potere. La politica si personalizza.
I Romani, prevalentemente agricoltori e guerrieri, non si erano occupati di problemi filosofici e scientifici;
avevano concentrato il loro interesse culturale sui problemi giuridici, riguardanti il governo della società.
Nel 168 a. C. la conquista della Macedonia portò i Romani a contatto diretto con la cultura greca. Allora
essi avvertirono i problemi che uno scambio intensificato con quella civiltà avrebbe comportato e cercarono
di limitare quei contatti, specialmente riguardo alla eventuale influenza negativa che avrebbero avuto
dottrine etiche e politiche incentrate sui concetti di felicità individuale e nelle quali si sosteneva l’opportunità
per gli individui di astenersi dagli impegni della vita civile. Si temeva che simili dottrine potessero esercitare
una funzione disgregatrice dello stato. La diffusione della filosofia greca era vista come un pericolo per
l’integrità della tradizione romana, fondata su saldi principi etici e giuridici. Perciò si delineò un vero e
proprio partito contrario alla politica di apertura verso i dotti che dalla Grecia sempre più numerosi si
stabilivano a Roma, incoraggiati dal notevole successo della loro attività dialettica e discorsiva. Catone il
Censore capeggiava quel partito. Un giureconsulto del 161 ordinò che i retori e i filosofi, venuti in Roma
come esuli della Macedonia, fossero espulsi.
L’incontro più significativo della filosofia greca (nelle sue correnti principali, accademica, stoica,
peripatetica) con la cultura romana avvenne nel 156, quando Atene inviava a Roma una missione
diplomatica, formata da tre filosofi (Carneade, Diogene di Babilonia e Critolao), rappresentanti di quegli
indirizzi. In quell’occasione costoro approfittarono per fare conoscere le loro dottrine, destando grande
595
Massimo interprete e rappresentante della “curiosità” filosofica dei Romani fu indubbiamente Cicerone, il quale
curò di apprendere l’intero panorama delle dottrine diffuse nel suo tempo e nelle sue opere fece intervenire, a dibattere e
dialogare, i sostenitori di esse, dimostrando di possedere conoscenze approfondite e di orientarsi con sicurezza nella
scelta delle opinioni più verosimili. Tutto ciò dimostra che il panorama filosofico greco era allora penetrato
nell’ambiente culturale romano.
596
C. Marchesi, Storia della letteratura latina, Principato, Messina 1950, pp. 104-5.
597
Op. cit., p. 104.
interesse. Specialmente Carneade impressionò con la sua oratoria, formata alla scuola di Platone e ricca di
sottili argomentazioni dialettiche. Famoso rimase il suo discorso sul contrasto tra la giustizia e la saggezza,
in cui la politica romana era indicata come esempio di prassi politica fondata sul diritto di conquista e non
riportata ai principi della più ampia conoscenza della natura degli uomini. I tre filosofi vennero perciò
invitati a lasciare Roma.
Ma nel corso di qualche decennio la situazione a Roma venne a mutare. I giovani interessati alla
formazione politica scoprirono sempre più numerosi il vantaggio dell’insegnamento retorico e si recavano a
frequentare le scuole filosofiche e oratorie della Grecia (specialmente quelle di Atene), mentre i dotti greci
erano invitati a stabilirsi a Roma, protetti da notevoli personalità politiche, che assicuravano il loro sostegno
per lo sviluppo di un’intensa attività culturale. Così a Roma soggiornò per oltre un decennio Panezio, grande
rappresentante della media Stoa. Egli era legato al circolo ellenizzante di Scipione Emiliano, che raccoglieva i
maggiori rappresentanti della cultura romana: lo storico Polibio, Terenzio, Lucilio, Caio Lelio, Quinto Elio
Tuberose e altri. Nel I secolo a. C. Roma era il centro culturale più notevole dell’intero mondo ellenistico.
“Sarebbe erroneo tuttavia ritenere che la Grecia, con i successi ora ricordati, sia effettivamente riuscita a
imporre a Roma la propria cultura. Che non sia stato così ce lo dimostra un fatto semplicissimo, ma molto
significativo: mentre la lingua greca si era rapidamente diffusa in tutto il mondo mediterraneo orientale (per
esempio in Egitto), tanto da diventarvi l’unico mezzo di comunicazione della cultura, nulla di simile accadde
in occidente. Nel campo linguistico la resistenza di Catone riportò piena vittoria: i romani continuarono a
scrivere in latino (cercando evidentemente di arricchire il loro vocabolario), e la civiltà mediterranea finì a
poco a poco per diventare bilingue”.598
Quanto la mentalità romana abbia influito sulle trasformazioni indotte nel campo scientifico dal modello
romano di cultura si vede chiaramente nelle opere di due scrittori, Polibio e Strabone, l’uno storico e l’altro
geografo, entrambi rivolti a considerare la realtà umana che si articolava nel mondo allora conosciuto.
Polibio (vissuto nel II secolo a. C.) nelle sue “Storie” (in quaranta libri) intese narrare le imprese di Roma, col
proposito di esaltare l’inclinazione dei romani al governo dei popoli e alla diffusione del diritto. Roma
appariva come un modello di ordinamento politico, adatto a essere esteso ai diversi popoli, in quanto sintesi
ed equilibrio di potere unitario e di riconoscimento delle autonomie nazionali e cittadine. Strabone (vissuto
un secolo e mezzo dopo) si interessò della complessa varietà dei popoli, delle culture e dei costumi,
abbandonando il campo della geografia astronomica e matematica fino allora coltivata.
Si può dire, dunque, che, se la Grecia vinta vinse a sua volta la sua vincitrice, mise, tuttavia, la sua cultura
al servizio della civiltà romana. Il progetto di una ellenizzazione del mondo conosciuto costituì l’obiettivo
greco fin dai tempi di Alessandro Magno, per cui, quando l’unificazione culturale fu resa possibile in seguito
alle conquiste romane, lo spirito che si impose come motivo di umanesimo universale fu ancora quello greco.
Polibio vide con chiarezza il ruolo delle due civiltà nell’attuazione del progetto unitario: solo Roma, con la
sua costituzione politica, avrebbe potuto procedere all’unificazione politica del mondo, comprendendo
Oriente e Occidente, cioè popoli diversi per credenze religiose, costumi, culture e spiritualità. Roma
contribuì a quel progetto con la sua cultura giuridica, che garantiva a tutti i popoli eguali condizioni di
autonomia. Lo spirito greco era tuttavia il grande fattore culturale dell’unificazione, specialmente attraverso
l’uso e la diffusione della sua lingua. L‘unità e la sintesi greco-romana rappresenta, pertanto, il più grande e
meraviglioso evento che la storia umana abbia registrato.
La “humanitas” occidentale non sarebbe se stessa senza l’impalcatura giuridica romana e senza la
profonda realtà dello spirito greco, vera e propria “sostanza” dell’eventualità storica propria dell’Occidente.
In questo senso la spiritualità occidentale non può essere che eclettica e pluralistica nel senso più
profondo. “Eclettico”, nel senso ciceroniano dell’humanitas, vuol dire essenzialmente aperta e disposta ad
accogliere in sé una molteplicità indefinita di motivi, di tendenze, di strutture ideali. Il che vuol dire, ancora,
estrema ricchezza di influssi, capacità di dialogo, disposizione alla sintesi. Tale appare la razionalità
occidentale, non chiusa e dogmatica, ma aperta e flessibile. Alla base dell’eclettismo vi è la convinzione che
l’approccio alla verità (alla conoscenza) è molteplice e diversamente articolato. L’esistenza umana è finita e si
realizza in rapporto a ipotesi possibili, di volta in volta intraviste.
I Romani si trovarono di fronte a un’ipotesi di umanità basata sulle regole della vita associata. Ciò che di
più valido (e dunque “vero”) gli uomini possono esprimere e attuare è la forma di una vita civile tale da
assicurare a ognuno la maggiore felicità possibile. Le istituzioni umane maggiormente convenienti sono
quelle della “città” fondata su una legislazione.
Platone individuò nelle “leggi” la massima espressione della razionalità.
Scopo dell’uomo è la costruzione della città giusta.
598
L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. I, Garzanti, Milano 1970, p. 319.
Cicerone è il massimo rappresentante della “humanitas” romana. Egli riconobbe al pensiero accademico
(della scuola di Platone) il migliore contributo alla fondazione e al governo della città. Ma lo stato romano si
estende al governo di una molteplicità di popoli, per cui le sue istituzioni devono poter valere per la
costituzione di un “imperium”, cioè di una legislazione idonea per l’umanità universale. Accanto al
platonismo accademico, Cicerone poneva lo stoicismo nel suo sviluppo “politico” più significativo, cioè una
forma di “cosmopolitismo” capace di abbracciare “gentes” diverse. Il significato politico dell’eclettismo
risiede specialmente in questo accostamento di platonismo e di stoicismo sul piano del cosmopolitismo. Tale
spirito occorreva inserire nel corpo dell’”humanitas”: il cosmopolitismo stoico, la convinzione che l’umanità
costituisce un corpo solo, solidale e unitario, tale da richiedere istituzioni unitarie e una forma di governo
universale. Cicerone interpreta l’universalismo romano. Missione di Roma è unire i popoli nelle medesime
istituzioni e strutture politiche. La stessa etica epicurea poteva essere presa in considerazione, se essa
esprimeva qualcosa di valido per il conseguimento della felicità umana. Si trattava, allora, di eliminare dal
contesto dell’umanesimo romano quel riferimento alla divinità che finiva per configurarsi come motivo di
timore, di paura di fronte al soprannaturale. Occorreva riconoscere il dominio della natura, come sola e
unica legislazione universale. L’epicureismo insegnava che una sola legislazione comprende l’umanità e la
natura, che per tutti si tratta di obbedire agli stessi principi. La concezione politica romana era, invece,
strettamente legata a un sistema di istituzioni religiose, era, in qualche modo, espressione della religiosità. La
“pietas” faceva parte dell’”humanitas”. L’epicureismo eliminava ogni residuo soprannaturale, riportava
tutto al governo della natura. Lucrezio scrisse il grande poema della natura come unico ordine delle cose e
dell’umanità. Sulla base delle leggi naturali ogni individuo raggiunge la felicità, vivendo conformemente ai
principi della vita serena, senza cercare di prevaricare sulla natura. Non vi sono altre leggi che quelle
comprese nell’ordine della natura. “Humanitas” e “naturalitas” coincidono. Cicerone aveva, invece, un forte
senso di religiosità: perciò avversava l’epicureismo, sebbene ammirasse Lucrezio, per avere esplorato le
regioni dell’universo, scoprendo dovunque le medesime leggi, l’universale principio della vicenda
dell’aggregazione e della disgregazione degli atomi. Secondo Cicerone, un ordine divino è alla base
dell’ordine della natura e della storia. La vita degli uomini è incardinata nell’ordine divino e religioso, fa
parte del soprannaturale. Gli spiriti umani fanno parte della vita immortale dell’universo. In questo senso,
“divinitas”, “naturalitas”, “humanitas”, “civitas” s’intrecciano insieme e costituiscono l’ordine dell’universo
e della storia.
Per l’epicureismo, invece, le istituzioni politiche sono un che di superfluo e non necessario. Esse servono a
contrastare e mitigare la ferocia umana, insita nella condizione naturale; sono in questo senso necessarie. Lo
scenario della natura è dominato dal contrasto, dalla vicenda dell’aggregazione casuale degli atomi e dal
destino di morte di ogni entità che viene a formarsi. L’epicureismo è caratterizzato da una nota di
pessimismo. L’uomo è destinato a dissolversi nella generale disgregazione delle cose.
Invece Cicerone professa la fede nell’immortalità dell’anima. Gli spiriti umani provengono da una sede
divina (dall’anima del mondo) e a una sede divina ritornano. Gli uomini che hanno contribuito al progresso
della civiltà politica sono premiati con la vita eterna di spiriti preposti all’ordine del mondo.
Gli spiriti che si sono prodigati nella vita civile dopo la morte sono assunti nelle sfere celesti e ad essi
viene dunque in qualche modo assegnato il compito di sovrintendere allo svolgimento della storia attraverso
gli influssi inviati dalla sede eterna. E’ la convinta credenza nella funzione degli spiriti immortali, esposta
nell’ultimo libro della “Repubblica”, il “Somnium Scipionis”, così diffuso nel medioevo. Gli spiriti beati di
Dante hanno qui la loro fondamentale concezione teorica.
L’unificazione politica dell’umanità rappresenta, in tale prospettiva, il fine ultimo della storia.
Nella spiritualità romana era compresa questa convinzione: che ai Romani era stata affidata (dallo stesso
Spirito del mondo) la realizzazione della “civitas” universale. Questa convinzione fa parte della
“humanitas” ciceroniana, della quale parte fondamentale è quella religiosità che ruota intorno alla credenza
nell’immortalità dell’anima e nel destino celeste degli spiriti immortali.
Cicerone, d’altra parte, non abbraccia una verità definitiva, assume il pensiero platonico (accademico)
come ipotesi teorica fondamentale, che trova motivi di sintesi e di approfondimento con quello stoico.
L’umanesimo latino aveva così il suo massimo rappresentante teorico, trovava la sua sintesi compiuta.
Lo stato romano si configurava come il principio federativo di tutti i popoli, come l’eclettismo costituiva il
principio metodico della sintesi culturale, idonea a evitare ogni dogmatismo e a costituire l’umanesimo come
ipotesi aperta, come fondamento e forma di pensiero critico.
Si tratta, ora, di aggiornare il progetto del governo mondiale, tracciando, sulle basi del diritto naturale, le
linee di una legislazione universale (tenendo conto ad esempio delle proposte di Kant nel suo saggio sulla
pace universale) che sia condizione (e ragione sufficiente) di un ordine politico nuovo.
L’eclettismo di Cicerone era anche una prova della vitalità e attualità del pensiero di Platone.
Lo stoicismo a Roma
L’impero romano, istituito con l’avvento dell’era volgare, procedeva alla unificazione del mondo
mediterraneo, come incontro e unità di Oriente e Occidente e dunque come luogo di una civiltà nuova, atta,
ormai, a presentarsi come istanza capace di superare differenze culturali, credenze religiose, concezioni
metafisiche. Veramente si profilavano i contorni di una civiltà universale, costituita dalla coesistenza di
culture diverse. Roma si affermava come istanza legislatrice superiore, per la quale assumevano legittimità,
entro i limiti della legge pubblica, le varie religioni e i vari culti. Il cristianesimo sembrava destinato a
succedere a concezioni religiose diverse, proprio per la sua capacità di richiamare a sé le folle dei più poveri
e umili, disposti a vivere esperienze di vita comunitaria e fortemente legati a una prospettiva di eternità. Il
bisogno di redenzione dell’esistenza rispetto alla sua finitezza cresceva nella misura in cui le filosofie
tradizionali mettevano in risalto proprio tale limite. L’epicureismo, specialmente, appariva del tutto inadatto
a interpretare le istanze dei tempi, con la sua prospettiva di universale dissoluzione delle cose. Lo stoicismo,
con la sua prospettiva panteistica, rispondeva meglio a tale esigenza. Ma il razionalismo morale, al quale
sostanzialmente si riportava la concezione stoica, era insufficiente per venire incontro alle tendenze
misticheggianti che si accompagnavano al più diffuso spirito di religiosità.
L’ultimo stoicismo esprime tra grandi suoi rappresentanti nel mondo romano: Seneca, Epitteto e Marco
Aurelio (l’imperatore filosofo).
Seneca599 (che fu maestro di Nerone ma che proprio per ordine di costui fu condannato a darsi la morte)
ha ampiamente argomentato i termini della morale come condizione di autosufficienza interiore e di
equilibrio e armonia spirituale. La condizione di vita felice consiste nella tranquillità dell’animo, è sostenuta
dalla fiducia in un mondo retto dalla provvidenza, si realizza in una pratica di vita fraterna (per cui la
fraternità si estende a tutti gli esseri dell’universo e non è prerogativa solamente umana).
Epitteto ha dimostrato che la felicità è possibile, solo se essa è cercata dall’individuo nell’interno di sé,
come desiderio di ciò che è in suo potere.600
Marco Aurelio601 (in concomitanza col suo ufficio) concepì la vita umana come servizio per la fondazione
dell’umanità razionale. Ribadì, in questo senso, la concezione di Epitteto, della vita come costruzione morale
del soggetto e come espressione della interna spiritualità. Così si profilava il progetto dell’umanità
universale come costruzione interiore, edificio da innalzare all’interno di sé. Con ciò l’umanesimo si
delineava come affermazione dell’autonomia spirituale, con l’idea dell’umanità come mondo che ha il suo
fondamento in sé.
Le componenti della spiritualità occidentale
Il poeta Paul Valéry ha individuato le grandi componenti della civiltà occidentale, sintetizzandole nel
trinomio Roma-Gerusalemme-Atene, cioè nei simboli del governo dei popoli fondato sul diritto, della
morale universale e della coscienza interiore, della conoscenza razionale e dell’umanesimo. Esaminiamo
più a fondo queste componenti che costituiscono le radici della nostra cultura, il fondamento culturale,
religioso e civile dell’Occidente.
Il mondo greco ha specialmente elaborato l’idea della razionalità come misura della conoscenza,
dell’attività pratica e della stessa costituzione dell’universo. L’ebraismo, e poi il cristianesimo, ha
maggiormente approfondito l concetto della responsabilità personale e dello stesso valore della persona. Per
i greci, invece, il soggetto individuale, che pure è il portatore del principio di razionalità, appartiene alla vita
della comunità. Ma è la romanità che specialmente fonda i principi del diritto, privato e pubblico, e delinea
una vera e propria dottrina dell’organizzazione statale dei popoli nella forma di autonomie nell’ambito di
organismi proiettati verso l’universalità. L’impero romano costituisce il più significativo esempio di un
ordine statale rivolto a comprendere il governo dei vari popoli in un’unità politica di comune cittadinanza.
Dall’antichità romana, pertanto, noi ereditiamo l’idea del governo universale nel rispetto delle autonomie
culturali. Una tale forma di governo e di cittadinanza comune (estesa a tutta l’umanità) costituisce il disegno
progettuale tuttora valido per la risoluzione dei problemi internazionali.
599
Specialmente famose sono le sue Lettere a Lucilio sulla felicità umana.
Il suo Manuale (tradotto anche da Leopardi) è una delle opere filosofiche maggiormente conosciute e diffuse.
601
I suoi Colloqui con se stesso (la sua unica opera) hanno avuto una straordinaria fortuna.
600
Accanto all’universalità politica si pone quella religiosa, che per certi versi è più difficile da attuare, per le
difficoltà connesse alla costituzione di una piattaforma comune per le diverse fedi e i vari culti che
costellano il pianeta. In questi ultimi tempi, nonostante le manifestazioni di fanatismo che continuano a
mietere vittime (specialmente nel mondo islamico), si sono avute prove significative di dialogo e tentativi di
avvicinamento tra le religioni. La teologia universale riceve una spinta notevole dallo stesso cristianesimo,
che da una parte si rivela come la professione di fede maggiormente idonea a mantenere vivo il fenomeno
del proselitismo e dall’altra parte appare come la principale protagonista del dialogo religioso ecumenico. Il
cristianesimo, in particolare, ha superato il più diffuso fenomeno della connessione tra fede e cultura dei
popoli, realizzando, piuttosto, una connessione tra le singole coscienze e il divino, sulla base della possibilità
di separare l’appartenenza a un ordine di cultura e a un sistema politico dalla professione di fede.
In questo senso, il cristiano si trova nelle condizioni più agevoli a vivere la sua laicità (come autonomia
sul piano delle convinzioni politiche e dell’appartenenza a un organismo statale). Il concetto di laicità si è
sviluppato, infatti, specialmente nel mondo moderno nell’ambito della cultura determinata dalla dottrina e
dalla fede cristiana. La democrazia, come forma politica più adatta all’affermazione dello stesso spirito del
laicismo, si è affermata senza difficoltà e in piena armonia con lo sviluppo della religiosità. Nessun
impedimento è derivato all’affermazione di questa prassi politica dalla fede o dalla Chiesa. Oggi l’Occidente
si riconosce ampiamente nel laicismo e nella democrazia. Il laicismo assicura la più ampia autonomia al
pensiero, alla critica, alla vita politica, alle scelte morali.. La religiosità riguarda, in questo caso, la sfera
interiore dell’individuo, dunque anche le personali convinzioni morali, che il soggetto intende seguire, anche
se l’ambito politico gliene consentirebbe altre. Il governo politico, infatti, si dichiara neutrale rispetto alle
convinzioni religiose e si dispone in modo da consentire l’espressione e la pratica delle varie dottrine e fedi.
A ognuno, dunque, va garantita la libertà di seguire, nei propri comportamenti, un determinato credo
religioso (e morale).
L’ordine politico si caratterizza come rigorosamente laico, tale, cioè, da non dipendere e da non interferire
con l’esperienza della religiosità. Dicendo ai suoi seguaci “Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio
quel che è di Dio”, Gesù ha fondato il laicismo nella storia e nella condotta dell’uomo. All’autorità politica,
dunque, il cristiano riconosce le prerogative proprie. Lo stato, d’altra parte, arretra di fronte alla libertà della
coscienza individuale, non impone mai una fede, non interferisce negli articoli e nei principi della fede. La
coscienza individuale è sacra: essa viene investita dalla fede o rimane il campo proprio dell’assoluta libertà
di pensiero, la fonte di ogni “verità”.
E il principio dell’assoluta autonomia della coscienza appartiene alla cultura greca. Il soggetto appare
come la fonte di ogni decisione, di ogni scelta. Anche se si tratta di conformare il proprio comportamento
alle leggi dello stato, si tratta, comunque, di deliberare intorno a ciò che, in ultima analisi, è rimesso alla
libertà dell’individuo. Socrate decide di morire comportandosi da cittadino, piuttosto che fuggire dal
carcere, contravvenendo agli obblighi derivati dall’appartenenza alla comunità politica. La sua morte,
quindi, appare come la conseguenza di un atto di libera scelta. Questo principio dell’assoluta libertà della
coscienza costituisce il dato fondamentale della concezione greca dell’uomo. L’uomo è l’unico ente che può
decidere intorno alla propria sorte. L’essere dell’uomo dipende dalla scelta che egli di volta compie intorno a
se stesso. Achille decide di frenare la sua ira contro Agamennone, Ulisse decide di rimettersi in viaggio per
fare ritorno in patria, rifiutando le preghiere della ninfa Calipso che lo implora d restare. La consapevolezza
intorno alla libertà umana appare connaturata con lo stesso spirito greco. L’attività spirituale, infatti, è ciò
che appare come carattere proprio della cultura greca: il mondo è il prodotto della libera creazione dello
spirito libero.