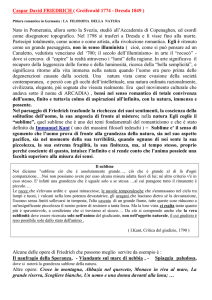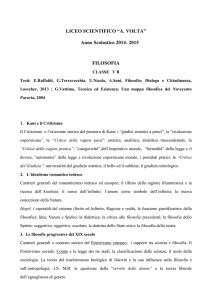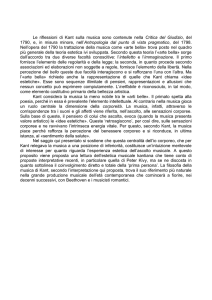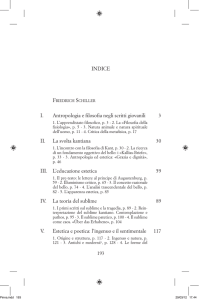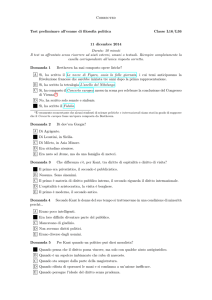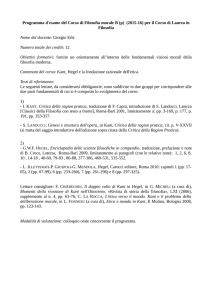RIVISTA QUADRIMESTRALE - ANNO XX
NUOVA SERIE - N. 59 - SETTEMBRE-DICEMBRE 2006
SOMMARIO
Pubblicazione quadrimestrale promossa dal Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce, con la collaborazione del “Centro Italiano di Ricerche fenomenologiche” con sede in Roma.
Questa rivista si pubblica anche con i contributi del M.I.U.R., attraverso il Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università degli Studi di Lecce, e
dello stesso Dipartimento.
Parte di questa pubblicazione rientra nel Progetto di Rilevante Interesse Nazionale su “Fenomenologia, narrazione, riflessione etico-politica: testi e temi
del pensiero francese del Novecento”, a cui partecipano le Università di Bari,
Lecce, Roma Tre, Sassari e Verona.
2
Direttore responsabile: Giovanni Invitto
Comitato scientifico: Angela Ales Bello (Roma), Angelo Bruno (Lecce), Antonio
Delogu (Sassari), Giovanni Invitto (Lecce), Aniello Montano (Salerno), Antonio
Ponsetto (München), Mario Signore (Lecce).
Redazione: Doris Campa, Raffaele Capone, Maria Lucia Colì, Daniela De Leo, Lucia
De Pascalis, Alessandra Lezzi, Giorgio Rizzo.
Comitato Scientifico e Segreteria hanno sede presso il Dipartimento di Filosofia e
Scienze sociali, Università degli Studi - Via M. Stampacchia - 73100 Lecce - tel.
(0832) 294627/8; fax (0832) 294626. E-mail: [email protected]
sito: siba2.unile.it/ese
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: Piero Manni s.r.l., Via Umberto I, 51
73016 San Cesario di Lecce - Tel. 0832/205577 - 0832/200373. Iscritto al n.
389/1986 del Registro della Stampa, Tribunale di Lecce. Abbonamento annuo:
Italia t 25,00, Estero t 35,00, c/c postale 16805731 intestato a Piero Manni
s.r.l., Lecce. L’abbonamento, in qualunque mese effettuato, decorre da gennaio e dà diritto a ricevere i numeri arretrati dell’annata.
Un fascicolo t 10,00, degli anni precedenti il doppio.
Stampato presso Tiemme - Manduria
nel settembre 2006 - per conto di Piero Manni s.r.l.
5
Franco Ferrarotti
Fenomenologia della soggettività etica
20
Pierre Taminiaux
Parole e cose: Beckett e l’Arte
29
Germano De Marzo
Il tenebroso fascino del sublime nel sistema kantiano
54
Debora Maccanti
L’attenzione al vedere nella filosofia di Wittgenstein
69
Silvio Paolini Merlo
Il pensiero compositivo di Beethoven
87
Giuseppe Moscati
Feuerbach tra Spinoza e Schopenhauer:
due etiche e due antropologie a confronto
92
Cosimo Caputo
Marx e la matematica
96
Nicoletta Ghigi
I “Dialoghi metafisici” di Hedwig Conrad-Martius
100
Bianca Maria D’Ippolito
L’intersoggettività fra ragione e passione
105
Marina Pia Pellegrino
Spunti di una “fenomenologia dell’infanzia”
3
118
Recensioni
148
Nota su Prin
151
Pubblicazioni ricevute
4
NOTE PER GLI AUTORI
I contributi vanno inviati alla Direzione di “Segni e comprensione” c/o Dipartimento di Filosofia e scienze sociali – Via V. M. Stampacchia 73100 Lecce. I testi debbono essere inviati in duplice copia, su carta formato A4, dattiloscritta su una sola facciata, a doppia interlinea, senza correzioni a mano.
Ogni cartella non dovrà superare le duemila battute. Il testo deve essere inviato assolutamente anche su floppy disk, usando un qualsiasi programma
che, però, dovrà essere indicato (Word, Windows, McIntosh). Si può utilizzare anche l’e-mail: [email protected]. Il materiale ricevuto non
verrà restituito.
Per la sezione “Saggi” i testi non dovranno superare le venti cartelle comprese le note bibliografiche, per la sezione “Note” non dovranno superare le
sette cartelle, per la sezione “Recensioni” e “Notizie” le tre cartelle.
Si raccomanda che i titoli siano brevi e specifici. La redazione si riserva il
diritto di apportare eventuali modifiche, previa comunicazione e approvazione
dell’Autore.
Agli Autori saranno inviate tre copie del fascicolo in cui appare il loro lavoro.
“Segni e comprensione” è disponibile in edizione telematica sul sito http://siba2.unile.it/ese,
alla pagina Pubblications. Ogni numero sarà scaricabile due mesi dopo la pubblicazione
cartacea della rivista.
FENOMENOLOGIA
DELLA SOGGETTIVITÀ ETICA
di Franco Ferrarotti
1. La natura umana come realtà diveniente
L’anima come “soffio”, lo spirito come “movimento”. L’ironia di Arthur Schopenhauer (Geist? Wer ist der Bursche? “Spirito? E chi è mai questo giovanotto?”) è fuori luogo; esprime uno stato umorale più che una esigenza teoretica
(il disappunto per la grande fama di Hegel). Lo spirito si manifesta e si realizza nel movimento storico, in cui si muove e da cui, in quanto spirito individuale, viene trasceso. In ciò, come già in Kant e, anzi, approfondendolo, Hegel va
oltre il concetto statico di “sostanza” della filosofia scolastica e l’essenzialismo
che ha tanta parte nelle riflessioni degli epistemologhi moderni (per esempio,
Karl Popper). Il “soggetto” non è subjectum, cioè “ciò che giace sotto”. La sostanza –substantia– non è solo ciò che “sotto-sta”.
È già stato osservato che l’intento profondo di Hegel consisteva nel superare in modo produttivo il concetto di soggettività, come singulus kierkegaardiano, e di autocoscienza, in cui peraltro è riconosciuto l’apporto cruciale dell’età moderna, e nel mostrare che la via del pensiero speculativo passa attraverso la mediazione tra universale e singolare. Per Hegel, infatti, tutto dipende
dal concepire ed esprimere il vero non come sostanza, ma altrettanto come
Soggetto. Poiché la sostanza è essa stessa Soggetto, proprio perciò ogni contenuto è anche la riflessione di sé in se stesso. Il Soggetto è questo: che esso
si dà a se medesimo l’esser altro e che mediante la negazione di sé ritorna a
se stesso, ossia produce se stesso.
Secondo Hegel, il Soggetto solo nel predicato ottiene la sua esplicita determinazione e il suo contenuto: per sé è una mera rappresentazione o un nome
vuoto.
Di qui, la sua storicizzazione, al di là di ogni congelamento naturalistico, come individuale e universale. L’individuale è in effetti il medesimo che il reale in
atto; solo che il primo, l’individuale, viene fuori dal concetto e così, quale universale, è posto sempre come identità negativa con se stesso, mentre il reale,
essendo dapprima solo in sé o immediatamente l’unità dell’essenza e dell’esistenza, può produrre effetti; ma l’individualità del concetto è senz’altro ciò che
attua –e non già, come la causa, con l’apparenza del produrre un altro– ma è
ciò che attua se stesso. L’individualità non è da intendersi nel senso di individualità solo immediata, al modo in cui noi parliamo di cose singole e o di uomini singoli. Ma l’individualità, il soggetto, è il concetto posto come totalità. Hegel chiarisce che il momento delle individualità è quello che comincia a porre i
momenti del concetto come differenze, essendo l’individualità la riflessione in
SAGGI
112
Tommaso Tuppini
Io sono un (pensiero) autarchico
5
6
vola o della pietra o di un albero – nel senso che la natura dell’uomo non rinvia ad una datità fissa, ma è invece concepibile solo come processo. L’uomo
non è. Diviene ciò che fa. Più che homo sapiens è, in questo senso, homo faber, e, più ancora, homo historicus. L’agire umano è dunque cruciale per la definizione dell’essere umano. D’altro canto, l’agire umano è problematico nel
senso che non è né assolutamente libero né assolutamente determinato. È un
agire condizionato, nel senso che è compreso e racchiuso in un orizzonte storico definito. Si muove in una situazione empiricamente constatabile.
L’agire umano deve, è costretto, quindi, a prendere atto della situazione e
procedere all’analisi preliminare delle forze in gioco che pesano e condizionano, aiutano e ostacolano il suo agire. Questo condizionamento è reale, ma non
decisivo. Resta all’essere umano il compito della scelta. In ogni istante, l’essere umano compie una scelta (anche il decidere di non scegliere è una scelta),
le cui conseguenze gli sono in parte prevedibili. In questo senso, la scelta –inevitabile– è sempre un rischio. Essa sottolinea, d’altro canto, e nello stesso tempo prova e conferma la libertà dell’essere umano, la sua capacità di porsi come agente positivo o negativo, di fare il bene o il male. In questo senso, emerge un nesso significativo fra libertà e possibilità –possibilità drammatica perché
aperta sul bene o sul male– libertà relativa e possibilità effettiva.
2. La costituzione del Sé
È nella scelta che il soggetto si costituisce nella sua individualità –unica, irripetibile, irriducibile ad altro. La costituzione del Sé– o formazione del soggetto, come anche si potrebbe dire –è processo laborioso, che rinvia necessariamente alla socializzazione primaria, alla famiglia, alla classe d’appartenenza,
alla fase storica– in una parola, all’altro da Sé. Non si dà Io che non rimandi,
inevitabilmente, a un Tu, a un contatto, a un rapporto. Di che tipo? Simbiosi, sinergia, conflitto?
Forse Søren Kierkegaard ha affrontato, con maggior impeto di altri, il tema
del singulus: “La categoria per la quale devono passare […] il tempo, la storia,
il genere umano […] la categoria dello spirito, del risveglio dello spirito, contrario quanto può essere alla politica […] con questa categoria (del singulus) sta
o cade la causa del Cristianesimo”.
Per questa via, in Kierkegaard il “singolo” diventa la categoria fondamentale
dell’esistenza in quanto –è stato osservato– strappando l’uomo alla pressione
della folla, lo pone davanti a Dio e gli permette il salto decisivo della fede.
Ed ecco il paradosso del tempo moderno: “Il nostro tempo ha perso ogni
definizione sostanziale della famiglia, dello Stato, del genere umano; esso è
costretto ad abbandonare il singolo individuo a se stesso che diventa così, nel
senso più profondo del termine, il creatore di se stesso”.
E tuttavia, anche l’essere umano più solitario ha il suo Tu: è appunto il se
stesso, l’alter ego, l’ego superior e l’ego inferior, l’incessante confabulazione
del sé con se stesso. per cui si possono vedere, in mondi di pensiero e contestuali differenti, le Confessioni e i Soliloqua di S. Agostino e gli Essais di Michel
SAGGI
sé negativa del concetto e perciò, anzitutto, il libero distinguere di esso come
la prima negazione, onde viene posta la determinatezza del concetto, ma come particolarità.
Si rende quindi evidente che le parti e il tutto sono inscindibilmente legati e
si comprende, d’altro canto, come la stessa scuola storica, malgrado il suo fondamentale orientamento anti-hegeliano, sapendo che in fondo non si dà storia
che non sia storia universale giacché solo in base al tutto il particolare si definisce nel suo significato, finisce per essere hegeliana. Occorre rifarsi, è stato
suggerito con buone ragioni da Gadamer, al modo in cui la scuola storica si è
definita in contrapposizione a Hegel: “Il rifiuto della costruzione aprioristica della storia rappresenta anche l’atto di nascita di tale costruzione. […] La premessa decisiva di questa posizione è costituita dalla critica di Herder alla filosofia
della storia dell’Illuminismo. Il suo attacco all’orgoglio razionalistico dell’Aufklärung trovava la sua arma più tagliente nel carattere esemplare dell’antichità
classica, di cui si era fatto banditore soprattutto Winckelmann. […] Bastò che
Herder procedesse poco oltre la base posta da Winckelmann, riconoscendo in
ogni passato il nesso dialettico di esemplarità e di irripetibilità, per giungere a
contrapporre, alla visione teleologica della storia degli illuministi, una prospettiva storicistica universale”1.
È appena necessario osservare che ciò comportava un colpo mortale alla
validità meta-storica e in-temporale del valore, di ogni valore, ma anche il rischio di fagocitare ogni valore nell’indistinto fluire delle cangianti condizioni
storiche misconoscendo la distinzione fondamentale tra forma e formulazione
del valore. I valori sono prodotti storici e nello stesso tempo preservano una
validità meta-storica. In quanto tensioni permanenti, non si esauriscono nella
storicità pura e partecipano della natura degli archetipi, che sono sovrastanti e
impervi all’esperienza storica, cui danno senso. Essi si pongono come punti di
riferimento non impassibili, e quindi non solo da contemplare nella prospettiva
di una estenuata estetizzazione, ma da vivere, nella durezza slabbrata e oscura della quotidianità nel suo laborioso farsi. Di qui, il problema del raccordo fra
valori e esperienza da parte del soggetto, in quanto agente storico, dotato di
un apparato psico-genetico, o natura, ma in primo luogo attore sulla scena storica, che nella storia si forma e a poco a poco si manifesta.
In questo senso è legittimo affermare che l’uomo non ha natura, nel senso
che animali non umani hanno natura e sono da questa ‘programmati’, ma storia, e quindi libertà – una libertà relativa, che non è data dell’alto né coercitivamente offerta dalla dotazione fissa di stimoli istintivi, ma una libertà come liberazione all’interno di un quadro condizionante, che è essenzialmente storico.
Sarebbe utile a questo proposito una rilettura del saggio kantiano, Sul male radicale della natura umana, che è la “prima parte” di La religione nei limiti della
pura ragione, anche per approfondire la problematicità del termine e del concetto di “natura umana” (the nature of human nature) e per rendersi conto del
perché si possa fondamentalmente parlare di un’irruzione della società artificiale (così suona il titolo di un contributo del sociologo Heinrich Popitz2, Der
Aufbruch der artifiziellen Gesellschaft 3).
L’uomo non ha natura allo stesso modo in cui si parla della natura della ta-
7
8
Hegel, debba venire dal soggetto, che proprio il soggetto abbia il primato. La
materia inerte, per Hegel, non può mai contenere neppure un granellino di verità, si identifica con l’appiattimento meccanicistico, incapace di cogliere i fenomeni nella loro globalità significativa, ossia totalizzante, che al più può comprendere l’influsso delle circostanze esterne sugli esseri umani, ma non l’azione reciproca di questi sulle condizioni esterne.
C’è allora in Hegel questo, in apparenza, sconcertante gioco di specchi: l’interno come l’esterno; l’esterno come l’interno. Gli uomini non sono schiavi, ma
non sono neppure padroni; non sono servi ma neppure signori; non sono proletari, ma neppure capitalisti7. Il senso della filosofia hegeliana sembra essere
questo: la scoperta dell’avvenire del passato; questa è l’essenza della filosofia
della storia e quindi, per necessaria conseguenza, la storia della filosofia (cfr.
E. Bloch, Eclaircissements sur Hegel). Non dovrebbe stupire, a questo punto,
che il significato della Fenomenologia dello Spirito si presenti, in definitiva, come una sorta di paesaggio retrospettivo, come un lungo ricordo che in sé contiene e consuma l’avvenire, tanto da poter dire che lo scopo della riflessione filosofica ad altro non miri, platonicamente, che a sapere ciò che si era già saputo, attraverso la rammemorazione interiore, che aiuta gli esseri umani, esseri incompiuti, a giungere al proprio compimento e alla piena coscienza di questo compimento.
3. La costruzione dell’identità del soggetto
Dal punto di vista dell’analisi sociologica, si possono distinguere alcuni gradini nel processo della costruzione dell’identità e dell’auto-coscienza del Soggetto:
a) l’identità è in funzione della dimensione temporale della coscienza di sé;
b) l’identità comporta necessariamente il sentimento di unitarietà esperenziale e di tendenziale coerenza;
c) l’identità non è un dato, ma un processo – un processo che consiste nel
padroneggiare e organizzare significativamente una molteplicità di stimoli e impulsi (la personalità nevrotica è infatti quella che nello stesso momento ha in
sé due forze, contrarie e simmetriche, che la lacerano e la paralizzano);
d) l’identità si fonda su un triplice processo: 1. di separazione rispetto al
gruppo originario; 2. di autonomia; 3. di affermazione;
e) l’identità si rafforza: 1. con il sentimento di originalità; 2. con l’azione e
l’iniziativa; 3. ponendosi come valore, da accettare e da amare.
In tutti questi gradini del processo di auto-costruzione, l’altro è essenziale.
Si può anche concordare con Kierkegaard che il singolo è “la categoria fondamentale dell’esistenza”; ma l’in-dividuum, come l’etimo suggerisce, non dovrebbe essere divisibile; in realtà, l’individuo è plurale, molteplice, overlapping.
Un poeta veggente l’ha perfettamente intuito ed espresso: “Je est un autre”
(Artur Rimbaud). Come lo ha intravisto il giovane Nietzsche, un altro veggente: “Gli organismi […] sono definiti individui in quanto centri di fini. Ma ci sono
unità solo per il nostro intelletto. Ogni individuo ha in sé un’infinità di individui
SAGGI
de Montaigne. Si distingue, per lunga tradizione, il monologo dal dialogo, ed è
nel dialogo che, sulla scorta dell’insegnamento platonico, Schlegel e Schleiermacher hanno colto una via d’uscita. Essi hanno visto appunto nel principio del
dialogo, che si prolunga fino all’ermeneutica odierna, lo schema metafisico fondamentale per conoscere la verità e per costituirla come conquista partecipata, come valore inter-soggettivo.
Ma anche il monologo è pur sempre un dialogo. Forse un giorno si scoprirà che è possibile un dialogo oltre la diade, oltre il rapporto diretto del gruppo
primario, una sorta di “oclòlogo”, ossia di un dialogo di massa. Viviamo o possiamo scegliere di vivere nella solitudine, come Jean-Jacques Rousseau nelle
Promenades d’un penseur solitaire o Henry David Thoreau nelle Walden sulle
rive del laghetto di Concord o fra le pagine del Journal intime di Frédéric Amiel,
ma non si dà “discesa introspettiva” che possa far dimenticare il semplice fatto che vivendo noi non viviamo in realtà mai da soli, ma conviviamo, ossia interdipendiamo.
La crisi dell’individuo dell’illuminismo trova la sua radice esistenziale nell’illusione di una sovrana autosufficienza che non si giustifica né sul piano storico né su quello teoretico4. Non siamo nulla in senso assoluto, ossia al di fuori
delle circostanze di tempo e di luogo specifiche. Siamo ciò che siamo stati. Più
precisamente: ciò che ricordiamo di essere stati5. Memoria e ricordo si legano
nella formazione dell’identità e sono dunque ingredienti fondamentali per la costruzione della soggettività come realtà relativamente unitaria e coerente. Questa costruzione è in Hegel un’esperienza mobile, letterariamente “di viaggio” –
die fahrende Erfahrung. Non è, o non è soltanto, una metafora, come forse ancora la si può cogliere nella Storia di un’anima di S. Teresa di Lisieux. È l’indicazione di una realtà mobile, mai data, mai scontata, che si fa e diviene, oggetto che non si cristallizza mai, ma che a sua volta in concomitanza si automodifica6.
Hegel distingue tre gradi o piani della coscienza di sé: il primo piano è quello del puro e semplice hic et nunc del singolare elementare e determinato. Il
secondo piano è posto in essere dalla percezione, con la sua caratteristica illusione della cosa come centro d’incontro e unità di proprietà molteplici. Il terzo piano è quello della comprensione della cosa in quanto ne ordina il contenuto costituito dall’intreccio delle forze costitutive del dato fenomeno, il quale
si sdoppia e si pone nello stesso tempo come forza interna e realtà esterna.
Da questo punto di vista, in Hegel la Erinnerung, ossia la reminiscenza, non è
solo ricordo retrospettivo, o Gedächtnis, bensì ricordo come ricostruzione, che
non si limita ad essere la riproduzione di una riproduzione, ma è l’interiorizzazione del Sé, il ritorno del Sé a se stesso. In questo senso, si può parlare di un
vero e proprio va-e-vieni fra esperienza e coscienza (del quale si ricorderà Sartre in Questions de méthode).
Hegel però parte dall’Essere indeterminato. Credo invece legittimo e produttivo partire dall’essere determinato, circoscritto, storicamente dato. Per Hegel, nonostante il va-e-vieni, sembra farsi strada il timore che dall’empiria, dal
dato empirico non si possa più riattingere il livello concettuale in senso forte
(che è dato come un a-priori). Non è certo un caso che il primo impulso, per
9
10
troveremo, sviluppati e perfezionati in Montaigne e Rousseau. Ora è vero che
Rousseau afferma, nel Libro primo delle sue Confessioni, di essersi entusiasmato, nei primi anni dell’infanzia e forse formato leggendo ad alta voce fino a
notte fonda e talvolta fino al mattino le Vite parallele di Plutarco al padre orologiaio a Ginevra. Ma per Plutarco e, in generale per i classici, la vita individuale aveva senso e meritava di essere raccontata solo in funzione pubblica. Nelle Origines Catone il Vecchio si gloriava di non aver menzionato un solo nome
proprio. Le biografie del Greci erano enkòmia, elogi funebri, recitati a edificazione dei cittadini, praesente cadavere.
L’uomo, presso i classici, non si definisce mai in quanto tale, per via immanente. Lo si può definire per esclusione, differenziandolo simultaneamente dagli dei e dagli animali. Lo si può definire in base al posto occupato nella società oppure in vista di una gerarchia divina sopraterrena, in termini di idee iperuranie che ne fondano e garantiscono l’anima, o la parte nobile, non soggetta
alla morte, alla decadenza fisica e alla corruzione che sembrano attendere, come esito inevitabile, i corpi. Ma l’uomo non si definisce mai come “uomo interiore”, come valore in sé. Non si può dire che il Cristianesimo abbia, a questo
proposito, prodotto innovazioni radicali. L’interiorità cristiana non vale di per sé;
vale e conta in quanto apre le porte del paradiso e della vita eterna.
Paolo di Tarso l’ha detto con la secca chiarezza in tutto degna di un militare di professione: Non habemus hic manentem civitatem. Il caso di S. Agostino e delle sue Confessioni è, d’altro canto, straordinariamente istruttivo. L’intento edificante di S. Agostino ne svela la pseudo-modernità. Lo fa cadere al
di fuori delle coordinate dell’individualismo occidentale, vale a dire al di fuori
della concezione dell’individuo come causa sui, realtà autonoma, indipendente e autosufficiente. Contrariamente a Rousseau e a Stendhal, a Benvenuto
Cellini o a Goethe, S. Agostino non si confessa a se medesimo. Per quanto il
suo sia un serrato dialogo e talvolta un drammatico scontro fra l’ego inferior e
l’ego superior, S. Agostino si confessa essenzialmente a Dio, chiama in causa
Dio e i disegni imperscrutabili della provvidenza. È, in fondo, Dio che parla a
Dio nel foro della coscienza di Agostino. L’individuo è solo un tramite, l’occasione e il segno di una presenza trascendente nel mondo.
4. L’Io in fuga
In Rousseau, invece, come del resto in Montaigne, l’individuo è insieme
mezzo e fine. La Confessioni di Rousseau, come i Ricordi d’egotismo di Stendhal, sono la vivisezione di un individuo che sperimenta in corpore vivo: autochirurgia, discesa agli inferi in una interiorità immanente, chiusa in sé, troppo
disincantata per credere o sperare in un disegno sovramondano. Rousseau
non si accetta così com’è: folle, ingrato, multiplo, quindi infido, forse schizoide.
È troppo figlio del suo tempo: illuminista, razionalista malgré lui. Non può accettare l’incoerenza. Sente e proclama le sue colpe. Spera con ciò di essere
assolto. Stendhal, sul filo della memoria, parte dall’oggi per risalire indietro nel
tempo. Non dissimile in ciò da Mark Twain, che si lascia andare a libere asso-
SAGGI
in quanto centri di fini. Ma ci sono unità solo per il nostro intelletto. Ogni individuo ha in sé un’infinità di individui viventi”. Difficile dir meglio. E poi ancora, citando Goethe: “Ogni essere vivente non è un singolo, ma una molteplicità, anche quando ci appare come individuo, resta sempre una riunione di esseri viventi autonomi”. E ancora: “Ogni individuo ha in sé un’infinità di individui viventi. È solo un modo di vedere grossolano, ricavato forse inizialmente dal corpo
umano”8.
È però in Max Scheler che la categoria kierkegaardiana del singulus trova
le istanze critiche più appuntite. Per Scheler, da solo, il singulus non regge. La
diffidenza di Scheler nei confronti dell’Io mi sembra radicale, affine a quella di
Sigmund Freud e di Emile Durkheim. Scheler scorge nell’Io un vero pericolo
per l’assolutezza della conoscenza. “Non vi è –scrive– nessuna ‘condizione’
del mondo o dell’essere del mondo che si debba conoscere o sperimentare attraverso un Io o attraverso un che conoscente (Erkennendes) che porti in sé
nell’essenza dell’egoità (Ichheit) […]. Solo il cogitare è ‘condizione’ nel senso
della suddetta connessione essenziale (non un cogito), come del resto l’essere del mondo non è meno ‘condizione’ del cogitare stesso […]. Origine di un
esperire da una persona e sorgere di un’esperienza in un persona sono perciò
due cose radicalmente diverse” (Ursprung eines Erlebens aus einer Person
und Entstehung eines Erlebnisses in einer Person sind eben grundverschiedene Dinge).
L’individuo è, del resto, conquista relativamente recente della tradizione culturale europea. Jacob Burckhardt ne scorgeva le origini, dal punto di vista storico, nel particolarismo esasperato dei piccoli Stati dell’Italia rinascimentale.
“La natura di questi stati –precisa Burckhardt– siano essi repubblicani o dispotici, è la causa principale se non l’unica, del precoce sviluppo dell’Italiano, è soprattutto grazie ad essa che egli è divenuto un uomo moderno. È ancora grazie ad essa che egli è stato il primo dei figli dell’Europa attuale. Nel Medioevo
le due facce della coscienza, la faccia oggettiva e la faccia soggettiva, erano
in qualche modo velate, la vita intellettuale somigliava ad un dormiveglia. Il velo che avvolgeva gli spiriti era un tessuto di fede e di pregiudizi, di ignoranza e
di illusioni; faceva apparire il mondo e la storia sotto colori bizzarri. […] L’Italia
di prima strappa questo velo e dà il segnale dello studio obiettivo dello Stato e
di tutte le cose di questo mondo; ma accanto a questo modo di considerare gli
oggetti di sviluppo sotto l’aspetto soggettivo; l’uomo diviene individuo spirituale e acquista la coscienza di questa nuova condizione”9.
Altrove, specialmente in La storia e il quotidiano (Laterza, Roma-Bari 1986),
ho richiamato la tesi di Burckhardt, come suggestivo anticipo, che scorge nell’uomo rinascimentale l’alba dell’individuo autosufficiente dell’Illuminismo.
Burckhardt ricorda che espressioni come “uomo singolare”, “uomo unico”
cominciano allora ad avere corso. Indicano gli “uomini superiori” o anche gli
“uomini universali”, come Leon Battista Alberti. Sono espressioni inaudite, di
assoluta originalità, che stanno a significare e attribuiscono un valore all’individuo in sé, indipendentemente dalle funzioni sociali o pubbliche che egli riveste,
e quindi prescindendo dalla sua posizione nella comunità e nello Stato. È
un’idea di individuo che si lega all’autoconsapevolezza secondo modi che ri-
11
12
delle biografie nella società presente e particolarmente all’interno del contesto
culturale di massa. Diceva che recentemente lo stesso concetto di vita in quanto unità autosviluppantesi e significativa ha poco senso oggi come il concetto
dell’individuale, ed è la funzione ideologica delle biografie a richiamare la narrativa su modelli arbitrariamente selezionati e a ricordare che c’è ancora una
cosa come la vita. La vita stessa nella sua apparenza completamente astratta
è divenuta mera ideologia. […] L’ideologia dell’industria culturale fa ricorso soprattutto al sistema divistico preso a prestito dall’arte individualistica e dal suo
sfruttamento commerciale. Più il suo funzionamento e il suo contenuto sono disumani, e più insistente e più riuscita è la pubblicità che fa a presunte grandi
personalità”12.
La crisi della soggettività moderna e il disagio di massa, variamente espresso in una quantità di disadattamenti e di depressioni le cui radici e genesi sociale sono per lo più ignorate, vengono dunque da lontano.
L’identità dell’individuo in senso moderno –un’identità che viene oggi pesantemente chiamata in causa o forse solo notabilmente registrata dalla postmodernità– si costruisce sulla base del “politeismo dei valori”, ossia sulla base
di vari concetti del bene etico-politico, che pur nelle loro differenti diramazioni
si costituiscono in definitiva come i suoi criteri legittimati. In primo luogo, l’autonomia dell’individuo, fondata sulla presunzione di poter fondare su di sé i propri valori di riferimento scorgendo, nell’etica, più che una trama o disegno trascendentale, una tecnica della convivenza nell’epoca del “disicanto del mondo”. È impossibile fare a meno di citare questa frase tanto suggestiva quanto
fuorviante, almeno fino a quando non si riesca a raggiungere quel punto cruciale di intersezione in cui il problema teorico dell’etica e della eventuale fede
religiosa confluisce e incontra, al di là delle dispute puramente nominalistiche,
l’esperienza storica così come è effettivamente vissuta dagli individui e dai
gruppi umani. È probabilmente per questa ragione fondamentale che la ricerca tecnologica e di sociologia della religione di oggi non può considerarsi esaurita nell’esame, pur scrupoloso e filologicamente provveduto, delle fonti, vale a
dire dei sacri testi.
Max Weber, fra i sociologi, mercé il concetto di “tipo ideale” che è, come è
noto, uno strumento analitico euristico con materiali storici e indicante un comportamento sociale medio, è riuscito a darci alcuni esempi persuasivi di disincanto socializzante e di vita sociale razionalizzata a confronto con la quotidianità di epoche paleo-tecniche e pre-razionalistiche. Ciò non sempre è stato capito.
Il crociano di stretta osservanza Carlo Antoni, quando rimprovera a Max
Weber una non perfetta conoscenza dei testi teologici del Calvinismo con riguardo all’etica economica, dimostra di non aver compreso l’intento di Weber,
che è ovviamente estraneo a qualsiasi disputa teologica di scuola. Il concetto di secolarizzazione in Weber non ha pretese di correttezza dogmatica e filologica, come invece gli fa puntigliosamente osservare Carlo Antoni, nel volume Dallo storicismo alla sociologia, una transizione che per Antoni non è
precisamente un progresso. Le stesse istanze critiche non dovrebbero a rigore meravigliare se fiorissero oggi sotto la penna di insigni studiosi, come Gio-
SAGGI
ciazioni contro ogni successione cronologica, con un pudore, tuttavia, che
Rousseau e Chateaubriand non conoscono.
Difficile scrivere una autobiografia senza parlare di sé, o addirittura senza
parlare o parlare con l’asciutta impersonalità degli articoli del codice civile.
Gli autobiografi sono dei chiacchieroni frustrati. Citando Emmanuel Lévinas, Beatrice Didier ha osservato che, nella misura in cui l’autobiografo tenta
di mostrare il suo viso, egli invita alla parola. Viso e discorso sono legati. Il viso parla. Esso parla in quanto rende possibile e comincia ogni discorso. È difficile tacere alla presenza di qualcuno; questa difficoltà ha il suo fondamento
ultimo in questa significazione propria del dire, quale che sia il detto. Bisogna
parlare di qualcosa, della pioggia o del bel tempo, poco importa, ma parlare, rispondere a lui e rispondere quindi di lui. Il lettore di autobiografie rischia di parlare troppo10.
Ma questa idea di individuo, tema di autobiografie, che si osserva con principe distacco giorno per giorno, nei suoi movimenti interni, nei suoi slanci e nelle sue ricadute, punto di partenza e punto di arrivo, che presume di riassumere in sé l’evoluzione umana, si presenta obsoleta, non è più omogenea alle società di massa tecnicamente progredite e corrisponde sempre meno ai loro imperativi funzionali.
L’Io è oggi in fuga. L’antropocentrismo è in crisi. La filosofia del “pensiero
debole” è il puntuale riflesso e il disperato tentativo (in termini pseudofilosofici,
in realtà e psicologizzanti) di correre in soccorso ed eventualmente di rianimare una personalità fatalmente indebolita. La soggettività umana non è più al
centro. Si avvertono in ogni campo i segni della sua emarginazione. È forse da
questo punto di vista, a parte le dolciastre illusioni di chi pensa di risolvere le
sue crisi esistenziali con un viaggi a Katmandu, che l’Occidente ha qualcosa
da imparare dall’Oriente. C’è qui una responsabilità storica del Cristianesimo
di cui occorre prendere buona nota.
Et Verbum caro factum est. Con il dogma dell’incarnazione del Cristo, del
figlio di Dio che si fa uomo fra gli uomini, non si provvede solo ad una funzione salvifica dell’umanità. Si colloca (surrettiziamente) l’uomo al centro dell’universo e si consuma la grande scissione fra anima e carne, fra corpo e spirito.
Con il dogma dell’immacolata concezione, sia pure con le migliori intenzioni, si
butta fango sulle origini stesse della vita. L’egolatria consacrata al Cristianesimo storico, che ha eretto in dogma l’umanizzazione del figlio di Dio, ha forse
oggi, per la prima volta, i giorni contati. Il primato assoluto dell’uomo e la sua
posizione dominante nell’universo sono stati duramente intaccati sotto aspetti
importanti, dalla transizione del sistema tolemaico a quello copernicano in
astronomia, alla scoperta freudiana dell’inconscio, alla crisi dell’idea del grand’uomo come solitario demiurgo e alla odierna fine della storia come storia di
ristrette élites destinate per imprescindibile diritto di nascita al potere.
Leo Löwenthal ha notato a questo proposito una funzione spuria e mistificante del genere biografico nella società di massa11: “Quando scrissi dei cambiamenti culturali nella selezione e nel trattamento delle biografie nelle riviste
popolari da quelli che chiamavano ‘eroi della produzione’ a ‘eroi del consumo’,
Adorno mi ammonì in una lettera del 1942 che sottolineava la funzione teorica
13
14
5. Un mondo orfano
È appena necessario osservare che questi processi di trasformazione hanno luogo all’interno di un passaggio ancora più radicale, di quella che Karl Polanyi ha creduto di poter chiamare la “grande trasformazione”. Da un tradizionalismo magico-religioso, quindi da una visione della vita e del proprio destino
come essenzialmente trascendente, tanto da poter dire con Goethe Alles Vergnägliche/ist nur ein Gleichnis, siamo passati a una società caratterizzata dal
processo di industrializzazione su scala sempre più vasta, che ha l’ambizione
esplicitamente affermata di produrre da sé i propri valori e che del resto non riconosce come vincolante alcun criterio valutativo esterno alla correttezza interna dei propri procedimenti.
Caduta la trascendenza o, più precisamente, tradotti e ridotti i principi trascendenti ad abitudini metodiche quotidiane, il mondo moderno appare come
un orfano, che Nietzsche avrebbe definito “umano, troppo umano”. Il contrasto
con i tipi precedenti di società, tutti legati a un marcato simbolismo magico-religioso onni-pervasivo, è parso a molti studiosi così forte da scorgervi una rottura qualitativa. Un’osservazione del grande storico delle idee olandese J. Huizinga cade qui opportuna: “Lo spirito di quel tempo era così riempito di Cristo
che la più tenue analogia che un’azione o un pensiero avesse con la vita o con
la passione del Signore, ne evocava immediatamente l’immagine. Una povera
monaca, portando legna da ardere in cucina, si immagina di portare la croce:
la sola idea di portare il legno basta per circondare l’azione dell’aureola di un
supremo atto d’amore. Una donnetta cieca nel fare il bucato prende la tinozza
e il lavatoio per il presepio e la stalla”15.
Questa potenza simbologica e trasfigurante ha del tutto abbandonato l’individuo moderno e il suo mondo immanente, persuaso di potere da sé, dal proprio interno, esprimere gli orientamenti etici di cui non si dà gruppo umano che
possa fare a meno. I criteri legittimanti di questa supposta autosufficienza rimandano a una triplice costellazione di valori:
a) alla consapevolezza interiore del proprio valore, che risuona chiarissima
nelle parole più sopra citate di Kant, secondo una prospettiva meta-utilitaria, e
quindi tendenzialmente universale, orientata al Bene e quindi non priva del
senso della misura, connaturata alla fìnitudine umana, eppure destinata nel giro di poco più di un secolo a tradursi nel perseguimento della propria felicità al
di fuori e al di là di ogni parametro di ragionevolezza;
b) al senso della comunità in cui l’individuo fiorisce e si sviluppa fra eguali
–una comunità, è appena necessario osservare, strettamente elitaria– mantenendo inalterata e, anzi, rafforzando la propria capacità di iniziativa e autodeterminazione nel perseguire i propri fini;
c) all’individuo che considera se stesso come proprio “capolavoro” in un illimitato processo di auto-deificazione16; poiché l’individuo moderno non può rischiare di giungere a morte prima di avere pienamente vissuto, come temeva
Rousseau, perché al di là del comportamento strumentale pragmaticamente finalizzato, questo individuo si realizza nei comportamenti espressivi in cui esigenze etiche e atteggiamenti estetici giungono a fondersi.
SAGGI
vanni Filoramo, o di agguerriti filologi che sembrano specializzarsi nella produzione di libri attraverso libri senza mai veramente correre il rischio di eventuale sporcarsi le mani e toccare quella che Machiavelli usava chiamare la
“realtà effettuate”.
Di fronte al grande parlare e al diffuso scrivere che oggi si fa intorno alla fine della storia e alla critica della modernità, a confronto con la corriva accettazione del concetto di post-moderno, sarebbe forse utile rammentare che né il
discorso storico e ancor meno quello filosofico-teologico si possono fare con
gli avverbi di tempo. A mio sommesso parere, la modernità non è ancora esaurita. È stata invece investita da una crisi che ne impone la revisione e la riformulazione sul piano teoretico in senso pieno, e non solo su quello delle vaporose fumisterie estetizzanti. Alcuni valori primari, che ne costituiscono il fondamento, come la dignità dell’individuo, la sua libertà, il suo “diritto naturale” alla
sopravvivenza e ai mezzi di sussistenza indispensabili, attendono ancora di
essere inverati sul piano storico. Tanto da poter dire che la modernità, lungi
dall’essere stata “superata” dal post-moderno, rimanda invece ad un processo
storico incompiuto mentre molte, forse troppe critiche della modernità fanno
solo pensare all’ansia di chi sia partito in gran fretta per un viaggio di cui ha dimenticato lo scopo e che all’improvviso ricordi d’aver lasciato la luce accesa in
cucina.
Nessun dubbio che la concezione unilineare del progresso –continuo e irreversibile– sia insostenibile13. Ma nessuno, d’altro canto, neppure fra gli illuministi più generosi e meno illuminati ha mai pensato che il progresso fosse
una fatalità cronologica. Forse il solo senso in cui appare lecito oggi parlare di
una crisi della modernità è che questa ci ha fatto finalmente comprendere che
nella tradizione del mondo classico e del mondo medioevale vi erano potenziali semi positivi ancora da sviluppare, valori e tensioni da rendere storicamente
produttivi. La modernità ci fa oggi comprendere che la tradizione non è tradizionale, che essa è rivoluzionaria. Il monito kantiano, rivolto al nascente individuo, Sapere aude! conserva ancora, intatta, la sua attualità. Le parole di Kant
sono del 1784 e meritano di essere richiamate: “L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se
stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende dal difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo”14.
Ricerche accreditate documentano che il controverso concetto di “secolarizzazione” non è solo un concetto. È in primo luogo una pratica di vita. Si ricollega essenzialmente con l’idea di “mondo moderno” come mondo dominato e definito dal “calcolo razionale”, vale a dire come mondo della onnicalcolabilità, in cui emergono, nella routine quotidiana più che nel pensiero riflesso, i
fenomeni correlativi del “disincantamento” e della laicizzazione della “chiamata” o vocazione religiosa (Beruf) che tende a mondanizzarsi come competenza burocratico-metodica specifica, anche quando si continui a indicarla con il
termine piuttosto ambiguo di “missione”.
15
16
porsi quale prerogativa fondante delle grandi strutture organizzative impersonali.
Nel romanzo L’uomo senza qualità, Robert Musil ci offre, forse inconsapevolmente, un’esemplificazione eloquente della duplicità problematica dell’esperienza umana. Accade un incidente automobilistico. Una donna, investita mentre sta attraversando la strada, muore. Il vigile di turno stende il verbale, annota diligentemente le circostanze di fatto, il luogo, l’ora, la causa oggettiva dell’incidente: i freni non hanno funzionato. Arriva il marito della donna morta. È sconvolto. Si dispera. Il vigile lo avvicina e gli ripete, nella maniera più persuasiva possibile: “Stia tranquillo. È tutto chiaro. I freni non hanno funzionato”.
Dà al marito una spiegazione tecnica ineccepibile. Ma il marito continua a
disperarsi, angosciato. Non gli interessano le spiegazioni tecniche. Considera
la realtà della morte – una realtà così comune e nello stesso tempo così scontata che nessuno riesce di regola a pensarci seriamente. Riesce al più a pensare alla morte del vicino. La morte è un’ombra che pesa intollerabilmente sulle società tecniche, mette crudamente in luce i problemi tecnicamente non solubili. Le società industrializzate hanno semplicemente cancellato la morte.
Hanno risolto il problema sopprimendolo. Da realtà angosciosa e problema
metafìsico, la morte è stata derubricata a mero incidente tecnico. Il pensiero
calcolante ha preso il sopravvento. Ci si comporta come se la morte non esistesse. In California il morto è ritratto mentre sta telefonando. La toeletta del
morto ha dato luogo a una fiorente industria di cosmesi funeraria. Si leggano
“II caro estinto” (The Loved One) di Evelyn Vaugh e The American Way of Death di Jessica Mitford. Non è aberrazione. È un esito rigorosamente logico.
Una volta negato il limite, la morte non è più concepibile.
Lo scandalo della morte per le società industrializzate non dovrebbe stupire18: è lo scandalo per società e gruppi umani che non riconoscono il limite, travolti dal fare per fare. Presso altre società –paleotecniche, medioevali,
protoindustriali– vigeva una grande familiarità con la morte, spesso considerata come un’altra forma di vita, se non il momento del trapasso, come si diceva, verso una “miglior vita”. La morte era un fenomeno normale, accettato, cui tutta la famiglia estesa, partecipava, compresi i bambini. È interessante notare che Martin Heidegger a questo proposito ripete letteralmente Platone con il suo Sein zum Tode, purtroppo sfruttato abilmente dai nazisti nella loro pedagogia per i giovani, la famosa “educazione alla morte”. Per il filosofo classico, la morte libera l’anima dall’involucro corporeo ed è quindi sommamente desiderabile da parte del vero filosofo. Per Martin Heidegger, poiché ognuno ha la sua morte (un’esigenza che viene artisticamente espressa
con grande forza da Rainer Maria Rilke nei Quaderni di Malte Lauris Brigge
con la morte del nonno che ricercava la sua, solo la sua, specifica, unica),
questa si pone come condizione per la riconquista dell’autenticità dell’individuo al di là della banalità del “si dice” quotidiano (ma perché Heidegger ritiene che il “si dice” sia necessariamente inautentico? Cfr. il mio Mass media e
società di massa, 1992. Forse si tratta di un riflesso del suo fondamentale
elitarismo, disprezzo della gente comune?).
SAGGI
Si apre qui e si rende evidente una debolezza mortale per l’individuo moderno in quanto la convergenza fra perfezione formale tecnica, norma etica e
fruizione estetica comporta che le due verità –quella scientifica o verificata o
stipulata in base a standard oggettivi o esterni– e quella legata alla consapevolezza interiore vengano a confondersi, ponendo in essere il rischio dell’appiattimento scientistico della presenza umana nel mondo con l’ovvia conseguenza della drastica riduzione del pensiero meditante, o riflessivo o involontario, al pensiero calcolante, pragmaticamente finalizzato, e quindi del problema umano, in quanto tensione permanente, al problema tecnico, solubile caso
per caso, previa l’esatta applicazione delle istruzioni per l’uso.
La caduta della consapevolezza problematica e quindi la confusione fra
razionalità tecnico-formale e razionalità sostanziale non hanno soltanto decretato, sul piano storico, il trionfo della tecnologia come strumento di risoluzione, caso per caso, delle questioni che si pongono all’uomo di oggi, circoscrivendole e distaccandole dal quadro globale dell’esistenza, che per questa via viene dapprima oscurato, come riferimento non empiricamente valicabile e quindi risibile, inconsistente, per essere poi semplicemente dimenticato come irrilevante. Di fatto, la mentalità prevalente, che si afferma in tutte le sfere della vita, è quella della specialistica competenza metodica e dell’esprit polytechnicien.
Forse vi è fin dall’origine della “dissidenza soggettiva”, come m’è parso di
poterla cogliere nella Libertà del Cristiano di Lutero17, questo varco aperto all’egocentrico specialismo, legato all’insindacabile interpretazione personale
delle Scritture, che tende, anche inconsapevolmente, a obliterare la necessità del rapporto con l’altro, che non ha da essere, necessariamente, l’autorità
costituita, e insieme del riconoscimento-accettazione dell’alterità per la costruzione del Sé. È stato dimenticato l’insegnamento dei classici: i Greci hanno acquistato autoconsapevolezza, storica e politica, solo dal contatto con i
Barbari.
Sta di fatto che l’individuo moderno è solo e che le sue libertà, pur consacrate nella carta degli “immortali principi” del 1789, hanno potuto essere considerate come privilegio puramente individuale, tanto che la stessa Rivoluzione francese ha riguardato solo i citoyens, vale a dire i proprietari di terra
francese, e le sue libertà sono state quindi percepite come scontate nei termini di una acquisizione perenne. Persino un sociologo problematico ai limiti dell’angoscia e della nevrosi come Max Weber non sembra rendersi conto
della loro fragilità. Non prevede né si accorge dell’incombente notte totalitaria del regime hitleriano.
Si noti che qui non siamo nelle steppe russe. Non si tratta del “dispotismo
orientale”, di cui si occupava Karl Wittfogel con la sua “teoria idraulica del potere”. Ci troviamo nel cuore dell’Europa occidentale, a poche centinaia di chilometri da Parigi, la ville lumière. Eppure: l’individuo dei lumi è fragile. Le sue
libertà, già tanto esaltate, sono in realtà labili. La soggettività etica, in quanto pura, esclusiva prerogativa dell’individuo, è in pericolo. Quella che dapprima sembrò una grande vittoria sulla tradizione e sull’autorità costituita, era in
realtà un grande pericolo. Già la ragione stava abbandonando l’individuo per
17
18
Cfr. H. G. GADAMER, Wahrheit und Methode, tr. it., Bompiani, Milano 1983.
Cfr. H. POPITZ, Verso una società artificiale, tr. it. di G. Auletta, con mia “prefazione”, Editori
Riuniti, Roma 1996.
3 Forse, ancora una volta, come già ai tempi di Galileo, non sarà necessario lasciar passare
molto tempo –allora bastarono tre secoli– per rendersi conto del grave errore della Chiesa quando oggi procede alla esplicita sacralizzazione della “natura”.
4 Cfr. in proposito il mio Macchina e uomo nella società industriale, ERI, Torino 1962.
5 Cfr. in proposito il mio Il ricordo e la temporalità, Laterza, Roma-Bari 1975.
6 “In verità –è stato notato– si rende giustizia al concetto di essere soltanto quando viene compresa anche l’esperienza genuina che produce la sua instaurazione, l’impulso filosofico ad esprimere l’inesprimibile […] la filosofia in verités de raison né in verités de fait. […] La sua storia è un
insuccesso costante, in quanto, teorizzata dalla scienza, ha sempre di nuovo cercato il concetto”
(T. ADORNO, Dialettica negativa, Einaudi, Torino 1970, p. 97; corsivo nel testo).
7 È allora possibile una lettura della dialettica hegeliana non scolasticamente definita dal punto di vista logico formale, che trova invece la sua origine nella inquietudine e nella sofferenza, in
uno sprotetto, forse vano tendere verso una totalità mai pienamente raggiungibile.
8 F. NIETZSCHE, Appunti filosofici – 1867-1869, Adelphi, Milano 1931, p. 21; p. 153.
9 Cfr. J. BURCKHARDT, La civiltà del Rinascimento in Italia, tr. it., Sansoni, Firenze 1921, pp. 153154; corsivo nel testo.
10 Cfr. B. DIDIER, Stendhal autobiographique, Puf, Paris 1983, p. 49. Ma per osservazioni concettualmente rigorose, per quanto non garantite rispetto al rischio d’una interpretazione psicologi1
2
stica, cfr. W. DILTHEY, Critica della ragione storica, Einaudi, Torino 1954 (tr. it. dei voll. V e VII dei
Gesammelte Schriften, Teubner, Leipzig-Berlin), specialmente pp. 295 e 302-310; Dilthey cita, come esempi di autobiografie, quelle di Sant’Agostino, Rousseau e Goethe.
11 Naturalmente nessuno potrà negare o sottovalutare l’apporto della biografia alla valorizzazione dell’individuo, specialmente del grande individuo per cui cfr. K. J. WEINTRAUB, The Value of
the Individual, University of Chicago Press, Chicago 1978.
12 Cfr. L. LÖWENTHAL, L’integrità degli intellettuali, tr. it., Solfanelli, Roma 1991, pp. 46-47.
13 Cfr. il mio The Myth of Inevitabile Progress, Greenwood, New York 1985.
14 Cfr. il mio Macchina e uomo nella società industriale, cit., p. 4.
15 In L’Autunno del Medioevo, tr. it.. Sansoni, Firenze 1978, p. 264.
16 Donde, fra l’altro, la caduta del senso classico della misura, del limite (medèn ágan; ne quid
nimis); il venir meno del terrore dell’ápeiron — le mitiche “Colonne di Ercole”, che la geografia classica antica collocava a Gibilterra.
17 Si veda il mio Una teologia per atei, Laterza, Roma-Bari 1983.
18 Cfr. il mio Vietato morire - Miti e tabù del secolo XXI, La Mandragora, Imola 2004.
SAGGI
Sulla base dei lavori di A. Koyré (soprattutto il “mondo del pressappoco”),
John U. Nef (The Cultural Foundations of Industrial Civilization) e Raymond
Aron (La società industriale; il mio Macchina e uomo nella società industriale, 1962), si possono individuare alcune caratteristiche della società industriale:
a) precisione estrema;
b) quantità contro qualità; intercambiabilità delle parti rispetto all’originalità
(artigianale) del prodotto;
c) restringimento della dimensione delle famiglie;
d) separazione del luogo di lavoro dal luogo della vita familiare;
e) concorrenza inter-personale per vantaggi materiali;
f) individualismo selvaggio in un mercato planetario impersonale;
g) declino dell’idea di prossimo; equiparazione fra valore monetario e valore morale;
h) erosione e scomparsa della comunità.
In questo tipo di società il processo di individuazione tocca il suo apice. Si
possono, da questo punto di vista distinguere tre fasi evolutive, che sono alla base dei tre passaggi fenomenologici dell’obbligazione etica: 1. Tradizione (verità
rivelata); 2. Coscienza dell’individuo come realtà autonoma (I. Kant); 3. Uscita
dall’autonomia intersoggettivamente vincolante alla ricerca della propria autenticità attraverso l’imprevedibile spontaneità. Donde, crisi del rapporto inter-umano
e dei fondamenti della convivenza; socio-genesi della depressione individuale;
caduta del senso dello sviluppo umano e angosciante timore del futuro.
19
di Pierre Taminiaux
A Spoon Jackson
20
Scrivendo il suo articolo critico intitolato Le Monde et le Pantalon, Beckett
ha raggiunto la lunga lista di scrittori francesi, d’origine o d’adozione, che si sono dedicati parallelamente alla critica d’arte1. Si possono citare qui i “salons” di
Diderot, nel diciottesimo secolo, quelli di Baudelaire, nel diciannovesimo, ed
ancora gli scritti di Valéry, di Reverdy, di Ponge o di Malraux, nel ventesimo secolo, insieme a tanti altri. La critica d’arte, in questo senso, non è la riserva di
caccia dei sedicenti specialisti o eruditi. Essa deborda dal dominio puramente
accademico per estendersi al mondo della letteratura, che non manca di affrontarla in maniera frontale. Lo scrittore ed il poeta, in questo campo, hanno
anche loro qualcosa da dire, poiché l’arte, dopo tutto, appartiene a tutti o, piuttosto, a tutti coloro che la guardano con attenzione e rispetto. In Le Monde et
le Pantalon, il proposito beckettiano sull’arte è d’altronde radicalmente originale e senza concessioni. Egli non prende mai in prestito la retorica prudente e
secca dei maestri stabiliti della critica d’arte e, al contrario, il suo proposito costituisce un vero e proprio assalto contro ogni forma di critica tradizionale e forse persino, al di là, contro la critica tout court.
Che cosa è un critico d’arte, dopo tutto, se non qualcuno che si autorizza a
parlare dei quadri, dei disegni o delle sculture con delle parole, secondo una
traduzione (o un dislocamento) simbolico particolarmente pericoloso e incerto?
La critica letteraria, non soffre dello stesso problema. Essa rende conto in effetti dell’universo poetico, del romanzo o teatrale utilizzando un linguaggio verbale, che, fondamentalmente, non è diverso dal linguaggio del suo oggetto. In
altre parole, si possono spiegare le immagini e le rappresentazioni visive o plastiche con queste parole? E queste sono almeno in grado di rendere conto del
visibile e della sua creazione senza tradire l’identità dell’oggetto al quale si riferiscono? Queste domande sono presenti implicitamente, se non esplicitamente, nel testo di Beckett2. Ma esse rinviano ugualmente a problemi più estesi che toccano la scrittura beckettiana nel suo insieme, a partire da En attendant Godot e Fin de Partie fino a Compagnie (Company) o Mal Vu, Mal dit. Il
critico d’arte, inoltre, non parla semplicemente delle opere o dell’arte in quanto tale: egli cerca essenzialmente di esprimere il proprio sguardo sull’arte attraverso le proprie parole, e la sua preoccupazione fondamentale è piuttosto,
in questo senso, quella della presenza indiscutibile del suo sguardo nel cuore
della scrittura.
L’opera di Beckett, in effetti, non ha mai smesso di interrogare la profondità e la verità dello sguardo per e nell’esistenza umana. Chiusi in se stessi o all’interno dello spazio scenico, i personaggi concepiti dallo scrittore sembrano
spesso, così, essere incapaci di vedere qualunque cosa sia intorno ad essi. La
voce di Compagnie, per esempio, sorge dal nero e dunque da un mondo in cui,
alla lettera, è impossibile vedere3. Pensiamo inoltre anche al titolo stesso di
Mal Vu, Mal dit, che mette chiaramente in relazione il problema dello sguardo
e della sua mancanza (della sua assenza) con quello del linguaggio. Da un
punto di vista metafisico, punto di vista di cui nessuno può dire che non costituisca una delle dimensioni più importanti della sensibilità beckettiana, lo
sguardo è in qualche modo antinominico alla costituzione e all’espressione del
linguaggio. Poiché l’uomo, in effetti, è votato per la sua condizione alle tenebre
e all’“assurdo”, si mette necessariamente in un universo privo di luce, di chiarore e, dunque, giunge a parlarne perché, precisamente, non gli è permesso di
vedere intorno a lui. Il linguaggio, in questa prospettiva, è l’unica cosa che rimane quando tutto il resto è immerso nel buio.
Non bisogna stupirsi, dunque, che Beckett non si sia veramente soffermato sulla critica d’arte. Le Monde et le Pantalon, in effetti, si presenta come una
sorta di meteora nella sua opera, se si esclude la sua breve collaborazione con
Georges Duthuit per un testo su Tal Coat, André Masson e Bram Van Velde4.
Questo breve saggio fu scritto all’inizio dell’anno 1945, in occasione delle mostre congiunte dei fratelli Abraham e Gerardus Van Velde, due pittori astratti
olandesi, alle gallerie Mai e Maeght a Parigi. Fu pubblicato in seguito in “Les
Cahiers d’art” e molto più tardi, come libro autonomo, dalle Éditions de Minuit,
l’anno della sua morte, cioè il 1989. La data del suo concepimento è senza alcun dubbio rivelatrice: corrisponde alla fine della seconda guerra mondiale e si
situa, dunque, in un contesto fortemente turbato da questa realtà. La pittura dei
fratelli Van Velde appartiene per molti aspetti al dominio dell’espressionismo
astratto, che diverrà, negli anni successivi alla Liberazione, una corrente dominante delle arti plastiche in Francia e negli Stati Uniti. Nel 1945, pertanto, questo stile era ancora sconosciuto e poco apprezzato dal mondo dell’arte e soprattutto dal pubblico. I decenni precedenti erano stati segnati soprattutto dalle rivoluzioni cubiste e surrealiste che continuano ad esercitare un’influenza
considerevole, alla fine della guerra, sull’arte moderna nel suo insieme. Beckett diventa, così, in qualche modo, l’avvocato del diavolo: sceglie di difendere due artisti d’importanza marginale, la cui reputazione in Francia resta limitata se si considera che loro vi lavoravano già da quindici o vent’anni. È d’altronde la prima volta che questi due fratelli costituiscono l’oggetto di una mostra
personale nella capitale francese, occasione eccezionale, dunque, che Beckett
intende cogliere.
Si sa che lo scrittore frequentò, durante la sua vita, molte personalità associate al modernismo artistico e pittorico e che manifestò un grande interesse
per le attività degli artisti d’avanguardia. È sufficiente citare, in merito, la lunga
amicizia che lo legò a Peggy Guggenheim5. Il testo di Le Monde et le Pantalon
non costituisce, dunque, in sé, una sorpresa. Ciò che lo è di più, è il tono che
attraversa il saggio critico di Beckett, un mélange d’ironia a distanza e
d’asprezza spontanea (si potrebbe perfino parlare d’insolenza, un’insolenza
che paradossalmente sfocia nell’affermazione della necessità del rispetto dell’arte e degli artisti). L’autore comincia con lo smontare i pregiudizi che accom-
SAGGI
PAROLE E COSE: BECKETT E L’ARTE
21
22
re, l’impiego di “mezzi letterari”? La scrittura come la pittura autentiche, non
oserei dire “pure”, non possono esistere ed affermarsi che al di là e contro tali mezzi. L’idea stessa di mezzo, nella sua semantica abituale, è inevitabilmente associata a quella di fine. L’uomo, in questo senso, si serve di certi
mezzi per pervenire a certi fini. Ma l’opera di Beckett ci avrà perfettamente insegnato che la scrittura non si destina ad alcun fine, e che il suo linguaggio si
nutre della rimuginazione nella misura in cui l’essere e la sua voce sono chiusi in un cerchio perpetuo, se non vizioso, quando invece la geometria, al contrario, specifica dei fini, offre a questi la promessa di una linea che sbocca ad
un punto dato. E cosa potrebbe significare veramente, per la scrittura, quest’ultimo punto, questo sedicente risultato, o sbocco che, comunque, non è?
A che cosa mira? Al peggio, al meglio? In altre parole, poiché tutto è già finito, poiché siamo tutti già inseriti in questo cerchio che costituisce esso stesso una chiusura e un fine, non si è ancora e sempre che all’inizio, come ci ricordano bene le prime parole di Fin de Partie.
L’arte dei fratelli Van Velde, così, esprime la sfida di questo inizio per la pittura. Davanti a questa pittura (ma anche la pittura in generale), Beckett si mette allora nella posizione dell’appassionato che solo l’amore dell’arte agita. Così egli dice: “Tutto ciò che voi saprete mai di un quadro, è quanto l’amate”7. Il
sapere della critica gli sembra vano, chiaramente, ed egli non lo considera o
quasi. Tutta la vera pittura, in questo senso, è quella che permette di sottolineare la vanità di questo sapere ed è capace di acuire una sorta di sguardo
originale e puro, lontano dal linguaggio e dal pensiero. È in questo che si può
affermare che l’arte celebrata da Beckett è soprattutto un’“arte bruta”. Non lo è
necessariamente e strettamente nel senso estetico e storico del termine (nella sfera di Jean Dubuffet), ma piuttosto nel senso di un’arte che chiama con
forza ed in modo irresistibile uno sguardo bruto, cioè primitivo nel suo desiderio selvaggio di superare e di andare al di là del peso di un’eredità culturale comune. Questo sguardo nasce in qualche modo al di fuori della storia, storia dell’arte riconosciuta e legittimata dalla critica, in uno stato di sospensione profonda del tempo.
Ma questo sguardo implica ugualmente il sentimento della fissità e dell’immobilità delle cose all’interno del quadro stesso. La pittura ha sempre cercato di voler fermare il tempo, rappresentandolo. Essa costituisce, dunque, per
essenza un’arte della sospensione. Il rapporto privilegiato di Beckett con la
pittura astratta definisce inoltre uno spazio visivo e pittorico il cui oggetto si è
ritirato, poiché l’oggetto, secondo il proprio ragionamento, si è affermato nella storia dell’arte occidentale come la parte intrinseca o il nodo della rappresentazione classica. Al di là dell’oggetto, allora, non ci sono che cose. “La pittura di A. Van Velde sarebbe dunque in primo luogo una pittura della cosa in
sospensione, direi volentieri della cosa morta, idealmente morta, se questo
termine non avesse delle spiacevoli associazioni. Cioè, la cosa che si vede
non è più soltanto rappresentata come sospesa, ma assolutamente come essa è, fissata realmente. È la cosa sola isolata dal bisogno di vederla, dal bisogno di vedere. La cosa immobile, nel vuoto, ecco infine la cosa visibile, l’oggetto puro. Io non vedo altro.”8
SAGGI
pagnano ancora nel 1945 le reazioni negative di una grande parte degli amatori d’arte perfino “illuminati” verso l’arte moderna. L’astrazione, secondo questi pregiudizi, sarebbe il rifugio degli artisti incapaci, di coloro che non sanno
disegnare, per esempio. Beckett si diverte qui davanti a frasi comuni e più volte ripetute, del tipo: “Un bambino potrebbe fare altrettanto”. Egli si sforza di mostrare che tali commenti mirano a negare contemporaneamente l’originalità e
la libertà d’espressione dell’artista moderno. Lo scrittore, dopo tutto, non è
stato fatto oggetto di simili attacchi concernenti i suoi scritti Malone Meurt o
L’Innommable? Non si è tentato di affermare, in effetti, che questo tipo di scrittura rifletteva un’incapacità profonda di raccontare una storia, un fallimento
della narrativa, dunque, così come un’impotenza ad esplorare la dimensione
psicologica dei personaggi sulla quale la tradizione del romanzo realista del
XIX secolo si è fondata? La radicalità estetica, sia letteraria o pittorica, si paga
allo stesso modo, vale a dire cara. Essa costituisce in ogni epoca l’oggetto di
assalti o di ciechi rifiuti e spesso di malafede. Il progetto letterario beckettiano
si è eretto non soltanto contro i canoni della letteratura classica, al seguito di
Joyce, ma anche e forse soprattutto, contro la nozione di letteratura propriamente detta (o piuttosto artatamente detta, per osare un gioco di parole nello
spirito dello scrittore di cui ci occupiamo in questo testo). Scrivere, adesso lo
sappiamo grazie a Beckett, non è affatto fare letteratura. In altri termini, non è
fare romanzo, né poesia, né tanto meno teatro. Il genere, in effetti, ha comunque un cattivo genere. Ora è precisamente su questa nozione sacrosanta di
genere che una certa eredità accademica e scolastica della letteratura si è a
lungo costruita. Essa non è scomparsa oggi, lontana da ciò, nella nostra cultura mediatica basata sulla commercializzazione generalizzata del libro e, più in
particolare, della produzione romanzesca (impiego qui appositamente
l’espressione “produzione romanzesca” invece di quella, più semplice e diretta, di “romanzo”, per sottolineare che una tale concezione si inscrive deliberatamente in un ordine onnipotente dell’efficacia economica).
In Le Monde et le Pantalon, parallelamente, Beckett si sforza di mostrare
che dipingere, per l’artista moderno, non è o non è più fare, in questo caso,
pittura, cioè belle arti. Gli obiettivi e le esigenze della letteratura e dell’arte si
ricongiungono, dunque. Il pittore non si dedica più ad un esercizio convenzionale e sterile che consiste nel ripetere un genere qualunque, dalla natura morta al ritratto. In questa prospettiva, Beckett giunge a mettere in dubbio l’esistenza di “mezzi strettamente plastici”: “Sarebbe in ogni caso utile, e perfino
interessante, sapere ciò che si intende per mezzi plastici. Ora nessuno lo saprà mai. È una cosa che solo gli iniziati subodorano. Ma supponiamo che la
definizione sia acquisita, una volta per tutte, in modo tale che qualunque critico potrà gridare, davanti ad un quadro da giudicare: ‘Bene, i mezzi sono plastici’, e che sia stabilito allo stesso tempo che solo la pittura che se ne serve
è buona. Che dire, in questo caso, dell’artista che vi rinunciasse” 6? Beckett ritrova, così, nel movimento dell’arte moderna e dell’avanguardia, un principio
quasi morale e non semplicemente estetico di rinuncia alla Duchamp che lo
tocca intimamente nel proprio progetto di scrittura. Perché cosa potrebbe veramente significare, per Beckett, soprattutto dopo Mal vu, Mal dit o Cap au pi-
23
24
tificato12 o dell’oggetto, allora, non ci sono più verosimilmente che cose, cioè
delle masse che brulicano e si fissano, dei frammenti di materia vaga e indefinita. Si tratta, come scrive Beckett, di “forzare l’invisibilità innata delle cose
esterne fino a che questa invisibilità stessa diviene cosa, non semplice coscienza del limite ma una cosa che si può vedere e far vedere, e farlo, non nella testa (i pittori non hanno testa, leggete dunque il canovaccio al posto, o stomaco, nei luoghi ove io li agghindo), ma sulla tela”13.
Il partito preso de la cosa, in pittura, non è il partito preso delle cose, in poesia14. Il discorso beckettiano non propone in alcun caso un fissare contemplativo sul mondo della natura, come appare nel progetto pongiano: la cosa, qui,
non è il luogo di una possibile armonia tra l’uomo e il mondo, poiché questo
mondo, secondo il dialogo sarcastico tra il tagliatore ed il suo cliente che apre
la testa, vale in ogni modo meno di un pantalone (questa strana storia si ritrova d’altronde in Fin de Partie). La pittura dei fratelli Van Velde, in altre parole,
non sfocia nella creazione di nature morte moderniste o espressioniste. La cosa, in questo contesto, costituisce all’opposto il sintomo essenziale di un universo catastrofico. L’opera di Beckett sembra oggi ancora, così, di grande attualità e di una grande urgenza proprio perché essa ci confronta sempre con
questa presenza esistenziale e non soltanto congiunturale della catastrofe intorno a noi. Nel tempo dello Tsunami e dell’uragano Katrina, è, credo, facile da
comprendere quanto la catastrofe provochi come conseguenza principale la visione di un mondo “cosificato”. Cosa resta, in effetti, dopo di essa, cosa lascia
sul suo passaggio? Non esattamente il nulla, il niente, ma piuttosto uno stato
selvaggio e originale di pura decomposizione, uno stato-limite in cui gli oggetti (ma senza dubbio anche i soggetti) non hanno più nome, in cui essi hanno
l’uno dopo l’altro perso ogni forma e struttura proprie. Questo stato in cui le case o i mobili non sono più riconoscibili, in cui non esistono più che come ammasso di lamiera schiacciata e come pezzi di legno o tavole rotte e confuse, è
quello della cosa divenuta universale, della cosa seminata dappertutto in modo irresistibile. La parola “cosa” non assomiglia, d’altronde in francese, alla parola: “chaos”? La differenza è solo di una lettera. Le Monde et le Pantalon, in
questo senso, è “Il Mondo e la cosa”, o “Il Mondo e qualcosa”, poiché la cosa,
qualunque sia il processo di degradazione che essa subisca, non è mai assolutamente niente (gli abitanti di New Orléans o del Missisipi che ritornano sui
luoghi del disastro lo sanno bene: possono sempre ritrovare, in mezzo alle macerie e agli innumerevoli detriti, qualche piccola traccia di oggetti di proprietà
personale ai quali attribuiscono, costi quel che costi, qualche segno infimo di
vita che sia testimonianza del loro passato interamente distrutto). La cosa,
dunque, afferma sempre un po’ d’esistenza malgrado il potere di ciò che la nega. Essa è ciò che rimane, ciò che resta verso e contro tutto, ciò che sussiste
e sopravvive al di là della distruzione comune. Essa traccia nel cuore dell’annientamento, mai veramente una (poiché non identificabile), ma comunque
unica (nel suo genere). “Io non posso continuare, io continuo.” Cioè continuo
circondato di cose, in mezzo ad esse ed in esse, dopo la catastrofe.
La cosa non è dunque neanche astratta. Essa costituisce al contrario una forma ultima di materia, l’ultima che appartenga esclusivamente all’essere15. Essa
SAGGI
La scrittura beckettiana non è anch’essa marcata dalla tentazione ed il potere incessante dell’immobilità? I personaggi di En attendant Godot e la voce
narrativa di Compagnie non sono, dopo tutto, inchiodati quasi esclusivamente
al non-avvenimento e dunque ad un mondo che si situa al di là di ogni azione9? La statica (ma questa statica è anche estasi) dell’attesa chiama nuovamente allora e senza ambiguità la presenza di uno sguardo uscito dal niente e
che ritorna ad esso, allo spazio della cosa pura e semplice. Lo sguardo, in questo senso, costituisce l’attesa del vedere. Io guardo in attesa di vedere, fisso
le cose nel buio nella speranza che ci sia, malgrado tutto, un visibile davanti
ed intorno a me, cioè qualcosa da vedere.
Tuttavia, questo sguardo non è strettamente di natura estetica, nella misura in cui la legge delle cose impone al contrario l’immagine di un mondo senza forme, o perfino informe. Beckett sarebbe piuttosto, in quest’ottica, un antiBaudelaire, sbarazzato di ogni nostalgia e di ogni sogno di perfezione plastica
nascosta nel passato. La parola “bellezza”, così, non appare nel suo discorso.
La cosa non è né bella né brutta, d’altronde, essa si fa vedere, si afferma e si
constata nell’assoluto. Le Monde et le Pantalon non esprime affatto, lo si sarà
capito, il ragionamento di un esteta, nel senso tradizionale, baudeleriano ma
anche proustiano del termine10.
La cosa, pertanto, non nega il movimento, ma chiede piuttosto un movimento fuori di sé, propriamente estatico. “Questo, al contrario, è interamente rivolto verso l’esterno, verso il tumulto delle cose nella luce, verso il tempo. Perché
non si ha conoscenza del tempo che nelle cose che esso agita, che impedisce
di vedere. È dandosi interamente al di fuori, mostrando il macrocosmo scosso
dal tremore del tempo, che esso si realizza, che realizza l’uomo se si preferisce, in ciò che egli ha di più incrollabile, nella sua certezza che non c’è né presente né riposo11”. Lo sguardo pronuncia in questo senso l’imperativo dell’esteriorità per l’essere nel suo rapporto col mondo visibile. Io guardo, cioè io sono
al di fuori. Lo sguardo mi proietta nell’agitarsi inevitabile delle cose fuori di me.
È per questa ragione precisa che la scrittura beckettiana, e in particolare, certamente, Le Monde et le Pantalon, non è essenzialmente una scrittura dell’interiorità. Proclamando, in effetti, il regno della cosa, essa fa sentire continuamente una voce estirpata da se stessa che esce letteralmente dal proprio buco (è la lezione e il senso di Pas moi [Not I ], in cui la bocca dell’attore emette
le parole verso l’esterno in modo forsennato). Io guardo e parlo, dunque viene
fuori, qualcosa viene fuori, in ogni modo, e si estrae da me, come dei pezzi di
visione e di linguaggio. Nella parola “estratto”, dunque, c’è contemporaneamente la nozione dell’uscita e quella del frammento, del pezzo o della parte separati dal tutto, un doppio significato eminentemente beckettiano.
La pittura, quella dei fratelli Van Velde in particolare, esprime splendidamente anch’essa questa potenza di un’estasi negativa al centro delle cose.
Perché il mondo beckettiano, fondamentalmente, si costruisce a partire da una
posizione di doppia negazione, quella dell’identità propria del soggetto colta
prima di tutto come figura piuttosto che come personaggio, e quella dell’oggetto, cioè essenzialmente della relazione (si sa bene che nel paesaggio lunare
di Godot, non c’è più posto né per l’uno né per l’altra). Al di là del soggetto iden-
25
26
Il suo testo termina con una serie di affermazioni ed interrogazioni laconiche sulla presenza dell’umano nell’arte e nella pittura. Egli precisa bene che
questa parola non appare troppo spesso in primo piano se non in circostanze
estreme, dopo grandi massacri e grandi guerre. L’umano, in altri termini, non
può farsi sentire e non può essere visto che dopo la catastrofe (e non prima,
altrimenti non ci sarebbero senza dubbio mai catastrofi). In ogni modo, un tale
vocabolo è generalmente utilizzato male (o piuttosto mal detto, per riprendere
il linguaggio stesso di Beckett), ed usurpato del suo significato autentico. Il potere della cosa, quindi, rimanda senza equivoci a quello dell’uomo e più ancora, al di là di lui, della comunità (perché è proprio la comunità che è in gioco
prioritariamente nell’umanità possibile dell’arte). Gli avvenimenti recenti legati
all’uragano Katrina nel Sud degli Stati Uniti ci hanno così mostrato quanto l’immagine ripetuta delle cose, delle proprietà, oggetti e beni personali distrutti e
sradicati dalle forze della natura nei media, ha permesso malgrado tutto di riunire una forma (un’illusione?) di comunità nei suoi sforzi per venire in aiuto alle vittime, mentre questa comunità era largamente assente (la comunità come
coscienza dell’altro) nel momento in cui la catastrofe si è prodotta e sicuramente prima di essa.
“Cosa diverrà, in questa fiera, questa pittura solitaria, solitaria della solitudine che si copre la testa, della solitudine che tende le braccia. Questa pittura,
di cui la minima particella contiene più umanità vera di tutte le loro processioni verso una felicità di agnello sacro”17, si domanda ansiosamente Beckett in
conclusione. È l’evolversi stesso dell’essere umano e dell’umanità che è dunque in gioco nell’arte e nella pittura. L’umano la cui origine profonda, la cui prima condizione, necessaria e sufficiente, è sempre l’inumano. Una tale considerazione, per la dimensione che bisogna chiamare etica dell’arte, non è certamente tipica della critica né dell’arte che si sviluppano in Francia nei decenni posteriori alla seconda guerra mondiale. L’arrivo della Pop Art e soprattutto,
dopo di essa, dell’arte concettuale derivata direttamente o indirettamente da
Duchamp chiuderanno al contrario troppo spesso la critica stabilita dello stile
“Art Press”, ma anche il mondo dell’arte contemporanea in un intellettualismo
ermetico e nei suoi dibattiti molto “parigini” staccati spesso da ogni preoccupazione rivolta all’uomo. Il discorso beckettiano rivela qui al contrario, dietro il suo
tono ironico e quasi disinvolto, il bisogno di un’autentica poetica della critica,
attenta all’opera e contemporaneamente allo sguardo che si rivolge ad essa.
La cosa, in questa logica, stabilisce una relazione personale e quasi intima tra
l’amatore e l’artista, al di là di tutti i linguaggi e di tutte le figure retoriche che
pretendono di definire l’arte moderna secondo il modello troppo prevedibile
dell’astrazione e dell’idea. Essa si vuole dunque concreta, perché vicina all’uomo ed al suo desiderio vitale della forma, scappando così alle trappole della
gratuità e della semplice ipotesi mentale.
La critica della critica sottolinea in questo senso la necessità di uno sguardo dell’origine, contemporaneamente solitario e universale. La vera catastrofe,
allora, sarebbe di non potere più vedere, o più precisamente, di non potere più
vedere la cosa. Una tale impossibilità, in effetti, ridurrebbe la scrittura ad una
semplice postura di linguaggio. Le Monde et le Pantalon, in questa prospetti-
SAGGI
si guarda, si vede, e si tocca, secondo Beckett. È per questa ragione che l’arte
che si dice astratta dei fratelli Van Velde (ma ciò concerne senza dubbio l’arte
astratta in generale), esprime in realtà un rapporto diretto col visibile. Lo scrittore rigetta qui categoricamente ogni prospettiva che sottolinei l’intellettualismo di
un tale approccio. Ciò che lo attira, al contrario, in questa pittura, è la preponderanza data alla spontaneità e soprattutto all’istinto, come lo slancio fisico dell’artista davanti alla sua tela. Ci si può domandare allora se questo discorso non si
rivolga anche ai nemici della sua scrittura, a tutti coloro, dunque, che sono tentati di confinarla al dominio della sperimentazione oscura e/o della speculazione
filosofica. (Critiche di cui furono ugualmente oggetto, a loro tempo, altri approcci
dei quali Beckett condivide il senso dell’innovazione e della radicalità formali, da
Mallarmé a Joyce passando per Gertrude Stein.) Beckett ricorda qui, per chiarire il suo proposito, la figura di uno scrittore evocato da Cervantès, e che, alla domanda “cosa dipinge?”, rispondeva: “ciò che uscirà dal mio pennello”.
Una tale celebrazione della spontaneità dell’artista moderno riavvicina inevitabilmente Beckett all’arte bruta, ma anche ad alcuni movimenti d’avanguardia europei nati nell’immediato dopoguerra, in particolare al movimento Cobra,
fondato dal poeta e pittore belga Christian Dotremont nel 1948, che raggruppò
delle personalità artistiche come Jorn, Appel o Alechinsky. Questo movimento,
sorto in gran parte dal Manifesto del surrealismo rivoluzionario del 1947, tentò
in effetti di reiterare la necessità di un’espressione diretta dell’artista nell’ottica
di un primitivismo di essenza poetica, espressione che il surrealismo, secondo
Dotremont, aveva progressivamente abbandonato nel corso della sua storia
tumultuosa. L’arte della cosa pone dunque, in questo senso, la questione dell’essere nell’opera d’arte, del suo sorgere senza concessioni attraverso la forma e la materia, qui ed ora. La cosa esige così per natura il sentimento di un
tempo senza prolungamento né ritardo, quello dell’arte che non è semplicemente pensiero, ma prima di tutto gesto e azione. È proprio ciò che l’apprensione della catastrofe presenta o che in seguito esercita: essa forza l’immediatezza dell’arte, poiché essa offre l’immagine di un mondo portato velocemente
alla distruzione e all’annientamento, un mondo che rischia allora di non lasciare più niente dietro di sé. Qualche cosa deve uscire adesso da me stesso, così, perché è possibile che domani sia già troppo tardi. All’inizio del 1945, evidentemente, la catastrofe si presenta all’uomo nella sua realtà politica e storica mondiale più cruda, e non soltanto sotto la sua dimensione metaforica sorta dalla scrittura e dall’arte.
Il discorso critico beckettiano, in questa prospettiva, afferma un “non pensato” dell’arte ed un potere etico (e non semplicemente estetico) del non-sapere. Perché la cosa è in ogni modo, per natura, ciò che io non posso veramente conoscere né pensare, e soprattutto ciò che non posso nominare con
precisione (altrimenti, logicamente, la cosa sarebbe altra cosa che una cosa).
Essa resiste, dunque, nella sua essenza, ad ogni gergo tecnico (o accademico) e ad ogni linguaggio erudito, cioè al linguaggio abituale della critica d’arte
professionale. La cosa, in questo senso, appartiene all’appassionato (ma questo termine, evidentemente, possiede per Beckett le sue lettere di nobiltà e la
sua ragione d’essere profonda)16.
27
va, ci apre gli occhi indicando che la bocca aperta, la bocca che parla è essa
stessa un occhio contemporaneamente vuoto ed intensamente pieno, che essa gli somiglia in ogni caso come due gocce d’acqua.
IL TENEBROSO FASCINO DEL SUBLIME
NEL SISTEMA KANTIANO
1 L’aggettivo “francese” prende tutto il suo senso, in questo caso specifico, quando
si sa che Le Monde et le Pantalon fu il primo testo che Beckett scrisse direttamente nella lingua di Voltaire.
2 Si potrebbe considerare, così, questo testo come una riflessione sullo scacco inevitabile della critica d’arte, sulla critica d’arte come figura dello scacco del discorso critico, piuttosto che come una riflessione sull’artista moderno e sulla propria confessione
di scacco du e nell’arte.
3 Per una discussione della problematica beckettiana dello sguardo, in particolare
del suo rapporto con la fotografia, vedi il mio saggio Le regard du noir, in “Surmodernités: entre Rêve et Technique”, L’Harmattan, Paris 2003.
4 Questo testo, intitolato Trois dialogues, fu pubblicato nel 1949, in “Transition”, 5.
Fu il risultato, come indica il suo titolo, di conversazioni tra Beckett e Duthuit sulla pittura e la storia dell’arte.
5 Per una discussione approfondita sui rapporti di Beckett col modernismo, vedi in particolare l’opera critica di Pascale Casanova, Beckett l’abstracteur, Le Seuil, Paris 1997.
6 S. BECKETT, Le Monde et le Pantalon, Ed. de Minuit, Paris 1986, p. 16.
7 Ivi, p. 20.
8 Ivi, p. 28.
9 Voglio contraddire qui la prospettiva del filosofo Alain Badiou che, nel suo saggio
Beckett, l’increvable desir (Hachette, Paris 1995), insiste al contraio sulla potenza dell’avvenimento in Beckett, che lega alla questione della felicità in opposizione a quella
del senso. Scrive così: “La risorsa di felicità è molto più grande quando ci si rivolge verso l’avvenimento che quando si cerca invano il senso dell’essere” (p. 39).
10 Penso qui in particolare alla sensibilità baudeleriana così come si esprime negli
Ecrits Esthétiques, Union Générale d’Edition, Paris 1986.
11 S. BECKETT, op. cit., p. 34.
12 Questo spossessamento dell’identità nel cuore della voce stessa, in Beckett, Thomas Tresize lo concepisce secondo la moda de “l’impersonalità”, in riferimento a Blanchot, nella sua opera Into the Breach: Samuel Beckett and the ends of Literature (Princeton University Press, 1990), che costituisce uno studio filosofico rigoroso sulla trilogia Molloy, Malone Meurt, L’Innommable.
13 S. BECKETT, op. cit., p. 39.
14 Vedi al riguardo FRANCIS PONGE, Le parti-pris des Choses, Gallimard, Paris 1942.
15 Voglio così contestare indirettamente la prospettiva di Pascale Casanova che,
nella sua opera Beckett l’abstracteur, insiste al contrario sul predominio dell’astrazione
e del formalismo puro nell’opera dello scrittore, fino ai suoi rapporti con l’arte moderna.
16 Essa appartiene anche al filosofo, sopratutto quando si sforza di studiare i rapporti tra la scrittura e il pensiero. Penso in particolare qui a Derrida, il cui celebre seminario delle Univarsità di Yale, nel 1972, si concentrava sulla problematica della cosa negli
scritti di Plonge, Blanchot e Heidegger.
17 S. BECKETT, op. cit., p. 44.
Sono pochi i concetti che in filosofia registrano, all’interno del pensiero di un
grande autore, un peso così rilevante com’è quello riportato dal concetto di sublime nella riflessione sistematica e complessiva di Kant. Se è vero che può
essere riscontrato un movimento che va da una fase scientifico-naturalistica
–più attenta a problemi matematici e di fisica–, e poi precritica –in cui si susseguono osservazioni deboli e semplici pruriti intellettuali–, fino ad una speculativa in senso stretto –che non lascia sfuggire nulla alla presa del pensiero–,
quasi a simboleggiare un mutamento che va dal particolare all’universale e che
sembra superare abbastanza agevolmente le fratture e gli ostacoli di tale tragitto; è pur vero che alcuni nodi sono presenti e chiedono di essere sciolti: il
sublime rappresenta uno di quei grovigli che il pettine di Königsberg sbroglia e
rende districati ed appianati. Il “sistema” kantiano –la cui evoluzione è databile tra gli anni ’70 e ’90 del Settecento– si mostra nella sua forma più compatta
se si analizza il posto ed il valore assegnato, nella Critica del Giudizio, al concetto di sublime. Se è vero che la Terza critica fa come da termine medio (Mittelglied)1 tra le prime due e quindi da “cerniera” del sistema; se è vero anche
che il suo principio a priori è il «principio della finalità formale della natura»2 in
cui, per il tramite della finalità (quella propria della Ragion pratica), si guarda in
maniera più efficace il mondo (di competenza della Ragione pura) permettendo così il passaggio3 tra le due critiche –ovvero tra i due mondi–; tutto questo
sembra comunque rimanere un procedimento fittizio, serrato nei soli margini e
confini della formalità procedurale. In realtà, il concetto di sublime contribuisce
alla formazione di quel ponte di collegamento facendolo altresì apparire come
dato dal pensiero in modo reale e sostanziale.
I vent’anni che vedono la pubblicazione della dissertazione De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770), della Critica della ragione
pura (1781), della Critica della ragion pratica (1788) e della Critica del Giudizio
(1790), rendono evidente la convinzione kantiana di una spaccatura tra il mondo noumenico e quello fenomenico; questa frattura aperta con la Dissertatio
non può essere ricomposta con i soli strumenti delle prime due Critiche che rimangono appropriati ognuno per ciò che concerne il proprio oggetto d’indagine: la soluzione è portata in seno dalla Critica del Giudizio che all’oggetto dello studio della Prima critica applica il metodo di conoscenza dell’Altra.
Il “sublime” in Kant ha radici certamente più antiche del “classico” ed abusato riferimento al 1790. Tali ceppi non partono precipuamente dalle Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime (1764), in cui appronta comunque
una prima e superficiale analisi dei due concetti4, ma risalgono alle influenze di
28
di Germano De Marzo
SAGGI
(traduzione dal francese di Paola Invitto)
29
1. Più di un concetto
30
Il termine sublime trae dal latino diverse possibili e contrapposte etimologie:
il prefisso sub (sotto, entro o anche dal basso in alto) rimane invariato; il radicale invece può avere distinte interpretazioni: limen (soglia –ma anche architrave–, dimora, frontiera); limes (via traversa, linea di confine); limus (limo; fango). Sublime è ciò che è sotto l’architrave, sospeso e quindi elevato: che sta in
alto; ma sublime è anche ciò che sale obliquamente, per via traversa e non lineare; sublime è, infine ed al contrario, ciò che sta sotto il fango, che è nascosto e, al limite, anche brutto.
Il Settecento, sull’onda della sua tendenza a scavare fino al centro magmatico per riportare alla luce ciò che è nascosto, sarà il secolo in cui maggiormente l’estetica (quella che insieme all’economica, per Croce, rappresentava un
scienza moderna e mondana) si occuperà del bello e del sublime. A quest’ultimo, e specialmente in questo periodo, non è comunque ascrivibile un’unica interpretazione.
Due sembrano particolarmente significative in relazione all’argomento qui
trattato: quella di Edmund Burke e quella di Johann Christoph Friedrich Schiller. Esse infatti è come se cingessero e poi premessero da due lati le riflessioni di Kant, tanto da permetterci di cogliere meglio l’ampiezza del suo respiro.
Al Burke il sublime non appare solo come la proiezione più alta del movimento compiuto del bello6; ma ad esso va opponendosi per via della sua resistenza all’idea di armonia e regolarità; per la sua vicinanza al terribile e contemporanea separazione da ciò che è amabile; e, infine, per la sua affinità al
brutto, vero e forse unico antagonista del bello7. Lo Schiller, invece, non si oppone tanto alla distinzione tra bello e sublime, quanto alla separazione dei due,
sostenendo la necessità di una loro fusione, riprendendo così e trasformando
un tema evidentemente kantiano. Sanare, infatti, il conflitto tra sublime e bello
permette, in Schiller, la conciliazione della contesa tra razionalità e sensibilità8.
Per Burke, il sublime è inteso come un piacere misto a terrore; esso non nasce solo da fenomeni naturali, ma anche da prodotti umani; ed all’interno delle arti, non è solo la pittura o l’architettura, ma anche, o forse soprattutto, la forza della poesia, dell’eloquenza intima delle parole a suscitare il sublime9. Di
tutt’altra idea è Mendelssohn che recensì la Ricerca sull’origine delle idee del
sublime e del bello di Burke10. Nel suo denso lavoro, Mendelssohn incalza il
Burke proprio per ciò che riguarda il bello e il sublime derivanti dalla Parola. In
tal senso si legge: «dobbiamo confessare che noi, dalla comprensione e dal
gusto fine del sig. autore, ci saremmo aspettati un’esecuzione più completa di
questo oggetto»11.
Se in Burke il sublime non educa, stricto sensu, è vero anche che l’impressione che suscita nell’animo non si può considerare come fosse asettica, come se non producesse alcun cambiamento. Così sarà per Kant, qualche anno
dopo, quando affermerà che la visione del sublime non farà altro che renderci
consapevoli del sublime che è in noi, che è una sublimità eminentemente pratica. È la moralità, il soprasensibile, che si manifesta in un oggetto sensibile12.
È proprio su questa scia che si pone il lavoro di Schiller.
In relazione alle già citate Lettere sull’educazione estetica dell’uomo vanno
ricordati almeno altri tre brevi saggi: quello intitolato Del sublime13, un altro Sul
patetico14, e, infine, uno Sul sublime15.
Questi lavori, con una lieve eccezione per quello Sul patetico, ripropongono,
intrecciandole a distanza di anni, una serie di considerazioni che non nascondono un evidente debito intellettuale nei confronti di Kant. Sono infatti ripresi, talvolta con la stessa terminologia, i passi che, nella Critica del Giudizio, scandivano
il tempo alla distinzione tra la natura sensibile e quella intelligibile nell’uomo, con
il riconoscimento dei limiti della prima e la netta superiorità dell’altra16; ed ancora, la distinzione tra sublime dinamico e matematico17; la possibilità data all’uomo, stando al riparo dalla terribile potenza devastatrice della natura, di cogliere
il sublime che è in lui18; infine, i classici riferimenti utilizzati da Kant per rendere
al lettore l’idea di come si manifestino gli oggetti sublimi e terribili19.
In realtà, Schiller, che pure troppo spesso sembra indugiare sulle tematiche
kantiane, offre una personale impostazione di pensiero quando cerca di ricompattare la frantumazione tra bello e sublime. È una linea che discende dalle
Lettere sull’educazione estetica e, nel mentre evidenzia i compiti della “cultura” per raggiungere un’educazione morale, mostra un eguale interesse, ed una
viva attesa, verso una considerazione matura della bellezza20. Per Schiller:
il tratto distintivo dell’umanità è la volontà, e la ragione stessa non è altro
che la sua eterna regola. L’intera natura agisce in modo razionale; la prerogativa dell’uomo risiede unicamente nell’agire razionalmente con consapevolezza e volontà. Tutte le altre cose devono; l’uomo è l’essere che
vuole21.
A chi spetta il compito di rendere l’uomo capace di essere ciò che vuole? È
la cultura che interviene sdoppiando il suo intervento. Da un lato la cultura materiale che permette all’uomo di affermare la sua volontà in modo realistico:
«quando l’uomo oppone violenza a violenza, e dunque domina la natura in
quanto parte della natura»22; dall’altro la cultura morale che, idealisticamente,
consente all’uomo di separarsi «dalla natura e in tal modo vanifica[re] rispetto
a se stesso l’idea di violenza»23. Nel primo caso,
l’uomo educa il suo intelletto e le facoltà dei suoi sensi o per rendere le
forze della natura, mediante le loro leggi, uno strumento della sua volontà, oppure per proteggersi dai loro effetti, che egli non è in grado di con-
SAGGI
quegli autori che prima di lui già si erano posti il problema di pensare oltre che
al bello, anche al sublime. Da Platone allo Pseudo-Longino al Burke passando per una serie di interpreti e commentatori, il sublime aveva già ottenuto un
posto rilevante nelle considerazioni sull’estetica come sull’antropologia umana.
Rotto il sigillo kantiano si apriranno definitivamente le porte a quell’attenzione per il sublime (cioè per il non più catalogabile, indicizzabile o controllabile
dell’esperienza umana) che ne farà l’indiscusso protagonista sulla scena della
modernità ed oltre5.
31
Ed è per questo che l’uomo necessita di un’altra cultura: l’uomo, infatti, non
può che essere se stesso in ogni circostanza, e quindi in nessun caso può tollerare qualcosa contro la sua volontà. Se non è più in grado di opporre alle forze fisiche un’adeguata forza fisica, non gli rimane dunque altro, per non subire violenza, che eliminare del tutto un rapporto che gli è così sfavorevole, annullando concettualmente una violenza che dovrebbe praticamente subire. Annullare concettualmente una violenza, tuttavia, non significa che sottoporsi volontariamente alla stessa. La cultura che rende l’uomo capace di questo compito si definisce morale25.
Se, quindi, il sublime contribuisce a mostrare una destinazione soprasensibile dell’uomo, è vero anche che necessita di altro: è alla cultura che «spetta il
compito di render libero l’uomo e di aiutarlo a dispiegare interamente la sua essenza. Essa dunque deve porlo in grado di affermare la sua volontà, giacché
l’uomo è l’essere che vuole»26.
Il tema della cultura e dell’educazione connette strettamente il bello al sublime:
32
il bello è già una manifestazione della libertà; ma non di quella che ci libera da ogni influenza della materia e ci eleva sopra la potenza della natura, bensì di quella che noi godiamo come uomini all’interno della natura. Nella bellezza ci sentiamo liberi, giacché gli istinti sensibili si armonizzano con la legge della ragione; nel sublime ci sentiamo liberi, giacché gli
istinti sensibili non hanno alcun effetto sulla legislazione della ragione:
qui infatti lo spirito agisce come se non fosse sottoposto ad altra legge
che la propria27.
In altre occasioni, Schiller terrà a ribadire la convinzione della necessità di
armonizzare, o meglio, di prendere atto della reale armonia che lega assieme
il bello e il sublime; si legge, infatti, che
l’ideale supremo a cui tendiamo è di rimanere in armonia con il mondo
sensibile, quale garante della nostra felicità, senza per questo esser costretti ad entrare in contrasto con il mondo morale, che determina la nostra dignità28.
Se l’educazione e la cultura morale rendono l’uomo ciò che vuole essere, e
la nostra destinazione consiste nel seguire il codice degli spiriti puri al di là di
ogni barriera sensibile, così da perfezionare l’educazione estetica e ampliare
la capacità di sentire del cuore umano anche oltre il mondo sensibile, in coerenza con la dimensione complessiva della nostra destinazione, è necessario
che il sublime si accompagni al bello29.
Ci sono altri passi (che qui bisognerà sacrificare per evitare una lunga ed
impegnativa deviazione) di importanza rilevante per cogliere nella pienezza del
suo movimento il passaggio Burke-Kant-Schiller. È però il caso di concludere
per sottolineare che se è vero che per alcuni il sublime è l’artificio stilistico della retorica o della poesia –come per altri è l’eccezionale forza naturale–, talvolta lo vediamo combattere tenacemente contro il bello per poi superarlo definitivamente; altre volte sembra andare incontro ad esso in una fertile unione. Va
registrato che l’interpretazione del sublime come vero e proprio argomentocerniera tra estetica ed etica si deve indubbiamente a Kant: da qui deriva la
centralità della questione del sublime nell’autore di Königsberg.
2. Il bello si comunica; il sublime ci comunica
Al di là delle frastagliate percezioni su bello e sublime e delle divergenze,
come anche delle somiglianze tra i due concetti, sembra che questi abbiano in
comune dell’altro: essi appaiono come gli estremi di un elastico che nel suo
punto mediano è fissato ad un concetto-cardine: la comunicazione. E questo,
ad onor del vero, sembra un tema molto più apropriato al nostro tempo di
quanto non fosse calzante al Settecento kantiano, col che si mostra anche tutta la capacità predittiva e l’attualità di un classico come Kant.
Nelle due forme dell’eloquenza interiore che modifica il singolo rispetto al
mondo, e del silenzio esteriore che modifica i singoli nel loro contatto reciproco, vengono a sciogliersi rispettivamente il sublime ed il bello.
Il primo muove la sensazione nell’interno dell’animo e del pensiero producendo un cambiamento che, pur rimanendo confinato nella sfera individuale,
con la presa d’atto del senso ultimo della vita dell’uomo, è tendenzialmente
orientato a superare quei confini; il secondo è come se venisse mosso dall’intuizione (kantianamente intesa) che pervade con la sua tensione verso l’esterno tutti gli spazi del mondo, e che si manifesta nella propensione a incontrare
gli altri singoli in una pluralità condivisa. Così, quel primo cambiamento interno ci impone di passare dalla massima individuale alla legge universale; il secondo ci impone di passare dall’intuizione personale alla sua condivisione;
l’uno e l’altro, insieme, fondano la necessità del confronto con gli altri.
Per ciò che concerne il bello, corre l’obbligo di sottolineare altri due aspetti
fondamentali che entrano in gioco: l’universalità del giudizio e la comunicabilità del sentimento. Nella Critica del Giudizio «il tema del giudizio estetico è, anzitutto, il tema dell’universalità di siffatto giudizio, quella stessa che può essere messa in crisi dal caleidoscopico diffrangersi del sentimento del bello preso
in esame nelle Osservazioni»30.
Il carattere è dunque l’universalità, che è propriamente l’opposto dell’individualità intesa come egoismo: «egoista estetico è colui che si accontenta del
proprio gusto: gli altri trovino pure cattivi i suoi versi, i suoi dipinti, la sua musica ecc., e degni di critica e di riso. Egli si priva del progresso verso il meglio,
isolandosi col proprio giudizio, applaudendosi da sé e ricercando in sé solo la
pietra di paragone del bello artistico»31. Bisogna superare l’isolamento e tendere all’universalità: «l’universalità del giudizio estetico si cerca di dedurla in
contrasto con il principio secondo il quale de gustibus non est disputandum»32.
Kant, infatti, scrive: «Il primo luogo comune del gusto sta in questa proposizio-
SAGGI
trollare. Tuttavia le forze della natura si lasciano dominare o respingere
solo fino a un certo punto, al di là del quale si sottraggono alla potenza
dell’uomo e lo sottopongono alla propria24.
33
34
le rocce che sporgono audaci in alto e quasi minacciose, le nuvole di
temporale che si ammassano in cielo tra lampi e tuoni, i vulcani che scatenano tutta la loro potenza distruttrice, e gli uragani che si lascian dietro
la devastazione, l’immenso oceano sconvolto dalla tempesta […] riducono ad una piccolezza insignificante il nostro potere di resistenza, paragonato con la loro potenza. […] Queste cose le chiamiamo volentieri sublimi, perché esse elevano le forze dell’anima al disopra della mediocrità ordinaria, e ci fanno scoprire in noi stessi una facoltà di resistere interamente diversa, la quale ci dà il coraggio di misurarci con l’apparente onnipotenza della natura40.
Così, quasi a richiamare dialetticamente la facoltà del piacere, «il sentimento del sublime è dunque un sentimento di dispiacere, che nasce dall’insufficienza dell’immaginazione […] rispetto alla valutazione della ragione»41; ma «è una
legge (della ragione), ed appartiene alla nostra destinazione, valutare piccolo,
in confronto con le idee della ragione, tutto ciò che la natura, come oggetto dei
sensi, contiene di grande per noi»42. La sproporzione che si viene a creare tra
la grandezza eccezionale di un fenomeno della natura e la possibilità della nostra ragione a possedere l’idea della totalità (abbracciando, cioè, un tutto che
non può essere abbracciato), «desta in noi il sentimento di una facoltà soprasensibile»43.
Nasce così «il sentimento della inadeguatezza della […] immaginazione a
formare una esibizione delle idee di un tutto; l’immaginazione raggiunge il suo
massimo, e, per la spinta ad estendersi ancora, ricade su se stessa, e in tal
modo si produce una piacevole emozione»44. Così il sentimento si riavvolge e
trapassa nuovamente dal dispiacere al piacere; e dal piacere alla stima: «sicché il sentimento del sublime della natura è un sentimento di stima per la nostra propria destinazione, che, con una specie di sostituzione […], attribuiamo
ad un oggetto della natura, il quale ci rende quasi intuibile la superiorità della
destinazione razionale delle nostre facoltà conoscitive, anche sul massimo potere della sensibilità»45.
Ne deriva non solo che il sublime non si trova in nessuna cosa della natura, ma anche che non è sublime in quanto alla capacità di provocare paura, ma
poiché svelatore di una ricchezza sorprendente che è infusa nell’uomo. Infatti,
«in tal modo la natura […] non è giudicata sublime in quanto è spaventevole,
ma perché essa incita quella forza che è in noi»46.
Il sublime “ci” comunica vuole dunque significare: per il tramite del sublime
troviamo la nostra “superiore” collocazione; veniamo a conoscenza, cioè prendiamo coscienza, delle nostre qualità morali; del nostro essere programmati alla socialità.
L’affermazione: «la comunicazione fonda la società»47, e cioè sia il luogo
privilegiato per il costituirsi della coesione sociale, è facilmente condivisibile,
ma difficilmente verificabile; solo per accennare brevemente a questa sostanziale impossibilità, si vuole citare, provocatoriamente, un brano di grande spessore e lungimiranza. La citazione –dal titolo Isolamento per comunicazione,
evidentemente pungente–, è contraria ad ogni visione disincantata sulle possibilità della comunicazione. Vale la pena riportarne un breve passo:
l’affermazione che il mezzo di comunicazione isola non vale solo nel
campo spirituale. Non solo il linguaggio bugiardo dell’annunciatore della
radio si fissa nel cervello […] e impedisce agli uomini di parlare fra loro
[…]. Il progresso separa letteralmente gli uomini. Lo sportello alla stazione o nella banca permetteva all’impiegato di chiacchierare col collega e
di partecipargli un modesto segreto; le vetrate dei moderni uffici, le sale
enormi in cui innumerevoli impiegati trovano posto insieme e sono facilmente sorvegliati dal pubblico e dai dirigenti, non consentono più colloqui
o idilli privati. […] Ma il mezzo di comunicazione separa gli uomini anche
fisicamente. […] Gli uomini viaggiano rigidamente isolati l’uno dall’altro
SAGGI
ne, colla quale ognuno che sia privo di gusto crede di difendersi da ogni biasimo: ognuno ha il proprio gusto. Il che non significa altro se non che il fondamento determinante di questo giudizio è puramente soggettivo […]; e che il
giudizio non ha alcun diritto all’approvazione necessaria degli altri. Il secondo
luogo comune del gusto […] è: del gusto non si può disputare»33. Ma è proprio
questa posizione ad essere attaccata, infatti, «sul gusto si può contendere […].
Perché dove è lecito contendere, vi può essere la speranza dell’accordo»34.
È dunque questo che va ricercato; ed il modo è lo stesso Autore ad offrirlo:
«all’egoismo si può opporre soltanto il pluralismo, cioè quel modo di pensare,
per cui non si abbraccia nel proprio io tutto il mondo, ma ci si considera e comporta soltanto come cittadini del mondo»35.
Per Kant nell’«individualità non c’è istinto selvaggio, la tendenza all’egoismo dell’uomo di natura di Hobbes. C’è, piuttosto, il sentimento della bellezza
e della dignità della natura umana […] la quale natura, avverte anche Kant,
“sempre crea l’uomo per la vita civile”»36.
È dunque una tendenza propria dell’uomo quella per cui si deve cercare
l’accordo con gli altri e fondare la società; infatti, «per se stesso un uomo relegato in un’isola deserta non ornerebbe né la sua capanna, né la sua persona,
non cercherebbe dei fiori e tanto meno ne coltiverebbe per adornarsene; soltanto nella società egli comincerà a pensare di non essere semplicemente un
uomo, ma un uomo [civile]: perché così è giudicato colui che è disposto e capace di comunicare agli altri il proprio piacere, e che non è soddisfatto da un
oggetto, se non ne può condividere con gli altri il piacere»37.
Per quello che riguarda il sublime, conviene stabilire, intrecciandole, almeno tre questioni iniziali: dove si trova, come si caratterizza ed in quale senso
“ci” comunica.
Per Kant «il vero sublime non può essere contenuto in alcuna forma sensibile, ma riguarda solo le idee della ragione, le quali, sebbene nessuna esibizione possa esser loro adeguata, anzi appunto per tale sproporzione che si
può esibire sensibilmente, sono svegliate ed evocate nell’animo nostro»38.
Sebbene, dunque, il sublime è da ricercarsi nell’uomo, è vero anche che perché sia visibile esso necessita di una forma sensibile. Da qui il carattere ambiguo di essere una forma informe: quando dichiariamo qualcosa «sublime, si
vede subito che non intendiamo di cercare una misura adeguata fuori di essa,
ma soltanto in essa medesima [poiché essa è grande in senso assoluto e non
relativo]. È una grandezza, che è eguale solo a se stessa»39. Per cui,
35
Bisogna certo registrare, nell’insieme delle posizioni, che quest’ultima citazione è vittima di un retroterra sociale che spingeva verso la disillusione, che
non lasciava molto spazio ad una visione armonica e ottimista della vita. Adorno ed Horkheimer, avendo vissuto sulla loro pelle gli eccessi della comunicazione dittatoriale, dell’estetica del fascismo e del nazismo, non potevano lasciare fuori dalla giurisdizione della critica uno tra gli aspetti più significativi e
fondanti dell’esperienza umana e cioè la comunicazione.
3. Il primo “sublime” in Kant
36
Le considerazioni presenti nelle Osservazioni del 1764 sono di duplice natura: da un lato, ci troviamo dinanzi un Kant molto lontano dalla sua riconosciuta attitudine al rigore sistematico e metodologico nell’analisi; dall’altro, rintracciamo più volte temi e questioni che saranno ripresi puntualmente nell’ultima
Critica, ed in questo si ha conferma dell’idea che alcune nozioni poste nella
Critica del Giudizio abbiano una collocazione storiografica anteriore (tuttavia,
anche se precedenti all’artificioso edificio della Terza critica, esse non splendono propriamente per originalità e purezza)49. Nonostante ci si trovi «di fronte a
un Kant minore; lo scritto sollecita però un notevole interesse […]. È uno scritto molto datato, ma proprio perciò ci informa in maniera insostituibile su un momento della preparazione e della evoluzione culturale di Kant. Ne illustra inoltre taluni aspetti della personalità e del costume»50.
Ma veniamo al testo. Alla prima occasione l’autore dichiara che
il sentimento raffinato che ora vogliamo analizzare si distingue anzitutto
in due specie: il sentimento del sublime e il sentimento del bello. Ambedue provocano nell’animo una deliziosa commozione, ma in modo completamente diverso. La visione di un monte le cui cime innevate si levano sopra le nubi, la descrizione dell’infuriare di una tempesta […] suscitano piacere misto a terrore; invece, l’occhio che spazia su prati in fiore,
valli percorse da rivi serpeggianti, […] procurano anch’esse sensazioni
deliziose, però liete e aperte al sorriso51.
È la prima volta in cui introduce un’iniziale distinzione tra i due concetti; il
testo prosegue poi con una serie di brevi riflessioni, talvolta vere e proprie
sentenze d’autorità, altre volte norme, o massime, che si caratterizzano per la
sicurezza di un’espressione che non contempla mezzi termini. Si legge, infatti, che «sublime è la notte, bello il giorno»52; «il sublime commuove, il bello attrae»53; «il sublime deve sempre essere grande, il bello può essere anche piccolo. Il sublime deve essere semplice, il bello può essere adornato e abbellito»54; «la vista di una piramide egiziana commuove […]. La Basilica di San
Pietro a Roma è fastosa, […] grande e semplice […] da destare una grandio-
sa sensazione del sublime»55; «una durata interminata è sublime»56. Ed ancora: «l’intelligenza è sublime, lo spirito arguto è bello» 57.; «qualità sublimi ispirano rispetto, le belle invece amore»58. Si intrecciano considerazioni antropologiche al gusto personale, sempre all’insegna del dogma: «la tragedia si distingue a mio avviso dalla commedia proprio per questo: che nella prima il
sentimento vien mosso al sublime, nella seconda al bello»59; oppure «capelli
scuri e occhi neri sono più affini al sublime, capelli biondi e occhi azzurri al
bello. All’età avanzata si addicono le qualità del sublime, alla giovinezza invece quelle del bello»60. Il testo è intessuto in tutte le sue parti da stime di questa caratura: «la qualità del sublime terribile, quando si fa del tutto innaturale,
diventa stravaganza. […] Affrontare arditamente i pericoli, in difesa dei nostri
diritti, di quelli della patria o degli amici è sublime, ma erano stravaganti avventure le crociate e le imprese della cavalleria antica» 61; «il dominio delle
proprie passioni secondo principî è sublime, ma la mortificazione della carne,
i voti e le altre virtù monastiche son fanfaluche»62; «fra le qualità morali, solo
la vera virtù è sublime»63.
Questa serie quasi interminabile di opinioni non toglie nulla ad un testo che
ha ben poco del carattere delle ultime opere più impegnate teoreticamente;
certo è che l’austerità con cui siamo stati abituati a considerare l’Autore sembra stemperarsi dinanzi ad espressioni così deboli, e si fa largo l’immagine di
un Kant molto più effimera, talvolta allegra, comunque leggera.
Se le Osservazioni non brillano per profondità, così i pensieri appuntati sulla sua copia personale del testo, le famose Bemerkungen (Annotazioni) non
riescono a solleticare l’attenzione oltre un lieve accenno di sorriso, nonostante siano state considerate, da grandi interpreti del pensiero kantiano, come un
lascito fondamentale nella comprensione delle sue riflessioni64.
Le considerazioni tra il serio e il faceto che innervavano il testo delle Osservazioni, sembrano intessere anche gli interfogli annotati a mano dall’Autore. Continua infatti la galleria delle definizioni, asserzioni e verità –tra cui si riportano solo quelle immediatamente attinenti l’argomento trattato– sempre
con lo stesso tono enfatico: «un essere umano può suscitare in un altro due
tipi di emozione positiva: il rispetto e l’amore, il primo attraverso il sublime, il
secondo, attraverso il bello»65; «il sole che sorge è splendido quanto il sole
che tramonta, ma la visione del primo volge verso il bello, la visione del secondo verso il tragico e il sublime»66; «il bello e il sublime non sono la stessa
cosa. Il primo riempie il cuore, rende rigida e tesa l’attenzione, per cui stanca.
Il secondo invece scioglie l’anima in un sentimento molle e, rilassando i nervi, induce il sentimento in uno stato di commozione più delicato, che però, se
è eccessivo, si trasforma in languore, noia e disgusto»67; «il bello risplende
quando c’è operosità, allegria e vivacità, mentre quando queste vengono a
cessare e traspare una tranquilla soddisfazione, allora emerge il sublime. La
mattina presto il bello, la sera il sublime»68; «sembra quasi che nel sentimento del sublime le forze dell’uomo si dilatino, mentre si riducono nel sentimento del bello»69.
SAGGI
su cerchi di gomma. In compenso, in ogni automobile di famiglia si parla
solo di ciò di cui si discute nell’altra […]. La comunicazione provvede ad
uguagliare gli uomini isolandoli48.
37
Il titolo della dissertazione del 1770, De mundi sensibilis atque intelligibilis
forma et principiis70, pone un accento particolare sulla “congiunzione” e “coniugazione” dei due mondi: l’utilizzo dell’atque, al posto del semplice et, parla
chiaro. La congiunzione latina atque significa certamente “e”, ma non solo: giustappone una frizione, tra termini, dalla natura insolita; essa, infatti, non tende
solo ad escludere ma anche a specificare il senso di una sostanziale distinzione all’interno della convergenza; è un “questo e quello” in cui si vuole dire che
i due vanno di pari passo ma rimangono separati. È, infine, anche un “e per
giunta” che tende ed esaltare (come accadrà per il primato della Ragion pratica rispetto alla Pura) ciò che segue.
Tutto ciò è rivelatore di un’idea –una convinzione o un chiodo fisso– che accompagnerà e segnerà l’ultimo periodo della produzione kantiana.
Sulla forma e i princìpi del mondo sensibile e di quello intelligibile, si può dire poco altro: Kant pone tra queste righe i semi del suo pensiero maturo:
38
nella Dissertazione troviamo già presenti […] alcune parti fondamentali della filosofia critica e in particolare le seguenti idee, presenti anche
nella [Ragion Pura]: la separazione tra “mondo sensibile” e “mondo intelligibile”, tra fenomeno e noumeno; la dottrina delle forme pure dell’intuizione, spazio e tempo; la confutazione della metafisica razionalistica71.
Qui nascono i primi germogli sulle forme a priori dell’intuizione:
ora dimostrerò che questi principi formali del mondo fenomenico (universi phaenomeni), assolutamente primi e universali, che sono inoltre schemi (schemata) e condizioni di ogni cosa sensitiva conosciuta dall’uomo,
sono due: il tempo e lo spazio72.
Kant esprime in queste pagine l’idea che ci sia concesso di percepire le cose non come sono in sé, ma come vengono modificate durante la percezione
di esse, nell’adattamento alle forme (dello spazio e del tempo) della nostra intuizione. La questione verrà ripresa con gli stessi termini nell’Estetica trascendentale della Critica della ragione pura.
In questo testo troviamo, inoltre, la famosa distinzione tra fenomeni e noumeni:
la sensibilità (sensualitas) è la ricettività del soggetto, per mezzo della quale è possibile che le condizioni rappresentative di esso siano modificate in
un determinato modo dalla presenza di un oggetto. L’intelligenza (rationalitas) è la facoltà del soggetto, per mezzo della quale esso può rappresentarsi quelle cose che per la loro qualità non possono colpire i sensi. L’oggetto della sensibilità è il sensibile; mentre quello che non contiene null’altro se non ciò che è conoscibile solo per mezzo dell’intelligenza è l’intelligibile: il primo è quello che anticamente nelle scuole era chiamato fenomeno (phaenomenon), il secondo noumeno (noumenon). La conoscenza, in
quanto è soggetta alle leggi della sensibilità, è sensitiva, in quanto è soggetta alle leggi dell’intelligenza, è intellettiva, o razionale73.
Infine, l’istituzione del tribunale della ragione trova qui la sua legittimazione:
con ogni cura è da guardarsi che i principi propri della conoscenza sensibile non varchino i loro limiti e invadano il campo delle cose intellettive74.
Che la Dissertazione segnasse uno spartiacque tra le opere kantiane è lo
stesso autore ad affermarlo in una lettera scritta a Johann Heinrich Tieftrunk e
datata 13 ottobre 1797 in cui «Kant consigliava di cominciare la collezione delle sue opere con la Dissertazione del ’70, tralasciando gli scritti precedenti»75.
Abbiamo visto l’importanza di un libricino che condensava in sé molte questioni dal peso considerevole sia all’interno della speculazione kantiana che,
più in generale, della teoria della conoscenza. Come si apra la frattura tra i due
mondi è stato detto; rimane da vedere come si possa chiudere all’insegna dell’arco segnato dalle Critiche che è, o che si ripropone di essere, lineare, progressivo e talvolta forzatamente perfetto76.
SAGGI
4. La Dissertatio e le Critiche
5. L’ultimo “sublime”
Il concetto di sublime è e rimane nell’animo dell’osservatore, e non nelle
“cose”, ma subisce una progressiva torsione epistemologica: si parte dall’assunto empirico per arrivare a quello critico-analitico. Fino ad assumere le sembianze di un ponte mobile tra la terraferma del pensiero e l’isola del sentimento battuta dai venti e dalle mareggiate.
Ciò che mancava alle precedenti considerazioni kantiane sul sublime –in
cui il taglio antropologico faceva arenare il giudizio nelle secche delle opinioni
sul carattere dell’uomo, la nazionalità o le distinzioni tra sessi– era l’impegno a
dare valore epistemologico a tale concetto: il 1790 segna il momento in cui il
sublime diviene la cifra interpretativa di un uomo non più divisibile. L’uomo della facoltà di conoscere non è più contrapposto a quello della facoltà di desiderare, e non in virtù di una tregua –quella che emerge dalla terza antinomia cosmologica 77– ma in forza di una angolatura prospettica che predilige alla disimpegnata osservazione di un singolo aspetto, la più sofferta comprensione della drammatica compresenza78 delle due forme.
In breve, l’uomo si presentava, nel pensiero kantiano, come oggetto proprio
della Ragion Pura –e cioè come essere biologico, soggetto alle forze naturale
ed agli istinti animali–, da un lato; ma anche come questione specifica della
Ragion Pratica –e cioè come essere capace di porre degli scopi, capace di elevare la sua massima individuale a legge morale ed universale–, dall’altro. Queste due forme peculiari dell’esistenza umana –così lontane l’una dall’altra eppure, al tempo stesso, fuse inscindibilmente nell’uomo–, riescono a trovare un
adeguamento nella Critica del Giudizio?
Kant rileva che il sublime deve essere distinto in due forme: quella del sublime matematico e quella del sublime dinamico.
39
40
in quanto la persona agente è considerata al tempo stesso come noumeno
[…], è esso stesso libero da ogni legge naturale»83.
In virtù di questa doppia espressione «si può pensare almeno come possibile un legame naturale e necessario tra la coscienza della moralità e l’aspettazione di una felicità ad essa proporzionata, come sua conseguenza»84.
Poiché «la perfetta adeguatezza della volontà alla legge morale è la santità:
una perfezione di cui nessun essere razionale del mondo sensibile è capace, in
nessun momento della sua esistenza […], essa potrà trovarsi solo in un processo all’infinito»85. Ed è nella propensione all’infinito che è pensato l’uomo: «tale
progresso infinito è possibile solo presupponendo un’esistenza, e una personalità dell’essere razionale stesso, perduranti all’infinito: e ciò prende il nome di immortalità dell’anima. Dunque, il sommo bene è possibile, in senso pratico, solo
presupponendo l’immortalità dell’anima»86. Infine, per la possibilità di una felicità commisurata alla moralità, e cioè per una corresponsione del premio al merito, si deve giungere «al presupposto dell’esistenza di una causa adeguata a
tale effetto; cioè, a postulare l’esistenza di Dio, come necessaria alla possibilità
del sommo bene»87. Per Kant, infatti, «la morale non è, propriamente, la dottrina del modo in cui noi possiamo renderci felici, bensì del modo in cui dobbiamo
renderci degni della felicità»88. Libertà dell’agire, immortalità dell’anima ed esistenza di Dio costituiscono i tre gradi con i quali si passa dal sensibile all’oltresensibile; sono i tre passaggi dell’adeguamento dei due mondi.
Si diceva, un iniziale collegamento era stato formulato nella Prima critica;
abbiamo appena visto un successivo collegamento nella Seconda; si tratta ora
di tornare alla Terza critica per cogliere un ultimo elemento mediano tra uomo
fenomenico e noumenico.
Nel sublime, l’esser degni di felicità è strettamente connesso con l’essere
umiliati; più precisamente è un lato della nostra umanità ad essere schiacciato dall’altro. Dinanzi al sublime, la nostra immaginazione è sconfitta, ma vittoriosa è la nostra ragione in quanto capace di sfuggire alla morsa stringente della sensibilità89.
È propriamente l’umiliazione a divenire il mezzo per raggiungere o avere
consapevolezza di essere destinati ad uno stadio superiore dell’esistenza:
«mentre il sublime matematico consiste nell’umiliazione dell’immaginazione
sensibile, che evoca la rappresentazione della ragione come facoltà della totalità, e quindi rimane nell’ambito delle nostre facoltà intese come facoltà conoscitive […]; il sublime dinamico consiste invece nell’umiliazione della nostra intera
sensibilità, che evoca la rappresentazione della nostra dignità morale, e quindi
propone con evidenza estetica quello ch’è lo stesso conflitto dell’uomo nella sua
condizione umana, di essere ragionevole finito preso nel contrasto della sua
esistenza fenomenica con la sua esistenza noumenica, preso nella lotta fra la
sensibilità con le sue inclinazioni e la razionalità con la legge del dovere»90.
Il passaggio riporta qualcosa delle iniziali osservazioni sul sublime del
1764, e precisamente le considerazioni sul carattere morale dell’uomo, infatti,
il sublime «deve dunque interpretarsi come espressione del sentimento morale. Contemplare il sublime significa trasfigurare la realtà figurando il sentimento morale, cioè fare del sensibile la manifestazione del soprasensibile»91.
SAGGI
Nel primo l’uomo è posto dinanzi ad un fenomeno naturale la cui dimensione è talmente grande da non permettere il formarsi di un’idea adeguata per
mezzo di un unico colpo d’occhio; il pensiero così corre più volte sulla visione
non riuscendo però a trattenere le misurazioni parziali che va, via via, ottenendo. Il fenomeno dunque sfugge all’abbraccio del pensiero e non permette di
essere posseduto: nel sublime matematico «la nostra immaginazione tocca
presto il suo limite, dimenticando le sue prime misurazioni e facendoci apparire smisurata la cosa. Ma proprio dinanzi a questo smacco dell’immaginazione noi avvertiamo in noi stessi “la voce della ragione”, in quanto facoltà che
esige la totalità […]. Il fatto che noi siamo in grado, di fronte a quel che ci appare infinito, almeno di pensare alla totalità, ci rende consapevoli della presenza in noi stessi di qualcosa che va al di là delle limitazioni dei sensi» 79. In
questo caso è evidente il rapporto che si viene a creare tra sublime ed intelletto conoscente.
Nel secondo caso, l’uomo è posto dinanzi ad un oggetto della natura che è
enormemente potente; tale forza è terribile, terrorizza l’uomo e lo immobilizza
temporaneamente. La sensibilità viene sconfitta e con essa l’uomo biologico
che, ormai senza più fiato, si arrende all’irresistibile abbraccio mortale che lo
cinge. Ma nel sublime dinamico, all’iniziale senso di smarrimento, subentra
un’altra condizione dello spirito. Qui, infatti, «siamo condotti a riflettere non soltanto sulla debolezza fisica che ci caratterizza come esseri naturali, ma a scoprire in noi anche una indipendenza dalla natura, una nostra superiorità sulla
natura bruta, che ci proviene dalla nostra qualità di esseri capaci di moralità.
La natura in questo caso è sublime perché suscita in noi il sentimento della nostra destinazione soprasensibile, e il piacere riguarda la scoperta di questa nostra destinazione, occasionata da un dispiacere […]. La prossimità con i temi
dell’etica è, nel caso del sublime dinamico, assolutamente palese. […] Ma anche nel sublime matematico […] non è difficile scorgere quanto sia forte il legame con il mondo morale»80. In quest’altro caso si sottolinea come il sublime
sia in rapporto con la sensibilità.
Per il tramite del sublime dunque, nella sua duplice caratterizzazione di matematico e dinamico, si ottiene una sorta di specchio fedele della presenza
drammatica, nell’uomo, di sensibilità e ragione.
In verità, un primo accordo (dal punto di vista conoscitivo) si è detto che era
stato trovato nella risoluzione della terza antinomia cosmologica della Ragion
pura; un successivo passo avanti (dal punto di vista pragmatico) erano stato
fatto nella Critica della ragion pratica, quando Kant si era occupato della determinazione del concetto di sommo bene; vediamo brevemente come.
Per Kant «virtù e felicità insieme costituiscono, in una persona, il possesso
del sommo bene»81; ma la virtù è vivere moralmente reprimendo, dunque, le
tendenze naturali; e la felicità è vivere secondo natura, mettendo a tacere la
voce della ragione che impone di universalizzare la massima del proprio comportamento. La compresenza risulta dunque sofferta; e «la questione: com’è
praticamente possibile il sommo bene?, rimane […] un problema insoluto»82.
Va detto che «un identico essere agente che, come fenomeno […], ha nel mondo sensibile una causalità sempre conforme al meccanismo naturale, tuttavia,
41
42
Non è facile adeguare le diverse sensazioni che scaturiscono dalla lettura
del sublime: quella che lo vede come un artificioso tentativo di porre rimedio ad
un errore concettuale (il divieto di transito tra le due critiche con la necessaria
coesistenza nell’uomo dei due relativi mondi); o, dall’altro lato, quella che crede in una genuina analisi del necessario svolgersi del sistema. Va però detto
che, superata questa iniziale diffidenza, bisogna riconoscere e rendere giustizia di uno sforzo che brilla per originalità e densità teoretica.
Il sublime è il vertice di una piramide la cui base si compone di diversi stadi:
da uno iniziale in cui la teoretica distingue il vero dal falso, per passare poi ad un
altro in cui l’etica separa buono da cattivo, giungendo infine all’estetica che contrappone bello e brutto. Questi stadi sembrano percorsi nel loro punto mediano
da un perno che rafforza la struttura e la rende compatta: il sublime infatti, nel
pieno rispetto delle regole poste dalla speculazione –che denunciava come falsa la possibilità di determinare la connessione dei due mondi, ma come vera la
pensabilità di tale tentativo (tanto da dichiarare nelle pagine iniziali della Ragione pura l’importanza, la presenza immanente, del noumenico per l’uomo)92–, torce progressivamente ciò che è brutto nella natura –e al limite cattivo per la sopravvivenza– in ciò che è bello e buono nel nostro animo. Il sublime proietta
un’immagine oltre il vertice della piramide, e con essa puntella il cielo; quel cielo
stellato che con la legge morale riempiva di ammirazione l’animo di Kant.
Se è vero che il sublime dinamico prende avvio da una manifestazione terrena, e per la precisione naturale, ed è, cioè, fuori dall’artificio umano; purtuttavia il sublime in genere fa continuo riferimento al prodotto umano per eccellenza: la società. Infatti, «il primo esempio di sublimità sul quale Kant si indugia a lungo è quello della terribilità ispirata dalla solitudine, dalla privazione del
nostro bisogno di società»93. Come ha sostenuto Antimo Negri, l’estetica fonda la comunità in Kant; e, d’altra parte, quando nei Sogni di un visionario «Kant
avanzerà tra il serio e l’arguto il paradosso di una possibile attrazione naturale tra gli spiriti analoga alla attrazione newtoniana tra i corpi, non possiamo non
pensare al sensus communis»94. Il tema della socievolezza sarà sempre presente e passerà dai Sogni di un visionario alle Osservazioni, e poi ancora attraverserà la Ragion pratica ed il Giudizio. E nel passaggio dalle Osservazioni
alla Ragion pratica «l’originario sublime-terribile […] delle prime pagine si
stempera sempre più […] man mano che l’interesse di Kant si rivela un interesse morale, l’ammirazione diventa “rispetto” (Achtung) e il sublime “dignità”
(Würde)» 95.
Nel 1790 «di fatto a Kant non importa nulla del bello e del sublime al di qua
della dimensione morale. Sa bene che ci può essere un sublime non morale,
addirittura immorale: ma esso lo è, anche in questi casi, per quel che di morale vi è mescolato […]. Egli tratta esclusivamente di un sublime-morale, e di un
“bello”, di un non-sublime, come pre-morale»96.
Il sublime, al pari del principio a priori della Critica del Giudizio97, compie il
passaggio tra due continenti reciprocamente ostili. È il rimedio possibile ed auspicabile ad una separazione senza risoluzione.
Così, tirando le fila del discorso, Kant attribuisce al sublime almeno due funzioni particolari: il sublime ribadisce il primato della ragione sulla sensibilità; il
sublime permette, infine, un altro possibile collegamento dei due mondi per il
tramite dell’iniziale sentimento di dispiacere (dovuto alla paura che si prova dinanzi ad un fenomeno naturale di eccezionale portata) che si tramuta in piacere per la propria destinazione (e per la propria capacità di sottrarsi alle ferree
e coercitive leggi della natura).
Si conclude così il percorso che dalla totalità separata delle prime due critiche porta ad una totalità dispiegata nella Terza critica.
1 Cfr. I. KANT, Kritik der Urteilskraft, bey Lagarde und Friederich, Berlin und Libau 1790; trad.
it. di A. Gargiulo, riv. da V. Verra, Critica del Giudizio, introd. di P. D’Angelo, Laterza, Roma-Bari
2002, p. 5.
2 Cfr. ivi, Introduzione, § V “Il principio della finalità formale della natura è un principio trascendentale del Giudizio”, pp. 31-43. È lo stesso autore ad affermare che tale principio sia frutto dell’ultima critica: «la finalità della natura è, dunque, un particolare concetto a priori, che ha la sua origine unicamente nel Giudizio riflettente» (p. 31). In una particolare occasione le armi della Ragione pura sembrano essere inefficaci nel loro uso, ed allora bisogna volgere altrove l’attenzione, infatti quando «l’esperienza ci presenta nelle cose una regolarità a intendere o spiegare la quale non
basta più il concetto universale intellettivo del sensibile, […] allora può e deve essere applicato a
priori tale principio alla conoscenza degli esseri che sono nel mondo, ed esso ci apre nello stesso
tempo vedute vantaggiose [nella conoscenza e comprensione del mondo stesso]» (pp. 7-9; lo spaziato è nel testo).
3 Il termine Übergang (passaggio) ricorre più volte nell’Introduzione alla Critica del Giudizio; la
frequenza con cui l’autore utilizza l’espressione è un indice molto sensibile dell’importanza che il
lavoro occupa proprio in relazione alla compiutezza del sistema filosofico. Occorre così riportare,
sintetizzando al massimo, i passi-cardine che vedono l’utilizzo del vocabolo. Kant afferma che
«sebbene vi sia un immensurabile abisso tra il dominio del concetto della natura, o il sensibile, e
il dominio del concetto della libertà, o il soprasensibile, in modo che non è possibile nessun passaggio dal primo al secondo […]; tuttavia […] il concetto della libertà deve realizzare nel mondo
sensibile lo scopo posto mediante le sue leggi, e la natura, per conseguenza, deve poter essere
pensata in modo che la conformità alle leggi, che costituiscono la sua forma, possa almeno accordarsi con la possibilità degli scopi […]. Sicché vi deve essere un fondamento dell’unità tra […] natura e […] libertà […]; un fondamento il cui concetto […] permette nondimeno il passaggio dal modo di pensare secondo i principii dell’uno al modo di pensare secondo i principii dell’altro»; poco
dopo si legge che «la facoltà stessa del Giudizio [effettua] ancora un passaggio dalla pura facoltà
di conoscere, vale a dire dal dominio dei concetti della natura, al dominio del concetto della libertà; allo stesso modo che nell’uso logico rende possibile il passaggio dall’intelletto alla ragione»; in
seguito si trova che «il Giudizio […] fornisce il concetto intermediario tra i concetti della natura e
quello della libertà, concetto che rende possibile il passaggio dalla ragion pura teoretica alla ragion
pura pratica»; ed infine un’ultima ripetizione che recita: «il Giudizio rende possibile il passaggio dal
dominio del concetto della natura a quello del concetto della libertà» (ivi, pp. 21, 27, 63, 65; lo spaziato è nel testo; il corsivo è mio). Kant, già in precedenza, aveva offerto la chiave di lettura del
passaggio per il tramite del Principio della finalità formale della natura, affermando che «con ciò la
conoscenza della natura non si è affatto arricchita d’una particolare legge oggettiva, ma per il Giudizio si è solo stabilita la massima: di osservare la natura secondo queste leggi, e mediante esse
dare coesione alle forme della natura» (I. KANT, Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Faksimile und Transkription, a cura di N. Hinske, W. Müller-Lauter, M. Theunissen, Stuttgart-Bad Cannstatt 1965; trad. it. e note di P. Manganaro, Prima introduzione alla Critica del Giudizio, introd. di
L. Anceschi, Laterza, Bari 1984, p. 76). In breve, dinanzi alle infinite possibili leggi con cui la natu-
SAGGI
Conclusione
43
44
colo, ossia tutto ciò che è in certo senso terribile, o che riguarda oggetti terribili, o che agisce in
modo analogo al terrore, è una causa del “sublime”; ossia è ciò che produce la più forte emozione che l’animo sia capace di sentire» (p. 86). Infatti, «il terrore è in ogni caso […] la principale causa del sublime» (p. 115). Per l’autore «vi è una grande differenza fra ammirazione e amore. Il sublime, che è causa della prima, risiede sempre in oggetti grandi e terribili, mentre l’amore si rivolge a oggetti piccoli e piacevoli; noi ci sottomettiamo a ciò che ammiriamo, ma amiamo ciò che si
sottomette a noi» (p. 203). In riferimento alla potenza, «un’aria di robustezza e di forza è molto pregiudizievole alla bellezza: un’apparenza di delicatezza ed anche di fragilità le è quasi essenziale»
(p. 207). Per Burke non è propriamente la proporzione il discrimine tra bello e sublime; si legge infatti: «ho grande ragione di dubitare che la bellezza sia un’idea che appartiene alla proporzione»
(p. 167). Qualche riflessione più avanti sostiene che «il vero contrario della bellezza non è la sproporzione o la deformità, ma la bruttezza» (p. 187). La bruttezza può, d’altra parte, essere accostata al sublime seppur con alcune accortezze. L’autore scrive: «ritengo che la bruttezza abbia un certo rapporto con l’idea di sublime. Ma non insinuerei affatto che la bruttezza per se stessa sia
un’idea di sublime, a meno che non sia unita a qualità tali da eccitare un forte terrore» (p. 213). In
conclusione, è utile riportare una breve ricapitolazione che l’autore stesso compie nel suo scritto:
«gli oggetti sublimi sono vasti nelle loro dimensioni, e quelli belli al confronto sono piccoli; se la
bellezza deve essere liscia e levigata, la grandiosità è ruvida e trascurata; […] la bellezza non dovrebbe essere oscura, la grandiosità dovrebbe essere tetra e tenebrosa; la bellezza dovrebbe essere leggera e delicata, la grandiosità solida e perfino massiccia. Il bello e il sublime sono davvero idee di diversa natura, essendo l’uno fondato sul dolore e l’altro sul piacere» (pp. 221-222).
8 Cfr. F.J.C. SCHILLER, Über die ästhetische Erziehung des Menschen («Die Horen» 1795),
trad. it, introd. e note di A. Negri, Lettere sull’educazione estetica dell’uomo. Callia o della bellezza, Armando Editore, Roma 1971. Per Negri nasce, in Schiller, l’«esigenza della conciliazione tra
intelletto e sensibilità che ben figurano, in seno ad una problematica che solo apparentemente è
solo gnoseologica ed etica ed estetica, rispettivamente, l’ordine civile e l’ordine umano» (p. 14).
Nell’uomo educato esteticamente si concilia la sua condizione umana con quella civile. All’interno della rivoluzione estetica operata da Schiller, sempre secondo l’interpretazione di Negri, si vede sorgere «il motivo della cerchia delle relazioni belle (Kreis des schönen Umgangs), della comunicazione bella (schöne Mitteilung). Quando la comunicazione bella è in atto, quando tra gli
uomini si stringono relazioni belle, allora soltanto finisce lo Stato dei contratti necessari a costringere gli uomini ad essere liberi» (p. 33). La barbarie borghese costringe l’uomo ad essere libero,
sottraendolo al suo stato selvaggio, ma «una tale “barbarie” –sostiene il curatore–, peraltro, si ha
quando […] non si crede alla possibilità dell’avvento di un terzo uomo, né selvaggio né barbaro,
dell’uomo colto o educato, senza far violenza alla sua natura animale, senza schiacciare la sua
sensibilità» (p. 37). A riguardo Schiller è chiaro e sintetico: «prima che avesse avuto il tempo di
afferrarsi, con la sua volontà, saldamente alla legge, essa gli avrebbe tolto di sotto i piedi la scala della natura» (Lettera terza, p. 114). La barbarie borghese è la naturale deriva di un rapporto
che riconosce nell’altro solo un mero strumento per raggiungere altro; qui si inserisce, nell’intervento di Negri, la sofferta conclusione per cui «le relazioni belle non ci sono più, perché vige, nella società borghese, il rapporto utilitaristico, per il quale l’uomo esige dall’uomo il nudo pagamento in contanti» (p. 45).
9 Burke è persuaso del fatto che le parole «ci impressionino in modo molto diverso da quello in
cui noi siamo impressionati dagli oggetti naturali, dalla pittura o dall’architettura: tuttavia le parole hanno nel suscitare idee di bellezza e di sublime una parte altrettanto considerevole quanto qualunque
di esse, e talvolta molto maggiore» (E. BURKE, Ricerca sull’origine delle idee del sublime e del bello,
cit., pp. 279-280). Se è vero, però, ed è lo stesso Burke a riferirlo, che la poesia non possa raggiungere nella descrizione una aderenza così precisa come la pittura, è altresì convinto che il suo compito sia «di far impressionare piuttosto con la simpatia che con l’imitazione, di spiegare l’effetto delle
cose sulla mente dell’autore o di altri piuttosto che presentare una chiara idea delle cose stesse» (ivi,
p. 295). In conclusione, afferma l’autore, «poiché le parole impressionano non per un potere originale, ma per rappresentazione, si potrebbe supporre che il loro influsso sulle passioni dovesse essere
leggero; pure la cosa sta altrimenti; poiché troviamo per esperienza che l’eloquenza e la poesia sono altrettanto capaci, anzi molto più capaci, di riprodurre impressioni profonde di quello che non sia
ogni altra arte e in moltissimi casi perfino la natura stessa» (ivi, p. 296).
10 La recensione appare nella «Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Kün-
SAGGI
ra organizza il suo corso, ciò di cui si è alla ricerca è un principio unificatore del tutto: cercare di ricondurre il molteplice all’unità. È, dunque, con la consapevolezza di questo vuoto da colmare che
inizia la stesura della Critica del Giudizio.
4 Cfr. G. MORPURGO-TAGLIABUE, Introduzione a I. KANT, Osservazioni sul sentimento del bello e
del sublime, trad. it. di L. Novati, BUR, Milano 1998 (ed. orig., Beobachtungen über das Gefühl des
Schönen und Erhabenen, J.J. Kanter, Königsberg 1764), pp. 5-75; soprattutto laddove sono riportate, senza contestazioni, le parole del primo biografo di Kant, L.E. Borowski, che definisce il testo
di Kant come «degno di stare sul pettinatoio delle dame» (il lavoro di Borowski è contenuto in La
vita di Immanuel Kant narrata da tre contemporanei, trad. di E. Pocar, prefazione di E. Garin, Laterza, Bari 1969; l’ed. orig. Immanuel Kant: sein Leben in Darstellungen von Zeitgenossen. Die
Biographien von L.E. Borowski, R.B. Jachmann und A.Ch. Wasianski, Deutsche Bibliothek, Berlin
1912, contiene il testo di Borowski scritto nel 1792 e successivamente edito col titolo Darstellung
des Lebens und Charakters Immanuel Kants, bei Friedrich Nicolovius, Königsberg 1804); ma l’attenzione di uno studioso vigile e ponderato come Morpurgo-Tagliabue non si limita a questa nuda
ed acritica registrazione storiografica e biografica: egli infatti disposto com’è alla più autentica purezza intellettuale è persuaso di scorgere anche nello scritto in “stile popolare” di Kant il valore profondo dei foglietti di cui è costituito. Come infatti si può leggere, Morpurgo-Tagliabue afferma: «chi
ignori queste paginette […] non afferrerà interamente il senso delle definitive pagine della morale
della Fondazione della metafisica dei costumi (1795) e dell’estetica della Critica del Giudizio
(1790): ne possiederà il significato, ma in astratto, non ne coglierà il particolare senso» (pp. 6-7).
5 Come ha acutamente rilevato Adorno: «dopo il crollo della bellezza formale, delle idee estetiche tradizionali restò, attraverso tutta l’arte moderna, solo quella del sublime» (TH.W. ADORNO,
Ästhetische Theorie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1970; trad. it e cura di E. De Angelis, Teoria estetica, Einaudi, Torino 1975, p. 280). In questa prospettiva, in riferimento specifico ai rapporti tra bello e sublime in Kant, alla parabola descritta dal bello nel suo movimento, alle analogie tra
giudizio di gusto e giudizio morale, si rimanda al saggio, denso e impegnativo, di P. PELLEGRINO,
Kant e la “categoria” del bello, «Bollettino di Storia della filosofia dell’Università degli studi di Lecce», vol. X, 1990-92, pp. 185-198. I rapporti spesso conflittuali tra bello e sublime sembrano acutizzarsi –fra ’700 e ’800–, sino alla loro inconciliabile resistenza oppositiva, nell’emergere dell’estetica del brutto (un lavoro che già solo con il titolo segna un’evidente alternativa al percorso classico segnato da bello e sublime è: K. ROSENKRANZ, Ästhetik des Hässlichen, Verlag Bornträger, Königsberg 1853; trad. it. a cura di S. Barbera, presentazione di R. Bodei, Estetica del Brutto, Il Mulino, Bologna 1984; cfr. anche la più recente versione, sempre a cura di S. Barbera, con presentazione di E. Franzini e appendice biobibliografica di P. Giordanetti, Aesthetica, Palermo 2004), di
quell’«ombra del bello» (R. BODEI, Le forme del bello, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 93-126) che vede aumentare, in un vivo crepuscolo, i suoi contorni; o nel crescere, dunque, dell’importanza assunta dal gusto per l’orrido – secondo le varie forme artistiche che si dipanano nel Novecento e
che vanno da configurazioni più blande per arrivare ad aspetti maggiormente caricati: «l’armonia,
che come risultato rinnega la tensione che in essa si pone in parità, diventa così elemento disturbante, falso; se si vuole, dissonante. […] Ne deriva un risultato qualitativamente nuovo. Gli orrori
anatomici di Rimbaud e di Benn, il fisicamente repellente e ripugnante di Beckett, i tratti escrementizi di vari drammi contemporanei […]; nel brutto la legge della forma capitola per impotenza»
(TH.W. ADORNO, Teoria estetica, cit.; soprattutto il punto intitolato “Sulle categorie del brutto, del bello e della tecnica”, pp. 67-89, qui pp. 67-68); fino all’attenzione sempre crescente per ciò che disgusta (come ad es. avviene nella produzione cinematografica sull’horror sempre meno attenta al
senso e più propensa a bombardare con impressioni “scollegate” e ad effetto, dove l’unico fine è
rendere la visione sgradevole e generare un senso di nausea non motivato e neanche lontanamente assimilabile allo shock adorniano che aveva ben più alta funzione: aprire le menti e criticare il mondo completamente amministrato).
6 Del lavoro di E. BURKE, A philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime
and Beautiful (R. & J. Dodsley, London 1757), vanno ricordate almeno due trad. it.: quella con trad.
siglata E. C. e R. B., Ricerca sull’origine delle idee del sublime e del bello, a cura di A. Baratono,
Minuziano, Milano 1945; e un’ed. più recente a cura di G. Sertoli e G. Maglietta, Inchiesta sul bello e il sublime, Aesthetica, Palermo 1992.
7 Cfr. E. BURKE, Ricerca sull’origine delle idee del sublime e del bello, cit., dove, riguardo l’opposizione di terribile ed amabile, sostiene che «tutto ciò che può destare idee di dolore e di peri-
45
46
che si apre ai nostri piedi, una bufera, un vulcano in eruzione, un costone roccioso che si protende sopra di noi come se stesse per precipitare, il mare in tempesta, il vento tagliente della zona
polare, la stagione estiva nella zona tropicale, animali velenosi e feroci, un’inondazione e altri fenomeni simili, sono potenze della natura contro cui è vano sperare di poter resistere, e che tuttavia entrano in conflitto con la nostra esistenza materiale» (DS, cit., p. 29).
20 Certo, un maturo senso per la bellezza già basta a renderci fino a un certo grado indipendenti dalla natura come potenza. Un animo che si sia nobilitato al punto da essere toccato più dalle forme che dalla materia delle cose, e da trarre dalla pura riflessione sulle stesse un pieno appagamento, senza alcun riguardo al loro possesso, un tale animo porta in sé un’inalienabile, un’interiore pienezza di vita, e poiché non ha bisogno di appropriarsi degli oggetti tra cui vive, non corre neppure il rischio di esserne defraudato (F. SCHILLER, SS, cit., p. 69).
21 Ivi, p. 67.
22 Ivi, p. 68.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem. Solo l’uomo educato moralmente, e nessun altro, è interamente libero. O egli è superiore come potenza alla natura, oppure è in accordo con essa. Nulla di ciò che questa gli arreca è violenza: infatti, ancor prima che lo raggiunga, essa è già divenuta una sua propria azione, e
la natura dinamica non potrà mai raggiungerlo, giacché egli si è separato volontariamente da tutto ciò che essa può raggiungere (ivi, pp. 68-69).
27 Ivi, p. 70.
28 Ivi, p. 79.
29 Ivi, p. 81. Solo quando il sublime si coniuga al bello e la nostra sensibilità è stata educata in
pari misura per entrambi, siamo cittadini completi della natura, senza per questo divenire suoi
schiavi, e senza perdere il nostro diritto di cittadinanza nel mondo intelligibile (ibidem).
30 A. NEGRI (a cura di), Il giudizio estetico, Radar, Padova 1968, p. 6.
31 I. KANT, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefaßt von Immanuel Kant, bey Friedrich
Nicolovius, Königsberg 1798; trad. it. di G. Vidari, riv. da A. Guerra, Antropologia pragmatica, Universale Laterza, Roma-Bari 1985, § 2 “Dell’egoismo”, pp. 10-13, qui p. 12; lo spaziato è nel testo.
Negri sostiene che «l’egoismo estetico è il fondamentale obiettivo polemico di Kant» (A. NEGRI, Il
giudizio estetico, cit., pp. 6-7).
32 Ivi, p. 7.
33 I. KANT, Critica del Giudizio, cit., § 56, p. 355; lo spaziato è nel testo.
34 Ibidem; lo spaziato è nel testo.
35 I. KANT, Antropologia pragmatica, cit., § 2, p. 12; lo spaziato è nel testo. Va registrato che «il
pluralismo […] implica necessariamente l’atteggiamento cosmopolitico […] del modo di sentire, per
il quale il mio modo di sentire sta accanto al modo di sentire di un altro, senza che essi tendano
ad identificarsi o di fatto si identifichino» (A. NEGRI, Il giudizio estetico, cit., p. 7).
36 Ivi, p. 9. È l’uomo naturale che «trova nella bellezza e nella dignità il modo di sentirsi uguale all’altro. Si progetta, per dir così, una sorta di egalitarismo estetico, per il quale la sensibilità si
fa comunicante» (ibidem). Infatti per Kant «se si ammette come naturale nell’uomo la tendenza alla società, e la socievolezza, cioè l’attitudine e l’inclinazione alla vita sociale, come una qualità inerente ai bisogni dell’uomo, in quanto creatura destinata alla società, e quindi inerente all’umanità,
– allora non si potrà non considerare il gusto come la facoltà di giudicare di tutto ciò in cui il proprio sentimento può esser comunicato ad ogni altro, e quindi come il mezzo di soddisfare ciò che
è richiesto dall’inclinazione naturale di ognuno» (I. KANT, Critica del Giudizio, cit., § 41, p. 271; lo
spaziato è nel testo).
37 Ibidem.
38 Ivi, p. 161. In seguito riprenderà la questione pressapoco con lo stesso tono: «per conseguenza, è da chiamarsi sublime non l’oggetto, ma la disposizione d’animo» (ivi, pp. 171-173); e,
ancora: «la vera sublimità non dev’essere cercata se non nell’animo di colui che giudica, e non nell’oggetto naturale» (ivi, p. 183).
39 Ivi, p. 171.
40 Ivi, p. 195.
41 Ivi, p. 187.
SAGGI
ste» nel 1758, II, pp. 290-320; cfr. M. MENDELSSOHN, Gesammelte Schriften: Jubiläumsausgabe, a
cura di I. Elbogen et al., Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1977, vol. IV “Rezensionsartikel in Bibliothek der schonen Wissenschaften und der freyen Künste: 1756-1759”, a cura di
Eva J. Engel, pp. 216-236.
11 Ivi, p. 234; trad. mia.
12 Cfr. L. PAREYSON, L’estetica di Kant, Mursia, Milano 1968; soprattutto la Conclusione, pp.
195-198.
13 Il saggio appare col titolo Vom Erhabenen. Zu weitern Ausführung einiger Kantischen Ideen,
«Neue Thalia», n. III, 1793; trad. it., Del sublime. A proposito di alcune idee kantiane ulteriormente considerate, in F. SCHILLER, Del sublime, a cura di L. Reitani, Abscondita, Milano 2003, pp. 1336 (in seguito citato come DS).
14 Il lavoro viene pubblicato col titolo Über das Pathetische, «Neue Thalia», nn. III e IV, 1793;
trad. it., Sul patetico, in F. SCHILLER, Del sublime, cit., pp. 39-63 (in seguito citato come SP).
15 Lo scritto Über das Erhabene (realizzato nel periodo che va dal 1794 al ’96) appare nel 1801
nella raccolta Kleinere prosaische Schriften von Schiller. Aus mehreren Zeitschriften vom Verfasser
selbst gesammelt und verbessert (4 voll., Crusius, Leipzig 1792-1802), curata dallo stesso Schiller;
trad. it., Sul sublime, in F. SCHILLER, Del sublime, cit., pp. 67-82 (in seguito citato come SS).
16 Si legge infatti che «Sublime è quell’oggetto nella cui rappresentazione la nostra natura sensibile riconosce i propri limiti, mentre la nostra natura razionale avverte la propria superiorità, la propria libertà da ogni limite; un oggetto, dunque, contro cui soccombiamo fisicamente, ma su cui ci
eleviamo moralmente, vale a dire in virtù delle idee. Solo come esseri sensibili soggiaciamo a vincoli, come esseri razionali siamo liberi. L’oggetto sublime in primo luogo rende a noi visibile la mancanza di indipendenza che ci caratterizza come esseri naturali, mostrandoci in secondo luogo l’indipendenza che, come esseri razionali, affermiamo sulla natura dentro e fuori di noi» (F. SCHILLER,
DS, cit., p. 13). In un altro lavoro, Schiller ribadisce che nella «discordanza tra i tratti che sono stati impressi alla natura animale secondo la legge della necessità, e quelli determinati dallo spirito indipendente, si riconosce la presenza di un fondamento sovrasensibile nell’uomo, che può porre un
limite agli effetti della natura, e appunto per questo differenziarsene» (ID., SS, cit., p. 47).
17 Per Schiller «noi affermiamo con la nostra ragione una duplice indipendenza dalla natura; in
primo luogo potendo (teoreticamente) andare al di là dei presupposti naturali e immaginare più di
quanto conosciamo; in secondo luogo potendo (praticamente) superare le condizioni della natura
e contrastare la nostra cupidigia con la nostra volontà. Un oggetto nella cui percezione sperimentiamo la prima forma di indipendenza si dice teoreticamente grande, un sublime della conoscenza. Un oggetto che rende tangibile l’indipendenza della nostra volontà è praticamente grande, un
sublime dell’animo. Nel sublime teoretico la natura s’oppone all’impulso a rappresentare in quanto oggetto della conoscenza. Nel sublime pratico essa s’oppone all’istinto di conservazione in
quanto oggetto della sensazione. Nel primo caso la si considera unicamente come un oggetto che
può ampliare le nostre conoscenze; nel secondo la si concepisce come una potenza che può determinare il nostro stato. Per questa ragione Kant definisce il sublime pratico come sublime della
potenza o dinamico, in contrapposizione al sublime matematico» (DS, cit., p. 14).
18 Come già in Kant «il loro [dei fenomeni sublimi] aspetto diventa tanto più attraente per quanto più è spaventevole, se ci troviamo al sicuro; e queste cose le chiamiamo volentieri sublimi, perché esse elevano le forze dell’anima al disopra della mediocrità ordinaria, e ci fanno scoprire in noi
stessi una facoltà di resistere interamente diversa, la quale ci dà il coraggio di misurarci con l’apparente onnipotenza della natura» (I. KANT, Critica del Giudizio, cit., p. 195), anche Schiller è convinto che «l’oggetto spaventoso non deve dunque rivolgere la sua potenza contro di noi, oppure,
quando ciò si verifichi, il nostro spirito deve rimaner libero mentre i nostri sensi vengono sopraffatti. Quest’ultimo caso si verifica però assai di rado ed esige una superiorità della natura umana che
difficilmente si può rinvenire in un uomo. Quando ci troviamo realmente in pericolo, infatti, e
un’ostile potenza della natura ci minaccia, non c’è spazio per il giudizio estetico» (DS, cit., p. 20).
19 Famoso è il passo in cui Kant propone alcuni esempi di sublime: «le rocce che sporgono audaci in alto e quasi minacciose, le nuvole di temporale che si ammassano in cielo tra lampi e tuoni, i vulcani che scatenano tutta la loro potenza distruttrice, e gli uragani che si lascian dietro la devastazione, l’immenso oceano sconvolto dalla tempesta, la cataratta d’un gran fiume, etc., riducono ad una piccolezza insignificante il nostro potere di resistenza, paragonato con la loro potenza»
(I. KANT, Critica del Giudizio, cit., p. 195). Anche Schiller ripropone lo stesso schema: «un abisso
47
43
48
Ibidem.
Ivi, p. 82.
55 Ivi, pp. 82-83. Anche nell’Analitica del sublime, all’interno della Critica del Giudizio, Kant
espone emblematicamente il caso in cui si trova chi è dinanzi alle piramidi d’Egitto o alla basilica
di San Pietro a Roma: «non bisogna né avvicinarsi troppo né tenersi troppo lontani dalle Piramidi,
per provare tutta l’emozione che dà la loro grandezza. […] Allo stesso modo si può spiegare il turbamento o quella specie d’imbarazzo da cui, come si racconta, è colpito lo spettatore nell’entrare
la prima volta nella chiesa di S. Pietro a Roma. Vi è qui il sentimento della inadeguatezza della sua
immaginazione a formare una esibizione delle idee di un tutto» (I. KANT, Critica del Giudizio, cit.,
p. 175).
56 I. KANT, Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, cit., p. 83.
57 Ivi, p. 84.
58 Ibidem.
59 Ivi, p. 85.
60 Ivi, p. 86.
61 Ivi, pp. 87-88.
62 Ivi, p. 89.
63 Ibidem.
64 Cfr. a riguardo la pur illuminante Introduzione di K. Tenenbaum a I. KANT, Bemerkungen. Note per un diario filosofico, a cura della stessa Tenenbaum, Meltemi, Roma 2001, pp. 7-28. Nel suo
lavoro la Tenenbaum scrive che «le Bemerkungen costituiscono un vero e proprio “diario filosofico”, che consente di entrare nell’intimità del laboratorio kantiano in cui stanno prendendo forma
elementi fondamentali del suo pensiero maturo» (ivi, p. 7). La curatrice suggerisce di «notare come le Bemerkungen offrano la possibilità di osservare in presa diretta la metodologia della ricerca
kantiana, che procede parallelamente su vari piani, mescolando […] competenze disciplinari disparate, unificate però nell’intento di “giungere a conoscere la peculiare destinazione e i limiti delle facoltà e inclinazioni umane”» (ivi, p. 9). Le Bemerkungen diventano, in quest’ottica, una «testimonianza preziosa di quegli anni di ricerca, di certezze sempre rimesse in questione, di carte sempre rimescolate» (ivi, p. 13).
65 Ivi, p. 33.
66 Ivi, p. 45.
67 Ivi, p. 55.
68 Ivi, pp. 169-171.
69 Ivi, p. 171.
70 Vi sono molte versioni della Dissertatio (originalmente stampata dal libraio J.J. Kanter di Königsberg nel 1770 col titolo “De mundi sensibilis atque intellegibilis forma et principiis, Regiomonti, Stanno regiae aulicae et academicae tipographiae”) tra cui bisogna segnalarne almeno tre che
mantengono il titolo latino: una con trad. it., introd. e note di G. De Giuli, Carabba, Lanciano 1936;
una versione contenuta in P. PIMPINELLA - A. LAMARRA, Indici e concordanze degli scritti latini di Immanuel Kant, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1987-1991; un’altra con trad. it. e cura di R. Ciafardone,
Edizioni di storia e letteratura, Roma 2002; ed infine, ma non cronologicamente, quella che traduce il titolo con La forma e i princìpi del mondo sensibile e del mondo intelligibile (Dissertazione del
1770), introd., trad. it., note e apparati di A. Lamacchia, Rusconi, Milano 1995, che riproduce «con
qualche miglioramento e aggiornamento bibliografico – il testo della traduzione e della introduzione, editate con lo stesso titolo, nel 1969, presso l’Editrice Liviana di Padova» (ivi, Nota editoriale,
p. 51).
71 Ivi, Introduzione, p. 38. Al termine del suo denso contributo, Ada Lamacchia scrive icasticamente che «si può quindi concludere che nella Dissertazione sono già presenti alcuni motivi fondamentali che rimangono acquisiti alla filosofia critica, e che introducono il razionalismo critico di
Kant» (ibidem).
72 Ivi, Sez. III, § 13, p. 93; il corsivo è nel testo. Per Kant, la percezione dei fenomeni viene data all’uomo per il tramite dell’intuizione –o modificazione di un organo di senso–; questa ha due
forme a priori (poiché non basate sull’esperienza) che sono lo spazio ed il tempo e sulle quali adattiamo il mondo nel procedimento percettivo. In questa concisa citazione Kant offre il preludio della successiva formulazione che esporrà nell’Estetica trascendentale della Critica della ragione pura. Si legge infatti che «nel corso di questa indagine si troverà che sussistono, come principî del53
54
SAGGI
Ibidem.
Ivi, p. 171. Kant offre una vera definizione: «sublime è ciò che, per il fatto di poterlo anche
solo pensare, attesta una facoltà dell’animo superiore ad ogni misura dei sensi»; in seguito scriverà: «Il potere anche solo pensare senza contraddizione l’infinito dato, esige nell’animo umano una
facoltà, che sia essa stessa soprasensibile» (ivi, pp. 173 e 181; i corsivi sostituiscono lo spaziato
nel testo).
44 Ivi, pp. 175-177.
45 Ivi, p. 187. Si legge anche che «la nostra propria insufficienza suscita la coscienza di una
facoltà illimitata del nostro stesso soggetto» (ivi, p. 191); oppure: «l’impossibilità di resistere alla
potenza naturale ci fa conoscere la nostra debolezza in quanto esseri della natura, cioè la nostra
debolezza fisica, ma ci scopre contemporaneamente una facoltà di giudicarci indipendenti dalla
natura, ed una superiorità che abbiamo su di essa» (ivi, p. 195).
46 Ivi, p. 195.
47 C’è una parabola che unisce, nel segno della comunicazione e della socialità, il sentimento
del bello e l’universalità del giudizio con il sentimento del sublime e la coscienza del fine morale
nell’uomo: così, «per sensus communis si deve intendere l’idea di un senso che abbiamo in comune, cioè di una facoltà di giudicare che nella sua riflessione tien conto a priori, del modo di rappresentarne di tutti gli altri» (ivi, § 40, p. 263; il corsivo e lo spaziato sono nel testo). Ed in questo
trova forza la speranza del consenso condiviso. Poiché però, «nel giudizio si esprime uno stato
sentimentale, o uno stato d’animo […]: quello del piacere o del dispiacere dell’oggetto. Ora, è questo stato d’animo che vuole essere condiviso, comunicabile» (A. NEGRI, Il giudizio estetico, cit., p.
27). Tirando le fila, «non si comprenderà mai la portata teoretica dell’estetica kantiana, se non se
ne coglie il profondo respiro politico e sociale» (ivi, p. 8). Non si può non convenire con Negri quando afferma, a conclusione della sua Introduzione, che «Kant dà una lezione estetica e provoca un
problema morale» (ivi, p. 37).
48 M. HORKHEIMER - TH. W. ADORNO, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Querido, Amsterdam 1947; trad. it. di R. Solmi, introd. di C. Galli, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi,
Torino 1997, pp. 239-240.
49 Come chiarisce uno scrupoloso interprete dell’estetica di Kant, «viene d’obbligo ricordare
[…] il celebre saggio di Edmund Burke, la già citata Ricerca filosofica sull’origine delle nostre idee
del sublime e del bello (1757), che suscitò viva attenzione in Germania dopo che era piaciuta al
Lessing, il quale vi trovò il primo spunto del suo celebre successivo Laocoonte (1766) […]. A distanza di pochi mesi, nel 1758, Lessing lo aveva tradotto per proprio uso e ne parlava ai conoscenti, tra i quali Moses Mendelssohn […]. Questi stese una ampia recensione dell’opera di Burke […]. Non sappiamo se Kant lesse nel testo l’opera del Burke: è certo che egli conoscesse l’inglese […]. Ma soprattutto fece tesoro delle notizie date dal Mendelssohn» (G. MORPURGO-TAGLIABUE, Introduzione a I. KANT, Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, cit., p. 16). Dalle
Osservazioni emergono un lunga serie di elementi che caratterizzano la figura generale del filosofo di Königsberg; spicca l’influenza non troppo sotterranea e le sollecitazioni che ebbe dal periodo
in cui visse: dalla lettura, dallo studio e dal confronto con i grandi paradigmi del Settecento. D’altra parte, il secolo subiva ancora influenze lontane: «del sublime longiniano veniva evidenziato soprattutto […] il pauroso, il terrifico, il pericoloso, il veemente, come doti che impressionando affascinano ed esaltano lo spettatore e soddisfano il suo bisogno di animazione. […] Le nozioni che
traducevano il gusto del secolo: il bello piacente e il sublime inquietante» (ivi, pp. 18-19). Verrebbe dunque da dire che anche Kant ne fosse profondamente influenzato, ma in realtà se è vero che
l’ipotesi «che Kant accingendosi a trattare del sublime non avesse preso visione dell’opera di Longino non sembra nemmeno da pensarsi […] eppure […] si può parlare al più di qualche vaga eco»
(ivi, p. 22). Ma non si può non prendere atto che era «più palese il rapporto col Burke. Come ne
aveva adottato il bello-grazioso rococò, così ne accetta inizialmente il sublime-terribile» (ivi, p. 23).
50 Ivi, p. 6. Più là nella sua Introduzione, Morpurgo-Tagliabue dirà che «per quanto il saggio sia
tutto meno che dimostrativo e argomentativo, ma abbia l’apparenza di una scorrevole e persino un
po’ svagata serie di osservazioni e di aforismi, tuttavia la sua struttura vorrebbe essere quella di
un teorema: con una I sezione di premesse a modo di definizioni, una II sezione di dimostrazioni,
una III di conferme o deviazioni, una IV di corollari» (ivi, p. 27).
51 I. KANT, Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, cit., pp. 80-81.
52 Ivi, p. 81.
42
49
50
so generale della ricerca rispetto alla ‘ragione pura’ o alla ‘ragione pratica’; esse si dichiarano prevalentemente nel rilievo di una insufficienza sistematica, e nella conseguente esigenza di integrazione teorica per colmare tale insufficienza» (ivi, p. 18).
77 Nonostante il divieto a spingere la conoscenza oltre il fenomeno, nella Critica della ragione
pura Kant si accinge a studiare la totalità dell’esistente –cioè il mondo nella sua doppia costituzione fenomenica e noumenica–, per il tramite delle antinomie cosmologiche: «le idee, di cui ora ci
occupiamo, le ho chiamate sopra idee cosmologiche, in parte perché per mondo si intende l’insieme di tutte le apparenze […]; in parte anche perché la parola mondo […] significa la totalità assoluta dell’insieme delle cose esistenti» (Critica della ragione pura, cit., p. 478). Aggiunge: «per antitetica io intendo […] il contrasto di due conoscenze all’apparenza dogmatiche […], a nessuna delle quali si attribuisca un diritto prevalente all’assenso» (Ivi, p. 479). È dal reciproco rapporto di tesi ed antitesi che scaturisce una risoluzione del conflitto. È il terzo contrasto ad avere grande centralità, occorre dunque riportare alcuni brani: la tesi recita: «la causalità secondo le leggi della natura non è l’unica causalità, onde possano venir derivate tutte quante le apparenze del mondo. Per
spiegare le apparenze, è altresì necessario ammettere una causalità mediante libertà» (Ivi, p.
502). Per contro l’antitesi afferma che: «non vi è alcuna libertà, e piuttosto, nel mondo tutto accade unicamente secondo le leggi della natura» (Ivi, p. 503). Poiché la risoluzione del contrasto impegnerà per molte pagine, occorre arrivare brevemente alla conclusione. Ci sono solo due tipi di
causalità: o secondo natura o secondo libertà. L’uomo, ad esempio, è vincolato biologicamente al
mondo della necessità, ma dal punto di vista morale è parte del mondo incondizionato. La compresenza è dunque possibile infatti: «libertà e natura, ciascuna nel suo pieno significato, si ritroverebbero simultaneamente e senza alcun contrasto proprio nelle medesime azioni, a seconda che
queste vengano confrontate con la loro causa intelligibile oppure con la loro causa sensibile» (Ivi,
p. 580). La compresenza è assicurata, dunque, dalla non belligeranza dei due mondi; ma la pace
è ancora esclusa dalla radicale ed inconciliabile distanza di natura e libertà (posizione che rimane
inalterata fino alle considerazioni della Critica del giudizio).
78 Per Pareyson «il punto in cui maggiormente si vede come la possibilità di giudizi estetici sia
legata alla doppia natura dell’uomo, sensibile e ragionevole, è il sublime. Infatti il sublime si fonda
non soltanto sulla simultanea presenza nell’uomo di sensibilità e ragione, ma addirittura sulla loro
drammatica compresenza, cioè sul loro contrasto, e sulla vittoria della ragione sulla sensibilità. […]
L’oggetto che nella contemplazione appare come sublime è immenso: e può essere un immenso
di grandezza, ch’è l’infinito, o un immenso di forza e potenza, ch’è il terribile. Di fronte a questo oggetto infinito o terribile il soggetto contemplante è colpito in doppio modo nel sentimento di piacere e dispiacere, a seconda che si badi al punto di vista dell’immaginazione o a quello della ragione» (L. PAREYSON, L’estetica di Kant, cit., p. 65).
79 P. D’ANGELO, Introduzione a I. KANT, Critica del Giudizio, cit., p. XXXVIII. Secondo Pareyson
«di fronte all’infinito l’immaginazione si rivela impotente: l’immaginazione infatti è l’apprensione
della forma dell’oggetto, cioè dell’unità del suo molteplice: ma l’infinito non può essere appreso dall’immaginazione nella sua unità, cioè compreso, poiché […] l’immaginazione lo coglie solo parzialmente […]: l’immaginazione sensibile rivela la propria impotenza, il che colpisce negativamente il
sentimento di piacere e dispiacere: l’umiliazione dell’immaginazione provoca un dispiacere. […] Di
fronte all’infinito l’immaginazione come facoltà della comprensione è umiliata, ed esaltata è la ragione come facoltà soprasensibile della totalità: il contrasto fra sensibilità e razionalità termina con
la sconfitta della sensibilità e col trionfo della razionalità: nasce il sublime, che a un oggetto della
natura, singolare per la sua grandezza, attribuisce l’aspetto dell’infinito, cioè proietta su un oggetto dell’immaginazione la dignità della ragione. È il sublime matematico. Analogamente di fronte al
terribile si rivela impotente la nostra intera sensibilità, la nostra natura fisica […]: si percepisce che
la potenza della natura è tale che di fronte ad essa la nostra esistenza fisica è impotente, esposta
com’è al più facile annientamento […]. D’altro lato rimane evocata la nostra esistenza soprasensibile, la nostra dignità morale, la nostra destinazione di là dalla sensibilità; […] sappiamo bene che
queste forze, per quanto potenti e terribili siano, nulla valgono contro la nostra natura morale […];
quanto più è umiliata la nostra sensibilità e la nostra esistenza fisica, tanto più è esaltata la nostra
dignità morale e la nostra esistenza soprasensibile; […] ne nasce un sentimento di piacere, per
l’esaltazione della nostra natura soprasensibile» (L. PAREYSON, L’estetica di Kant, cit., p. 66).
80 P. D’ANGELO, Introduzione a I. KANT, Critica del Giudizio, cit., pp. XXXVIII-XXXIX. Pareyson ricorda che «il contrasto fra sensibilità e razionalità termina anche qui con la sconfitta della sensibi-
SAGGI
la conoscenza a priori, due forme pure dell’intuizione sensibile, cioè spazio e tempo» (I. KANT, Kritik der Reinen Vernunft, Hartknoch, Riga 1781; trad. it. e cura di G. Colli, Critica della ragione pura, Adelphi, Milano 1995, p. 77; il corsivo è nel testo).
73 I. KANT, La forma e i princìpi del mondo sensibile e del mondo intelligibile, cit., Sez. II, § 3, p.
75; il corsivo è nel testo. La conoscenza in senso stretto riguarda il mondo fenomenico (phaìnomai, appaio) che appare dinanzi a noi e «la capacità di ricevere rappresentazioni (recettività), attraverso il modo con cui noi siamo modificati dagli oggetti, si chiama sensibilità» (I. KANT, Critica
della ragione pura, cit., p. 75; il corsivo sostituisce il grassetto nel testo). La conoscenza intellettuale riguarda le cose in sé, il mondo noumenico (noumenon, pensato), ciò che può essere solo
pensato e mai intuito. Nella Prima critica scrive infatti: «la conoscenza […] si rivolge soltanto ad
apparenze, lasciando per contro che la cosa in sé certo sussista come per sé reale, ma sia da noi
sconosciuta» (ivi, p. 26), ed in seguito aggiungerà che «noi non possiamo aver conoscenza di alcun oggetto in quanto cosa in se stessa, ma solo in quanto esso è oggetto dell’intuizione sensibile, cioè in quanto apparenza. […] Occorre tener bene a mente: proprio quei medesimi oggetti, noi
dobbiamo almeno avere la possibilità di pensarli anche come cose in se stesse, per quanto non
possiamo conoscerli come tali. Altrimenti infatti deriverebbe da ciò la proposizione assurda, che
sussiste un’apparenza senza un qualcosa che in essa appaia» (ivi, p. 30; lo spaziato è nel testo).
74 I. KANT, La forma e i princìpi del mondo sensibile e del mondo intelligibile, cit., Sez. V, § 24,
p. 133; il corsivo è nel testo. Nella Pura parlerà del tribunale della ragione: la ragione, infatti, deve
assumere «la più gravosa di tutte le sue incombenze, ossia quella della conoscenza di sé, e perché istituisca un tribunale, che la garantisca nelle sue giuste pretese, ma possa per contro sbrigarsi di tutte le pretensioni senza fondamento non mediante sentenze d’autorità, bensì in base alle
sue eterne ed immutabili leggi. E questo tribunale non è altro se non proprio la critica della ragione pura» (I. KANT, Critica della ragione pura, cit., pp. 9-10).
75 A. LAMACCHIA, Introduzione a I. KANT, La forma e i princìpi del mondo sensibile e del mondo
intelligibile, cit., p. 5. Cfr. anche le diverse posizioni, a riguardo, riportate dalla Tenenbaum, tra cui
brilla quella di Kuno Fischer. La Tenenbaum afferma infatti che: «la nuova prospettiva di Fischer
attribuisce dunque agli scritti “precritici” il ruolo di “chiave” per la comprensione della filosofia critica. […] È importante che con il suo autorevole intervento si sia superato il divieto di prendere in
considerazione gli scritti anteriori alla Dissertatio del 1770» (K. TENENBAUM, Introduzione a I. KANT,
Bemerkungen. Note per un diario filosofico, cit., pp. 7-28, qui p. 14). La lettera in questione è preceduta da un progetto-abbozzo, datato anteriormente al 13 ottobre 1777, che sembra essere «filosoficamente più interessante» (I. KANT, Epistolario filosofico: 1761-1800, a cura di O. Meo, Il Melangolo, Genova 1990, pp. 372-374, qui nota 1, p. 372), in cui Kant rivolgendosi al Tieftrunk scrive: «consento volentieri alla Sua proposta di raccogliere e pubblicare i miei scritti minori. Vorrei però che tale raccolta non accogliesse quelli precedenti al 1770. Potrebbe dunque aprirla la traduzione tedesca della mia dissertazione inaugurale De mundi sensibilis» (ivi, p. 373).
76 Vengono in soccorso di quest’idea alcune considerazioni presenti in uno scritto anteriore alla definitiva Introduzione alla Critica del Giudizio; Kant «ha lasciato inedito il testo di una introduzione alla terza Critica che, trovata da Dilthey nel 1889 presso la biblioteca della università di Rostock, fu pubblicata per la prima volta da Bueck nel 1914, e che, per solito, vien designata con il
titolo di Erste Einleitung» (L. ANCESCHI, Introduzione a I. KANT, Prima introduzione alla Critica del
Giudizio, cit., pp. 7-53, qui p. 7; il corsivo è nel testo). Anche in questo primo abbozzo introduttivo,
la Critica del Giudizio appare nata, «nello svolgimento del pensiero di Kant, […] da una acuta esigenza di organicità sistematica, di piena integrazione e unità del sistema» (ivi, p. 11); in questa
«Prima Introduzione, Kant –in modo affatto esplicito– procede prima di tutto ad un esame dell’idea
di sistema» (ivi, p. 43; il corsivo è nel testo). In una celebre lettera inviata a Marcus Herz, che Anceschi data erroneamente 20 aprile 1777, ma che in realtà è stata composta il 20 agosto 1777,
Kant scrive: «le mie ricerche, una volta esercitate in modo frammentario […], hanno preso forma
sistematica, mi han condotto gradualmente all’idea del tutto, il che ha per primo effetto rendere
possibile il giudizio di valore, e l’influenza reciproca delle parti» (cfr. l’ed. tedesca Kant’s Briefwechsel: 1747-1788, Bd. I, De Gruyter, Berlin-Leipzig 1922, Briefe 120, pp. 211-214, VI capoverso; qui
però conserviamo la traduzione di Anceschi nella sua Introduzione a I. KANT, Prima introduzione
alla Critica del Giudizio, cit., p. 11). Bisogna sottolineare che «le insoddisfazioni di Kant non riguardano propriamente i risultati dottrinali raggiunti nelle due Critiche nel loro specifico orizzonte problematico; non riguardano la soluzione di questo o di quel problema particolare; e neppure il sen-
51
52
te meccanica o fisica […], là dove noi ci attendevamo una connessione teleologica […]: in tal caso ci viene soltanto a mancare una nuova unità, ma noi non distruggiamo affatto l’unità razionale
nel suo uso empirico» (ivi, p. 693; lo spaziato è nel testo). In precedenza, aveva affermato che
«l’ideale dell’ente supremo […] non è null’altro se non un principio regolativo della ragione, in base a cui si considera ogni congiunzione nel mondo come se provenisse da una causa necessaria,
sufficiente per ogni cosa, allo scopo di fondare su tale causa la regola di un’unità sistematica, e
necessaria secondo leggi universali, nella spiegazione del mondo» (ivi, p. 639; lo spaziato è nel
testo).
93 G. MORPURGO-TAGLIABUE, Introduzione a I. KANT, Osservazioni sul sentimento del bello e del
sublime, cit., p. 23. «Sublime e bello ineriscono entrambi per lui alla partecipazione comunitaria
umana: non per nulla il suo esempio più tipico di terrore sublime […] era l’incubo della solitudine,
la privazione di società» (Ivi, pp. 26-27).
94 Ivi, p. 9. Nelle sue annotazioni alle Osservazioni Kant ritornava spesso sull’idea che ci fosse un senso comune benigno, tale da poter rendere la comunità coesa e pacifica: «non vi è alcuna inclinazione immediata verso azioni moralmente cattive, bensì un’inclinazione immediata verso
azioni buone» (I. KANT, Bemerkungen. Note per un diario filosofico, cit., p. 55). Ed ancora, scriveva: «non posso convincere un’altra persona se non attraverso i suoi propri pensieri. Devo dunque
presupporre che l’altro abbia un intelletto giusto e buono, altrimenti è inutile sperare che egli possa venire conquistato dalle mie ragioni. Ugualmente non posso influire moralmente su qualcuno
se non attraverso i suoi stessi sentimenti. Devo dunque presupporre nell’altro una certa bontà di
cuore, altrimenti non sentirà mai in sé disgusto per le mie descrizioni del vizio e attrazione per le
mie lodi della virtù» (ivi, p. 71). In un’ulteriore annotazione auspicava di «tenere in gran conto l’intelletto comune e il gusto comune» (ivi, p. 229), indici precisi e sinceri di un senso diffusamente
presente nell’uomo.
95 G. MORPURGO-TAGLIABUE, Introduzione a I. KANT, Osservazioni sul sentimento del bello e del
sublime, cit., p. 70.
96 Ivi, pp. 34-35.
97 Conviene sottolineare almeno due questioni: la necessità della composizione del principio
della finalità formale della natura nell’accostarsi ai fenomeni del mondo; l’utilità che tale principio
porta all’impostazione della Pratica. Per quanto riguarda il primo punto, Kant afferma: «dobbiamo
quindi pensare che nella natura, considerandola nelle sue leggi puramente empiriche, siano possibili leggi empiriche infinitamente varie, che, tuttavia, son contingenti per noi […]; e secondo le
quali giudichiamo come contingente l’unità della natura nelle sue leggi empiriche, e la possibilità
dell’unità dell’esperienza» (I. KANT, Critica del Giudizio, cit., p. 37). Per Kant corre l’obbligo di «ammettere una tale unità, perché altrimenti non si troverebbe una generale connessione delle conoscenze empiriche da formarne un’esperienza totale […], il Giudizio deve ammettere pel proprio
uso, come principio a priori, che ciò che è contingente per noi nelle leggi particolari (empiriche) della natura, contenga tuttavia un’unità conforme a leggi nella composizione del molteplice in
un’esperienza possibile in sé, sebbene tale unità noi non possiamo comprenderla e la possiamo
soltanto pensare» (ibidem; il corsivo è nel testo). Il principio della finalità formale della natura «rappresenta soltanto l’unico modo che noi dobbiamo seguire nella riflessione sugli oggetti della natura allo scopo di ottenere un’esperienza coerente in tutto nel suo complesso» (ibidem). Passando
alla seconda questione, c’è un passo in cui si fa avanti l’ipotesi che il principio della finalità formale della natura possa divenire una sorta di dimostrazione di seconda mano della corretta posizione tenuta nella Critica della ragion pratica: dimostrare infatti la correttezza dell’impostazione teleologica dello sguardo sul mondo torna a vantaggio della Pratica in cui l’impostazione finalistica era
volta alle considerazioni sull’uomo. Kant scrive che allorquando «l’esperienza ci presenta nelle cose una regolarità a intendere o spiegare la quale non basta più il concetto universale intellettivo
del sensibile, […] allora può e deve essere a applicato a priori tale principio alla degli esseri che
sono nel mondo, ed esso ci apre nello stesso tempo vedute vantaggiose per la ragion pratica» (ivi,
pp. 7-9; il corsivo e lo spaziato sono nel testo).
SAGGI
lità e col trionfo della razionalità: nasce il sublime, che a un oggetto della natura, singolare per la
sua forza e potenza, attribuisce quella forza e potenza che solo la razionalità possiede in conflitto
con la pochezza della nostra natura sensibile. È il sublime dinamico. Il sublime, dunque, consiste
nell’esteriorizzare, in oggetti che si prestano a cogliere questa proiezione, il conflitto delle due nature in noi, e quanto più drammatico è il conflitto, tanto più intensa è l’impressione di sublimità che
ne consegue […]. Perciò sublime è ciò che piace per la sua opposizione all’interesse dei sensi, e
per l’implicita esaltazione della ragione. Ora il sentimento che si prova di fronte alla superiorità della ragione sulla sensibilità è il sentimento morale, sì che la qualità del sentimento del sublime è
identica a quella del sentimento morale» (L. PAREYSON, L’estetica di Kant, cit., p. 67).
81 I. KANT, Kritik der Praktischen Vernunft, Hartknoch, Riga 1788; trad. it., cura e introd. di V.
Mathieu, Critica della ragion pratica, Rusconi, Milano 1993, p. 229.
82 Ivi, p. 233; lo spaziato è nel testo.
83 Ivi, p. 235; lo spaziato è nel testo.
84 Ivi, p. 243.
85 Ivi, p. 249; lo spaziato è nel testo.
86 Ibidem, lo spaziato è nel testo.
87 Ivi, p. 253; lo spaziato è nel testo.
88 Ivi, p. 263; lo spaziato è nel testo.
89 Per Pareyson «l’immaginazione non è posta in gioco regolare dall’intelletto, ma è posta in
contrasto con la ragione: l’armonia che si stabilisce fra immaginazione e ragione è indiretta, in
quanto è mediata da una lotta in cui la ragione esce vittoriosa e l’immaginazione manifesta la propria impotenza, e l’armonia consiste proprio in questo giusto risultato del contrasto, perché è giusto che l’immaginazione sia umiliata rispetto alla ragione e la ragione trionfi […]. In tal modo l’immaginazione è asservita alla ragione, e diventa suo “strumento” […]. Perciò il giudizio che verte
sul sublime “non si presenta affatto come un gioco, ma come qualcosa di serio nell’impiego dell’immaginazione”» (L. PAREYSON, L’estetica di Kant, cit., pp. 98-99).
90 Ivi, p. 115.
91 Ivi, p. 196.
92 Va precisato che sono presenti, nella Ragione pura, parti preziose per la comprensione complessiva del suo lavoro: non è nel 1790 che Kant sente l’esigenza di venire a capo di un sistema
filosofico, questo è stato già detto, ma già nella speculazione del 1781 sono evidenti tentativi di
connessione totale, anche se portati avanti più come idee regolative, questioni pensabili, che come fatti veri e propri, e dunque dimostrabili. La possibilità di pensare di un principio regolativo della ragione per ricondurre il molteplice ad unità è abbozzata all’interno della Critica della ragione
pura ed anticipa quel che verrà presentato, dieci anni dopo, come il principio della finalità formale
della natura nelle considerazioni della Critica del Giudizio. A proposito dell’eventuale presenza di
finalità nella natura, e in riferimento alla legge della scala continua delle creature (introdotta da
Leibniz), Kant scrive: «i gradini di una siffatta scala (per quanto possono essere dati dall’esperienza) sono troppo distanti tra loro –e le divergenze che noi crediamo piccole sono comunemente,
nella natura stessa, crepacci così larghi– che non si può affatto contare su tali osservazioni come
mezzi per rivelarci le intenzioni della natura. […] D’altra parte, il metodo di cercare un ordine nella natura in base a tale principio, e la massima di considerare un siffatto ordine come fondato in
una natura in generale […], costituiscono certamente un legittimo ed eccellente principio regolativo della ragione, che come tale, tuttavia, va troppo in là, perché l’esperienza o l’osservazione possa stargli alla pari. Tale principio, peraltro, senza determinare alcunché, addita semplicemente alla ragione la strada verso l’unità sistematica» (I. KANT, Critica della ragione pura, cit., p. 678). Più
in là si legge che «la suprema unità formale, che si fonda soltanto su concetti della ragione è l’unità delle cose, conforme a un fine: e l’interesse speculativo della ragione rende necessario il considerare ogni ordinamento del mondo, come se fosse scaturito dal disegno di una suprema ragione. Un tale principio apre infatti prospettive del tutto nuove alla nostra ragione, in quanto questa
viene applicata al campo delle esperienze: seguendo tali prospettive, la ragione può collegare le
cose del mondo secondo leggi teleologiche [la trad. it. cit. riporta erroneamente teologiche in luogo di teleologiche], e giungere così alla massima unità sistematica di tali cose» (ivi, p. 692; lo spaziato è nel testo). Non sembrano neanche esserci troppi rischi, infatti, «se ci arrestiamo a questo
presupposto, considerandolo come un principio semplicemente regolativo, neppure l’errore potrà
recarci danno. Da ciò, difatti, potrà tutt’al più seguire, che si ritrovi una connessione semplicemen-
53
di Debora Maccanti
54
Forse non è stata presa sufficientemente in considerazione la funzione che
Wittgenstein dedica nel corso di tutta la sua opera all’esame dei processi visivi ed è in vista di questo compito che procede l’analisi di questo saggio. Sin dal
Tractatus la logica è in ultima istanza uno strumento per riconoscere la perspicuità del simbolismo ed in particolare dalla seconda metà degli anni Trenta si
chiarisce l’intreccio tra vedere, interpretare, linguaggio e reazioni istintive e immediate che conducono ad una nuova concezione del linguaggio stesso. Il modo in cui Wittgenstein affronta lo studio del fenomeno del sorgere degli aspetti mette in luce che il suo obiettivo principale non è quello di criticare un’incoerente teoria della visione quanto piuttosto quello di indagare il significato della
percezione degli aspetti nel campo del linguaggio più che in quello della percezione1. Nonostante si possa parlare di un interesse per il vedere-come sin
dalla composizione del Tractatus 2 e in modo più specifico a partire dal 1935,
gli anni in cui Wittgenstein si dedica in maniera più sistematica a questi temi
sono quelli tra il 1947 e il 1948. Inizialmente, la discussione era legata alla psicologia della Gestalt 3 che Wittgenstein conosceva principalmente in relazione
alle idee di Wolfang Köhler4.
Ciò che Wittgenstein accettava della psicologia della Gestalt era la concezione secondo la quale ciò che noi percepiamo immediatamente non è un mosaico di stimoli discontinui e disorganizzati ma forme e unità strutturate5: questo significa che noi non vediamo tre punti messi in posizione triangolare, ma
i vertici di un triangolo. La concezione della visione elaborata dalla psicologia
della Gestalt si opponeva così all’approccio atomista e riduzionista secondo il
quale noi costruiamo oggetti percettivi sulla base di dati sensoriali e atomistici.
Wittgenstein non condivide però il fatto che Köhler reifichi le Gestalten trasformando una forma in un’entità mentale privata, riproponendo così quel tipo di
argomentazione che nel Libro Marrone aveva rifiutato nel corso dell’analisi del
processo che permette di vedere in un disegno una svastica che finiva per sanzionare la prevalenza della forma sul significato6: la critica di Wittgenstein era
rivolta infatti a quella concezione secondo la quale noi non vediamo lo stesso
oggetto sotto aspetti diversi ma vediamo piuttosto due oggetti visivi7, il cui significato viene loro attribuito come un’entità separata dal disegno. La proposta
di Wittgenstein è di fornire una ragione plausibile per un diverso modo di esprimersi8, in modo da evitare di parlare di due oggetti visivi diversi: per Wittgenstein non possiamo analizzare il fenomeno del cambiamento d’aspetto dicendo che noi attribuiamo un significato ad un disegno composto da linee che ci
sembrano a prima vista senza senso ma dobbiamo piuttosto riconoscere che
il significato del disegno è nel disegno e noi non attribuiamo ad esso un diverso significato, né tanto meno accade che l’immagine che noi riconosciamo vada a combaciare con una che abbiamo nella nostra mente. Per Wittgenstein, il
confronto tra ciò che vediamo e un’immagine che abbiamo nella nostra mente
non avviene neanche quando riconosciamo una persona dopo molto tempo
che non la vediamo: il riconoscimento è immediato, non si tratta né di un’immagine che si incontra con un ricordo, né del confronto di due immagini9, piuttosto, noi reagiamo, linguisticamente, a ciò che riconosciamo nell’immagine.
Quando guardiamo la fotografia di un volto, noi non vediamo solo macchie scure o chiare, ma vediamo anche l’espressione del volto e, se questo volto è sorridente, la cosa più facile da fare, è sorridere a nostra volta, più che fornire una
descrizione10.
Questa è la ragione per cui Wittgenstein critica anche l’ipotesi avanzata da
Köhler secondo la quale noi vediamo oggetti diversi in una figura o in un disegno perché cambia la loro organizzazione spaziale: questa ipotesi viene contraddetta dal fatto che se chiediamo di dipingere ciò che di diverso abbiamo visto, noi non cambiamo l’organizzazione spaziale della figura. L’errore di Köhler11 consiste nell’aver tentato di risolvere i nostri problemi concettuali riguardo al vedere con metodi sperimentali, mentre ciò che intende fare Wittgenstein
è proporre una chiarificazione filosofica dei nostri concetti; egli prende spunto
dai casi analizzati da Köhler per darne una nuova lettura in termini di tecnica
grammaticale12.
Il problema che Wittgenstein solleva a proposito della percezione degli
aspetti è il fatto che noi vediamo qualcosa di diverso anche se la figura che
stiamo guardando non è cambiata13: anzi solo se non cambia possiamo parlare di percezione continua degli aspetti. Wittgenstein rifiuta varie ipotesi quali
spiegazioni di questo fenomeno: scarta, ad esempio, l’interpretazione neurofisiologica14, secondo la quale il significato di ogni concetto visivo può essere ridotto ad un particolare processo fisiologico, in quanto essa non è in grado di
spiegare l’alternanza degli aspetti. Questo tipo di spiegazione potrebbe indicare una sequenza di aspetti ma non la loro alternanza nel senso in cui noi diciamo di vedere un complesso di segni ora come un’anatra, ora come un coniglio,
vale a dire, non è in grado di spiegare come un aspetto continuo si accompagni ad un’alternanza di aspetti: questo invece è l’elemento decisivo ed essenziale nell’argomentazione wittgensteiniana, secondo la quale l’alternanza degli
aspetti è connessa a filtri grammaticali che, sulla base di una percezione continua, costruiscono visioni alternative dell’oggetto osservato. Data la struttura
di una percezione, che è configurazione di segni, l’alternanza degli aspetti è
una sequenza di variazioni su un tema percettivo che ne costituisce il sostrato
permanente: questo significa che l’alternanza degli aspetti presuppone quella
continuità di un dato percettivo sulla base del quale soltanto l’osservatore può
dire di vedere la figura dell’anatra-coniglio ora come anatra ora come coniglio.
Tale concezione si estende dall’ambito percettivo al più vasto ambito della semantica e della grammatica filosofica; anche qui infatti ritroviamo la necessità
della continuità e permanenza di un significato primario come base, a partire
dalla quale si sviluppano svariate modulazioni nell’ambito di una sequenza di
SAGGI
L’ATTENZIONE AL VEDERE
NELLA FILOSOFIA DI WITTGENSTEIN
55
56
la percezione continua di un aspetto in contrapposizione ad una relazione interpretativa nei confronti di queste cose; il guardare un’immagine non implica
una selezione tra i molti modi di percepirla. Come per gli oggetti-immagine, la
percezione continua degli aspetti è un caso di vedere più che di conoscere grazie all’immediatezza della descrizione; l’attenzione è piuttosto sulla prontezza
della reazione che non sulla correttezza della descrizione.
L’altra ipotesi che Wittgenstein rifiuta è quella che spiega il cambiamento
con una variazione a livello di organizzazione della nostra impressione visiva18
di ciò che vediamo: questa congettura presuppone che le impressioni visive
siano entità o fenomeni interni che rassomigliano agli oggetti materiali con cui
condividerebbero le proprietà dell’organizzazione spaziale sia nel colore che
nella forma. In questo modo, la nostra relazione con il mondo esterno verrebbe ad essere mediata da una serie di copie interne di ciò che noi vediamo generate sotto l’influsso degli oggetti che percepiamo: esse sarebbero dei veri e
propri oggetti interni, già sottoposti a critica da Wittgenstein con il suo private
language argument. Se il nostro accesso al mondo fosse mediato dagli oggetti interni, questo significherebbe che la descrizione di ciò che vediamo non riuscirebbe a cogliere il significato direttamente, ma avrebbe bisogno di un’ulteriore interpretazione che conferisse significato a ciò che noi vediamo solamente come colore, forma e organizzazione spaziale; al contrario, la percezione è
una struttura verbale che incorpora un contenuto esperenziale, non inferenziale, vale a dire che non viviamo un’esperienza sensoriale distinta dall’esperienza della parola che la esprime. Un’esperienza della percezione, infatti, è coniugata con un’espressione, Äusserung, ma anche con questa precisazione rimane enigmatico il modo in cui possiamo comprendere il cambiamento d’aspetto
quando niente cambia: per questo è necessario indagare il fenomeno del sorgere degli aspetti da un altro punto di vista, rifiutando sia spiegazioni di ordine
neurofisiologico sia di cambiamento organizzativo a livello percettivo.
Il nesso concettuale tra il sorgere di un aspetto e la percezione continua di
un aspetto è testimoniata anche dal fenomeno che Wittgenstein definisce come cecità agli aspetti, vale a dire dall’incapacità di vedere un cambiamento
d’aspetto come alternanza. Colui che è cieco agli aspetti può infatti vedere prima l’anatra e poi il coniglio ma non può vedere l’alternanza19, e questo è un limite concettuale o logico, non causale: il paradosso che sorge quando noi vediamo qualcosa di diverso in qualcosa che non sembra cambiare sembra svanire se noi consideriamo il rapporto tra la percezione continua degli aspetti e il
sorgere di un aspetto. Questo modo di guardare non fa ricorso all’esistenza di
due oggetti visuali, secondo il quale noi attribuiamo significato ad un’immagine; non esiste quella duplicità che per Wittgenstein fa sorgere il paradosso in
questione. Con questa mossa, Wittgenstein ha assunto nei confronti di questo
problema lo stesso atteggiamento preso di fronte ad ogni confusione filosofica:
egli ha infatti spostato l’asse di indagine e invece di penetrare la presunta realtà nascosta dell’esperienza del sorgere degli aspetti, ha provato a considerare questa problematica nel contesto più ampio dell’analisi della tecnica grammaticale20. Le condizioni e gli aspetti che nel Tractatus risultavano indicibili e
ineffabili vengono sostituiti e rimpiazzati dalle relazioni dirette e immediate che
SAGGI
significati secondari. Queste diverse e molteplici modulazioni di quella che è
l’espressione appartenente al significato primario nella successione dei significati secondari che ne derivano è la possibilità di configurare gli usi di
un’espressione in termini di variazione. Per esemplificare l’impossibilità di dare una descrizione del fenomeno del sorgere degli aspetti basato su un’interpretazione che subentra dopo la percezione, Wittgenstein introduce gli oggetti-immagine, figure o disegni schematici, come quelli dell’anatra-coniglio, che
consentono di formulare una descrizione del fenomeno visivo in contrapposizione alle filosofie che introducono un modello interpretativo della percezione,
vale a dire che questa particolare classe di oggetti-immagine, nella loro schematicità, esemplifica il modello di una percezione del significato al di fuori di
qualunque procedura o strategia interpretativa, in termini di un’aderenza immediata al contenuto e al significato della figura. La loro introduzione, a prima vista, appare strana se si considera che il fenomeno del sorgere degli aspetti viene introdotto non in riferimento ad un oggetto-immagine ma alla somiglianza di
due volti, esempio attraverso il quale Wittgenstein introduce la distinzione tra i
due impieghi della parola vedere, il primo che ha come oggetto un oggetto, il
secondo che ha come oggetto la somiglianza e quindi una relazione15.
Gli oggetti-immagine permettono però di chiarire il fatto che una teoria della visione che pretenda di spiegare il cambiamento di aspetti su basi neurofisiologiche o in termini di cambiamento di organizzazione visiva soggettiva è
inapplicabile anche ai più comuni casi di percezione: l’elemento che Wittgenstein rifiuta di questo tipo di ipotesi è il fatto che noi saremmo costretti ad aggiungere un elemento interpretativo che conferisca senso ad un insieme di linee mentre, come ho già scritto in precedenza, vedendo un disegno noi vediamo nello stesso tempo un significato e non c’è la prevalenza di una struttura
formale precostituita rispetto al significato (come intenderebbe la Gestalt Psychologie): gli oggetti-immagine vengono introdotti proprio per saldare il legame
tra l’essere continuamente in vista di un aspetto e il suo apparire improvvisamente – come nel caso dell’alternanza anatra-coniglio16. Proprio per questo,
Wittgenstein avverte la necessità di passare dalle riflessioni sugli oggetti-immagine a quelle su immagini e disegni comuni17. Sembra che in relazione alle
immagini comuni, nel senso ordinario del termine, non sia appropriato parlare
del sorgere di un aspetto poiché per esse non sorge il problema dell’alternanza –che è specificamente introdotto dagli oggetti-immagine– e in quanto le immagini ordinarie non contengono ambiguità. Ma si può parlare del sorgere di
un aspetto, in effetti, anche in riferimento alle immagini ordinarie: esempi dell’emergenza di aspetti sono il notare che la figura di un ritratto sembra sorridere dalla parete o l’osservare che una palla raffigurata fluttua nello spazio. In
questi casi non ha luogo l’esperienza del vedere-come poiché non c’è un
aspetto dell’immagine che viene vista ora come una figura e ora come un’altra
figura in alternanza ma si tratta piuttosto dello sviluppo di un ulteriore significato immanente all’immagine stessa: in questo caso, infatti, non esprimiamo la
nostra osservazione: “Sembra che quel ritratto sorrida” con “Adesso lo vedocome” ma si può dire che nonostante la differenza di questi casi vi sia un’analogia grammaticale. Per Wittgenstein, anche in questo caso, si può parlare del-
57
58
terizzato dall’interpretazione ma è al contrario propriamente basato su reazioni primitive.
La proposta di Richard Shusterman27 è quella di rivedere criticamente l’elemento linguistico e interpretativo sullo sfondo delle reazioni immediate, riferendosi in modo particolare all’ultimo periodo della filosofia di Wittgenstein. Shusterman, pur concordando con esponenti di orientamento ermeneutico nel rifiuto di una ricerca fondazionalista, prende le distanze da essi riconoscendo
che il loro errore è quello di eguagliare il nonfondazionale con l’interpretativo e
di non tener conto del fatto che anche se tutta la comprensione è selettiva, non
tutta la comprensione selettiva è interpretativa: noi potremmo comprendere
qualcosa senza pensare affatto a questa cosa, mentre per interpretare qualcosa abbiamo bisogno di pensarci. Per questo, Shusterman28 trova in Wittgenstein un modello alternativo all’universalismo ermeneutico; secondo tale modello la comprensione, pur rimanendo di carattere linguistico, ha anche a che
fare con l’abilità, appresa tramite l’addestramento, di dare la giusta risposta in
un gioco linguistico29. In questo modo, la padronanza di un linguaggio è la padronanza di modelli di gesti e di risposte per agire effettivamente in una forma
linguistica piuttosto che la padronanza di un sistema di regole semiotiche per
interpretare i segni. Il punto in cui, per Shusterman, fallisce l’universalismo ermeneutico è quello di considerare l’interpretazione come qualcosa dalla quale
non si può prescindere mentre ciò da cui non si può prescindere è propriamente il linguaggio.
Sulla stessa linea di Shusterman30 si colloca Simo Säätelä secondo cui l’interpretazione non è una precondizione per la comprensione. L’introduzione
della discussione sulle reazioni estetiche, definite come una delle cose più importanti in relazione all’estetica, sembra trovare un parallelo nella nozione di
reazioni primitive, di cui Wittgenstein parla soprattutto nello scritto sulla causalità31. Con questa mossa, Wittgenstein propone un’alternativa sia alle diverse
forme di idealismo gnoseologistico, che hanno la tendenza a riferirsi all’esperienza interna sia all’empirismo che vorrebbe trattare i concetti come direttamente e causalmente connessi ai loro oggetti32. Lo stesso Rhees, nella prefazione all’edizione inglese del Libro Blu e Libro Marrone aveva riconosciuto che
il ricorso all’interpretazione appare necessario solo se noi non comprendiamo
l’uso del linguaggio, ad esempio quando la percezione del significato cade fuori dal suo uso33.
L’introduzione delle reazioni primitive e la loro distinzione dall’interpretazione si lega al modo in cui, per Wittgenstein, il linguaggio non è basato su un
pensiero o su un’interpretazione né emerge dal ragionamento. In polemica
con la spiegazione del linguaggio proposta da Agostino, Wittgenstein precisa34 che il linguaggio è intimamente connesso con il modo di agire e reagire
e che solo un’indagine dei fenomeni linguistici nella loro specificità dissipa la
nebbia che noi tendiamo a sollevare quando assumiamo che il significato di
una parola sia un concetto generale: è una tale assunzione a circondare il funzionamento del linguaggio di una caligine che impedisce una visione chiara.
L’accento posto sulle reazioni mira anche a saldare immediatamente il nostro
comportamento al nostro linguaggio, restituendo un’opacità che non ha però
SAGGI
gli interlocutori hanno con gli usi applicativi del linguaggio e con la stessa realtà delle cose e degli eventi che sono filtrati attraverso le tecniche grammaticali; in altri termini l’aderenza diretta e immediata che i membri di una comunità
linguistica intrattengono con il loro linguaggio è quella condizione non ulteriormente esplicabile o analizzabile in un senso analogo a quello in cui nel Tractatus non erano ulteriormente definibili e analizzabili le proprietà formali della
grammatica, del linguaggio matematico e della stessa capacità del linguaggio
di riferirsi alla realtà: se nel Tractatus il soggetto parlante proiettava una relazione logica sul mondo dei fatti, negli scritti successivi questo soggetto manifesta invece la diretta e immediata appartenenza a quell’orizzonte linguistico
che coincide con la sua forma di vita. In questo senso sussiste, sia pure nei
termini di una svolta, una simmetria tra la situazione teorica del Tractatus e
quella degli scritti successivi, ossia tra l’indicibile e l’ineffabile da un lato e i modi del vedere negli scritti composti a partire dagli anni Quaranta poiché allo
stesso modo in cui nel Tractatus è indicibile il rapporto che la proposizione ha
con il fatto che rappresenta, ora, negli scritti posteriori, vi è una diretta partecipazione in termini di esperienza vissuta, diretta e spontanea del linguaggio
che, come tale, per i suoi caratteri di spontaneità, immediatezza e di esperienza diretta dei significati non è ulteriormente esplicabile e assume pertanto i caratteri di quella che Wittgenstein definisce evidenza imponderabile.
Sin dal manoscritto indicato con il numero 14021 si trova l’espressione intransitives Verstehen, capire intransitivo22, che prefigura la distinzione tra una
comprensione interpretativa e una intransitiva, vale a dire non mediata. Ciò su
cui Wittgenstein intende richiamare l’attenzione è che esistono due modi in cui
il significato di una frase può essere afferrato: il primo consiste nell’esprimere
il significato con altre proposizioni, il secondo, al contrario, vede il significato di
una proposizione intrinsecamente legato alla propria espressione verbale23.
Wittgenstein riconosce che afferrare questa espressione significa anche cogliere un sentimento o un’emozione ad essa internamente collegato: afferrare
un simile significato è principalmente una questione di esperienza. La comprensione intransitiva è qualcosa che non rimanda ad un altro mezzo di
espressione poiché non si dà un contenuto o un significato che possa essere
separato da un particolare tipo di espressione. Il significato è interno all’espressione usata per articolarlo ed è per questo motivo che significato ed espressione sono inseparabili.
Dalle sfere del vedere e del rappresentare, Wittgenstein, attraverso un’operazione di revisione critica, esclude il concetto di interpretazione24 nel senso in
cui esso consisterebbe in una mediazione, ad opera di un soggetto, del dato
percettivo. L’interpretazione risulta così essere per Wittgenstein il contrassegno di una mitologia filosofica qualora venga intesa come elaborazione e mediazione del dato percettivo. Essa ha in effetti, per Wittgenstein, uno statuto del
tutto indipendente da quello di percezione e rappresentazione e risulta consegnata ad una classe diversa di applicazioni linguistiche consistenti nell’elaborazione di ipotesi25. Per Wittgenstein è naturale che determinati segni vengano
interpretati, ma questo non avviene ogni volta che capisco un segno26 ed in
particolare il vedere-come non viene considerato da Wittgenstein come carat-
59
60
L’importanza dell’esperienza vissuta del significato risiede nell’atteggiamento
verso il linguaggio che esso esibisce: possiamo apprezzare l’importanza dell’esperienza vissuta del significato con l’analogia istituita dallo stesso Wittgenstein tra l’esperienza del significato e l’esperienza del notare un aspetto. Attraverso le esperienze del significato, un’espressione usata in un certo modo
cambia se cambia il modo in cui essa viene impiegata: proprio come nel caso
delle immagini parliamo di una percezione continua degli aspetti, così nel caso del linguaggio parliamo di una percezione continua del significato che ci
permette di parlare della familiare fisionomia delle parole44.
Il fatto che Wittgenstein scriva che se noi ripetiamo una parola molte volte, alla fine la percepiamo come un insieme di suoni mostra che questo non è il modo normale in cui noi percepiamo la parola. Questa particolare situazione esemplifica che il nostro normale rapporto con il linguaggio è quello di percepire direttamente le parole scritte e gli elementi parlati come parole e proposizioni dotate
di significato non come semplici suoni che devono essere interpretati. Quando
percepiamo le parole e le proposizioni come già dotate di significato, ciò che noi
abbiamo è una percezione continua del significato che trova un suo analogo nella percezione continua degli aspetti. Il cieco al significato è colui che, come nel
caso delle immagini, non riesce a cogliere l’alternanza tra percezione continua
del significato e il sorgere di un nuovo significato45 o colui che non riesce, ad
esempio, a cogliere un sorriso in un’espressione sorridente46.
A proposito della percezione continua del significato, Wittgenstein enfatizza
il ruolo svolto dalla familiarità47 di una parola o di un’espressione che permette un riconoscimento immediato. Il ruolo di questa familiarità, di questa aderenza al linguaggio alla propria forma di vita assume i tratti del riconoscimento del
proprio linguaggio come di una fisionomia48. Il gioco linguistico della familiarità
e del riconoscimento fisiognomico del linguaggio è un tratto che è stato trascurato dalla maggior parte della letteratura secondaria su Wittgenstein. I concetti di riconoscimento immediato, familiarità, aderenza fisiognomica al linguaggio
non sono termini che si possono confondere con la percezione diretta perché
l’immediatezza di queste percezioni esprime la profonda assimilazione dell’organizzazione di un gioco linguistico: è come se la posizione di una parola nel
campo linguistico fosse stata assorbita nella propria fisionomia49, costituita non
solo da elementi linguistici50.
L’introduzione della nozione di familiarità51 fa parte della revisione critica di
quella concezione metafisica ed essenzialistica propria della tradizione filosofica che pretendeva di individuare nelle relazioni tra le componenti di
un’espressione linguistica oppure nel rapporto tra un enunciato e la realtà una
relazione di tipo essenziale e intrinseco che Wittgenstein contrassegna con
l’espressione passen zu, vale a dire con il convenire 52, che ora Wittgenstein rilegge in termini di familiarità. Contro l’atteggiamento essenzialista, Wittgenstein oppone il suo punto di vista esternalista in base al quale non possiamo
parlare di un rapporto intrinseco tra le componenti di un apparato linguistico o
tra le parole e le cose. Come emerge con chiarezza da un testo basato sugli
appunti di Wittgenstein con il Circolo di Vienna, pubblicato recentemente con il
titolo di Voices of Wittgenstein 53, Wittgenstein tematizza questa forma di ester-
SAGGI
connotazione negativa. Le reazioni, sebbene primitive, non sono pre-linguistiche, ma possono essere comprese solo all’interno di un gioco linguistico: Peter Winch osserva che, anche se abbiamo delle reazioni pre-linguistiche, solo un gioco linguistico può fornire la giusta cornice per comprendere una simile reazione35.
Primitivo è un termine relativo; tali reazioni sono considerate primitive dal
punto di vista di un particolare gioco linguistico36. Come già Winch aveva sostenuto, anche Säätelä precisa che le reazioni spontanee, come ad esempio
commuoversi durante una rappresentazione teatrale, possono essere comprese solo all’interno di una cultura che mette in scena la musica e apprezza un
determinato tipo di espressione artistica: per questo, anche se il pianto preso
in se stesso è una reazione primitiva, l’oggetto verso cui si ha una determinata reazione è comprensibile solo all’interno di una cultura specifica37.
Parlare di reazioni primitive significa dire che esse forniscono quel livello
primario che non è suscettibile di spiegazioni o di interpretazioni. La reazione
al dolore di un’altra persona presuppone il gioco-linguistico del comportamento del dolore: la situazione è vista sotto l’aspetto della sofferenza, ed è questo
che rende la situazione intelligibile38 nel senso che anche se le reazioni in sé
non sono necessariamente linguistiche il nostro riconoscerle come reazioni
presuppone il contesto di un gioco linguistico39. Le reazioni primitive, i fatti della nostra storia naturale come vengono indicati da Wittgenstein, ci inducono a
riconoscere che il linguaggio40 non deriva da una riflessione intellettuale41.
Se il vedere-aspetti è legato alle reazioni primitive, emerge un rapporto di
aderenza tra il soggetto linguistico e la figura osservata che Wittgenstein sviluppa nei termini di familiarità e di fisionomia. Il processo che avviene nella
comprensione di una proposizione è lo stesso che avviene nell’intendimento di
un’immagine: in entrambi i casi, scrive chiaramente Wittgenstein a partire dagli anni Trenta, non si tratta di un problema di interpretazione ma di vedere
qualcosa di differente. Le riflessioni che Wittgenstein opera nell’ambito del percepire aspetti sono importanti perché sono, come già in parte ho cercato di far
vedere, legati al modo in cui egli concepisce il linguaggio42. Sostenere che un
processo psicologico non determina il significato di una parola non vuol dire
non tener presente ciò che Wittgenstein indica come esperienza vissuta del significato, espressione di cui Wittgenstein inizia a parlare nelle Ricerche subito
dopo aver esposto il suo argomento contro il linguaggio privato: questo testimonia il carattere positivo dell’espressione esperienza vissuta del significato e
il suo ruolo diverso giocato all’interno della filosofia di Wittgenstein. Attraverso
l’esperienza vissuta del significato, Wittgenstein mostra da un lato di recepire
le componenti sensoriali, percettive e affettive, mentre dall’altro estende questa dimensione all’interno della grammaticalizzazione dell’esperienza esprimendo il modo in cui un affetto o un’esperienza sono vissuti insieme alle parole che le esprimono. Un’esperienza psicologica o sensoriale intesa nei termini
delle filosofie di tipo mentalistico ossia in termini di un processo occulto, non
fornisce alcuna comprensione circa il significato di una parola, mentre la nozione di esperienza vissuta del significato esprime un’esperienza sensoriale insieme all’esperienza dell’espressione linguistico-concettuale che la comunica43.
61
62
renza diretta, familiarità, esperienza vissuta del significato e simili, le espressioni linguistiche non risultano più sostituibili tra loro58. Il linguaggio non è un
insieme di parole e proposizioni che noi incontriamo nel mondo ma si situa all’interno di una forma di vita. Attraverso l’indagine del sorgere degli aspetti,
Wittgenstein ha voluto manifestare l’atteggiamento umano verso le parole e le
immagini, anziché elaborare una teoria della visione59.
Il problema di Wittgenstein è in realtà il problema del riconoscimento che è
indubbiamente legato alla familiarità. Alcuni metodi di proiezione sono più familiari di altri60 allo stesso modo in cui chi legge, ascolta o pronuncia una proposizione in una lingua che gli è familiare percepisce le parole in modo totalmente differente da chi le ascolta in una lingua a lui sconosciuta61: imparando
ad usare una parola, noi impariamo a collegare ad essa un determinato sentimento e ad averne una determinata impressione, in modo tale che la comprensione consiste proprio nell’esperire un’espressione che viene in questo modo
ad incidere sulla mia vita62. Nondimeno, la non-familiarità è un atteggiamento
attraverso il quale dobbiamo passare per raggiungere lo stato di familiarità: ciò
a cui Wittgenstein è interessato è proprio il processo che permette di passare
dallo stato di non familiarità a quello di familiarità63 o in altre parole ciò che permette il riconoscimento. Grazie alla nostra aderenza al linguaggio, noi riusciamo a trovare una serie di tratti comuni che ci permettono di passare da una situazione di novità a una di familiarità. Da qui deriva l’importanza che Wittgenstein attribuisce ai casi intermedi sia per quanto riguarda il riconoscimento sia
per quanto riguarda la rappresentazione perspicua: ciò che è necessario sottolineare è che perché questo processo avvenga e produca conoscenza, noi
non dobbiamo sapere a priori il tipo di connessioni e di somiglianze che intendiamo seguire ma esse vengono create proprio grazie alla flessibilità del linguaggio. In altre parole, possiamo riconoscere ciò che è comune solamente in
base alla nostra capacità di riuscire a vedere che non implica un rimando ad
una teoria ma deve piuttosto la propria forza all’immediatezza (nel senso di
pregnanza) della visione. Sia il riconoscimento che la familiarità hanno a che
fare con quel carattere di intimità che avvertiamo quando comprendiamo qualcosa anche se non siamo in grado di indicare o afferrare il modo particolare in
cui questo processo avviene. Questo non significa affatto, come ho accennato
più volte, che Wittgenstein ricorra a oscure spiegazioni per affrontare i fenomeni cui è interessato, ma vuol dire piuttosto essere coscienti di un certa opacità
con cui la nostra comprensione del mondo deve convivere e che è dovuta proprio alla familiarità che noi sviluppiamo con il linguaggio.
Per Wittgenstein il vedere, videre e il sapere, wissen sono profondamente
imparentati, entrambi hanno un significato primitivo64: Io so è infatti simile a Io
vedo nel senso che ciò che io so è una proiezione nell’occhio e nella coscienza della percezione di un processo esterno ma questo tipo di proiezione mostra la rappresentazione che ci facciamo del sapere e non ciò che sta a suo
fondamento. Inoltre, la nozione di fondamento per Wittgenstein non ha carattere ontologico ma è qualcosa che, al pari del resto del linguaggio, ci viene insegnato65. Il sapere è affine ad una decisione66 ed è concepibile solo all’interno di un gioco linguistico67. Questo deve indurre a riflettere sulla natura uma-
SAGGI
nalismo per cui le relazioni cui ho appena fatto riferimento sono costruite da
una tecnica grammaticale: gli aspetti di essenzialità sono, in realtà, solo manifestazioni della familiarità che ha un interlocutore con l’apparato del proprio linguaggio e non hanno la loro origine in un fondamento metafisico o essenzialista. Nei termini della familiarità, Wittgenstein spiega l’alone metafisico generato dall’apparente e presunto convenire di una cosa all’altra.
Concetti e termini quali esperienza vissuta del significato, aderenza e familiarità non contraddicono quanto Wittgenstein aveva scritto contro il linguaggio
privato né introducono di nuovo elementi psicologistici: queste espressioni
esprimono piuttosto l’assorbimento da parte degli appartenenti alla comunità
linguistica del linguaggio come forma di vita, come insieme di contesti e circostanze simbolici ed extra-simbolici nei quali si esprime l’applicazione del linguaggio. Con i concetti di esperienza vissuta del significato e di aderenza alla
parola, Wittgenstein non ha voluto psicologizzare i processi linguistici ma ha
mostrato come il soggetto sia partecipe del linguaggio inteso come una certezza vivente54.
Wittgenstein lega le osservazioni sulla percezione degli aspetti alla riflessione sul significato primario e secondario di una parola proprio perché il significato secondario presuppone familiarità con il significato primario. Il senso secondario non illumina il senso primario perché io posso dire di considerare il
mercoledì come un giorno grasso senza spiegare il significato di grasso in relazione a mercoledì, allo stesso modo in cui posso considerare il martedì magro senza illuminare con questa espressione i due termini fondanti. Inoltre non
ci sono altre parole che potrebbero esprimere le mie inclinazioni in un contesto specifico: è proprio la parola con la sua familiarità che può esprimere ciò
che intendo. Dalla discussione sul significato primario e secondario emerge
che per Wittgenstein il nostro attaccamento alle parole, la nostra tendenza ad
assimilarle, è come l’acquisizione di una seconda natura: le reazioni pre-linguistiche che sono una parte della natura umana formano la precondizione per
l’organizzazione e l’apprendimento del linguaggio, ma l’acquisizione delle forme linguistiche modella questa natura e permette reazioni linguistiche dirette,
possibili solo grazie alla padronanza delle tecniche grammaticali. Così, il cieco
agli aspetti che non riesce a cogliere il rapporto di alternanza tra significato primario e secondario manca di questa immediatezza di reazioni linguistiche. Il
cieco agli aspetti non riesce ad assimilare il linguaggio, è alienato da esso, e
per questo è condannato ad un impoverimento della sua vita; manca di quella
seconda natura che il linguaggio conferisce agli uomini.
In più, l’idea che le parole abbiano una fisionomia mette in crisi la concezione della parola come strumento; considerare la parola come uno strumento implica la sua sostituibilità55 mentre, se consideriamo la parola come un gesto,
come aderente al suo significato non possiamo accettare l’idea che una parola possa essere sostituita56: le parole non solo hanno un significato, ma anche
un’anima ed è per questo che le parole non sono sostituibili57. In realtà, nella
prima parte delle Ricerche, centrata sulla nozione di prassi e di applicazione
del linguaggio, le parole hanno un’effettiva sostituibilità tra loro, mentre nella
seconda parte, con l’emergenza dei temi del linguaggio come fisionomia, ade-
63
Note
64
1 Cfr. S. MULHALL, On Being in the World. Wittgenstein and Heidegger on Seeing Aspects, Routledge, London and New York 1990, p. 4: “Wittgenstein’s investigation of aspect perception is designed to illuminate much more than a bizarre type of visual experience: in reality, it highlights what
is distinctively human about human behaviour in relation to things in the world, what it is that distinguishes human practical activity from that automata”.
2 Alla proposizione 5.5423 del Tractatus, Wittgenstein scrive a proposito del percepire il cubo
di Necker in due modi differenti, a seconda delle relazioni che stabiliamo tra le diversi parti e che
ci fanno vedere due fatti diversi. Nei Quaderni, in data 9.11.14, scrive, in relazione a questa proposizione: “Vexierbilder und das Sehen von Sachverhalten”, MS 102 24r.
3 Köhler ricorda come fin dai tempi di Goethe il sostantivo “Gestalt” abbia due significati: oltre
alla connotazione di forma o foggia quali attributi di cose, esso ha anche il significato di una concreta entità per se stessa, che fra le proprie caratteristiche abbia o possa avere una forma.
4 Nel manoscritto indicato con il numero 135, Wittgenstein scrive giornalmente osservazioni
sulla filosofia della “Gestalt” di Köhler.
5 Cfr. W. KÖHLER, La psicologia della Gestalt, Feltrinelli, Milano 1961, p. 84: “l’esperienza sensoriale non è né un mosaico di fatti puramente locali nel senso che ogni punto di un corpo sensoriale non dipende esclusivamente dal suo stimolo locale. Essa sembra piuttosto l’espressione di
una credenza a priori in quella che deve essere la natura delle cose nonostante l’esperienza del
contrario”. L’inizio della filosofia della “Gestalt” è stato segnato da Max Wethmeir che criticò la teoria dell’esperienza sensoriale.
6 Cfr. MS 134 59; TS 229 391; TS 245 281; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia
della psicologia, Adelphi, Milano 1990, I, § 869: “è –contrariamente all’opinione di Köhler– proprio
un significato quello che vedo”; cfr. Köhler, La psicologia della Gestalt, cit., p. 96, cfr. anche P. T.
Geach, Wittgenstein’s Lectures on Philosophy of Psychology, 1946-7, notes by P. T. Geach, K. J.
Shah and A. C. Jackson, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf 1988, pp. 102, 333; cfr. anche L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sui colori, Einaudi, Torino 1981, I, § 39: “io non dico (come fanno gli psicologici gestaltisti) che l’impressione del bianco si origina in questo e quest’altro modo.
Piuttosto, la questione è esattamente questa: quale sia il significato di questa espressione, la logica del concetto”.
7 Cfr. W. KÖHLER, La psicologia della Gestalt, cit., pp. 61, 77.
8 Cfr. MS 135 49; TS 229 430; TS 245 307; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia
della psicologia, cit., I, § 1035: “se uno non riconosce il Mediterraneo sulla cartina nel caso sia colorato in maniera diversa, questo non vuol dire che qui si ha davvero di fronte un oggetto visivo diverso. (L’esempio di Köhler) –pp. 122ss– Questo potrebbe al massimo fornire una ragione plausibile per un determinato modo di esprimersi. Non è proprio la stessa cosa dire: Ciò mostra che qui
si vedono realmente due cose diverse e In queste circostanze sarebbe meglio parlare di due diversi oggetti visivi”.
9 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, cit., I, § 1041: “Nel riconoscere una persona dico: Ora vedo –I lineamenti sono gli stessi, solo che…– e qui segue una descrizione dei mutamenti di fatto avvenuti. –Immaginati che uno dica: Il viso è più pieno di un tem-
po– dovrei dire che è una peculiarità dell’immagine visiva, dell’impressione visiva, a mostrarmi che
è così? Senza dubbio si dirà: No; qui un’immagine si incontra con un ricordo. Ma come fanno a incontrarsi? Certo – è come se qui venissero messe a confronto due immagini. Ma non sono due
immagini ad essere messe a confronto; e se lo fossero, bisognerebbe pur sempre averne riconosciuta una come l’immagine del volto quale era in passato”. Cfr. anche TS 310 132; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Libro Blu e Libro Marrone, Einaudi, Torino 2000, p. 207.
10 Cfr. MS 135 91; TS 229 441; TS 245 315; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, cit., I, §§ 1072, 73.
11 Cfr. W. KÖHLER, La psicologia della Gestalt, cit., p. 117; in queste pagine si parla di un cambiamento di visione in relazione ad cambio di organizzazione.
12 Cfr. J. SCHULTE, Wittgenstein: an introduction, State University of New York Press, Albany
1992, pp. 75-85.
13 Il modo in cui Wittgenstein si esprime a proposito del notare un aspetto è il seguente: „ich betrachte ein Gesicht, auf einmal bemerke ich seine Ähnlichkeit mit einem andern. Ich sehe dass es
sich nicht geändert hat; und sehe es doch anders. Diese Erfahrung nenne ich Das Bemerken eines
Aspekts“; MS 144 38; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 19993, p. 255.
14 A proposito del modo in cui Wittgenstein considerava la possibilità di una spiegazione fisiologica nell’ambito del sorgere degli aspetti, riporto qui alcune citazioni: L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, cit., I, § 989: “supponiamo che certi aspetti si possano spiegare in base al movimento degli occhi: questo allora vorrebbe dire che essi sono di natura puramente ottica; e quindi dovrebbe esserci un modo di descriverli che non ha bisogno di servirsi delle analogie tratte da altri campi. Allora in luogo di: Vedilo come…! si dovrebbe poter impartire l’ordine:
Lascia vagare lo sguardo così e così o qualcosa del genere”; cfr. anche § 990. Anche se al § 997
Wittgenstein scrive: “non c’è dubbio che spesso si evoca un aspetto con un movimento degli occhi, dello sguardo”; al § 1012 annota: “[…] la spiegazione fisiologica all’inizio è apparentemente un
aiuto, ma poi si dimostra un mero catalizzatore dei pensieri. Io la introduco soltanto per liberarmene immediatamente”. Ancora a proposito di una spiegazione fisiologica, Wittgenstein scrive: “Se si
pensa a delle correnti sulla retina (o a cose del genere) si vorrebbe dire: Dunque l’aspetto viene
visto tanto quanto la forma e il colore. Ma questa ipotesi come potrebbe esserci d’aiuto nel raggiungere una convinzione simile? Ebbene, essa favorisce la tendenza a dire che qui non vedremmo due differenti strutture, Gebilde. Ma se questa tendenza dev’essere fondata, il suo fondamento lo devo trovare altrove”; I, § 1024. L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia della psicologia,
cit., I, § 1031: “non è curioso che nel descrivere un’impressione visiva accada davvero raramente
di far riferimento anche al modo in cui vaga lo sguardo? Se poi l’oggetto è piccolo, se si tratta, ad
esempio, di un volto, non lo si vede quasi per niente, benché anche in questo caso lo sguardo sia
costantemente in movimento”. Wittgenstein, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, cit., I,
1038: “considerazioni di tipo fisiologico qui confondono e basta. Perché aggirano il problema logico, concettuale”. Sullo stesso tema, I, § 1063.; I, §§ 1116-1126.
15 Cfr. MS 144 38; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., p. 255.
16 Cfr. MS 144 40-1; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., p. 257.
17 MS 114 52; MS 144 135b: „wie wäre diese Erklärung: Ich kann etwas als das sehen, wovon
es ein Bild sein kann? Das heißt doch: Die Aspekte im Aspektwechsel sind die, die die Figur unter Umständen ständig in einem Bild haben konnte“; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche,
cit., p. 265.
18 Cfr. MS 144 42-3; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., p. 259.
19 Cfr. MS 144 74-5; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., p. 280: “sorge ora la domanda: è possibile che esistano uomini privi della facoltà di vedere qualcosa come qualcosa –e come starebbero le cose in questo caso? […] Chiamiamola cecità per l’aspetto– e cerchiamo di vedere che cosa di potrebbe intendere con quest’espressione. (Un’indagine concettuale). Colui che è
cieco per l’aspetto non vedrà il mutamento dell’aspetto C. Ma non dovrà neppure riconoscere che
la doppia croce contiene una croce bianca e una nera? Dovrà non essere in grado di venire a capo del compito: Mostrami, tra queste figure, quelle che contengono una croce nera? No. Questo sarà in grado di farlo, ma non dirà ora è una croce nera su sfondo bianco”; cfr. anche MS 135 179; TS
232 611; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, cit., II, § 42.
20 Cfr. S. MULHALL, Inheritance and Originality. Wittgenstein, Heidegger and Kierkegaard, Clarendon Press, Oxford 2001, p. 158.
SAGGI
na della conoscenza e sul fatto che sapere e sicurezza appartengono a due
categorie diverse68: la sicurezza dell’uomo si riferisce solo al suo atteggiamento69. La confusione che noi facciamo tra la parola sicurezza e la parola sapere
è ciò che ci induce ad essere stregati dalla parola sapere70. Ciò su cui non discutiamo, come ad esempio le proposizioni matematiche, è ciò che è stato
considerato come un perno della discussione cui, per così dire, è stato apposto il marchio dell’incontestabilità71.
65
66
that people may have before they learn to talk; however, the language-games, a ‘primitive form’ of
which we see in those reactions, provide the framework within which we identify in the first place
the reactions of which we speak. Only thus are we able to make the distinctions between them
which we need and which would be indiscernible, would indeed make no sense, if wider context of
the language-game were not presupposed”.
36 Cfr. P. WINCH, Discussion of Malcolm’s Essay, cit., p. 123; J. SCHULTE, Experience and expression. Wittgenstein’s Philosophy of Psychology, Clarendon Press, Oxford 1993, p. 53.
37 Cfr. S. SÄÄTELÄ, Aesthetics as Grammar. Wittgenstein and Post-Analytic Philosophy of Art,
cit., p. 189: “so if someone cries at an opera, his reaction is only intelligible in a culture which has
the practice of performing arts and music. It should be clear that such reaction presuppose certain
kinds of background knowledge and competence. This also makes them essentially contextual.
The crying in itself is a primitive reaction. However, the object of the reaction is not ‘primitive’ in the
same sense”.
38 L. HERTZBERG, Primitive Reactions – Logic or Anthropology?, in Midwest Studies in Philosophy, XVII, 1992, pp. 24- 39, p. 33.
39 IVI., p. 30; cfr. anche MS 114 209; MS 145 53; TS 228 154; TS 233a 49; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Zettel, cit., § 234.
40 Cfr. E. MACH, Conoscenza ed errore. Abbozzi per una psicologia della ricerca, Einaudi, Torino 1982, p. 130: “si impara a parlare e a capire la lingua come si impara a camminare”.
41 Cfr. J. E. EDWARDS, Ethics without Philosophy. Wittgenstein and Moral Life, University Presses of Florida, Fort Meyers 1982, 1985, PP. 197-8: “in this passage –Edwards si riferisce al § 244
delle Ricerche Filosofiche– we can again see the deep roots of private language in the picture of
rationality-as-representation. Confronted with Wittgenstein’s possibility, the interlocutor’s question
–So ‘pain’ means crying?– elegantly reveals his controlling assumption that language always means something, i. e., that it is always a re-presentation of something else: a fact, a state of mind.
Since language-thought is always representation, sensation language must be talk about sensations, reports of the inner landscape. But in Wittgenstein’s image language can present as well represent, and sensation language can be seen as a way to present to others the reality of one’s
pain”.
42 Cfr. S. MULHALL, On Being in the World. Wittgenstein and Heidegger on Seeing Aspects, cit.,
p. 35: “all the conceptual distinctions I have been highlighting in the realm of general relationship
towards pictorial symbols find an analogous application in the field of attitudes towards linguistic
symbols – towards language in general”.
43 Cfr. ivi, pp. 37-8.
44 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., p. 286.
45 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, cit., I, §§ 1102-7.
46 Cfr. ivi, I, § 1103.
47 Cfr. S. MULHALL, Inheritance and Originality. Wittgenstein, Heidegger and Kierkegaard, cit.,
pp. 165-6.
48 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, I, § 568: “il significato: una fisionomia”.
49 Cfr. S. MULHALL, On Being in the World. Wittgenstein and Heidegger on Seeing Aspects, p.
42.
50 MS 131 139; MS 144 16; TS 229 265: TS 245 195: “jedes Wort –möchte man sagen– kann
zwar in verschiedenen Zusammenhängen verschiedenen Charakter haben, aber es hat doch immer einen Charakter –ein Gesicht. Es schaut uns doch an.– Man konnte sich ja wirklich denken,
jedes Wort sei ein kleines Gesicht, das Schriftzeichen könnte ein Gesicht sein. Und man könnte
sich auch denken, dass der ganze Satz eine Art Gruppenbild wäre, so dass der Blick der Gesichter
eine Beziehung zwischen ihnen hervorbrachte und das Ganze also eine sinnvolle Gruppe gäbe. –
Aber worin besteht die Erfahrung, dass eine Gruppe sinnvoll ist? Und wäre es zum Verwenden des
Satzes notwendig, dass man ihn so als sinnvoll empfindet?“; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, cit., I, § 322.
51 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., I, § 336: “un uomo politico francese scrisse
una volta che è una peculiarità della lingua francese che le parole siano collocate nello stesso ordine in cui vengono pensate”. Cfr. anche L. WITTGENSTEIN, Libro Blu e Libro Marrone, cit., p. 189.
52 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., I, § 216.
53 Baker (2003).
SAGGI
21 Il manoscritto indicato con il numero 140, Grosses Format, è stato composto all’incirca nel
1934 ed è stato pubblicato con il titolo di Grammatica Filosofica.
22 Cfr. MS 140 35; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Grammatica filosofica, La Nuova Italia, Firenze 1990,
p. 44.
23 Secondo Jörg Zimmerman il tipo di comprensione che rimanda solamente alla propria
espressione verbale è il tipo di comprensione cui fa riferimento tutta l’opera di Wittgenstein per
esprimere la relazione tra linguaggio e mondo; cfr. J. ZIMMERMAN, Sprachanalytische Äesthetik. Ein
Überblick, Frommann-Holzboog GmbH & Co, Stuttgart 1980.
24 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Libro Blu e Libro Marrone, Einaudi, Torino 1983, 2000. p. 8: “ora tu potresti domandare: interpretiamo noi le parole prima d’obbedire all’ordine? E in alcuni casi troverai
che tu fai qualcosa che potrebbe chiamarsi: interpretare prima d’obbedire; in altri casi no”.
25 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., p. 279: “è proprio vero che ogni volta vedo
qualcosa di diverso, o invece non faccio altro che interpretare in maniera differente quello che vedo? Sono propenso a dire la prima cosa. Ma perché? – Interpretare è pensare, far qualcosa; vedere è uno stato. Ebbene, i casi in cui interpretiamo sono facilmente riconoscibili. Quando interpretiamo facciamo ipotesi che potrebbero anche dimostrarsi false”.
26 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Grammatica filosofica, cit., p. 13: “accade naturalmente che io interpreti segni, dia ai segni un’interpretazione: ma certamente non ogni volta che capisco un segno! (Se
mi si chiede Che ora è?, in me non ha luogo nessun lavoro di interpretazione, semplicemente reagisco a quel che vedo e odo. Se uno mi sguaina un coltello in faccia non gli dico? Lo interpreto come una minaccia)”.
27 Cfr. R. SHUSTERMAN, Beneath Interpretation, in Hiley D. R., Bohman J., Shusterman R. (eds.),
The Interpretative Turn: Philosophy, Science, Culture, Ithaca, Cornell University Press 1991, p.
104. Shusterman precisa anche che la sua posizione è contraria a quella di Susan Sontag dal momento che in Against Interpretation, il suo attacco all’interpretazione non è diretto contro l’interpretazione stessa ma contro l’interpretazione nell’ambito dell’arte. Per Shusterman la critica che Sontag dirige all’interpretazione è normativa, non prende in considerazione il fatto che può esserci una
conoscenza non interpretativa. Questo è invece l’obiettivo che si prefigge Shusterman.
28 Ivi, p. 116: “Linguistic understanding is a matter of being able to make the right responses
or moves in the relevant language-games, and where such ability or language acquisition is first
gained by brute training or drill”.
29 Cfr. MS 136 135b; TS 212 690; TS 233b 10: „die Grundlage jeder Erklärung ist die Abrichtung. (Das sollten Erzieher bedenken)“; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Zettel, Einaudi, Torino 1986, §
419.
30 Sulla stessa linea di rivalutazione dell’immediato si colloca anche David Best, cfr. D. BEST,
Feeling and Reason in the Arts, George Allen & Unwin, London 1985 e F. Coleman, cfr. F. J. COLEMAN; A Critical Examination of Wittgenstein’s Aesthetics, in American Philosophical Quarterly, v.
5, n. 4, October 1968.
31 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Cause and Effect: Intuitive Awareness, in Philosophia, vol. 6, nos. 3-4,
pp. 409-425, September-December 1976.
32 Cfr. S. SÄÄTELÄ, Aesthetics as Grammar. Wittgenstein and Post-Analytic Philosophy of Art,
Uppsala University 1998, p. 138.
33 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Libro Blu e Libro Marrone, cit., pp. LXIV- LXVI: “si penserà ancora che
ciò che sia linguaggio debba significare qualcosa a me. E così via. E per questa ragione (per comprendere quali fossero queste difficoltà) era necessario per Wittgenstein addentrarsi (così come
egli fece) in tutta la complessa questione del vedere in qualcosa qualcosa”.
34 MS 115 80; MS 142 46 (1 nov. 1936); TS 220 3; TS 227a 8; TS 227b 8; TS 239 3 (1 jan.
1942): “wenn man das Beispiel im §1 betrachtet, so ahnt man vielleicht, in wiefern der allgemeine
Begriff der Bedeutung der Worte das Funktionieren der Sprache mit einem Dunst umgibt, der das
klare Sehen unmöglich macht. – Es zerstreut den Nebel, wenn wir die Erscheinungen der Sprache an primitiven Arten ihrer Verwendung studieren, in denen man den Zweck und das Funktionieren der Wörter klar übersehen kann. Solche primitive Formen der Sprache verwendet das Kind,
wenn es sprechen lernt. Das Lehren der Sprache ist hier kein Erklären, sondern ein Abrichten“; tr.
it, L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., I, §5.
35 Cfr. P. WINCH, Discussion of Malcolm’s Essay, in N. Malcolm, Wittgenstein: A Religious Point
of View?, Routledge, London 1993, p. 124: “it is perfectly true that we are speaking of reactions
67
55
56
178.
68
Cfr. L. WITTGENSTEIN, Ricerche filosofiche, cit., p. 18.
Cfr. ivi, I, §§ 508; 530-2.
S. MULHALL, Inheritance and Originality. Wittgenstein, Heidegger and Kierkegaard, cit., p.
57 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Grammatica filosofica, cit., p. 35: “nessuna parola può essere sostituita da un’altra in base all’effetto che ha; così non si può sostituire un gesto con un altro. (La parola ha un’anima, non semplicemente un significato). E nessuno mai crederebbe che una poesia rimanga essenzialmente immutata quando, in seguito a un’opportuna convenzione, alle sue parole
se ne sostituiscono altre”.
58 Cfr. S. MULHALL, Inheritance and Originality. Wittgenstein, Heidegger and Kierkegaard, cit.,
pp. 178-9.
59 Cfr. ivi, pp. 178-82.
60 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Osservazioni sulla filosofia della psicologia, cit., p. 109: “si dice che le
cose sono simili in base a qualche regola di proiezione; ma alcune regole di proiezione sono più
familiari di altre”.
61 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Grammatica filosofica, cit., p. 24: chi legge una proposizione in una lingua che gli è familiare, sente in modo completamente differenti le parole delle differenti specie.
62 Cfr. ivi, pp. 30-1.
63 Cfr. in part. TS 310 77-85 ss.; tr. it., L. WITTGENSTEIN, Libro Blu e Libro Marrone, cit., pp. 164-7.
64 Cfr. L. WITTGENSTEIN, Grammatica filosofica, cit., § 90.
65 Cfr. ivi, § 449: “qualcosa ci deve essere insegnato come fondamento”.
66 Cfr. ivi, § 362.
67 Cfr. ivi, § 560: “e il concetto di sapere è accoppiato con quello di gioco linguistico”.
68 Cfr. ivi, § 308: “sapere e sicurezza appartengono a categorie differenti. Non sono due stati
d’animo come, per esempio, congetturare ed essere sicuri. […] ora quello che ci interessa non è
l’essere sicuri ma il sapere. Cioè, c’interessa che a proposito di certe proposizioni empiriche non
possa esserci alcun dubbio se, in generale, un giudizio sia possibile. Oppure anche: Sono disposto a credere che non tutto quello che ha la forma di una proposizione empirica sia una proposizione empirica”.
69 Cfr. Ivi, § 404.
70 Cfr. Ivi, § 435.
71 Cfr. Ivi, § 655: “sulla proposizione matematica è stato impresso, per così dire ufficialmente,
il marchio dell’incontestabilità. Vale a dire: Potete pure andarvene a discutere di altre cose! Questa sta ben salda. È un perno, intorno al quale può ruotare la vostra discussione”.
IL PENSIERO COMPOSITIVO DI BEETHOVEN
VADEMECUM PER UN ASCOLTO CONSAPEVOLE
DEGLI ULTIMI QUARTETTI PER ARCHI
di Silvio Paolini Merlo
Avvertenza da leggersi come premessa
Questi appunti sulla musica dell’ultimo Beethoven si basano su almeno due
convinzioni di fondo: da un lato, che quello musicale non è in nessun caso un
linguaggio asemantico, sprovvisto di suoi percorsi di senso, significante solo
sul piano formale e scritturale, come creduto in genere dagli analisti di scuola
semiologica e fenomenologica, e dall’altro, che esso non possiede nemmeno
uno statuto oracolare tale che, per via estatico-ascetica, rinvii a valori ineffabili trascendenti il fatto musicale, come immaginano gli ermeneutici e in generale gli spiritualisti variamente antistoricisti. Secondo chi scrive la musica è sempre stata il risultato concreto, fabbrile, di una pratica sociale determinata. Dallo stornello popolare alle sinfonie di Beethoven i suoni hanno uno statuto indissolubilmente antropico e antropologico, che rinvia alla storia della cultura e degli usi locali. Ciò evidentemente non comporta che essi non abbiano significato: una partitura o uno strumento musicale, così come un’incudine o un martello, non hanno molto significato se visti nella loro immediatezza fenomenologica, ma ne hanno invece moltissimo se visti nella prospettiva di chi li adopera, di chi li pone in atto, poiché nel loro impiego essi sono e insieme non sono
(semplicemente) strumenti. In effetti non si è sempre prestata la giusta attenzione, forse neppure in tempi recenti, a quanto ogni prodotto, ogni fatto o evento culturale includa ab intra, in maniera più o meno diretta, non tanto metodi
tecniche o codici, ma uomini, individualità storiche personali, e quindi come
ogni sorta di riflessione sulla cultura non sia altro che esistenza. Se tuttavia è
abitudine diffusa sostenere che la musica sia “umana”, non è purtroppo egualmente usuale dire che essa vada interamente risolta nell’uomo, che in essa
nient’altro vi sia da cercare all’infuori dell’uomo. Se pare logico risalire dal linguaggio adottato ai suoi codici impliciti, alla sua grammatica e sintassi, non è
purtroppo egualmente logico considerare la lingua in funzione di una poetica
che la racchiude e la plasma. Ciò nasconde sempre lo stesso tipo di errore:
quello di considerare l’idioma ma non il soggetto che lo parla (o che lo ascolta), l’opera ma non l’autore (o il fruitore), il “verbo” ma non l’individuo (la coesistenza fra noi e chi ha scritto).
Potrà perciò apparire naturale concludere che Beethoven, scrivendo, ragioni non diversamente da Goethe o da Shakespeare, o che narri di storie e di miti proprio come Omero e Platone. La realtà, chiaramente, è più complessa:
egli, come ogni altro artista, non dice solo per mezzo del linguaggio con cui si
esprime ma anche per mezzo dei criteri e delle scelte operative di cui si avva-
NOTE
54
69
70
dell’incipit della Nona Sinfonia, e così via. Percorrerla porterebbe inevitabilmente a svilire il principio di libertà proprio di ogni linguaggio artistico, un principio al quale Beethoven si è attenuto come pochi altri. Perciò in questi appunti non si esporranno risultati “oggettivi”, descrittivi o argomentativi, né si proporranno tesi o ipotesi di esegesi scritturale. Ci si limiterà a fornire, all’uditore comune, alcune possibili chiavi di accesso delle quali servirsi.
Quartetto in Si bemolle maggiore, Op. 133 detto “Grande Fuga”
(estate - autunno 1825)
L’ultimo gruppo dei quartetti di Beethoven non rappresenta, come talvolta
si è detto, il risultato di un unico fiotto creativo. Al contrario, sul piano estetico, esso andrebbe suddiviso a sua volta in due sottogruppi distinti, appartenenti a due fasi di lavoro profondamente differenti e, almeno per alcuni aspetti, diametralmente contrapposte. Premesso che i quartetti sono sei, e non cinque come per lo più viene affermato, in essi è possibile riconoscere –per così dire “a orecchio nudo”– un primo gruppo di composizioni più poeticamente
uniformi e unitarie, che sono d’impianto ancora relativamente settecentesco,
haydniano, e da cui viene a espandersi un clima emotivo di apollinea e un poco nostalgica senilità. Qui Beethoven ricerca il consolidamento del proprio stile, l’equilibrio formale, il più elevato grado di affinamento di un processo di intensificazione drammatica e di amplificazione dell’elaborazione tematica che
risale praticamente ai primi quartetti dell’op. 18. Si tratta di quelli che andrebbero detti i quartetti “Galitzin”, dal nome del principe russo Nikolaj Galitzin che
li commissionò a Beethoven dopo le prime della Missa Solemnis e della Nona Sinfonia. Sono questi i quartetti, elencati secondo l’ordine di scrittura, op.
127, 132 e 130. Subito dopo, arrivano i quartetti che Beethoven scrive senza
alcuna commissione o sollecitazione esterna (il principe gliene aveva commissionati al massimo tre), ma solo in risposta all’insorgere di una nuova esigenza espressiva. Questa esigenza, che potrà essere interpretata nei modi
più diversi, induce l’autore a cambiare in gran parte direzione, proiettare il proprio linguaggio verso ambiti formali e pratiche armonico-strutturali decisamente anticonvenzionali, rinnovando e riarticolando dal loro stesso interno le forme strumentali canoniche, a cominciare da quelle della sonata e della fuga.
Ma questa esigenza, che pure è possibile attribuire a un personalissimo recupero dello stile speculativo dell’ultimo Bach, già avviato dal compositore con
le ultime sonate per pianoforte, con le Trentatré variazioni sul walzer di Anton
Diabelli e con la Missa Solemnis, non è tuttavia interamente riconducibile a
questioni di linguistica musicale. Si tratta dei quartetti, sempre secondo l’ordine di composizione, op. 133, 131 e 135, tra i quali il 133 è senza dubbio il più
avanzato e il 131 il più grande e complesso. Credo sia perciò opportuno parlare di due stadi creativi, quello relativo agli ultimi e quello relativo agli ultimissimi quartetti. La distinzione mi sembra importante perché lì si termina un discorso, qui invece se ne comincia un altro.
Si è fatto un gran discutere, da Romain Rolland sino a Ivan Mahaim1, se sia
NOTE
le per esprimersi, e ciò in primo luogo a causa del diverso tipo di reazione che
la lingua o la materia plastica adottata oppongono al suo volere plasmante.
Non è lo stesso il pensiero x espresso da un musicista piuttosto che da un filosofo o da un matematico, e ciò perché nel loro specifico approccio non un
semplice aspetto della realtà viene a modificarsi, ma la realtà tout court. Questo pensiero x può, inoltre, “riposare” nella struttura formale del linguaggio
adottato, e pertanto lasciarsi guidare da essa, o viceversa, come avviene nel
caso di Beethoven, determinarne la fisionomia sino a farne una sua semplice
estensione, una suppellettile occasionale, un supporto catalizzatore. Restare
sul piano della sintassi e della forma per comprendere il “senso” di un concerto bachiano, ad esempio, è perfettamente possibile; fare lo stesso con Beethoven, specie con l’ultimo Beethoven, è assolutamente impossibile. A parte
quanto varie volte dichiarato dallo stesso compositore circa il rapporto fra suono e pensiero argomentativo, è certo che la particolare forza evocativa che il
proprio linguaggio acquisisce non si esaurisce solo in meditazioni astratte legate alla situazione umana o alla natura e ai limiti costitutivi del linguaggio musicale, ma include scelte specifiche di ordine poetico, ovvero codici para o metalinguistici dei quali il proprio linguaggio si è avvalso, e che pertanto, pur non
essendo del linguaggio, sono passati nel linguaggio.
Il criterio di mantenersi saldamente a un livello di analisi formale o peggio
segnico-notativa –al riguardo esistono decine di procedimenti tutti più o meno
validi e sensati– è perciò tanto poco utile quanto esaustivo. A maggior ragione,
trasvolare dal piano morfologico a quello di una pura speculazione teoretica,
magari eruditissima ma satura di precomprensioni ideologiche o speculative, a
rischio di assegnare a un linguaggio fornito di regole proprie cose che non provengono da quel linguaggio, significati metalinguistici che non sono anche linguistici, non può certo dirsi metodo meno fumoso ed equivoco dell’altro. In
questo senso, la particolarità della musica beethoveniana, che più di ogni altra
“parla” al nostro ascolto prim’ancora di risuonare, ha lasciato perplessi o esitanti la maggior parte dei critici e degli studiosi. Nella sterminata bibliografia
beethoveniana, come è noto, non esistono monografie paragonabili a quelle di
Mozart o di Bach, mentre sul piano musicologico ed estetico-filosofico le migliori cose restano frammentarie o incompiute. Quale intimo imbarazzo si nasconda nell’entusiasmo che traspare dalle pagine sparse di Adorno, da poco
riproposte, è facilmente percepibile per qualsiasi lettore avveduto, sebbene
non esperto di cose musicali. Secondo la prospettiva sociologica cara al loro
autore, Beethoven dovrebbe risultarvi –e non vi risulta– il più reazionario e borghese dei compositori, la sua estetica una dialettica illuminista soggiogante e
aggressiva, il suo mondo poetico quello stesso dell’uomo-eroe che sottende alle molteplici barbarie dell’ultimo secolo. Tuttavia incapsulare, in questo o in altro modo, la prospettiva poetica intrinseca del linguaggio beethoveniano entro
un quadro di categorie culturali prefissato è del tutto vano. Questa via favorisce numerosi cliché interpretativi come, da una parte, il tristemente noto rigetto dell’arte formalista da parte dei regimi comunisti e nazional-socialisti, e dall’altra lo storicismo ingenuo che vorrebbe far discendere il Tristano dal Fidelio,
il serialismo integrale dei seminaristi di Darmstadt dalle quinte e quarte sciolte
71
72
li” di qualche genere5. La fuga non è per lui che un campo di esperienze compositive assolutamente libero, suscettibile dei più impensabili sviluppi, un espediente per estendere il proprio linguaggio verso una pluralità di principî e di forme, in qualche caso radicalmente alternativi. Campo che, com’è evidente, resta “aperto” in quanto sistema di sviluppo, ma nello stesso tempo autonomo e
inconfrontabile come concezione poetica. Se le fughe della Missa, della Nona,
dell’Ouverture Die Weihe des Hauses e della Sonata op. 110 hanno l’intento di
fondare un ordine cosmico sovrano e inalterabile, le fughe delle opere 102 n.
2 (l’ultima Sonata per violoncello), 106 (la Sonata Hammerklavier), 131 e 133,
sono invece qualcosa di fortemente problematico. Non hanno la sistematicità
scientifica dell’Arte della fuga o dell’Offerta musicale bachiane, ma al contrario
diventano il vivaio di idee e di procedimenti elaborativi volta per volta diversi,
attraverso i quali proiettare le forme acquisite, a cominciare dalla fuga, in direzioni nuove e più evolute. Nelle mani di questo Beethoven, la fuga non rappresenta più una forma come le altre, accostabile o integrabile alle altre, ma un
processo a sé, una scaturigine di tutta la musica, un caos originario da cui partire e verso cui tornare.
È stato sollevato da più parti –nel solco aperto da quelli che Carli Ballola
chiama i “commentatori scolastici”6 del compositore– il quesito se la Grande
Fuga possa realmente considerarsi una fuga. Al di là dei punti di vista, legittimamente diversi, attravero i quali è possibile valutare un’opera d’arte, la Grande Fuga si presenta, considerata nel suo aspetto formale, come una sonata
contrappuntistica in un unico movimento che, pur assumendo l’impostazione
complessiva di una fuga, se ne serve come puro espediente di partenza per
avventurarsi in regioni inesplorate, sperimentare forme linguistiche totalmente
alternative, implicite ma mai venute alla luce in modo compiuto nel genere della fuga vocale antica, archetipo e seme germinatore di tutte le forme musicali
posteriori, a cominciare da quella della sonata classica, basate sui due grandi
principî dello sviluppo e della ripetizione. Partiamo perciò da questo assunto:
la Grande Fuga è indiscutibilmente qualcosa di più di una semplice fuga, e tuttavia è una fuga. Cominciamo pertanto col vedere, sotto il profilo accademico,
cos’è una fuga: la fuga è una composizione in stile polifonico basata sull’imitazione asincronica e sul principio dell’equidistribuzione fra le parti. Essa, di norma, si costituisce a partire da tre elementi essenziali: 1) un primo tema, o motivo, ben caratterizzato e chiaramente definito nel suo aspetto melodico e ritmico, detto “soggetto”; 2) un secondo tema, o motivo, costruito in modo da
combinarsi nel modo più naturale col soggetto pur presentando tratti e caratteri ben differenziati rispetto a esso, detto “controsoggetto”7; 3) una trasposizione di soggetto e controsoggetto nella tonalità della dominante, ovvero a distanza di tre toni e mezzo rispetto al suono fondamentale, che si dice “risposta”.
Una fuga, inoltre, si articola abitualmente in tre parti: una prima detta esposizione, una seconda detta svolgimento, una terza detta stretto. L’esposizione
consiste nel disporre soggetto controsoggetto e relativa risposta in modo da far
circolare a turno il materiale tematico fra tutte le parti (voci o strumenti) previste dall’organico del pezzo. Lo svolgimento è formato da una serie di divertimenti tratti dal soggetto o dal controsoggetto, e da nuove esposizioni costruite
NOTE
o non sia necessario valutare la Grande Fuga, nel suo senso strutturale e linguistico-formale complessivo, come opera autonoma o come parte integrante
del Quartetto in Si bemolle maggiore op. 130, del quale doveva costituire in origine il finale. A tutt’oggi, nei concerti e nelle incisioni discografiche, si assiste
spesso all’esecuzione della Grande Fuga come finale dell’op. 130. Ciò è tanto
più singolare perché a legittimare l’arbitrarietà della scelta sono in questo caso i musicisti stessi, ovvero proprio coloro che sono forniti degli strumenti migliori per cogliere le abnormi differenze esistenti fra le due scritture. Il finale,
che perciò qui non chiamerò “il nuovo finale” ma semplicemente “il finale” dell’op. 130, è giocoso, brillante, costruito nella forma di un rondò-sonata in perfetto stile viennese, in tutto e per tutto conforme al clima posto alla radice dell’intera composizione. La Grande Fuga rappresenta invece una creazione assolutamente inaudita, non solo animata da intenzioni espressive radicalmente
contrapposte ma cresciuta da se stessa e in se stessa. A chi voglia avvalersi
di quell’“estetica del contrasto” che tanta (effimera) fortuna ha incontrato da
parte delle avanguardie novecentesche, va ribadito che essa mal si applica al
caso di Beethoven: il compositore lavorava come noto seguendo una sua regola del contrappasso, per cui, ad esempio, la Quinta e la Sesta sinfonia vennero scritte quasi nello stesso tempo, i quartetti op. 131 e 135, anch’essi così
diversi fra loro, nacquero praticamente insieme. Perché dunque non ammettere la stessa cosa a proposito di uno tra i più alti testamenti creativi dell’arte
beethoveniana? Del resto, anche a volerne prescindere, è provato che l’autore non intese mettere da parte un finale per introdurne un altro (così, ad esempio, ritiene Romain Rolland), ma prese coscienza a cose fatte di avere per le
mani qualcosa che non aveva più senso in relazione al tutto. A poco valgono i
numerosi tentativi, ampi e dotti (penso in particolare alle tesi di Paul Bekker richiamate nelle lezioni universitarie di Massimo Mila sull’argomento2), di mostrare la presenza di derivazioni tematiche germinali recuperate dai restanti
movimenti, provenienti dallo stesso come da altri quartetti del gruppo. La tesi
di una serie di estrapolazioni modulari costruite sul nome di Bach, a partire dalle quali Beethoven avrebbe concepito i quartetti op. 130, 131, 132 e 133, fattasi strada e ampiamente circolata nel corso degli ultimi decenni soprattutto
dopo gli studi di Joseph Kerman e Carl Dahlhaus3, anche ad ammetterla quale prova dell’esistenza di segreti o impliciti Leitmotive comuni ai quattro quartetti, non dimostra in realtà nessuna comunanza di intenti poetici ed estetici fra
la Grande Fuga e il Quartetto in Si bemolle maggiore. Si tratta di ipotesi suggestive, ma che si arrestano a un livello semiologico. Esse valgono né più né
meno di altre che, partendo dal punto di vista opposto, vorrebbero anticipato
nella “variazione integrale” dell’ultimo Beethoven il principio compositivo della
“melodia infinita” di Richard Wagner4. La realtà è che l’op. 130 e l’op. 133 hanno in comune esclusivamente la tonalità d’impianto, così come tra Beethoven
e Wagner non c’è maggiore affinità di quanta ve ne sia tra Verdi e Cherubini.
È bene perciò invitare il lettore-uditore a non trascurare il fatto che, in queste pagine, Beethoven adopera gli artifici del contrappunto esattamente come
Kant adopera le categorie a priori dell’intelletto, vale a dire come principî compositivi a priori di ogni possibile forma, e mai invece in quanto “forme musica-
73
74
Cos’è questo primo tema? È il soggetto o il controsoggetto? Non v’è dubbio, da come Beethoven lo espone, che esso sia a tutti gli effetti l’elemento più
importante della fuga, così come è altrettanto indubbio che l’elemento più im-
portante di cui una fuga si compone è il soggetto. Tuttavia, ciò che accade nelle battute successive sconvolge completamente questo criterio: dopo averlo
armonizzato e accompagnato con una figurazione in semicrome (il tema B),
Beethoven altera –non di molto, ma in ogni caso altera– i connotati originari del
tema A. Lo si sente, in pianissimo, trasformato in una specie di ansimare affannoso, rotto da pause. Un attimo dopo, in fortissimo, c’è l’attacco vero e proprio
della fuga, nel quale tuttavia viene introdotto un tema totalmente differente, da
indicare pertanto come tema C, articolato in amplissimi intervalli di decima e
subito accompagnato dal tema A, modificato nel modo che si è visto. Ciò che
accade, in altri termini, è che il tema principale viene immediatamente destituito dall’essere soggetto della fuga per trasformarsi nel suo controsoggetto, ossia nel controcanto di un tema di cui non si comprende la provenienza e al quale inutilmente si tenterebbe di dare una giustificazione qualsiasi sul piano dei
rapporti formali. Tema, infatti, di cui l’introduzione non ci dice e non ci lascia
presagire assolutamente nulla.
Le innovazioni più sorprendenti insite in questa operazione mi paiono pertanto consistere in queste tre cose: a) che la fuga inizia col controsoggetto anziché col soggetto, cioè tutto al contrario di come normalmente succede; b) che
il soggetto viene trattato come fosse un controsoggetto, fatto anche questo assolutamente senza precedenti; c) che il soggetto non ha praticamente nulla di
motivico, ma è anzi, per sua stessa essenza, a-motivico. Si è inteso frequentemente parlare (così in particolare nel caso di Vincent d’Indy8) di una prima e
di una seconda fuga, in altri casi ancora (Giovanni Carli Ballola9) di una doppia fuga, una fuga vale a dire costruita su due soggetti. Non ritengo condivisibili queste letture: la fuga in realtà è unica e rigorosamente monotematica.
L’idea di soggetto, intesa nel suo significato fraseologico classico, non ha qui
più alcun significato vincolante. Beethoven ragiona già, sia pure a suo modo,
in termini puramente intervallari. Il tema principale (il soggetto) è, infatti, una
costruzione intervallare pura, la quale, come visto, è sostanzialmente a-motivica. Ogni costrutto melodico nuovo, ogni inciso motivico introdotto, poggia in
modo inequivocabile su quest’unica traccia, sorta di embrione tematico primordiale, esposto in fortissimo dalle battute d’esordio: non tanto suoni in successione lineare, quanto movimenti intervallari ascendenti e discendenti raggiunti
per salto, sul tipo di certi bassi cromatici bachiani o frescobaldiani udibili in molti tipi di accompagnamento per arie, preludi e corali. Qui l’elemento è preso a
sé, elevato a principio cardine e quasi a paradigma di tutto il senso del pezzo.
Un elemento tuttavia che, pur subendo come visto dei mutamenti, pur cambiando aspetto, resta sempre fortemente associato a un eidos, un’idea-immagine che è quella del movimento irreversibile, del divenire inarrestabile, inteso
come forza vitale, come impeto creativo cieco e come dissoluzione permanente, come ritorno all’indistinzione primordiale, alla totale ineludibile mancanza di
senso storico propria degli avvenimenti naturali. La Grande Fuga cioè, a ridirlo in termini più tecnici, è una fuga costruita non tanto su di un vero e proprio
soggetto quanto su di un puro movimento armonico onnipresente (il tema A)
che non si regge su nulla di preciso e di definito. Una specie di vortice perennemente modulante nel quale vengono inghiottiti e amalgamati a turno temi e
NOTE
sulle tonalità vicine, ovvero relative ai gradi fondamentali della scala d’impianto. Gli stretti, infine, ripropongono le entrate di soggetto e controsoggetto in
modo sempre più serrato, concludendo con un pedale di dominante e una coda costruita sul primo grado, anch’essa in forma di pedale, impostata per lo più
come un ultimo stretto. Schemi quantomai rigidi, eretti sopra rapporti armonici
se possibile ancora più rigidi. Da questa che è la “forma-fuga” come principio
e come precetto, veniamo alla fuga costruita da Beethoven.
Il pezzo, di enorme complessità, può essere scomposto in dieci parti: I. Una
introduzione, nella quale viene esposto quello che chiamerò il tema A, o tema
“principale”, vero asse portante dell’intera composizione, presente in ognuna
delle parti che seguono (battute 1-30); II. Una prima sezione della fuga, (batt.
30-158); III. Un primo intermezzo nel carattere di un episodio fugato, (batt. 159232); IV. Un secondo intermezzo nel carattere di un divertimento (batt. 233272); V. Una seconda sezione della fuga, comprendente una nuova esposizione (batt. 273-492); VI. Una breve ripresa del primo intermezzo e una riesposizione del secondo (batt. 493-564); VII. Una prima coda, o coda interna, ricavata in modo molto libero dal tema del secondo intermezzo e dal tema introduttivo, coda che, strutturalmente, funge da sutura (batt. 565-656); VIII. Una falsa
ripresa della prima sezione della fuga, seguita da una falsa ripresa del primo
intermezzo fugato, l’una e l’altra nella tonalità d’impianto (batt. 657-662); IX.
Una riesposizione del tema introduttivo (batt. 662-682); X. Una seconda coda,
composta da un pedale di sottodominante (in luogo di quelli sulla dominante e
sulla tonica) e da una libera riesposizione dei temi introdotti nella prima sezione della fuga, come si trattasse di chiudere un movimento di sonata tradizionale (batt. 683-741). Vediamo meglio: c’è da osservare, innanzitutto, che l’attacco della fuga è mediato, ossia è preceduto da un’introduzione che sostituisce l’esposizione nel tratteggiare il carattere e nell’esporre gli incisi tematici
che verranno elaborati dalle sezioni seguenti. Il primo, che si ascolta in fortissimo nelle prime battute, dopo il lungo accordo tenuto, è una furibonda successione di settime diminuite seconde minori e seste maggiori, nell’aspetto e nell’effetto quantomai ambigue e inquietanti: la serie intervallare, fortemente dissonante, parte e ritorna in pochi attimi nel tono di Sol maggiore, piuttosto estraneo a quello di Si bemolle, ma affermandolo lo annulla, eludendone e sospendendone l’impianto armonico (vedi esempio). Il secondo inciso, il tema B, più
lirico e accorato, esprime qualcosa di totalmente diverso: afflizione, lamento,
supplica. Esso viene esposto in contrappunto doppio con il primo tema, proprio
come si trattasse del suo controsoggetto naturale.
75
76
enorme rilevanza poetica poiché viene a sostituire l’asprezza della settima diminuita con l’assoluta consonanza dell’ottava–, il tema principale irrompe come un raggio di luce improvviso che, inaspettato e provvidenziale, arriva dall’alto a fendere le oscurità di tutto lo scenario precedente. Da ora in avanti la
speranza si aggiungerà al terrore, contrastandolo.
Quartetto in Do diesis minore Op. 131 (inverno 1825 - luglio 1826)
L’ultimo e il più personale dei grandi quartetti di Beethoven comincia con
una fuga. Dopo una fuga, la “grande”, ecco dunque ancora una fuga. Le differenze fra l’una e l’altra, tuttavia, sono considerevoli: se quella impiega un linguaggio tutto proiettato verso l’espressionismo romantico, questa sembra invertire la marcia e tornare a una scrittura di gusto arcaicizzante, interamente
calata nello spirito del barocco franco-fiammingo, e, in modo affatto evidente,
di quello bachiano. In entrambe i casi, tuttavia, l’obiettivo resta quello di attuare una fusione dinamica tra flusso contrappuntistico ed elaborazione formale.
È noto che fra i non molti spartiti musicali trovati nella Schwarzspanierhaus,
l’ultima abitazione del compositore, vi si trovasse la serie completa del Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. Già nell’autunno del 1817,
Beethoven aveva lungamente meditato sulla raccolta di preludi e fughe del
Clavicembalo, trascrivendone la fuga in Si minore per quintetto d’archi. È perciò oltremodo curioso constatare, alla luce di coincidenze così importanti e così precise, il fatto che mai nessuno abbia rimarcato a dovere come la seconda
parte della figurazione che compone il soggetto di questa fuga (il punto B riportato nell’esempio) derivi o comunque coincida esattamente, sotto ogni aspetto, al soggetto di una delle fughe della prima parte del Clavicembalo, la Ottava in Mi bemolle minore (originariamente in Re diesis minore), tonalità che
Beethoven raggiunge alle battute 45-50.
Beethoven, Op. 131, batt.1-4
J. S. Bach, Das wohltemperierte Klavier, Fuga VIII, batt.1-2
NOTE
motivi diversi, collegati fra loro solo in virtù di questo elemento anonimo e imprecisato che li guida.
Cos’è questo elemento, nella mente di Beethoven? Se nella Quinta era il fato,
se nella Nona era la divinità, o meglio “il divino”, qui probabilmente è l’universo naturale, è la dinamica del vivente nel senso più strettamente evoluzionistico e naturalistico della parola. È il tutto, non solo la morte ma la vita stessa (spinta verso
la morte), inteso come forza che a ogni istante travalica i poteri dell’uomo, forza
che per questo li domina e li rende vani. È una forza onnipervasiva, perfettamente unitaria, rigidamente strutturata, sempre coerente in se stessa ma cieca e tiranna, come una macchina inesorabile, fatale, oppressiva, del tutto incurante delle
aspirazioni umane. È, insomma, il senso della totalità posto come radicale indifferenza verso i destini dell’uomo, dell’umanità, del mondo umano, del suo ostinato
desiderio di perfezione, di dedizione, di lotta e conquista. Quanto al primo episodio o intermezzo fugato, che è la parte centrale dell’opera, esso alterna un momento lirico costruito sul tema B, sorretto da accordi ribattuti, a un momento in stile fugato, dove i due temi si incastrano in contrappunto doppio. Il tema principale,
ripetutamente introdotto, pianissimo e legatissimo, assume ora toni insinuanti come lo strisciare di un serpente. Tanto la sezione precedente era basata sull’incalzare di un movimento inarrestabile e convulso, tanto questa successiva sembra
voler sospendere il fluire naturale del tempo, e trasferire la dimensione del volere
individuale in un campo di totale passività, o meglio di assoluta remissività. È una
lunga, stupefacente meditatio mortis, riflessione profondissima sul rapporto tra
speranza e annullamento, tra memoria ed eternità, nel quale il senso di ogni cosa sembra svelarsi e compiersi, librarsi all’infinito e svanire. Il secondo intermezzo, che pure svolge un ruolo del tutto transitorio, acquisisce un significato preciso
nell’economia complessiva del pezzo, dal momento che serve ad aprire e chiudere la seconda parte della fuga. Non ha la severità di un fugato, benché non manchino imitazioni e incastri, ma ha piuttosto l’aspetto di un semplice divertimento
svolto a partire da una variazione del tema A. Lo si può riconoscere per il suo tono serafico, velatamente sarcastico. Tale è il contrasto con la gravità udibile ovunque in tutte le restanti sezioni del pezzo, che potrebbe il compositore avere alluso alla meschina avidità di chi preferisce vivere restando avvinghiato alla rassicurante superficie delle cose.
Diffido tuttavia l’ascoltatore a leggere la Grande Fuga come un teorema
apocalittico o nichilistico sulla vita umana, che di fatto non appartiene alla mentalità né alla cultura di Beethoven, nutrita di etica illuministica kantiana e di
umanismo eroico goethiano e schilleriano. Esiste in realtà, anche stavolta, per
chiunque sia in grado di ragionare “con le proprie orecchie”, una svolta nettissima all’interno del pezzo, la quale giunge poco prima della coda, generandosi internamente al processo di sviluppo della seconda sezione della fuga, e ne
costituisce a tutti gli effetti il primo seme, la scaturigine interna, la causa prima.
È il disegno in fortissimo esposto dal primo violino alle battute 416-420 (vedi
esempio), disegno che consiste in una nuova elaborazione del tema principale trasposto al tono della dominante. Non è solo un evento nuovo, ma, ripeto,
una svolta nettissima che investe profondamente il senso dell’intera composizione. Modificato nel suo stesso aspetto intervallare –una modificazione di
77
78
eroe, dell’uomo nuovo, del Faust goethiano come simbolo di libertà, prototipo
del Freigeist nietzschiano. Il nuovo mondo, la realtà emendata dai conflitti e dai
soprusi, il pacifismo universale kantiano cantato nella Nona sinfonia, non saranno mai raggiunti dalla società vivente, dalla società alla quale il compositore si rivolge, e nessuno individualmente potrà mai ottenerla. In questo senso di
afflizione profonda, di anelito a un infinito annullamento che si teme e si rigetta, vi è nello stesso tempo il culmine del proto-romanticismo beethoveniano e
il superamento definitivo del culto romantico per l’irrazionale, che qui viene anticipato e risolto. Fra i moltissimi esempi della letteratura musicale nei quali è
possibile trovare influenze di questa pagina beethoveniana troviamo infatti il
Parsifal di Wagner, ma anche il Primo Quartetto di Béla Bartók.
L’Allegro molto vivace, così come tutti i cinque movimenti successivi, nasce
dal suo precedente senza soluzione di continuità, e vi procede nel modo più
spontaneo. Il tema, tra i più commossi e toccanti mai scritti da Beethoven, non
esprime tuttavia il senso di una gioia assoluta ma qualcosa di controverso e
oscuro. È al solito un impedimento del volere, l’aspirazione e l’impossibilità di
appartenenza elettiva a un tutto che c’è e non c’è, che si avverte e insieme non
si riconosce. Segue un breve episodio di transizione, indicato Allegro moderato e poi Adagio, il quale, tecnicamente, supplisce alla necessità di modulare da
una tonalità a un’altra, mentre, sul piano espressivo, serve a introdurre, nei
modi e nei toni di un recitativo, l’atmosfera idillica di un tema tenero e nobile,
in apparenza privo di conflitti, fraternamente confidenziale, dal quale si snodano sei variazioni. Il tema, come si legge, è un “molto cantabile”, tuttavia esso,
scritto nella forma regolare di un lied –in due periodi, formati da quattro semifrasi simmetriche– viene trattato sul piano della scrittura come fosse sin da subito soggetto a elaborazione, come fosse già variazione di se stesso. La quinta variazione rappresenta il culmine di questo processo di lenta e graduale affrancazione dalla fisionomia melodica del tema e, in generale, dall’idea stessa
di melodia come sorgente lirica, come vincolo a un fraseologismo piano e conseguente: del tema non resta letteralmente più nulla all’infuori dell’impalcatura
armonica. Ciò che ne rimane spinge potentemente il suono oltre la materia,
schiudendo uno spazio antinaturalistico in cui l’immagine del tema sembra come evaporare e dissolversi. Dopo questo completo allontanamento dal corpo
e dal volto un tempo attribuiti al tema, Beethoven dà il via con la sesta variazione a un discorso completamente diverso, o forse, più precisamente, a un discorso nel quale i presupposti e le valenze espressive della variazione sono
già interamente venute via dal tema, ne hanno in tutto abbandonato la garbata atmosfera d’incanto lirico, e sono ritornate al dissidio lancinante della fuga.
Su questo straordinario Adagio, ma non troppo e semplice, che è il vero climax
di tutto il quartetto, si è fra gli altri soffermato Marliave. «Poche pagine nella letteratura musicale –scrive– raggiungono la profondità e la pregnanza introspettiva ottenuta qui. Di questa luminosa frase potrebbe Beethoven aver detto con
Goethe: ho qui riposto molte delle mie più segrete meditazioni»13. La “luminous
phrase” cui Marliave allude è in effetti nient’altro che la ripresa sistematica delle prime tre note del tema, una semplice successione di suoni ribattuti i quali,
sul tempo debole di ogni misura, vengono melodicamente “appoggiati” dalla
NOTE
Malgrado, anche qui, si sia molto discusso se il primo movimento dell’op.
131 sia o meno una fuga, le sole obiezioni sollevabili al riguardo consistono a
mio avviso nell’ambiguità tonale dell’esposizione causata dalla risposta del
soggetto alla sottodominante (Fa diesis) anziché alla dominante, e nell’assenza del controsoggetto, trattandosi per il resto non solo di una fuga vera e propria, con tanto d’esposizione svolgimento e stretti, ma di un tentativo di recupero della forma nel suo significato più originario, quello dell’imitazione sistematica a partire da un unico tema fondamentale. Sorvolo sugli aspetti aridamente tecnici che possono dimostrare la coerenza armonica della scelta beethoveniana per il quarto grado, aspetti sui quali si è ampiamente profuso Joseph Kerman10, e mi limito alle valenze formali. L’assenza del controsoggetto,
frequente in moltissimi esempi di fuga e di fugato lungo tutta la storia della musica, varrebbe a invalidare le tesi di una scrittura formalmente regolare se, e
solo se, la presenza o l’assenza di un controcanto per il soggetto-tema potesse essere ammessa quale condizione sufficiente di per sé a distinguere una fuga da una qualsiasi altra composizione contrappuntistica, come ad esempio un
canone o un ricercare. Cosa del tutto errata. L’impiego del controsoggetto in
realtà è relativamente tardo, venendo per la prima volta definito e codificato in
termini di tema secondario dai teorici del Seicento; prima di allora, tra controsoggetto e parte libera non esiste quasi nessuna differenza specifica.
Il soggetto della fuga, già a valutarlo da solo, è una perfetta condensazione plastica dell’insanabile dissidio che anima l’intera composizione. Come notato fra gli altri da Joseph De Marliave11, questo soggetto contiene in realtà non
una ma due idee o incisi motivici fortemente differenziati: un primo (indicato come A nell’esempio) che esprime tensione, aspirazione, desiderio, apertura verso il mondo, e un secondo (B) che al contrario esprime ripiegamento, rassegnazione, prostrazione, desolazione, chiusura. Tra l’uno e l’altro vi è un punto
di congiuntura dinamico, in coincidenza del La naturale indicato col segno di
sforzato “sf ”, che sigilla l’identità del massimo sforzo con la frattura e lo scacco. Beethoven ottiene questo risultato nel modo più semplice e sorprendente:
il primo inciso (l’inciso A) consiste in un suono di dominante che risolve sulla
tonica poggiando sulla nota sensibile, seguendo cioè un disegno melodico che
si direbbe tipico di una chiusura anziché di un principio di frase. Appena dopo,
sul tempo forte della battuta successiva, giunge in sforzato un nuovo suono,
corrispondente a un sesto grado o sopradominante del tono di partenza, che
difatto riapre il senso armonico della frase. L’evocazione di fondo è daccapo
quella dello sgomento e dell’afflizione di fronte a tutto ciò che sovrasta la vita,
germe di quel desiderio di distacco dalla prigionìa della condizione naturale dal
quale trarranno ampiamente spunto i compositori romantici, da Schumann a
Mahler. Come, ritengo, solo in pochi altri esempi musicali bachiani o in alcuni
passi della poesia omerica e virgiliana, qui davvero si invera a pieno il senso
insieme lirico e tragico di ciò che Burke12, forse meglio di Kant, ha indicato circa le cause e le componenti del “sublime”. Il vuoto, l’oscurità, la solitudine, il silenzio, che nello stesso tempo sono oppressivi e necessari, generano nell’uomo il sentimento del sublime. È il punto di crisi massimo, mai manifestato con
tanta vividezza dal Beethoven precedente, dell’ideale epico-stoico dell’uomo
79
80
ragione e fede, tra dubbio e certezza, tra desiderio e rinuncia, tra ciò che si è e
ciò che non si è, un conflitto tuttavia che nasce dall’incapacità di accettare la dinamica interna di questo conflitto, dinamica che per l’autore è e non può che essere quella finalistica, provvidenzialistica, emanazionistica, espressa dal credo
cristiano. Questa fenditura, sempre più grande, torna e ritorna a colpire la coscienza di Beethoven senza dargli pace.
Il finale dell’op. 131 è, in certo senso, il trionfo di quel motivo della volontà
di superamento eroica che rappresenta il luogo topico prevalente, che tanto affascinerà Nietzsche, da cui tutta la poetica beethoveniana si dirama. Il motivo
della lotta che dall’Appassionata va alla Hammerklavier, dalla Terza Sinfonia a
questo quartetto, si accompagna al momento della perfetta simbiosi con il cosmo, rappresentata da pagine come il Concerto per violino, o come la Sesta
sinfonia, o ancora il “Benedictus” della Missa Solemnis, dove la natura diviene
l’ipostasi ideale, ma apparente, del processo di superamento della realtà. Se
la prima componente della diade è animata da una foga mistica nella quale albergano una profonda esigenza di riscatto e di liberazione dal male temporale
(il contemptus mundi che Beethoven, come i romantici, assimila dal medioevo), essa è però interamente esistenziale, scavata nell’immanenza delle condizioni contingenti, ambientata in uno scenario terrestre. Se la seconda componente è continuamente protesa a un’unità primordiale andata perduta, da
cercare in una superiore armonia che è già data, in una verità trascendente assoluta, essa è nello stesso tempo lo specchio di un cosmopolitismo umanistico e illuministico, che allude a un mondo dove il pensiero è misura di ogni cosa. Questa diade, assolutamente inconciliabile sul piano filosofico, priva di
qualsiasi possibilità di unificazione dialettica, si manifesta in tutta la sua drammaticità nei due temi del finale dell’op. 131. Il primo tema, introdotto da una figurazione trocaica quanto mai dura, aspra, sferzante, è la ricerca affannosa di
un senso che l’uomo non è in grado di dominare: il senso delle nostre azioni,
ma anche il senso dell’impossibilità di accettare a pieno la vanità assoluta che
le nostre azioni ottengono nel mondo. Il senso del terribile che in esse si rivela, per cui dove qualcosa nasce qualche altra deve recedere e venire distrutta,
dove un sentimento prende vita qualche altro finisce. Il secondo tema, una scala discendente seguita da tre lunghe note acute, è o dovrebbe essere il luogo
del ritorno a casa, della conciliazione definitiva, ma il suo gesto rimane sospeso, quasi rivolto a ciò che non si è ottenuto e che tuttavia può ancora essere
trovato. Perciò non si tratta di un cedimento, di una resa, del prostrarsi passivo del credente comune. È un desiderio di capire il senso del cercare, il valore positivo del significato nascosto delle cose, significato che forse non è nella mente come non è nelle cose.
Quartetto in Fa maggiore Op. 135 (terminato nell’ottobre 1826)
Col Quartetto in Fa maggiore Beethoven sembra tornare al clima degli esordi. Sia per dimensioni che per assetto formale assistiamo a qualcosa di molto
simile ai sei Quartetti op. 18, mentre dal punto di vista stilistico ed espressivo
NOTE
nota superiore. Questa che è la più antica forma di ornamentazione musicale,
assume adesso una funzione sottilmente allusiva, priva di qualunque manierismo, in grado di proiettare le movenze del tema, e la sua innocenza espressiva, su di un piano infinitamente più vasto e sfaccettato. Non va detto un espediente del tutto nuovo in Beethoven: qualcosa di molto simile è udibile, alle
batt. 367-416, nel movimento conclusivo della Settima sinfonia. Ma la plurivocità espressiva, il coesistere tellurico di sentimenti e situazioni diversissimi, l’irradiazione lungo una stessa direzione della più alta spiritualità e della più terrena apprensione sono qui spinti a un livello di perentorietà, di efficacia, di sobrietà e concisione lirica imparagonabile alla produzione sinfonica del compositore. La ripresa del tema, dopo una successione di cadenze affidate a turno
ai quattro strumenti, è nello stesso tempo sospesa e anticipata, e ancora una
volta variata sia nel tempo che nel carattere. Anziché riaffermarsi nella sua apparenza melodica, il tema viene come ricomposto e rigenerato, scaturendo poco a poco dal nulla.
Il Presto è una forma assolutamente nuova di scherzo, ben più simile allo
schema del rondò che non a quello, normalmente tripartito, dello scherzo con
trio. L’idea è quella di un gioco di ombre cinesi, non tanto burlesco quanto satirico, col quale parodiare l’inganno dei sensi. Vi si distinguono assai chiaramente un primo e un secondo tema, ma essi vengono sviluppati e riesposti in
modo tale da risultare alternativi e richiamarsi vicendevolmente. Ogni “ritorno”,
tuttavia, imperniato su ripetuti ritardandi, interruzioni, false riprese, offre di volta in volta, impercettibilmente, qualche cosa di diverso, qualche figura che di
nascosto si è aggiunta o sostituita alle altre, qualche tassello scambiato di posto. L’atto stesso dell’ascolto viene qui non solo spiazzato, ma privato di senso. La ricerca del dissimile nell’identico, del discontinuo nella continuità, che
per l’intelligenza razionale racchiude la certezza del vero, l’illusione del giudizio oggettivo, è qui condannata a dondolare sulla tela di un ragno.
Introdotta da un lungo intenso sospiro, dopo l’ode alle bellezze della vita (le
variazioni) e l’indiavolata scorribanda nel tumulto delle traversìe quotidiane (lo
scherzo), torna con l’Adagio quasi un poco andante l’angoscia per le miserie, le
disarmonie, le inattuazioni dell’umanità. È una breve frase in Sol diesis minore,
di struggente intensità, affidata dapprima alla viola e poi riesposta tre volte,
identica ma un’ottava sopra, dal primo violino. Conduce direttamente al finale,
del quale rappresenta non tanto l’introduzione quanto la ragione causale, la sorgente linfatica, l’antepredicazione, la potenziale ineluttabile necessità di essere.
Il finale, in effetti, districa e dualizza in pieno, attraverso il consueto bitematismo
della forma sonata classica, ciò che nell’adagio viene sentito come una falsa
unità, come una terribile opprimente condizione comune a ogni essere vivente.
Da un lato la violenza sprigionata dai principî naturali della vita, specie quelli che
rendono possibile la conservazione e la trasformazione della materia da ciò che
esiste a ciò che solamente sussiste, a discapito di qualsiasi identità individuale;
dall’altro il desiderio, la passione, la speranza più insopprimibili di riconoscersi
parte di questo processo come di un tutto indivisibile, di affrontare il mondo proprio in virtù di questo continuo movimento di avanzamento e di trasmutazione.
Tensione contro distensione. È la malattia mortale dell’esistenza, la fenditura tra
81
82
tavia, a dispetto della Weltanschauung estetica prevalsa in epoca moderna,
Beethoven resta un artista-artigiano, compagno fedele dei propri strumenti, per
il quale non contano parole, codici o lessici, ma il loro utilizzo espressivo. Prima di grammatica o sintassi, egli del proprio linguaggio intende mutare la prassi. Non sono in questione gli strumenti del dire ma i suoi contenuti, le sue funzioni, il come riaprirli ai valori della possibilità.
Più che di un primo e di un secondo tema, il movimento iniziale si compone di una prima e di una seconda serie di materiali tematici. La prima è costituita da una concisa figurazione con doppie acciaccature, ripetuta due volte,
quasi rapidi sussulti inquisitivi, a seguire una linea melodica spigliata e serena,
accompagnata dal pizzicato del violoncello, infine un motivo dall’andamento
più composto e compassato, costruito su intervalli di settima e di seconda. Tutto questo già solo nelle prime quindici battute. Segue (alle batt. 17-24) un breve ponte modulante che conduce direttamente al secondo tema. Su di esso, o
meglio al suo interno, si snodano una sequenza di motivi del tutto nuovi, che
sembrano propagarsi moltiplicandosi senza controllo sino a quando, con un
improvviso sussulto, il discorso torna sui propri passi e si ricompone, diligentemente. È l’inizio dello sviluppo, breve, serrato, densissimo. Segue una ripresa
nel senso più regolare della parola, e una coda. Carli Ballola parla di «ibernazione della forma sonata»19, una definizione che, per le stesse ragioni esposte
sopra, ritengo piuttosto infelice. Il primo tempo dell’op. 135 rappresenta una
nuova, ulteriore concezione del sonatismo, che andrebbe meditata attentamente, presa ad esempio e ulteriormente svolta. Si potrebbe dire una specie
di divertimento, o di sonatismo estemporaneo basato sul principio dell’improvvisazione e dell’invenzione permanente. Al prolificare delle figure si unisce il
sovrapporsi delle situazioni emotive, ormai irriducibili agli stereotipi dualistici di
gioia/dolore, amore/odio, serio/faceto, propri della Affektenlehre e della retorica musicale barocca, affermatasi assieme alle teorie meccanicistiche seicentesche.
Nella forma, il Vivace è uno scherzo con trio. Per il resto, può dirsi l’esempio più drastico del momento di distacco dall’ethos dell’eroe. Ora questo distacco è totale, non solo cinico ma assurdo e grottesco. Dietro la sua facciata
distesa e sorridente, si nasconde il baratro, la disfatta imminente, il collasso, la
follia. L’operazione metascritturale è tuttavia evidente: l’invenzione non viene
espressa ma controllata dall’esterno, la scissione tra espressione musicale e
Sehnsucht poetica dell’autore è permanente dalla prima all’ultima nota. La gioia suggerisce angoscia, la vitalità separazione e dissoluzione, e così via. Col
terzo movimento giungiamo al tradizionale “Adagio”, qui indicato Lento assai,
cantante e tranquillo. Si presenta suddiviso in tre parti chiaramente distinte: la
prima, quella in cui l’aria è esposta per la prima volta sottovoce dal violino, è
un momento di stasi pressoché completa, quasi di progressivo intorpidimento.
Il contrasto fra serena solarità del canto e cupezza sinistra dell’accompagnamento rende manifesto uno stato di profonda ansietà, di fremente tensione,
che tuttavia non contrasta questo lento inesorabile cadere nel sonno ma lo accompagna come per sottolinearne l’influsso. La seconda parte, il Più lento, ha
esplicitamente qualcosa di lugubre. Qui i movimenti si fanno ancora più debo-
NOTE
abbiamo a che fare con una delle cose più ardite mai tentate dall’ultimo Beethoven. Il sonatismo viennese viene qui attentamente ripristinato, con le sue
proporzioni simmetriche, le sue galanterie, le sue movenze aggraziate. Ma
questo ritorno all’ordine è soltanto la maschera dietro cui si nasconde uno
squarcio abissale. Un’ombra si insinua ovunque, dietro ogni figura, accompagnando ogni gesto: l’ombra del malessere, del sopruso, dell’abominio, della
prevaricazione alienante. L’op. 135, in questo senso, è lavoro nel quale si respirano assai più le atmosfere surreali dell’op. 133 che non quelle pre-espressionistiche e neobarocche dell’op. 131, ed è di quest’ultimo non meno innovativo sul piano dell’originalità e della complessità scritturale. Con la sola eccezione, forse, del Quartetto serioso op. 95, Beethoven non si era mai spinto così oltre nella direzione della metascritturalità: tutta la composizione medita su
se stessa, si osserva senza lasciarsi osservare. L’ironia è, anche in questo caso, l’ultima parola, ma un’ultima parola che è già anche la prima di un nuovo
discorso, di un nuovo ampio itinerario.
Dopo la ripartizione proposta da Wilhelm von Lenz in un suo celebre quanto informale scritto, si è varie volte tornati a discutere circa l’esistenza di “tre
stili” nella parabola evolutiva dell’arte beethoveniana14, chiamati insistentemente in causa allo scopo di definire, in qualche modo, se e sino a che punto
l’autore sia stato un “classico” o un “romantico”, un “conservatore” o un “rivoluzionario”. In uno dei suoi non rari momenti di compiaciuta causticità, Adorno
ha parlato di una «morte dell’armonia»15 nel tardo stile, da attribuire a una drastica dissociazione del rapporto tra scrittura polifonica, oggettiva e universale,
e scrittura monodica, soggettiva e individuale, rapporto che, a suo dire, avrebbe mantenuto un alto grado di coesistenza sino a tutto il Settecento. Sorvolando sul carattere surrettizio del presupposto hegeliano della “cattiva individualità”, che Adorno impiega quale categoria ermeneutica privilegiata per sostenere la sua tesi, mi sembra difficile concordare con la conclusione adorniana senza dare per buona l’ipotesi di un Beethoven a due anime. Piegando i principî
armonici e i valori formali perpetuati dalla tradizione alle proprie esigenze
espressive, convertendoli in pure strumentalità, affermandone cioè l’insignificanza sostanziale, egli non ha negato assolutamente nulla di essi, ma al contrario ne ha affermato come nessuno prima il valore epistemologico. «Solo l’arte e la scienza, scriveva Beethoven all’editore Schott nel 1824, ci fanno sperare in un’esistenza più nobile»16. L’idea che Beethoven, giunto alla fine del proprio percorso creativo, venga attanagliato dal dubbio di avere sbagliato tutto,
lasciandosi sopraffare da una smania improvvisa, ormai impossibile da soddisfare, di superare o addirittura abbandonare il proprio linguaggio, è in realtà un
mito della storiografia romantica. Perciò nessuna morte dell’armonia, nessun
sovvertimento dei suoi principî cardine, nessuna alterazione della forma sonata, nessun passaggio dall’organico all’inorganico17. Beethoven è il caso epocale dell’artista di transizione, comune a tutte le epoche, il quale comprende che
è arrivato il momento, per le ragioni storiche sociali e politiche che segnano il
suo tempo, di esprimere cose diverse, di concepire non tanto il suono ma l’esecutore e l’uditore in modo nuovo, di trasferire il “fare musica” dalla sua dimensione salottiera e ricreativa a quella universalistica del mondo civilizzato18. Tut-
83
84
Gunti al termine della commedia, l’autore ci pone di fronte al nucleo centrale del suo ultimo travaglio interiore, alla concretizzazione massima e insieme
alla trasfigurazione ultima della sua rinnovata esigenza espressiva: la legge
morale, la bellezza, il mondo e i suoi abitanti, hanno o non hanno un senso dinanzi alla morte? Il titolo annotato da Beethoven in testa al finale, «Der schwer
gefasste Entschluss» (La difficile decisione), la cui enigmaticità ha solleticato
per lungo tempo la fantasia di storici e biografi, riflette non solo il senso dell’ambiguità indicibile che si trova a fondamento di tutto il quartetto, ma chiarisce assai bene quale sia il messaggio ascritto a questa ambiguità. È un messaggio che allude a ogni possibile chiedere, a ogni possibile dubitare, e ancora prima all’incapacità di accettare la nostra condizione esistenziale, storica e
perciò finita. Il chiedere come tale, cioè, mi pare non essere più il centro del
pensiero musicale del compositore, perché, qui come altrove, egli è già oltre il
dubbio, e nel considerarlo non lo vede come un problema a sé. A prevalere è
piuttosto il problema della scelta, della decidibilità dei singoli atti umani, della
prospettiva entro la quale agire e rendere operoso il proprio dubitare. Da un lato il dubbio che non agisce, la domanda che resta senza risposta, il cercare
che non vede più alcuno scopo da raggiungere, dall’altro l’agire operoso di chi
sa gioire delle più grandi come delle più piccole cose della vita, il candido, generoso disporsi all’istante che si consuma come se lì, proprio e solamente lì,
risieda la più chiara, la più semplice, la più esaustiva delle risposte.
1 R. ROLLAND, Les derniers Quatuors in ID., Beethoven: Les grandes époques creatrices, 4-6,
La Cathédrale interrompue, Editions du Sablier, Paris, 1947 ; I. MAHAIM, Beethoven, naissance et
renaissance des derniers Quatuors. La terre natale et la trilogie, Ed. Desclée de Brouwer, Paris,
1964.
2 M. MILA, Beethoven: I quartetti Galitzine e la Grande Fuga, Corso monografico di Storia della Musica, “Corsi universitari”, G. Giappichelli Editore, Torino, 1969, pp. 94-98.
3 Mi riferisco agli studi J. KERMAN, The Beethoven Quartets, Oxford University Press, London,
1967, Cap. 9, pp. 269-302, e C. DAHLHAUS, Ludwig van Beethoven und Seine Zeit, Laaber-Verlag,
Laaber, 1987, tr. it. Beethoven e il suo tempo, a cura di L. Dallapiccola, “Biblioteca di cultura musicale. Autori e opere”, E.D.T., Torino, 1990, pp. 228-232. Senza fare esplicito riferimento al nome
di Bach, come noto corrispondente nella nomenclatura tedesca ai suoni Si bemolle-La naturaleDo naturale-Si naturale (vedi esempio), tutti in relazione di seconda minore e/o di settima maggiore, soprattutto Dahlhaus ha riportato con molta chiarezza una serie di corrispondenze intervallari
che legano assieme i quartetti op. 132, 130, 133 e 131. Fra l’altro, significativamente, egli non le
riconosce per delle corrispondenze tematiche in senso stretto, ma preferisce rinviare alla “magia
delle relazioni” evocata da Thomas Mann a proposito dei motivi conduttori wagneriani (Ivi, p. 229).
E tuttavia, potendosi astendere a due lavori, il Quartetto in La minore op. 132 e il Quartetto in
Do diesis minore op. 131, in sé assolutamente compiuti e inconfrontabili con l’op. 130, queste corrispondenze mi sembrano confortare largamente la mia ipotesi di lettura.
4 G. CARLI BALLOLA, Beethoven. La vita e la musica, “La musica”, Rusconi, Milano, 1985, p. 267.
5 La posizione empiristica di Tovey, in relazione a questo genere di problemi interpretativi, rimane a mio avviso non solo la più condivisibile ma anche la più proficua. Egli scrive infatti che «il
concetto che la musica debba essere logicamente connessa da puri legami tematici è stato quasi
altrettanto dannoso ai compositori quanto ai teorici e agli insegnanti. Molti capolavori presentano
una superba struttura di connessioni tematiche, ma tali connessioni non possono garantire di per
sé una logica molto superiore a quella di una serie di giochi di parole. […] La fuga, ad esempio,
non è una forma, nel senso in cui parliamo di forma sonata: è un tipo di ordito, non una forma. Si
può comporre a mo’ di fuga, così come scrivere poesie in versi sciolti» (cfr. D. F. TOVEY, Alcuni
aspetti delle forme artistiche beethoveniane, in AA.VV., Beethoven, a cura di G. Pestelli, “Polifonie”,
Il Mulino, Bologna, 1988, p.36, passim). In realtà, come Tovey sa benissimo, una fuga può essere sia procedimento compositivo che forma musicale, né più né meno di quanto accade per la variazione. Tuttavia, la “logica” delle connessioni tematiche presente in una fuga di Beethoven è, in
generale, assai più libera di quanto viceversa non accade in un suo tempo di sonata. Ciò per ribadire l’assunto in base al quale, giunto a questa fase del suo lavoro, Beethoven non intende più la
fuga come una forma statica e chiusa, ma come un laboratorio permanente attraverso il quale sottoporre a revisione integrale tutte le forme codificate dalla tradizione settecentesca.
6 G. CARLI BALLOLA, cit., p. 282.
7 Non è forse superfluo ricordare che i termini “soggetto” e “controsoggetto” non hanno alcun
significato psicologico o gnoseologico, e non rinviano pertanto a centri di coscienza sul tipo di quelli studiati dalle scienze sociali dalla fenomenologia o dalla metafisica classica. “Soggetto” è, nel linguaggio della musica, sinonimo esclusivo di “tema”, e pertanto ha un significato che rinvia direttamente al linguaggio letterario e teatrale: il “tema musicale” sta infatti a una rappresentazione scenica esattamente come lo svolgimento sta allo schema narrativo. Esso è l’idea di fondo dalla quale si sviluppa un’azione.
8 P. M. TH. V. D’INDY, Analyse des dix-sept quatuors de Beethoven, d’après les notes prises à
la Schola Cantorum de Paris (en 1900) au cours de composition de M. Vincent d’Indy, Recueillies
et rédigées par P. Coindreau, Paris, 1910, p. 23. Agli appunti di Pierre Coindreau, piuttosto asciutti e schematici, si attiene scrupolosamente anche Joseph De Marliave nella sua lettura della “Grande Fuga” in J. DE MARLIAVE, Les Quatuors de Beethoven, Librairie F. Alcan, Paris, 1925, tr. ingl. a
cura di H. Andrews, Beethoven’s Quartets, with an Introduction and Notes by J. Escarra and a Preface by G. Fauré, Dover Publications, New York, 1957, pp. 293-295.
9 G. CARLI BALLOLA, cit., p. 282.
10 J. KERMAN, cit., pp. 296 ss.
11 J. DE MARLIAVE, cit., p. 297.
12 E. BURKE, Philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful, A.
& J. M. Duncan, Glasgow, 1818, tr. it. Inchiesta sul Bello e il Sublime, a cura di G. Sertoli e G. Miglietta, “Aesthetica”, 12, Aesthetica, Palermo, 1985.
13 J. DE MARLIAVE, cit., pp. 310-311 (la traduzione dall’inglese è mia).
14 W. VON LENZ, Beethoven et ses trois styles, pubblicato a S. Pietroburgo nel 1852 e a Bruxelles nel 1854, riedito da Gustave Legouix a Parigi nel 1909, con una premessa e una bibliografia
di opere relative a Beethoven di Michel De Calvocoressi, lo studio è più volte riapparso in lingua
francese sino all’edizione della Da Capo Press di New York, 1980, che mi risulta essere l’ultima.
NOTE
li, il sentire sempre più smarrito, come di chi brancola nel buio. La terza parte,
coincidente con la ripresa del tema, è la fine dell’incubo. Il movimento conclusivo ha per l’appunto il compito di radicalizzare la parodia di questo conflitto,
basato com’è interamente sull’alternarsi di due frammenti tematici, l’uno il rovescio dell’altro. Il primo, sconvolto e angosciato, chiede «deve essere così?»,
mentre l’altro, gioioso, risponde serenamente «deve essere così!».
85
86
FEUERBACH TRA HOBBES E SCHOPENHAUER:
DUE ETICHE E DUE ANTROPOLOGIE A CONFRONTO
di Giuseppe Moscati
Le grandi tematiche della felicità e della virtù, del desiderio e della volontà,
ci forniscono una chiave di rilettura, tra l’altro, del possibile confronto di un autore come Ludwig Feuerbach con un suo contemporaneo, Arthur Schopenhauer1, e con un altro “filosofo-antropologo” che a suo tempo si era occupato delle stesse questioni, vale a dire Thomas Hobbes. Proviamo a trarre, su tali
aspetti, delle brevi considerazioni proprio in riferimento al possibile rapporto tra
le visioni del mondo di questi tre autori.
Partiamo da Schopenhauer, che viene letto da Feuerbach in particolare nel
1860, è da lui apprezzato in riferimento ad alcune argomentazioni etiche, ma
che nel complesso dal filosofo bavarese viene giudicato un “moralista soprannaturalista”, anche se di particolare prestigio2. Se, infatti, a Feuerbach dovette
interessare da vicino ciò che Schopenhauer scriveva della volontà di vivere e
della corporeità, dell’etica e delle sensazioni, ad essere inaccettabile per il filosofo bavarese rimaneva l’impronta metafisica di quella morale, nonché il suo
esito nichilistico. Nel suo Spiritualismo e materialismo, anzi, Feuerbach sarebbe entrato nel vivo del discorso sulla sensazione e sul suo oggetto: «“La sensazione, di qualunque specie sia –dice Schopenhauer, un idealista contagiato
peraltro dall’‘epidemia’ del materialismo– resta limitata alla regione compresa
entro la pelle, e non può quindi contenere mai niente che si trovi al di là di questa pelle, dunque fuori di me”. Ora però l’oggetto non è per noi soltanto oggetto della sensazione, è anche la base, la condizione, il presupposto della sensazione; all’interno della nostra pelle noi abbiamo un mondo oggettivo, ed è
questo soltanto il motivo per cui ne trasponiamo uno ad esso corrispondente
fuori della nostra pelle»3.
L’etica schopenhaueriana, insomma, «appariva a Feuerbach degna di considerazione in quanto aveva individuato nella compassione un fondamento positivo, reale, e quindi efficace dell’azione morale. Le riserve di Feuerbach riguardavano, invece, l’interpretazione metafisica data da Schopenhauer al principio della compassione, che si sarebbe dovuto invece più coerentemente riportare al principio sensibile della felicità, e soprattutto la distinzione del carattere intellegibile da quello fenomenico attraverso cui Schopenhauer –in questo
fedele discepolo di Kant– pretendeva di mediare la più assoluta libertà del volere con la sua più rigorosa determinazione»4.
Credo che rimanga significativo, comunque, che, ad appena otto anni dall’uscita de Il mondo come volontà e rappresentazione, il giovane Feuerbach discutesse, nel corpo centrale dei suoi Pensieri sulla morte e sull’immortalità dell’anima, della rappresentazione che l’uomo si fa del mondo in cui vive. «L’Essere essenziale di un individuo –leggiamo– è perciò anche il modo del suo
pensare; da questo, infatti, dipende e viene determinato il modo del suo senti-
NOTE
La tesi del Lenz riprende a sua volta la tripartizione introdotta da François-Joseph Fétis in F.-J. FÉTIS, Biographie universelle des musiciens, Voll.1-8, F. Didot Freres Fils & Co., Paris, 1835.
15 T. W. ADORNO, Beethoven. Philosophie der Musik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,
1993, tr. it. di L. Lamberti, Beethoven. Filosofia della musica, a cura di R. Tiedemann, “Biblioteca
Einaudi”, 118, G. Einaudi, Torino, 2001, fr. [311], p. 217.
16 PH. A. AUTEXIER, Beethoven. La force de l’absolu, Gallimard, Paris, 1991, tr. it. di S. Orsi,
Beethoven. La forza dell’assoluto, a cura di M. Buysschaert, “Universale Electa/Gallimard”, 31,
Electa/Gallimard, Milano, 1993, p. 93.
17 T. W. ADORNO, cit., fr. [308], p. 216.
18 Inammissibile, in proposito, ritengo sia il deduzionismo di chi vorrebbe annullare qualunque
soluzione di continuità nell’opera tarda beethoveniana fra la tendenza all’astrattismo e all’arcaicismo e una sua presunta “atemporalità”, al punto da concludere, come sostiene Dahlhaus, che essa è «già alla sua nascita intimamente estranea all’epoca a cui appartiene esteriormente» (cfr. C.
DAHLHAUS, cit., p. 220).
19 G. CARLI BALLOLA, cit., p. 286.
87
88
l’istinto di felicità degli altri al pari del suo, riconosce la differenza –anche sessuale– nell’unità10. Proprio qui, nel quadro di un’argomentazione etica che si
gioca tra i termini di unità, responsabilità ed impegno-autoimpegno, Walter
Schulz va alla ricerca di una notevole vicinanza di prospettiva tra l’etica di
Martin Buber e l’etica del rapporto (Ethik des Bezuges) feuerbachiana. Lo studioso tedesco così scrive in merito: «L’etica umanistica individuale, che appartiene alla borghesia del XIX secolo, viene messa in dubbio in modo decisivo nel primo dopoguerra. Si cerca di concepire un’etica in cui sia centrale il
rapporto reciproco tra gli uomini (das menschliche Miteinander). Il concetto di
responsabilità diventa qui di nuovo essenziale proprio nel suo significato originario secondo cui ognuno è responsabile nei confronti di un altro in quanto
è un Tu. L’impostazione di quest’etica dialogica però è sostenuta da un presupposto determinato: al contrario dell’etica individualistica umanistica, il rapporto reciproco (Miteinander) va elevato a categoria fondamentale, in quanto
deve essere garantito come rapporto reale. Ciò implica che sia necessario
trovare una differenza tra l’Io e il Tu che renda impossibile “livellare” i due termini. Il primo pensatore che ha elaborato espressamente questa argomentazione è Feuerbach […]. Feuerbach –sostiene opportunamente Schulz– fonda
il rapporto interumano nella differenza tra i sessi. Solo questa duplicità sessuale come pura naturalità esclude la possibilità che l’Io e il Tu nel rapporto di
riflessione si annullino reciprocamente come autentici partners»11. E il Feuerbach maturo torna più volte sul tema, come ad esempio in quelle pagine di
Spiritualismo e materialismo in cui il processo di maturazione è inteso come
“la vera identità di soggetto e oggetto”12.
Del resto è proprio il confronto con un autore come Buber che può aiutarci
a riconsegnare il giusto valore alle pagine di Feuerbach, tanto più che il debito culturale di Ich und Du (1913) nei confronti dell’opera feuerbachiana è esplicito13. «Nel rapporto inter-soggettivo il comportamento rivelativo dell’io –ha notato Prini– si pone in funzione e nella prospettiva di un tu come rivelante e rivelato. L’io è certamente ipseità, ossia è se stesso, autorelazione, sia pure all’inizio soltanto virtuale, ma il sé di questa autorelazione perderebbe ogni senso se non fosse fin dall’inizio anche etero-relazione, relazione all’altro»14.
Perciò l’uomo, secondo Feuerbach, non può ridursi ad un essere che contende i beni ai propri simili, non può proprio fare a meno della sua “fede” nell’unità con gli altri uomini. Lo stesso Alberto Burgio scrive: «“Homo homini
Deus” è il “supremo principio pratico” di una filosofia capace di restituire alla
comunità degli uomini il governo del proprio destino»15, mentre nella Presentazione al saggio del ’46 il Frigo non poteva che concludere con la messa in evidenza dell’attualità del filosofo tedesco: «La teoria di Feuerbach, secondo cui
l’uomo nella religione ha a che fare con se stesso, ha fatto epoca. L’oggetto
della filosofia contemporanea è effettivamente solo l’uomo in rapporto con la
natura e con l’altro uomo. Feuerbach ha reso effettivamente obsoleto lo strumentario con cui il teologo e il credente un tempo si avvicinavano a Dio. Oggi
il cristiano e il teologo non si preoccupano, né sentono l’esigenza, di provare
razionalmente l’esistenza di Dio: come per il pensiero dell’essere, anche per il
pensiero di Dio sembrano usurate e inservibili tutte le categorie e le strategie
NOTE
re, del suo intendere e del suo agire e, in generale, il suo restante Essere; infatti, il mondo è come egli se lo rappresenta ed egli stesso è ciò che il mondo
è per lui e come è per lui. Il tuo modo di pensare, determinato e particolare,
che mai ha sostenuto la prova del fuoco della scepsi e della negazione, è dunque per te il principio fondamentale assoluto tanto del tuo Essere quanto di tutte le tue rappresentazioni, di tutti i tuoi pensieri, di tutte le tue intuizioni. Ma nelle conseguenze di questo principio […], cioè nelle tue rappresentazioni, conoscenze ed intuizioni determinate, spunta in te la coscienza della mancanza, dei
confini di esse, e quindi del loro stesso principio»5, mancanza che solo in quelle condizioni (conseguenze e determinazioni) si rende “oggetto per te”6. «Perciò –insisteva Feuerbach– consideri il mondo che ti rappresenti come il mondo effettivo in quanto tale»7.
Quanto invece alla questione del rapporto Feuerbach-Hobbes, esso può
dirsi anche confronto tra due “opposte antropologie”: all’homo homini lupus
hobbesiano, infatti, Feuerbach oppone un deciso homo homini Deus. In particolare su questo aspetto ha impostato la sua lettura del saggio di Feuerbach
del 1846, Contro il dualismo di corpo e anima, di carne e spirito, Gian Franco
Frigo, il quale parla di “ateismo umanizzante” e di vero e proprio rovesciamento del pessimismo hobbesiano8. «Come l’Autore stesso avverte –egli scrive– è
un saggio di chiarificazione dei Principi della filosofia dell’avvenire […]. In essi, Feuerbach, rigettando con forza ogni forma di estraneazione idealistica o
teologica, indicava come unico tema della riflessione filosofica l’uomo nella sua
naturalità e finitezza. Il saggio sul Dualismo rappresenta dunque una ripresa e
un chiarimento di quel compito attraverso la messa a fuoco della struttura concettuale “duplicante” che caratterizza la razionalità non solo teologica, ma anche scientifica dell’epoca moderna e senza il cui superamento nessuna autentica antropologia è possibile. L’esaltazione convinta e non priva di pathos della sensibilità in tutte le sue sfumature propone un’antropologia in cui l’uomo diventa homo homini Deus, capovolgendo il pessimistico motto di Hobbes che
sta emblematicamente all’inizio del pensiero moderno»9.
Qui è l’antropologia, dunque, il faro verso cui la filosofia nuova è invitata a
dirigersi, è l’idea di un’antropologia radicata nei sensi e in ciò che sta a cuore
all’uomo –compresa la religione– ad essere cioè idea guida per l’uomo a-venire. In essa rivivono tutte le convinzioni feuerbachiane più profonde, dall’unità
di carne e spirito al concetto di natura spinozianamente (o brunianamente) intesa, dal rapporto io-tu all’etica comunicativa, dal linguaggio come massimo
potenziale di valore dialogico alla “passività” dell’essenza umana… Ma, pur riconoscendo la imprescindibilità di adottare, in quella filosofia dell’avvenire che
Feuerbach propone e auspica, dei principi passivi, e, pur ammettendo che l’uomo è se stesso nel mentre avverte il bisogno –e scopre la propria come una
natura suscettibile di essere “ferita” da ciò che le è esterno (oggetto o altri oggetti)–, Feuerbach respinge la visione dell’homo homini lupus non potendo
condividerne la radicalità del pessimismo.
L’uomo di Feuerbach, d’altra parte, è costitutivamente aperto all’Altro, ricerca una via etica di comunione (e con essa una politica in tal senso), tende
al soddisfacimento dei propri e degli altrui desideri, sa, cioè, riconoscere
89
90
1 Nell’ambito della critica, è forse Ferruccio Andolfi ad interpretare in maniera più equilibrata il
rapporto Feuerbach-Schopenhauer (cfr. F. ANDOLFI, L’eudemonismo di Feuerbach, in L. FEUERBACH, Etica e felicità, Guerini e Associati, Milano 1992, pp. 109-111), assieme al Pacchi (cfr. A. PACCHI, Introduzione ad AA.VV., Materialisti dell’Ottocento, a cura dello stesso, Il Mulino, Bologna
1978, pp. 16-21), il quale affronta le tematiche della conoscenza, della materialità e della corporeità, su cui è invece da vedere soprattutto il saggio di L. CASINI, La riscoperta del corpo. Schopenhauer, Feuerbach, Nietzsche, Studium, Roma 1990.
2 Cfr. F. ANDOLFI, L’eudemonismo di Feuerbach, cit., in particolare pp. 109-110.
3 L. FEUERBACH, Spiritualismo e materialismo specialmente in relazione alla libertà del volere,
a cura di F. Andolfi, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 189 (corsivi miei). «Noi sentiamo –continua Feuerbach– “all’interno della pelle” – ma all’interno di una pelle che è porosa, al punto che sull’intera superficie cutanea di un uomo adulto non si trovano meno di sette milioni di pori, vale a dire di
aperture, di uscite verso l’al di là della pelle […]. Respiriamo prima ancora di vedere, di udire, di
toccare, di odorare, di gustare; respiriamo perché senz’aria non possiamo vivere né sentire. Senza respiro non c’è ossigeno, almeno per noi e in noi, senza ossigeno non c’è fuoco né calore, senza calore non c’è sensazione né entusiasmo. L’ardore della sensazione, dell’entusiasmo –noi sentiamo, anzi, soltanto in stato di eccitazione nervosa– non è una frase poetica, ma una verità percepibile ai sensi, dimostrabile anche con il termometro. Quasi tutte le lingue e i pensatori dell’antichità identificano addirittura anima, spirito, principio vitale con aria, etere (aria finissima delle regioni superiori), calore, fuoco» (ivi, pp. 189-190).
4 F. ANDOLFI, Introduzione a L. FEUERBACH, Spiritualismo e materialismo…, cit., pp. 25-26 nota
23. Lo stesso Schopenhauer, del resto, identifica coscienza e corporeità, svelando le proprie influenze materialistiche frutto di letture filosofiche (Hobbes, Cabanis, illuminismo francese in generale), ma anche scientifiche (Bichat, Magendie). Per questo, cfr. A. PACCHI, Introduzione ad AA.VV.,
Materialisti dell’Ottocento, cit., p. 17.
5 L. FEUERBACH, Pensieri sulla morte e sull’immortalità dell’anima, a cura e con una preziosa
Introduzione di F. Bazzani, Editori Riuniti, Roma 1997, pp. 133-134.
6 Cfr. ivi, p. 134.
7 Ibid. Riguardo alla volontà, il giovane filosofo già aveva scritto: «Attraverso la specie del volere, la volontà –che in sé, in quanto sostanza ed elemento, è eguale ed una in tutti gli uomini– diviene la tua volontà, specificata, limitata, differenziata; diviene, cioè, carattere» (ivi, p. 103, corsivi
miei). Il carattere veniva così a coincidere, in quanto volontà determinata, con l’essenza stessa
della persona: «Ma tu stesso, questo soggetto particolare, non sei assolutamente nulla al di fuori
di questa volontà specificata; questa specie della volontà, questo limite della volontà una ed uguale a se stessa, è la tua essenza, sei tu stesso. Il carattere dell’uomo, infatti, non è una qualità o un
possesso del medesimo, bensì fa tutt’uno con lui in quanto soggetto particolare […]. Ciò che tu sei
lo sei soltanto nell’ambito di questa misura» (ibid., corsivi miei).
8 Cfr. G.F. FRIGO, Homo homini Deus, ossia l’ateismo umanizzante, in L. FEUERBACH, Contro il dualismo di corpo e anima, di carne e spirito, “Micromega”, n. 1 (gennaio-dicembre) 1997, pp. 147-151.
9 Ivi, pp. 147-148.
10 Nei Principi della filosofia dell’avvenire si legge: «Il punto di vista naturale per l’uomo, il punto di vista della differenza tra l’io e il tu, tra il soggetto e l’oggetto, è il punto di vista assoluto, e di
conseguenza anche il punto di vista della filosofia» (L. FEUERBACH, Principi della filosofia dell’avvenire, a cura di L. Casini, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 138-139, § 56).
11 W. SCHULZ, Le nuove vie della filosofia contemporanea, vol. V: Responsabilità, trad. di M.
Garda, Marietti, Genova 1988, pp. 121-122.
12 Cfr. L. FEUERBACH, Spiritualismo e materialismo…, cit., pp. 190-191
13 «Buber, che era stato alla scuola di Jodl, confessa di aver ricevuto da Feuerbach, fin dalla
sua giovinezza, “l’impulso decisivo” (Il problema dell’uomo) per la sua teoria dell’Io-Tu […]» (U. PERONE, Invito al pensiero di Feuerbach, Mursia, Torino 1992, p. 177). Del principio dialogico, comune a Feuerbach e Buber, poi, si sono interessati il Löwith e il Sass (cfr. C. CESA, Introduzione a Feuerbach, Laterza, Roma-Bari 1978, pp. 157-158).
14 P. PRINI, Alcune considerazioni sopra l’interpersonalismo delle scelte e delle responsabilità,
in Aa.Vv., Libertà ed etica della responsabilità, Cittadella, Assisi 1997, p. 20.
15 A. BURGIO, Introduzione a L. FEUERBACH, L’essenza del cristianesimo, prefaz. di A. Banfi, Feltrinelli, Roma 1994, p. XVIII.
16 Cfr. M. HEIDEGGER, Essere e tempo, a cura dello stesso, trad. it. di E. Mazzarella, Guida, Napoli 1980, p. 106.
17 G. F. FRIGO, Presentazione di L. FEUERBACH, Contro il dualismo…, cit., p. 151 (corsivi miei).
18 A. BANFI, Prefazione a L. FEUERBACH, L’essenza del cristianesimo, cit., p. 7 (corsivi miei).
NOTE
che finora avevamo usato. Ormai ogni nuovo modo di considerare Dio e la religione deve fare propria l’indicazione di Feuerbach, scorgendovi in primo luogo un problema dell’uomo. Dalla prospettiva contemporanea, che ha accettato di vivere nell’orizzonte della morte di Dio, possiamo interpretare l’ateismo di
Feuerbach come il cosciente ritirarsi dell’uomo nella sua naturalità nel senso in
cui Heidegger ha parlato di un ritirarsi dell’essere nell’accadere e nel venire a
compimento naturali (“Storia dell’essere significa destino dell’essere”16). Una
naturalità, che per Feuerbach e per noi, non è affatto pacificata e in sé compiuta, ma –conclude il critico– scissa e aspirante a una pienezza di senso, per
soddisfare la quale l’uomo ricorre all’autoestraniazione religiosa o esperisce il
divino come assenza»17.
Su naturalità e impulso alla liberazione dell’uomo feuerbachiano si era già
espresso, con riferimento allo stretto legame del pensiero feuerbachiano con il
vissuto dell’uomo Feuerbach, Antonio Banfi. Il quale ci suggerisce che «il centro vivo e personale della filosofia di questo pensatore apparentemente freddo,
rigido, malato di insuperabile isolamento, è proprio la fede e l’amore per l’uomo;
non per l’uomo di ragione dell’illuminismo e neppure per l’uomo spirituale del romanticismo idealista, ma per l’uomo in carne ed ossa che nella sua naturalità
stessa ha il principio di un intimo sviluppo, per l’uomo che ha il suo equilibrio dinamico nell’infinita, inappagabile sete di felicità, verso cui si tende con tutta la
forza del suo sentimento e del suo desiderio. La liberazione di quest’uomo dai
molti vincoli che l’incatenano è il problema centrale del pensiero di Feuerbach,
che pur di questi vincoli ha dolorosamente sofferto»18. Ecco perché l’etica e la
visione antropologica feuerbachiana, confrontate con le posizioni di altri due
classici del pensiero filosofico quali sono Hobbes e Schopenhauer fungono,
quanto all’attualità di Feuerbach, da significativa, decisiva cartina al tornasole.
91
di Cosimo Caputo
92
Nel 1978, nell’introduzione al suo Ideologia (ISEDI, Milano, p. 15; nuova
ediz. Meltemi, Roma 2005, p. 58), Ferruccio Rossi-Landi scriveva che “la grandezza di Marx fondatore del socialismo scientifico ha nuociuto alla grandezza
di Marx come pensatore; e che è tempo di rimediare”.
Se il Marx agitatore rivoluzionario può essere messo da parte, il Marx studioso resta ancora valido per la portata demistificante e innovativa delle sue posizioni teoriche, per le molte domande che ancora non hanno avuto risposta, se
non quella del rifiuto acritico accomunato al rifiuto del socialismo reale. Eppure,
come Adam Smlth, Marx continuerà ad essere una fonte per chiunque voglia capire il capitalismo e tenere viva la prospettiva (o la speranza) di andare oltre il
mondo così-com’è. Nel momento in cui il “nuovo ordine mondiale” restaura il suo
neoliberismo, nessuna denegazione riesce a sbarazzarsi di tutti gli “spettri di
Marx”, dice Jacques Derrida nel suo omonimo libro del 1993 (trad. it. Cortina, Milano 1994, p. 51). È in nome della giustizia e della responsabilità che Derrida torna a parlare di Marx: “Sarà sempre un errore non leggere e rileggere e discutere Marx. E insieme a lui, tanti altri […]. Sarà sempre un errore, un venir meno alla responsabilità teorica, filosofica, politica. Da quando la macchina per far dogmi e gli apparecchi ideologici ‘marxisti’ (Stato, partito, cellule, sindacati e altri luoghi di produzione dottrinale) sono in via di estinzione, non abbiamo più scuse,
solo alibi, per distoglierci da questa responsabilità. Non ci sarà altrimenti avvenire, nessun avvenire senza Marx. Senza la memoria e l’eredità di Marx: e comunque di un certo Marx, del suo genio, di uno almeno dei suoi spiriti” (ivi, p. 22).
Con lo spirito politico, filosofico, economico convive in Marx lo spirito matematico, come provano i suoi Manoscritti matematici, ora tradotti in italiano da
Augusto Ponzio e ripubblicati da Spirali nel dicembre 2005, dopo una prima
edizione del 1975 presso le edizioni Dedalo di Bari, curata dallo stesso Ponzio
e da Francesco Matarrese, preceduta, nel 1972, dalla traduzione di Lucio Lombardo Radice del manoscritto “Sul concetto di funzione derivata”, tranne l’“Aggiunta” finale, nel n. 6 dei “Quaderni” di Critica marxista, intitolato “Sul marxismo e le scienze”.
Nel 1974 esce l’edizione tedesca, mentre quella inglese è del 1983, quella
francese del 1985 e del 1987 l’edizione in gallego.
Dell’esistenza di questi manoscritti dette notizia Engels nella seconda edizione dell’Anti-Dühring (1885). La loro pubblicazione integrale era stata annunciata
nel 1927 dall’Istituto Marx-Engels di Mosca come XVI volume delle Opere dei
due pensatori tedeschi, ma apparvero solo nel 1968 (Nauka, Mosca), al di fuori
del progetto originario, in una edizione bilingue (tedesco e russo) sotto la direzione di Sonia A. Janovskaja, che già dagli anni Venti si occupava di questi scritti
marxiani ma che era morta proprio nel 1968, poco prima della pubblicazione del
libro. Questa traduzione russa è divisa in due parti. La prima parte, intitolata Natura e storia del calcolo differenziale, contiene Due manoscritti sul calcolo differenziale: “Sul concetto di funzione derivata” e “Sul differenziale”, del 1881 (apparsi per la prima volta in russo nel 1933 nella raccolta “Marxismo e scienza” nella rivista Sotto le bandiere del marxismo), Abbozzi e aggiunte al manoscritto “Sul
differenziale” (anche questi pubblicati nella stessa raccolta “Marxismo e scienza”) e i manoscritti sulla Storia del calcolo differenziale.
La seconda parte, sotto il titolo Descrizione dei manoscritti matematici, raccoglie in ordine cronologico e analizza filologicamente i quaderni di appunti sulla matematica lasciati da Marx, riproducendone alcune parti.
L’edizione russa, presentata da Sonia A. Janovskaja, è corredata di note e
di sei appendici concernenti le fonti utilizzate da Marx. Tutte le edizioni successive in altre lingue, ivi compresa questa edizione italiana, tengono conto dell’originale tedesco pubblicato come testo a fronte della traduzione russa.
In una lettera dell’11 gennaio 1858 a Engels, Marx dice che, lavorando all’elaborazione dei “principi dell’economia”, ha avvertito la necessità di riprendere e approfondire la sua conoscenza dell’algebra. E in un’altra lettera ancora a Engels, scritta tre giorni dopo, dichiara che si dedicherà alla lettura della
Logica di Hegel, dove il calcolo differenziale è oggetto di approfondita riflessione. “Negli anni successivi –scrive Ponzio nell’introduzione– e per tutti gli anni
settanta, i riferimenti allo studio della matematica divengono rarissimi. Tuttavia,
nella lettera del 31 maggio 1873, Marx parla di applicazione della matematica
all’analisi economica con diretto riferimento a fenomeni come, ad esempio, la
fluttuazione dei prezzi, per i quali il calcolo differenziale si rivela particolarmente utile […]. Ma è soprattutto negli ultimi anni della sua vita (morì il 14 marzo
1883) che Marx si occupa di matematica in maniera sistematica, dedicandosi
esclusivamente al calcolo differenziale” (p. 23).
Secondo Sonia Janovskaja ed Ernest Kol’man, gli interessi matematici di
Marx sono unicamente funzionali al suo lavoro di critica dell’economia politica.
Alain Alcouffe, curatore dell’edizione francese dei Manoscritti, propende invece per l’autonomia degli studi matematici dagli interessi marxiani per l’economia politica, sottolineandone piuttosto la valenza filosofica per le loro implicazioni nella logica dialettica. In tal modo egli collega la riflessione di Marx con
quella di Hegel e fa notare che gli stessi Janovskaja e Kol’man sono autori di
un testo, Hegel e la matematica, pubblicato nel 1931, in cui riconoscono l’origine hegeliana dei lavori matematici di Marx, anche se con lo scopo di mostrarne la differenza con l’orientamento idealistico.
Certamente il rapporto con Hegel non è marginale neppure negli scritti matematici marxiani, ma non è “il caso di enfatizzarlo come tende a fare invece
Alcouffe”, commenta Ponzio (p. 17) che ritiene riduttiva anche la tesi di Janovskaja e Kol’man (v. p. 14). Gli interessi di Marx, secondo Ponzio, sono sia di
carattere teoretico (rivolti alla matematica pura) sia di carattere applicato (funzionali alla critica dell’economia politica), ma è la dialettica il baricentro della
sua ricerca; è la dialettica il luogo di congiunzione teorica tra matematica ed
economia politica. Ognuna di esse costituisce una prospettiva attraverso la
NOTE
MARX E LA MATEMATICA
93
94
passiva registrazione, di mera esplicitazione, di accettazione della scienza nel
suo essere di fatto, ma è connesso, al contrario, con la critica, con la trasformazione, con la ricostruzione, con il processo soggettivo della negazione della negazione” (pp. 36-37). Ciò dice di una non contrapposizione con Engels: Marx è
convinto della dialettica delle scienze naturali ed esatte. È la tesi che A. Ponzio
sostiene nel suo Dialettica e verità (Dedalo, Bari 1975, p. 13) e che qui approfondisce evidenziando le differenze di metodo tra i due pensatori nell’interpretazione della dialettica del calcolo differenziale. Così infatti scrive: “Marx, date le
sue profonde conoscenze, poteva direttamente e attivamente intervenire nel
campo della matematica là dove Engels doveva limitarsi a estrapolare leggi ‘dialettiche’ della matematica già data, già fatta, quale si presentava ad un certo livello di sviluppo e relativamente alle sue limitate informazioni; è per questo che,
come fa notare Lombardo radice [nella presentazione dei Manoscritti in “Critica
marxista”, cit., p. 276], il discorso di Engels sul calcolo differenziale dà l’impressione di una ‘dialettica collocata sulla testa’, metafisica (p. 37).
L’approccio di Marx è interno al farsi della matematica e della sua storia,
mentre quello engelsiano è esterno.
“La differente interpretazione del calcolo differenziale in Marx ed Engels
–precisa Ponzio (ibidem)–, piuttosto che essere spiegata, ancora una volta, attribuendo a Engels una diversa concezione della dialettica rispetto a Marx, trova la sua spiegazione in ciò che della dialettica delle scienze naturali ed esatte dice lo stesso Engels nella prefazione del 1885 dell’Anti-Dühring: ‘Per una
concezione dialettica e ad un tempo materialistica della natura è necessario
che siano note la matematica e le scienze naturali. Marx aveva solide cognizioni di matematica’”.
La dialettica materialistica è radicata nella riflessione sulle procedure delle
scienze. Si delinea una nuova forma di storicismo, uno “storicismo scientifico”,
come lo ha chiamato Ludovico Geymonat, che pone al centro dell’attenzione i
cambiamenti concettuali, la dinamica delle teorie, la genesi e lo sviluppi dei fatti scientifici. Non ci si può, pertanto, limitare ad una mera applicazione della matematica all’economia senza preoccuparsi di verificarne i fondamenti, come
hanno fatto i “marginalisti” che hanno accettato il calcolo differenziale come veniva presentato, aprioristicamente, senza una valutazione delle sue strutture logico-storiche. Operando in questo modo, non solo il contenuto (il calcolo) ma
anche la sua espressione algebrica divengono forme senza sostanze, astrazioni senza determinazioni, puri segni-feticci. Il feticismo scientifico è rapportabile
al feticismo economico. Si può così ipotizzare –dice Ponzio– una connessione
nelle moderne teorie economiche “fra una visione feticistica del mercato e una
visione feticistica del simbolo matematico: non si indaga sui processi di produzione, sulla genesi del valore di scambio della merce e del valore di scambio del
simbolo […]. Risulta allora che la critica dell’economia politica e la critica della
fondazione metafisica del calcolo e del simbolo matematico devono procedere
in stretta connessione”. Se poi dal segno matematico si passa la segno in generale, emerge “la connessione fra critica dell’economia politica e teoria critica
del segno” (p. 42), ovvero una critica dell’economia politica del segno che dice
–come ha evidenziato Rossi-Landi– di un’omologia fra semiotica ed economia.
NOTE
quale è possibile considerare gli scritti matematici marxiani. “In primo luogo
–ancora nelle parole di Ponzio–, relativamente all’oggetto diretto del discorso,
cioè in riferimento alla teoria e alla storia del calcolo differenziale, al contributo che, in sede di revisione critica delle concezioni sei-settecentesche avviatasi a partire da Lagrange e portata avanti nell’Ottocento da A-L. Cauchy (17891857) e Karl Weierstrass (1815-97), essi offrono. In secondo luogo, essi possono essere analizzati in riferimento alla complessa problematica della dialettica, ove si evidenzi il senso che l’interpretazione marxiana dell’operazione differenziale assume in rapporto al processo dialettico della negazione della negazione, visto che, come Marx stesso dice all’inizio del manoscritto Sul concetto di funzione derivata, l’operazione differenziale risulta un processo particolare di negazione della negazione […]. In terza istanza, i Manoscritti matematici
rappresentano il modo di elaborazione, di perfezionamento e di sviluppo dell’impalcatura matematica dell’analisi economica marxiana, e mostrano come
Marx si rendesse conto della necessità di padroneggiare il calcolo differenziale occupandosene in maniera sempre più diretta ed organica [… nel] periodo
in cui cominciava a diffondersi, con Menger, Jevons e Walras, la ‘moda’ della
teoria marginalistica, che finirà con il monopolizzare l’impiego della matematica e del calcolo differenziale nello studio dell’economia” (pp. 28-29).
Matematica, dialettica ed economia politica si intersecano e questo loro intersecarsi è in perfetta consonanza con la concezione dialettico-materialistica
di Karl Marx.
La prima prospettiva entro cui si possono vedere i Manoscritti riguarda la
storia della matematica e più in generale la storia delle scienze, e consiste proprio nel riconoscere l’esistenza di uno sviluppo e di una trasformazione delle
teorie e delle metodologie scientifiche. Le scienze non sono una pacifica accumulazione di risultati ma crescono ben diversamente: esse rimettono cioè in discussione i princìpi delle teorie già accettate, ne correggono i risultati acquisiti o ne limitano la validità e soprattutto stabiliscono sempre nuovi rapporti fra di
esse, generando nuovi campi di sapere. La vita delle scienze è integrata nella
vita sociale e politica e ne subisce i condizionamenti delle scelte ideologiche
che bloccano o accelerano i programmi di ricerca. Le astrazioni scientifiche sono sempre determinate, materializzate, attraverso opposte determinazioni. Diremmo che le astrazioni sono sempre ibride, frammiste all’ombra della loro luce. Non c’è separazione escludente fra le scienze, come fra scienze e filosofie. Le scelte teoriche rispondono sempre a una progettazione sociale.
Anche le altre due prospettive sui Manoscritti, quella più propriamente filosofica sulla dialettica e quella sull’economia politica, devono essere viste nella
loro contrapposizione ad un approccio metafisico che concepisce il mondo come persistente all’infinito nel suo esser-così senza che possa trasformarsi.
“L’evidenziazione della natura dialettica del calcolo differenziale –aggiunge
Ponzio– e, in generale, della matematica coincide con la sua critica e con le procedure che ne realizzano lo sviluppo in senso scientifico. Risulta in tal modo una
visione non dogmatica, non metafisica della dialettica e delle scienze, secondo
la quale il riconoscimento del carattere oggettivo della dialettica, anche nel caso
della matematica e delle scienze della natura, non implica un atteggiamento di
95
di Nicoletta Ghigi
96
La traduzione dei Dialoghi metafisici di Hedwig Conrad-Martius1, condotta
in maniera magistrale da Anselmo Caputo, offre la possibilità per riaprire uno
scenario significativo sull’orizzonte della storia della filosofia e del pensiero
scientifico contemporanei e, allo stesso tempo, per ripensare da una nuova
prospettiva le più importanti analisi della scuola fenomenologica.
Come sostiene da tempo Ales Bello nei suoi numerosi, nonché essenziali,
studi sulle opere e sul pensiero dell’autrice, la sua impostazione originale e il suo
peso all’interno della scuola fenomenologica di Husserl –di cui era allieva– ed
anche nel panorama della filosofia occidentale del XX secolo, è di indubbio valore2. Conrad-Martius ha infatti proposto una fenomenologia della vita e della natura che, pur allontanandosi dalla fenomenologia husserliana per il mancato uso
dello strumento privilegiato dell’analisi fenomenologica, vale a dire dell’epoché
trascendentale, conserva –come in Edith Stein, sua amica e compagna di ricerche3– il carattere dell’analisi dell’essenza proprio della fenomenologia eidetica.
«La soglia del fenomenologicamente rilevante, nota Caputo, così, si amplia sino
a includere, per esempio, anche le fiabe e gli spiriti che le animano, allo scopo di
arrivare alla chiarificazione di ciò che è spirituale» (ib., p. 19).
Differenziandosi dunque sostanzialmente dalla fenomenologia del Maestro,
la filosofia di Conrad-Martius, pur sempre nella sua assoluta originalità, si propone come una fenomenologia, come cioè un’analisi dell’essenza e del “senso” delle cose con cui si trova a fare i conti. Da questa prospettiva, la sua filosofia della vita può dirsi orientata verso una descrizione di tipo realistico, vale
a dire, concernente propriamente la realtà delle cose che animano il mondo
della vita. E di ausilio ad una simile ricerca è la biologia che è utile a chiarire
la struttura dei viventi e la loro insita finalità vitale che li guida verso un unico
senso. «Le piante, gli animali, gli esseri umani, scrive nella Prefazione Ales
Bello, sono indagati mostrando che non è possibile comprenderli separandoli;
essi manifestano una mirabile gradualità e interconnessione, che culmina negli umani…l’esame degli organismi compiuto dalla biologia dimostra che questa storia ha un senso e una finalità»4. In questo orizzonte di ricerca i Dialoghi
si costituiscono come una sorta di fenomenologia del mondo naturale e umano e si propongono di delineare l’entelechia, l’anima, che muove contemporaneamente la natura vegetale e quella animale.
Le tre sezioni in cui si articola l’opera, scritta sotto forma di dialogo tra due
personaggi realmente esistiti, Montano e Psilandro, sono dedicate a tre fondamentali aspetti di questa fenomenologia, vale a dire: Pianta e animale, L’anima, Dell’uomo, quest’ultima suddivisa a sua volta in: Dell’animale e della sua
fonte, Demoni e angeli, spirito e spiriti, L’evoluzione – L’uomo. Tali dialoghi sono detti metafisici sulla base del concetto aristotelico di metafisica per cui l’argomento principale è l’essere, concepito in tutte le sue forme e varietà. Parlare dell’essere significa dunque parlare di metafisica come ontologia reale, ovvero come una disciplina che ha per oggetto la realtà dell’essere delle cose5.
In questo senso, la fenomenologia, intesa come descrizione dell’essere delle
cose, per Conrad-Martius conduce in ultima analisi alla metafisica. Proprio nel
condurre l’analisi fenomenologica, scrive infatti a proposito, ci si spinge «infine
completamente nelle braccia della metafisica»6.
Nella prima sezione, Pianta e animale, allo scopo di rintracciare i fondamenti della realtà nell’essere della vita, i due interlocutori prendono in considerazione la possibilità che la pianta abbia un’anima. L’essere che promana dalla pianta è appunto la sua vita, l’anima, che attraversa tutta la sua estensione
dall’interno all’esterno, rendendo così la pianta un’unità vivente dotata di un
suo motore vitale, l’anima. Anche l’animale ha questa virtù, ma proprio per il
fatto che non è immobile ma è in grado di muovere e dominare il proprio corpo (l’estensione in cui si manifesta il suo vivere, ovvero il suo essere animato),
esso possiede l’anima ad un grado superiore. In misura ancora maggiore tale
possesso è proprio dell’uomo, poiché egli ha anche la consapevolezza di possedere un’anima.
Tale questione, l’anima, è l’oggetto della seconda sezione, nei cui riguardi
Conrad-Martius afferma che l’uomo ha uno spirito, ma lo spirito non ha la “pesantezza” dell’anima; mentre cioè l’anima mira a mantenersi in sé in una materia, lo spirito, scrive a proposito, «non giunge mai in se stesso ad un’autentica fissità, non giunge mai ad una rigida ed essenziale determinazione»7. Lo
spirito resta cioè “in sospeso”, e non si materializza fisicamente pur essendo
in senso proprio appartenente ad una fisicità: lo spirito infatti diviene “estasi”
(ossia si manifesta come tale) per l’appunto nell’anima. La sua struttura è poi
differente negli spiriti elementari (quali le creature del mondo fantastico delle
fiabe), negli angeli o nello spirito umano.
Mentre infatti l’uomo, come si sostiene nella terza sezione Dell’uomo, non
è legato ad alcuna sfera dell’essere in particolare, grazie alla sua natura spirituale, i demoni non avendo uno spirito non possono giungere ad un’esteriorizzazione e, quindi, sono condannati a restare privi di una reale esistenza. Poiché egli è dotato di un’anima ed anche di un Sé, ovvero di uno spirito, si distingue dagli angeli decaduti e dai puri spiriti per la sua medietà tra lo spirituale e
il materiale. L’uomo è cioè illuminato dalla sua fonte, vale a dire da Dio, come
di un’entelechia che abita l’intero universo e lo plasma secondo una sua propria intima legge (logos). L’evoluzione del vivente determina così un passaggio dalla sfera materiale, pesante, a quella dello spirito, leggera, secondo un
senso che pervade ogni ente8. E questa ontologia del mondo, la cui esistenza
è un processo continuativo che aumenta con l’aumentare del suo elemento
fondamentale, vale a dire, della luce, rappresenta il significato stesso dell’essere nella sua concretezza. Tutto è dunque materiale, perché attraverso la
quantità di luce presente negli essenti si determina lo stato della materia che li
forma individualmente9.
NOTE
I DIALOGHI METAFISICI
DI HEDWIG CONRAD-MARTIUS
97
98
La competenza scientifica e, come si è più volte sostenuto, l’originalità delle analisi di Conrad-Martius pongono questo testo –tradotto egregiamente e
sempre ricondotto alle opere parallele da parte del curatore Anselmo Caputo–
al centro delle principali questioni ontologiche e fenomenologiche del nostro
tempo. Di indubbio valore scientifico e di assoluta rilevanza in ambito filosofico, i Dialoghi richiedono attualmente di essere considerati dalla critica come
un’opera di grande respiro sia all’interno della scuola fenomenologica sia in relazione al dibattito epistemologico contemporaneo.
1 H. CONRAD-MARTIUS, Dialoghi metafisici, tr. it. di Anselmo Caputo, Prefazione di A. Ales Bello, Besa, Nardò (Le) 2006.
2 Cf. A. ALES BELLO, Fenomenologia dell’essere umano – Lineamenti di una filosofia al femminile, Città Nuova, Roma 1992; L’universo nella coscienza. Introduzione alla fenomenologia di Edmund Husserl, Edith Stein, Hedwig Conrad-Martius, ETS, Pisa 2003; ID., Edith Stein und Hedwig
Conrad-Martius: eine menschlische und intellektuelle Begegung, in R.L. FETZ, M. RATH, P. SCHLUZ
(Hrg.), Studien zur Philosophie von Edith Stein, Alber, München 1993; ID., Hedwig Conrad-Martius
– Ontologia e vita, in A. ALES BELLO, F. BREZZI (a cura), Il filo (sofare) di Arianna. Percorsi del pensiero femminile nel Novecento, Mimesis, Milano 2001; ID., Il problema dell’essere in Edith Stein e
in Hedwig Conrad-Martius, in «Aquinas», 3 (2002); ID., Hedwig Conrad-Martius and the Phenomenology of Nature, in A.T. Tymieniecka (ed.), Phenomenology World-Wide. A Guide for Research
and Study, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2002.
3 Nella sua celebre opera Potenza e atto, Edith Stein discute ampiamente le analisi dei Dialoghi (cf. E. STEIN, Potenza e atto, tr. it. a cura di Anselmo Caputo, Città Nuova, Roma 2003).
4 A. ALES BELLO, Prefazione a H. CONRAD-MARTIUS, Dialoghi metafisici, cit., p. 9.
5 Da qui la differenza fondamentale con Heidegger per il quale la metafisica ha causato l’oblio
dell’essere e, al contempo, con Husserl per il quale la metafisica ha un’accezione storicamente negativa e si configura come l’estrema dogmatizzazione del pensiero filosofico moderno e, quindi,
come allontanamento dalla vera realtà, quella trascendentale dell’Io.
6 H. CONRAD-MARTIUS, Dialoghi metafisici, cit., p. 124.
7 Ib., p. 82.
8 La teoria evoluzionistica si caratterizza in Conrad-Martius, a differenza di Darwin e di Bergson, come sostiene Caputo, per il fatto che «l’evoluzione non procede per linee ritte e regolari,
non si distende da un unico tronco ramificandosi in rami collaterali, ma prende avvio da più sorgenti principali, soggette poi anch’esse a ramificazione» (ib., p. 42).
9 Tali questioni sono trattate anche in: H. CONRAD-MARTIUS, Naturwissenschaftlich-metaphysusche Perpektiven, F.H. Kerle Verlag, Heidelberg 1949.
10 A. ALES BELLO, L’universo nella coscienza, cit., p. 192.
11 Tale critica mossa da Conrad-Martius allo Husserl di Ideen I può essere tuttavia riconsiderata alla luce del fatto che l’essere che viene posto tra parentesi e, quindi, il significato che all’essere viene dato in relazione alla coscienza (da cui l’idealismo trascendentale) non significano ipso
facto che l’essere sia dato per Husserl soltanto come creazione da parte del cogito. L’essere è comunque. Quello che interessa alla fenomenologia trascendentale è il processo costitutivo che porta alle cogitationes, vale a dire alla costituzione oggettiva, mentre l’essere, la cosa “in carne ed ossa” così come si dà al di fuori del suo darsi per la coscienza, è del tutto ininfluente.
12 H. CONRAD-MARTIUS, Das Sein, Kösel Verlag, München 1957, p. 125 (tr. it. A. Caputo, Introduzione a Dialoghi metafisici, cit., p. 17).
NOTE
La differenza con Husserl così come con Heidegger è a questo punto quanto mai evidente. Se infatti per il padre delle fenomenologia è impossibile trattare la materialità come reale al di fuori della vera realtà che è quella risultata
dall’epoché, allo stesso modo è impossibile per Heidegger comprendere l’essere in maniera così tanto esplicita come realtà “in carne ed ossa” di uno spirito incarnato in un corpo. La posizione di Conrad-Martius si staglia perciò all’infuori delle due differenti ontologie proposte dai suoi celebri contemporanei,
proponendo una ontologia che dell’oggetto riconosce la realtà esistenziale e
non soltanto soggettivamente costituita, ma, allo stesso tempo, dà dell’essere
una connotazione teleologica e spirituale, nell’uomo, come reale e tangibile
presenza. La sua rilettura del pensiero tomista, così come in Edith Stein, permette dunque a Conrad-Martius, per così dire, di materializzare l’essere heideggeriano e, al contempo, di realizzare l’eidos husserliano come essenza di
un essente reale. Da una tale prospettiva, come già aveva anticipato Hering allontanandosi da Husserl con la sua distinzione tra eidos e Wesen, per ConradMartius l’essere ideale quanto quello reale sono esistenze (è riferibile loro la
copula “è”), di cui l’essere umano è un “portatore” reale (upocheimenon). «Ciò
che caratterizza la realtà, scrive a proposito Ales Bello, è l’esistenza di un “sostrato” (Träger) che è “caricato” di una quiddità (Washeit) per cui una entità
reale è la totalità dei due momenti»10.
Come in Das Sein ed in Realontologie, l’intento dei Dialoghi è così quello di
restituire al mondo reale la sua imprescindibile preminenza, poiché il mondo
ideale delle essenze è comunque esistente solo in virtù di un soggetto reale
che è portatore della realtà dell’ideale. In questo senso l’esistenza, come in
Heidegger, in Conrad-Martius ha la priorità sull’atto costituente. È l’essere reale, l’essere cioè delle cose e del mondo naturale della vita, a precedere l’atto
di pensiero e non viceversa, come sosteneva l’idealismo trascendentale della
fenomenologia husserliana11. L’ontologia reale di Conrad-Martius, in contrasto
con la filosofia idealistica, intende dunque dire che «dobbiamo porci al di fuori
del “cogito” e collocarci dentro il “sum” in qualità di un espressivo “io sono”. Il
momento d’essere presente nel “sum” coglie e comprende l’Io nella sua fondatezza ontico-sostanziale, nella quale esso non è solo una res cogitans, bensì
una res cogitans»12.
Il ritorno all’esistenza così come al mondo-della-vita significano, dunque,
per Conrad-Martius, l’affacciarsi ad un approccio metafisico e realistico di entrambi gli ambiti: metafisico perché l’esistenza deve la sua origine ad una evoluzione che si dipana biologicamente animata da un senso (la sua materialità
spirituale che ci conduce direttamente a Dio); realistico perché soltanto in una
considerazione della realtà come essere di ciò che è effettivamente “in carne
ed ossa” è possibile comprendere il vero senso della rivoluzione fenomenologica operata da Husserl. Solo infatti rilevando il vero senso dell’epoché che ci
riporta non ad un Io trascendentale ma alla vera realtà, il mondo-della-vita e
l’esistenza possono trovare una loro identità ed un loro senso all’interno della
natura e di ciò che è vivente. In questo senso, quindi, la vera realtà, quella che
percepiamo e che comprendiamo come rispondente alla categoria dell’essere,
è il sostrato di cui l’upocheimenon è indiscusso portatore.
99
di Bianca Maria d’Ippolito
100
Lyotard ha definito il post-moderno come epoca della “fine delle grandi narrazioni”. La ‘modernità’, dunque, è l’epoca delle “grandi narrazioni”2. E in effetti, in Cartesio troviamo congiunte l’idea di una costruzione ab ovo del mondo e
l’idea dell’io. La “narrazione” si lega fin da principio all’io “narrante”. Ciò che l’io
narra è la costruzione del mondo – finché, nel corso di essa, giunge ad esplorare le sue operazioni costruttive. È, secondo un’immagine fichtiana, un occhio
che guarda se stesso.
La fine dell’“epoca delle grandi narrazioni” possiamo collocarla nella denuncia foucaultiana della “continuità” e del “soggetto”. Diversamente dalle altre
‘epoche’, che sono state ‘temporalizzate’ e ‘nominate’ a distanza3, la nostra si
è autonominata. Né in positivo né in negativo, ma come in un distanziamento
che non si sa dare forma e nome. Epoca della struttura anonima e della discontinuità. Dove comunità e umanità sono a rischio, come Masullo denuncia
in Paticità e indifferenza4.
Il tema del soggetto e dell’io si accompagna, nella filosofia moderna, ad un
sempre più marcato profilo etico che, a partire da Kant, ha il suo culmine nell’idealismo tedesco. Tra Fichte e Husserl si colloca la più forte caratterizzazione etica della “costruzione” –quanto più il tema si evolve ad illuminare, nella
‘costruzione’ il costruire, e l’io va incontro all’auto-interrogazione– o all’autoanalisi.
Nel libro di Aldo Masullo Lezioni sull’intersoggettività. Fichte e Husserl si coglie il pathos etico e civile che investe l’‘io’, al culmine della sua consapevolezza
“architettonica”. Così come, nel saggio recente: “Paticità e indifferenza”, l’autore,
fa vedere, nel ritrarsi dell’io, il nuovo clima ‘politico’ – in senso latissimo.
La riedizione del libro sull’intersoggettività è dunque quanto mai illuminante. Ci consente di vedere l’esito di quella ‘post-eriorità’, in una sorta di ‘postumanità’ che non ha bisogno di congegni elettronici per mostrare ‘freddezza’.
È l’uomo de-mondanizzato che accede al post-umano, e le ‘protesi’ sono il sintomo di un evento interiore.
Altrettanto significativo, quasi simbolico, è il tempo assegnato a questo tema, con la scelta di Fichte e Husserl. Con il primo, l’io si libera della corazza di
forme kantiane, per dispiegarsi apertamente nel mondo; nel secondo, assume
consapevolezza storica della propria vicenda, prende posto in una storia della
figura ‘moderna’. La tesi di Masullo è che qui, tra Fichte e Husserl, si consuma
la differenza d’essere e di valore tra ontologia e storia. A ciò conduce lo sviluppo del tema dell’intersoggettività. Con Fichte, la particolarità e l’effettualità si
mostrano come la struttura stessa della ragione; con Husserl, viene assunto
nella trascendentalità e significatività lo stesso corpo dell’uomo – portando a
compimento ciò che possiamo chiamare la genealogia dell’umano5. La ‘genealogia’, infatti, è genesi secondo il significato. Masullo nota in un altro libro recente: “Filosofia Morale” come «Nella filosofia critica di Fichte, invece, l’altro io
lo incontro «prima» di essere io»6.
Ma perché il tema intersoggettivo sorge e viene assunto in entrambi i casi
in una consapevolezza ‘commossa’ –quasi con l’urgenza di contrastare un pericolo vitale? La proposta di Masullo, che qui fa tutt’uno con la tesissima diegesi dei testi rispettivi– viene in primo piano come oggetto d’indagine nel suo
contraltare recente Paticità e indifferenza. In questo arco teoretico, in cui il tema intersoggettivo manifesta, nel pieno sviluppo fichtiano e nella sua ripresa
già segnata da un’ansia presaga in Husserl, si svolge sotterraneamente la vicenda genealogica dell’‘uomo’ – l’assunzione animosa e l’esperienza disgregante che accompagna la storia della coscienza europea.
Certo, nella storia del pensiero si era affacciato il problema della relazione
interumana. Ciò era avvenuto, significativamente, in due momenti topici della
storia civile e culturale europea. Platone, nel secondo libro della Repubblica,
aveva posto il problema dell’origine della Città7: e nell’età illuministica, come ha
osservato Althusser, nessuno si sottrasse al problema circa l’origine della società8. Si tratta di due momenti di civiltà al massimo splendore culturale; due
fasi di espansione civile e di mutamento dei costumi. In entrambi i casi, giunte
ad un hapax del loro sviluppo, le civiltà s’interrogavano sulle fondamenta di
una convivenza che appare tanto mutata da ‘prima’.
Ma, pur nell’uguale rilevanza teorica e civile – la domanda era differente,
anzi capovolta rispetto a quella che Fichte, per primo, propone. La pluralità dei
soggetti a pari titolo ‘umani’ non solo non era in discussione, ma appariva come il dato primario. La domanda concerneva il perché e il come del loro mettersi insieme.
Il punto d’inizio dell’intera vicenda spirituale –che giunge fino alla soglia della seconda guerra mondiale– è da porre nella critica di Fichte a Kant: Kant non
si pone il problema dell’esistenza di altri esseri razionali. In effetti, il formalismo
è funzionale all’abolizione del problema di un’esistenza ‘esterna’. Masullo, invero, mostra come l’‘idealismo’ in Kant tenda proprio a superare l’abisso che si
apre di fronte all’idea di una corrispondenza tra due ‘realtà’. Nello stesso tempo, l’autosufficienza del mondo ‘reale’ nella sua organica architettura formale,
rappresenta la salvaguardia dell’autonomia e dell’intangibilità della soggettività altrui. In Kant, come in Husserl e in Sartre, l’idea di ‘percezione interna’ garantisce l’assoluta proprietà e intangibilità, per ciascuno, del suo mondo interiore ed insieme condanna all’estraneità radicale i soggetti tra loro. Sartre giunge a dire che per Husserl l’altro è “un’assenza”9.
Se Kant rifiuta di intendere l’io –mio e altrui– come una ‘cosa’ di cui si possono indicare i predicati – la ‘coscienza del dovere’ o ‘voce dell’autocoscienza’ denunciano il «nascosto ontologismo» che salva l’io dallo svuotamento
formale.
Ma perché in Fichte e Husserl diventa così inderogabile il problema dell’esistenza degli ‘altri’ – essere razionali?
NOTE
L’INTERSOGGETTIVITÀ
FRA RAGIONE E PASSIONE1
101
102
non come pluralità, nelle regioni del diritto e dell’etica si mostra la ricchezza delle sue dimensioni concrete. Se l’Io è sempre già-dato, deve diventare Io. La pluralità si trova all’orizzonte dell’Io come dover-essere Io. L’io come tensione tra
fatto e libertà lascia emergere la pluralità come sua limitazione e sollecitazione.
Come in Fichte la particolarità dell’Io comporta il problema della pluralità degli esseri razionali, così in Husserl la concretezza dell’io come portatore di
mondo annuncia insieme l’enigma e la sua soluzione. E come l’Io di Fichte
comporta un’ontologia della particolarità, così l’Io di Husserl si presenta come
‘concreto’ – cioè avente-mondo. L’io è coscienza intenzionale, orizzonte aperto entro cui si manifesta in modo continuo e regolato il ‘mondo’. L’io è come tale portatore di mondo, l’apparire del mondo. Questa struttura regolata, che si
annuncia in una costanza temporale, resta tuttavia sospesa, nel suo senso, ad
un interrogativo estremo, di principio. Se la ‘coerenza’ è la garanzia del ‘mondo’ – qual è la misura della ‘coerenza’? Qui viene in questione, radicalmente,
quel concetto di ‘normalità’ che è misura inindagata di un mondo comune. Masullo, cogliendo la criticità del concetto, ne fa risaltare la carica eversiva. Se la
coerenza fosse compatta, senza mutamento, o se al contrario venisse completamente sconvolta – non si potrebbe distinguere fra apparenza e realtà. In altri termini, se è vero che l’io include la trascendenza del mondo, il mondo moltiplica l’io e lo porta fuori di sé.
Nella proposta di Husserl non soltanto si conferma l’essenzialità della particolarità dell’Io, ma vi emerge anche il corpo, la ‘natura appartentiva’, che
ora viene riscattata all’essenza ed alla soggettività. Qui, infatti, la dimostrazione dell’esistenza di altri esseri razionali non può essere affidata alla dialettica. È nell’analisi del suo proprio esperire, nella sua memoria carica di futuro, che l’io trova l’altro, trovandosi in ‘coppia’. L’elemento originario dell’io
come di ogni altro oggetto è l’esperienza di sé come coppia. L’analisi dell’Io
completo fa emergere dalle stratificazioni di senso in cui si è costituito,
l’esperienza fondante. Tale esperienza è l’unione intenzionale di una presenza e di un’assenza. La relazione tra corpo e coscienza è infatti invertita nella coppia: ciascuna coscienza si esperisce dall’interno, ma non coglie il proprio corpo in esperienza esterna, come oggetto nel mondo. Il mio corpo-oggetto è il mio corpo per me come visto dall’altro. L’assunzione del corpo proprio come trascendentalmente rilevante è la chiave fenomenologica per l’intersoggettività come monadologia.
Accogliendo il corpo nella dimensione trascendentale, Husserl porta a compimento la tesi della co-appartenenza tra io e mondo. Non più solo il tempo,
ma la distanza, l’orientazione, l’alto e il basso indicano la loro sorgente in quella struttura di ‘coppia’ di cui il corpo è l’organo. Così la dimensione del ‘significato’ raggiunge la massima ampiezza (il mondo) e la massima profondità (il
corpo). Penetra fino alle fibre del sentire più silente, appropria le cellule. Duplicandosi, fa umano il vivente.
La grande epoca espansiva, che rintraccia il significato in tutta l’ampiezza
del mondo e la profondità dell’organismo, s’interrompe alle soglie dell’epoca
oscura dell’Europa. Comincia L’epoca delle passioni tristi, come suona il titolo
di un libro recente16.
NOTE
Nell’idealismo tedesco, al contrario, il tema dell’Io, colto dapprima nella
neutralità ontologica del formalismo kantiano, conduce ben presto ad una impasse di principio. Masullo coglie il punto che segna, quasi inavvertito all’inizio,
lo slittamento decisivo da Kant a Fichte: l’io non è più forma, ma atto. Come tale, è auto-intuizione, intuizione intellettuale. «Insomma –scrive Masullo– il sistema della vita spirituale sarebbe inintelligibile, se il nostro spirito non avesse
una qualche conoscenza di quell’atto fondante della spiritualità che è l’Atto puro della Ragione»10.
Nel passaggio dalla forma all’atto si produce qualcosa d’incalcolabile. Innanzi tutto, l’io al suo sorgere, è già riflessione: nel sapersi, è già duplice. Non
può aver consapevolezza di sé, senza sapersi come già-stato. La coscienza
come atto implica un passato. Husserl parlerà di alterità interna, paragonerà
l’esperienza dell’alter ego alla relazione interna dell’io con il suo passato. Masullo sottolinea il passaggio decisivo: l’Io non potrebbe rappresentare nulla,
senza questa apertura in se stesso, se «non si ponesse quindi come un preposto»11. L’atto della duplicazione apre all’infinito la relazionalità essenziale
dell’Io. L’io è il distanziamento di sé a sé e l’infinito ricongiungimento. È questa
la sua azione fondamentale.
Nell’intepretazione di Masullo viene fortemente sottolineata mutazione che
subisce la natura dell’ontologia in Fichte. Non più l’essere immobile, consistente in sé, assoluta identità. Con l’autointuizione dell’Io, all’ontologia si addice la
duplicità, l’azione, il distanziamento: il tempo e l’alterità. Scrive Masullo: «L’uomo dunque in quanto ragione è identità, universalità e unità, in quanto determinato dalla natura, dal Non-io, è invece contraddizione…è nella necessaria
struttura della ragione l’esigenza dell’esteriorità…la ragione o è storicizzata o
non è affatto»12; «La ragione, se è, non può non essere entrata nella storia, e
non può uscirne senza cessare d’essere» 13.
Da La missione del dotto al Fondamenti del diritto naturale a il Sistema della dottrina morale, viene rilevata l’incalzante progressione della tematica dell’Io
storicizzantesi o dell’intersoggettività. Lo sviluppo dell’Io nella sua storicizzazione ne mostra la radicalità – in un senso che si potrebbe dire marxiano: per
l’uomo, la radice è l’uomo stesso. Masullo fa vedere nell’Io fichtiano –la cui essenza è di storicizzarsi– la radice dell’uomo. La radice dell’uomo, ancora, è il
sapersi in quel ‘pre’ che fin dall’inizio è plurale. La filosofia come scienza è questa scoperta. Scrive Masullo in Filosofia Morale: «La vita si fa come una ‘piega’, si ri-piega su di sé. In ciò è il punto d’origine della fenomenalità, dove il vivente si converte in umano e si apre a se stesso come soggettività […] Consiste in ciò l’umanità originaria dell’emozione»14. L’‘alterità si annuncia fin nella
radice emozionale dell’io.
Se la coscienza si sa a partire da un ‘pre’, la datità e la particolarità appartengono all’Io o ragione per essenza, e non sono un puro fatto. Le sfere del diritto e della morale definiscono le modalità del nesso necessario tra libertà e
datità, storicità e universalità. Masullo stringe nel suo discorso il carattere essenziale di tale nesso e ne sottolinea con forza il significato: «la particolarità
non nasce nel tempo»15.
Se, in quanto particolare, l’Io non può esser pensato, e dato a se stesso, se
103
A proposito di: A. MASULLO, Lezioni sull’intersoggettività. Fichte e Husserl, a cura di G. Cantillo e Chiara de Luzenberger, ESI, Napoli 2005.
2 J.-F. LYOTARD, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, tr. it. di C. Formenti, Feltrinelli, Milano 1983, pp. 6 ss, 32 ss.
3 Cfr. R. KOSELLECK, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, tr. it. di Anna Marietti Solmi, Marietti, Genova 1986.
4 A. MASULLO, Paticità e indifferenza, Il Melangolo, Genova 2003, p. 93 ss.
5 Per questa espressione cf. G. CANTILLO, Introduzione, in A. MASULLO, Lezioni sull’intersoggettività, cit., pp. 7-24.
6 A. MASULLO, Filosofia Morale, Editori Riuniti, Roma 2005, p. 131.
7 PLAT., Rep., 368e ss.
8 Cfr. L. ALTHUSSER, Montesquieu. La politique et l’histoire, PUF, Paris 1969.
9 J.-P. SARTRE, L’essere e il nulla, tr. it. a cura di G. Del Bo, Milano 1970, p. 350.
10 Lezioni sull’intersoggettività. Fichte e Husserl, cit., p. 41.
11 Ibidem.
12 Ivi, pp. 50-51.
13 Ivi, p. 52.
14 Op. cit., p. 25.
15 A. MASULLO, Lezioni sull’intersoggettività. Fichte e Husserl, cit., p. 73.
16 M. BENASAYAG, G. SCHMIT, L’epoca delle passioni tristi, tr. it. di Eleonora Missina, Feltrinelli,
Milano 2004.
1
104
SPUNTI DI UNA “FENOMENOLOGIA
DELL’INFANZIA”
di Marina Pia Pellegrino
Nel quadro del pensiero di Edith Stein e Gerda Walther, entrambe discepole di Edmund Husserl, l’antropologia ha un ruolo centrale: dall’indagine sugli
Erlebnisse si dipartono molti raggi, che riguardano i rapporti dell’essere umano con i suoi simili, con la natura, con Dio.
L’interesse antropologico è senz’altro molto forte nei fenomenologi: si pensi anche solo alla funzione dell’opera di Max Scheler, La posizione dell’uomo
nel cosmo1 per la definizione di un’antropologia di tipo filosofico e, in particolare, al secondo volume delle Idee2 di Husserl (trascritto dalla Stein per la pubblicazione) dedicato ai problemi della “costituzione” della natura materiale, della natura animale e del mondo spirituale.
La visione dell’uomo come un microcosmo (esplicitata dalla stessa Edith
Stein nel testo che prenderemo in esame per l’argomento che qui ci interessa3), che racchiude in sé il mondo vegetale e animale ed è aperto, tramite lo
spirito, al mondo soprannaturale, lega la speculazione fenomenologica a quella classica: ad Aristotele, alla metafisica cristiana del medioevo e al pensiero
rinascimentale. Questo legame assume un significato se si tiene conto della
polemica nei confronti del positivismo, che trova nell’evidenziazione husserliana dell’essenza il punto di propulsione. Si tratta, in particolare, di svincolare
l’interpretazione della natura dal modello meccanicistico, a base delle scienze
naturali, e di rendere conto degli aspetti qualitativi del cosmo intero. La delineazione di una filosofia della natura, che riformuli alcuni concetti fondamentali a
partire dalla fisica aristotelica, e una concezione dell’essere umano, che ne
contempli l’unità nella complessità degli aspetti, sono punti ineludibili di un ripensamento della vita, come fenomeno da cogliere nella sua superficialità.
Su questa linea e all’interno di un’antropologia che si può definire “fenomenologica”4, collegantesi alla rinnovata speculazione su tutto ciò che ci si manifesta, emergono nelle opere della Stein e della Walther alcuni spunti, che vorremmo raggruppare sotto il titolo di una “fenomenologia dell’infanzia”. Partiamo, innanzi tutto, dal metodo con cui le due filosofie cercano di rispondere alla questione: che cosa si manifesta quando siamo dinnanzi ad un essere umano? Esse hanno dal loro “maestro” sia la riduzione eidetica che quella trascendentale e se la Stein si lascia guidare, da un certo punto in poi, anche da San
Tommaso, non rinnega affatto il modo di procedere fenomenologico, che, a
suo avviso, è stato utilizzato da tutti i grandi filosofi, benché solo Husserl l’abbia esplicitato chiaramente e sistematicamente. «Ho già espresso il principio
più elementare del metodo fenomenologico: considerare le cose stesse. Non
tener conto delle teorie sulle cose, escludere, ove è possibile, tutto ciò che si
NOTE
La passione che si ritira dal mondo, perde intenzionalità. È la “desertificazione assiologica”, di cui parla Masullo in Paticità e indifferenza. Tagliate le sotterranee radici intenzionali, silenziata la parola umanizzatrice dell’‘invito’, si dà
una sorta di freudiana “perdita dell’oggetto”. La stagione dell’“indifferenza” –come dice Masullo– richiede una ripresa del tema a partire da qui – ancora una
volta dalla pensata ‘singolarità’ di una passione, che si svela umana e storica
nel sapere della perdita.
105
106
ha tratti proprii, che la distinguono dalla bellezza delle altre opere, e la rendono simile, semmai, a quella della natura.
Vogliamo seguire da vicino le nostre fenomenologhe ed iniziamo da un testo, quasi sconosciuto, da Gerda Walther: Phänomenologie der Mistik6, pubblicata per la prima volta nel 1923 e poi nel 1995, nella quale l’autrice vuole definire il vissuto mistico. Attraverso una ricognizione degli Erlebnisse, si perviene
all’“essenza fondamentale” dell’essere umano, che rinvia al “fondamento d’essenza” divino. Questa essenza può essere vissuta anche a partire da uno, in
particolare, dei suoi tre aspetti, benché essi siano tutti presenti nella totalità dell’individuo e possano venir isolati soltanto dalla riflessione, la quale è tuttavia
necessaria per divenire consapevoli delle superficialità e delle differenze. Proprio per quanto riguarda il lato corporeo dell’essenza umana, è possibile rilevarlo in maniera perspicua nello stadio infantile: «Possiamo rappresentarci lo spiegamento armonico dell’essenza fondamentale corporea ad un determinato grado di sviluppo, ma anche semplicemente in un bel bambino. Lo spirito sembra
qui ancora sonnecchiare, svegliarsi a malapena, ma il corpo vivente è sviluppato in piena armonia e freschezza, la psiche è ancora come versata nel corpo e
sprofondata in esso. […] I bambini possono naturalmente avere moti anche
“spirituali” e “psichici”, ma cio è fuso dentro tutto il proprio corpo, come se qui
“spirito” e “psiche” non formassero ancora un ambito proprio all’interno della totalità psichico-spirituale dell’essere umano, come se non avessero ancora
“aperto la loro dimora” in un determinato settore al suo interno, ma come se fossero, per così dire, “dappertutto ed in nessuna parte” […] Perciò, poiché anche
a questo grado, come negli adulti […], in special modo tutto lo psichico si manifesta per lo più corporalmente, si esprime molto più nella mimica ed in generale in tutto l’essere corporeo, altrettanto, tuttavia, tutto il corporeo ha già qui, fin
dal principio, molto di più un aspetto psichico-spirituale, poiché “spirito” e “psiche” sono “dispiegati”, per così dire, all’interno di tutto il corpo. Perciò succede
che noi troviamo negli esseri umani a questo livello [siano essi fanciulli, o esseri umani “primitivi” di culture decadute o popoli “selvaggi”] una bellezza quasi
toccante e “innocente”, che esprime un’armonia di corpo e psiche, come possiamo rinvenire in modo simile, in fiori e animali di una bellezza perfetta.»7
Se il Leib è come tale attraversato dallo psichico, quindi in ogni età, nell’infanzia si ha qualcosa di ancora diverso. La bellezza del bambino ha, infatti, caratteri che differiscono da quella dell’adulto, anche quando questi vive ed esprime la propria vitalità corporea non per sé, dal lato sensuale, ma nella totalità e
nel gioco armonioso delle forze, come avviene nello sport, nelle prestazioni
agonistiche: la prima è bellezza “di spirito e anima”, pur nella condizione “dormiente”, mentre nella seconda si manifesta unilateralmente la forza vitale fisica e il corpo è vissuto come “serbatoio” di forza. Ma cosa vuol dire che psiche
e spirito, nell’infanzia, non sono ancora ritirati in una “dimora” loro propria? È
necessario far presente che la Walther accoglie, per far luce sull’essere umano, ispirazioni diverse, provenienti non solo dalla tradizione del pensiero occidentale, ma anche da quello orientale. Non stupisce, pertanto, quella sorta di
“localizzazione” per cui, nello sviluppo della persona, il “cuore” e la “testa” si
configurano come “sedi” proprie dei vissuti rispettivamente psichici e spirituali.
NOTE
ascolta, si legge o che si è costruito da soli, avvicinarsi ad esse con uno sguardo privo di pregiudizi ed attingere ad una visione immediata. Se vogliamo sapere cos’è l’essere umano dobbiamo porci nel modo più vivo possibile nella situazione in cui facciamo esperienza del suo esserci, vale a dire di ciò che noi
sperimentiamo in noi stessi e di ciò che sperimentiamo nell’incontro con gli altri. […] Il secondo principio recita: indirizzare lo sguardo all’essenziale. L’intuizione non è solo la percezione sensibile di una certa singola cosa come essa
è qui ed ora; vi è una intuizione di ciò che essa è secondo la sua essenza e
ciò può, a sua volta, significare ciò che essa è secondo il uso essere proprio,
e ciò che essa è secondo la sua essenza universale.»5
Già dal primo impatto con gli altri, ciò che di essi attingiamo, innanzi tutto,
è l’aspetto esteriore, ma la corporeità dell’essere umano non è solo corpo materiale, bensì un Leib, un corpo vivo, animato, mosso dall’interno, da un io che
guarda il mondo in una maniera “desta”. Ci troviamo di fronte ad un essere corporeo-psichico-spirituale, i cui atti mostrano una quantità peculiare, una “nota
individuale”: tale impronta è impressa alla totalità dell’essere umano personale da un nucleo interiore (Kern). La persona è aperta verso l’esterno, verso il
mondo, in cui agisce, influenza altri ed è influenzata, produce opere; verso l’interno, attraverso la consapevolezza dei propri vissuti, di tutto il proprio io corporeo-animato-spirituale; al di sopra di sé, verso un Essere assoluto.
Ci si può fare un’idea adeguata di questa antropologia solo seguendo le minuziose analisi delle due pensatrici: il ripercorrere il dipanarsi dei vissuti e il risalire ai loro punti d’origine, serve a mettere in luce distinzioni “essenziali”. Proprio queste configurano ambiti diversi tra loro, che in generale corrispondono
alla tradizionale rappresentazione dell’essere umano come composto di corpo
e anima, ma con ulteriori specificazioni, che ci pongono eloquentemente sotto
gli occhi ciò che sperimentiamo vivendo e di cui non abbiamo una consapevolezza riflessa.
Sia la Stein che la Walther non trascurano la definizione che la descrizione
di quel particolare stadio della vita che è l’infanzia, in cui l’essenza fondamentale umana, nel suo triplice aspetto corporeo-psichico-spirituale, si manifesta in
modo sui generis. È necessario non scambiare tali descrizioni con quelle della psicologia, pur se le autrici non negano l’utilità di avvalersi anche dei contributi di questa disciplina; queste sono a pieno titolo descrizioni fenomenologiche, che puntano alle caratteristiche essenziali del fenomeno che si vuole focalizzare, prescindendo da valutazioni e deduzioni di ogni sorta, come abbiamo appreso dalle parole della Stein. Inoltre le due studiose sono attente anche
ad una dimensione metafisica, per cui gli ambiti da loro indagati, quindi anche
l’essere umano, non hanno solo valore di “ontologie regionali”, in senso husserliano: è in gioco la struttura stessa della realtà, il cui senso riposa, in ultimo,
in un Essere assoluto.
Nello stadio dell’infanzia si presenta come concentrata nella sfera visibile
della Leib la totalità degli aspetti dell’essenza umana. Si potrebbe dire che l’essere psichico-spirituale dell’individuo è completamente “incorporato” e che, se
nello stadio adulto egli si esprime formando con “opere” l’ambiente esterno,
ora è la corporeità stessa la sua “opera”. Per questo la bellezza del bambino
107
108
vegetativa”, non si vuol attribuire un’anima alle piante, nel senso in cui l’attribuiamo all’uomo: l’autrice afferma che questo è proprio di una trasposizione
poetica, di una visione sentimentale della natura. Tale punto ci sembra di
grande rilievo perché la Stein, in qualche modo, ci informa che le sue descrizioni sono di altro tipo, sono fenomenologiche e di una fenomenologia che si
innesta su un piano ontico-metafisico. Con “anima della pianta” si intende un
principio vitale interiore. «Assumere la forma che è germinalmente contenuta
in essa mi pare costituisca il senso fondamentale del processo vitale della
pianta. […] Mi sembra che la vita della pianta consista propriamente nell’organizzazione della materia. L’“anima vegetativa” è interamente forma corporis e null’altro. Mi pare che manchi totalmente ciò in cui siamo soliti ravvisare
la peculiarità dell’anima in quanto tale – un’apertura interiore. È mia opinione
che alla pianta appartenga essenzialmente una mancanza di coscienza. Tutto il suo essere è orientato a manifestare nella forma visibile ciò che essa è,
non è dischiusa verso l’interno, non esiste per se stessa e non vive in se stessa. È dunque, in un senso ontico (non etico) slegata da sé e aperta senza riserve. Il che le conferisce ai nostri occhi l’aspetto di purezza e innocenza. […]
D’altro canto, manifestando la sua essenza, non si rivolge a qualcuno, tende
solo alla luce. Pertanto, malgrado l’apertura con cui manifesta la sua vita, essa è chiusa in se stessa in maniera singolare. Ciò le conferisce il carattere di
tranquillità e pacificità»10. Cosa si ritrova di tutto ciò nell’essere umano? E, comunque, possiamo attribuirglielo nello stesso senso? «Vorrei riallacciarmi a
ciò che ho ora indicato come appartenente allo sviluppo puro dell’essere vegetale e che avevo menzionato precedentemente come caratteristica del corpo vivente umano, cioè la posizione verticale. Sembra che qui essere umano
e pianta si inconrino in qualcosa che manca all’animale. Si tratta realmente
dello stesso fenomeno? Anche in quest’ultimo caso la posizione verticale
sembra un trionfo sulla materia e nel volto umano come nel fiore si può ravvisare la più perfetta manifestazione del proprio essere. Tuttavia, la posizione
ella testa nell’essere umano sembra assumere un altro significato; la testa è
ciò che domina tutto il corpo, ciò da cui esso viene abbracciato con lo sguardo, compreso e governato. Qui la direzione verticale è duplice, dal basso verso l’alto –la crescita verso la luce, dall’alto verso il basso– un percepire se
stesso dall’alto. Perciò il corpo umano si differenzia da quello vegetale e animale, malgrado la comunanza del carattere organico»11.
Pur nel comune possesso di una materia formata, nei vari gradi dell’essere
la forma ha un significato diverso: nel mondo vegetale si manifesta un tendere alla specie, per cui la singola pianta tende a diventare quercia, faggio o abete, oltre che, come abbiamo visto, a svilupparsi verso la luce. Al contrario l’essere umano si distingue per la presenza di un io, consapevole di sé e rivolto
intenzionalmente verso il mondo, che si qualifica, inoltre, nella direzione di un
nucleo interiore, o qualità semplice, così singolare che si potrebbe denominare solo con un nome proprio. A differenza, dunque, della pianta ed anche dell’animale: «nell’essere umano l’individualità assume un significato nuovo, non
rintracciabile in alcuna creatura a lui inferiore.»12 Tenendo conto di siffatte distinzioni essenziali, “quanto vi è di vegetale nell’essere umano” si manifesta
NOTE
La bellezza infantile è poi diversa anche dalla “kalokagathia” delle statue
greche, in cui è raffigurato un impregnamento psichico, non spirituale. Forse è
questo il motivo per cui, nota la Walther, le leggende greche sugli dei non ci
toccano molto profondamente. Il fanciullo richiama, invece, l’indivisa armonia
di corpo-psiche-spirito prima della caduta nel peccato, nello stato paradisiaco
di innocenza inconsapevole. Di qui il carattere “naturale” della bellezza infantile, che non è effetto di quella trasfigurazione dell’essere corporeo-psichico della persona, quando questa decide consapevolmente di vivere per Dio. Tuttavia
qualcosa del bambino è proprio anche del santo, come pure dell’artista, come
sostiene Edith Stein parlando della dottrina di San Giovanni della Croce, nell’opera a lui dedicata8. È una sorta di realismo o nativa ricettività dell’anima,
che si lascia plasmare e nella quale le impressioni si imprimono in modo indelebile. Certo nel bambino non c’è ancora maturità di giudizio e per questo ha
bisogno di un’azione educativa all’esterno, che ha tanto più effetto quanto più
è tempestiva, proprio grazie a tale recettività. Dunque è possibile imprimere in
lui anche una scienza, come quella del mistico dottore, che non è teoria o complesso dottrinale, ma “verità viva, reale e attiva”.
L’intimo dinamismo di ciò che è vitale, che cresce formandosi dall’interno,
trova espressione particolare nella bellezza dei fanciulli e in quella della natura, che suscitano stupore in quanto sono, in qualche modo, spettacolo del mistero profondo della vita.
Vogliamo a questo proposito prendere in considerazione l’opera di Edith
Stein sulla Struttura della persona umana. Qui l’antropologia è fondamento per
una “scienza dell’educazione”: non dimentichiamo che questo testo aveva funzione didattica e rappresenta il corso di lezioni tenute dalla Stein nel semestre
invernale 1932-33, all’Istituto di Pedagocia scientifica di Münster. Soprattutto
attraverso il confronto con l’apparato filosofico-aristotelico di San Tommaso, in
particolare con i concetti di forma e materia –potenza e atto– individuo, genere, specie, si fa leva sulla gradazione gerarchica delle forme, che si dispiegano nel cosmo e si concentrano nell’essere umano.
«Nella cosmologia, come l’ha delineata Tommaso d’Aquino, seguendo Aristotele, il mondo creato si presenta come una serie gerarchica di formazioni:
cose materiali, piante, animali, esseri umani, puri spiriti. […] Essa ci mostra come la problematica dell’essere umano sia legata a quella di tutto il mondo reale e a quella della distinzione degli ambiti della realtà. Pertanto essere uomo
significa allo stesso tempo cosa materiale, pianta, animale e spirito, ma tutto
questo in modo unitario. San Tommaso ha difeso con la massima energia l’unità della forma sostanziale […] sostenendo che l’essere umano è tutto ciò che
è in virtù di una forma interiore, in virtù della sua anima umana, che è anima
razionale e perciò diversa da quella delle piante e degli animali, ma contiene
in sé, come parte inferiore, ciò che è proprio di queste ultime»9.
Per l’argomento che stiamo trattando, ci pare utile soffermarci sul paragrafo dedicato all’aspetto vegetale nell’essere umano. Tra parentesi, la questione dell’“anima delle piante” era stata trattata anche da un’altra allieva di Husserl: Hedwig Conrad-Martius, alla quale la Stein s’ispira. Cosa caratterizza,
prima di tutto, l’essenza della pianta? Con l’espressione di Aristotele “anima
109
110
1 M. SCHELER, Die Stellung des Menschen im Kosmos, 6, Auflage, Francke Verlag, Bern 1962,
tr. it., La posizione dell’uomo nel cosmo e altri saggi, a c. di R. Padellaro, Fabbri Editori, Milano
1970 e La posizione dell’uomo nel cosmo, a c. di M.T. Pansera, Armando Editore, Roma 1997.
2 E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie unf phänomenologischen Philosophie, a
cura di W. Biemel, 1950-1952, tr. it., Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, Einaudi, Torino 1965.
3 E. STEIN, Der Aufbau der menschlichen Person, in Edith Stein Werke, XVI, Herder, Freiburg
i. Br. 1994, tr. it. La struttura della persona umana, a cura di A. Ales Bello, Città Nuova, Roma 2000.
4 Si confronti a questo proposito: A.M. PEZZELLA, L’antropologia filosofica di Edith Stein, Città
Nuova, Roma 2000.
5 E. STEIN, La struttura della persona umana, cit. p. 66.
6 G. WALTHER, Phänomenologie der Mystik, seconda edizione. Walther Verlag, Olten und Freiburg i. Br. 1955. La traduzione dei brani citati da quest’opera è nostra.
7 Ivi, p. 102-103.
8 E. STEIN, Kreuzewissenschaft. Studie über Joannes a Cruce, in Edith Steins Werke, I, E. Nau-
welaerts – Herder, Louvain-Freiburg 1950; tr. it. Scientia Crucis. Studio su S. Giovanni della Croce, Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, Roma 1982.
9 E. STEIN, La struttura della persona umana, cit. pp. 78-79.
10 Ivi, pp. 102-103.
11 Ivi, pp. 81-82.
12 Ivi, p. 88.
13 Ivi, p. 82-83.
14 E. Stein, Zum Problem der Einfühlung, Max Niemayer, Halle 1917; tr. it. Il problema dell’empatia, Ed. Studium, Roma 1985 e L’empatia di M. Nicoletti, Il Prisma, Milano 1986.
NOTE
nel modo più puro nel bambino: «Non si usa solo un’immagine poetica quando si paragonano così volentieri i bambini ai fiori, ma vi è un fondamento reale, infatti si rintraccia anche in questo caso uno sviluppo ed una manifestazione di sé relativamente intatti, un riposo in se stessi. E perciò abbiamo anche
un’impressione di innocenza, di pace e di altruismo.»13 È da tener presente,
però, che anche nell’età infantile ogni individuo umano è unico ed esprime in
modo personale i tratti caratteristici dell’infanzia. Qualcosa di diverso s’intende
quando si parla di “anima dell’artista” etc., volendo indicare dei tipi. In questo
senso un’“anima fanciullesca” può voler comprendere anche connotazioni che
non si addicono allo stadio adulto della vita. Come si vede, si tratta di rilevare
ciò che si manifesta nelle cose stesse e i termini non hanno valore di mediazione simbolica.
Se non si tratta di un riflesso del sentimento, c’è una modalità conoscitiva
in particolar modo deputata a cogliere il vivente, senza, per altro, annullare l’alterità altero specifica di ogni ente? La risposta sta nella dissertazione della
Stein sull’Einfühlung14, a cui anche la collega Gerda Walther si riferisce. L’empatia, o entropatia, ci mette in contatto diretto con gli esseri viventi: è possibile empatizzare piante e animali, benché in modo non completo, oltre che i nostri simili. La percezione non sarebbe sufficiente, poiché si rivolge solo all’aspetto cosale-spaziale; affinché possiamo renderci conto di uno stato interno, seppure espresso nella corporeità, è necessaria un’intuizione emapatizzante.
Scoprendo, in sede filosofica, la portata di tale vissuto, la Stein, e sulle sue
orme la Walther, l’hanno reso operante, insieme all’intuizione eidetica, anche
in questa prima delineazione di una “fenomenologia dell’infanzia”. A questa,
quale settore di un’antropologia fenomenologica, potrebbero utilmente ispirarsi discipline come la pedagogia, la psicologia dell’età evolutiva etc., ma anche
l’arte e la religione.
111
di Tommaso Tuppini
112
«Io non sono né un romanziere né un filosofo, e neppure un artista: io sono un maniaco.» Questa dichiarazione retrospettiva circa il senso della propria
opera rilasciata da Pierre Klossowski1 potrebbe benissimo figurare ad esergo
dell’ultimo lavoro di Marco Fortunato. Alternative alla vita. Esistenza e filosofia2
è un testo eminentemente “ossessivo-maniacale”, si potrebbe dunque dire, ed
in una duplice accezione.
Vediamo di esaminare la prima di queste accezioni. L’ossessione-mania costituisce anzitutto, per gran parte, il vero e proprio tema speculativo del libro
che, attraversando un vasto raggio di riferimenti autoriali (da Leopardi a Kierkegaard, da Spinoza a Hegel, da Rensi a Cioran, da Nietzsche al Freud di Al
di là del principio di piacere), ne distilla pur sempre riflessioni concernenti lo
statuto e (per dirla alla Kant) i limiti di possibilità d’esperienza di un soggetto
una volta per tutte sottratto al confronto con la dimensione dell’alterità e come
irrimediabilemente sedotto dalla condizione prenatale di un’inscalfibile Medesimezza. La particolarità del saggio di Fortunato è, per così dire, di non di passare dottamente in rassegna gli ipse dixit degli autori di riferimento, bensì di
mostrarne esclusivamente i riflessi sullo spirito di un vero e proprio personaggio filosofico di sua invenzione, il cui nome alquanto rivelativo è Akronos3, che
non ha in alcun modo i tratti esangui dell’allegoria o della prosopopea, ma quelli più spessi dell’esemplarietà. Si può senz’altro dire ch’egli, nelle pagine più
riuscite, occasioni nel lettore quella vertigine speculativa che è data di esperire quando, deleuzianamente, concetto ed aneddoto di vita s’intrecciano e si
rendono indistinguibili l’uno all’altro. L’intera concettualità del libro non è dunque contemplata “in presa diretta” dagli occhi dello spirito, ma è filtrata dalla figura uni-dimensionale di Akronos, il quale attraverso una esperienza percettiva ed intellettuale assolutamente variegata e collocata sui piani più eterogenei
dell’esistenza (prove scolastiche, giochi con compagni di classe, letture –prevalentemente di carattere narrativo-romanzesco e/o filosofico–, rapporti con i
genitori, partite a tennis, spettacoli televisivi, esperienze da spettatore di cinema…) ritrascrive questo mosaico di vita così sconnesso secondo il registro del
proprio fantasma ricorrente: il fantasma dell’Unicità, «senso di quella sua prerogativa dai quattro quarti di “nobiltà” filosofica che è l’ossessività: se la vita è
impermanenza e avvicendamento ed è o almeno dovrebbe essere acconsentimento e abbandono al trionfante divenire, l’alterazione che Akronos le apporta è l’intervento tendenzialmente immobolizzante del dispositivo ossessivo,
apoteosi della ripetizione dell’identico»4. L’ossessione per il fantasma dell’Identico è inscritta nel nome stesso di Akronos. Egli, innamorato della «piena con-
tinuità»5, e, forse proprio per questo, tanto più esposto allo «shock della nonidentità»6 in ogni occasione di commercio mondano con le cose, esperisce nel
tras-correre del tempo e nel divoramento di ciò-che-è da parte di Chrònos la
radice di un dolore che minaccia ineluttabilmente di risospingerlo un po’ più
lontano da quella condizione di «positività assoluta»7 il cui attingimento gli si
configura per tutta la durata della sua esistenza come il supremo Bene. Akronos è dunque colui la cui vita consiste tutta di un saggio di obliterazione attiva
di quel tratto di alterità che discrimina il suo Sé dalle cose e lo aliena dal proprio vissuto in un estenuante esercizio di “addomesticazione” degl’incontri8.
Nei confronti delle cose, dunque, la strategia messa in atto da Akronos sta sotto la costellazione di una specie di lucidissimo dandysmo che, per certi versi,
ci sembra ricordare quella figura della fenomenologia della contemporaneità
che Baudrillard –di cui vengono per altro discusse alcune tesi nell’ultima parte
del libro– ha definito “precessione del modello”9. Per Akronos si tratta, infatti,
di parare «il soprassalto dello Schreck, dello spavento improvviso»10, l’evento
traumatico che l’Autore raccontatore/raccontato non circoscrive ad episodi che
per la comune comprensione sono catalogabili in quanto particolarmente sorprendenti od inattesi, ma che caratterizza ontologicamente qualsiasi momento
d’incontro e/o di esposizione all’alterità, nella misura in cui in ciò è implicita una
abdicazione al proprio potere di controllo. Per questo l’attività per eccellenza in
cui Akronos si trova impegnato è quella di una vigile ed indefessa sorveglianza degli accadimenti che ne assediano le facoltà di animadvertere, «lavorio
mentale di preparazione-anticipazione di un evento»11, il che vale: di qualsiasi
evento, poiché esso, nel suo e-venire, nella sua sorgività vergine, è ciò che minaccia «di prendere d’infilata il potere di controllo e di anticipazione di Akronos»12 e dunque reca in sé l’annuncio del periculosum per eccellenza e dello
scacco sempre imminente, «immagine paradigmatica del passaggio, casus
macroscopico del “voltar pagina” in cui Akronos vede-incontra temporalità, mutamento, caducità, dunque in definitiva morte»13. La strategia della radicale
precessione ovvero del controllo più minuzioso che Akronos dispiega per parare i colpi di ogni e-venienza del reale14 non consiste però in un ingenuo misconoscimento dell’urgenza e dell’imprescindibilità dell’esperienza del passaggio, così come viene implicitamente rifiutata –in quanto inefficace– ogni possibilità di, semplicemente, mettere la testa sotto la sabbia di fronte allo spettacolo, per quanto desolante esso possa essere agli occhi di Akronos, dell’incessante trascorrere. Se l’esperienza del passaggio e della perdita, comunque declinati, è il trauma, «di per se stesso l’intollerabile (per Akronos), […] di per se
stesso lo sbagliato che non dovrebbe esser(ci)», la strategia di controllo che
permette di recuperare lo scacco subìto non si configura, in fondo, come nulla
di diverso dal dolore e dalla punizione ch’egli subisce nell’istante stesso in cui
accade la perdita e lo scacco, anzi: Akronos prepara la propria vittoria sull’esistenza proprio nutrendo la consapevolezza che «d’ora in poi sarà punito dal
dolore ossessivo che consiste in micropensieri di interferenza, in refrains mentali che “ripetono” quell’evento e quindi significano/dicono mutamento e morte»15. Vale a dire, così come anche balena dalle ultimissime righe che chiudono in modo molto suggestivo il saggio: per certi versi l’evento (del dolore) è an-
NOTE
IO SONO UN (PENSIERO) AUTARCHICO
113
114
no omogenea e risultano disposti con grande simmetria. Se all’inizio il ritmo di
questa disposizione risulta alquanto veloce, esso si distende negli ultimi due
capitoli, quelli, appunto, dedicati all’esercizio della memoria e al tema del nulla, in cui la consapevolezza della difficoltà del “legamento” in unum sembra
non potersi più disgiungere dalla consapevolezza della sua indissociabilità dalla estrema dilatazione disperdente. Per questo l’Autore si concede maggior
tempo, l’andamento discorsivo rallenta non perché diventi maggiormente analitico (il “dovere” dell’analiticità è un’istanza della scrittura che percorre l’intero
volume, senza mai eccepire o modificare la propria misura), ma proprio, sembrerebbe, per lasciare al grande nemico Chrònos d’infilarsi tra le pieghe di un
pensiero che, qualora portasse all’estremo della coerenza le proprie tesi speculative, dovrebbe avere temporalità inconsistente del fulmine e la contrazione
del punto. Allo stesso modo, il pensiero dell’assoluta positività, come esso
stesso ama definire sé, si ammanta di una ironica pellicola di mono-tonia –e sicuramente non c’è nulla di più lontano da una scrittura romanzesco/plurivoca
di quella di Fortunato–, tende senza esitazioni alla riproduzione monologica di
un ragionamento che non desidera interruzioni, che s’imbizzarrisce di fronte all’interlocuzione, vera incarnazione di un verbale horror vacui, politicamente
senz’altro scorrettissimo, perché più di tutto ha orrore di quel vuoto che potrebbe introdursi nel corso di questa conversazione a senso unico per l’interferenza di un qualsiasi “parlamentare”. Eppure, questa voce, la quale alle volte fa
della propria orgogliosa unicità (non nel senso della particolarità, evidentemente, ma nel senso di un invocato nemo apud me) la ragione del suo voler-dover
farsi ascoltare, se non ammette alcun intervento da parte di terzi è a tal punto
terrorizzata dall’idea che ciò possa accadere e dalla consapevolezza che, anzi, proprio l’imminenza di questa accidentalità sia la sola necessità superiore
alla moira del proprio istituirsi, che la sua indiscutibile mono-tonia finisce per
anticipare i turbamenti che le potrebbero causare gl’interventi altrui. Pur di non
provar il turbamento della dialogicità in prima persona la voce di Akronos/Fortunato si convince ad assorbirne la scaturigine (la voce altrui) nella propria parola. Ed infatti non c’è praticamente una sola tra le tesi speculative che si affacciano alla mente di Akronos di cui egli non si appropri senza giocarne, al
momento opportuno, il rovesciamento. La peculiarità della scrittura di Fortunato è tale per cui tutto ciò non significa per ciò stesso un’adesione a schemi di
pensiero dialettico – pur tenendo in debita considerazione la profonda “simpatia” che Akronos non finisce di dichiarare esplicitamente e nel corso dell’intero
testo per quella piega del pensiero che chiama se stessa: pensiero dialettico.
Dunque, neppure il maestro Adorno può essere in questo caso chiamato in
causa come nume tutelare della scrittura filosofica, nella misura in cui neppure una dialettica negativa, irrisolta, sembra poter comprendere nel proprio raggio la costruzione di questa ragnatela. Il passaggio da una tesi alla sua antitesi accade con tale ostentata automaticità e la scansione è a tal punto enfatizzata (cfr., ad es., il numero cospicuo di capoversi che cominciano con un
«Ma…») da far pensare ad una inconfessata, oscura mancanza di fede da parte di Akronos nella efficacia di questo strumentario polarizzante per poter risolvere la questone cruciale dell’affermazione del proprio solus ipse. In virtù di
NOTE
che il proprio stesso rimedio. In questo senso «un posto di primo piano» ha
nell’orizzonte speculativo di Akronos la lettura di «Al di là del principio di piacere, per l’idea espressavi da Freud che per l’apparato psichico (il) dis-piacere
sia la libera mobilità dell’eccitamento e che la prima e più elementare operazione cui ricorre per smorzarlo-per ridurlo consista nel cercare di “legare”/di
stringere in unum quel disperso eccitamento»16, ma, ancora di più, per il fatto
che quest’opera di “legamento” in unum del dis-piacevole/disperso viene presentata da Freud come costituente di per se stessa una ripetizione di ciò che
ha causato dis-piacere. Ed è proprio la nozione della “ripetizione” a costituire
uno degli snodi teoretici decisivi del libro di Fortunato, per il fatto che in essa
si trovano dialetticamente entre-croisées l’elemento del periculosum e quello
della progettazione salvifica, la paura e la rassicurazione, il sé e l’altro, eteronomia ed autarchia, la distrazione e l’ossessione. Akronos è infatti consapevole che l’amore per il soggiogamento ed il controllo non è mai “assoluto”, una
volta per tutte “sciolto”, ch’esso è sempre un amore-per che muove-da, un’attività proiettiva che rimane comunque situata nello spazio di un con-fronto non
cassabile con l’occasione che lo ha occasionato, con l’accidentale pretesto, si
potrebbe dire, che si colloca comunque all’origine di questo testo della più rigorosa necessità. Non si dà “abbassamento” della realtà alle proprie esigenze
compositive senza l’“affronto” di dover subire –inizialmente– la dura spigolosità di questo stesso reale che l’anticipazione progettante (o, è la stessa cosa,
la memoria) desidera di adeguare a sé: per questo la protesta di Akronos si
confonde con un ossequio nei confronti dell’oggetto della propria protesta e
proprio nell’indecidibile momento in cui esso viene fatto oggetto di protesta. Il
cocciuto rifiuto è, al contempo, «conciliarsi con la realtà, […] un prenderne le
distanze non senza rivolgerle l’omaggio di attraversarla e subirla-dopo averle
rivolto l’omaggio di attraversarla e subirla»17. Presa di distanza che è, dunque,
di per sé anche un gesto di adesione, “solecismo” del gesto (di pensiero) da
parte di Akronos, si potrebbe dire ritornando alla suggestione di Klossowski
dalla cui intervista abbiamo preso le mosse in apertura di questa Nota: il “tocco” che Akronos pratica nei confronti del reale è quello di Lucrezia verso Tarquinio che la aggredisce, braccio alzato e «gomito puntato […] con una mano
aperta e l’altra abbandonata lungo il fianco, […] mano che offre il palmo, senz’ombra di dubbio, col pretesto di parare», ma, nello stesso tempo, allude ad
una complicità/vicinanza che non è più stornabile18.
L’autarchismo fallimentare di quest’esercizio di pensiero, e che pure fa di
questo fallimento il cardine di gravitazione del proprio dipanarsi, prima ancora
che nel tema speculativo proposto risulta evidente nello stile di scrittura del suo
Autore. E con questo veniamo a chiarire la seconda di quelle accezioni in cui
si era detto all’inizio si poteva comprendere in che senso il testo di Fortunato
sia “maniaco-ossessivo”. La scrittura di Fortunato presenta agli occhi del lettore una articolatezza compatta che fa pensare alla tela di un pazientissimo ragno. Alla costruzione di una ragnatela fa pensare anzitutto la pagina di Fortunato considerata anche solo ocularmente: i blocchi di parole che i capoversi di
volta in volta formano, presentano quasi tutti, pur con qualche concessione alle esigenze –per altro non estrinseche– della variatio, una lunghezza più o me-
115
116
1 Eros, Belzebù &Co., intervista di F. Hauser a P. Klossowski, in “Nouvel Observateur”, n. 902,
1982.
2 M. FORTUNATO, Alternative alla vita. Esistenza e filosofia, Il melangolo, Genova 2004.
3 Per questo il libro si presenta come il seguito di una pubblicazione precedente dello stesso
Fortunato che aveva il medesimo “protagonista”: Il soggetto e la necessità. Akronos, Leopardi,
Nietzsche e il problema del dolore, Guerini, Milano 1994.
4 M. FORTUNATO, Alternative alla vita, cit., p. 6.
5 Ivi, p. 63.
6 Ivi, p. 64.
7 Ivi, p. 77.
8 Cfr. ivi, p. 34.
9 Cfr. in particolare J. BAUDRILLARD, Simulacres et simulation, Galilée, Parigi 1981, pp. 9-68.
Fortemente ispirate alla lettura baudrillardiana sembrano le non infrequenti “apologie” del fare della tecnica, la quale –in quanto esempio più limpido del fenomeno della precessione– non può che
trovare in Akronos un “fan” entusiasta: «l’occhio sulfureo di Akronos Weltfeind in qualche misura
si compiace dello spettacolo degli enti colti nella loro massima abiezione, vale a dire trasformati,
alterati, manipolati, asserviti dalla tecnica». La «brevità, velocità, facilità e potere di derealizzazione», come momenti di soggiogamento del reale alla propria pianificazione progettante, «si presentano strettamente congiunti e come condotti al loro diapason dal fenomeno moderno-contemporaneo per eccellenza, la tecnica […]. Più in generale brevità, velocità, e im-mediatezza rifulgono in
tutte quelle funzioni e in tutti quei processi spesso altamente spettacolari della tecnica nei quali si
verifica quasi uno schiacciamento dell’effetto sulla causa, del compimento sull’input, della fine sull’inizio, dell’arrivo sulla partenza», M. FORTUNATO, Alternative alla vita, cit., pp. 42, 244.
10 Ivi, p. 35.
11 Ivi, p. 36.
12 Ivi, p. 25.
13 Ibidem.
14 La descrizione più limpida di questa strategia Fortunato ce la dà quando ritrae Akronos «ancor bambino o poco più» mentre «contrappunta eventi sportivi vissuti da spettatore e giochi o ga-
re di cui lui stesso è protagonista con cronache dal ritmo così battente da arrivare quasi ad offrire
la descrizione se non addirittura il commento delle loro fasi prima ancora che accadano […],
indic[ando] alla parola/al logos un compito più alto e in certo modo terribile, mir[ando] a farne la
potenza a tal punto immune».
15 Ivi, p. 26.
16 Ivi, p. 232. Il riferimento è in questo caso a S. FREUD, Al di là del principio di piacere, Boringhieri, Torino 1983, pp. 18, 49-60, 98-99.
17 M. FORTUNATO, Alternative alla vita, cit., p. 234.
18 P. KLOSSOWSKI, La revoca dell’editto di Nantes, Sugarco, Milano 1982, p. 30. “Solecismo” ovvero “paradossalità” del gesto di Akronos, come ha sottolineato opportunamente nel suo intervento intorno allo stesso testo Tito Perlini nella Nota intitolata significativamente Attraverso i paradossi (cfr.: Segni e Comprensione, XX, 57, pp. 113-117).
NOTE
quest’ironia sotterranea la scansione binaria di ogni dialettica finisce per trapassare nell’immobilità di uno scambio in cui, per così dire, tutto è già in tutto,
in cui le de-finizioni avverse sfumano come i contorni degli affreschi leonardeschi tanto amati dal Nostro, ed in cui l’ossessione per la positività si trasforma
in una seduzione dei passaggi più sottili. È quando il lettore fa quest’esperienza di ultimo rivolgimento della dilatazione dialettica in una microscopica piega
del pensiero che ci si rende conto di come effettivamente la scrittura di Fortunato riesca nella difficilissima impresa di togliere il movimento affermandolo, di
raccogliere la propria ragnatela nella velocità assoluta di movimento di ciò che
su di essa si sposta per raccoglierne le disjecta membra. Da questo punto di
vista, il libro è estraneo ad ogni compiacimento per la sconfitta e ad ogni possibile abdicazione al proprio esercizio. Il libro, nel suo compiuto svolgimento e
come pratica di un pensiero che va al di là della dialettica servendosi spesso
dei suoi stessi strumenti, è un bollettino della vittoria, ha il carattere inconsueto, al giorno d’oggi, di mantenere tutte le promesse che fa e la sua coerenza
interna è tale da suscitare una certa ammirazione mista a sgomento, come si
suol dire, in chi non è abituato alla lettura di un Autore fino a questo punto conciliato con la propria opera.
117
118
Questo numero di “Kainos” si propone come un’effettiva opera monografica perché il tema “rifiuti” funge da effettivo nucleo aggregante dei vari saggi;
autori e autrici procedono infatti ad uno scavo tematico in forma di un dissodamento che dilata l’area di ricerca, in quanto i materiali che emergono da questa specie di trivellazione offrono nuovi stimoli al “da pensare”. Dove qui il “da
pensare” riguardo ai rifiuti muove dall’esplicita intenzionalità etico-politica che
accomuna le diverse competenze disciplinari di quanti e quante si sono impegnati in tale rilettura pluriprospettica di una realtà così multiforme. Il che accentua la cogenza del tema per l’oggi non tanto perché ne esalta l’attualità quanto perché ne fa emergere il carattere in certo modo strutturale alla vita, intesa
sia in senso biologico che esistenziale, e si potrebbe dire da un punto di vista
complessivamente ecologico.
Il volume, che si apre con la Presentazione del progetto editoriale a cura di
Giuseppe Tortora di un volume annuale in forma di “libro” della rivista telematica “Kainos” (www.kainos.it), seguita da una Introduzione redazionale, è articolato in tre sezioni: la più ampia –Ricerche– è composta di undici saggi, la più
breve –Percorsi– di due saggi e quella di chiusura –Recensioni– di otto articoli; tutti i testi convergono, ciascuno muovendo da una specifica prospettiva, sul
tema comune costruendo pezzo per pezzo le varie facce di Rifiuti. Come spiega Tortora nella Presentazione si tratta di un lavoro a più mani che riprende
una pratica filosofica di antica, ma in gran parte persa, memoria: il filosofare insieme. Nell’Introduzione viene subito delineato lo spettro semantico intorno a
cui si snodano i vari interventi: “rovine, macerie, scarti, rifiuti”, e i tre exergo posti in apertura tratti rispettivamente da Père Ubu, W. Benjamin e Eraclito ci introducono ai termini basici del discorso: “Merde!, Stracci e rifiuti…, mucchio di
rifiuti gettati a caso”, dove i tre autori richiamati oltre a prospettarci l’ampio spazio di riferimento che caratterizza il volume in esame (che dai classici greci arriva ad abbracciare la contemporaneità) ne indicano la rotta, che è quella del
“rendere giustizia” a quanto va sotto l’etichetta “rifiuto” e che può magari farci
immaginare “il più bello dei mondi”.
Vorrei partire da questa immagine eraclitea in cui “il più bello dei mondi”
è “proprio come un mucchio di rifiuti gettati a caso”, per sottolineare la venatura escatologica di un simile approccio ai rifiuti. Dove l’escatologia, quale
teoria di una fine tanto radicale quanto innovativa del mondo, fine che apre
a cieli nuovi e terre nuove in cui sarà resa giustizia a quanto è stato oggetto
di rifiuto e scarto, fa leva su una modalità molto drastica di giudizio, che operando di taglio discrimina tra il grano e la lolla, con un’ottica però rovesciata
rispetto a quella del mondo antecedente l’escaton, cioè il giudizio che non a
caso si dice salvifico (Introduzione, p.13). Uno dei caratteri più interessanti
del “libro” in esame è dato, a mio avviso, proprio dal fatto che nel far trasparire il possibile sfondo escatologico di un discorso politico sui rifiuti, improntato all’idea che essi in verità costituiscono il sale del mondo, sceglie di non
privilegiare tale linea di lettura e preferisce lavorare sul versante critico di cosa sia da salvare o da scartare, non facendo sua la modalità escatologica del
giudizio, giocata appunto sul rovesciamento dialettico che rivela la positività
del negativo.
Aggiungo che in maniera più o meno esplicita l’escatologia pervade ogni visione autenticamente utopica, in cui la logica del mondo viene sconfessata da
una logica altra, innestata su criteri di verità antitetici a quelli del mondo: criteri che richiamano una dimensione di trascendenza fondata su l’exemplum e la
testimonianza. Il discorso condotto da autori e autrici di questo volume è tutto
intramondano ed è concentrato sulla contingenza del mondo, quindi sulle contraddizioni, i paradossi e le antinomie della vita nel mondo e del mondo, che
non possono essere eluse pena la lacerazione dell’umano. Contraddizioni, paradossi e antinomie che chiedono di essere considerate e affrontate, caso per
caso, in maniera non dualistica, secondo la modalità proposta dall’evangelista
Marco del sì o no, ma articolando il discorso e lavorandoci sopra punto per
punto per ampliarne la portata esplicativa. Che è quanto fanno gli autori e le
autrici di Rifiuti con i loro approfondimenti di settore sempre tesi a cogliere la
visione d’insieme del problema in esame, che è poi quanto richiede l’analisi di
ogni realtà complessa quale è anche quella umana. Tutti i saggi delle due partizioni, così come le recensioni a libri attinenti il tema “rifiuti”, possono allora essere letti come un cimento intorno alla domanda posta in chiusura dell’Introduzione: “Come elaborare una risposta filosofica (ma non ‘soggettiva’ [aggiungo
io politica] che sia finalmente in grado di non lasciare, come sempre, l’ultima
parola alla religione?” (p.13).
Affronto quindi l’attenta declinazione semantica del termine al centro del volume: rifiuti, che ogni saggio concorre ad arricchire quanto più mira a delimitarlo, sia cercando di circoscrivere il campo d’uso alla vita inorganica, organica,
artificiale, o l’alone di significatività, quindi le valenze allegoriche e metaforiche.
Ancora richiamo l’Introduzione in cui si distinguono i rifiuti assoluti o radicali, gli
“irriciclabili”, che sfuggono anche al criterio più minimalista di utilizzabilità, dai
rifiuti in forma di scarti che, come le “macerie”, possono evocare una “perdita”,
e quindi un “oblio” fruttifero, che ci segnala tempi e spazi diversi, indicativi di
un diverso modo di vivere il tempo e lo spazio che siamo usi a considerare nostro. L’area semantica del termine è quindi presa in esame a largo raggio, coinvolgendo tutta una serie di termini limitrofi quali innanzitutto resti e rovine, per
raggiungere anche zone più remote in cui risuonano parole come cesura e
scarto.
Il volume si apre con un testo di Zygmunt Bauman, autore ripreso in altri
saggi e recensito con acutezza critica da Eleonora de Conciliis, di cui condivido appieno le riserve garbatamente accennate. In merito alla riflessione di
Bauman, nota nel contesto italiano (che ho avuto modo di recente di considerare per quanto attiene alla questione educativa), mi limito a segnalare come nello scritto qui riportato affiorino molti dei termini costitutivi della costellazione rifiuti quanto più centrata sull’economia: scorie, esuberi, discariche,
pratiche di esclusione, ritardatari della modernità…, che ci portano agli hors
du nomos, ai sans papiers, ai profughi, ai rifugiati, cioè all’eccedenza umana
che si pretende circoscrive nei ghetti e negli iper-ghetti, estranei ad ogni possibile integrazione. Ricorrono quindi nomi di studiosi che saranno richiamati
RECENSIONI
“KAINOS”, n. 1, 2006, Rifiuti, edizioni Filema, pp. 238.
119
120
briella Baptist nel suo Jacques Derrida e l’eredità che resta. Con la sua scelta di lavorare su un testo doppio, o sdoppiato, di Derrida, Baptist rende immediatamente evidente l’impossibilità di chiudere il discorso “Rifiuti” su una
posizione univoca e di darne una lettura in chiave storicistica. Tutti gli autori
e le autrici richiamati nei vari saggi (Arendt, Batallie, Benjamin, Baudrillard,
Cavarero, Derrida, Melville, Nancy, Simmel, …), pongono in questione il problema del rapporto tra storia e memoria, tra nome proprio e universalità,
quindi il problema della pietra scartata e delle scorie della storia. Problema
che interroga l’estetica e l’arte, non solo in quanto pacificatrice ma anche come esercizio critico costante. Qui cito degli interventi, per me molto stimolanti, quali il saggio di Daniele Dottorini (Ar)resto dell’immagine, Pratiche di rifiuto nel cinema, dove il rifiuto è visto come eccedenza/ripetizione/selezione/distanza/ripresa nell’arte del montaggio; il percorso di Andrea Bonavoglia, Waste: quel che resta dell’arte in cui torna il tema del riciclaggio analizzato da
Giusepper Russo nel suo saggio Il riciclaggio dei rifiuti nel teatro di Tadeusz
Kantor. Si tratta sempre di muoversi fra i “resti”, quasi come funamboli, su un
crinale tra integrazione e sovversione, come propone Paolo Pagani nelle sue
dense Note su Baudrillard e Bataille, leggendo il resto come residuo eccedente, o sperpero, che può offrire un’opportunità comunicativa che va in favore della circolazione della stessa comunicazione. Menziono infine il saggio
La voce e i rifiuti della trascendenza di Vincenzo Cuomo, del quale ho già
avuto modo di menzionare la ricerca che da tempo conduce sulla voce, e che
qui viene ripresa attraverso uno scavo sullo scarto, anche cesura, che si crea
tra voce e parola, a partire dall’analisi del simbolo per approdare, attraverso
un percorso molto dettagliato, all’affermazione che “il fenomeno della voce ci
fa comprendere che non c’è che gli scarti. Ci fa comprendere che il
vivere/esistere […] non consiste che nello scarto” (p. 85).
Come si vede il tema del rifiuto si dipana lungo un arco molto variegato di
significati, orientamenti, intenzionalità, tendendo di volta in volta ad essere letto come preferenza, scelta, occasione, […] di ripensare se stessi nel rapporto
col mondo, cioè con gli altri e la più universale umanità.
In conclusione di queste annotazioni rilevo la mancanza di un intervento sul
tema rifiuti relativo all’ambito educativo, che pure è uno di quelli in cui e da cui
più emerge la problematicità di quanto viene etichettato, o finisce col risultare,
o assume il ruolo di rifiuto. Si tratta di una vera e propria questione problematica a più facce, si pensi solo a quelle sociale, politica, esistenziale, il che lo
presenta come uno dei nodi riflessione critica transdisciplinare, come d’altronde fanno vedere diversi degli autori citati nei saggi menzionati, quali, ad esempio Bauman ed Arendt: pensatori della modernità e postmodernità attenti a individuare in ogni campo gli indicatori di ingiustizia che attentano alla condizione umana.
Margarete Durst
RECENSIONI
anche in altri saggi: Giorgio Agamben, Michel Augier, Goffmann, e non ultima Arendt, di cui riecheggia la riflessione sui rifugiati quale avanguardia dei
popoli, autrice cui Meccariello dedica il saggio Resti di umanità nel pensiero
di Arendt.
In Wastefull Planet Bauman sottolinea come la dimensione planetaria che
sta assumendo la discarica umana, acutizzando il problema dei rifiuti umani,
mette in crisi le varie forme più o meno dolci e dure di contenimento, quindi
tanto la ghettizzazione che il riciclaggio, ponendo sotto gli occhi di tutti “l’incoerenza e la friabilità della dottrina della costruzione dell’identità” (p.35).
Quella identità, anche europea e occidentale, che ha avuto bisogno di ancorarsi alla storia, alla genealogia che risale di generazione in generazione per
strutturarsi come forma di dominio, cioè di potere che assoggetta assimilando, consumando e ributtando fuori dopo il consumo l’altro da sé che ha ridotto a sé. Secondo la ciclicità di un rapporto d’incorporazione identitaria su cui
scava Eleonora De Conciliis, nel suo saggio Identità e rifiuto appunti per
un’antropologia del postmoderno. Ma ovviamente i rifiuti umani sono una delle interfacce del grande prisma rifiuti, che dilaga nel mondo contemporaneo
con una rapidità sempre più allarmante. Serenella Iovino, con il suo saggio
Rifiuti tossici? Non nel mio cortile (nel loro sì, però). Un’analisi del razzismo
ambientale circostanziata, ci introduce a una problematica che prospetta la
costitutiva paradossalità dell’“oggetto” rifiuto; in altra forma espressa anche
dal percorso proposto da Paolo Attivissimo, Spam, spazzatura digitale. Come tenere a bada il rifiuto che è funzionale allo sviluppo della cosa buona,
evitando che esso fagociti la stessa? L’idea di una messa in crisi del sistema
immunitario, e quindi di metastasi sempre più invasive corre lungo questi testi, focalizzando un nesso perverso che solo una visione capillarmente ecologica sembrerebbe poter contrastare. Da qui l’esemplarità di posizioni del
tutto paradossali di totale rifiuto per non dovere rifiutare nulla; su questo fronte cito il saggio di Tommaso Auriemma, Il rifiuto assoluto. Su Bartleby lo scrivano di Hermann Melville, in cui si solleva anche la questione del rapporto
tra uomo e animalità. Tale saggio è in certo modo accostabile al bel testo di
Bruno Moroncini, Le rovine di Benjamin, in cui ci si addentra nella pratiche di
rifiuto che permettono di salvare qualcosa di salvabile che non concorra a
reiterare la produzione di rifiuti. Spostarsi sul piano propriamente culturale,
del rifiuto come rovina quindi come messa in gioco della memoria, non significa però affatto perdere di vista la faccia più macroscopica del rifiuto fisico,
come ben ci mostra il saggio già citato di Eleonora de Conciliis, in cui è messo a fuoco il nesso tra desiderio, bisogno, perversione nel vissuto psicofisico di esseri umani che si sentono, o ritengono, affrancati dalle regole della
modernità.
Il problema è infatti sempre quello di mettere ordine, dare un senso che però sia un senso altro rispetto a quello dell’utile, e che non sia imposto dall’alto
ma muova dal basso, dal “micro”: una serie infinita di microsensi che emerge
dai rifiuti.
Il rifiuto può essere allora letto in chiave di ciò che resta e/o di ciò che si
salva. Su tale linea indaga, analizzando un testo molto problematico, Ga-
121
122
Nel 1938 Walter Benjamin,in una pagina rimasta a lungo inedita,scriveva un
importante commento alla “leggenda della nascita del libro Tao Te king” nel
quale metteva in evidenza la centralità del sentimento di amabilità che ne ha
consentito, alimentato e reso attuale la filosofia.
Pagine analitiche e contestualizzate nelle vicende della cultura cinese, dal
VII al II secolo a. C., ha dedicato a Lao Tseu M. Conche, uno degli esponenti
di spicco della filosofia francese contemporanea, pensatore di grande spessore morale e teoretico, conosciuto per i suoi studi sulla filosofia di Montaigne e
sul pensiero antico, per le accurate edizioni critiche dei testi dei filosofi antesocratici, come preferisce chiamarli, delle opere superstiti di Epicuro, della tradizione epicurea e scettica. Lo studio sul Tao è stato incentivato da questa cultura e si inserisce nel progetto di sollecitare la conoscenza della storia dell’umanità nel momento in cui conflitti socio-religiosi, conseguenze di guerre regionali in estese aree del mondo, rifiuto e negazione dei valori rischiano di rendere vano il concetto stesso di umanità. Ripensare il Tao significa mettersi all’ascolto di una delle voci più alte che invitano alla meditazione sul concetto di
uomo, ascoltare la natura, la parola che al di là dei millenni risuona con voce
pacata e sommessa ma sempre efficace, per mettere in luce le connotazioni
essenziali dell’esistente.
La pregevole, se pur breve introduzione (pp. 7-37), illustra la complessità del
testo, muovendo dalla data di composizione e dal titolo, che non risulta essere
della mano di Lao ma è attribuito ad un imperatore cinese del II° secolo, Hanking-ti (pp. 156-140), che lo intitolò Tai Te king, titolo che è rimasto definitivo.
Il testo, secondo Conche, si inserisce nel dibattito sul confucianesimo che
è particolarmente vivace nel momento noto come periodo delle Primavere e
degli Alunni. “Alcuni, come Confucio, si riferiscono ai valori dell’epoca e del periodo dei sovrani Tcheu, inteso come età dell’oro. Altri, detti legisti, vogliono, in
nome dell’efficacità, inasprire la legislazione per assicurare potere allo stato.
Ritengo verisimile che il taoismo sia nato nel periodo di un’intensa attività intellettuale, soprattutto se si analizza la forza con la quale l’opera di Lao contesta il potere dello stato, che i legisti vorrebbero rafforzare e che egli invece intende delimitare” (pp. 8-9) Il rapporto con il confucianesimo, che da parte sua
tende a celebrare la modernità della civilizzazione, appare difficile,controverso
e le critiche rivoltegli” possono essere il segno della reazione del vecchio saggio alle nuove idee diffuse da Confucio” (p. 9).
Fin dall’epoca più antica, il testo è stato diviso in due parti: Il libro della Vita, Il libro della Virtù, di 81 capitoli, dei quali 37 nella prima parte, 44 nella seconda. Si tratta di una distinzione di comodo, non essenziale che nasce dal disegno di far coincidere il numero dei capitoli con il numero sacro, 81, appunto.
Compito etico-morale di quest’opera, secondo Conche, fare emergere il significato della natura nelle sue determinazioni più semplici ed universali. Attento, per formazione e dedizione agli echi della sapienza greca, Conche richiama certe assonanze con la componente antesocratica soprattutto quando in
relazione al concetto di physis, e ad Eraclito in particolare, senza tralasciare la
lezione epicurea quando si tratta dell’amicizia, che è alla base dell’etica di Lao.
Di grande interesse la contrapposizione tra le tesi di Lao e quelle di Confucio.
“Confucio vuole agire sulla realtà storica cinese ed è quello che ha fatto. Ma
non ha avuto in Europa un’influenza degna di nota e, se suscita il nostro interesse, lo si deve all’atteggiamento per cui siamo interessati ad una lezione che
però non ci riguarda intimamente. La lezione di Lao Tseu ci riguarda da vicino.
In Lao Tseu gli uomini che fanno la storia non sono presenti. Egli non crede
possibile riformare la società attraverso i mezzi-strumenti di Confucio. Si considera come sradicato dal tempo storico e per questo può parlare a tutti gli uomini che si sforzano di comprenderlo, in qualsiasi parte del mondo essi si trovino” (p. 13). Non è facile comprendere Lao, i cui scritti sono stati accusati di
“laconismo”: ma non era criptico lo stesso Eraclito? E non sono considerati
criptici quegli autori che non si consacrano all’ovvio, ma tendono all’essenziale e all’eterno? È merito di Conche aver proposto una traduzione ed una lettura del Tao organica e critica, accompagnata –come da solerte impegno abitudiale– da un commento analitico e preciso e dal profondo respiro teoretico. Cito, a titolo d’esempio, alcuni aspetti esaminati nel capitolo XIX (p. 131; commento pp. 132-134):
1 - Liberati della saggezza, rigetta la prudenza
il popolo ci guadagnerà cento volte di più
2 - Liberati dell’umanità, rigetta la giustizia
il popolo ritornerà alla pietà filiale ed all’amore paterno.
3 - Liberati dall’ingegnosità, rifiuta il profitto
non ci saranno più né ladri né briganti.
4 - Se questi tre precetti non sono che ornamenti del tutto
insufficienti,
che il popolo tenga fede a questo:
Sii semplice.
Ancorati a ciò che non è artefatto;
pensa poco a te stesso;
abbi pochi desideri.
In queste righe ri raccoglie la morale, segnata dall’assoluta mancanza di
adesione a qualsiasi forma di ritualità. Il conflitto con la ritualità evidenzia l’incompatibilità del Tao con le tesi di Confucio che sosteneva: Chi non conosce i
riti non sarà costante nella propria condotta. Misconoscere i riti conduce alla
caduta dei regni, alla rovina delle famiglie, alla perdita degli individui. Lao fa notare che i riti non sono nati dal popolo ma, al contrario, sono stati codificati ed
istituiti dagli antichi re, e perciò il Tao non ha bisogno di ritualità perché la negazione dell’egoismo e la rinuncia ai desideri inutili non si ottiene con i riti. Secondo il confucianesimo l’umanità (jen), la giustizia (j), l’amore filiale (hisiao),
l’amore paterno (tz’u) sono imposti ed artificiali. Lao propone di considerarli naturali e spontanei, ma in questo caso il discorso sulla virtù è del tutto inutile.
Non è certamente la cultura che rende felici gli uomini, ma la “via”, la vera natura che costituisce l’essenza nella quale siamo e con la quale entriamo in simpatia con il mondo.
RECENSIONI
LAO TSEU, Tao Te king, traduit e commenté par M. Conche, PUF, Paris 2003,
pp. 423.
123
124
Santo Arcoleo
M. CONCHE, Confession d’un philosophe. Reponses à André Comte-Sponville,
PUF, Paris 2003, pp. 279.
«Filosofo a lungo nascosto o sconosciuto, tranne che ai colleghi ed agli studenti», Marcel Conche, secondo A. Comte-Sponville, già suo assistente alla
cattedra di Filosofia alla Sorbonne, è tra i rari filosofi francesi i cui testi “non istituzionali” continuano ad essere letti ed apprezzati. Dedicati alla teoresi (cfr., fra
gli altri, Orientation philosophique, Temps et destin, L’Aléatoire, Présence de la
Nature) o a pensatori fondamentali della storia del pensiero (Pyrrhon ou l’apparence, Montaigne ou la conscience heureuse, Montaigne et la philosophie),
ultimamente hanno spaziato fra tematiche autobiografiche (Ma vie antérieure)
ed analisi di opere poetiche (cfr. Essai sur Homère).
La vastità dei suoi orizzonti, la meditazione critica dei contemporanei, le
considerazioni sulla disgregazione e lo smarrimento dell’autenticità dell’uomo,
soggiogato tavolta dalle molteplici tentazioni antiliberali, mettono a dura prova
il concetto di libertà, conteso da più parti. Con il richiamo all’orrore per lo scempio della natura questo pensatore, schivo e solitario, adotta un mezzo desueto ed espone e ripropone “in diretta” dottrine filosofiche fondamentali, dell’oggi
o del passato più illustre, inserite in un progetto ed in un programma che si alimentano nell’ulteriorità della ricerca.
Le “confessioni”, nella storia del pensiero, hanno dei precedenti illustri, da
Marco Aurelio a S. Agostino ed, attraverso i medievali, fra cui spiccano le pagine di Petrarca, all’epoca moderna, in cui le annotazioni di J.-J. Rousseau sono assai illuminanti. Ma si potrebbero, con grande efficacia, richiamare le pagine di Descartes o l’Autobiografia del Vico e da qui procedere verso la modernità e la post-modernità. Ma lo spirito che anima le “confessioni” di Conche obbedisce ad un progetto personale: il suo confiteor laico è un bilancio non un ripiegamento dell’animo alla ricerca del Vero, del Bene, di se stesso,e non è in
funzione di un’autobiografia che tenda a giustificare le proprie scelte o a rafforzare la propria verità. Queste “confessioni” permettono a Conche di rispondere a XXVI grandi questioni, spaziando nella variegata composizione delle correnti filosofiche contemporanee e ripropongono il sentimento di koinonia, proprio del mondo antico ed indispensabile per l’uomo contemporaneo.
L’indagine muove dall’analisi dei concetti di uomo saggio, di saggezza, e affronta il tema nodale della felicità e della amicizia, approdando ad una significativa meditazione sull’amore, tema già approfondito nel saggio Analyse de
l’amour et autres sujets (Puf, Paris 1999), ricco di considerazioni ma, a mio avviso, indispensabile per comprendere anche l’uomo Conche. Superando l’imbarazzo di un riserbo naif, egli scrive una delle più belle pagine di tutti i tempi
dedicate all’amore coniugale. Egli ricorda la sua Marie Thérèse, musa, nume
tutelare, “anima bella” di cui la morte non ha annullato l’esistenza. “So che non
la rivedrò. Non credo che ci sia qualche luogo in cui Lei vive o esiste. Ma che
debbo concluderne? È del tutto impossibile che l’anima possa cessare di essere o almeno che la cessazione di essere dell’anima possa essere pensata
[…]. L’annientamento non può essere pensato, perché si pensa sempre qualche cosa. Che un’anima sia peritura non può essere pensato. La semplicità di
un’anima non impedisce che essa sia ricca e complessa come l’assoluta semplicità di Dio, che è compatibile con la molteplicità dei nomi divini” (pp. 42-43).
La presenza di Marie Thérèse, il suo ricordo costante, sono una delle sicurezze del volume che trae materia dal confronto con i protagonisti della storia del
pensiero rivisitati all’interno delle proprie esperienze personali. Perciò la ripresa delle problematiche sull’anima è un ritorno alle suggestioni di Lucrezio, Epicuro, Montaigne, Pascal.
Assai complesso è l’itinerario che Conche compie nella sua analisi della
physis condotta in sintonia con gli “antesocratici”, dei quali ripropone l’intero
orizzonte conoscitivo, prima radice della cultura occidentale; essi non sono il
RECENSIONI
Agli uomini occorrono precetti semplici ma efficaci; la loro natura comanda
di “essere semplici come la seta bianca, non tinta; essere tanto naturali quanto un tronco d’albero allo stato originario, non ancora scorticato; non attardarsi nel pensar a se stessi ed ai propri interessi particolari; desiderare il meno
possibile, ossia solo quello che la natura ci chiede – i desideri naturali sono limitati di numero e facili da soddisfare” (p. 134).
Il commentario, articolato in una vasta gamma di sollecitazioni filosofico-antropologiche, spiega ed approfondisce un testo non facile e teoreticamente
complesso per le numerose “trappole nascoste”. La consapevolezza che non
ci sia nulla di fisso, né Dio né anima, ci guida nella comprensione del Tao” fonte da cui emana senza cessa l’evento che si è. Questa fonte non è che una
delle “diecimila fonti”,espressione quest’ultima che,nel linguaggio Tao, ci conduce alla tesi secondo la quale “tutti gli esseri che non sono nulla di fisso, sono fonti che procedono da una fonte madre”. Questa non è che la via, il Tao,
in quanto origine da cui tutto deriva incessantemente. Il saggio è come la fonte: più dona e più riceve (LXXXI, 2). Si vada alla fonte: il saggio non chiama,
spetta a noi andare verso di lui (LXXXI, 3). Il saggio è colui che si desidera incontrare, senza un motivo particolare, e privo di specifiche qualità. Ed è questo incontro con la saggezza che Conche augura ai lettori. Ideale di saggezza
particolarmente efficace contro la violenza, cifra nella quale affonda la “civiltà”
contemporanea. I grandi saggi dell’antichità, Socrate, lo stesso Gesù Cristo si
sono scontrati con il problema della violenza ed entrambi, figure emblematiche
dell’occidente, ne sono stati travolti, proprio come nel secolo appena trascorso, fra i molti altri, Gandhi e Martin Luther King. “Socrate e Gesù hanno voluto rendere gli uomini migliori […]. Hanno creduto, l’uno e l’altro, che poteva esserci una violenza buona, che talvolta poteva essere giustificato un uso violento della forza. Significava fare una concessione ai violenti. La vera forza esclude la violenza […]. Lao-Tseu oppone T’ien, il cielo, la Natura, e jen, il sociale,
la civilizzazione. Si può sfuggire alla violenza facendo ritorno al ‘Cielo’ - che
non significa alcuna trascendenza – e questo, in vita, attraverso la saggezza,
dopo la vita, attraverso la morte. Il saggio vivente può sembrare essere morto”
(pp. 414-415).
125
126
nella realtà compositiva e culturale dell’Autore. Il volume del Conche è uno
spaccato teoretico non solo del suo pensiero, ma della situazione presente del
pensiero contemporaneo, all’interno del quale predominante appare il ruolo del
pensiero francese e di quello tedesco. Rimangono nell’ombra l’universo filosofico inglese, quelli italiani e spagnoli, questi ultimi sicuramente non all’avanguardia. E questo è un chiaro segno della perifericità delle culture “liminari”,
che non hanno il vigore di superare la soglia che impedisce loro di porsi a fianco dei grandi sistemi.
La filosofia anglo-americana –con le eccezioni di Bradley, James o Dewey–
a partire dal primo Novecento è stata improntata a Russell e si è sviluppata
nelle scuole di Cambridge e Oxford, nelle università degli Usa, fautrici delle
correnti analitiche, alternative alle tendenze metafisico-ontologiche delle scuole franco-tedesche: perciò la antimetafisicità delle prime non si raccorda con le
seconde. Conche, sia pure aperto al dialogo, non intravede alcuna possibilità
di estendere un intesa con quelle filosofie che, a priori, postulano la negazione della metafisica. È convinto che “la filosofia in quanto metafisica (che è la
parte inamovibile della filosofia) è ricerca della verità nei confronti del Tutto della Realtà. Queste due nozioni, Tutto e Realtà, sono essenzialmente problematiche […]. Secondo me il Tutto di ciò che esiste è la natura; ma non esiste assolutamente alcuna dimostrazione del naturalismo che s’imponga a tutti. In
Metafisica non esiste alcuna prova che non possa essere contestata. Così
ogni metafisica è particolare: esistono le Metafisiche. È questo il pluralismo filosofico, che non sarebbe possibile senza uno scetticismo di fondo, che altro
non è che il riconoscimento dell’essenziale ignoranza dell’uomo, della sua condizione” (p. 141). Approfondimenti su questo soggetto si trovano nella questione XXIII, L’offerta della natura infinita (pp. 173-186) e nella XXIV: Essere veramente: essere causa sui (pp. 187-198). C’è anche da richiamare il ruolo importante della morale, oggetto di molte riflessioni, qui riprese ed estese ulteriormente, oltre i valori e la dottrina del fondamento, al ruolo della civilizzazione ed
alla religione, considerata come assolutizzazione dell’intimo anelito dell’uomo.
“La religione ha avuto un nuovo slancio dopo Hiroshima. Nella sua forma odierna la religione è figlia della bomba atomica. Si nutre dell’angoscia diffusa di
fronte la possibile scomparsa dell’uomo. Trova conforto negli attentati, come
quello dell’11 settembre 2001, che fanno scoprire a tutti la fragilità della realtà
umana. Trova aiuto nell’astronomia: alcuni astrofisici che seguono il modello
secondo il quale l’universo sarebbe cominciato 15 miliardi di anni fa, lasciano
intendere che prima del bing-bang c’era stato il fiat del Creatore. Un fisico, ricevuto in Vaticano, ha incantato Giovanni Paolo II. Non affermiamo dunque
che la religione non abbia un avvenire. La religione ha, come dice Freud, un
avvenire: l’avvenire d’una illusione” (pp. 199-200). Complessa e senza limiti, la
conoscenza umana si apre ai nuovi orizzonti della tecnica, della scienza, della storia e della politica. E se la questione palestinese –come un tempo la questione balcanica e più recentemente quella afgano-irachena– sollecita la riflessione del filosofo, quella dell’uono Conche rimane attonita ed affranta di fronte
un’umanità spezzata,violata e ferita. Collegandosi a Pascal, alla sua visione
del cristianesimo, alla dottrina della sofferenza, Conche dichiara di soffrire, co-
RECENSIONI
modello per intendere la natura né suggeriscono un metodo, sono invece la risposta più compiuta alla questione sul significato della natura, che essi hanno
interrogato e sulla quale hanno trovato la risposta definitiva, autentica,universale ai propri interrogativi. In questa originaria risposta, la verità “dipende dal
fatto che essi sono vicini –si sono meno allontanati– alle istituzioni degli uomini liberi che pensano solo unicamente solo per sé il mondo e la vita”. Conche
riconosce i suoi debiti verso tutti i sistemi, in particolare verso Aristotele, del
quale però contesta la teologia naturale, l’eternità delle speci, la teoria del movimento e la dottrina di Dio quale causa finale e la finitudine dell’Universo, in
breve “tutto ciò che è diventato insostenibile dopo Galileo” (p. 48). Il significato della natura rivela “l’esperienza mistica dell’infinità della natura, nella quale
tutto passa e non passa. Quello che non passa:la fugacità del tutto, la morte,
il tempo, la natura, il divenire. Se distolgo lo sguardo dalla molteplicità degli esistenti effimeri, per tornare a guardare verso il tutto dell’esistenza, considerata
come tale, il mio progetto non sarà più l’apparenza della natura, la realtà che
fugge, ma l’eterno […]. Che ne è della natura? Non è un essere, ma ciò che
implica la finitudine: essa è l’Essere, se si intende con ciò tutto quello che è
eterno, ed è infinita perché non esiste che lei” (p. 52). La natura tende alla “globalizzazione” dell’essere e del conoscere, che Conche collega alla gnoseologia ed all’ontologia. Sono aspetti che riprendono la filosofia di Montaigne, Pascal, Kant, Nietzsche ed Heidegger. Ma è presente anche Jean Wahl, del quale Conche sottolinea il vigore teoretico e l’importanza dell’analisi storiografica:
è stato Wahl ad iniziare la cultura francese alla conoscenza ed all’approfondimento dell’opera di Heidegger.
La XIII questione (pp. 79-85), dedicata a Marx ed Heidegger, esamina il significato politico del marxismo negli anni ’50, e principalmente le tesi economiche. Conche dichiara la sua distanza dal materialismo storico e dalla rivoluzione sociale: Marx non ha mai affrontato i problemi della liberazione contadina
né ne ha compreso il ruolo, assai diverso dalla rivoluzione borghese e da quella proletaria. Cita una certa assonanza con Heidegger, per la sua origine contadina, per le stesse gioie comuni nell’ambiente rurale. “Povero, per affrontare
gli studi superiori, conobbe gli stessi problemi finanziari identici ai miei. Sposò,
come me, una donna di classe sociale diversa dalla sua […]. Originariamente
di fede cattolica, abbandonò come me la religione della sua infanzia” (p. 83).
Esaurisce in brevi battute la querelle sulla “prolusione” del Rettorato e sull’adesione al nazismo Heidegger “ha riconosciuto il suo errore; e poi, chi non ha
commesso errori? Non c’è stato forse un sostegno internazionale alla politica
estera sovietica all’indomani della repressione di Budapest nel 1956? Nel 1956
il mio comportamento era reattivo: condannavo dentro di me la repressione come violenta ed ingiusta, ma l’URSS era violentemente attaccata ed io sono solito essere a fianco dei miei amici specialmente quando hanno torto […]. In breve oggi i filosofi, relativamente giovani […] hanno il diritto di essere severi con
Heidegger; quanto a me, questo diritto non me lo riconosco (p. 85) (cfr.il saggio Heidegger resistente, in appendice al volume Sit venia verbo, di M.
Deutsch, Interlinea, Novara 1998, pp. 71-101).
Ogni recensione di un’opera deve saperne contestualizzare il contenuto
127
Santo Arcoleo
H. MALDINEY, Della transpassabilità, trad. e cura di F. Leoni, Mimesis, Milano 2004.
128
È uscito recentemente in italiano Della transpassibilità di Henri Maldiney, a
cura di Federico Leoni, edizioni Mimesis, collana “l’occhio e lo spirito”, Milano
2004.
Un’ampia ed articolata introduzione ed una nota preliminare su Maldiney di
Federico Leoni –che svolge da tempo attività di ricerca sulla filosofia contemporanea e, in particolare, sulla fenomenologia francese– permettono di situare
quest’opera in un più ampio contesto filosofico.
Nella versione originale, questo saggio fa parte della raccolta Penser l’homme et la folie (Grenoble, Éditions Jérôme Millon, collection Krisis, 1991 e 1997)
di cui usciranno prossimamente con Einaudi, sempre a cura di Federico Leoni, altri tre saggi: “Psicosi e presenza”, “Crisi e temporalità nella psicosi”,
“Evento e psicosi”, riuniti nel titolo omonimo Pensare l’uomo e la follia. (Prima
di queste importanti traduzioni, solamente due brevi saggi di Maldiney erano
disponibili in lingua italiana: “Cézanne e Sainte-Victoire. Pittura e verità”, (tratto da: L’art, l’éclair de l’être, Péronnas, Éditions Comp’Act, collection La Polygraphe, 20032, pp. 21- 35), tradotto in: “Pratica filosofica”, n° 10, Milano, Cuem,
1996; e Cervino (tratto da: Ouvrir le rien, l’art nu, La Versanne, Éditions Encre
Marine, 2000), tradotto da Monica Del Ranco, postfazione di Carmelo Colangelo, Verbania, Tarara, 2002.)
Autore ancora poco conosciuto in Italia, Henri Maldiney è già una delle figure di rilievo del pensiero contemporaneo. La sua filosofia si distingue per originalità, innovazione, profondità, per aver saputo intrecciare in modo singolare ed inedito, ma al tempo stesso pertinente, riflessioni che spaziano dalla filosofia classica alla fenomenologia, dall’estetica alla psicopatologia, dalla pittura
alla poesia. Originalità e profondità che permettono a Maldiney di compiere
quel difficile ma auspicabile incontro tra ambiti sicuramente diversi ma accomunabili dall’investigazione dell’“enigma umano” o dell’esperienza umana.
Molti i filosofi che lo hanno influenzato; tra i più importanti: Heidegger, Husserl, Fink, Merleau-Ponty, Lévinas, Fichte, Schelling e Nietzsche. Molti gli au-
tori contemporanei di cui si è occupato e con i quali ha instaurato un dialogo
per noi prezioso; tra questi: Ludwig Binswanger, André du Bouchet, Roland
Kuhn, Françis Ponge, Jacques Schotte, Erwin Straus, Victor von Weizsäcker.
Molti infine i saggi da lui consacrati alla pittura cinese e all’opera di grandi artisti del ventesimo secolo come Paul Cézanne, Jean Bazaine, Robert Delaunay, Nicolas De Staël, Wassily Kandinsky, Pier Mondrian, Paul Klee, Pierre Tal
Coat.
Sulla scia di Lévinas e di Heidegger, ma in modo ancor più innovativo, Maldiney cerca di individuare un nuovo registro fenomenologico che sia al di qua
di tutto ciò che è costituito in modo dualistico secondo la struttura “soggettooggetto” spesso privilegiata dalla filosofia. Questo registro è appunto la dimensione estetica dell’esistenza, nel senso greco dell’aisthésis, la dimensione primordiale del sensibile, di un sentire che può anche trasformarsi in una perturbazione stessa dell’esistenza. L’aisthésis, per Maldiney, è legata a tutto ciò che
è “sentito come un aspetto del mondo prima ancora di essere un aspetto di
questa o quella cosa”. L’aisthésis costituisce uno spazio di senso intuitivo e
sensibile, spesso occultato dalle filosofie della coscienza. E proprio per questo
Maldiney afferma più volte che “l’arte è la verità del sentire”.
In effetti, sia l’arte che la follia attestano in modo privilegiato il carattere inoggettivabile del sentire e dell’esistenza. Né l’arte né la follia sono concettualizzabili: nell’una come nell’altra si è confrontati a ciò che non è tematizzabile,
all’espressione stessa dell’imprevedibile. Se all’origine di un’opera d’arte vi è
sempre un gesto, un grido che lacera la trama dell’oggettività, la psicosi esprime invece in modo paradigmatico ciò che vi è d’irriducibile nell’esistenza umana, un’esistenza “costretta a misurarsi con l’impossibile”. Crisi –patologica– e
creazione –estetica– sono innanzitutto imprescindibilmente legate all’esistenza e sono fondamentali per la comprensione della nostra presenza, del nostro
modo di rapportarci al mondo: “il patologico deriva visibilmente dal patico, dal
pathos, dall’espressione”.
In Della transpassibilità, Maldiney chiarisce la radice etimologica e concettuale di due nozioni chiave della sua filosofia: la transpassibilità e la transpossibilità. Si tratta di due neologismi strettamente legati all’articolazione del suo
pensiero.
All’inizio del saggio incontriamo una prima definizione: “transpossibilità e
transpassibilità definiscono due modi di esistere in trascendenza, di cui l’essere malato segna lo scacco”. L’opposizione “possibilità-passibilità” riprende la
distinzione aristotelica tra “poiêin” e “pathêin” (agire e patire) o tra “nous poietikós” e “nous pathetikós” e i termini “possibile” e “passibile” vanno qui riferiti
alle “distinzioni post-aristoteliche relative al funzionamento del pensiero”
(“nous” o “intellectus”). A partire dall’opposizione aristotelica tra “intelletto attivo” e “intelletto possibile”, Maldiney si rifà al senso del “possibile” come riconducibile alla radice “pathêin” (subire in opposizione al fare), vale a dire sia “in
potenza” sia “ricettivo o passivo”.
L’intento di Maldiney è cogliere il senso autentico di quella che con Victor
von Weizsäcker definisce la “dimensione patica dell’esistenza”, in cui la capacità di subire o patire implichi al tempo stesso un’attività come apertura del pro-
RECENSIONI
me Pascal, in Gesù Cristo, considerando che Gesù Cristo si incontra, ad un
certo momento, nella kamikaze palestinese. “Si, ho vissuto il cristianesimo totalmente come Pascal, ma anche male, ossia senza uscire dalla mia camera
e scrivendo solo parole invece di uscire come S. Vincenzo de’ Paoli a fare
quello che bisognava fare” (p. 50).
L’immagine di una natura attiva e vivente, dell’uomo combattuto fra il pensare e l’agire, la religione come sostegno ed aiuto ad un’umanità dilacerata e
sofferente, sono alcuni dei temi con i quali Conche ci invita a riflettere sull’oggi, ancorati al passato, ma proiettati verso un domani che sarà meno tragico
se l’uomo opererà una conversione verso il Bene, parola che come il Vero e
l’Essere “si dice in molti modi”
129
130
La descrizione dell’orizzonte come evento porta non soltanto a sovvertire
l’opposizione io-altro, ma anche a comprendere diversamente l’apertura verso
noi stessi. Le dimensioni del patico, dell’evento, della transpassibilità e della
transpossibilità sono quelle che permettono un’apertura a noi stessi, correlativa dell’apertura all’altro.
Se “l’evento per eccellenza è l’incontro”, l’incontro non è solo “incontro con
l’altro” ma anche e soprattutto “incontro con se stessi”. Del resto la psicosi mostra in modo emblematico che vi è sempre una parte di alienazione nella relazione con l’altro.
Le ultime pagine di Della transpassibilità si chiudono proprio su questa dimensione dell’alterità a sé come “dimensione dell’assenza”, ma di un’assenza
necessaria per la costituzione stessa della propria soggettività.
L’incontro transpassibile con l’altro è innanzitutto passibile di una trasformazione dell’esistenza, correlativa a questo stesso incontro con l’altro. L’esistenza stessa ci obbliga a fare la prova dell’impossibile: essere se stessi non è altro che esistere alla prova dell’impossibile.
RECENSIONI
prio campo di ricettività. Proprio la dimensione patica ci aiuta a pervenire al
senso della transpassibilità: “la passività dell’io nei confronti di ciò che può portarlo a se stesso, afferma Maldiney, può essere una prima immagine di ciò che
intendiamo per transpassibilità”. Maldiney conferisce una grande importanza
alla dimensione patica dell’esistenza ed attribuisce a Straus e a von Weizsäcker il merito di aver enfatizzato che l’esistenza non è riducibile alla sola dimensione conoscitiva ma comporta sempre la dimensione del patico, del sentire
che, sebbene diverso dalla conoscenza, costituisce un modo privilegiato dell’esperienza stessa e permette un’altra apertura al mondo. Se Straus evidenzia la natura in-intenzionale e in-oggettivabile del sentire, per definirlo piuttosto
come “comunicazione simbiotica con il mondo”, von Weizsäcker dal canto suo
rileva il carattere strettamente passivo dell’esistenza: “la parola patico, afferma, indica che l’esistenza è meno posta che subita.”
Passibile dell’imprevedibile, l’esistenza è senza fondamento. Il rifiuto di
Maldiney nei confronti di qualunque istanza soggettiva, incompatibile con la
transpassibilità, che sia all’origine dell’esistenza stessa, lo porta ad avere, su
questo punto, un’attitudine critica sia nei confronti di Husserl che di Heidegger.
La nozione di soggettività trascendentale husserliana, così come la progettualità del Dasein heideggeriana, non rendono conto della dimensione imprevedibile dell’evento. Per Maldiney un orizzonte aperto non è aperto da un progetto. È piuttosto l’orizzonte di cui siamo “passibili”, l’orizzonte di un’esistenza che
non è assunta attivamente ma che è subita.
La transpassibilità indica quindi non solo l’impossibilità di una presa di posizione preliminare del soggetto, ma anche l’impossibilità di una predeterminazione originaria di un orizzonte già possibile. Con la nozione di evento, Maldiney cerca di caratterizzare l’irruzione del nuovo, dell’inatteso, dell’imprevedibile. L’evento apre ad un nuovo mondo ed implica così una trasformazione costitutiva dell’esistente nel suo rapportarsi al mondo, agli altri, a se stesso.
La nozione di evento, e quella del reale ad essa correlativa come ciò che
non è atteso, ciò che è irriducibile all’evidenza, introducono al problema dell’alterità. Anche su questo punto né Husserl né Heidegger hanno apportato, per
Maldiney, delle risposte soddisfacenti. Anche su questo punto, i concetti di
transpassibilità e di transpossibilità permettono effettivamente di pensare la
destituzione, la privazione dell’esistente nell’accoglienza dell’alterità dell’evento. “L’evento, afferma Maldiney, il vero e proprio evento-avvento, che espone
al rischio del divenire altri, è imprevedibile. È incontro con l’alterità”.
Nel caso della psicosi, ci troviamo di fronte ad una enigmatica interruzione,
ad una preclusione della dimensione dell’evento, della transpossibilità e della
transpassibilità: “nella psicosi la trasformazione dall’uno all’altro mondo non ha
luogo. Per l’esistenza immobilizzata nel frammezzo dei due mondi, non si dà
più evento. Essa si trova sprovvista di tale esistenziale.” La rottura improvvisa
dell’esistenza e l’apertura di una nuova forma esistenziale obbligano l’esistente a confrontarsi con l’impossibile, con delle situazioni estreme dell’esistenza.
La transpassibilità costituisce quindi la dimensione più profonda e più enigmatica della nostra esistenza e fonda la nostra possibilità stessa di esistere in
quanto è una possibilità che ci oltrepassa.
Maude Dalla Chiara
A. SAVIGNANO, Don Chisciotte illusione e realtà, Rubbettino, Soveria Mannelli
2005, pp. 88.
Nel 2005, il quarto centenario della prima pubblicazione del Don Qujiote de
la Mancha è stato celebrato in Spagna con vari convegni di studio e diverse
pubblicazioni. In tale occasione gli studiosi si sono soffermati sulle molteplici
interpretazioni dell’opera cervantina, e in particolare sulle letture offerte dai più
grandi autori spagnoli del Novecento. Al di fuori della Spagna, non va sottaciuta altresì la rilevanza delle interpretazioni rese dai più grandi filosofi, romanzieri e poeti europei, tra i quali Kant, Schelling, Novalis, Goethe, Heine, Thomas
Mann e Pirandello. Nell’Introduzione al suo volumetto, Armando Savignano osserva che tuttavia l’Europa non ha compreso il significato filosofico del romanzo, e aggiunge: “Il fraintendimento dell’umanesimo di Cervantes scaturisce dall’aver dimenticato la funzione rivelatrice e speculativa del linguaggio retorico.
Cervantes non parte dall’identificazione razionale della realtà, ma da un capovolgimento dell’identità logica inventando un nuovo genere: il romanzo attraverso cui si espresse con un linguaggio ingegnoso, metaforico, creativo e storico” (p. VI). Il romanzo di Cervantes rappresenta nelle vicissitudini di Alonso
Chisciano il Buono il nucleo drammatico della vita umana, l’illusione e il disinganno che ogni uomo sperimenta nella sua esistenza.
La “storia degli effetti” relativa al romanzo è resa particolarmente intricata
e intrigante dal fatto che Cervantes dissemina nel libro una miriade di “allusioni simboliche al senso universale della vita” offrendo ben pochi “indizi per la
sua interpretazione” (ibidem). Come è stato talora autorevolmente scritto, l’ingegno dell’autore consiste soprattutto in una straordinaria capacità di cogliere
le misteriose corrispondenze tra i diversi ambiti del reale. All’interno di una Wir-
131
132
espressione è affidata alla novella” (p. 23). Il popolo spagnolo è il meno “teorico” tra i popoli europei e Ortega non è certo l’unico a pensare che la sua visione del mondo si rinvenga, molto più che nei trattati di filosofia, nella letteratura: nel romanzo, nella novella e nella poesia sono dispersi i tesori della “metafisica” spagnola. In tali opere, e segnatamente in Cervantes, si attinge quel sapere che per Ortega è verità che sostiene e rischiara la vita umana. Si tratta
del “sapere ciò cui attenersi” nella vita, quello di cui l’io ha bisogno per orientarsi nella “circostanza” che gli è coessenziale (“Yo soy yo y mi circunstáncia”)
e per salvare insieme se stesso e la circostanza. Soffermandosi sulla lettura
del Don Chisciotte proposta da Ortega, Savignano non manca di rilevare le diverse e significative suggestioni derivanti dalla fenomenologia tedesca. Tale
lettura intende dissolvere l’ambiguità che è stata ascritta a Cervantes e al suo
romanzo, ponendo in luce l’essenza tragica di Don Chisciotte. Egli è “eroe tragico perché volendo essere se stesso deve vivere in perpetuo confronto-scontro con la circostanza” (p. 33).
Di diverso tenore è l’interpretazione proposta da Ramiro de Maetzu, autore
che appartiene alla “generazione del ’98”, ovvero a quegli intellettuali che, in
quel periodo di grave crisi per la Spagna, si interrogavano sulle cause del declino e preconizzavano, pur con diversità di accenti e di proposte, il suo superamento. Per de Maetzu, Cervantes è partecipe del clima culturale creato dall’umanesimo. Questo è inteso nella sua accezione più elevata dall’autore, che
propugna un confronto critico con l’universo valoriale dell’umanesimo per superare una crisi dovuta a suo giudizio dallo “scacco etico” delle visioni del mondo che si contendono il campo, il liberalismo e il collettivismo. Nella sua maturità, de Maetzu difende le ragioni di un cattolicesimo conservatore di impronta
nazionalista e tutt’altro che scevro di tendenze imperialiste, il quale rinviene
nell’opera di Cervantes un universo valoriale da riscoprire. Inoltre, Don Chisciotte è per lui l’ipostasi più significativa della decadenza spagnola e nelle sue
vicende viene rappresentato il disincanto che consegue all’“avere voluto troppo”. Il popolo spagnolo, nel passato, è incorso in tale errore, ma all’inizio del
Novecento, per de Maetzu esso incorre nell’errore opposto, il non volere quasi più nulla, l’abulia che costituisce il male nazionale da combattere affinché la
Spagna si riappropri della dignità che le compete nel consesso delle nazioni
europee.
La riflessione sul Don Chisciotte accompagna la meditazione sui valori della hispanidad anche in Américo Castro, intellettuale che conobbe l’esilio in seguito alla guerra civile originata dalla sollevazione franchista. Tale riflessione è
attestata dagli importanti saggi sull’onore, risalenti al 1916, e dal volume Il pensiero di Cervantes (1925). Savignano nota che l’interpretazione di Castro “cerca di superare la frattura tra chisciottisti –ovvero i fautori di un approccio modernizzante nell’ambito della teoria del romanzo– e i cervantisti, ritenuti conservatori” (p. 52). Inoltre, ad essa va ascritto il merito di denunciare i limiti di
una lettura che aveva considerato Cervantes quale uomo dotato di una fervidissima immaginazione creatrice, ma tutt’altro che eccezionale sul piano intellettuale, un ingenio lego che accoglie ed esprime i modi di pensare prevalenti
al suo tempo. Castro pone opportunamente in rilievo le molteplici suggestioni
RECENSIONI
kungsgeschichte sterminata, lo studio di Savignano prende in considerazione
l’interpretazione proposta nel Novecento da autori spagnoli quali Miguel de
Unamuno, Ortega y Gasset, Ramiro de Maetzu, Américo Castro, Salvador de
Madariaga e María Zambrano. Per l’autore, de Unamuno situa Don Chisciotte
“tra idealismo e tragedia”, Ortega “ne fa l’archetipo della volontà di avventura”,
de Maetzu lo considera “la figura del disincanto spagnolo”, Castro “ricostruisce
il pensiero e la visione del mondo di Cervantes”, de Madariaga “propone una
lettura psicologica e politica” mentre María Zambrano “pone in luce l’ambiguità di Cervantes e l’enigma chisciottesco” (p. VII).
Tra tali letture, si segnala per la sua paradossalità quella proposta da Miguel de Unamuno nel primo Novecento in opere quali Commento alla vita di
Don Chisciotte e Del sentimento tragico della vita. Per il pensatore basco alla
“limitatezza dell’ingegno” di Cervantes sopperisce la “miracolosa grandezza di
Don Chisciotte” in virtù della quale lo scrittore “superò di gran lunga se stesso”
(p. 1). Allorché in Spagna prevale la tendenza a leggere l’opera cervantina da
una prospettiva erudita o estetizzante, Unamuno, con il vigore espressivo che
gli è proprio, afferma che il Don Chisciotte è “la Bibbia spagnola” e va letto alla luce di una visione religiosa della vita, fortemente connotata in senso tragico, proscrivendo quindi qualsiasi tentativo di interpretazione in chiave umoristica. Proprio la meditazione chisciottesca consente a Unamuno di compiere un
percorso volto a scoprire le motivazioni profonde del suo impegno intellettuale. Per il pensatore, il romanzo ha costituito dunque una sorta di Guida. È, questo, un genere letterario che ha una prestigiosa tradizione all’interno della cultura spagnola, come nota María Zambrano, la quale ravvisa in esso una forma
di pensamiento di cui l’uomo ha estremo bisogno nelle epoche di crisi, come
quella in cui scrive. Da un’altra prospettiva, in considerazione dell’importanza
assunta dal Don Chisciotte nella maturazione spirituale e intellettuale di Unamuno, si potrebbe vedere nell’opera un singolare Bildungsroman, non in rapporto al protagonista, ma allo stesso Unamuno, e a chi, come lui, non si limiti
a leggerla alla stregua di qualsiasi opera narrativa, ma intenda realmente “dimorare” nelle sue pagine. Attraverso le meditazioni chisciottesche il rettore di
Salamanca scopre qual è la sua missione: “risvegliare la coscienza della libertà attraverso l’amore per la verità”. Si tratta “ad un tempo di una missione ‘religiosa’ e civile come lo esigevano la conversione” a un “protestantesimo liberale di ispirazione ritschliano-cattolica” (p. 5). La temperie dell’epoca richiede
uomini che siano “cavalieri della fede” come lo è stato Don Chisciotte. La fede
di questi è per Unamuno il paradigma dell’atteggiamento religioso autenticamente “agonico” e tragico, della fede che lotta nel creare ciò in un crede.
La lettura del personaggio cervantino offerta da Ortega y Gasset nelle celebri Meditazioni del Chisciotte (1914) fa da contrappunto a quella di Unamuno, pur essendo, per certi versi, debitrice nei suoi confronti, come nota Savignano (p. 19). Si tratta qui di una lettura schiettamente filosofica, che considera l’autore del più grande romanzo della letteratura ispanica soprattutto come
“l’unico filosofo spagnolo”. Nelle sue Meditaciones, Ortega “ha conseguito viva
consapevolezza della peculiarità unica e irriducibile della vita umana, anche se
il suo modo d’essere gli appare sotto forma di eroismo e tragedia, la cui
133
134
ancora maggiore ai personaggi della poesia e del romanzo, che guadagnano
nella sua prospettiva un coefficiente di realtà non minore degli uomini in carne
ed ossa, qualora siano dotati di una volontà eroica. Per Zambrano, Don Chisciotte resta comunque una vivida ipostasi dell’insieme di valori che sostengono la vita autentica, il “vivere che è convivere” nelle parole del maestro Ortega: la solidarietà e la fede nel popolo, che animano peraltro l’impegno di un autore caro alla pensatrice, Antonio Machado. Nella sua riflessione, María Zambrano si distanzia sia da Ortega che da Unamuno in quanto entrambi, in forme
diverse, hanno inteso dissolvere l’ambiguità di Don Chisciotte, ovvero proprio
ciò che dà luogo a un’interpretazione inesauribile. Lo stesso Cervantes ha una
sua “ambiguità” per l’autrice, in quanto fa di Don Chisciotte, che ha la vocazione dell’eroe mitico, un personaggio romanzesco, esponendolo alla burla dei
suoi contemporanei. Invero, l’Hidalgo vuole conferire realtà al suo sogno, “inventare” così la sua vita e l’agonismo che questo progetto suscita in lui è per
María Zambrano –forse non meno che per Miguel de Unamuno– quanto di più
serio e drammatico vi sia nella volontà umana.
RECENSIONI
che derivano a Cervantes dalla complessa cultura del Rinascimento europeo,
e italiano in particolare. L’arte di Cervantes è riuscita a ridare vita, pur in forma
diversa, alla disputa, sviluppata dai trattatisti del Rinascimento, che opponeva
le ragioni della poesia a quelle della storia. Nel romanzo, l’Hidalgo dalla Triste
Figura rappresenta le prime e il suo scudiero le seconde: “Don Chisciotte difende ciò che è universale e verosimile, Sancio il dato sensibile, naturale e particolare” (p. 55). Così, ciò che a Sancio sembra una bacinella da barbiere sembra al Cavaliere “l’elmo di Mambrino” e a un altro può sembrare un’altra cosa
ancora. Cervantes non intende risolvere la disputa, schierandosi da una parte
o dall’altra, e pare legittimare una visione del mondo che tenga conto di una
molteplicità di valutazioni espresse in circostanze diverse, piuttosto che fare
appello all’universale condivisibilità degli “elementi oggettivi”.
Non meno interessante è l’interpretazione resa da un altro grande intellettuale antifranchista, Salvador de Madariaga, scrittore, giornalista, diplomatico
e infine cattedratico all’Università di Oxford. Madariaga osserva che l’immaginazione di Cervantes, “romantica per natura” e “classica per sobrietà”, “dà luogo ad un mirabile equilibrio di concezione ed espressione” (p. 69). In Don Chisciotte la follia permette comunque che talora affiorino momenti di lucidità: egli
ha in se stesso il peggiore nemico dei suoi progetti di gloria, nella coscienza
che avverte come tutto sia illusione. Madariaga considera inoltre inadeguata la
trita contrapposizione tra un Don Chisciotte idealista e un Sancio realista. In realtà, lo scudiero “è, in un certo modo, una trasposizione di Don Chisciotte in
una chiave distinta”. In entrambi la ragione –intellettuale e tendente all’idealismo nel cavaliere, empirico-pragmatica nello scudiero– perde l’equilibrio e
soggiace all’illusione. Questa si configura in Sancio come la prospettiva del potere, conseguente alla conquista dell’isola di Barattaria, mentre nell’Hidalgo si
incentra sulla gloria. Per Madariaga, convinto europeista, Don Chisciotte incarna gli ideali dell’uomo europeo, attratto dai valori propri dell’eroe più che da
quelli testimoniati dal santo. L’europeo tende a seguire la ragione, e l’eroe cervantino ha una sua “ragionevolezza”, in lui la ragione è quasi in concordia discors con la follia. L’uomo europeo ha affermato gli ideali di libertà, e Don Chisciotte nelle parole rivolte allo scudiero si mostra ben consapevole della loro
incomparabile rilevanza (“La libertà, Sancio, è uno dei doni più preziosi che i
cieli abbiano dato agli uomini”).
Se per Unamuno, come si è detto, il romanzo cervantino costituisce la Bibbia spagnola, per María Zambrano, acuta interprete dello stesso Unamuno e
“discepola eterodossa” di Ortega, Don Chisciotte è per gli spagnoli il “più chiaro mito, il più vicino all’immagine sacra”. La riflessione zambraniana al riguardo si dispiega in un arco temporale alquanto ampio, dagli scritti risalenti alla
guerra civile (La reforma del entendimiento español) a quelli della tarda maturità (segnatamente dei saggi riportati nel volume España, sueño y verdad). Durante la guerra civile, la pensatrice ama vedere in Don Chisciotte l’incarnazione dello spagnolo che nel conflitto si schiera dalla parte del popolo. Nell’Hidalgo la volontà pura “urta con la realtà storica rispetto alla quale egli si rifugia nella follia per additare la giustizia e il bene” (p. 74). In seguito, durante l’esilio,
l’autrice riprende la riflessione su Don Chisciotte, allorché presta un’attenzione
Nunzio Bombaci
S. BORUTTI, Filosofia dei sensi. Estetica del pensiero tra filosofia, arte e letteratura, Cortina, Milano 2006, pp. 173.
Secondo Silvana Borutti, il pensiero di Kant sarebbe «ancipite», dal momento che esso si muove «tra la cosa in sé come apertura di esperienza, invio, di cui è interdetta la conoscenza», da un lato, e «l’oggetto come costrutto, proiezione dell’attività formale del soggetto»: è un giudizio teorico, che
deriva dai due differenti aspetti sui quali hanno puntato l’attenzione le interpretazioni di Kant proposte, rispettivamente, da Martin Heidegger e da Ernst
Cassirer. Da un lato, ci sarebbe l’essere dato dell’oggetto, ci sarebbe l’essere consegnato a questo manifestarsi dell’ente non soltanto la conoscenza
scientifica di quest’ultimo da parte del soggetto, ma qualsiasi forma di esperibilità; dall’altro, il ruolo costruttivo, nella conoscenza scientifica dell’oggetto, delle funzioni epistemiche del soggetto, ruolo in virtù del quale l’oggetto
conosciuto non è, appunto, un dato che si manifesta, bensì l’esito di un costrutto. Leggere la presenza, in Kant, di queste due tendenze come contrapposte in una dimensione di evoluzione storica, secondo la celebre ricostruzione dello sviluppo della deduzione trascendentale e di tutta l’opera kantiana proposta da H. J. De Vleeschauwer (evoluzione che spiegherebbe, anche, la peculiare e decisiva posizione di Kant nello sviluppo della riflessione
filosofica europea fra Settecento e Ottocento, dallo psicologismo gnoseologico, di ascendenza empirista, all’idealismo), significa formulare un giudizio
di carattere storiografico; leggere, invece, la contemporanea presenza delle
due tendenze, che definisce la posizione kantiana nella tensione fra esse e
che la determina, appunto, come ancipite significa esprimere un giudizio teorico, che può valere per definire la posizione di Borutti stessa.
135
136
In questo modo, attraverso la presentazione dell’altro dall’esperienza come
necessario all’esperienza stessa, siamo in presenza del primo dei due possibili modi in cui, come si è detto, è interpretabile il fenomeno conoscitivo nella
riflessione filosofica di Kant e in quella di Borutti: l’essere consegnato dell’esperienza al manifestarsi di un’alterità che è, per colui, che esperisce, data.
Ecco, allora, perché l’esperienza artistica può rappresentare il paradigma dell’esperienza in quanto tale: se l’intelletto è la fonte costruttiva e la sensibilità
quella recettiva, come accade nella celebre partizione kantiana, nella fruizione
dell’opera d’arte si mostra la continuità fra i due termini, continuità che, tuttavia, sposta il baricentro verso la dimensione dell’essere dato dell’oggetto che
si manifesta, piuttosto che verso quella del suo essere costruito. Il fatto conoscitivo risulta, cioè, gravitare verso il polo della recettività, che consiste nella
sensibilità, piuttosto che verso quello dell’attività, che è prerogativa del pensiero. Il carattere ancipite della posizione di Borutti non comporta, dunque, una
simmetria fra i due termini, sensibilità e pensiero. Infatti, anche se, analizzando la «filosofia involontaria» dell’ultimo Calvino, l’autrice sottolinea che «il dato appare carico di teorie, enciclopedie e concettualizzazioni», il superamento
dei dualismi fra intelletto e sensibilità, anima e corpo, soggetto e oggetto, idealismo ed empirismo avviene su un terreno che non è davvero mediano perché
non può essere neutro, dove il peso inerziale della datità di ciò che si manifesta tira a sé il costruire dell’intelletto. Per questo, la conoscenza è estetica, nella duplice accezione che il termine ha acquisito, negli ultimi due secoli, nella riflessione contemporanea: la conoscenza è estetica perché ha la propria radice nella recettività del sensibile, ed è estetica perché l’esperienza artistica mostra ciò, come si è detto, in modo paradigmatico. Qui si colloca l’elemento di
maggiore persuasività e originalità di Filosofia dei sensi, nonché di rigore argomentativo, che si mostra nel carattere unitario dell’opera: l’esame di singole
esperienze artistiche non soltanto non è estrinseco alla posizione teorica sostenuta con argomentazioni provenienti dal patrimonio concettuale della riflessione filosofica, ma non si limita neppure a essere la mera applicazione di una
posizione teorica altrimenti elaborata. La «filosofia dei sensi» di Borutti (filosofia che è «estetica» nel primo senso del termine), in quanto rinvia alla tesi relativa al carattere sensibile della radice del pensiero, non può non essere filosofia dell’esperienza artistica (filosofia «estetica» nel secondo senso del termine). Alla deriva in questo duplice senso –ma soprattutto nel primo– «estetica»
dell’interpretazione del fatto conoscitivo, in quanto spostamento dell’accento
sulla sensibilità quale radice della conoscenza, esistono, in Filosofia dei sensi,
alcuni elementi di correzione e di controtendenza, primo fra tutti la tesi secondo la quale è la forma simbolica a fare l’oggetto, «non attraverso la mediazione universalizzante del sapere, ma attraverso la mediazione dello spazio-tempo locale dell’esperienza del senso»; ma è proprio questa mediazione a fare sì
che la costruzione dell’oggetto sia, appunto, estetica, cioè a fare sì che una filosofia dell’esperienza non possa che essere «filosofia dei sensi».
L’«estetica del pensiero», cioè il carattere sensibile del pensiero, esposta
in Filosofia dei sensi mostra, in questo, un’evoluzione rispetto alla posizione
assunta da Borutti nella sua ultima opera precedente questa, cioè Filosofia
RECENSIONI
In altri termini, la posizione dell’autrice di Filosofia dei sensi si riflette in
quel carattere ancipite che l’autrice attribuisce all’approccio trascendentale
kantiano, dal momento che Borutti colloca la conoscenza tra pensiero e sensibilità, cercandone il luogo più proprio nel terreno di incontro dove le manifestazioni delle due dimensioni sfumano l’una nell’altra: tra dire e tacere, cioè
tra pensiero discorsivo e manifestazione dell’oggetto, tra percezione e immaginazione, tra desiderio e riconoscimento del senso, come recitano i titoli dei
capitoli della prima parte di Filosofia dei sensi. Prima parte che è, appunto,
dedicata all’«estetica del pensiero», cioè al rapporto fra il pensiero e la dimensione che Borutti sottolinea essere la sua radice sensibile: dimensione «estetica», appunto, secondo l’etimo del termine che identifica, ancora con il celeberrimo caso della prima Critica kantiana, nella ricerca estetica l’indagine sulla facoltà conoscitiva sensibile. Che la seconda parte dell’opera sia dedicata
alla «filosofia dell’esperienza artistica» discende da questa tesi, relativa alla
radice sensibile del pensiero: secondo Borutti, infatti, l’arte –tanto quella figurativa, quanto quella letteraria, esaminate, qui, attraverso capitoli dedicati, fra
gli altri, a Francis Bacon e Italo Calvino– mette in luce la radice sensibile del
pensiero, cioè mette in luce il radicarsi della spontaneità nel pensiero, in seguito all’incontro con un’alterità che il pensiero può soltanto, passivamente, riconoscere. Per questo, l’arte è unheimlich, cioè «spaesante»: essa mostra infatti al pensiero, che fonda la spontaneità del proprio procedere sul principium
individuationis, cioè sul dispositivo dell’identità quale principio di concettualizzazione, che l’esperienza è, sempre, tale in quanto è esperienza di un’alterità che non si riduce all’esperienza stessa. L’esperienza è, cioè, possibile a
condizione del darsi, in essa, di un’istanza che sia irrevocabilmente altra rispetto al sé, cioè che sia inesorabilmente inappropriabile da parte di colui che
compie l’esperienza.
Questo aspetto diviene più evidente quando l’arte si trova ad avere a che fare con l’elemento fantastico: Borutti esamina questo caso prendendo le mosse
dall’analisi fenomenologica dell’esperienza onirica –autobiografica– del déjà vu,
dove il riconoscimento come familiare di un luogo mai conosciuto prima mette
in evidenza quello che è lo statuto ontologico del fantastico –che è l’essere altro rispetto al sé, ma un essere altro che il sé, riconoscendolo come tale, sente
tuttavia come un essere proprio o, meglio, come un aver da essere proprio– e
il suo ruolo epistemico, che è quello, come sostiene l’autrice, di «produrre un
nuovo ordine dell’esperienza, mostrandone così il segreto». Questo segreto è,
appunto, quello della consustanzialità dell’altro, nella sua irriducibilità, a ciò che
è proprio al sé e al procedere della sua esperienza, attraverso il pensiero, per
via delle sue categorizzazioni, basate sul procedimento di riconduzione al proprio, cioè all’identico, di ciò che è altro e difforme. Tuttavia, seguendo l’autrice,
questa presentazione dell’«estraneità del proprio» costituisce il tratto caratteristico non soltanto dell’arte che abbia a che fare con l’elemento fantastico, bensì dell’arte in quanto tale, nella misura in cui essa produce una ricomprensione
dell’esperienza del quotidiano: nell’esperienza di fruizione e creazione dell’opera d’arte emerge, infatti, come ciò che si esperisce sia debitore, nella sua possibilità di essere esperito, a un’istanza che esperibile non è.
137
138
cettuale dell’immagine e l’analisi della realtà da essa designata attraversano
tutta Filosofia dei sensi: come afferma l’autrice, infatti, nel «farsi immagini» di
qualcosa si coniugano un aspetto «ricettivo-passivo» e uno «produttivo-attivo», ma è proprio questo coniugarsi a fare sì che il secondo risulti debitore al
primo; è questo che giustifica la tesi secondo la quale «la radice estetica del
pensiero è nel farsi immagini». Per questo, l’esperienza è, in primo luogo,
esperienza d’immagine, esperienza che costituisce il paradigma dello stesso
fenomeno conoscitivo (da qui, la tesi circa il carattere iconico del pensiero, che
equivale, in questo modo, a quella circa il suo carattere estetico) ed esperienza che costituisce «evidentemente, un fenomeno primario», nel darsi dell’immagine non come rappresentazione di una cosa, ma come ab-soluta, cioè come sciolta, dalla cosa: non come rinvio a un ente sussistente posto al di là di
essa, ma come presentazione pura, come «stato nascente» dell’ente, che consiste nel suo manifestarsi («l’immagine non è riflesso della cosa, ma sua epifania»). Quello dell’immagine è, dunque, un potere ontologico, di cui l’arte, secondo Borutti, fa esperienza; tesi, questa, che rinvia all’equivalenza che sussiste, nella prospettiva della pensatrice pavese, tra filosofia dei sensi e filosofia
dell’esperienza artistica e che esplicita l’identificazione tra filosofia dell’esperienza artistica e filosofia dell’esperienza tout court.
Decisivo –nonché illuminante nei confronti dell’assunzione della prospettiva fenomenologica e degli effetti di questa assunzione– è il ruolo giocato dalla figura concettuale della Gegebenheit, cioè di quell’«apparire nella forma del
darsi, o della donazione», in virtù del quale ciò che si dona non resta, appunto, al di là del suo darsi come un ente sussistente e per questo non costituisce,
a differenza di quanto accade nel paradigma rappresentazionale, una cosa in
sé rispetto al fenomeno; è la realtà designata da questa figura concettuale a
determinare, infatti, lo spostamento del baricentro del fatto conoscitivo in direzione della passività recettiva, ovvero della sensibilità. Il tema della donazione,
anzitutto, costituisce il fondamento di legittimità della tesi circa la radice estetica del pensiero; in secondo luogo, permette di offrire una soluzione del problema dell’oggettivazione in una direzione che non solo non condivide quella dell’approccio ermeneutico-testualista, di cui già in Filosofia delle scienze umane
si rilevavano i limiti nei confronti delle possibilità esplicative delle scienze umane, ma che si discosta marcatamente, anche, dal percorso dell’approccio trascendentale, che nella soluzione del problema dell’oggettivazione proposta
nell’opera del 1999 faceva sentire maggiormente il suo peso. Si è già detto del
rigore, consistente nell’organicità della posizione espressa e nella stretta consequenzialità argomentativa con la quale essa è sostenuta, di Filosofia dei
sensi, opera che costituisce, almeno per due aspetti, un punto di riferimento
nella riflessione europea contemporanea: per la sintesi originale che propone
relativamente al problema del rapporto tra concetto e sensibilità, da un lato, per
la riconduzione a unità della divaricazione, verificatasi nel Novecento, tra la riflessione filosofica dedicata a creazione e fruizione dell’opera d’arte e quella
dedicata, invece, alle modalità della conoscenza umana dall’altro. Va aggiunto
che l’opera è godibile nella sua lettura. Quando l’analisi si occupa, in modo che
non è mai né accessorio, né meramente applicativo, di un’incisione di Dürer o
RECENSIONI
delle scienze umane, pubblicata nel 1999. In essa, infatti, la pensatrice pavese assumeva come centrale la questione dell’oggettivazione, per risolvere la
questione relativa ad autonomia e specificità delle scienze umane e sociali nei
confronti delle scienze fisico-naturali. Muovendo dall’esame degli approcci
epistemologici che hanno storicamente fatto perno sul concetto di spiegazione e di quelli che hanno fatto perno, invece, sul concetto di comprensione, nel
1999 Borutti individuava nel carattere compositivo e olistico della forma la radice del procedimento di costruzione dell’oggetto: il carattere «finzionale» della conoscenza designava, in questo caso, il ruolo supplettivo della conoscenza stessa nei confronti di una presenza, quella dell’oggetto in quanto dato, di
cui si sottolineava l’assenza. Diversamente, in Filosofia dei sensi sembra acquisire maggiore rilievo l’altra valenza della finzione, cioè il suo essere «provocazione di un mondo di oggetti», dove il carattere poietico della finzione
consiste nel suo essere «manifestatività, apertura estatica del vero». Il motivo
di questa evoluzione della posizione teorica di Borutti da Filosofia delle scienze umane a Filosofia dei sensi deve essere rintracciato, crediamo, nel diverso
terreno sul quale si pone l’indagine nelle due opere. In quella del 1999, la questione è anzitutto di ordine epistemologico: si tratta, come si è detto, di individuare nella procedura di oggettivazione la specificità delle scienze umane, e
ciò porta a porre l’accento sul carattere di costrutto dell’oggetto, come è evidente, all’interno dell’antropologia, nella figura concettuale del campo. In questo modo, la riflessione sulla conoscenza scientifica induce Borutti a sottolineare gli elementi specificamente intellettuali e il loro ruolo costruttivo, laddove, per contro, in Filosofia dei sensi l’accento si sposta sulla manifestatività del
dato in virtù del fatto, soprattutto, che qui è cambiato l’angolo prospettico: non
più l’indagine relativa alla conoscenza scientifica, bensì l’analisi della conoscenza in quanto articolazione del più ampio fenomeno dell’esperienza umana. È pur vero che anche in Filosofia dei sensi è presente il problema dell’oggettivazione, e che è pure presente il richiamo esplicito all’approccio trascendentale, come fattore di deprivazione del carattere di datità sostanziale dell’oggetto, deprivazione che apre verso un’«ontologia del possibile»; ma è altrettanto vero che l’approccio trascendentale comporta, anche e soprattutto,
che questa rimozione di datità sostanziale dell’oggetto avvenga nella direzione della spontaneità determinativa del soggetto, ovvero della sua costruttività
nei confronti dell’oggetto, e nella direzione del primato di tale spontaneità nei
confronti della recettività propria del senso, mentre è proprio questo primato
ciò che viene meno in Filosofia dei sensi.
Nel carattere ancipite della posizione di Borutti nella sua ultima opera vive
dunque, certo, la tensione, richiamata dalla stessa autrice, fra un approccio in
senso lato trascendentale e uno, in senso altrettanto lato, fenomenologico; tuttavia, il cadere dell’accento sul carattere di manifestatività del dato sposta la riflessione della pensatrice pavese, pur attraverso il decisivo influsso wittgensteiniano, nel campo dell’approccio fenomenologico e struttura l’impostazione
delle questioni –prima fra tutte, quella del rapporto fra attivo e passivo, che determina la soluzione di quella relativa al rapporto fra corporeo e intellettuale– a
partire da alcuni assunti centrali in quest’ultimo. Non è un caso se la figura con-
139
Flavio Cassinari
P. PELLEGRINO, Estetica e comunicazione, Congedo, Galatina 2005, pp. 286.
140
La pubblicazione del testo di Paolo Pellegrino ha rilanciato alcune questioni essenziali inerenti le realtà estetico-filosofiche della comunicazione. Questo
intervento nelle sue intenzioni vuole essere una sorta di sintesi problematica
della posizione assunta dall’Autore.
Articolato in due parti: 1. Che cosa comunica l’opera d’arte? Esperienza
estetica e dimensione comunicativa; 2. Le teorie della comunicazione nella filosofia del Novecento, il libro esamina, nella prima parte, la connessione tra
l’esperienza estetica e la dimensione comunicativa, nella seconda, ripercorre
le principali tendenze nel panorama filosofico del Novecento, rivisitandole dal
punto di vista del linguaggio e della comunicazione. Questo volume si offre come un utile manuale per l’insegnamento dell’estetica, focalizzata da una visuale d’osservazione centrata sul grandangolo della comunicazione.
Per mettere bene a fuoco con quali questioni di fondo il libro si trovi a fare
i conti e, in risposta a queste ultime, verso quali prospettive lentamente si apra
la strada, occorre ripercorrere la traiettoria delineata nel variegato panorama
del rapporto tra estetica e comunicazione.
La pietosa bugia insita nel rispondere celiando che la comunicazione è ciò
che tutti sanno che cosa sia, rivela un disagio reale. In quanto, pur in presenza di un consolidato apparato bibliografico «che dà l’illusione che sia ormai tutto chiaro e non ci sia più nulla da scoprire, è difficile respingere l’impressione
che sia in atto una distorsione nell’accostare il tema della comunicazione, nel
senso che si tende ad appiattirla riduttivamente sul versante dell’industria culturale […], dell’informazione […] e della pubblicità» (p. 7).
L’attuale stato degli studi e delle ricerche che analizzano le strutture e le
funzioni del linguaggio consentono di scorgere subito che la direzione di lavoro imboccata e i livelli problematici lungo i quali essa si dipana non tiene conto dell’approfondimento teorico-filosofico. «Invece, è facile constatare come
tutto l’arco della filosofia del Novecento sia stato investito da autentiche bufere e rotture epistemologiche di radicale portata, e sempre su un terreno che
aveva nella comunicazione il suo banco di prova» (p. 8). Ed è questo il livello
determinante della svolta linguistica, di quella ermeneutica, e di quella comunicativa.
L’alternativa nell’estetica, intravista anche da Perniola, è avvalorata da Pellegrino, che in un’analisi attenta mette capo ad una nuova definizione dell’at-
teggiamento estetico. Nel corso del Novecento l’estetica ha annesso al suo territorio anche la ricerca degli studi di vita, avvalendosi dei contributi che provengono dalle scienze umane, storiche e sociali. Questo ampliamento consente di
comprendere tutte le attitudini e i comportamenti guidati da quel disinteresse
interessato, che nel corso dei secoli ha costituito l’aspetto essenziale dell’esperienza estetica. «L’estetica finisce così col fornire i criteri deonotologici
dai quali è retto l’esercizio di ogni attività intellettuale e sui quali si fonda il suo
prestigio […] insomma la qualità espressiva del discorso o della scrittura, in altre parole la competenza comunicativa in senso ampio» (p. 15).
Questo rapporto tra estetica e comunicazione è un intreccio che si dilata in
innumerevoli ramificazioni e si dispiega in infinite stratificazioni, attraverso molteplici falde, orientato verso l’esperienza di verità: l’opera d’arte come depositaria di un segreto – di un enigma, e al contempo, costitutivamente votata alla
comunicazione.
Nasce da questa tensione dialettica, che si sprigiona in ogni opera d’arte,
l’acuto scandaglio messo in atto da Pellegrino nei confronti delle poetiche del
Novecento che privilegiano l’aspetto del poièin, il tema del corpo e il rapporto
con gli altri, fino alle tendenze più specificatamente operanti in ambito artistico
che decretano l’abolizione della figura e della rappresentazione e il trionfo dell’immagine astratta. Questi movimenti ondivaghi vengono, nel libro, sintetizzati e il loro ritmo altalenante serve all’Autore al seguente scopo «nel quadro delle teorie novecentiste, in cui il rapporto dell’estetica con la comunicazione si è
svolto all’insegna di un’oscillazione caratteristica, ci è sembrato importante
mettere in evidenza i diversi orientamenti, spesso rivali, ma tali da presentare
sul terreno della comunicazione temi e argomenti di sicuro interesse e di stimolo per definire l’identità» (p. 16).
All’intricato problema del segreto, Pellegrino dedica il capitolo primo della
prima parte: L’opera d’arte tra segreto e comunicazione. In cui la dilatazione
semantica del termine segreto è esaminata in tutte le sue sfaccettature, fino al
messaggio ricavato dal mito della Sfinge che costituisce un’utile indicazione ed
una prima approssimazione per giungere a identificare il problema del segreto
nell’arte. Ponendo la questione in questi termini, l’Autore, evoca problemi e approfondimenti ampi, inserendoli nella tessitura filosofica che va elaborando nel
corso del libro.
Ma entriamo subito, senza altri preamboli in medias res e rileggiamo le relazioni a cui si accenneva: «al centro di teoria estetica c’è un arduo passaggio
in cui Adorno, affrontando la questione del significato delle opere d’arte, lo ritrova serrato dal loro carattere di enigma […] ponendo in questo modo i termini del problema, non è difficile dedurre che, per Adorno, il compito della teoria
estetica si concentra nella soluzione obiettiva dell’enigma che si cela in ogni
opera d’arte» (p. 24). Le opere d’arte sono per Adorno enigmatiche non per la
loro composizione, ma per il loro contenuto di verità. Il discorso potrebbe continuare e altri esempi potrebbero entrare in questa costellazione culturale, ma
valga per tutti l’esempio di Heidegger indicativo del comune riferimento all’enigma come la verità nascosta dell’opera d’arte:«nella connessione immanente fra l’arte e la filosofia che aiuta l’arte a venire in chiaro con se stessa, la
RECENSIONI
di una tela di Caravaggio, così come quando prende in esame il concetto di
Darstellung in Wittgenstein, si ha molto spesso l’impressione di venire a sapere qualche cosa al quale non si era pensato ma che era naturale trovare, se
solo si fosse guardato meglio, se solo si fosse dato retta al testo, o al quadro,
nel suo mostrarsi; il che, oltre che del tutto coerente con le tesi sostenute da
Borutti, è anche molto piacevole.
141
142
Il rilievo estetico-filosofico delle questioni che attraversano a fondo le avanguardie artistiche del ’900, Pellegrino lo coglie oltre che nella codificazioni dei
trattati di estetica, anche nei grandi artisti che se ne sono occupati nei loro
scritti di poetica. Tra i temi affrontati le categorie di ordine e disordine, di estetico e artistico, di passività e creatività.
Le tracce dell’influenza di questa problematica Pellegrino le evidenzia nell’opera di Merleau-Ponty, ponendo in evidenza le novità teoriche di una ontologia in cui la genesi dell’essere è percettiva, perché la sua sostanza è chaire.
E nel processo comunicativo dell’arte è impossibile dire «dove finisca la natura e cominci l’uomo o l’espressione: sono le cose stesse che parlano, quelle
cose che si rivelano al nostro corpo che percepisce, la cui “carne” è la stessa
delle cose e partecipa a un comune divenire» (p. 67). Ciò e possibile solo in
quanto l’esito del visibile e l’invisibile comporta la rivelazione della carne estatica e chiasmatica i cui spostamenti, le continue reversibilità, le oscillazioni e
gli intrecci, sono i motivi di una compiuta fenomenologia della visione, del tatto, dell’udito.
Così risalire, come fa Pellegrino, all’evento che dà luogo al linguaggio, ma
dire che, nello stesso tempo, tale luogo resta inespresso in quanto inaccessibile, equivale al compito di restituire il mondo come senso d’essere assolutamente diverso dal rappresentato che nessuna delle rappresentazioni esaurisce
e che tutte raggiungono l’Essere selvaggio.
Particolarmente penetrante, in questa cromatica ricostruzione del panorama della teoria estetica novecentesca, risulta l’analisi dell’estetica della ricezione, conosciuta anche come “Scuola di Costanza”. Ci troviamo all’interno di un
orientamento di pensiero in cui è riesaminato il rapporto lettore opera d’arte:
quest’ultima non contiene un messaggio eterno e immutabile, non è un ricettore passivo, ma è parte di un processo attivo, implicito è il collegamento con il
pensiero del filosofo precedentemente citato, Merleau-Ponty, del chiasma tra
passività e creatività dell’atto percettivo.
La considerazione nella esperienza estetica del lettore come la terza dimensione, accanto all’autore e al critico, alla quale riferirsi nella definizione dell’opera, trova nell’estetica della ricezione la struttura portante, in quanto in essa l’opera va studiata come qualcosa che non è concluso ma si proietta in una
continuità dialettica verso il pubblico.
La prima parte del libro si conclude con una ricostruzione del tema della comunicazione con le tendenze filosofiche del Novecento, da Heidegger ad Adorno fino a Croce: «con un atteggiamento che complessivamente appare inspirato ad un gusto estetico di carattere “aristocratico”, lontano e distante dalla prassi comunicativa ritenuta banale e di basso profilo» (Ivi, p. 120). Costante termine di paragone, fucina dalla quale attingere rilevanti riflessioni è l’approccio adorniano al rapporto comunicativo, quella oscillazione caratteristica nella quale rinvenire gli aspetti intrecciati nella logica della costellazione. Pellegrino si appoggia felicemente alle istanze adorniane per sostenere le sue argomentazioni.
Nella seconda parte del volume si dà conto di una serie di svolte (quella linguistica, quella ermeneutica e quella comunicativa), che hanno contrassegnato le vicende teorico-comunicative del ’900.
RECENSIONI
verità tende a dislocare dalla filosofia e a rifugiarsi nell’arte, diventando suo affare (“la musica spiattella i segreti dell’arte”, sostiene Adorno, mentre per Heidegger “l’essenza dell’arte è la Poesia”)» (p. 25).
Questione cruciale per Heidegger: la verità che l’arte mette in opera è tutt’uno con la non-verità, in un processo di infinita metamorfosi che si dibatte tra
“illuminazione e nascondimento dell’ente”.
«Preso nel dinamismo di questa continua oscillazione, la verità di cui qui si
tratta non è fondata sull’eternamente identico a sé, ossia sulla necessità, ma è
in rapporto –come per Kant– con le due intuizioni pure dell’estetica (spazio e
tempo) e con la dimensione –costitutiva in Hegel– in cui cielo e terra s’incontrano, con la storia» (p. 37).
Spostando l’asse e aprendo la strada all’estetica che deve risolversi nell’ermeneutica, Pellegrino, rilancia la riflessione gadameriana in cui è raccolta l’eredità heideggeriana trasfigurata in chiave ermeneutica. La problematica relativa
alla connessione tra verità e interpretazione è contestualizzata dall’Autore all’interno di una ricostruzione storiografica in cui da un lato sono collocati gli analitici e dall’altro i continentali. Ma andiamo per ordine e apriamo direttamente il testo: «il tratto comune che unifica l’orizzonte di ricerca degli studiosi di orientamento ermeneutico (prevalentemente continentali) si incentra nel problema dell’interpretazione, o meglio, nella connessione tra verità e interpretazione» (p. 42).
L’attenzione filosofica dell’Autore è rivolta inoltre anche verso altre questioni che emergono prepotentemente nel Novecento, ricordiamo ad esempio la
pluralità dei linguaggi dell’arte, che scandisce la varietà e molteplicità delle
esperienze, delle poetiche e degli stili delle avanguardie artistiche del modo in
cui il Novecento si è autorappresentato […] in un percorso che è possibile riassumere come un itinerario che si snoda dalla crisi della rappresentazione […]
al trionfo delle immagini […]. Dopo alcuni secoli di dominio incontrastato del logos, del discorso e della parola, assistiamo all’apoteosi dell’immagine. Un’apoteosi che contribuisce a sua volta a edificare un universo magico-mitico, che
sancisce il trionfo del virtuale» (pp. 45-46).
Con acume critico, Pellegrino, immergendosi nell’universo mitico sintetizza
l’ampia letteratura che affonda le sue radici nell’età moderna, quando esplode
la questione del mito.
L’abolizione e il trionfo dell’immagine risultano essere il risultato dell’entrata in crisi del paradigma conoscitivo centrato sul realismo che trascina con sé
il modello figurativo ed artistico in genere della rappresentazione.
All’uopo, Pellegrino delinea il percorso attraverso il quale è tramontato nella coscienza europea un modo di concepire la conoscenza fondato sul rapporto tra un soggetto conoscente e un oggetto esterno ed estraneo al soggetto conoscente. Approdando al trionfo dell’interpretazione, già decretato da Nietzsche, prima ancora che da Heidegger e da Gadamer.
«Se i metodi di raffigurazione del passato sono volti unicamente al visibile,
invece l’arte, che secondo Klee “non ripete le cose visibili, ma rende visibile”,
deve riprendere tutte le forme elementari della visione, per giustificare il processo del loro formarsi. […] Le opere non sono oggetti che devono venire “giustificati” dal pensiero, ma veri e propri atti di pensiero» (pp. 54-55).
143
144
Daniela De Leo
G. P. CAPRETTINI, Tutta colpa della tivù, Donzelli, Roma 2004, pp. 133.
La televisione –si dirà per cominciare con un bisticcio– non gode certo di
buona stampa. Oggi più che mai: se è vero infatti che anche in passato il medium di massa per eccellenza ha attirato i sospetti e gli strali acutissimi degli
apocalittici, almeno nei primissimi tempi della sua diffusione (ci si riferisce soprattutto alla storia nazionale) non fu necessario militare nelle file degli integrati per nutrire la propria riflessione sul “nuovo” mezzo di un certo fiducioso ottimismo. Sentimento che si innestava, allora, su di una ragionevole (se non proprio
razionale) considerazione delle potenzialità ancora non dispiegate dalla comunicazione televisiva, lo “specifico” (la controversa categoria di ascendenza cinematografica poteva essere ancora chiamata in causa) della quale sembrava in
effetti autorizzare speranze e aspettative più che legittime, da più parti.
Da ormai molto tempo si può registrare un abbastanza generalizzato disincanto nei confronti della televisione; è ben possibile –e si rimanda per questo
ad una qualsiasi buona storia del mezzo– ripercorrere le tappe di questa progressiva perdita di innocenza nei suoi riguardi, passando in rassegna le molte
e cospicue trasformazioni (di ordine ovviamente non soltanto tecnologico e
produttivo) che hanno condotto alla situazione presente. Oggi, al cospetto di
una (ormai post-) neotelevisione generalista che sembra effettivamente aver
toccato il punto più basso della sua curva discendente, appare davvero difficile dar corso non si dirà a qualche forma di fondato ottimismo, ma anche soltanto ad un pensiero che si proponga di non essere rinunciatario verso un medium che comunque la si pensi resta fondamentale all’interno delle società occidentali contemporanee.
Tra i motivi di interesse del volume di Caprettini è proprio l’aleggiare, in esso, di un cauto spirito costruttivo, il quale corrobora una riflessione che non rinuncia ad essere critica nel senso integrale del termine: vale a dire anche propositiva. Tale intelligente volontà di non assistere passivamente allo sfascio
non significa, ovviamente, indossare il paraocchi e negarsi alla comprensione
di quanto di squallido e degradante –etica ed estetica in televisione sono notoriamente tutt’uno– imperversa ogni giorno sugli schermi nazionali (si comprendono nell’aggettivo, nella fattispecie, anche quelli locali). Un andamento
conversativo e un tono ironico supportano il dispiegarsi di un approccio ai diversi modi del discorso televisivo contemporaneo che l’autore, semiologo, ha
avuto modo di approfondire analiticamente in precedenti ed importanti lavori
sull’argomento. Non sfuggono all’analisi, perciò, la volgarità della televendita,
tutta incentrata sull’eccesso e sulla fisicità, sull’ostentazione dell’organico-corporeo; o il cinismo agonistico del talk show, il genere che forse meglio di tutti
si pone come paradigma dell’imperante intrattenimento di flusso; o infine la banalità seriale della fiction, i suoi orizzonti meschini e fasulli. Connettivo: una dimensione “carnascialesca” che si incarica di legare e di uniformare entro un
unico registro allegramente alienante i materiali più eterogenei. Ma quella stessa perizia critico-analitica che permette a Caprettini di enucleare alcuni tra i più
significativi capisaldi della odierna fenomenologia della comunicazione televisiva, gli consente poi anche di intercettare i pur rari momenti in cui il mezzo si
riscatta, e manifesta una inopinata capacità di giocare un ruolo ancora positivo entro le società complesse. La televisione ha insomma qualche residua virtù, accanto ai suoi moltissimi vizî. Si vedano ad esempio le pagine, acute e
molto stimolanti, che l’autore dedica all’apparizione –nel luogo stesso della
chiacchiera fine a se stessa– di un maestro del paradosso dissestante come
Carmelo Bene. Ma al di là di queste impennate, che non a caso si devono alle occasionali performances di singole personalità d’eccezione, la parte construens della riflessione di Caprettini sembra maggiormente interessata a prospettive meno dirompenti ed oltranzistiche, non estemporanee, improntate ad
un sobrio senso della realtà: in cui il medium punti –orizzonte probabilmente
ad esso più congruo: lo notava di recente Peppino Ortoleva– non tanto a guadagnare gli alti gradi della pura esteticità quanto piuttosto ad una (certo prosaica, sicuramente non “geniale”: ma almeno decorosa) qualità.
Avere fiducia nelle perduranti possibilità di produrre una televisione di qualità, e di poterne quindi fruire, è in effetti attitudine praticabile soltanto se si ri-
RECENSIONI
Il problema del linguaggio, che costituisce uno dei caratteri più peculiari della filosofia contemporanea rappresenta per Pellegrino un osservatorio privilegiato da cui rilevare gli atteggiamenti comuni a molte correnti filosofiche tra il
XIX e XX secolo.
Nella rassegna proposta i pensatori sono presentati in una concatenazione
dialettica e tale convergenza avviene nel segno di grandi problemi della filosofia: «al di là della flessibilità e della congruenza degli stili di analisi adottate dalle varie scuole, c’è da registrare una larghissima convergenza sull’idea di
un’assoluta centralità del fatto linguistico, visto sia come l’unico autentico reperto –insieme con tutti gli altri comportamenti segnici– disponibile per studiare l’uomo e i suoi fenomeni, sia come il potenziale nucleo di tutte le strutture
razionali dell’agire umano» (p. 154).
Gli ultimi tre capitoli della II parte sono dedicati a: 1. Heidegger e la differenza nei confronti della comunicazione, 2. Gadamer, la svolta ermeneutica e la
competenza comunicativa, 3. Apel e Habermas: la svolta comunicativa. Con una
lineare e chiara sintesi espositiva, Pellegrino, ripropone il problema della fondazione dell’ermeneutica filosofica partendo da Schleiermacher. Ciò segna l’inizio
di una intensa riflessione sulla filosofia stessa e il suo stesso interrogare.
Lungo il percorso aperto da Schleiermacher si tracciano le linee che da Dilthey vanno verso Heidegger fino a Gadamer e si offre un complesso e articolato reticolato di approcci in cui esaminare una sorta di modello dei problemi
che si pongono nel compito ermeneutico.
Proprio a questo punto, sul piano della domanda sul compito ermeneutico,
ritroviamo i termini che marcano i limiti del processo di recupero e ripetizione
indicati da Pellegrino: ermeneutica, fenomenologia ed esistenzialismo in Ricoeur e Pareyson, il pragmatismo di Rorty e il decostruzionismo di Derridà, la
svolta comunicativa in Apel e Habermas.
145
146
li messaggî partecipano: non è necessario essere mcluhaniani per crederlo):
ai fini di una ricezione degli stessi che possa contare sulla preventiva demistificazione di ogni loro portata mitologica, e fare sicuro affidamento sulla capacità –prima di tutto tecnica, appunto– da parte del cittadino-utente di disinnescare in essi ogni aura posticcia, di disvelare ogni riposta carica magica. Che
poi tali pratiche profilattiche si riducano a mero igienismo o divengano anche
habitus ludico-edonistico o che, infine, giungano a manifestare addirittura interessanti risvolti “creativi” ed espressivi, ciò non si rimette certo a questioni attinenti alla qualità televisiva, alla caratura del messaggio-stimolo.
Appare evidentemente chiaro, disponendosi nell’àlveo di simili considerazioni, come il problema della qualità televisiva mostri un suo spessore schiettamente politico; la comunicazione televisiva, nella lettura che ne offre l’autore, non si incentra affatto su di un medium maledetto, costitutivamente (e dunque irrimediabilmente) segnato da un qualche stigma originario che ne faccia,
in modo fatale, un produttore-vettore di volgarità, ignoranza, ideologia, alienazione e quant’altro di pernicioso impesti oggi il corpo sociale. Tale mezzo può
e deve essere prima di tutto riguadagnato, sempre nell’ottica di Caprettini, ad
una sua virtuosa neutralità “tecnica”, che ne riattivi le sempre attuabili –e malgrado tutto ingentissime– potenzialità progressive. Queste ultime si mantengono peraltro tutte imperniate sullo specifico “debole” dell’immagine (sonora)-inmovimento, cui nel presente si aggiungono, semplicemente, le inedite prospettive aperte dalle innovazioni tecnologiche (non si pensa tanto, qui, all’alta definizione o alla trasmissione satellitare, ad esempio; e neppure alle pur notevolissime possibilità di integrazione con i nuovi media interattivi; quanto piuttosto
alle vertiginosamente incrementate possibilità offerte dalla diffusione delle tecnologie “a basso costo”: con il conseguente, attivo, coinvolgimento del soggetto-moltitudine –nel senso di Paolo Virno– in nuove forme di protagonismo “territoriale”: lo vede ancora assai bene Caprettini, soffermandosi tra l’altro sulla
nascente esperienza delle cosiddette televisioni di strada).
I “discreti” e puntuali riferimenti bibliografici presenti nel testo accompagnano il lettore durante la lettura, e indirizzano quello più interessato verso fecondi approfondimenti; tali riferimenti, aprendo la discussione anche a problematiche di carattere più generale (non escluse quelle più squisitamente teoriche),
aggiungono valore ad un lavoro che non si può che segnalare per la piacevole e costruttiva lettura che esso offre: consentendo di sfuggire all’aut aut tra demonizzazione ed apologia del mezzo televisivo, i saggî raccolti nel volume di
Caprettini sollecitano la riflessione circa la ormai inderogabile necessità di un
cambiamento strutturale nelle politiche culturali (e dunque nella politica tout
court) nelle società occidentali, segnatamente nello sfortunato paese in cui la
televisione –anche in ciò erede sinistra della cinematografia– è ormai da tempo divenuta “l’arma più forte”.
Marco Gaetani
RECENSIONI
nuncia alla pietra di paragone costituita dalla “grande arte”, e si dislochi altrove non tanto l’imprendibile “specifico” quanto la funzione sociale del medium.
Questo gesto –non privo di coraggio, se molti intellettuali esitano ancora a
compierlo– è, se si considera attentamente il nostro discorso, il necessario presupposto del cauto ottimismo cui si accennava più sopra. Il momento propriamente costruttivo della proposta di Caprettini risiede allora, più che nella valorizzazione di esperienze-limite simili a quella pur significativa costituita dagli interventi alla maniera di Bene, nell’indicare positivi esempî di riferimento in alcune ben precise esperienze della “regolare” produzione e programmazione
televisiva; è insomma anche negli attuali palinsesti, tra gli sparuti format miracolosamente immuni dalla carnevalizzazione circostante, che è possibile rintracciare il germe, se non altro, di una futura possibile rinascita televisiva: in
certi programmi per l’infanzia o in alcuni “educationals”, per esempio; o ancora in certe altre produzioni, testimonianza sovente “decentrata”, “periferica”, di
un modo intelligentemente innovativo di intendere la programmazione “culturale”, o quella “di servizio”, o lo stesso intrattenimento puro. Altrettante dimostrazioni che la televisione può ancora essere luogo di sperimentazione e di ricerca, utile strumento per la crescita individuale e l’arricchimento sociale, oltre che
seria agenzia di supporto alla civile convivenza.
Caprettini –ponendo la propria argomentazione sotto le insegne di un intelligente understatement– scorge inoltre nella formazione il momento ineludibile
nella prospettiva di una auspicabilmente prossima renovatio televisiva. Una tale ri-fondazione, che si proponga come arduo obiettivo quello di riguadagnare
al mezzo le più ragionevoli aspettative nate con esso, implica –avverte l’autore– che la formazione ora in causa debba riguardare non soltanto i futuri “addetti ai lavori” – vale a dire coloro i quali costruiscono prevalentemente nelle
facoltà universitarie quelle competenze su cui incardinare le proprie future professioni; quanto –forse soprattutto– contemplare quella organica e capillare
educazione alla fruizione dell’audiovisivo di cui l’autore deve tuttavia constatare, con ironico stupore, la pressocché totale inesistenza nel sistema formativo
del nostro paese. Se infatti –ad esempio– palmare è la mancanza, all’interno
dei palinsesti dell’emittenza pubblica e privata, di contributi sostanziali a quell’opera di alfabetizzazione informatica e linguistica di cui pure gli attuali governanti menano gran propaganda; ancora più significativo appare che sulla opportunità di una efficace educazione alla comunicazione televisiva neppure si
solleciti la discussione, a livello di opinione pubblica. Alfabetizzazione audiovisiva che non può che passare –Caprettini lo sottolinea assai bene– attraverso
la pratica stessa del mezzo televisivo, cioè tramite un apprendistato dei rudimenti del “fare televisione” che dovrebbe pertanto non essere limitato a taluni
pur benemeriti progetti-pilota finalizzati all’apprendimento superiore e/o alla
formazione professionale. L’autore sembra insomma voler riportare in onore
–pur alla luce delle esperienze successive, che suggeriscono maggiore prudenza e meno facili entusiasmi– le posizioni di quanti sostennero, agli albori
europei dell’analisi massmediologica, l’opportunità di educare i fruitori medesimi alle diverse tecniche di “smontaggio” dei messaggî audiovisivi (e degli stessi media che, non semplicemente “veicolandoli”, sempre in qualche modo di ta-
147
testi e temi del pensiero francese del ’900.
Seminari di Reynaud Barbaras e Frédéric Worms
148
Nelle giornate 9-10 giugno, nell’ambito del PRIN di cui al titolo, coordinato
da Giovanni Invitto, si sono svolti, presso l’Università di Lecce, i seminari su
“Fenomenologia e pensiero contemporaneo” tenuti da Renaud Barbaras (Paris I) e Fréderic Worms (Lille). La particolare curvatura che il dialogo sulla fenomenologia francese contemporanea ha assunto si è fatto subito sentire nei
passi nodali del primo dei due interventi di Barbaras “Il problema dell’apparire
in Jan Patoãka. Fenomenologia dinamica e dinamica fenomenologia”. Riprendendo e seguendo la filosofia di Patoãka di Phénoménologie et ontologie du
mouvement, Barbaras disserta sull’idea di soggetto che non può essere costitutivo del mondo, ma deve porsi esso stesso tra ciò che appare. È l’idea del
soggetto che co-condiziona l’apparizione o co-partecipa all’apparire, piuttosto
che del soggetto costituente. Il nucleo di analisi profilato è quello di una teoria
cinetica della soggettività che dà vita ad una fenomenologia dinamica. Ed essa stessa presuppone una dinamica fenomenologica, che sarà la versione patoãkiana di cosmologia. Si inverte, in questa visione filosofica, la posizione del
soggetto come era stato delineato nelle teorie precedenti, in cui per giustificare la differenza tra corpi entrava in gioco la koiné.
L’inversione di marcia della filosofia di Patoãka, che Barbaras sottolinea, è
nel ricercare la determinazione come determinazione esistenziale del corpo,
per analizzare, non biologicamente come è formato il mio corpo o gli altri corpi, ma quale è il suo modo di esistere, cioè la condizione per la quale il mio corpo si dà agli altri corpi. Per dispiegare tutto il potenziale teorico di queste tematiche, Barbaras ripropone il dialogo tra Patoãka, Heidegger e Merleau-Ponty. Patoãka entra in colloquio con Heidegger, del quale condivide la determinazione dell’essere come Dasein, e tuttavia gli rimprovera di aver inteso questo
Dasein in maniera troppo formale, senza includere in esso la corporeità, come
fatto fondamentale, come movimento. Patoãka ripensa la filosofia merelaupontyana per contestare ad Heidegger questo formalismo. Dall’altro, riprende
Heidegger per contestare l’approccio di Merleau-Ponty, richiamando quest’ultimo alla necessità di pensare il corpo in maniera esistenziale. Come l’apparire è letto da Patoãka secondo la teoria cinetica, anche la percezione è definita in termini di movimento. Partendo dalla duplicità del soggetto il quale appartiene al mondo, ma al tempo stesso ne è condizione, occorre, per Patoãka, rinvenire che cosa nel soggetto sia comune rispetto agli enti di cui è condizione,
che cosa, invece, lo differenzi. La soluzione sarebbe il ripensare il movimento
come force, e la natura del movimento sarebbe in questa forza.
Rotti gli argini categoriali codificati, Barbaras, identifica la fonte remota di
Patocka in Aristotele, in quanto al di là della differenza tra i quattro modi del
movimento, ciò che permane è la lettura del movimento in termini di privazione e di acquisizione. Cioè il movimento è un accrescimento dell’essere, non
spiega solamente lo spostamento locale, ma è categoria ontologica che riguarda l’essere stesso delle cose. Il movimento non è soltanto la causa delle diverse qualità, quantità o determinazioni che vengono acquisite dal sostrato nel
movimento, ma è ciò che le unisce. In questo senso il movimento è ontogenetico perché non spiega tanto lo spostamento locale, secondo la deduzione che
aveva fatto la filosofia moderna, ma spiega la genesi dell’entità della cosa.
Inoltre, Barbaras sottolinea che la determinazione avviene tutta ed interamente al livello delle cose stesse le quali sono determinate attraverso il movimento, lo svelamento della soggettività si aggiunge, in qualche modo, a quella determinazione già acquisita dalla cosa. Il disvelamento non può essere fenomenalizzante, se non a partire da un movimento più profondo che è quello
dell’essere stesso questa è la ragione per cui lo svelamento va sempre ad aggiungersi ad una acquisizione delle determinazioni, non è il soggetto che compie l’unità. La force est voyante nella misura in cui l’essere stesso è costituito
dal movimento stesso. Solo a partire da questo movimento costituente è possibile il manifestarsi degli enti, di ciò che appare. Questo sfondo teorico conduce Barbaras a soffermarsi su alcune fratture createsi tra le scuole fenomenologiche della Francia e della Germania. Un’interpretazione di queste fratture è
rinvenibile nell’impostazione ontico-ontologica Husserl-Heidegger, la quale affonda le proprie radici nell’ontologia e punta a vedere la differenza tra l’essere
degli enti e l’essere, e un’altra che le affonda nella henologie neo-platonica in
cui la questione è quella della differenza ontico-cosmologica, cioè degli enti e
della loro unità. Queste elaborazioni tematiche schiudono, nel secondo intervento di Barbaras, la riflessione sulla dimensione del pensiero sartriano tra
phenomenologie e impossibilité de la phenomenologie.
In questo contesto si inserisce l’intervento di Frédéric Worms articolato in
due parti: una prima riflessione sulla via che porta dalla definizione minimale
del vitale a quella estensiva, la seconda riguarda invece la via che dall’estensivo porta al minimale. Il punto di partenza è che la nozione del vitale si costituisce in un paradosso. Da un lato, secondo un’accezione minimale, esso coincide con le condizioni minime che garantiscono il proseguimento della vita; dall’altro, invece, questa volta secondo un’accezione estensiva, vitale coincide
con il vivere bene reso possibile da valori che trascendono il mero piano del
proseguimento della vita. In realtà, secondo Worms, questo paradosso è insuperabile, poiché non si dà né un minimo senza i valori che caratterizzano
l’estensivo, né un livello estensivo senza le condizioni comprese nella definizione minimale del vitale. Se c’è un leit-motiv che ricompare, carsicamente,
quanto significativamente, è la nozione minimale del vitale: il vitale è la condizione della continuazione della storia di uno o più viventi nella loro relazione al
contesto e fra loro. Si deve subito osservare che, secondo la definizione minimale, il vitale coincide non già con ignote cause interne o immanenti, ma con
le condizioni esteriori del proseguimento della vita. In secondo luogo, si deve
rilevare che il circolo vizioso, che consisterebbe nella definizione del vitale fa-
RECENSIONI
FENOMENOLOGIA, NARRAZIONE, RIFLESSIONE
ETICO-POLITICA:
149
150
cendo riferimento alla nozione di vivente, è solo apparente. Infatti, è assolutamente impossibile parlare di vitale senza chiamare in causa le occorrenze reali e storiche del vitale, e cioè i viventi concreti. In effetti, come sottolinea
Worms, il vitale, nella forma del vivente, si dà sempre come singolarità legata
ad una temporalità individuale. Worms richiama poi l’élan vital tematizzato da
Bergson, analisi approfondita con il riferimento a Georges Canguilhem di Le vivant et la vie, secondo il quale pensare il vivente significa sempre pensare la
sua relazione con un contesto e con altri viventi, al punto che, tali relazioni costituiscono un carattere primitivo e originario dello stesso vivente.
La relazione tra viventi, come richiamato da Worms, si declina o come attaccamento, cioè come individuazione amorosa, o come aggressione. Nella
seconda parte della relazione, Worms ha sottolineato i due rischi insiti nella
dualità minimale-estensivo. Se si riduce il vitale alla sua definizione minimale
si finisce per teorizzare, infatti, una bioetica minimalista, in cui la posta in gioco è semplicemente la conservazione delle condizioni biologiche dell’esistenza stessa. D’altra parte, però, la tendenza a identificare il vitale con il solo livello descritto dalla definizione estensiva porta a ipostatizzare il vitale, a considerare la vita come valore trascendente a dispetto delle condizioni materiali
che la governano. Worms nota come, in realtà, la distinzione tra minimo e
estensivo non debba essere rigida, poiché molti dei valori che vengono riferiti
all’estensivo devono essere riportati al livello descritto dal minimale. L’ultima
parte della relazione di Worms tende a mostrare in che senso la questione “Cos’è il vitale” sia essa stessa vitale per mettere a tema il momento attuale della
filosofia. Lo scenario delineato da un excursus storico in cui Worms ha richiamato alcune figure “del vitale” nella filosofia francese del XX secolo –Bergson,
Canguilhem, Deleuze e Derrida–, ha costituito il quadro speculativo, del colloquio conclusivo, sulla filosofia francese contemporanea.
Daniela De Leo
PUBBLICAZIONI RICEVUTE DA “SEGNI E COMPRENSIONE”
Volumi:
M. ALCARO, Filosofie della natura. naturalsimo mediterraneo e pensiero moderno, Manifestolibri, Roma 2006, pp. 224;
P. ANTES, L’Islam. Una guida, a c. di L. Lestingi, Palomar, Bari 2006, pp. 174;
C. A. AUGIERI, a cura di, Le Identità giovanili nelle letterature del Novecento, Manni, San
Cesario di Lecce 2005, pp. 430;
S. BORUTTI, Filosofia dei sensi. Estetica del pensiero, tra filosofia, arte e letteratura, Cortina, Milano 2006, pp. XLVIII, 176;
R. CALCATERRA, a cura di, Semiotica e fenomenologia del sé, Aragno, Torino 2005, pp.
XXIV, 222;
C. CAPUTO, S. PETRILLI, A. PONZIO, Tesi per il futuro anteriore della semiotica, Mimesis,
Milano 2006, pp. 136.
M. CAPPUCCIO, Alan Turing: l’uomo, la macchina, l’enigma. Per una genealogia dell’incomputabile, pref. di C. Sini, Albo Versorio, Milano 2005, pp. 342;
H. CONRAD-MARTIUS, Dialoghi metafisici, ed. it. a c. di A. Caputo, pref. di A. Ales Bello,
Besa, Nardò s. d. (ma 2006), pp. 222;
P. CRAVERI, G. QUAGLIARIELLO, a cura di, La seconda guerra mondiale e la sua memoria,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 620;
A. MACRÌ TRONCI, La prospettiva neoumanistica della comunicazione, Pensa, Lecce
2005, pp. 224;
G. NICOLOSI, a cura di, I partiti politici nell’Italia repubblicana, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 460;
L. PEREGO, E. S. STORACE, R. VISONE, a cura di, Carlo Michelstaedter. Un’introduzione,
pref. di A. Vigorelli, Albo Versorio, Milano 2005, pp. 218;
A. PONZIO, La comunicazione, II ed., B. A. Graphis, Bari 2006, pp. 202;
A. PONZIO, P. CALEFATO, S. PETRILLI, a cura di, Con Roland Barthes alle sorgenti del pensiero, Meltemi, Roma 2006, pp. 696;
P. B. RAABE, Teoria e pratica della consulenza filosofica, Apogeo, Milano 2006, pp. XL,
330;
P. SALANDINI e R. LOLLI, a cura di, Filosofie nel tempo, op. dir. da G. Penzo, v. III, tt. I e
II, Spazio Tre, Roma 2006, pp. 2410;
M. SALVIOLI, Il tempo e le parole. Ricoeur e Derrida “a margine” della fenomenologia,
Edizioni studio domenicano, Bologna 2006, pp. 318;
M. SANTI, a cura di, Philosophy for children: un curriculo per imparare a pensare, Liguori, Napoli 2005, pp. 414;
M. SANTI, Ragionare con il discorso, n. e., Liguori, Napoli 2006, pp. 222;
G. SCOLARI, Il pensiero dell’essere e la luce, Montedit, Melegnano 2006, pp. 144;
M. SIGNORE, Lo sguardo della responsabilità. Politica, economia e tecnica per un antropocentrismo relazionale, Studium, Roma 2006, pp. 250;
M. TONDO, Di fronte al progetto di vita. Un percorso formativo con i giovani, pref. di A.
Cencini, Edb, Bologna 2005, pp. 166;
L. TUNDO FERENTE, a cura di, Etica della vita: le nuove frontiere, Bari, Dedalo 2006, pp.
300;
T. TUPPINI, Kant. Sensazioni, realtà, intensità, Mimesis, Milano 2005, pp. 266.
151
Periodici:
152
Acta Philosophica, f. I, v. 15, 2006 Acta Philosophica, f. II, v. 14, 2005; Istituti Editoriali
e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma;
Aesthetica Preprint. Supplementa, n. 16, febbraio 2006: S. TEDESCO, Il metodo e la storia; n. 17, maggio 2006: E. CRESCIMANNO, Implexe, fare, vedere. L’estetica nei Cahiers
di P. Valéry, C.I.S.d.E., Palermo;
Antologia Vieusseux, n. s., a. XI, n. 31, gennaio-aprile 2005; Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, Firenze;
Dianoia. Rivista di storia della filosofia, n. 10, a. X, novembre 2005; Cleub, Bologna;
Estudios Franciscanos, v. 107, n. 440, enero-agosto 2006; Provincias Capuchinas Ibéricas, Barcelona;
Fieri, n. 3, 2005: P. PALUMBO, a cura di, Il giovane Heidegger tra neokantismo, fenomenologia e storicismo; Annali del Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi, Palermo;
Foedus, n. 13, 2005; Associazione Artigiani e Piccole Imprese, Mestre
Giornale di Metafisica, a. XXVII, 2005, nn. 2 e 3; Tilgher, genova;
Itinerari, n. 3, 2005; Ed. Itinerari, Lanciano;
L’immaginazione, n. 218, n. 219, n. 220, n. 221; Manni, San Cesario di Lecce;
Máthesis. Revista de Educação, vol. 6, n. 1, jan.-jun. 2005; Facultade de Filosofia,
Ciências e Letras de Jandaia do Sul-Fafijan (Brasil);
Notes et documents, a. XXX, n. s., n. 3, octobre-décembre 2005; Inst. Int. Jacques Maritain, Roma;
Paideutika, n. s., n. 3, a. II, 2006; Tirrenia, Torino;
Rivista di Filosofia, n. 1, 2006; il Mulino, Bologna;
Rivista di Studi Utopici, n. 1, aprile 2006; Centro Interuniv. di Studi Utopici; Carra, Casarano;
Studia Patavina, n. 3, a. LII, settembre-dicembre 2005; Padova.