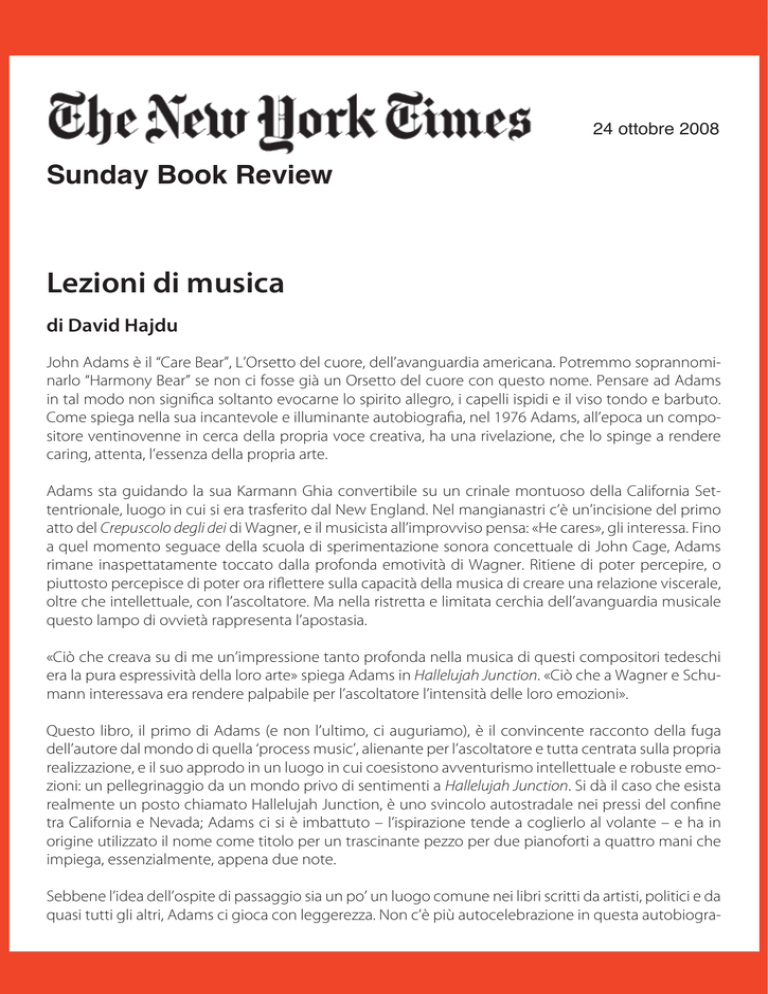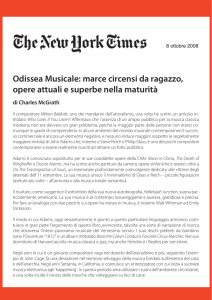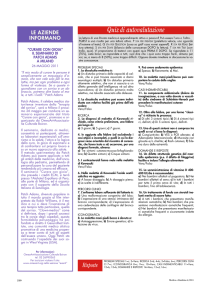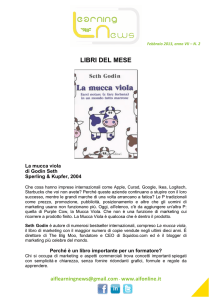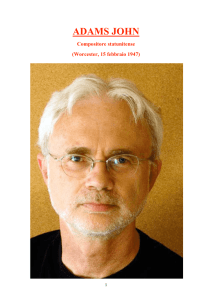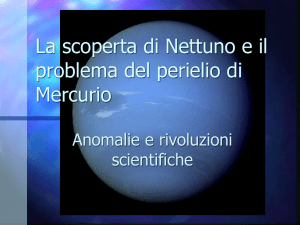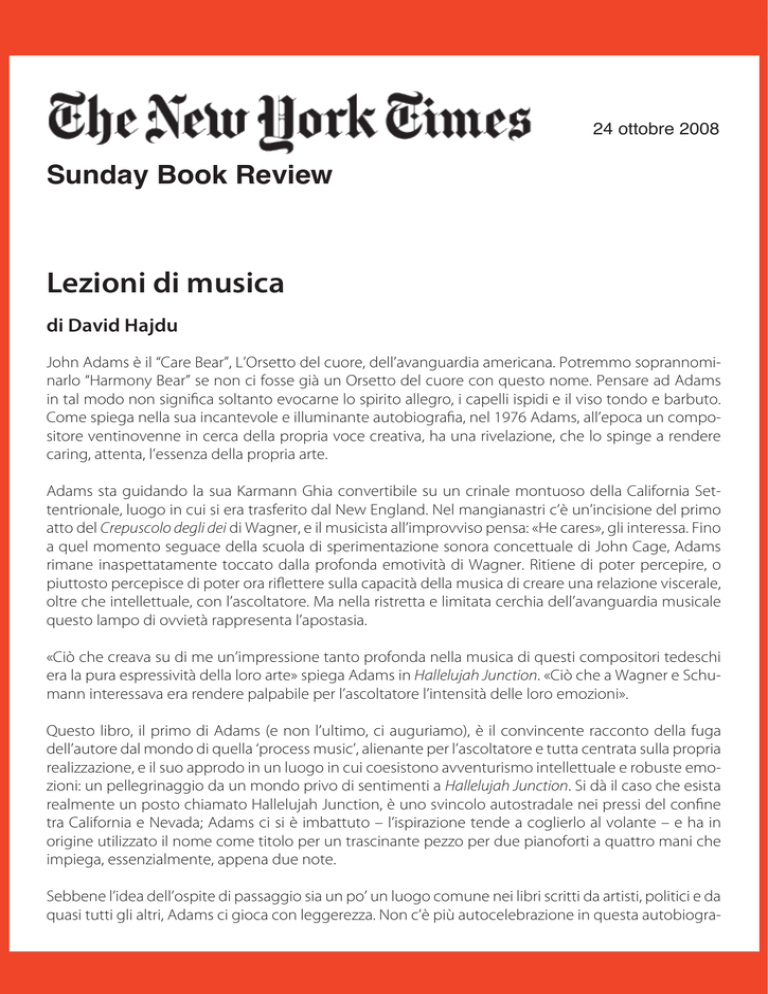
24 ottobre 2008
Sunday Book Review
Lezioni di musica
di David Hajdu
John Adams è il “Care Bear”, L’Orsetto del cuore, dell’avanguardia americana. Potremmo soprannominarlo “Harmony Bear” se non ci fosse già un Orsetto del cuore con questo nome. Pensare ad Adams
in tal modo non significa soltanto evocarne lo spirito allegro, i capelli ispidi e il viso tondo e barbuto.
Come spiega nella sua incantevole e illuminante autobiografia, nel 1976 Adams, all’epoca un compositore ventinovenne in cerca della propria voce creativa, ha una rivelazione, che lo spinge a rendere
caring, attenta, l’essenza della propria arte.
Adams sta guidando la sua Karmann Ghia convertibile su un crinale montuoso della California Settentrionale, luogo in cui si era trasferito dal New England. Nel mangianastri c’è un’incisione del primo
atto del Crepuscolo degli dei di Wagner, e il musicista all’improvviso pensa: «He cares», gli interessa. Fino
a quel momento seguace della scuola di sperimentazione sonora concettuale di John Cage, Adams
rimane inaspettatamente toccato dalla profonda emotività di Wagner. Ritiene di poter percepire, o
piuttosto percepisce di poter ora riflettere sulla capacità della musica di creare una relazione viscerale,
oltre che intellettuale, con l’ascoltatore. Ma nella ristretta e limitata cerchia dell’avanguardia musicale
questo lampo di ovvietà rappresenta l’apostasia.
«Ciò che creava su di me un’impressione tanto profonda nella musica di questi compositori tedeschi
era la pura espressività della loro arte» spiega Adams in Hallelujah Junction. «Ciò che a Wagner e Schumann interessava era rendere palpabile per l’ascoltatore l’intensità delle loro emozioni».
Questo libro, il primo di Adams (e non l’ultimo, ci auguriamo), è il convincente racconto della fuga
dell’autore dal mondo di quella ‘process music’, alienante per l’ascoltatore e tutta centrata sulla propria
realizzazione, e il suo approdo in un luogo in cui coesistono avventurismo intellettuale e robuste emozioni: un pellegrinaggio da un mondo privo di sentimenti a Hallelujah Junction. Si dà il caso che esista
realmente un posto chiamato Hallelujah Junction, è uno svincolo autostradale nei pressi del confine
tra California e Nevada; Adams ci si è imbattuto – l’ispirazione tende a coglierlo al volante – e ha in
origine utilizzato il nome come titolo per un trascinante pezzo per due pianoforti a quattro mani che
impiega, essenzialmente, appena due note.
Sebbene l’idea dell’ospite di passaggio sia un po’ un luogo comune nei libri scritti da artisti, politici e da
quasi tutti gli altri, Adams ci gioca con leggerezza. Non c’è più autocelebrazione in questa autobiogra-
fia ironica, intelligente e sincera di quanta ve ne sia nella musica della maturità di Adams, temeraria e
insieme elegiaca. E infatti Hallelujah Junction, insieme ai libri di Hector Berlioz e Louis Armostrong, trova
posto tra le autobiografie più godibili e acute scritte da musicisti di prima grandezza.
Adams sa scrivere in prosa, come ha dimostrato con articoli, note per i programmi di sala e conferenze,
alcune delle quali stanno alla base di certi capitoli o parti di questo libro. (La maggior parte del materiale pubblicato in precedenza è stato rimaneggiato, spesso con l’aggiunta di dettagli più vividi.) Nel
descrivere il Maggiolino Volkswagen che lo ha condotto da Cambridge alla California dopo la conclusione degli studi universitari a Harvard, Adams scrive: «Forse percependo che lo stavamo forzando a
compiere quest’ultimo viaggio soltanto per portarlo a morire in una terra sconosciuta, fece un rumore
simile a quello di un cucchiaio intrappolato in un tritarifiuti e si fermò scoppiettando».
E sa anche essere faceto. «Talvolta ho pensato» osserva Adams in un brano dedicato alla collaborazione tra diversi artisti, «che, dopo l’omicidio-suicido, si tratti della cosa più tremenda che due persone
decidono di fare insieme».
Come molte delle composizioni musicali di Adams, Hallelujah Junction è un insieme di elementi disparati, riflessioni demistificanti sul processo creativo, giudizi affilati sul proprio lavoro e quello dei colleghi,
dolci ricordi sull’infanzia da bambino prodigio nel New England, tirate contro ogni forma di vanagloria
e d’indifferenza (soprattutto quelle che passano per anticonformismo) e le tradizionali parti dedicate
alla propria opera, il tutto organizzato con un occhio all’equilibrio, al contrasto e all’effetto propulsivo.
Adams accosta e misura gli ingredienti con gran cura per creare un effetto di spontaneità.
Tra le parti più solide di questo libro ci sono le limpide critiche di Adams ad altri compositori, del passato e del presente, dentro e fuori l’avanguardia. Copland, scrive «amava il ruolo del compositore provocatorio, in particolare per la sua abilità a fondere l’asciuttezza e la spigolosità di Stravinsky con l’energia
popolare e i timbri rauchi del jazz anni Venti». Adams lacera abilmente Schoenberg, Stockhausen e
Babbitt per il severo meccanicismo e la freddezza che coglie nella musica dodecafonica e nel serialismo. Venera Ives per la sua famosa iconoclastia e per l’inventiva formale, pur ammettendo la propria
delusione perché le sinfonie di Ives non riescono a emozionarlo profondamente.
Adams è particolarmente appassionato e convincente nella difesa di compositori contemporanei
meno noti, come Glenn Branca, autore di una sinfonia per cento chitarre, e Robert Ashley che, lavorando in un regno di musica e parole, crea grandi pezzi vocali, definiti qui «meditativi, apparentemente
d’improvvisazione ma in realtà costruiti con cura», descrizione che si attaglia ad alcune delle composizioni di Adams stesso, soprattutto al suo concerto per orchestra e violino elettrico The Dharma at Big
Sur.
Più o meno allo stesso modo, Adams elogia Cornelius Cardew, fondatore della Scratch Orchestra, perché ritiene la musica di Cardew « sommamente antielitaria e antistorica» e «fresca, giocosa e umanistica». Nei giudizi sbigottiti sull’Occidente («il territorio […] indomito e misterioso»), e nelle evocazioni
di paesaggi aperti nella propria musica, Adams chiarisce, in Hallelujah Junction, la propria fascinazione
per il mondo naturale; e per un compositore, ammirarne altri la cui musica sembra molto simile alla
propria è solo naturale.
Considerato spesso un minimalista, Adams ne ha utilizzato l’estetica soprattutto come punto di partenza. Ha riconosciuto piuttosto presto che «il minimalismo come estetica dominante si sarebbe velocemente esaurito. Come il cubismo in pittura, si trattava di un’idea radicalmente nuova, ma la sua
visione del mondo riduttiva avrebbe presto lasciato coloro che lo praticavano intrappolati in un vicolo
cieco espressivo». L’importanza di Adams è fondata non tanto nel suo aver creato qualcosa di nuovo,
quanto piuttosto nell’aver fatto molto bene ciò che ha fatto: opere (Nixon in China e The Death of Klinghoffer, entrambe con la regia di Peter Sellars), sinfonie corali (On the Trasmigration of Souls, un’elegia
alle vittime degli attentati dell’11 settembre, vincitrice del Premio Pulitzer per la musica nel 2003), pezzi
per pianoforte e un’altra dozzina circa di importanti composizioni di vario genere. La sua musica è minimalista nel senso che Adams impiega il minor materiale necessario, ma non il minore possibile, pur
cercando di ottenere un effetto di massimalismo.
Con Hallelujah Junction, Adams ha messo in prosa un’argomentazione contro l’ideologia del continuum estetico, tesi che la sua musica ha sempre articolato esaurientemente con l’esempio. «Ritenevo
che quel particolare continuum fosse ridicolmente limitato, fondato com’era su una sorta di punto di
vista darwiniano dell’evoluzione stilistica» afferma. Se una composizione «non promuoveva in qualche
modo l’evoluzione del linguaggio, creando progresso grazie a un’innovazione tecnologica o accrescendo la complessità del discorso musicale, non valeva neppure la pena di discuterne».
A chi interessa? A John Adams. E perciò, adesso, interessa anche a noi.
David Hajdu è critico musicale per The New Republic e docente alla Columbia University Graduate
School of Journalism