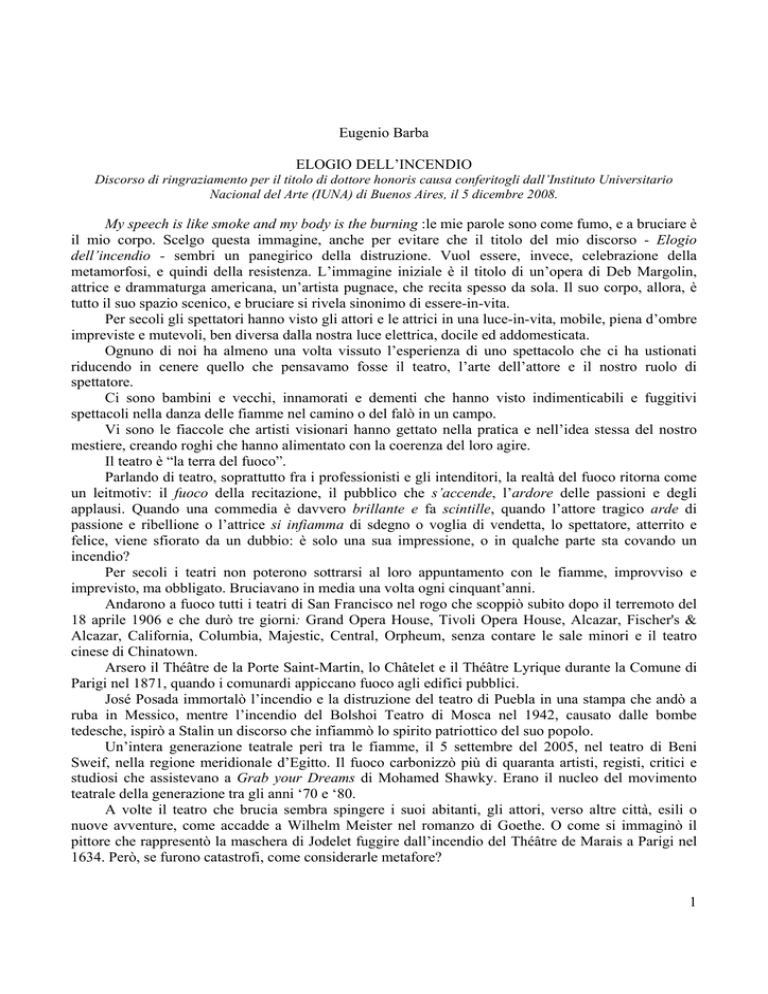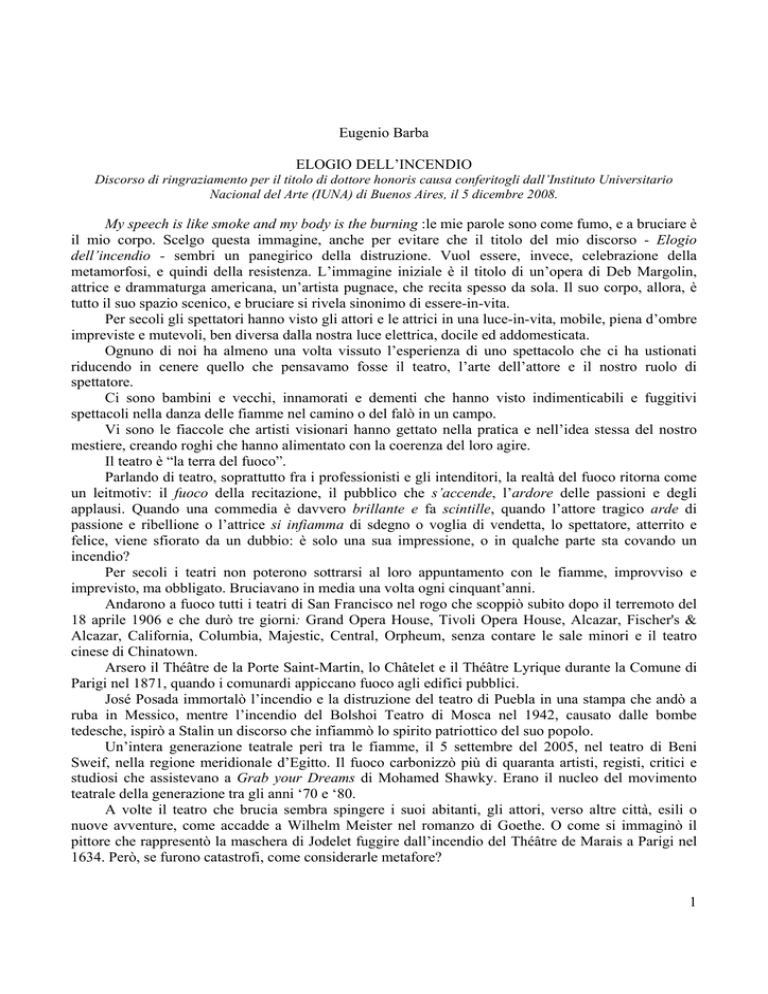
Eugenio Barba
ELOGIO DELL’INCENDIO
Discorso di ringraziamento per il titolo di dottore honoris causa conferitogli dall’Instituto Universitario
Nacional del Arte (IUNA) di Buenos Aires, il 5 dicembre 2008.
My speech is like smoke and my body is the burning :le mie parole sono come fumo, e a bruciare è
il mio corpo. Scelgo questa immagine, anche per evitare che il titolo del mio discorso - Elogio
dell’incendio - sembri un panegirico della distruzione. Vuol essere, invece, celebrazione della
metamorfosi, e quindi della resistenza. L’immagine iniziale è il titolo di un’opera di Deb Margolin,
attrice e drammaturga americana, un’artista pugnace, che recita spesso da sola. Il suo corpo, allora, è
tutto il suo spazio scenico, e bruciare si rivela sinonimo di essere-in-vita.
Per secoli gli spettatori hanno visto gli attori e le attrici in una luce-in-vita, mobile, piena d’ombre
impreviste e mutevoli, ben diversa dalla nostra luce elettrica, docile ed addomesticata.
Ognuno di noi ha almeno una volta vissuto l’esperienza di uno spettacolo che ci ha ustionati
riducendo in cenere quello che pensavamo fosse il teatro, l’arte dell’attore e il nostro ruolo di
spettatore.
Ci sono bambini e vecchi, innamorati e dementi che hanno visto indimenticabili e fuggitivi
spettacoli nella danza delle fiamme nel camino o del falò in un campo.
Vi sono le fiaccole che artisti visionari hanno gettato nella pratica e nell’idea stessa del nostro
mestiere, creando roghi che hanno alimentato con la coerenza del loro agire.
Il teatro è “la terra del fuoco”.
Parlando di teatro, soprattutto fra i professionisti e gli intenditori, la realtà del fuoco ritorna come
un leitmotiv: il fuoco della recitazione, il pubblico che s’accende, l’ardore delle passioni e degli
applausi. Quando una commedia è davvero brillante e fa scintille, quando l’attore tragico arde di
passione e ribellione o l’attrice si infiamma di sdegno o voglia di vendetta, lo spettatore, atterrito e
felice, viene sfiorato da un dubbio: è solo una sua impressione, o in qualche parte sta covando un
incendio?
Per secoli i teatri non poterono sottrarsi al loro appuntamento con le fiamme, improvviso e
imprevisto, ma obbligato. Bruciavano in media una volta ogni cinquant’anni.
Andarono a fuoco tutti i teatri di San Francisco nel rogo che scoppiò subito dopo il terremoto del
18 aprile 1906 e che durò tre giorni: Grand Opera House, Tivoli Opera House, Alcazar, Fischer's &
Alcazar, California, Columbia, Majestic, Central, Orpheum, senza contare le sale minori e il teatro
cinese di Chinatown.
Arsero il Théâtre de la Porte Saint-Martin, lo Châtelet e il Théâtre Lyrique durante la Comune di
Parigi nel 1871, quando i comunardi appiccano fuoco agli edifici pubblici.
José Posada immortalò l’incendio e la distruzione del teatro di Puebla in una stampa che andò a
ruba in Messico, mentre l’incendio del Bolshoi Teatro di Mosca nel 1942, causato dalle bombe
tedesche, ispirò a Stalin un discorso che infiammò lo spirito patriottico del suo popolo.
Un’intera generazione teatrale perì tra le fiamme, il 5 settembre del 2005, nel teatro di Beni
Sweif, nella regione meridionale d’Egitto. Il fuoco carbonizzò più di quaranta artisti, registi, critici e
studiosi che assistevano a Grab your Dreams di Mohamed Shawky. Erano il nucleo del movimento
teatrale della generazione tra gli anni ‘70 e ‘80.
A volte il teatro che brucia sembra spingere i suoi abitanti, gli attori, verso altre città, esili o
nuove avventure, come accadde a Wilhelm Meister nel romanzo di Goethe. O come si immaginò il
pittore che rappresentò la maschera di Jodelet fuggire dall’incendio del Théâtre de Marais a Parigi nel
1634. Però, se furono catastrofi, come considerarle metafore?
1
L’intero Padiglione Olandese dell’Esposizione Coloniale del 1931 andò in cenere, si salvò solo il
teatro. Era la sonnolenta estate del 1931 a Parigi, e i giornali seppero commuovere i loro lettori
descrivendo gli attori balinesi in fuga, stringendo al petto i loro dorati costumi. Molti parigini accorsero
a vedere gli spettacoli di questi bizzarri danzatori pronti a rischiare la vita per salvare i loro orpelli. Tra
loro, Antonin Artaud.
Chiudendo l’introduzione a Il teatro e il suo doppio, Artaud parla di fuoco. Sembra alludere al
martirio e si tratta invece di vita. Spiega quel che la cultura dovrebbe essere e non è. Il fumo delle sue
parole si sprigiona davvero da un corpo. Per questo conviene tradurre le sue parole alla lettera, come un
mantra contro lo spirito del suo secolo e di quello in cui viviamo:
Quando usiamo la parola vita dobbiamo renderci conto che non si tratta della vita riconosciuta
dalla superficie dei fatti, ma di questa sorta di fragile e mobile focolare al quale le forme non
appartengono. E se qualcosa è ancora infernale e maledetta, in questo tempo, è l’attardarsi
artisticamente su delle forme, invece d’essere come suppliziati che vengono arsi e fanno dei segni sui
loro roghi.
Artaud non parla esplicitamente di attori. Eppure quei segni, quel suppliziato e quel rogo sono
stati immediatamente intesi come un’immagine estrema ed ideale dell’attore. Julian Beck e Judith
Malina ne fecero la pietra angolare del loro Living Theatre, il teatro vivo.
Antonin Artaud fu forse il più povero, il più sofferente, certo il meno professionalmente
autorevole fra i protagonisti della Grande Riforma del teatro nella prima metà del secolo scorso. Dal
punto di vista del mestiere, ha ben poco da insegnare. Oggi lo annoveriamo fra i maestri, ma non fu mai
un maestro. Però fu l’allievo della propria anima divisa. Da essa imparò moltissimo. Legò
indissolubilmente il nocciolo dell’arte teatrale alle sofferenze dell’anima malata. Artaud non depose le
armi, continuò tutta la vita a soccombere rialzarsi e combattere. Fino alla notte in cui si sedette sul letto
e capì che l’ora era arrivata. Si levò una scarpa, e tenendosela in mano come un amuleto, iniziò l’ultimo
viaggio.
Artaud indicò a noi, popolo del teatro, non i segreti del mestiere, ma quel che attraverso il
mestiere dobbiamo soffrire e, forse, sperare: l’esilio. È appena un’infima parte della nostra professione.
Ma senza quell’infima parte, arte e mestiere sono solo un fuoco di paglia.
Sappiamo perché i teatri brucino e siano bruciati: per incuria, per la crudeltà del cielo, per
speculazione, per malavita, per fascismo, per vendetta e minaccia, per vecchiaia.
Nel teatro, in questa “terra del fuoco”, appaiono due diverse nature. L’una è catastrofe, l’altra
trasformazione. L’una distrugge, l’altra raffina, rafforza il ferro e separa l’oro dalla fanghiglia a cui è
incorporato. Di questo secondo fuoco faccio l’elogio. Da questo secondo fuoco la nostra professione
trae la vita e il suo valore. La sua danza.
Danziamo? Sì, danziamo. Oppure no, non danziamo: facciamo teatro. Ma chi saprebbe dire dove
sta la differenza, dove passa il confine?
Danziamo sempre, ma non sempre per adeguarci ad un genere estetico. Danziamo come su dei
carboni ardenti, perché questa danza è essenzialmente un rifiuto non distruttivo, una guerra non
violenta alla natura che ci assoggetta. E quindi, più o meno consapevolmente, un rifiuto della storia cui
apparteniamo. Come se avessimo le ali; come se pesantissime radici affondassero nella terra sotto i
nostri piedi; come se il nostro “io” fosse un altro. Come se davvero fossimo liberi. Ma umilmente,
perché questa danza ha l’umiltà d’un mestiere, poco più dell’esercizio del come se. E per gli spettatori è
innanzi tutto un passatempo.
Se qualcosa sembra non si possa associare all’elogio dell’incendio, è proprio l’idea di un
passatempo. Eppure…
2
La nostra arte non è fatta per essere arte. Non corre per raggiungere una forma definitiva. Corre
per sparire. È un’arte arcaica, non solo perché oggi è esclusa o si esclude dallo spettacolo principale del
nostro tempo, lo spettacolo dell’immagine riprodotta e riproducibile. Ma soprattutto perché sotto le
apparenze d’un passatempo può nascondere una ricerca spirituale, qualcosa che scuote, fortifica e a
volte modifica la nostra coscienza e ci immette in una condizione governata da altri valori.
Dobbiamo rimanere con i piedi ben piantati per terra e gli occhi fissi sulla cassetta degli incassi.
Ma non dobbiamo dimenticare che il teatro è finzione in transito verso un’altra realtà, verso il rifiuto
della realtà che crediamo di conoscere. Il teatro è finzione che può cambiare sia coloro che recitano che
coloro che osservano. Niente di altisonante, di minaccioso, di eretico o di folle. Solo passatempo.
Essere passatempo è il livello elementare della nostra arte, così come il pane lo è per la cucina
mediterranea. Non si mangia senza pane. Ma il solo pane alla lunga non basta.
A volte il passatempo è un valore in sé. Quando il tempo sembra non passare mai, per chi è
privato della libertà, per chi si tiene in piedi di fronte alla propria sofferenza, all’amputazione della
propria identità, o alla morte, il passatempo può essere la formula della vita, la resistenza all’orrore.
Dostojevskij racconta come il vaudeville recitato con costumi signorili e le catene ai piedi, nella
katorga siberiana, fosse per i condannati un modo per rifarsi una vita. Fare modestamente teatro, da
amateur, negli anni della guerra fra l’esercito e sendero luminoso, ad Ayacucho in Perù, era un’azione
vicina all’eroismo, per un gruppo di giovani che ho conosciuto. Erano attori perché desideravano anche
avere una zattera fuori dall’orrore.
In Europa, nel corso del Rinascimento, uno dei modi di far festa non erano semplicemente i
fuochi artificiali, era l’incendio. Il potente che organizzava i festeggiamenti comprava una o due case
popolari, cacciava via gli abitanti, le svuotava, le riempiva di fuochi d’artificio e polvere da sparo, poi
la faceva incendiare ed esplodere. Lo spettacolo era molto applaudito.
Per chi non vi è direttamente implicato, l’incendio può essere uno spettacolo. E per chi lo
racconta può essere una metafora della forza dirompente del teatro nel cuore d’una città, della sua
natura di focolaio di infezione morale. Oppure una immagine della vocazione degli attori ad essere dei
“senza casa”, sempre pronti ad essere sfrattati: dal fuoco, dagli integralisti, dalle autorità, dallo
sfruttamento economico.
Nel paese in cui nel 1981 bruciò il teatro Picadero, forse non dovrei usare l’incendio come una
metafora.
Quando leggo che in Argentina regnava la pace dei cimiteri, che vi furono trentamila
desaparecidos, migliaia di prigionieri politici e un milione di esiliati, che il popolo era senza dirigenti morti, incarcerati o fuori dal paese - e che qualsiasi forma di organizzazione sembrava impossibile, Il
Teatro Abierto mi appare come la danza sopra questi carboni ardenti di un pugno di attori e autori,
scenografi e tecnici, appena duecento, di fronte alla violenza della Storia.
Il comando della dittatura che incendiò la sala del Picadero nell’agosto 1981 non aveva previsto
che il suo atto criminale avrebbe scatenato una danza ben più grande. Numerosi direttori di teatri
commerciali si offrirono di continuare il Teatro Abierto, decine e decine di pittori dobnarono quadri per
raccogliere fondi e le personalità più note dei diritti umani e della cultura espressero la loro adesione.
Così lo scrittore Carlos Somigliana descrisse questa danza: “l’obiettivo profondo del Teatro
Abierto fu quello di tornare a guardare la nostra faccia senza vergognarci”.
Vi è un fuoco che non cessa di ardere nelle coscienze e nelle memorie dei teatranti, come anche
negli edifici dei teatri.
La sera del 7 maggio 1772, ad Amsterdam, durante la rappresentazione del Déserteur di
Monsigny, opera comica in tre atti, scoppiò un incendio che distrusse completamente il teatro
3
Schouwburg, facendo diciotto vittime. In appena tre anni, fu costruito un nuovo edificio, più imponente
e sfarzoso.
Fino al 1941, lo Schouwburg fu il teatro principale della città, situato nel Plantagebuurt, il cuore
del vecchio quartiere ebraico di Amsterdam. Nell'ottobre 1941, i nazisti che avevano occupato
l’Olanda, cambiarono il suo nome in Joodsche Schouwburg (Teatro Ebreo) per soli attori, musicisti e
spettatori israeliti. Nel settembre del 1942 il teatro fu chiuso e trasformato in un luogo per raggruppare
gli ebrei. 104.000 uomini, donne e bambini vi vennero ammassati, e da lì avviati ai campi di sterminio
della Germania e della Polonia.
Il teatro Schouwburg, da centro di cultura e divertimento, divenne un cupo luogo di angoscia e
dolore. Dopo la guerra quello spazio non poteva riprendere la sua funzione originale e restò chiuso per
anni. Fu scelto per diventare un luogo della memoria. Oggi, entrando nell'ex teatro, vediamo bruciare
una fiamma eterna.
Con questa immagine d’una fiamma di pura memoria, che brucia senza fumo di parole e senza
corpo, potrei chiudere questo discorso.
Concluderò, invece, con un brindisi.immaginario. Come si usa a teatro, quando si ricorre al mimo
al posto degli oggetti materiali.
Immaginate che qui, su questo tavolo accademico, ci sia una bottiglia di birra. E torniamo sulle
rive del Tamigi, in una delle nostre antiche patrie teatrali.
Troviamo la notizia del primo incendio nella storia del teatro europeo in una lettera del nobile
inglese Sir Henry Watton, datata 2 luglio 1613 e inviata a Sir Henry Bacon. Comincia così: “Ed ora
lasciamo riposare i discorsi politici e dello Stato. Mettiamoli a dormire. Ora vi voglio raccontare
qualcosa che in questa settimana è accaduta nella zona del Tamigi”.
Sir Watton riferisce che gli “Attori del Re”, la compagnia di Shakespeare, hanno messo in scena
un suo dramma intitolato All Is True. L’allestimento era suntuoso, con stuoie e tappeti sul palcoscenico,
una festa più ricca e maestosa delle vere cerimonie di corte. Durante lo spettacolo vennero sparate vere
salve di cannone e alcune scintille, volate fra la paglia del tetto, consumarono l’intero teatro in meno di
un’ora. Così spari il Globe: senza morti e senza feriti.
Il teatro, immediatamente riedificato con un tetto di tegole, fu riaperto un anno più tardi. Nel 1642
i Puritani, nel loro ardore religioso, chiusero tutti i teatri incluso il Globe che fu dimenticato anche
come forma di edificio teatrale: gli inglesi, alla riapertura dei teatri adottarono il teatro all'italiana.
Passarono più di tre secoli e il Globe Theatre, uno dei nostri miti, risuscitò. Resti del suo edificio
furono scoperti nel 1989 sulle rive del Tamigi e, su ispirazione di un attore e regista americano, Sam
Wanamaker, un nuovo Globe fu ricostruito nel 1997 uguale all'antico modello elisabettiano e vicino al
luogo in cui sorgeva l'originale.
Sapeva bene, Sir Watton, che ogni dramma deve chiudersi con il respiro leggero d’una farsa, e
concluse così la sua lettera a Sir Henry Bacon: “Soltanto uno degli spettatori rischiò la morte. Gli si
incendiarono le braghe e sarebbe forse finito arrostito se un allegrone mezzo ubriaco non l’avesse
spento versandogli addosso una bottiglia di birra”.
Fra tanti incendi, non sarebbe opportuno augurare anche a noi una buona birra?
4