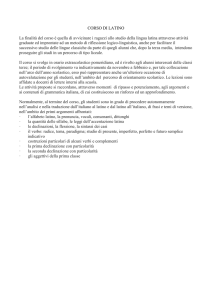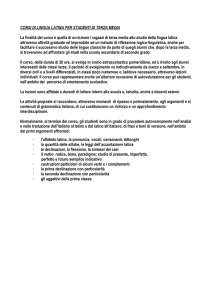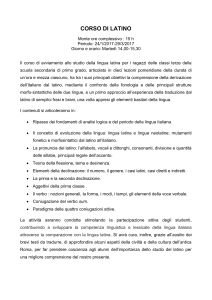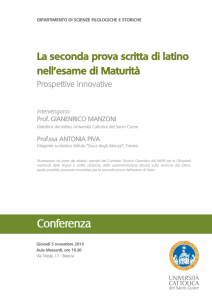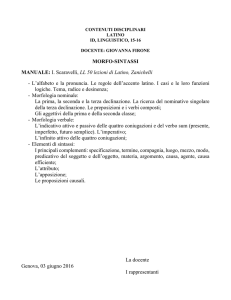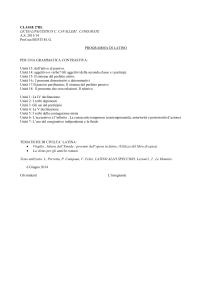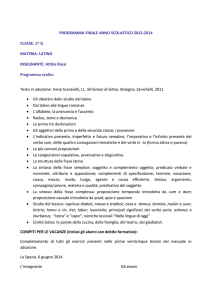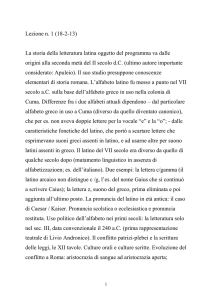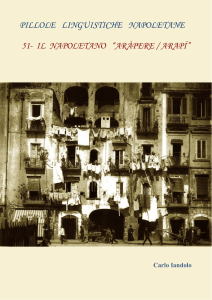Liceo T.L.Caro, Cittadella (PD)
23 gennaio 2012
Corso di Formazione “Didattica delle Lingue e Linguistica Formale”
Renato Oniga – Nicoletta Penello
Il nuovo paradigma scientifico e didattico della grammatica neo-comparativa
Alcuni orientamenti della ricerca linguistica hanno prodotto, negli ultimi
decenni, la nascita di un nuovo paradigma scientifico, che Liliane Haegeman ha
chiamato suggestivamente “la nuova sintassi comparativa”1. Rispetto alla grammatica
comparativa tradizionale, notoriamente orientata in direzione diacronica, e cioè volta
a comparare le lingue per ricostruire la storia delle famiglie linguistiche, in
particolare nel settore indoeuropeo, la nuova sintassi e più in generale la nuova
grammatica comparativa è orientata in direzione sincronica, e cioè compara le lingue,
non necessariamente solo all’interno della famiglia indoeuropea, per ricostruire il
nucleo comune a tutte le lingue, la cosiddetta Grammatica Universale, cioè il sistema
di costanti e di variabili che sta alla base della grammatica di ogni lingua 2.
Di fronte a questo nuovo orientamento della ricerca linguistica, che può piacere
o non piacere, ma ormai è un dato di fatto assodato da diversi decenni, a partire dagli
studi di Noam Chomsky, ritengo che anche lo studioso di lingue antiche sia chiamato
ad interrogarsi, che egli debba cioè, ancora una volta, prendere nella dovuta
considerazione quella che a suo tempo Germano Proverbio ha chiamato “la sfida
linguistica”3. Personalmente, sono convinto che il metodo neo-comparativo abbia in
sé le potenzialità per rinnovare e migliorare decisamente l’insegnamento delle lingue
classiche, in maniera analoga a come il metodo comparativo classico ha prodotto un
certo rinnovamento rispetto all’insegnamento grammaticale dei secoli precedenti.
Naturalmente, siamo ancora agli inizi di questo processo, e il mio tentativo si può
considerare finora unico a livello internazionale, ma sono sicuro che ben presto altri
seguiranno4.
C’è infatti una motivazione di fondo, a favore alla mia proposta di
rinnovamento della didattica delle lingue classiche in prospettiva neo-comparativa,
sulla quale vale la pena di soffermarsi un attimo. Nella linguistica contemporanea, al
di là delle controversie tra le diverse scuole di pensiero, c’è infatti ormai, almeno a
partire da Saussure, un certo accordo sul fatto che la grammatica può essere
considerata a buon diritto come una disciplina scientifica, in cui è possibile fare
ricerca, correggere vecchi errori e giungere a nuove scoperte. La comparazione non è
1
L. Haegeman, The New Comparative Syntax, London 1997.
K.É. Kiss (ed.), Universal Grammar in the reconstruction of ancient languages, Berlin – New York 2005.
3
G. Proverbio, La sfida linguistica, Torino 0000,
4
Si vedano ad esempio i numerosi contributi raccolti in Oniga – Zennaro (2006) e Oniga – Iovino – Giusti (2011).
2
un’opinione, o è giusta o è sbagliata. Ciò conferisce un valore scientifico intrinseco
alla ricerca linguistica, che si presenta oggi come un settore in continuo progresso.
Credo che non ci possa essere dubbio sul fatto che lo studio di una scienza è in
grado di attivare la curiosità per la scoperta e stimolare le migliori facoltà intellettuali
degli studenti. Al contrario, se l’insegnamento delle lingue antiche continuerà ad
essere proposto secondo la vecchia prospettiva scolastica, che considera questa
disciplina come un’attività puramente strumentale, priva di contenuti scientifici
interessanti, la reazione degli studenti, e oggi anche quella di un numero crescente di
personaggi capaci di orientare la cosiddetta opinione pubblica, non potrà che
continuare ad essere quella che è stata efficacemente riassunta, qualche decennio fa,
dallo scrittore austriaco Thomas Bernhard nella propria autobiografia, dove egli
individua precisamente l’origine del proprio rifiuto degli studi ginnasiali nella
convinzione che la materia di studio rappresentasse “il semplice sottoprodotto di un
materiale scientifico stantio ormai da secoli”5. Se l’insegnamento scolastico delle
lingue antiche continuerà semplicemente ad ignorare tutto ciò che è stato prodotto
dalla ricerca scientifica sulle lingue nell’ultimo secolo, non si potrà certamente dare
torto a questo giudizio impietoso.
La dignità scientifica della materia insegnata è un pre-requisito necessario, se si
vuole difendere il valore formativo di un insegnamento. Applicare allo studio delle
lingue classiche la prospettiva neo-comparativa significa proporre agli studenti una
materia valida per la formazione di una cultura linguistica di base, destinata ad
arricchire in modo permanente la personalità dell’alunno. Apprendere i primi
rudimenti di una scienza viva e in pieno sviluppo sarà un’esperienza intellettuale
utile, sia a chi continuerà poi lo studio del latino all’università, sia a chi si fermerà al
livello liceale, non diversamente da come lo studio della matematica sarà senza
dubbio formativa non solo per coloro che continueranno lo studio della disciplina ad
un livello superiore. Il mio progetto didattico nasce dunque da un’esigenza scientifica
e offre una via più aggiornata per tornare allo studio della grammatica delle lingue
antiche.
Naturalmente, ci si potrebbe giustamente chiedere perché mai questo studio neocomparativo debba essere applicato proprio alle lingue classiche, e non sia sufficiente
limitarsi alle lingue moderne. In realtà, l’obiezione andrebbe rovesciata, nel senso
che, se questa metodologia si è dimostrata valida per le lingue moderne, vale la pena
di domandarsi se essa possa essere utile anche alle lingue classiche. Nel caso che la
risposta a questa domanda possa essere affermativa, avremmo raggiunto il risultato di
riuscire ad applicare uno stesso metodo descrittivo ed esplicativo sia alle lingue
antiche, sia alle lingue moderne, come in effetti avveniva già nel periodo della
vecchia grammatica comparativa, quando ad esempio all’analisi delle lingue
germaniche non si applicavano metodi diversi dall’analisi del greco o del latino. Uno
degli obiettivi qualificanti a lungo termine dello studio del latino e del greco
dovrebbe essere infatti non tanto l’accumulo di nozioni minute per diventare dei
futuri filologi classici, ma lo sviluppo di una ‘cultura linguistica’ superiore, con
5
T. Bernhard, Autobiografia, trad. it. Milano 2011, p. 86.
ricadute positive anche sulla conoscenza consapevole dell’italiano e delle lingue
straniere.
Ecco allora che è facile capire perché proprio lo studio del latino e del greco, assai
più di quello delle lingue moderne, si presta ad utilizzare un metodo che conduce a
riflessioni generali sul funzionamento del linguaggio. In passato, la circostanza era
quasi inavvertita, perché la grammatica latina era in pratica l’unica teoria linguistica
universalmente condivisa. Nell’insegnamento del latino si sono infatti, per così dire,
stratificate e condensate nei secoli le riflessioni di filosofi quali Platone, Aristotele,
gli stoici antichi, i grammatici speculativi medievali e i logici di Port-Royal. Ciò è
accaduto perché il latino, fino a pochi secoli fa, occupava nell’universo intellettuale
la posizione privilegiata di lingua della cultura per eccellenza: ma anche perché una
lingua ‘morta’, e come tale sottratta alla mutevolezza del parlato quotidiano, permette
di raggiungere più agevolmente un alto grado di astrazione grammaticale, e dunque
una più attenta consapevolezza teorica dell’atto linguistico.
Non a caso, le prime grammatiche delle lingue moderne sono state realizzate
proprio sul modello della grammatica latina, che ha rappresentato a lungo lo
strumento più raffinato di analisi linguistica. Ecco perché, si diceva una volta, ‘il
latino insegna a ragionare’: ed ecco perché la pedagogia ha giustificato a lungo il
valore dell’insegnamento grammaticale del latino come contributo prezioso
all’educazione linguistica, e più in generale come addestramento di importanti
funzioni mentali, quali memoria, pazienza, capacità di analisi e concentrazione,
trasferibili poi utilmente in altri campi di studio.
Le domande di fondo che si pone chi si appresta a studiare una lingua con finalità
scientifiche, e non puramente pratiche e strumentali, sono sempre le stesse. Come
funziona una lingua? Com’è possibile che un parlante sia in grado di produrre e
capire un numero infinito di frasi che non ha mai sentito prima? Le lingue variano ad
arbitrio o ci sono dei princìpi universali? Dobbiamo ammettere di non saper
rispondere, se non in maniera parziale, a tali quesiti. Ma sono problemi affascinanti,
che vale la pena di affrontare, se non altro per tentativi: intorno a queste domande è
nata la stessa grammatica antica, che è appunto, in origine, una teoria del linguaggio.
Ancor oggi, il compito primario dell’insegnamento grammaticale dovrebbe essere
quello di porre i problemi, formulare le domande, prima ancora che suggerire risposte
preconfezionate. Come in ogni ricerca scientifica, le teorie cercano di approssimarsi il
più possibile alla realtà, senza pretendere di cogliere la verità ultima.
La sfida che si pone alla teoria linguistica è cercare di descrivere in modo formale,
per mezzo di un numero limitato di premesse, questo insieme altamente complesso di
princìpi generali e di regole particolari che costituisce la grammatica interiorizzata
nel parlante. Un problema di analisi morfologica o sintattica richiede capacità di
ragionamento, astrazione e generalizzazione, non dissimili da quelle necessarie per
risolvere un problema di matematica. Se si svuota lo studio della grammatica del suo
interesse scientifico, non si potrà poi difenderne il valore pratico nell’uso scolastico.
La negazione dell’interesse teorico finisce inevitabilmente per condurre
all’abbandono della grammatica stessa, intesa come riflessione linguistica, in favore
dello sviluppo di automatismi da memorizzare supinamente (cosa che appunto hanno
fatto, con indubbia coerenza metodologica, alcuni indirizzi didattici oggi correnti).
La prospettiva teorica giustifica invece pienamente la pratica scolastica dell’analisi
grammaticale come preliminare ad una traduzione ragionata. Tradurre in modo
consapevole significa infatti risalire dalla forma superficiale di una frase in una data
lingua di partenza alla sua struttura grammaticale più astratta, per poi ridiscendere
alla forma di superficie della lingua di arrivo, partendo dalle medesime relazioni
grammaticali elementari, ma sostituendo le unità lessicali, e tenendo conto delle
differenze parametriche tra le lingue. La traduzione presuppone sempre un
ragionamento estremamente complesso, che può rimanere implicito, ridotto a
meccanismi da assimilare supinamente, oppure può essere reso esplicito attraverso gli
strumenti dell’analisi linguistica. Questo secondo metodo mi pare indubbiamente più
interessante e meno arido per lo studio – anche scolastico – della grammatica. Si
tratta cioè non solo di descrivere il come, ma anche di ricercare costantemente il
perché dei fenomeni grammaticali, ribaltando la pratica scolastica abituale, e
concentrandosi dunque prima di tutto sui princìpi generali, anziché sulle eccezioni.
Esempi pratici di analisi neo-comparativa: latino vs inglese
1. Fonetica
Premessa: il concetto di suono e fonema
L’inventario dei suoni linguistici è un insieme finito e universale, che viene
rappresentato graficamente per mezzo dell’alfabeto fonetico internazionale.
Ciò accade perché tutti gli uomini sono in grado di pronunciare un medesimo e
limitato numero di suoni.
L’inventario dei fonemi varia invece da lingua a lingua (è un parametro).
Ciò accade perché un fonema può esistere in una data lingua ed essere assente
in un’altra. Ad esempio, la fricativa interdentale inglese /θ/ di parole come l’articolo
the, non esiste in italiano né in latino. Oppure, la labiovelare /qu/ esiste in latino, in
italiano e in inglese, ma non in tedesco.
Ma c’è anche un secondo motivo, per cui l’inventario dei fonemi varia da una
lingua all’altra. Uno stesso suono può assumere cioè il valore di fonema in una data
lingua, ma il valore di semplice variante (allofono) in un’altra lingua. Ad esempio,
l’italiano utilizza un unico fonema /s/, che in posizione intervocalica è realizzato da
due allofoni regionali. In parole come rosa, il fonema /s/ viene pronunciato come
fricativa sonora [z] al nord e sorda [s] al sud. Diversamente, l’inglese distingue i due
fonemi, sordo e sonoro, cioè /s/ e /z/, come dimostra la coppia minima price [prais] e
prize [praiz].
In conclusione, assai più che conoscere l’elenco delle lettere dell’alfabeto
latino o inglese o italiano, sarà perciò importante saper valutare esattamente
l’inventario dei fonemi latini.
- I fonemi dell’inglese e del latino (si veda anche lo schema separato, parte 3)
I fonemi del latino:
Le consonanti
Punto
Modo
Occlusive
Fricative
Nasali
Laterali
Vibranti
Labiali
Sorde
Sonore
p
b
f
m
Dentali
Velari
Sorde
Sonore Sorde
Sonore
t
d
k
g
s
n
l
r
Nella terminologia scolastica, le occlusive venivano chiamate “mute”, le sorde
“tenui”, le sonore “medie” e le fricative “spiranti”. Rimane tuttora in uso che la
fricativa /s/ sia detta anche “sibilante”, e che la laterale /l/ e la vibrante /r/ vengano
dette insieme “liquide”.
All’inventario delle consonanti latine devono poi essere aggiunte altre
consonanti meno comuni, perché di articolazione più complessa.
Le labiovelari sono scritte nell’alfabeto latino qu e gu e nell’alfabeto fonetico
internazionale [kw] e [gw]. Si tratta in entrambi i casi di digrammi, che indicano cioè
non la combinazione di una consonante velare con una vocale u, ma un fonema unico
(rispettivamente /kw/ e /gw/), costituito da una consonante velare (sorda o sonora) con
appendice labiale.
La lettera x è semplicemente un segno alfabetico unico per indicare la sequenza
di un fonema velare seguito da una /s/, cioè /k/+/s/ o /g/+/s/. Ad esempio, nella
declinazione delle parole crux, crucis e lex, legis, la x che si trova al nominativo
rappresenta la combinazione dei fonemi /k/+/s/ e /g/+/s/ rispettivamente.
La lettera z è stata introdotta nell’alfabeto latino per scrivere le parole greche
come zona, che possedevano l’affricata dentale sonora [dz], un fonema sconosciuto
al latino. In generale, le affricate costituiscono fonemi meno comuni nelle lingue del
mondo (l’italiano possiede anche le due affricate palatali sorda /tʃ/ di cento e sonora
/dʒ/ di già, che invece sono anch’esse sconosciute al latino classico).
Le semiconsonanti (o semivocali)
Le semiconsonanti o semivocali del latino sono la labiale /j/, come nell’inglese
yet [jet], e la palatale /w/, come nell’inglese well [wel].
Le semiconsonanti funzionano all’inizio della sillaba come le altre consonanti:
ad esempio le latino iacto [jakto] e venio [wenio] o nell’italiano ieri [jɛri] e uomo
[wɔmo]. Nell’alfabeto latino, come in quello italiano, i fonemi /j/ e /w/ sono scritti
con gli stessi segni che indicano le vocali corrispondenti (i e u).
Le uniche difficoltà che si possono incontrare in latino possono essere la
presenza o assenza delle cosiddette “lettere ramiste” (la possibilità cioè di trovare
scritto jacto o iacto, oppure venio o uenio).
Le semivocali si trovano dopo una vocale e funzionano come secondo
elemento del dittongo (come nell’italiano sei [sei] e pausa [pauza]).
Inoltre, ci sono dei rari casi in cui la i, pur trovandosi in inizio di sillaba davanti
a vocale, ha il valore di fonema vocalico /i/, e non di fonema semiconsonantico /j/.
Ad esempio, in latino, nella parola di origine greca Iason [iason] o nella forma di
participio presente i-ens [iens], la i davanti a vocale è anch’essa eccezionalmente una
vocale. Eccezioni di questo genere si trovano anche in italiano, ad esempio nella
parola diario [diarjo], dove la prima i è una vocale e la seconda una semiconsonante.
Le vocali
Alte (chiuse)
Medie
Basse (aperte)
Anteriori (palatali)
i
e
Centrali
a
Posteriori (velari)
u
o
La quantità vocalica
In latino la quantità vocalica ha valore fonologico: dunque, i fonemi vocalici latini
non sono cinque (come in italiano), ma dieci, perché per ogni suono vocalico esistono
due fonemi autonomi: una vocale lunga e una vocale breve. I fonemi vocalici del
latino sono dunque i seguenti: /ĭ/, /ī/, /ŭ/, /ū/, /ĕ/, /ē/, /ŏ/, /ō/, /ă/, /ā/.
La quantità vocalica in latino ha valore distintivo di fonema, come si può
notare dalle seguenti coppie minime: dĭco “io dedico” / dīco “io dico”; pŭtet “che egli
pensi” / pūtet “egli puzza”; vĕnit “egli viene” / vēnit “egli venne”; nŏvi “qualcosa di
nuovo” / nōvi “io so”; mălum “il male” / mālum “la mela”.
Fenomeni simili si possono osservare in inglese (ad es. sheep “pecora” e ship
“nave”), o in friulano (ad es. lât “lato” e lat “latte”). In italiano, invece, certamente
esistono suoni vocalici lunghi (ad es. fāto) e brevi (ad es. fătica), ma questi non
hanno il valore di fonemi, bensì solo di allofoni prevedibili in base al contesto (le
vocali accentate sono solitamente più lunghe di quelle non accentate). Nel caso di
coppie minime come fato e fatto, in italiano il valore distintivo non viene attribuito
alla quantità del fonema vocalico, ma a quella del fonema consonantico.
I dittonghi
Il dittongo (dal greco dìfthongos “che possiede due suoni”) viene percepito come una
vocale che cambia il proprio suono nel corso dell’emissione, cosicché all’inizio si
avverte il suono una vocale, e alla fine il suono di un’altra: ad esempio [au]
nell’italiano sauna.
Le grammatiche italiane distinguono solitamente i dittonghi in “ascendenti” (ad
es. piánta), se il suono aumenta dal primo al secondo elemento; e viceversa
“discendenti” (ad es. láico), se il suono diminuisce. Oggi i linguisti preferiscono però
considerare i dittonghi ascendenti non come veri dittonghi, ma come gruppi formati
da una semiconsonante più una vocale. Per tale motivo, il primo elemento /j/ o /w/ è
definito appunto come semiconsonante, perché ha una natura fonetica più vicina a
quella delle consonanti, che non a quella delle vocali. Gli unici veri dittonghi sono
pertanto i dittonghi discendenti, cioè i gruppi formati da una vocale più una
semivocale.
I dittonghi più frequenti in latino sono tre: au, ae e oe (ad esempio in causa,
Caesar, poena). Più rari sono eu ed ei. Poiché, come si è detto, i veri dittonghi sono
sempre “discendenti”, il suono diminuisce dal primo al secondo elemento: dunque, se
la sillaba è accentata, l’accento si pone sempre sulla prima vocale del dittongo: ad
esempio cáusa, Cáesar, póena.
Per la precisione, il valore fonetico proprio dei dittonghi ae e oe nel latino
classico era [ai] e [oi], e non [ae] e [oe]. Ce lo testimoniano le grafie fonetiche in
iscrizioni arcaiche, come aidilis per aedilis, e il fatto che alle parole latine Caesar e
poena corrispondono il tedesco Kaiser e il greco ποινή [poiné]. In secondo luogo, la
fonetica universale ci testimonia che il secondo elemento di un dittongo è tipicamente
una semivocale i o u, ma non una e. Anche in italiano esistono i dittonghi ai e oi (ad
esempio in mai e noi), e così anche in greco antico e in inglese (ad esempio night
[nait] e boy [bɔi]), ma in nessuna di queste lingue esistono i dittonghi ae e oe.
Possiamo dunque cogliere qui un limite della cosiddetta pronuncia classica del latino,
che ricostruisce dittonghi foneticamente improbabili come [ae] e [oe].
Nel latino tardo, ma anche nella pronuncia dialettale della stessa età classica (la
pronuncia detta “rustica”), i dittonghi ae ed oe furono invece “monottongati”, cioè
ridotti al valore fonico di una sola vocale [ē]. Per questo motivo, nella pronuncia
scolastica del latino, Caesar e poena vengono pronunciati [tʃezar] e [pena],
esattamente come le parole che ne sono derivate in italiano (Cesare e pena). Al
contrario, il dittongo au, di cui pure si hanno tracce di monottongazione nel latino
rustico (ad es. caupo > copo), e in alcune derivazioni italiane (ad es. aurum > oro),
nel latino letterario si mantiene stabile fino all’età tarda, ed è conservato anche nella
pronuncia scolastica.
Vantaggi dell’approccio neo-comparativo alla fonetica latina:
- Rendere interessante il capitolo dedicato all’alfabeto latino, che solitamente
viene del tutto ignorato nella didattica
- Permettere di capire bene il problema della pronuncia del latino, aiutando a
risolvere il problema della lettura erronea degli studenti, che si trascina dalla
scuola all’università
Il problema della pronuncia deriva paradossalmente dalla vitalità del latino come
lingua parlata nell’età moderna. Nacquero così le varie pronunce ‘nazionali’ del
latino, nelle quali la lingua latina tendeva ad essere il più possibile adattata a quella
della lingua madre del parlante. Ad esempio, ancor oggi è usuale in Francia mettere
sistematicamente l’accento sull’ultima sillaba delle parole latine che terminano per
vocale, così come si fa per quelle francesi: anche i professori universitari dicono
volentieri linguà Latinà.
La pronuncia nazionale italiana ha avuto poi una fortuna del tutto particolare,
perché è rimasta la più vicina alla pronuncia del latino in età tardoantica, e si è
conservata come pronuncia ufficiale della Chiesa Cattolica. Per questo, nella scuola
italiana, quella che viene chiamata pronuncia ‘scolastica’ o ‘ecclesiastica’ o
‘umanistica’ rimane tuttora la più praticata, e forse la più consigliabile, perché ci fa
sentire il latino come qualcosa di familiare, come un elemento della nostra stessa
identità.
Negli ambienti universitari si è invece affermata negli ultimi decenni la
pronuncia “classica” o restituta, che cerca di ricostruire la reale pronuncia degli
antichi, sulla base di solidi argomenti prodotti dalla ricerca storico-linguistica.
La soluzione consigliabile oggi nella scuola è di conoscere bene entrambe le
pronunce, ma di optare fin dall’inizio per una delle due, a giudizio dell’insegnante,
evitando soprattutto fastidiose confusioni tra le due. Ad ogni modo, il problema della
pronuncia appare tutto sommato secondario: come sappiamo, l’importante è
conoscere i fonemi di una lingua, il loro suono effettivo può ben ammettere delle
varianti regionali.
Pronuncia scolastica
La pronuncia cosiddetta scolastica è certo più facile per un parlante italiano: si tratta,
come si è detto, della pronuncia nazionale italiana del latino. In pratica, si può
semplicemente leggere il latino come se fosse italiano. Le divergenze rispetto alla
pronuncia dell’italiano sono infatti soltanto due:
- i dittonghi ae ed oe si pronunciano monottongati in [e]. Ad esempio, poena si
pronuncia [pena], esattamente come la parola italiana pena.
- l’occlusiva dentale sorda [t] diventa l’affricata corrispondente [ts], qualora si trovi
davanti a vocale i non accentata, e non sia preceduta da un’altra t, o da una s, o da
una x. Ad esempio, gratia si pronuncia [grátsia], esattamente come l’italiano grazia.
Al contrario, totius si pronuncia [totíus], perché la t precede una vocale accentata. La
t rimane inalterata anche se è preceduta da un’altra t, una s o una x: ad esempio in
Cottius, vestio, mixtio, e in alcune parole di origine greca, come tiara.
- come nella maggior parte delle lingue moderne (ad esempio nell’inglese photo), il
gruppo ph si pronuncia [f]: ad esempio, philosophus [filósofus].
Pronuncia classica
La pronuncia cosiddetta “classica” o restituta è il frutto della ricostruzione storica,
che cerca di riprodurre la pronuncia delle classi colte di Roma nel periodo “classico”,
cioè intorno al primo secolo a.C.
Le divergenze della pronuncia classica rispetto alla pronuncia scolastica sono le
seguenti:
- i dittonghi ae ed oe si pronunciano sempre come tali: cioè [ae] e [oe], anche se, a
rigore, la pronuncia più corretta sarebbe [ai] e [oi].
- l’occlusiva dentale t si pronuncia sempre [t].
- le occlusive velari c e g si pronunciano sempre come velari, cioè [k] e [g]. La
pronuncia scolastica segue invece l’uso italiano, dove esse si pronunciano velari solo
se sono seguite dalle vocali a, o, ed u (ad es. casa, cosa, cura), mentre, si
pronunciano come affricate palatali [tʃ] e [dʒ] se sono seguite dalle vocali e ed i (ad
es. cena, cima, gelo, giro).
- il gruppo ph si pronuncia come occlusiva aspirata [ph], e non come fricativa [f].
- la consonante h si fa sentire come l’aspirazione dell’inglese (how) o del tedesco
(Himmel), mentre, come si suol dire, in italiano “non vale un’acca”, cioè la h non
viene pronunciata.
- la s è sempre sorda, e non, come nell’italiano settentrionale, sonora in posizione
intervocalica: dunque rosa si pronuncia [rosa] e non si sonorizza in [roza].
- la v si pronuncia [w], cioè come semivocale labiale e non come la fricativa
labiodentale italiana [v].
In sostanza, la pronuncia classica è più vicina al valore proprio dei singoli fonemi
latini: i dittonghi sono pronunciati appunto come dittonghi; le occlusive sempre come
occlusive, e non come affricate; e così l’aspirata, la sibilante e la semiconsonante
mantengono sempre il loro valore fonetico proprio. La pronuncia scolastica introduce
invece tutta una serie di innovazioni: i dittonghi vengono monottongati, le occlusive a
volte diventano affricate, l’aspirazione scompare, la sibilante a volte si sonorizza, la
semiconsonante diventa fricativa.
La conoscenza della pronuncia classica ci permette perciò di capire che la
pronuncia scolastica è il risultato di una evoluzione storica, avvenuta nel latino tardo
proprio a partire dalla pronuncia classica.
Possiamo così capire meglio perché, solo per il latino, esistono due pronunce.
Sarebbe come se per l’inglese si usasse in alternativa la pronuncia attuale e quella
medioevale.
Anche alcune apparenti bizzarrie dell’italiano possono essere meglio comprese
in questo contesto, collocandole nella giusta prospettiva di evoluzione linguistica. Ad
esempio, la c si pronuncia [k] in casa, ma [tʃ] in cena, perché ad un certo punto della
storia del latino è avvenuto un tipico fenomeno di “assimilazione”: l’occlusiva velare
ha subito cioè l’influsso della vocale palatale ed è divenuta una affricata palatale.
2. Morfologia:
Premessa: il concetto di parola
Come la fonetica studia i fonemi, la morfologia studia le parole. Se il concetto di
parola è un universale linguistico, le sue proprietà specifiche variano da una lingua
all’altra, secondo dei parametri.
Un parametro essenziale è la flessione, cioè l’insieme di modificazioni che la parola
assume per esprimere delle informazioni grammaticali di vario tipo.
Nelle lingue con flessione ridotta, come l’inglese, le unità di base della morfologia si
possono considerare grosso modo coincidenti con le parole semplici, che si trovano
registrate in un dizionario. Ciò è possibile perché, in queste lingue, la flessione
avviene di regola tramite l’addizione di elementi a delle unità di base, che sono
chiaramente delle parole semplici. Ad esempio, per il nome boy e per il verbo to
want, le basi delle forme flesse (boy-s, want-s, want-ed) sono rispettivamente il nome
boy- e il verbo want-.
Nelle lingue con flessione ricca, come il latino (ma anche l’italiano), i casi di
semplice ‘aggiunta’ di elementi flessivi ad una forma di base, che sia essa stessa una
‘parola’, sono molto rari. Questo accade, ad esempio, per la flessione di un nome
come il latino consul “console”. Esso si declina nel seguente modo: Nom. consul,
Gen. consul-is, Dat. consul-ī, Acc. consul-em, ecc. In questa circostanza fortunata, la
base delle forme flesse è dunque il nome consul-, che coincide con la forma di
citazione che si trova sul vocabolario (il nominativo singolare). Ma di solito, il
meccanismo flessivo dei nomi latini è più complesso. Nella maggioranza dei casi, la
forma di base sottostante al paradigma flessivo non è in grado di comparire da sola
alla superficie della lingua, ma è qualcosa di più astratto, definibile solo per mezzo
dell’analisi linguistica. Prendiamo ad esempio la declinazione di un nome come crux
“croce” (che appartiene alla medesima classe flessiva del citato consul, cioè la terza
declinazione). Il paradigma flessivo è il seguente: Nom. crux, Gen. cruc-is, Dat. crucī, Acc. cruc-em, ecc. L’analisi linguistica, già proposta dagli antichi (Varrone, De
lingua Latina IX 44), ci permette di dimostrare facilmente che la forma di base
sottostante al paradigma è in questo caso un elemento astratto *cruc-. Il problema è
che tale forma non si trova mai alla superficie della lingua, e nemmeno sul
vocabolario. Eppure, questa forma astratta ha una reale esistenza nel lessico mentale,
e rappresenta appunto la forma di base per la flessione.
Le lingue con flessione ricca utilizzano come unità di base della morfologia delle
“parole astratte”, che nella tradizione scolastica sono chiamate “temi”.
Le cinque declinazioni
La grammatica latina distingue cinque declinazioni: il motivo deriva dal fatto che
le vocali in latino sono appunto cinque. L’appartenenza di un tema ad una delle
cinque declinazioni è determinata infatti, automaticamente, dalla vocale finale del
tema:
se il tema finisce in a, la parola segue la prima declinazione;
se il tema finisce in o, la parola segue la seconda declinazione;
se il tema finisce in i, la parola segue la terza declinazione;
se il tema finisce in u, la parola segue la quarta declinazione;
se il tema finisce in e, la parola segue la quinta declinazione.
Infine, se il tema finisce in consonante, a rigor di logica la parola dovrebbe seguire
una declinazione autonoma, ma la grammatica la considera parte della terza
declinazione, perché in effetti la declinazione dei temi consonantici presenta molte
analogie (e non poche confusioni) con la declinazione dei temi in -i-. Questo è il
motivo per cui la terza declinazione è oggettivamente più complessa delle altre. Una
presentazione che parta però dalle proprietà dei temi (ad esempio distinguendo temi
in occlusiva, nasale, ecc.), anziché dare regolette astruse e innaturali come quella dei
parisillabi e imparisillabi, permette di presentare in maniera più corretta, dal punto di
vista linguistico, la terza declinazione, e permette un più agevole confronto con il
greco, dove per fortuna la descrizione della terza declinazione si basa sulle forme dei
temi.
Il Caso
La declinazione è la flessione del nome. Le modificazioni subite dai temi nominali
hanno lo scopo di esprimere le informazioni di Numero e Caso. Anche questo è un
fenomeno universale, ma esistono variazioni parametriche tra le lingue.
L’informazione relativa al Numero è espressa anche in inglese, per mezzo della
desinenza zero (singolare) e –s (plurale). Talvolta anche in inglese la formazione del
plurale implica processi morfologici più complessi (apofonia: foot/feet).
Il latino, oltre al Numero, esprime per mezzo di modificazioni morfologiche anche
l’informazione relativa al Caso.
Per poter capire questo fenomeno, bisogna distinguere il concetto di Caso astratto e
Caso morfologico. Il Caso astratto è una proprietà universale di tutte le lingue.
Esistono infatti particolari insiemi di parole, tipicamente i verbi, i quali sono per
natura assegnatori di Caso. Ad esempio, un verbo transitivo deve necessariamente
assegnare il Caso accusativo al proprio oggetto.
Mentre il Caso astratto è una proprietà universale della grammatica di tutte le lingue,
il Caso morfologico varia secondo parametri diversi da lingua a lingua. Ad esempio,
in latino, in greco, o anche in tedesco, troviamo un sistema di casi morfologici molto
ricco e ben descritto dalle grammatiche. In altre lingue, come l’italiano o l’inglese, il
sistema dei casi morfologici è più ridotto, tanto che nelle grammatiche scolastiche si
dice spesso che il Caso è un concetto sconosciuto all’italiano.
In realtà, non c’è nulla di più sbagliato che presentare il Caso come una particolarità
esclusiva delle lingue classiche. Questo mette lo studente in una condizione di
difficoltà, perché si trova a dover maneggiare una categoria concettuale che gli viene
detta assente dalla propria madrelingua.
Sarebbe molto meglio dire fin dall’inizio che, anche alle grammatiche delle lingue
moderne, italiano e inglese inclusi, non sono sconosciuti neppure i Casi morfologici:
ad esempio, come si può notare dalla tabella seguente, i pronomi di terza persona
singolare possiedono in italiano una declinazione a tre casi morfologici, e in inglese a
due casi morfologici:
Maschile
Femminile
Nominativo
egli
ella
Dativo
gli
le
Accusativo
lo
la
Maschile
Femminile
Nominativo
he
she
Accusativo
him
her
Dunque, bisognerebbe dire che l’italiano e l’inglese possiedono un sistema di Casi
astratti assolutamente paragonabile a quello del latino, solo che l’assegnazione del
Caso solo raramente produce effetti morfologici.
Sintassi: (si vedano anche gli schemi nella parte 3)
Le parole flesse sono allo stesso tempo le unità massime della morfologia e le unità
minime della sintassi, perché la morfologia studia la struttura interna delle parole,
mentre la sintassi studia la struttura esterna delle stesse. La morfologia ci permette di
affermare che una parola appartiene a una determinata categoria sintattica (nome,
aggettivo, verbo, ecc.), ed esprime una serie di informazioni flessive (genere, numero,
caso, ecc.). La sintassi si occupa delle proprietà della parola quando essa va a
interagire con le altre. Il Caso ne è un tipico esempio. La grammatica tradizionale
parla in proposito di “costruzioni”, come se queste fossero qualcosa a sé stante, e non
il prodotto dell’interazione tra le proprietà delle singole parole, che determinano il
loro combinarsi all’interno della frase. Nella linguistica contemporanea, la
prospettiva tende ad essere rovesciata: si ipotizza appunto che le parole possiedano
una struttura esterna, considerando le strutture sintattiche come la proiezione delle
proprietà delle parole. Ad esempio, si è detto che il Caso accusativo è una proprietà
che il verbo assegna al proprio oggetto, in una determinata configurazione sintattica.
Un concetto fondamentale per poter analizzare in modo scientifico la sintassi, è
quello di “sintagma”.
L’esistenza di tali unità è piuttosto intuitiva, e corrisponde grosso modo all’idea che
tutti abbiamo dell’esistenza di “gruppi di parole”, che possono essere spostati da un
punto della frase a un altro. Proviamo a scrivere una frase qualsiasi, ad esempio leggo
[il giornale] [con interesse], e ci rendiamo conto che è possibile spostare l’ordine dei
sintagmi, leggo [con interesse] [il giornale]. Oppure [lo studente] [è sveglio] può
diventare [è sveglio] [lo studente].
Esiste anche un metodo formale, il cosiddetto metodo di analisi strutturale in
“costituenti immediati”, elaborato nella prima metà del Novecento dal linguista
americano Leonard Bloomfield, che permette di arrivare ad una definizione più
precisa di sintagma, e sul quale non possiamo qui soffermarci.
Diciamo solo che ogni sintagma ha un proprio costituente principale, detto in gergo
“testa”, e poi una serie di modificatori, che si stratificano gerarchicamente secondo
una struttura universale, che prevede la presenza delle posizioni cosiddette di
Specificatore, Testa e Complemento:
XP
(Specificatore)
X'
X
(Complemento)
Il diagramma ad albero simboleggia il fatto che tra gli elementi di un sintagma
esistono delle relazioni di tipo gerarchico (verticale), e non solo di tipo lineare
(orizzontale). La comprensione delle frasi richiede infatti l’individuazione delle
relazioni gerarchiche complesse di volta in volta concretamente realizzate tra le
parole, anziché la pura e semplice registrazione dei significati delle parole nella loro
successione lineare.
Esempio di sintagma nominale:
NPi
Specificatore
N'
N
Complemento
Omnium exspectatio
everybody’s expectation
visendi Alcibiadis
to see Alcibiades
Oltre a queste posizioni strutturali di specificatore, testa e complemento, ci possono
essere altri elementi facoltativi, detti aggiunti, sui quali si discute tuttora se possano
essere aggiunti solo a sinistra oppure anche a destra:
SX
Specificatore
X'
X'
(Aggiunto)
(Aggiunto)
X'
X
Testa
Complemento
Senza poterci ovviamente soffermare qui sul problema, osseviamo che sarebbe più
elegante se potessero esserci solo aggiunti a sinistra, come ad esempio:
NP
AP
N'
NP
N'
Ni
veteribus
Helvetiorum iniuriis
NP
populi Romani
the old offences by the Helvetii to the Roman people
Come si potrà notare in questo caso, l’ordine degli elementi tra latino e inglese varia
per quanto riguarda la posizione del nome rispetto allo specificatore. In latino, infatti,
è ammesso sia l’ordine canonico in cui la testa segue lo specificatore, sia quello in cui
la testa precede lo specificatore, che si può ipotizzare sia prodotto da un movimento
del nome:
SN
Spec
N
Helvetiorum iniuriae
SN
N
SN
Spec
iniuriae Helvetiorum
N
iniuriae
Nella traduzione italiana è ammesso solo l’ordine in cui la testa precede (“le offese
degli Elvezi”). In inglese, in realtà, sono ammessi entrambi gli ordini, ma in diverse
configurazioni sintattiche: da un lato the offences of the Helvetii, dall’altro the
Helvetii’s offences, con il cosiddetto genitivo sassone.
L’ordine delle parole nelle diverse lingue costituisce dunque solo un fenomeno di
superficie. La struttura più profonda del sintagma è definita dalla sua strutturazione
gerarchica, non dall’ordine lineare degli elementi. Anche se l’ordine superficiale è
libero, la stratificazione gerarchica degli elementi nel sintagma non cambia affatto, né
in latino, né in altre lingue.
Questo modo di vedere le cose dovrebbe senza dubbio facilitare lo studente
nell’apprendimento, dal momento che lo mette nella situazione tranquillizzante di
esercitare un dominio razionale sulla materia studiata.
Naturalmente, tutto ciò ha bisogno di essere dimostrato scientificamente in tutte le
frasi che lo studente potrà trovarsi ad affrontare. Questo è il lavoro che ci accingiamo
ad affrontare con il nostro corpus sintattico.
Possiamo fare qui solo un esempio della prima frase del De bello Gallico, in latino,
inglese e italiano:
Caes. Gall. 1, 1, 1
Principale con predicato nominale
TP
NP
T'
T
SC
QP
Q
AP
NP
A
PP
P
QP
Spec
Q'
Q
NP
N CP
Gallia est omnis Gallia divisa in partes tres partes
Caes. Gall. 1, 1, 1
Principale con predicato nominale
TP
DP
Det
N
T'
PP
T’
T
SC
DP
Det
AP
N
A
PP
P
QP
Q
NP
N CP
la
Gallia nel suo complesso è
la
Gallia
divisa in tre parti
Caes. Gall. 1,1,1
Main clause with noun phrase
TP
QP
T'
T
SC
QP
Q
NP
AP
A
PP
P
QP
Q
Q
N
NP
All Gaul is all
Gaul divided into three parts
Renato Oniga
(Università di Udine)