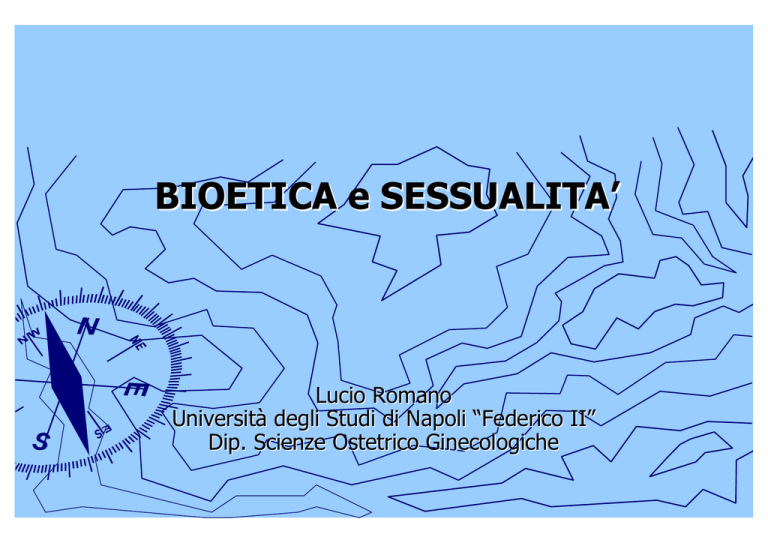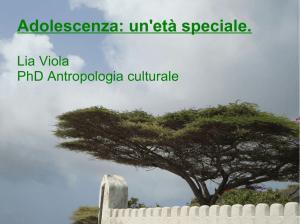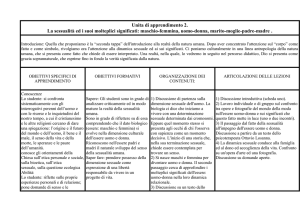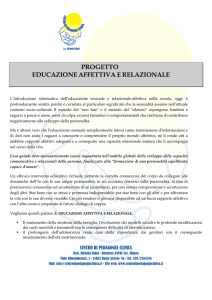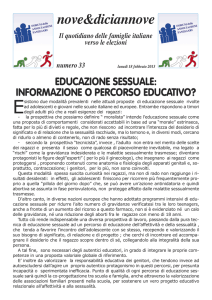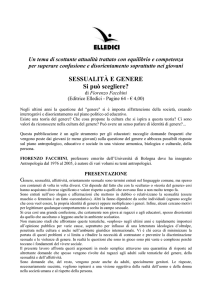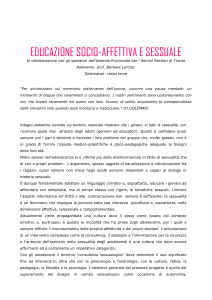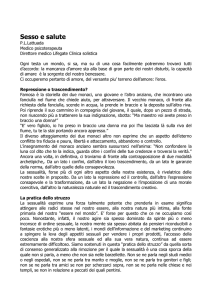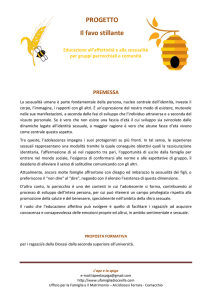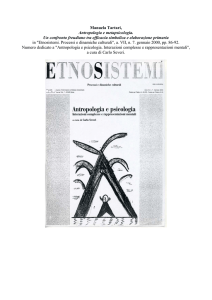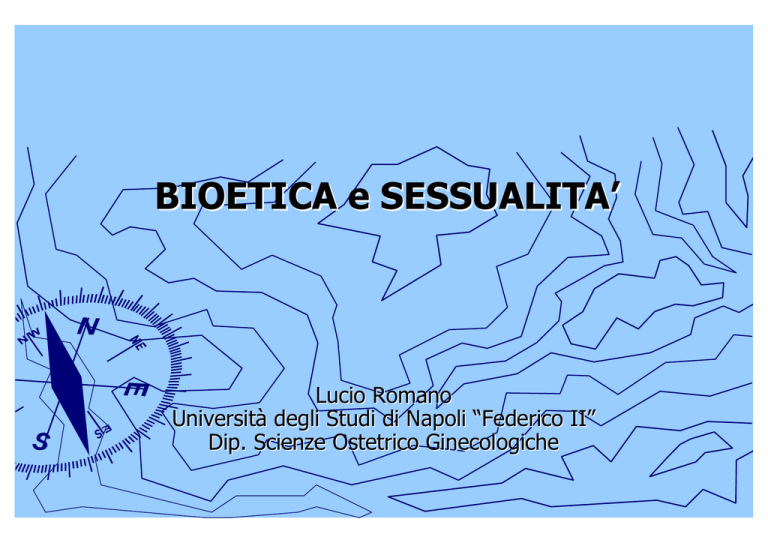
BIOETICA e SESSUALITA’
Lucio Romano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Dip. Scienze Ostetrico Ginecologiche
ATTI dell’ UOMO (actus hominis)
ATTI UMANI (actus humani)
ATTI dell’ UOMO
atti comuni a quelli degli animali, dei vegetali e anche del mondo
inanimato: nascere, vivere in senso biologico, digerire, crescere, …
atti che l’uomo pone ma che non sono specificamente umani
provengono dall’uomo ma non esprimono il carattere propriamente
umano
ATTI UMANI
atti che rivelano l’uomo in quanto uomo, cioè in quanto dotato di
soggettività razionale
atti che sono specificamente umani
provengono dall’uomo ed esprimono il carattere propriamente umano
(atti liberi e responsabili)
LIVELLI di ATTIVITA’ della PERSONA
 LIVELLO BIOLOGICO
funzione della vita organica “non volontaria”
 LIVELLO PRODUTTIVO
produzione di oggetti
 LIVELLO PROPRIAMENTE PERSONALE
rivelazione della persona nella sua unitotalità
La sessualità’:
 non può essere a livello solamente biologico
 non può essere a livello solamente produttivo
 è a livello personalistico
dimensione
somatica
dimensione
spirituale
dimensione
psichica
SESSUALITA’
 Dimensione costitutiva dell’essere umano
 Capacità di vivere e relazionarsi attraverso il proprio sesso,
dimensione originaria e strutturale della persona
La persona è un “io” aperto al “tu”, è un “essere in relazione”,
e la sessualità possiede una essenziale dimensione relazionale.
E’ il segno e il luogo dell’apertura, dell’incontro, del dialogo,
della comunicazione e dell’unità delle persone tra loro.
sessualità come bisogno di uscire dalla propria
solitudine, di comunicare con gli altri,
di ritrovarsi negli altri.
DOMANDE FONDAMENTALI
(tempo dell’essere, tempo dell’esistere)
n COME VIVO IO …
l’essere sessuato, la sessualità?
Cosa sento, provo e di cosa e come voglio parlarne ad un altro/a
di cui sono responsabile come genitore ed educatore?
o COME VIVIAMO NOI …
in quanto coniugi o educatore l’essere sessuati, la sessualità?
Cosa proviamo, sentiamo e cosa e come voglio parlarne tra di
noi e con nostro figlio/a o alunno/a?
p COME VORREI CHE VIVESSE …
questo figlio/a l’essere sessuato, la sessualità?
Cosa vorrei che provasse, sentisse affinché nel crescere diventi
una persona consapevole e completa?
D. Galardi, A. Dedè, Come parlare della sessualità, Piemme 1994
FORMAZIONE
IDENTITA’ SESSUATA
IDENTITA’ SESSUATA
DEFINIZIONE
“ La capacità del soggetto di auto-rappresentarsi
e percepirsi come soggetto unitario, con
caratteristiche e qualità stabili, permanenti e
diverse da quelle altrui. Si tratta di un cammino,
di una conquista, che esige la capacità
dell’individuo di assumere questa coscienza e
consapevolezza. “
M.L. Di Pietro, Educare all’identità sessuata, La Scuola, Brescia 2000.
dimensione biologica
IDENTITA’ SESSUATA
dimensione psicologica
dimensione spirituale
dimensione sociale
IDENTITA’ SESSUALE
dimensione biologica
dimensione psicologica
IDENTITA’ di GENERE
dimensione socio culturale
modificata da: M.L. Di Pietro, Educare all’identità sessuata, La Scuola, Brescia 2000
SVILUPPO SESSUALE
1
SESSO
GENETICO
zigote con cariotipo maschile (46,XY)
zigote con cariotipo femminile (46,XX)
2
SESSO
GONADICO
differenziazione gonadi: testicoli o ovaie
3
SESSO
ORMONALE
6a-8a settimana: androgeni (tessuto testicolare)
estrogeni (tessuto ovarico)
4
SESSO
DUTTALE
5
SESSO
FENOTIPICO
sviluppo genitali esterni maschili
sviluppo genitali esterni femminili
6
SESSO
CEREBRALE
differenziazione strutturale di aree cerebrali
(neocortex: att. cognitive, esper. coscienti, …)
7
SESSO
PSICOLOGICO
8a settimana: sviluppo dotti di Wolff (♂)
regressione dotti di Muller (♂)
sviluppo dotti di Muller (♀)
percezione identità sessuata maschile e ruolo sessuato
percezione identità sessuata femminile e ruolo sessuato
SESSO
FATTORI
GENETICO
GONADICO
ORMONALE
MORFOLOGICO
MORFOLOGICI
FISICO-ESTETICI
PSICOLOGICI
CULTURALI
SOCIALI
PSICO-ESISTENZIALI
- Come sono fatto?
- Come mi sento?
- Come mi vivo?
- Come desidero essere considerato?
IDENTITA’ SESSUATA
Disarmonia
Sofferenza
CORPO come “REALTA’ NATURALE”
CORPO come “REALTA’ CULTURALE”
Armonia
Salute
ADOLESCENZA
Primo Periodo
(12-14 anni)
Secondo Periodo
(14-16 anni)
Terzo Periodo
(> 17 anni)
 rapido sviluppo e
 si ampliano i rapporti
 completamento dello
accrescimento fisico
 persistenza del legame
con l’ambiente familiare
 sorgono nuovi interessi
 primi innamoramenti
 spesso narcisismo con
iniziali atteggiamenti di
ribellione
con l’ambiente esterno
 primi rapporti sessuali i
 si accentua lo spirito
critico verso la società
 conflittualità verso i
genitori
sviluppo puberale
 definizione della
propria identità corporea
e del proprio ruolo
 persistenza, molto
spesso, di instabilità
psicologica
SVILUPPO CAPACITA’ AFFETTIVE
Rapporti umani
positivi
 capacità di
relazione
 riconoscere
l’altro come
persona
 irrilevanza
delle differenze
Relazioni
amichevoli
 condivisione
idee importanti
 condivisione
interessi
 reciproco
“specchiarsi”
Amicizia
Amore
 condivisione
 affinità piena
ideali e progetti
di vita
 differenze
complementari
 costante
complementarietà
 reciprocità in
ogni campo
ANTROPOLOGIE
ORIENTAMENTI ANTROPOLOGICI
Antropologia  S. Freud
“permissivista” Â W. Reich
 H. Marcuse
 S. De Beauvoir
Antropologia  A.C. Kinsey
“naturalistica” Â W.H. Masters, V.E. Johnson
Antropologia
“personalista
ontologista”
 Magistero della Chiesa
ANTROPOLOGIA “PERMISSIVISTA”
 pansessualismo
 sessualità come espressione e struttura della
S. Freud
personalità
 personalità come elaborazione dell’inconscio e dei
meccanismi di difesa
 sessualità come “energia vitale in sé” e “scarico degli
W. Reich
istinti”
 soddisfacimento del proprio piacere
 repressione sessuale come “repressione” per
antonomasia
 libertà sessuale e polimorfismo sessuale
H. Marcuse
 corpo come oggetto di piacere
 supremazia della genitalità sulla sessualità
 liberazione della donna e autoprogettarsi
S. De Beauvoir
 scissione femminilità-maternità
 maternità come danno
ANTROPOLOGIA “NATURALISTICA”
 visione weberiana della cultura
 determinismo sociologico
A.C. Kinsey
 equazione tra l’essere (is) ed il dover essere (ought)
 norma statistica come criterio regolativo della
condotta sessuale
 atto sessuale come sola dimensione biologica
W.H. Masters
V.E. Johnson
 atto sessuale come reazioni misurabili
 terapie comportamentali
ANTROPOLOGIA PERSONALISTA ONTOLOGISTA
CONCEZIONE PLENARIA DELLA
SESSUALITA’
unitotalità della persona
(corpo, psiche e spirito)
apertura e oblatività della persona
complementarietà
dimensione unitiva e procreativa
trascendenza
(oltre il sé, verso l’altro e verso
l’oltre)
sacramentalità
FUNZIONE
come negli stadi inferiori della vita,
attraverso la complessità dei
fenomeni biologici e sensoriali,
assicura la continuità della specie
SIGNIFICATO
profondamente umano:
- capacità di conoscenza
- autocoscienza
- libertà e responsabilità
- socialità
- trascendenza
ANTROPOLOGIA PERSONALISTA ONTOLOGISTA
DIMENSIONE STRUTTURALE
il corpo umano esiste differenziato
in un corpo maschile e femminile
che tipizza la totalità della persona
DIMENSIONE ORIGINARIA
l’esistenza personale è filtrata
attraverso l’esperienza originaria
(fin dal concepimento si è maschio
o femmina) della propria
mascolinità o femminilità
DIMENSIONE ORIGINALE
essere uomo o donna è diverso
dall’essere maschio o femmina e
sottolinea la diversità sostanziale
nell’essere uomo o donna rispetto
all’essere maschio o femmina
nell’animale
DIMENSIONE PERSONALE
richiama la totalità della persona
come sinolo e tutta la persona è
sessuata: persona maschio o
femmina
DIMENSIONE
INTERPERSONALE
evidenzia la reciprocità dell’essere
sessuato, maschio o femmina, che
necessita dell’incontro e del dialogo
con l’altro (identità e alterità, unità e
dualità)
DIMENSIONE TRASCENDENTE
rappresenta un invito ad andare
oltre l’esperienza del finito come
apertura all’infinito
Perché ?
Fino a quando ?
Come ?
Fino a che punto ?
E’ possibile ?
Che cosa è ?
Come è ?
Ideologia ?
SESSUALITA’ - VITALITA’ - GIOIA DI ESSERE
SESSO - VITALISMO - EDONISMO
VITALITA’: slancio di essere
VITALISMO: iperattivismo di una funzione vissuta come
staccata dal contesto vitale
FORZA DELL’AMORE
AMORE DELLA FORZA
desiderio dell’altro
donazione per l’altro
conquista
grazia
autoaffermazione
determinato dal fascino
dell’altro e dalla bellezza
amore disinteressato e
dono di sé
amore ed accettazione
dell’altro, trasfigurandolo
desiderio di possesso
donazione gioiosa
“L’esercizio della sessualità fa intravedere l’altro, al di
là dell’altro, in ogni esperienza di incontro d’amore”
bellezza
potenza
infinito di
libertà
gaudio
comune-unione
S. Palumbieri, Antropologia e sessualità, S.E.I., 1996
PATOLOGIE DELL’AMORE
Anemia
senza il sangue dell’entusiasmo
Astenia
senza l’energia della volontà
Anoressia
Afasia
Asfissia
Cardiopatia
senza l’appetito dei valori
senza l’esercizio della comunicazione
senza la tensione della speranza
senza la funzione del “cuore di carne”
S. Palumbieri, Antropologia e sessualità, S.E.I., 1996
“dimmi come ami e ti dirò come conosci”
con-nascere
con-crescere
con-soffrire
con-godere
con-vibrare
con-aspirare
con-lottare
S. Palumbieri, Antropologia e sessualità, S.E.I., 1996
“Amo ergo sum”
(E. Mounier)