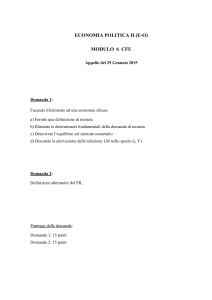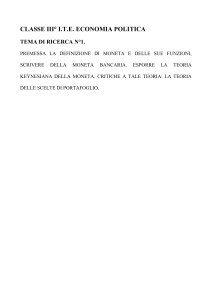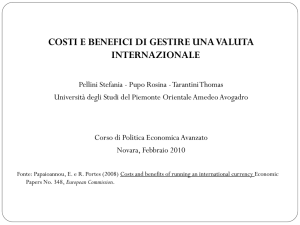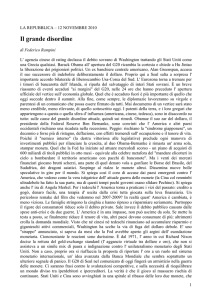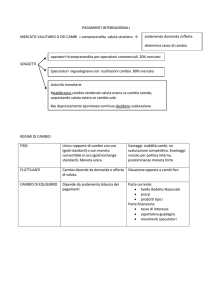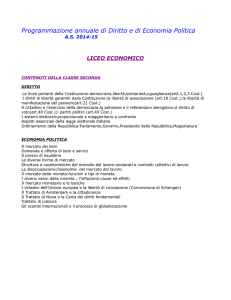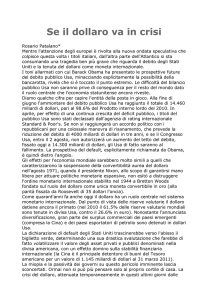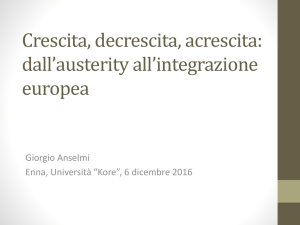LE
TEMPESTE
VALUTARIE
NELLA
STORIA:
OPPORTUNITA’ DEGLI INVESTIMENTI IN VALUTA
RISCHI
ED
Il 14 settembre 2010 un sintetico lancio di agenzia stampa ha annunciato il ritorno agli interventi
diretti sulla moneta nipponica da parte della Bank of Japan (BOJ), dopo sei anni di sostanziale
inattività: “Il dollaro balza di oltre due yen, dai minimi del 1995, grazie all’operato delle autorità
giapponesi che sono intervenute vendendo yen e comperando dollari americani”. Il ministro delle
finanze Yoshihiko Noda, di concerto con il governatore della BOJ Maasaki Shirakawa, nella stessa
data non ha escluso che a tale intervento ne possano seguire degli altri dello stesso tenore, qualora le
pressioni rivalutative sullo yen dovessero proseguire. L’intervento, secondo quanto affermato dalle
stesse autorità nipponiche, si era reso necessario in seguito al continuo apprezzamento dello yen nei
confronti del biglietto verde, giunto ai massimi livelli dal 1995 e cresciuto dall’inizio dell’anno di
oltre il 10%. Tali avvenimenti richiamano con forte analogia quanto accaduto nel marzo del 2009,
quando la Banca Nazionale Svizzera intervenne sul mercato valutario acquistando euro e dollari
contro franchi svizzeri per contrastare l’apprezzamento della propria divisa nei confronti del
biglietto verde e della moneta unica. Già in quell’occasione numerosi economisti, tra i quali il
professor Wyplosz dell’Università di Ginevra, lanciarono un monito contro tale intervento,
catalogato con il termine di “svalutazione competitiva”. Gli strali del gruppo di economisti erano
rivolti contro l’intervento unilaterale da parte della Banca Centrale mirato al deprezzamento della
propria divisa: se da un lato infatti esso avrebbe potuto portare ad un beneficio immediato
all’industria nazionale, favorendone la competitività sul mercato globale a tutto vantaggio delle
proprie esportazioni, dall’altro avrebbe indotto altri Paesi a ricorrere al medesimo intervento, ma di
segno opposto, innescando una pericolosa “guerra valutaria” fatta di interventi monetari
contrapposti chiamati appunto “svalutazioni competitive”. Se vi è un consenso pressoché unanime
sul fatto che tali interventi rappresentino un’arma a doppio taglio evidenziando nel tempo la loro
vacuità, sorge spontaneo l’interrogativo sulle ragioni che li giustifichino, cioè che in ultima analisi
ne motivino la messa in atto. Indagare su tali ragioni non ha un esclusivo fine di natura accademica,
bensì una logica ben più concreta ed operativa, considerate le conseguenze che tali interventi
comportano sul mercato delle valute, di gran lunga il più gigantesco mercato di scambi al mondo
(poco meno di 4.000 miliardi $ al giorno). Ciò non coinvolge esclusivamente tutte le aziende che
hanno un interscambio di natura commerciale con Paesi al di fuori della propria area valutaria, bensì
tutti gli investitori (piccoli e grandi) che in qualche misura presentano un’esposizione del proprio
portafoglio in divisa estera. Per meglio interpretare gli accadimenti di questi ultimi mesi ed
avanzare delle ipotesi ragionevoli in termini previsionali si rende necessaria una disamina storica
degli andamenti valutari; a tale fine si procederà attraverso i seguenti punti:
1. Le oscillazioni valutarie dalla Grande Depressione al 2000: analisi storica
2. L’avvento dell’euro e la crisi degli ultimi anni
3. Investire in valuta: determinanti, rischi ed opportunità
1. La moneta non è una merce qualsiasi, bensì è il mezzo di scambio universale. In altri
termini, il valore della moneta ha delle conseguenze dirette ed immediate sul valore dei beni
e servizi per la compravendita dei quali essa viene utilizzata ed universalmente accettata.
Nei testi accademici si possono facilmente reperire le tre funzioni esclusive della moneta:
mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore. La moneta, in qualità di bene, non
1
sfugge però alle determinanti della legge sulla domanda e l’offerta; trattandosi del “bene dei
beni” (cioè del bene attraverso il quale tutti gli altri beni e servizi acquisiscono o perdono
valore), il controllo su di essa è deputato ad un’autorità pubblica, solitamente la banca
centrale, a cui è demandato il compito di salvaguardarne il valore relativo, preservando il
sistema economico e produttivo dalle nefaste conseguenze derivanti dal depauperamento del
suo valore, fenomeno noto con il termine “inflazione”. L’influenza della moneta all’interno
del sistema economico moderno si rivela quindi immensa e con essa quella delle autorità che
detengono le leve per esercitare su di essa il potere di emissione e di controllo, il cosiddetto
signoraggio, chiamato in tale modo dal diritto di battere moneta che i signori medioevali si
attribuivano per rendersi indipendenti dai sovrani. La storia della moneta è quindi costellata
da numerose battaglie per l’accaparramento del potere di signoraggio e per l’affermazione
della supremazia di una moneta rispetto ad un’altra. L’analisi storica evolutiva della moneta
esula dall’argomento di questa disamina, quindi ci limiteremo ad osservare gli accadimenti
monetari di maggiore rilievo dell’ultimo secolo, in quanto propedeutici alla comprensione
dello scenario attuale. Essi sono i seguenti:
a. La situazione post-bellica degli anni Venti
b. L’anarchia monetaria degli anni Trenta
c. Gli accordi di Bretton Woods
d. L’abbandono definitivo del gold exchange
e. La crisi degli anni Settanta
f. Lo SME e l’accordo del Plaza
g. L’attacco alla lira e alla sterlina
h. Il fallimento della dollarizzazione
a. Al termine della Prima Guerra Mondiale, i Paesi vincitori (Francia, Regno Unito e
Russia) impedirono la creazione di un sistema monetario internazionale fondato su
nuove regole condivise, ponendo sulle spalle dei vinti (Germania ed Austria) un
fardello di debiti di guerra insostenibili per le loro casse. Ciò portò questi ultimi a
favorire consapevolmente il deprezzamento della propria moneta (il marco tedesco)
attraverso l’aumento vertiginoso e scollegato dai fondamentali della quantità di
circolante. Se da un lato questo deprezzamento indotto produsse l’effetto positivo per
la Germania di svalutare il proprio debito, dall’altro esso fu alla radice
dell’impennata inflativa che si tradusse nel fenomeno iperinflativo tedesco degli anni
Venti. In seguito a tale evento disastroso che lasciò un segno indelebile per il popolo
tedesco, le principali potenze decisero di restaurare il regime monetario ante-guerra:
il gold standard. Il valore delle diverse monete nazionali venne così determinato in
un rapporto fisso rispetto all’oro e l’obiettivo esclusivo delle politiche monetarie
tornò ad essere quello di garantire la stabilità del valore aureo delle monete. In un
gold standard puro, cioè di piena convertibilità tra l’oro e la moneta circolante, la
quantità di moneta non può eccedere la quantità di oro posseduta dal Paese; i
pagamenti internazionali vengono effettuati in oro e le monete non sono altro che
simboli delle quantità di oro depositate presso i forzieri delle rispettive nazioni. La
condizione indispensabile per il corretto funzionamento di questo regime è la libera
circolazione dei capitali, perché sono proprio i movimenti di capitale a riequilibrare
2
gli assetti: una riduzione della quantità di oro conseguente ad un deficit commerciale
con l’estero produce una riduzione dell’offerta di moneta e quindi un aumento dei
tassi di interesse; l’afflusso di capitale finanziario alla ricerca di maggiori rendimenti
garantirà il ritorno della quantità di moneta verso le condizioni iniziali. Tuttavia, se il
gold standard definito inizialmente (valore nominale della moneta rispetto all’oro) è
scorretto, i movimenti di capitale non possono riportare il sistema in una condizione
di equilibrio; in tale caso occorre una completa flessibilità del sistema interno dei
prezzi che fungerà da riequilibrio monetario. Il gold standard degli anni Venti aveva
introdotto dei gradi di flessibilità rispetto al sistema puro appena descritto, in quanto
consentiva di determinare il valore della moneta nazionale non solo rispetto all’oro,
bensì anche rispetto alla sterlina e al dollaro, che a loro volta garantivano la piena
convertibilità aurea: questo è il motivo per cui venne denominato gold exchange
standard.
b. Il ritorno al gold exchange standard durò solamente alcuni anni, aprendo una
successiva fase di anarchia nelle relazioni economiche e commerciali internazionali.
A minare la sostenibilità del sistema monetario di convertibilità aurea fu
principalmente la mancanza di volontà politica nell’accettare che il livello dei prezzi
fungesse da stabilizzatore dell’errato valore di convertibilità aurea stabilito per
numerose monete. Il Regno Unito decise di tornare alla parità aurea della sterlina
precedente al conflitto bellico anche se tale valore risultava grandemente
sopravvalutato: il motivo di ciò era la volontà politica londinese di salvaguardare la
City, il cui ruolo finanziario era risultato dominante e fonte di enormi guadagni e di
grande potere nel mezzo secolo precedente la Grande Guerra. Come introdotto nel
punto precedente, a tale sopravvalutazione monetaria avrebbe dovuto fare da
contraltare una consistente deflazione; essa però fu impedita dai movimenti
sindacali, che rafforzarono il loro peso nella seconda metà degli anni Venti. Per
tornare in equilibrio il sistema mondiale avrebbe dovuto prevedere un processo di
inflazione negli Stati Uniti e di deflazione in Europa e un movimento di capitali in
uscita dai mercati finanziari statunitensi verso quelli europei. In realtà avvenne
esattamente il contrario, in quanto gli Stati Uniti conobbero negli anni Venti un
boom economico significativo senza tensioni inflative, attirando capitali da tutto il
mondo. Quando la bolla speculativa scoppiò, nell’ottobre del 1929, fu l’intero
sistema finanziario ed economico del mondo a subire pesanti conseguenze in termini
sia di produzione che di disoccupazione: fu l’inizio della Grande Depressione degli
anni Trenta. La crisi portò i principali Paesi all’insostenibilità del gold standard: il
21 settembre 1931 il Regno Unito sospese la convertibilità della sterlina in oro,
innescando una reazione a catena da parte dei principali Paesi europei; un anno e
mezzo più tardi anche gli Stati Uniti abbandonarono il tallone aureo mettendo fine ad
ogni traccia di convertibilità aurea. Da quel momento in avanti, fino allo scoppio
della Seconda Guerra Mondiale, il sistema economico internazionale attraversò una
fase di assoluta anarchia, dominata dalle svalutazioni competitive delle monete e da
sempre più pesanti restrizioni protezionistiche sia nel commercio di beni e servizi,
sia nei movimenti di capitale. Numerosi storici dell’economia intravvedono in queste
guerre valutarie e protezionistiche i prodromi del secondo conflitto bellico mondiale.
3
c. Quando la Seconda Guerra Mondiale stava volgendo al termine, ed i suoi destini
parevano segnati, i delegati dei principali Paesi del mondo si riunirono in una
cittadina americana del New Hampshire, Bretton Woods, per riordinare il sistema
economico e monetario internazionale. Le ipotesi di riforma che ricevettero il
maggiore consenso furono due. La prima, presentata dal prestigioso economista
inglese Keynes, prevedeva l’istituzione di una moneta mondiale il cui rapporto con
l’oro sarebbe dovuto risultare variabile; tale proposta prevedeva la creazione di una
Banca Centrale Mondiale con il potere di erogazione di prestiti e quindi di creazione
di credito internazionale, finalizzato al sostegno, allo sviluppo e alla stabilizzazione
del ciclo economico. La seconda, presentata da White, capo della delegazione
statunitense, si basava anch’essa sulla creazione di un nuovo organismo
internazionale, ma con funzioni ben più limitate rispetto alla proposta inglese. La
proposta americana non prevedeva la creazione di alcuna nuova moneta mondiale,
bensì l’istituzione del dollaro come valuta di riserva internazionale, fissando il
concambio tra il biglietto verde e l’oro. Il mondo scelse la strada indicata dalla
delegazione americana ed il 22 luglio 1944 vennero firmati gli accordi di Bretton
Woods: si adottò un regime di cambi fissi basato sulla convertibilità mondiale del
dollaro statunitense in oro al prezzo di 35 dollari per oncia, con possibilità di
modifica delle parità delle valute in caso di squilibrio strutturale delle bilance dei
pagamenti, in caso di modifiche superiori al 10% delle parità prefissate. Gli accordi
di Bretton Woods suggellarono la posizione dominante degli Stati Uniti nel mondo a
livello politico, economico, militare, sancendo la supremazia monetaria del dollaro
rispetto a tutte le altre monete: il dollar exchange standard. Lungo tutti gli anni
Cinquanta il sistema funzionò: gli Stati Uniti finanziarono il processo di
ricostruzione delle economie europea e giapponese attraverso aiuti unilaterali,
surplus commerciali e movimenti di capitale a breve e lungo termine. La
preoccupazione maggiore di questo periodo fu la possibile carenza di dollari rispetto
alle esigenze espansive del commercio internazionale: dato che la produzione aurea
cresceva molto più lentamente rispetto alla crescita del commercio internazionale, la
domanda di dollari come mezzo di pagamento era in costante aumento. Nel 1960
l’economista Triffin analizzò lo scarto tra la dinamica della produzione aurea e
quella dell’espansione del commercio internazionale, evidenziando un problema di
lungo periodo per il dollar exchange standard: l’affidabilità. Considerata
l’inelasticità dell’offerta di oro, il rapporto tra la quantità di dollari detenuti dalle
Banche Centrali come riserva e dagli operatori come mezzo di pagamento da una
parte e la quantità di oro detenuta dalle autorità americane dall’altra, era destinato a
crescere, superando nel tempo la soglia critica del rapporto di parità. In altri termini,
la spinta verso ritmi di crescita sempre maggiori per l’economia mondiale avrebbe di
fatto reso insostenibile il dollar exchange standard. Secondo Triffin, qualora questo
fosse accaduto nessuno avrebbe più potuto garantire la convertibilità dollaro-oro,
innescando una potenziale perdita di fiducia nel biglietto verde.
d. Il problema proposto da Triffin fu sottovalutato per un decennio, anche se gli Stati
Uniti dal 1959 iniziarono ad accumulare deficit commerciale, in quanto le economie
europea e giapponese avevano recuperato completamente la competitività post
4
conflitto, marciando a ritmi di crescita sostenuti. L’aumento della spesa pubblica
statunitense derivante dal sempre più massiccio intervento in Vietnam finanziato
dall’incremento dell’offerta di moneta poneva le basi per un processo inflativo che
confliggeva con l’obbligo imposto dalla convertibilità aurea. La fiducia nei confronti
del dollaro iniziò a scricchiolare e l’azione della speculazione rese la situazione
insostenibile; il 15 agosto 1971 il presidente Nixon annunciò la decisione unilaterale
di interrompere la convertibilità aurea ed impose un sovra dazio d’importazione del
10% per impedire che i prodotti americani continuassero a subire uno svantaggio a
causa dei tassi di cambio sleali applicati dalle altre autorità monetarie mondiali. Con
queste decisioni unilaterali gli Stati Uniti decretarono il tramonto definitivo del
sistema monetario disegnato a Bretton Woods. La decisione di svalutare il dollaro
assunta dal presidente Nixon fu l’esito di una prova di forza in cui gli Stati Uniti
riaffermarono la loro posizione di assoluta egemonia sull’intero sistema economico
mondiale: sganciando il dollaro dall’oro, infatti, gli Stati Uniti eliminarono ogni
vincolo dalla loro politica economica senza rinunciare al privilegio assoluto che la
posizione centrale assunta dal biglietto verde avrebbe garantito loro a livello globale:
è l’affermazione del cosiddetto dollar standard. Nel 1971 la possibilità per le altre
valute di sostituire in tempi brevi il dollaro nel mercato mondiale era pressoché
nulla: nessun Paese era paragonabile agli Stati Uniti nello scacchiere internazionale,
né per economia, né per mercato finanziario o solidità sistemica e geopolitica; inoltre
il Giappone e la Germania, le uniche nazioni che avrebbero potuto aspirare ad un
ruolo maggiore per le loro monete, risultavano estremamente riluttanti ad agire in
questa direzione per evitare di danneggiare le relative economie, la cui forza
dipendeva in maniera considerevole dalle esportazioni verso il resto del mondo.
e. Negli anni successivi alla storica decisione di Nixon, il dollaro subì un significativo
deprezzamento, articolato in tre fasi: nel 1971, nel 1973 e nel biennio 1977-78.
Mentre nel 1971 il deprezzamento del biglietto verde fu perseguito come un
aggiustamento strutturale per recuperare la competitività perduta, i deprezzamenti
successivi costituirono la specifica risposta allo shock petrolifero del 1973,
configurandosi come una risposta delle autorità monetarie statunitensi alla crisi
economica di quel periodo.
5
La prima grande svalutazione del dollaro: da 3.20 a 2.30 marchi tra febbraio e giugno 1973
Gli effetti di questo orientamento della politica monetaria statunitense furono
duplici: se da un lato si determinò un sostanziale miglioramento della competitività
internazionale degli Stati Uniti, dall’altro si innescò una spirale inflativa che investì
tutto il sistema capitalistico nel corso degli anni Settanta. Le altre economie
industriali, infatti, per evitare di sopportare l’intero peso della crisi economica,
seguirono l’indirizzo espansivo nella politica monetaria, alimentando in tale modo
una crescente instabilità valutaria, finanziaria e commerciale a livello globale. Nel
1978 sui mercati finanziari mondiali iniziarono a manifestarsi chiari segni di una
crisi di fiducia nei confronti del dollaro; fu in questa situazione che si manifestò un
secondo shock petrolifero che produsse un aumento di oltre il 200% del valore del
greggio. In questa occasione, però, le autorità monetarie statunitensi adottarono un
atteggiamento fortemente restrittivo che fece salire i tassi di interesse provocando un
significativo apprezzamento del dollaro.
f. I numerosi shock valutari ed inflativi degli anni Settanta indussero la maggior parte
delle nazioni europee ad aderire ad un progetto comune di natura monetaria: il
Sistema Monetario Europeo. Tale accordo, stipulato nel marzo 1979, prevedeva il
vincolo reciproco di fluttuazione tra le rispettive monete all’interno di una banda di
oscillazione molto stretta (+/-2.25%) e l’introduzione di una moneta di calcolo
comune, l’Ecu (european currency unit). Nei primi anni Ottanta, come indicato nel
punto precedente, il dollaro americano si rivalutò significativamente nei confronti
delle principali monete estere a causa degli interventi fortemente restrittivi messi in
atto dalle autorità monetarie a stelle e strisce. Ciò causò non poche difficoltà
all’industria statunitense, alimentando un crescente deficit commerciale degli Stati
Uniti. Il 22 settembre 1985 all’hotel Plaza di New York si riunì il gruppo dei cinque
principali Paesi più industrializzati (Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e
Regno Unito) per definire un riordino valutario: essi concordarono sulla necessità di
un deprezzamento del biglietto verde, che, come si può osservare nel grafico
sottostante, non tardò a manifestarsi.
6
Svalutazione del dollaro post accordi del Plaza: da 3 a 1.5 marchi tra il 1985 e il 1987
g. Le divergenze economiche strutturali esistenti tra i Paesi aderenti al Sistema
Monetario Europeo emersero agli inizi degli anni Novanta, quando la lira italiana
(come si può osservare nel grafico sottostante) e la sterlina inglese, dopo un violento
attacco speculativo messo in atto dal noto finanziere Soros, operarono una
consistente svalutazione.
Grafico weekly del cross lira italiana/dollaro nel 1992
Nell’agosto 1993 i paesi appartenenti al Sistema Monetario Europeo decisero di
estendere provvisoriamente i margini di oscillazione delle proprie monete al 15%.
Nel frattempo, allo scopo di evitare in futuro forti fluttuazioni dei tassi di cambio fra
le monete europee e di eliminare le svalutazioni competitive, i governi dell’Unione
Europea decisero di rilanciare il progetto di una vera e propria unione monetaria,
cioè di progettare una vera e propria moneta unica; tale piano nell’arco di un
decennio avrebbe portato alla costituzione dell’Unione Monetaria e alla introduzione
dell’euro.
h. Durante gli anni Novanta gli Stati Uniti rafforzarono la loro leadership a livello
mondiale anche in seguito al crollo della superpotenza sovietica. Numerosi Paesi
7
emergenti presero quindi l’economia a stelle e strisce come modello, cercando di
seguirne i passi: la ricerca della stabilità portò tali nazioni alla cosiddetta
“dollarizzazione”, cioè la definizione di un legame molto forte tra le loro valute ed il
dollaro americano al fine di evitare fenomeni iperinflativi. Nei primi anni Novanta
questi approcci sembravano aver ottenuto successo: i Paesi emergenti riuscirono a
tenere sotto controllo l’inflazione e la spesa pubblica, modificando però il ruolo dello
stato nell’economia ed iniziando una forte ondata di privatizzazioni. Ben presto,
però, scoppiò un’ondata di crisi: nel 1995 in Messico, nel 1997 nel sud-est asiatico,
nel 1998 in Russia, nel 1999 in Brasile e nel 2001 in Argentina. Tutte queste crisi, le
cui caratteristiche e peculiarità evidenziavano dei distinguo, avevano come minimo
comune denominatore le nefaste conseguenze del forzato ancoraggio della valuta
nazionale al dollaro statunitense. I differenti passi di crescita delle diverse economie
nazionali dimostrarono l’insostenibilità sia del cambio fisso (hard peg) che dei
cambi intermedi (crawling peg) verso la valuta di un altro Paese (in questo caso il
dollaro) in assenza di un’effettiva integrazione fiscale, monetaria ed economica; essi
vennero abbandonati in seguito a pesanti crisi valutarie e del debito privato e
governativo.
2. L’euro è la moneta unica di sedici Paesi europei che vi hanno aderito attraverso un percorso
durato decenni che ha preso avvio dopo la Seconda Guerra Mondiale, è passato attraverso la
costituzione della Comunità Economica Europea (CEE), del Serpente Monetario Europeo
(SME) trasformatosi in Sistema Monetario Europeo da cui, come è stato analizzato nel
punto precedente, è nato l’Ecu. Il progetto di introduzione della moneta unica come valuta
circolante prese avvio all’inizio degli anni Novanta, quando venne stipulato lo storico
Trattato di Maastricht (1992), dal nome della cittadina olandese in cui venne firmato, che
stabilì le condizioni vincolanti per la transizione dalle valute nazionali alla nuova valuta
unica, che prese il nome di Euro. Si trattava di cinque criteri chiamati “parametri di
Maastricht”, il cui obiettivo era la convergenza delle diverse economie nazionali verso un
modello di riferimento più uniforme e virtuoso. I parametri presi a riferimento furono
monetari (inflazione), finanziari (tassi a lungo termine) e di finanza pubblica (deficit/PIL e
debito/PIL) oltre che di stabilità nel tempo (appartenenza allo SME da almeno due anni).
L’euro entrò in vigore per la prima volta il 1 gennaio 1999 in undici degli allora quindici
stati membri dell’Unione: in quella data esso fu introdotto per tutte le forme di pagamento
non fisiche (ad esempio, i trasferimenti elettronici, i titoli di credito), mentre le valute degli
stati partecipanti furono bloccate ad un tasso di conversione prefissato. L’euro è entrato
ufficialmente in circolazione, sotto forma di monete e banconote, a partire dal 1 gennaio
2002; da quel momento altri Paesi vi hanno aderito attraverso il rispetto del processo di
convergenza definito a Maastricht, e dal gennaio 2011 Eurolandia (l’area che identifica i
Paesi che hanno aderito al progetto della moneta unica) avrà un diciassettesimo membro:
l’Estonia. Si tratta quindi di un progetto aperto ed evolutivo; in un certo senso è un cantiere
aperto di natura monetaria che rispecchia l’auspicio di Keynes a Bretton Woods della
creazione di un’unica moneta mondiale; ciò malgrado l’edificio dell’euro nella crisi attuale
ha fatto segnare più di uno scricchiolio, evidenziando le difficoltà di un’area valutaria
8
composta da Paesi a distinte sovranità fiscali e finanziarie. Prima di entrare nel dettaglio
della situazione venutasi a creare nell’attuale crisi economica e finanziaria, è però utile
focalizzare l’attenzione sul fatto che, unitamente all’avvento dell’euro, il primo decennio del
nuovo secolo è stato caratterizzato dallo spostamento del potere economico verso l’est del
pianeta, e precisamente dall’affermazione della Cina come nuova superpotenza mondiale. I
suoi ritmi di crescita ed espansione hanno manifestato un trend di eccezionale durata ed
intensità fin dalla seconda metà degli anni Novanta; la maggiore parte degli economisti fa
risalire le origini di quest’affermazione a due eventi precisi: l’ancoraggio della moneta
cinese al dollaro statunitense (1995) e l’ingresso della Cina nell’Organizzazione del
Commercio Mondiale – WTO (2001). I due eventi, sebbene accaduti a distanza di anni,
devono essere analizzati congiuntamente, in quanto strettamente collegati tra loro; di essi ci
occuperemo all’interno della disamina evolutiva sulla situazione venutasi a creare durante
l’attuale crisi e sulle sue ripercussioni di natura valutaria; procederemo quindi
focalizzandoci sui seguenti punti:
a. Cina-USA: dagli interessi convergenti ai rapporti conflittuali
b. L’euro nella crisi di Eurolandia
c. Franco svizzero e yen da monete problematiche a “valute rifugio”
d. Una vittima eccellente della guerra valutaria: il real brasiliano
a. Il rapporto tra la Cina e gli Stati Uniti negli ultimi vent’anni è stato fondato su solide
basi di reciproco vantaggio: la Cina desiderava crescere economicamente per
affrancarsi dal sottosviluppo secolare, mentre gli Stati Uniti desideravano preservare
la propria supremazia economica mondiale, malgrado una sostanziale staticità della
produttività interna e una scolarizzazione e una competitività interna in declino. Gli
interessi di questi due grandi Paesi erano in effetti complementari: la Cina
abbisognava di un vorace mercato di sbocco della propria produzione e gli Stati
Uniti necessitavano di delocalizzare la produzione per calmierare un’inflazione che a
causa dei crescenti prezzi delle materie prime avrebbe potuto rialzare la testa. Il
soddisfacimento di queste esigenze portò alla definizione di accordi valutari e
commerciali che si sono rivelati fonte di instabilità a livello sistemico: il peg del
yuan con il dollaro e l’ingresso del colosso cinese nel WTO. Per quanto attiene
all’ancoraggio valutario, dal 1995 fino al 2005 la Cina mantenne un ancoraggio
stretto yuan-dollaro; nel 2005 decise di riformare il proprio sistema di cambio.
L’operazione si articolò in tre mosse: rivalutazione secca del 2,1% sulla moneta
americana; sganciamento immediato dal biglietto verde; nuovo ancoraggio dello
yuan a un paniere valutario di cui Pechino non ha mai svelato la composizione
(crawling peg). Da quel momento fino all’agosto del 2008 la moneta cinese si
rivalutò del 18% circa nei confronti del biglietto verde, ma, a causa dell’avvento
della crisi, in quella data il Celeste Impero congelò le oscillazioni valutarie
ancorando nuovamente la propria valuta al dollaro americano. Nel giugno di
quest’anno la Cina ha deciso di ritornare alla situazione precedente (crawling peg) e
da quel momento il yuan si è rivalutato nei confronti del dollaro statunitense del 2%
circa. Dietro questi numerosi interventi di natura valutaria vi è un rapporto
squilibrato tra i due giganti sino-americani che sta alla base della crisi sistemica degli
9
ultimi anni: l’eccesso produttivo cinese e l’eccesso di consumo americano. Se per
alcuni anni per entrambe le superpotenze tale situazione era non solo sostenibile ma
per certi versi anche auspicabile, l’esplosione della crisi ha fatto emergere la stretta
relazione esistente tra la forte crescita economica cinese e l’alta disoccupazione
americana: la cosiddetta 10%-10% rule, le cui percentuali identiche rappresentano la
prima il tasso di crescita dell’economia cinese e la seconda il tasso di disoccupazione
statunitense. D’altro canto l’assoluta pervicacia con cui la Cina ha perseguito la
politica del crawling peg mantenendo artificialmente basso il valore del yuan è
costata al gigante asiatico un prezzo significativo in termini di accumulo di riserve
monetarie in dollari. La Cina cioè, per preservare il mercato statunitense come
mercato principale di sbocco delle proprie merci, ha accettato per anni ingenti
pagamenti in dollari che hanno accresciuto le sue riserve nazionali: dal 2010 la Cina
è il principale creditore degli Stati Uniti, detenendo nelle sue mani titoli del Tesoro
americano per 900 miliardi $. L’insostenibilità di tale rapporto incestuoso sta ora
emergendo in tutta la sua pericolosità: la Camera degli Stati Uniti, a larghissima
maggioranza, ha recentemente approvato un progetto di legge che autorizza il
governo americano ad imporre sanzioni commerciali contro i Paesi che mantengono
intenzionalmente basso il valore della propria valuta, con un chiaro riferimento alla
sottovalutazione artificiale del yuan cinese. La Cina, dal canto suo, ha risposto che
tale decisione americana, qualora diventasse operativa, oltre che violare gli accordi
del WTO, lederebbe gravemente le relazioni esistenti tra i due Paesi, precisando per
bocca del suo stesso premier, Wen Jiabao, che “un eccessivo apprezzamento del
yuan potrebbe fare crollare le esportazioni del Celeste Impero, creando
disoccupazione e disordini sociali”. In effetti il dissenso da parte di molti nasce
proprio dall’ingresso della Cina nel WTO: esso avvenne nel 2001, dopo l’attacco alle
Torri Gemelle e nel pieno della crisi finanziaria della new economy a stelle e strisce.
In quel preciso momento storico furono intenzionalmente gli Stati Uniti a favorire
l’ingresso del gigante asiatico nell’Organizzazione del Commercio Mondiale, e ciò
fu fatto per incentivare gli scambi commerciali ed aiutare la ripresa economica
mondiale. La Cina però in sostanza da quel momento si trovò in una condizione di
vantaggio competitivo rispetto alle altre nazioni, avendo libero accesso ai loro
mercati, pur mantenendo il privilegio del crawling peg del yuan, mettendo in atto
sostanzialmente il protezionismo valutario.
b. Dalla sua costituzione fino al 2008 l’euro ha conosciuto un apprezzamento costante
nei confronti del dollaro statunitense: in circa sette anni (dal 2001 al 2008) l’entità
del movimento è stata straordinaria (100% circa) e praticamente, escludendo il 2005,
senza soluzione di continuità. I motivi di tale processo sono stati molteplici: tra i più
importanti identifichiamo la politica monetaria fortemente espansiva operata dalla
Federal Reserve e l’affermazione dell’euro come moneta rifugio vista la coesione e
la stabilità economica evidenziata da Eurolandia dalla sua costituzione. Vi è stata,
secondo alcuni economisti, una ragione in più rispetto a quelle appena enunciate: si
tratta di una specie di patto strategico tra gli Stati Uniti e la Cina di riversare su
Eurolandia e sull’euro le conseguenze dei propri squilibri valutari e commerciali. Per
comprendere questa considerazione è necessario ritornare a quanto indicato nel
10
punto precedente: enormi flussi finanziari e commerciali sino-americani avrebbero
dovuto spingere a rialzo il yuan verso il dollaro, ma ciò non è accaduto, considerato
il crawling peg esistente tra queste due valute; anzi, la forte rivalutazione dell’euro
nei confronti del dollaro, ha determinato un apprezzamento della moneta unica anche
verso il yuan cinese. Tutto ciò, ovviamente, avveniva mentre i flussi commerciali
dalla Cina verso Eurolandia salivano di intensità e quindi in aperto contrasto con la
normale legge di riequilibrio valutario che avrebbe invece portato il yuan ad
apprezzarsi contro l’euro. Le conseguenze negative di tale paradossale situazione
vennero analizzate da un documento della Confindustria tedesca, uno dei maggiori
centri di potere privato mondiali, che nel 2007 lanciò l’“allarme insostenibilità” per
l’apparato produttivo teutonico con un euro stabilmente sopra il cross di 1.50 contro
dollaro (in presenza di un ancoraggio stretto yuan-biglietto verde). Tale situazione è
mutata radicalmente a partire dall’ultimo trimestre del 2008, in quanto la fase più
acuta della crisi finanziaria è stata accompagnata da una significativa rivalutazione
del dollaro americano verso l’euro. Si è trattato di un tipico movimento di rientro dei
capitali nell’area dollaro, considerata safe heaven per eccellenza nei periodi di
straordinaria tensione finanziaria. Tale processo, dopo avere portato il cross
euro/dollaro in area 1.25 all’inizio del 2009, ha segnato una battuta d’arresto nello
stesso anno grazie alla sensazione di scampato pericolo sistemico, ma si è riproposto
con una rinnovata forza nel 2010, quando i mercati finanziari hanno vissuto la crisi
del debito greco. Si è trattato a tutti gli effetti di un bailout dello stato ellenico da
parte dell’Europa, ma ciò si è concretizzato dopo una lunga e difficile fase negoziale
tra i Paesi di Eurolandia, la Banca Centrale Europea ed il Fondo Monetario
Internazionale. Gli operatori del mercato valutario, nel frattempo, riconoscendo che
il progetto della moneta unica non poteva più essere considerato a senso unico,
hanno venduto euro portando il suo cross contro dollaro ad un valore di 1.18. Da
quel momento, e si tratta di storia recente (nel terzo trimestre 2010), la Federal
Reserve ha annunciato che si sarebbe adoperata con misure non convenzionali di
allentamento monetario (quantitative easing) al fine di sostenere il processo di
crescita dell’economia a stelle e strisce: di fronte ad un potenziale shock di offerta il
dollaro ha ripreso il suo rapido cammino di deprezzamento riportandosi a oltre 1.35
contro euro.
c. Nel punto precedente si è compreso come le tre principali Aree valutarie del mondo
(Stati Uniti, Cina e Eurolandia) hanno contrastato l’apprezzamento o addirittura
favorito il deprezzamento della propria valuta con il chiaro intento di sussidiare le
proprie esportazioni ed in tale modo la propria economia rispetto a quella dei
competitor. Considerato che tali svalutazioni competitive sono state accompagnate
da un ingente aumento della massa monetaria in circolazione, non sorprende
constatare che la pressione rivalutativa si è di volta in volta riversata su altre valute,
rappresentative di economie più piccole e masse monetarie inferiori rispetto ai tre
colossi valutari mondiali. E’ il caso, già citato all’inizio dell’articolo, degli anomali
apprezzamenti fatti segnare dal franco svizzero e dallo yen nell’ultimo periodo ed ai
quali hanno risposto, su sollecitazioni politiche interne, le rispettive banche centrali
cercando di porre un freno a tali pressioni rivalutative. L’intervento delle banche
11
centrali, che si concretizza solitamente nella vendita di valuta domestica e
nell’acquisto di valuta estera, è fallito per il franco svizzero nel 2009 (il cui rapporto
ha già rotto al ribasso la parità contro il biglietto verde); per lo yen la fine annunciata
pare essere la stessa anche in virtù della totale assenza di coordinamento con le altre
banche centrali mondiali, i cui obiettivi permangono divergenti. Tale situazione,
oltre ad evidenziare un movimento valutario erratico e del tutto scollegato dai
fondamentali economici, porta con sé crescenti rischi ritorsivi in un pericoloso gioco
che prevede l’individuazione di almeno una valuta perdente, costretta ad apprezzarsi
fino a quando non è possibile spostare l’attenzione rivalutativa su qualcun altro.
d. La vittima designata da mesi nella guerra delle svalutazioni è il real: la valuta
brasiliana dall’inizio del 2009 si è rivalutata del 35% circa verso un paniere di valute
rappresentative dei suoi principali partner commerciali. Se da un lato è vero che
l’economia carioca cresce da tempo a ritmi non molto inferiori all’economia cinese,
dall’altro essa pare essere costretta a pagare un prezzo molto più elevato in termini di
perdita di competitività. Non a caso nel settembre del 2010 il ministro delle finanze
brasiliano, Mantega, e il presidente della Banca Centrale, Meirelles, hanno dichiarato
che “il Paese non pagherà ancora a lungo il prezzo degli squilibri globali”,
ventilando una serie di misure per evitare un ulteriore apprezzamento del real. Si
tratta di un aumento della tassa sui capitali in entrata, dell’uso di reverse swap sul
mercato dei cambi e di interventi diretti da parte del Fondo sovrano mirati ad
indebolire la valuta. Fino a questo momento gli interventi messi in atto dalla Banca
Centrale non sono bastati, nonostante il Brasile abbia registrato nell’ultimo anno il
maggiore incremento di riserve valutarie al mondo dopo la Svizzera, con un +23%
da 221 a 273 miliardi di $. Il Brasile, come vedremo, si trova chiaramente sul lato
sbagliato del carry trade valutario: mentre gli investitori esteri ottengono infatti un
rendimento del 10% investendo in real, il governo del Paese sudamericano ricava lo
0.50% dalle sue riserve investite in dollari statunitensi.
3. Nei punti precedenti abbiamo analizzato l’evoluzione storica dei rapporti valutari
nell’ultimo secolo e gli avvenimenti di maggiore rilievo che hanno portato nell’ultimo
decennio ad una crescente tensione valutaria, la quale si manifesta attraverso le svalutazioni
competitive: si tratta di veri e propri interventi manipolatori il cui intento è quello di favorire
il deprezzamento della propria moneta rispetto alle altre. Ora prenderemo in esame
sinteticamente le determinanti economiche e finanziarie dei trend valutari e cercheremo di
attualizzare quest’analisi in termini concreti rispetto al rischio/opportunità che presentano gli
investimenti in valuta estera. Per quanto riguarda il primo aspetto, i principali studi
macroeconomici affermano che lo scenario previsionale dei cambi risulta essere tanto
maggiormente prevedibile quanto più si allunga l’orizzonte temporale di analisi. Tale
affermazione è suffragata dalla presenza di alcune determinanti nell’evoluzione dei cross
valutari, e precisamente:
a. Crescita dell’economia reale;
b. Inflazione e tassi di interesse;
c. Bilancia commerciale e flussi finanziari;
d. Rischio geopolitico
12
Per quanto riguarda il primo aspetto (a), è immediata la comprensione del rapporto
direttamente proporzionale esistente tra la forza dell’economia reale e il rafforzamento della
sua valuta di riferimento. Il secondo ambito (b) si basa sulla regola della parità del potere di
acquisto di due valute, legge secondo la quale una unità di valuta deve essere in grado di
acquistare la stessa quantità di beni in qualsiasi luogo del mondo. Secondo tale teoria, il
tasso di cambio tra due monete deve riflettere i differenti livelli di prezzo nelle due Aree
valutarie: ciò porta i Paesi con alta inflazione (relativa) ad avere valute che si deprezzano e
quelli con bassa inflazione (relativa) ad avere valute che si apprezzano. Tale teoria però non
tiene conto delle misure restrittive che le Banche Centrali mettono solitamente in atto per
contrastare l’inflazione; ciò porta ad uno spiazzamento dei flussi di capitale verso le Aree
valutarie con rendimenti superiori che solitamente coincidono con quelle ad inflazione
(relativa) superiore. La presenza di uno squilibrio della bilancia commerciale (c) è uno dei
fattori fondamentali di maggiore rilevanza, in quanto se le esportazioni superano di molto le
importazioni (avanzo commerciale) il naturale riequilibrio avviene attraverso un
apprezzamento della valuta domestica rispetto alle valute dei partner commerciali e
viceversa. La situazione dei Paesi in forte deficit commerciale è inoltre aggravata dalla
dipendenza della loro posizione dai flussi finanziari in entrata nel Paese di cui devono di
fatto finanziare il deficit commerciale ed in assenza dei quali la precarietà del loro equilibrio
è destinata ad emergere drammaticamente. Questo è il motivo per cui, soprattutto negli
ultimi decenni, ha assunto un’importanza crescente la stabilità geopolitica (d) di un Paese (o
di un’Area valutaria), il cui venire meno può provocare un’immediata e repentina fuga di
capitali con conseguente spiazzamento dei flussi finanziari e violenti deprezzamenti del
tasso di cambio. Considerati i punti appena esaminati, è facile comprendere come negli
ultimi anni, a partire dalla Cina (il cui regime di cambio è controllato) e fino agli Stati Uniti
(si noti l’atteggiamento monetario ultraespansivo della Federal Reserve), i tassi di cambio
non abbiano rispecchiato i fondamentali economici sopra enunciati. Secondo il Fondo
Monetario Internazionale il yuan è sottovalutato del 27% rispetto alle valute dei principali
partner commerciali; secondo numerosi economisti statunitensi la sottovalutazione della
moneta cinese sarebbe addirittura del 40%, ma, come il Presidente cinese ha recentemente
affermato, un apprezzamento repentino del yuan è fuori discussione in quanto le sue ricadute
sullo stato di salute della Cina in termini occupazionali, produttivi e finanziari (si pensi alle
perdite sulle riserve in dollari detenute) sarebbero inimmaginabili, con conseguenze
devastanti per l’intera economia mondiale in termini recessivi, oltre che di shock inflativo.
Mentre gli economisti continuano ad interrogarsi sulle modalità di un riordino valutario che
pare sempre più complicato da porre in atto, gli investitori si trovano di fronte alla difficoltà
di compiere delle scelte, in termini di allocazione valutaria, i cui andamenti, almeno nel
breve termine, seguono sempre meno le determinanti economiche fondamentali. A
prescindere quindi dalle due tendenze di fondo che paiono senza dubbio dover prevalere nel
medio periodo (la rivalutazione del yuan ed il deprezzamento del dollaro), la discriminante
da tenere sotto stretta osservazione nell’immediato è la differenza dei tassi di interesse
presente tra le differenti Aree valutarie. Osservando il grafico che rappresenta le curve dei
tassi di interesse in Paesi differenti si nota che nel breve termine i differenziali importanti
riguardano esclusivamente Turchia, India e Polonia rispetto alle altre valute, mentre per
trovare dei differenziali significativi tra le altre aree è necessario spingersi molto in avanti
13
nella curva, oltre le scadenze decennali. A conferma di ciò, la tabella sotto riportata
riepiloga i tassi di interesse corrisposti dalle differenti valute nelle scadenze trimestrali
(rilevati a settembre 2010):
Nazione
Stati Uniti
Giappone
Svizzera
Germania
Regno Unito
Polonia
Turchia
Australia
India
Brasile
Valuta
dollaro americano
yen
franco
euro
sterlina
zloty
lira
dollaro australiano
rupia
real
Tasso interesse a 3 mesi
0.23%
0.19%
1.23%
0.89%
0.80%
3.84%
7.68%
4.98%
6.10%
10.66%
L’interesse degli investitori alla ricerca di un extra-rendimento sarà senz’altro rivolto verso
le ultime cinque valute, mentre la differenza tra le prime cinque risulta sostanzialmente poco
significativa. Ciò significa che, fermi gli altri fattori di rischio (ad esempio per un’emissione
obbligazionaria della Banca Mondiale o della BEI), l’investitore potrà ottenere nel periodo
trimestrale un rendimento trentatre volte superiore investendo in lire turche e quarantasei
volte superiore investendo in real brasiliano rispetto all’investimento in dollari americani.
Chiaramente questo fenomeno è frutto delle politiche monetarie ultra espansive operate dalle
Banche Centrali dei Paesi già sviluppati che stanno da tempo mantenendo i tassi di interesse
a livelli eccezionalmente bassi; tale atteggiamento orienta quindi continui ed ingenti flussi di
investimento che partono dalle Aree core e si dirigono verso le valute a maggiore
rendimento, determinando in tale modo un loro costante apprezzamento. Tale fenomeno
risulta amplificato dalla comune pratica finanziaria del carry trade: si tratta di prendere in
prestito (o di vendere allo scoperto) una valuta con bassi tassi di interesse (ad esempio il
dollaro americano) e di investire le risorse ricavate in una valuta a tassi di interesse superiori
(ad esempio il dollaro australiano). Il protrarsi nel tempo di tale pratica produce effetti
pericolosi e perversi che rischiano di alimentare bolle finanziarie del tutto scollegate dai
fondamentali economici delle differenti Aree valutarie. Secondo l’ultimo Global Financial
Stability Report del FMI c’è un nesso statistico sempre più forte tra la liquidità generata
nelle maggiori Aree economiche del G4 ed i rendimenti degli indici azionari dei Paesi che
assorbono questi capitali; l’impatto della liquidità globale è cinque volte superiore
dell’effetto di quella interna in quattro Paesi, tutti a rischio bolla (non solo valutaria): Hong
Kong, Cina, Cile e Brasile. La storia dimostra che ogni volta che tali flussi sono diminuiti o
addirittura si sono prosciugati (come nel settembre 2008), i risultati sono stati disastrosi per
tutti gli investitori che avevano seguito pedissequamente il ciclo finanziario senza
ponderarne attentamente i rischi insiti: solo per fornire un esempio, nel corso dell’intero
2008, a seguito della crisi finanziaria, la lira turca perse ben il 50% del proprio valore nei
confronti del dollaro e circa il 25% rispetto all’euro. Ciò avvenne a causa della dipendenza
economica da una domanda estera molto concentrata su alcuni settori produttivi caduti in
14
crisi (ad esempio quello automobilistico, le cui vendite nel 2009 si sono contratte del 25% e
le cui esportazioni, nello stesso periodo, sono calate del 30.9%); avvenne anche a motivo
della necessità di fare ricorso all’indebitamento estero per finanziare il debito corrente, dato
il calo significativo nei flussi di capitale estero (il 65% del deficit corrente coperto con
l’indebitamento, il livello più elevato raggiunto dal maggio 2003) e del forte indebitamento
in valuta delle imprese turche nei confronti del sistema bancario estero (stimato ad 80
miliardi di dollari).
L’analisi effettuata fa emergere una situazione di pericolosa tensione valutaria a livello mondiale,
che rischia di sfociare in una guerra tra monete, cioè in fenomeni di forte volatilità ed erraticità dei
cambi. Il disordine mondiale valutario è alimentato dalle grandi superpotenze, Cina e Stati Uniti,
che con modalità differenti stanno perseguendo uno scopo identico anche se di fatto inconciliabile:
il deprezzamento della propria valuta al fine di sostenere l’economia interna. A fronte di questa
pericolosa escalation protezionistica le Aree valutarie minori rischiano di pagare le spese maggiori,
con conseguenti apprezzamenti valutari del tutto scollegati dai loro fondamentali economici. In
questa situazione di tensione è importante che l’investitore sia conscio di quanto sta accadendo
prima di allocare parte dei propri risparmi verso le valute emergenti, alla ricerca non solo di un
differenziale di tasso ma anche di un plusvalore rinveniente dall’apprezzamento della relativa
moneta, in quanto la storia dimostra che ogni fenomeno alimentato e sostenuto da una bolla di
liquidità rischia, all’atto del suo scoppio, di generare forti perdite per l’investitore spesso poco
preparato o del tutto inconsapevole. Come avvenuto tante volte in passato, anche in questo caso non
ci sarebbe da stupirsi se il disordine valutario alimentato dal crawling peg cinese e dalla politica
iperespansiva di Bernanke finirà per provocare un’ondata di tempeste valutarie, le cui nefaste
conseguenze finanziare ed economiche sono ad oggi difficilmente immaginabili.
Gabriele Pinosa
Go-Spa consulting
15