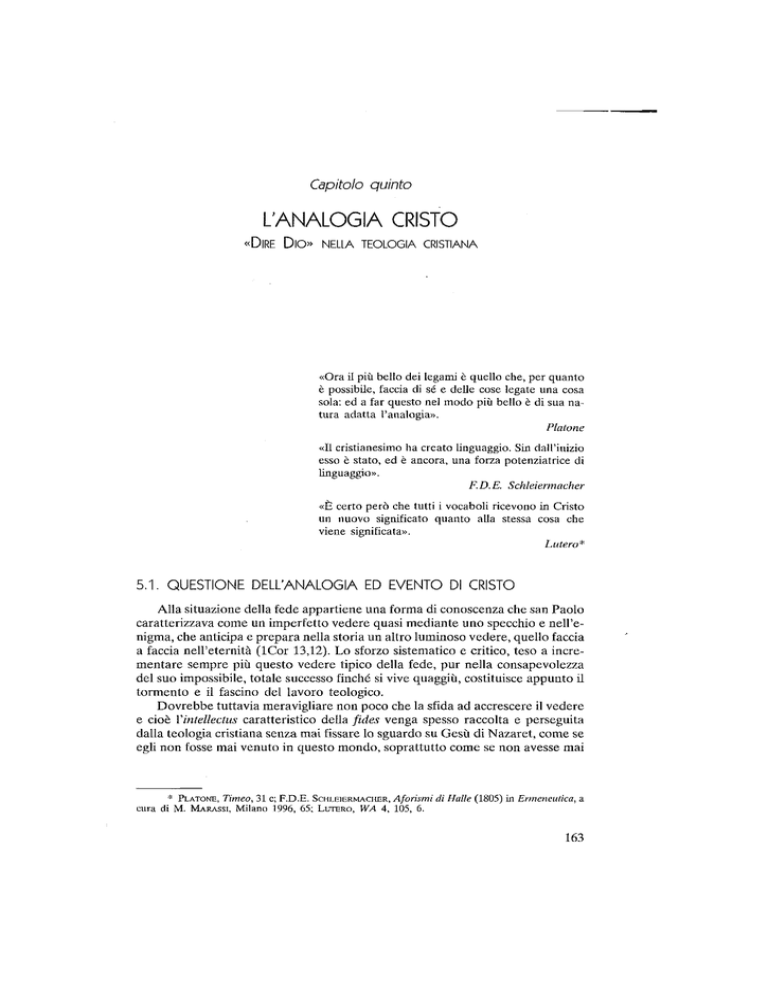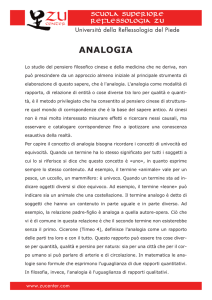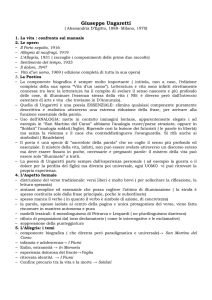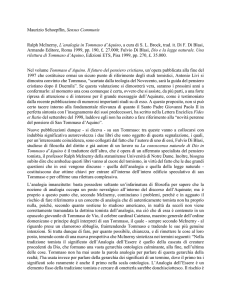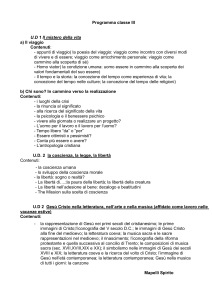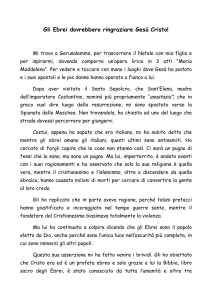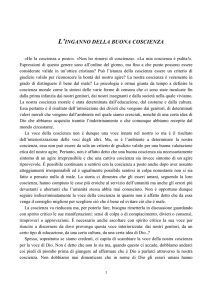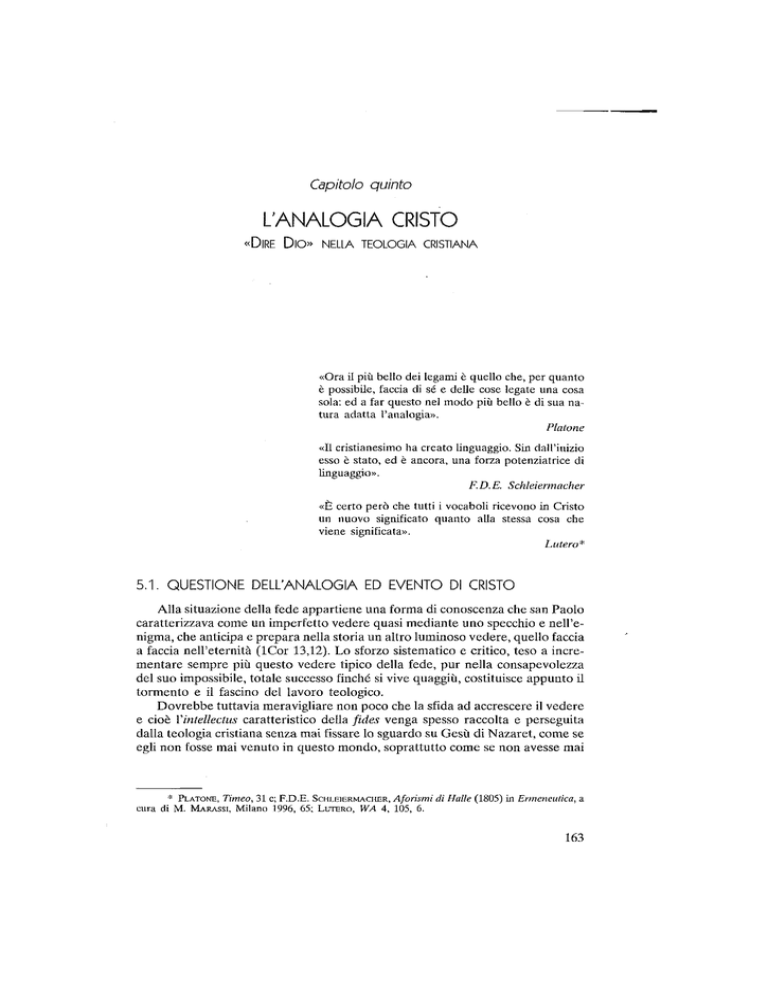
Capitolo quinto
L'ANALOGIA CRISTO
«DIRE DIO» NELLA TEOLOGIA CRISTIANA
«Ora il più bello dei legami è quello che, per quanto
è possibile, faccia di sé e delle cose legate una cosa
sola; ed a far questo nel modo più bello è di sua natura adatta l'analogia».
Platone
«11 cristianesimo ha creato linguaggio. Sin dall'inizio
esso è stato, ed è ancora, una forza potenziatrice di
linguaggio».
F.D.E.
Schleiermacher
«È certo però che tutti i vocaboli ricevono in Cristo
un nuovo significato quanto alla stessa cosa che
viene significata».
Lutero*
5.1. Q U E S T I O N E D E L L ' A N A L O G I A ED E V E N T O DI CRISTO
Alla situazione della fede appartiene una forma di conoscenza che san Paolo
caratterizzava come un imperfetto vedere quasi mediante uno specchio e nell'enigma, che anticipa e prepara nella storia un altro luminoso vedere, quello faccia
a faccia nell'eternità (ICor 13,12). Lo sforzo sistematico e critico, teso a incrementare sempre più questo vedere tipico della fede, pur nella consapevolezza
del suo impossibile, totale successo finché si vive quaggiù, costituisce appunto il
tormento e il fascino del lavoro teologico.
Dovrebbe tuttavia meravigliare non poco che la sfida ad accrescere il vedere
e cioè Vintellectus caratteristico della fides venga spesso raccolta e perseguita
dalla teologia cristiana senza mai fissare lo sguardo su Gesù di Nazaret, come se
egli non fosse mai venuto in questo mondo, soprattutto come se non avesse mai
* PLATONE, Timeo, 3 1 C; F . D . E . SCHLEIERMACHER, Aforismi
MARASSI, Miiano 1 9 9 6 , 65; LUTERO, WA 4, 105, 6.
cura di M.
di Halle
(1805)
in Ermeneutica, a
163
detto o fatto alcunché di intellettualmente significativo, in breve come se non
avesse mai avanzato la sconvolgente, immane pretesa di essere egli stesso la verità (Gv 14,6) (cf. c. 4). L'essere o la storia, il trascendentale o la liberazione,
questi e tanti altri concetti o categorie stabiliscono di volta in volta orizzonti e itinerari della teologia cristiana, mentre si accantona del tutto o lo si ritiene soltanto degno di successiva e coerente applicazione di procedure e di contenuti
Gesù Cristo, colui che si è autopresentato come la stessa persona veritatis. Si
pensi, per esempio, al modo in cui normalmente si affronta e si discute l'analogia, vale a dire una di quelle questioni cruciali che concernono la stessa primordiale giustificazione e coerente praticabilità del discorso teologico. Ci si domanda forse, di solito, se si dia, per caso, un concetto propriamente cristiano di
analogia, messo a punto cioè in forza di un chiaro e conseguenziale riferimento
non solo genericamente teo-logico, ma pure precisamente cristo-logico?
Certo, l'analogia costituisce un problema linguistico, logico, onto-logico.
Senza alcun dubbio essa concerne il dire, il pensare, l'essere stesso. Per questo
insieme di ragioni l'analogia non può non diventare anche, com'è in realtà avvenuto nel corso dei secoli, un problema teo-logico. Come si potrebbe infatti
dire e pensare l'essere senza che venga a porsi almeno la domanda intorno a
Dio? E, d'altra parte, come sarebbe possibile interrogarsi intomo a Dio senza
riflettere pure intorno al suo rapporto con l'essere, il pensare e il dire? È dunque del tutto necessario che Dio venga a costituire un problema onto-logico, logico e linguistico e che nella stessa teologia ci si misuri pure con la questione
dell'analogia.
Normalmente però non si è neppure sfiorati dal sospetto che si possa e anzi
si debba scrutare l'analogia pure alla luce dell'evento di Cristo. E tutto questo,
per quanto sorprendente possa apparire, vale in generale per l'intera storia della
teologia cristiana. Si lavora intorno all'analogia, come intorno a molti altri temi,
muovendo da una pre-comprensione stabilita da contenuti presupposti come razionali e quindi indifferenti, che in realtà restano fondamentalmente pre-cristiani o, comunque, per nulla cristo-logicamente vagliati. Che cosa debba intendersi per analogia, quali siano le sue interne articolazioni, quale sia la sua validità, tutto ciò si ritiene di apprenderlo come qualcosa di neutrale, per esempio,
dal (neo)platonismo, dall'aristotelismo o dal kantismo. Muovendo da quanto si è
compreso in questo o in quel modo, si cerca poi di adattare la soluzione così rica1
Selezionando tra la recente bibliografia, cf. Analogie et dialéctique, Genève 1983; Metafore
dell'invisibile. Ricerche sull'analogia, Brescia 1 9 8 4 (con bibl. alle pp. 2 8 5 - 2 9 0 ) ; Origini e sviluppi
dell'analogia. Da Parmenide a S. Tommaso, a cura di G. CASETTA, VaÙombrosa 1 9 8 7 ; La differenza e
l'origine, a cura di V. MELCHIORRE, Milano 1 9 8 7 ; V. MELCHIORRE, Analogia e analisi trascendentale.
Linee per una nuova lettura di Kant, Milano 1 9 9 1 ; ID., La via analogica, Milano 1 9 9 6 ; J. PALAKEEL,
The Use ofAnalogy. An Investigation in Ecumenical Perspective, Roma 1995. Per una sintetica messa
a punto, cf. l'ancora utile, ottima v. di P.A. SEQUERI, «Analogia», in Dizionario Teologico Interdisciplinare, coord. di L. PACOMIO, Torino 1 9 7 7 , 1 , 3 1 4 - 3 5 1 ; e, inoltre, H. HOLZ, «Analogia», in Concetti
fondamentali di filosofia, a cura di H . KRINGS - A.M. BAUMGARTNER - C. WILD, ed. it. a cura di G.
PENZO, Brescia 1 9 8 1 , 1 , 6 5 - 8 1 (a cui si aggiunge lo Schizzo bibliografico di G. Beschin, 8 1 - 8 5 ) . Utile
pure P. GIUSTINIANI, «Il "ritorno" dell'analogia in alcuni studi recenti», in Filosofia e Teologia
1
1(1992), 131-142.
vata alla intelligenza del mistero del Deus christìanorum. Perfino Barth, colui
che ha contestato con implacabile energia l'analogìa entis a vantaggio di una
analogia fidei e, insieme, ha costruito la sua gigantesca e incompiuta Kirchliche
Dogmatik con una metodica «concentrazione cristologica», ha poi elaborato lo
specifico discorso sull'analogia piuttosto nel quadro della categoria di rivelazione, ma al di fuori di qualsiasi esplicito collegamento cristologico. A quanto
pare, è stato per primo Eberhard Jungel, proprio ispirandosi a Barth, ma insieme superandolo, ad avviare l'indagine in questa direzione. Qui, in questo capitolo non si pretenderà se non di abbozzare appena qualche linea, non più che
l'avvio di una proposta, attingendo certo agli studi più recenti sull'argomento,
nel tentativo però di esplorare la quaestio de analogia in un orizzonte cristologicamente determinato. Si spera così di sottomettere il recupero della memoria
del passato cosiddetto onto-teo-logico a un discernimento critico in vista di un
futuro più coerentemente cristocentrico.
Da diverse parti sono stati già lanciati degli avvertimenti a prendere sempre
più sul serio lo stesso contenuto della fede per elaborare una teologia specificamente cristiana, avvertimenti che a prima vista potrebbero risultare d'una ovvietà sconcertante se non fossero anche fondatamente pertinenti. Un filosofo
che ha coltivato legami ambigui ma costanti con la teologia, Heidegger, ha per
esempio incalzato la stessa teologia a non maturarsi in virtù di qualcosa che le sia
estraneo, per esempio, a partire dall'essere, ma solo a partire da ciò che si fa presente in e con questo modo di esistere che è la fede: la teologia, in altri termini,
non dovrebbe costituirsi se non nella radicale tematizzazione della rivelazione e
della fede che ad essa corrisponde. Nel suo linguaggio allucinato lo stesso Nietzsche aveva una volta ammonito: «Dio in croce - si continua a non comprendere
lo spaventoso mondo di pensieri nascosto in questo simbolo». E non è forse
vero che la fede scaturisce da Dio e si concentra in Dio in quanto manifestato e
donato particolarmente nella croce di Gesù di Nazaret? Se questo crocifisso, riconosciuto nella fede come il Cristo risorto, il Signore e il Figlio di Dio, contiene
in sé la pienezza della grazia e della verità (Gv 1,14), allora egli racchiude pure
2
3
4
5
Per introdursi nella problematica dell'analogia in Barth, cf. B. MONDIN, The Principle ofAnalogy in the Protestant and Catholic Theology, The Hague 1963, 1968; H. CHAVANNES, L'analogie entre Dieu et le monde selon saint Thomas d'Aquin et selon Karl Barth, Paris 1969; A. MODA, Strutture
della fede. Un dialogo con Karl Barth, Padova 1990,11-73; nonché il più recente PALAKEEL, The Use
of Analogy, 13-66, 125-162, 339-345. Ma si veda pure A. MILANO, Rivelazione ed ermeneutica. Karl
Barth, Rudolf Bultmann, Italo Mancini, Urbino 1988, 7-44.
Cf. E. JUNGEL, Dio, mistero del mondo. Per una fondazione della teologia del Crocifisso nella
disputa fra teismo e ateismo (1977), Brescia 1982. Ma si veda pure dello stesso A. L'essere di Dio è nel
divenire. Due studi sulla teologia di Karl Barth, Casale Monferrato 1986 (si tratta della tr. it. della
Einfiihrung in Leben und Werk Karl Barths del 1982, e del più significativo Gottes Sein ist im Werden
del 1964). Su di lui cf., a questo proposito, S. CANNISTRÀ, «La posizione di E. Jungel nel dibattito sull'analogia», in La Scuola cattolica 122(1994), 413-446; P. GAMBERINI, Nei legami del Vangelo. L'analogia nel pensiero di Eberhard Jungel, Roma-Brescia 1994.
Cf. M. HEIDEGGER, «Fenomenologia e teologia», in Segnavia, a cura di F.-W. VON HERRMANN,
ed. it. a cura di F. VOLPI, Milano 1 9 8 7 , lOs.
F. NIETZSCHE, «L'Anticristo», n. 51, in II caso Wagner, Crepuscolo degli Idoli, L'Anticristo,
Scelta di frammenti postumi (1887-1888), a cura di G. COLLI - M . MONTINARI, Milano 1975 (Oscar
Mondadori), 185.
2
2
3
4
5
165
un «mondo di pensieri», che viene ad esigere un «rovesciamento di tutti gli antichi valori», una trasformazione così radicale ed omnicomprensiva, impegnativa e
trascinatrice da non escludere niente e coinvolgere tutto. La conversione {metànoia) non può certo riguardare soltanto l'antico, pagano modo di vivere o comunque non può valere semplicemente sul piano etico. Una teologia che voglia
elaborarsi in un orizzonte coerentemente cristiano dovrebbe misurarsi con qualsiasi problema e concetto all'interno della fede e mediante la fede in «chi è» questo Gesù, nato da donna, vissuto tra noi e morto sopra un patibolo infame (cf. c.
1.5). Se si abolisce o si attenua questo scandalo e questa follia nello stesso
«mondo dei pensieri» della teologia, si occulta o si estenua la potenza e la sapienza della croce di Cristo.
Naturalmente, affermando ciò, non si vuole contestare per principio e dissolvere per nulla quel patrimonio di riflessione accumulato nel corso dei secoli proprio, per esempio, intorno alla quaestio de analogia. Al contrario, si vuole tutto
valorizzare, semplicemente discernendolo criticamente, orientandosi anche in
questo caso a comprenderlo con sempre maggior rigore e coerenza alla luce di
Gesù di Nazaret colto come rivelazione assoluta, nel tentativo di riportare, come
suggeriva Paolo, omnem intellectum in obsequium Christi (2Cor 10,5). Un sapiente greco, Eraclito, aveva detto che «la via in su e la via in giù sono un'unica e
identica via» (fr. 60). Se ora Gesù di Nazaret ha preteso d'essere egli stesso la
«via» (odòs), almeno i suoi seguaci dovrebbero coltivare la preoccupazione che
egli costituisca pure il «met-odo» da prendere continuamente in considerazione
per ottenere la conoscenza di quella «verità» (alétheia) in cui consiste la stessa
«vita» (zoé) (Gv 14,6).
Ora, che la sequela di questo Gesù di Nazaret di per sé esiga, per esempio,
una ontologia o, per usare un termine sgradevole ai più, una metafisica, con
delle peculiari implicazioni logiche e linguistiche, già tutto questo potrebbe apparire poco comprensibile, se non addirittura bizzarro a chi rifiuti di rendersi
conto delle esigenze specificamente intellettuali della fede. In realtà, fin dai
primi secoli, dinanzi ai problemi imposti dal confronto con il pensiero greco, le
domande cioè intorno all'essere e al nulla, all'uno e al molteplice, al vero e al
falso, al bene e al male, i cristiani sono stati costretti ad esplicitare e formulare
delle asserzioni organizzabili in un insieme logico e linguistico unitario, modulato poi in forme diverse nei vari momenti e nei diversi pensatori: così in fondo si
è avviata la teologia cristiana.
Nel «mondo dei pensieri» prodotto finora dall'intelligenza della fede si è restati tuttavia ancora pesantemente condizionati dalle vicende dell'annuncio del
vangelo nel mondo antico, allorquando cioè apparve determinante soprattutto il
problema di Dio, della sua essenza e della sua opera, la creazione. Anche se in
seguito si sono dovuti affrontare dei problemi specificamente trinitari e cristologici ed inoltre la giustificazione per la fede e per le opere, le questioni della natura e della grazia, per quanto concerne, in particolare, l'ontologia o, se si vuole,
6
6
pienza
166
Cf. A .
MILANO, «Cristianesimo
42(1989), 245-293.
e metafisica. Tra "ragione debole" e "fede ignava"», in Sa-
la metafisica, si può sostenere che a tutt'oggi vale ancora per noi cristiani quanto
valeva nei primi secoli, che cioè «la nostra filosofia» è pure la «filosofia secondo
gli ebrei».
Come appare infatti dall'avvio del simbolo di fede, il credo, quella di un Dio
unico e trascendente, creatore e signore del cielo e della terra, è la dottrina in cui
il cristianesimo si accomuna all'ebraismo (insieme con l'islam). Ed è stata questa
stessa dottrina a gettare il primo germe della metafisica elaborata dal pensiero
cristiano. Nel corso dei secoli non sembra però che in questo campo si sia andati
molto al di là di come le cose furono originariamente impostate, continuandosi,
nonostante tutto, a concentrare sul problema di Dio e della creazione. Sicché resta comunque vero che «l'ortodossia, dal punto di vista metafisico, è il pensiero
ebraico». Ma, se le cose stanno davvero così, non è per niente azzardata la tesi
secondo la quale non s'è ancora ottenuta la cristianizzazione precisamente della
metafisica. E ciò perché non si è riusciti a svolgere tutte le conseguenze intellettuali implicate nella verità che accade e si manifesta in Gesù Cristo e in modo
tutto particolare nella sua croce e risurrezione, in quanto cioè induce Giovanni a
proclamare: «Dio è agape» (lGv 2,16).
Proprio se si riflette sull'essere di Dio quale appare definito dall'agape rivelata nella verità che è Cristo si è costretti a ripensare radicalmente il problema
della metafisica e, nel suo quadro, la stessa quaestio de analogia. Nell'orizzonte
dischiuso dalla fede la relazione originaria di Dio con l'uomo non dovrebbe essere tematizzata, come è finora avvenuto, soltanto e neppure principalmente alla
luce della creazione ex nihilo sui et subiecti, ma dovrebbe essere pure ed anzi
prima di tutto compresa alla luce della nuova creazione, quella attuata in Cristo
Gesù: «Se infatti uno è in Cristo - dice Paolo -, egli è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove» (2Cor 5,17). Il «Dio dell'Agape» (2Cor 13,11), colto nel mistero di Cristo, suggerisce, anzi impone di ritenere Dio riferito all'umanità più che in forza dell'essere creato dal nulla, in
modo ancora più intimo e irreversibile all'umanità avvinto in forza del nuovo essere prodotto per grazia. In una tale prospettiva Dio si rivela perciò analogo e,
dunque, pensabile, dicibile e perfino nel suo stesso essere più umano di quanto
sia umano l'uomo stesso.
Cerchiamo ora di comprendere se e in che modo tutto questo sia non tanto
ammissibile quanto irrinunciabile in un orizzonte teologico cristiano. L'analogia,
nel suo valore primordiale, elementare significa infatti relazione e, solo di conseguenza, proporzione, vale a dire un insieme di relazioni identiche o simili. Ebbene, considerata alla luce della verità che è Gesù Cristo e dunque ée\V «agape
della croce» (Rm 5,6-10), la relazione e pertanto l'analogia tra Dio e l'uomo
viene a comprendersi e legittimarsi secondo una positività e una pienezza inimmaginabili a chi la consideri nella sola luce della verità dell'essere. Nell'orizzonte scoperto dalla fede ci si prospetta un dato comune all'intero Nuovo Testa7
8
Cf., rispettivamente, TAZIANO, Or. adv. Graecos 31: PG 6, 8 6 7 ; CLEMENTE ALESSANDRINO,
Strom. I, 21: PG 8, 820.
C. TRÉSMONTANT, La métaphysique du christianisme et la naissance de la philosophie chrétienne, Paris 1961, 23.
7
8
167
mento, che cioè il primo e ultimo legame che congiunge Dio e l'uomo, gli uomini
tra loro, anzi lo stesso cielo e la terra, l'inizio e la fine, tutto ciò che fu, è e sarà, è
lui, Gesù Cristo. Il metodo adeguato a scrutare l'analogia nel suo senso ultimo e
radicale non sarà dunque deciso dalla linguistica, dalla logica, dall'ontologia: da
un punto di vista teologico cristiano una tale via sarà stabilita da questo Unico
chiamato Gesù Cristo.
Se si volesse attuare una rigorosa e coerente concentrazione cristologica si
dovrebbe tuttavia scartare qualsiasi integralismo. Da un autentico servizio della
fede si autoesclude il razionalista, ma pure il fideista. Dovrebbe infatti valere per
la teologia quanto Pietro diceva ai cristiani della prima ora: siate «sempre pronti
alla difesa (apologìan) con dolcezza e rispetto di fronte a chiunque chiede ragione (logon) della speranza che è in voi» (lPt 3,15). In una teologia che desidererebbe realizzarsi conseguenzialmente come cristiana non ci si potrebbe pertanto sottrarre dall'affrontare con pronta disponibilità tutte le domande da qualunque parte provengano. Per ciò che riguarda in particolare l'analogia, sarebbe
semplicemente insensato pretendere di scavalcare l'intera serie dei problemi che
si sono via via annodati intorno ad essa.
«Senza analogia - ha scritto infatti Jiingel - non ci sarebbe un discorso responsabile
su Dio. Ogni comunicazione linguistica che corrisponde a Dio si muove da sempre
nell'orizzonte di ciò che viene reso possibile dall'analogia. E perfino un tacere che sia
adeguato a Dio [...] potrebbe essere reso possibile solo da un'analogia che raggiunga
il proprio scopo ammutolendo».
g
Per elaborare con serietà un discorso teologico cristiano bisogna dunque misurarsi anche con la quaestio de analogia e sottoporsi a tutti gli interrogativi che
essa si tira dietro.
5.2. «IL PIÙ BELLO DI TUTTI I LEGAMI».
A N A L O G I A E O N T O - T E O - L O G I A GRECA
Se si volesse appena dignitosamente affrontare l'indagine, bisognerebbe allora chiedersi, senza svicolare, se e in che modo l'analogia possa comprendersi
alla luce della verità dell'essere, e se e in che modo una soluzione, trovata lungo
questa stessa strada, riesca a soccorrere il discorso cristiano intorno a Dio. A
quale teo-logia si perviene infatti percorrendo la via dell'essere? Detto in altro
modo, l'analogia ha a che fare e come con Vonto-teo-logia'ì
Certo, accettando questa sfida, bisognerebbe considerare se l'analogia riguarda primariamente la struttura dell'essere oppure la struttura del pensiero
oppure ancora la struttura del linguaggio. In quale rapporto, inoltre, si pongono fra loro queste strutture o, in altri termini, che cosa è analogo: l'essere, il
concetto, la parola oppure tutto ciò in perfetta simmetria? Poiché nella sua costi10
9
m
gia,
168
Dio, mistero del mondo, 3 6 7 .
Per quanto segue cf. A . MOLINARO, «Domande sull'analogia», in Origini e sviluppi dell'analo-
JUNGEL,
17-36.
tuzione, per così dire, nucleare l'analogia comporta relazione, si deve distinguere, e perché, fra la cosiddetta analogia di attribuzione e la cosiddetta analogia
di proprozionalità?
È possibile infatti che si abbia un rapporto di più cose con una sola o di una
cosa sola con molte, nonché un rapporto di più cose fra di loro. È nel primo caso
che si parla appunto di analogia di proporzione o anche di attribuzione, quando
cioè si ha un rapporto, per così dire, semplice (ordo ad unum, rapporto fra uno e
molti). Si parla invece di analogia di proporzionalità nel secondo caso, quando
cioè si ha un rapporto di molti fra loro e dunque propriamente un rapporto di
rapporti (ordo plurìum inter sé). Nella sua forma schematica l'analogia cosiddetta di proporzionalità assume questa figura classica: a sta a b come c sta a d. La
ratio di questa analogia si concentra tutta nel «come». Il rapporto tra a e b può
porsi in modi diversi e dunque può risultare equivalente, maggiore, minore, simile e così via in relazione al rapporto tra ced. L'analogia di proporzionalità resta sempre un rapporto, ma i termini dì questo rapporto sono a loro volta dei
rapporti.
Ma come e perché è nata e si è sviluppata questa problematica dell'analogia?
Una volta che si immerga nel flusso della storia tutto l'insieme delle domande
che si richiamano alla quaestio de analogia, ci si rende conto che ci troviamo dinanzi a interrogativi formulati di volta in volta in base a presupposti più o meno
consapevoli all'interno di una determinata, specifica tradizione culturale. Come
si sa, la riflessione sull'analogia deriva storicamente dai greci: poteva dunque
non essere segnata da questa sua origine? Se i greci si muovevano in un caratteristico orizzonte ermeneutico centrato sulla verità dell'essere e per questa via
hanno pure tentato di comprendere il divino, la loro intelligenza dell'analogia
poteva non risultarne condizionata?
Che per i greci sia stato il pensiero dell'essere a tirarsi dietro la questione
dell'analogia si può intravedere già in Parmenide come in Eraclito. Certo si può
discutere se e fino a che punto questi pensatori aurorali siano giunti perfino a
intuire la peculiare analogia di proporzionalità. In ogni caso, si potrebbe dire
con una certa fondatezza che l'essere viene da loro colto essenzialmente come
problema del rapporto fra l'uno e i molti. L'uno non è se non in rapporto ai
molti e dunque in rapporto al tutto. II tutto non è tutto se non è in rapporto ai
molti e dunque all'uno. La totalità dell'uno nei molti e dei molti nell'uno è
compresa e strutturata dall'essere. Ma in tal modo, al di là delle pur grandi differenze, Parmenide ed Eraclito restano pur sempre rinserrati in una visione del
mondo che potremmo definire «cosmocentrico-sacrale», in cui ciò che conta è
appunto la verità (alétheia) dell'essere (to on) colto come pervaso e sorretto dal
divino (to theion).
11
12
Cf. E. JONGEL, Zur Ursprung der Analogie bei Parmenides und Heraclit, Berlin 1964; MELLa via analogica, 173-207 (Eraclito), 209-229 (Parmenide). Ma si veda anche la messa a
punto di A. MOLINARO, «Parmenide ed Eraclito. Alle origini dell'analogia?», in Origini e sviluppo
dell'analogia, 36-62.
Cf. A . MILANO, «Il divenire di Dio. Sulla "teologia naturale" dei primi pensatori greci», in
Asprenas 20(1973), 5-59.
u
CHIORRE,
12
169
A quanto pare, il termine «analogia» ha fatto la sua prima comparsa nella
storia del pensiero occidentale con Platone, allorquando cioè viene detto nel Timeo:
«Non è possibile che due cose sole si combinino bene senza una terza. In mezzo alle
due bisogna che vi sia un qualche legame che le congiunga entrambe. Ora il più bello
dei legami è quello che, per quanto è possibile, faccia di sé e delle cose legate una
cosa sola: ed a far questo nel modo più bello è di sua natura adatta l'analogia».
13
Che cosa precisamente si intenda in questo testo per molti versi enigmatico,
che si tratti cioè dell'analogia di attribuzione oppure di quella di proporzionalità,
in ogni caso resta che, fin dall'apparire del termine, la ratio dell'analogia viene
colta nella funzione del legare, connettere, riferire, in una parola, nella relazione, e questo lo si prospetta attuabile nel campo del dire, del pensare e, prima
ancora, dell'essere stesso.
Certo Platone non ci offre ancora un'analisi articolata dell'analogia, anche se
in lui «si trova una sua torsione verso un senso più propriamente ontologico».
Neanche ci parla esplicitamente di analogia quando vuol descrivere i rapporti
del cosmo col divino. È tuttavia la stessa concezione platonica che dischiude
questa possibilità. Lo si intravede in quel celebre paragone tra l'idea del bene ed
il sole dì cui si parla nella Repubblica:
14
15
«Come nel mondo sensibile la luce e la vista somigliano al sole, ma non è giusto scambiarle per il sole, così anche nel mondo intellettuale è giusto ritenere che la conoscenza e la verità siano entrambe simili al bene, ma non è giusto ritenere che l'una o
l'altra siano il bene, la cui natura anzi è da considerare ben più preziosa».
16
La figura dell'analogia qui coinvolta è quella che in seguito sarà chiamata
analogia di proporzionalità. Ma essa si fonda, a sua volta, sulla dottrina ugualmente platonica della partecipazione delle cose sensìbili alle idee. Questa stessa
dottrina della partecipazione (méthexis o metàlempsis) sarà ripresa nel cosiddetto «sistema alessandrino del mondo», cioè nel neoplatonismo, per spiegare
non più il rapporto fra le idee e le cose, bensì l'emanazione dell'essere delle cose
dall'essere del divino. Da parte loro gli ebrei e i cristiani si approprieranno dell'iPLATONE, Tim. V I I , 31 c. Cf. XXXI, 69 b: «Come dunque anche da principio fu detto, essendo
queste cose in disordine, Dio mise in ciascuna, e con se stessa e con le altre, una giusta analogia in tal
grado e maniera che esse potessero essere simmetriche e proporzionate. Perché allora niente era disposto a questo modo se non per caso, né v'era cosa che meritasse d'essere chiamata con nomi che
hanno ora le cose, come fuoco e acqua o altro che sia, ma Dio primieramente ordinò tutte queste
cose, e poi da esse compose questo universo, vivente unico, che ha in sé tutti i viventi mortali e immortali».
Cf. G. LAFONT, «De l'analogie chez Platon. La réponse du "Parmenide" et du Timée», in Origini e sviluppo dell'analogìa, 63-77.
V . MELCHIORRE, La via analogica, 2 1 0 .
PLATONE, Rep. V I , 5 0 9 . Come osserva W . BEIERWALTES, Proclo. I fondamenti della sua metafisica ( 1 9 6 5 , 1 9 7 9 ) , Milano 1 9 9 0 , 3 6 6 e nota 2 6 , proprio la similitudine platonica del sole assurgerà nel
neoplatonismo e, in particolare, in Proclo «ad elemento motore nel tentativo di pensare al Principio
in modo analogico».
13
14
1 5
16
2
170
dea di partecipazione per render conto della propria peculiare dottrina della
creazione del mondo da Dio. Ed è sullo sfondo dell'idea platonica di partecipazione, ripresa sia dal neo-platonismo sia dal pensiero ebraico-cristiano, che si
penserà di comprendere l'analogia, riportando l'analogia di proporzionalità,
come al suo fondamento, all'analogia di attribuzione.
La prima grande analisi dell'analogia si è però avuta con Aristotele. Tuttavia
l'Aristotele storico non ha inteso come analogia proprio quella che sarà in seguito definita analogia di attribuzione ed in tal modo sancisce alla radice la «debolezza ontologica» di questa sua specifica dottrina. A proposito dell'analogia
di attribuzione Aristotele ha invece parlato di «omonimia relativa» (pros eri,
orào ad unum). Egli ha definito analogia soltanto quella di proporzionalità
quella cioè che di per sé non implica Tordo ad unum. In altre parole, Aristotele
ha riconosciuto come analogia soltanto quella, per così dire, «orizzontale», non
quella «verticale». Quella che i neoplatonici e poi gli scolastici chiameranno analogia di attribuzione per Aristotele non è propriamente una forma di analogia,
anzi ne è da lui ben distinta. Lo si vede, per esempio, nel celebre testo aristotelico solitamente addotto proprio per illustrare l'analogia di attribuzione:
17
18
«L'essere (to on) si dice in molteplici significati, ma sempre in riferimento ad una
unità e ad una realtà determinata; l'essere quindi non si dice per mera omonimìa, ma
nello stesso modo in cui diciamo "sano" tutto ciò che si riferisce alla salute: o in
quanto la conserva, o in quanto la produce, o in quanto ne è sintomo, o in quanto è in
grado di riceverla; o anche nel modo in cui diciamo "medico" tutto ciò che si riferisce
alla medicina; e potremmo addurre ancora altri esempi di cose che si dicono nello
stesso modo di queste. Così dunque anche l'essere si dice in molti sensi, ma tutti in riferimento ad un unico principio: alcune cose sono dette esseri perché sono sostanze,
altre perché sono affezioni della sostanza, altre perché vie che portano alla sostanza,
oppure perché corruzioni o privazioni; o qualità, o cause produttrici e generatrici sia
della sostanza sia di ciò che si riferisce alla sostanza, o perché negazione di qualcosa
di queste, ovvero della sostanza medesima».
19
A proposito dell'altrettanto celebre esempio: «come la vista è nel corpo, così
l'intelletto è nell'anima», Aristotele invece afferma esplicitamente che esso è
«secondo analogia» (kat'analogìan). In quest'ultimo caso non si tratta però di
«omonimia relativa» e non viene implicato quell'orbo ad unum, che in seguito
sarà visto costitutivo appunto dell'analogia di attribuzione, bensì si tratta sempliCf. E. BERTI, «L'analogia in Aristotele. Interpretazioni recenti e possibili sviluppi», in Origini
e sviluppi dell'analogia, 95. Cf. dello stesso A., «L'analogia dell'essere nella tradizione aristotelicotomistica», in Metafore dell'invisibile, 13-33.
Cf. MELCHIORRE, La via analogica, 2 4 3 . Sulla dottrina aristotelica dell'analogia cf. anche P.
AUBENQUE, Le probleme de l'ètre chez Aristote, Paris 1 9 6 2 ; ID., «Les origines de la doctrine de l'analogie de l'ètre», in Les étndes philosophiques 1 0 3 ( 1 9 7 8 ) , 3 - 1 2 ; ID., «Néoplatonisme et analogie de Tètre,» in Néoplatonisme. Mélanges offerts à J. Trouillard, Fontenay aux Roses 1 9 8 1 , 6 3 - 7 6 ; BERTI,
«L'analogia dell'essere nella tradizione aristotelico-tomistlca»; ID., «Il concetto di analogia in San
Bonaventura», in Doctor Seraphicus 3 2 ( 1 9 8 5 ) , 11-21; ID., L'analogia in Aristotele, 9 4 - 1 0 5 : per quanto
segue si attingerà ampiamente a quest'ultimo saggio.
ARISTOTELE, Metaph. IV, 1003 a 33-1033 b 10: trad. it. G. Reale, Napoli 1968, I, 291 s. Cf. il
Commento di san TOMMASO D'AOUINO, In IV Metaphlect. i, ed. R. Spiazzi, Torino-Roma 1950, n.
535.
17
18
171
cernente di analogia di proporzionalità. L'unica analogia riconosciuta come
tale da Aristotele è perciò quella di proporzionalità e viene da lui ritrovata nei
principi ontologici di tutti gli enti (i tre principi-elementi, cioè materia, forma e
privazione, e le quattro cause), nei loro principi logici (principio di non contraddizione e principio del terzo escluso), nell'opposizione che tutti li pervade (potenza ed atto) e infine nelle stesse categorie in cui si distribuiscono, senza che in
quest'ultimo caso l'analogia di proporzionalità venga però a identificarsi con
l'«omonimia relativa».
Per quanto concerne il rapporto tra Dio e il mondo o, meglio, in termini aristotelici, il rapporto tra la sostanza immobile e gli altri generi di sostanze (mobile
incorruttibile e mobile corruttibile), piuttosto che aH'ccomonimia relativa» del
tipo di quella esistente fra le categorie, Aristotele sembra pensare invece a un
rapporto di successione o consecuzione, che sostanzialmente significa rapporto
di anteriorità e posteriorità. Ciò non esclude tuttavia che egli ammetta, sia pure
implicitamente, una analogia, sempre però di proporzionalità, fra Dio e uomo.
Lo si intravede, per esempio, quando sostiene che «come l'intelligenza umana
[...] si comporta in qualche momento [...], in questo stesso modo si comporta anche l'intelligenza divina, pensando a sé medesima per tutta l'eternità». Aristotele certo ritiene che il cielo e la natura dipendono dalla sostanza immobile.
Tutto questo fa pure della sua filosofia, come è stato detto, un Abhàngigkeitssysterri. Aristotele tuttavia non pensa a una derivazione o provenienza del
mondo da Dio, cosa invece che accade piuttosto nei sistemi del mondo accademici e neoplatonici. In ogni caso, per Aristotele la dipendenza reale del mondo
da Dio non è espressamente spiegata con l'analogia, anche se ciò non è neppure
escluso.
L'analogia platonica, neoplatonica e poi scolastico-cristiana implica invece la
partecipazione e, anzi, si fonda su di essa. Questa partecipazione resta nell'ordine della causalità formale, la quale dà luogo a una derivazione, necessaria, secondo il concetto neoplatonico di processione, o libera cioè volontaria, secondo
quello ebraico-cristiano di creazione. Non sembra esserci invece spazio alcuno in
Aristotele per una dottrina dell'analogia fondata sulla partecipazione, cioè per
un'analogia di tipo «verticale». L'analogia aristotelica non solo non implica, ma
in più esclude quella peculiare forma di dipendenza che è la partecipazione, anche se non esclude la dipendenza in generale. Per Aristotele l'uomo fa parte
della natura {physis), che dipende da Dio, ma non si può dire che l'uomo o il suo
20
21
22
23
24
25
2 0
2 1
ARISTOTELE, Eth. Me. I, 4, 1096 b 26-29.
BERTI, L'analogia in Aristotele, 95s.
Cf. ARISTOTELE, Metaph. X I I , 4,1070 a 31-32. Ma
cf. anche ib. I X , 6,1048 a 37; X I V , 6,1093 b
17-21; An. Post. I, 10, 76 a 39.
Cf. ARISTOTELE, Metaph. XII, 7, 1072 b 24-25; 9, 1057 a, 7-10.
Ivi, XII, 7, 1072 b 13.
Perciò gli studiosi distinguono VAbhàngigkeitssystem dal Derivationssystem o dzW'Ahleìtungssystem caratteristici degli accademici e neoplatonici. Cf. E . BERTI, «Il problema della sostanzialità dell'essere e dell'uno nella "Metafisica" di Aristotele», in Studi aristotelici, L'Aquila 1975, 181208; ID., L'analogia in Aristotele, 97.
22
23
24
25
172
pensiero partecipi di Dio o del pensiero divino. Il concetto aristotelico di dipendenza non ha più per modello la causalità formale, come avviene per il platonismo, bensì altri tipi di causalità, quella cioè motrice, materiale e finale. Per Aristotele la sostanza divina immobile funge infatti da causa motrice e finale nei
confronti delle sostanze mobili (direttamente per il cielo, indirettamente per la
natura). Non si può in alcun modo sostenere che per Aristotele l'atto delle sostanze mobili sia una partecipazione dell'atto della sostanza immobile, perché
questa non è per niente un atto di essere (actus essendì), ma è più precisamente
un atto di pensiero. Per Aristotele non si pone nemmeno il problema che il pensiero umano sia una «partecipazione» del pensiero divino, anche se il primo ossia l'intelligenza (nous) viene detto a sua volta divino (theion).
Fra il pensiero umano e il pensiero divino c'è però, secondo Aristotele, una
vera e propria analogia, ma di proporzionalità, anche se ciò da lui non viene
detto esplicitamente. Certo il filosofo dichiara che «l'infinito non sta in alcun
rapporto (en oudenì logo) col finito». È chiaro che «rapporto» qui significa proporzione, commensurabilità. Non a caso infatti i latini tradussero: nulla proporlo finiti ad infinitum. Se per Aristotele fra uomo e Dio c'è analogia di proporzionalità, non c'è però analogia di semplice proporzione o attribuzione, mancandovi il suo presupposto essenziale cioè la partecipazione. Alla partecipazione
Aristotele sostituisce la predicazione: le cose non partecipano dell'essere, dell'identico, del diverso, ma di tutte le cose si predica l'essere, l'identico, il diverso.
Si abolisce pertanto in Aristotele il chorismòs, la separazione e cioè la trascendenza dell'idea (non ha senso dire che il predicato sia separato da ciò di cui si
predica), mentre la trascendenza viene riportata alla causalità formale e dunque
nei termini di una forma immanente.
Nell'onto-teo-logia aristotelica il mondo non partecipa di Dio, poiché Dio
non è né il predicato né la causa formale, ma la causa motrice e finale del
mondo. Escludendo dal rapporto tra Dio e il mondo qualsiasi partecipazione e
causalità formale, Aristotele stabilisce nondimeno, a suo modo, la trascendenza
di Dio sul mondo. Al contrario, questa trascendenza sembrerebbe invece compromessa dal neoplatonismo, che torna a concepire tale rapporto in termini di
partecipazione, di causalità formale e dunque, dal punto di vista aristotelico, di
immanenza. La forma infatti per Aristotele è sempre immanente. L'Uno di Plotino è trascendente solo se per trascendenza si intende l'assoluta superiorità, ma
non lo è se per trascendenza si intende la totale separazione, cioè l'assoluta indipendenza. L'Uno plotiniano non può fare a meno della restante realtà, nel senso
che non può fare a meno di emanare la realtà ovvero di generarla da sé.
Nell'onto-teo-logia neoplatonica il mondo procede in modo necessario dal principio divino e perciò questo stesso principio non può stare senza mondo e pertanto, da un tale punto di vista, non potrebbe dirsi propriamente trascendente.
26
27
28
Protr., fr. 1 0 C Ross. Cf. BERTI, L'analogia in Aristotele, 98, 1 0 2 .
De caelo I, 7, 275 a 14. Per i latini si veda, per esempio, TOMMASO D'AQUINO, In
De caelo I, lect. 14, ed. R. Spiazzi, Torino-Roma 1952, n. 139.
BERTI, L'analogia in Aristotele, 1 0 6 .
2 6
2 7
ARISTOTELE,
ARISTOTELE,
2 8
173
Aristotele, proprio mentre critica Platone, cerca pure di liberarsi da ogni residua influenza parmenidea. Egli critica la nozione di esse ipsum (auto to ori) con
esplicito riferimento a Platone, in quanto essa, a suo giudizio, come anche la nozione di unum ipsum o uno sostanziale, conduce al monismo di Parmenide cioè
all'immanentismo. Se infatti c'è un ente che ha come sua essenza l'essere, argomentava Aristotele, ne deriva che Yesse ipsum è un'essenza e dunque tutto ciò di
cui si predica l'essere si predica pure di questa stessa essenza. In tal modo però
tutto si riduce a una cosa sola, l'essere appunto per essenza, come per Parmenide. Il concetto di partecipazione, con cui Platone cercava di salvarsi dal monismo parmenideo, è invece per Aristotele insostenibile: è un «parlare a vuoto»,
un «far uso di metafore poetiche».
Certo, non si vuol dire che, accantonando il concetto platonico (poi neoplatonico) di partecipazione, Aristotele conquisti sia pure implicitamente il concetto di creazione. Al contrario, è anzi verosimile che Aristotele, se per ipotesi
avesse conosciuto il concetto di creazione, lo avrebbe respinto come incompatibile con l'eternità del mondo e insieme come l'espressione di un antropomorfismo indegno di Dio. Lo stesso racconto del Timeo platonico, che rappresenta
Dio come un «artigiano», esprime, a giudizio di Aristotele, una concezione antropomorfica, che non si addice alla sublimità del divino. Il mondo di Aristotele
è un cosmo eterno, non un universo creato. San Tommaso, da parte sua, ammetterà la possibilità teorica di un mondo ab aeterno e insieme creato. In ogni caso,
per Aristotele, Dio è atto puro, pensiero di pensiero e in lui «sussiste anche la
vita, perché l'attività dell'intelligenza è vita ed egli [Dio] è questa attività».
Se pensa e vive, per Aristotele, Dio «è» in modo perfettissimo. Da questo
punto di vista, il Dio di Aristotele si presenta come un Dio vivente e in qualche
modo personale. L'essenza di questo Dio resta tuttavia il pensiero, non l'essere,
anche se niente impedisce, anzi tutto esige che Dio come «pensiero di pensiero»
contenga pure l'essere. Il Dio di Aristotele non è però l'Esse ipsum subsistens
perché l'essere, contenendo tutte le perfezioni, non è un'essenza sola e non può
quindi essere l'essenza di nessun ente. Se fosse un'essenza sola, l'essere sarebbe
la più povera di tutte, perché sarebbe del tutto indeterminato, cioè si predicherebbe solo di se stesso, esattamente come il nulla. Soprattutto però il Dio di
Aristotele non è l'Esse ipsum subsistens perché non è un Dio creatore. Sarà l'idea di creazione che, come si accennerà fra poco, imporrà di «convertire» l'idea
greca di Dio, dell'ente e dell'essere. Nel nuovo orizzonte della rivelazione cristiana l'essere di Dio, l'essere dell'ente e l'essere stesso dovranno venir ripensati
e solo allora sarà possibile giungere a proclamare Dio l'Esse ipsum subsistens.
Certo l'essere, il problema massimo del pensiero greco, resta anche il problema massimo di Aristotele:
29
30
31
32
2 9
30
31
32
174
Metaph. ILI, 4, 1001 a 27 - b 1.
Ivi, I, 9, 991 a 21-22.
ARISTOTELE,
ARISTOTELE, De an. II, 4, 4 1 5 b 14.
Cf. BERTI, L'analogia in Aristotele, 113.
«Ciò che dai tempi antichi - egli ha scritto -, così come ora e sempre, costituisce l'eterno oggetto di ricerca e l'eterno problema: "che cos'è l'essere" (ti to on) [,..]; perciò
anche noi, principalmente, fondamentalmente e unicamente, per così dire, dobbiamo
esaminare che cos'è l'essere inteso in questo significato».
33
Anzi proprio Aristotele ha definito la filosofia prima come quella scienza
che «studia l'essere in quanto essere (perì tou ontos e on), cioè che cosa sia l'essere e quali attributi, in quanto essere, gli appartengano».
Tuttavia si impone pur sempre la domanda a quale teo-logia sia pervenuto
Aristotele percorrendo, a suo modo, appunto la via dell'essere. Certo, l'essere,
per il filosofo, si dice in molti sensi: fra l'altro, è diveniente, nel migliore dei casi
è analogo. Ed è ben vero che l'onto-logia aristotelica si compie e si esalta in una
teo-logia: è dunque una onto-teo-logìa. Rimane però che nella peculiare ontoteo-logia aristotelica, strutturata secondo l'analogia non di attribuzione, bensì di
proporzionalità, l'essere stesso non è la causa prima, non è Dio. «Dio - diceva il
giovane Aristotele in un dialogo perduto significativamente intitolato Sulla preghiera - è intelligenza o è qualcosa al dì sopra dell'intelligenza» (fr. 1 Ross). In
ogni caso, è l'intelligenza che appare ad Aristotele la più alta forma di essere
concepibile, anche se non è una determinazione del tutto adeguata ad esprimere
Dio. Alla fine, l'ultima parola della onto-teo-logia aristotelica non è altro che
questa: l'intelligenza, precisamente l'intelligenza di sé, l'autocoscienza, è semplicemente il più alto dei nomi che l'uomo è in grado attribuire a Dio, ragionando
appunto per analogia.
34
35
36
5.3. ESSERE E CREAZIONE.
IL PARADIGMA D E L L ' O N T O - T E O - L O G I A TOMISTICA
Proprio attingendo abbondantemente alle fonti del pensiero greco la teologia cristiana si è venuta costituendo in sapere della fede: in questa tensione, appropriandosi di svariati elementi, ha pure elaborato il proprio discorso sull'analogia. Platonismo, neoplatonismo, aristotelismo, tutto, con estrema libertà, è
stato assunto, filtrato e messo a servizio della comprensione del mistero del
Deus christianorum. E tuttavia, poiché, in particolare, la concezione aristotelica
dell'analogia non presupponeva, anzi escludeva la dottrina della partecipazione,
è dal platonismo e dal neoplatonismo, non dall'aristotelismo, che è venuto ai cristiani il forte incentivo a far propria l'analogia di attribuzione, subordinandole
l'analogia di proporzionalità, e tutto questo particolarmente a motivo del concetto di partecipazione.
Nello sforzo di comprendere sempre più la fides nel Dio unico, creatore e signore del mondo, mediante un intellectus filosoficamente attrezzato, per esem3 3
34
3 5
36
ARISTOTELE, Metaph. VII, 1, 1 0 2 8 b - 2-7.
Ivi, VI, 1, 1026 a - 31-32.
ARISTOTELE, Phys. I, 2, 185a.
Cf. BERTI, L'analogia in Aristotele, 115.
175
pio, Agostino, Pseudo-Dionigi, Tommaso d'Aquino, certo ciascuno a proprio
modo, non hanno però fatto interagire compiutamente la teo-logia con la cristologia. La ricerca della verità dell'essere è stata da loro scrutata essenzialmente
alla luce della dottrina del Dio della creazione, non è stata compiutamente transustanziata dalla dottrina del Dio della redenzione. Dalla onto-teo-logia coerentemente delineata in regime senza dubbio cristiano è emersa così una figura di
analogia non del tutto adeguata all'intelligenza dell'agape rivelata e donata nel
Dio crocifisso: è questa l'ipotesi di lavoro verso la quale cerchiamo ora di indirizzare più da vicino la nostra attenzione.
Il rapporto tra Dio e il mondo appare infatti nella Bibbia concepito in modo
del tutto peculiare ed anzi nel Nuovo Testamento in modo ancora diverso rispetto all'Antico. Nel Nuovo Testamento infatti la creazione viene ricompresa
radicalmente alla luce della cristologia: si pensi, per esempio, a Gv 1,3, Col l,16s,
Eb 1,2. In ogni caso, nel pensiero vetero e neotestamentario si attesta la creazione del mondo da Dio e pertanto la produzione dell'essere da Dio non necessaria, bensì assolutamente libera. Gli ebrei ed i cristiani sostengono così la trascendenza e l'assolutezza di Dio, da una parte, e la contingenza e la relatività del
mondo, dall'altra. Ritenendo di scoprire non certo in Aristotele, bensì in Platone, precisamente nel Timeo la presenza dell'idea di creazione, i cristiani hanno
allora pensato di potersi servire del concetto appunto platonico di partecipazione per comprendere la testimonianza delia Bibbia. Ne è derivata una sintesi
o, se si vuole, una specie di contaminatio in cui il creazionismo biblico si è fuso
con il processionismo neoplatonico.
Non basta. I cristiani si sono richiamati ancora a Platone quando, sempre
sullo slancio dell'interpretazione dell'idea di creazione, hanno pensato di concepire Dio come l'Essere per essenza. Platone nella Repubblica aveva affermato
che il Bene è «al di sopra dell'essenza» (epékeina tes ousìas). A questa stessa
dottrina s'erano ispirati pure dei neoplatonici come Plotino. Ma nelle sue «dottrine orali» (agrapha dogmata) Platone aveva identificato l'Uno, principio formale di tutte le cose, con l'Essere inteso come sostanza avente quale essenza
l'essere stesso. Ed ecco che i cristiani, a loro volta, hanno argomentato: se Dio
è il creatore e dunque produce la totalità delle cose e quindi l'essere dal nulla,
tutto questo non è forse possibile proprio perché Dio possiede l'essere in modo
pieno, supremo, assoluto tanto da potersi definire l'Esse ipsum subsistens?
Già sant'Agostino nel leggere la rivelazione dell'Esodo, in cui Dio si rivela a
Mosè come «Colui che è», parla di Dio come dell'Esse ipsum. A Dio infatti, secondo sant'Agostino, questo nome maxime ac verissime competit, perché solo
Dio è ì'incommutabilis'.
37
38
39
Cf. TRÉSMONTANT, La métaphysique du christianisme; L. SCHEFFCZYK, Schòpfung und Versòhnung ( H D G , II/2a), Freiburg i.Br. 1962; R . A . NORRIS, God and World in Early Christian Theology,
London 1966; G . MAY, Schòpfung aus dem Nichts, Berlin 1978 (bibl.); B. STUDER, «Creazione», in
Dizionario Patristico e di antichità cristiane, Casale Monferrato 1983, I, 827-831 (bibl.).
PLATONE, Rep. I, 19, 509.
Cf. ARISTOTELE, Metaph. Ili, 4, 10001 a 9-12.
37
3 S
39
«Ciò che infatti muta, non conserva lo stesso essere; e ciò che si può mutare, anche se
poi in concreto non muta, può sempre non essere ciò che è stato; perciò soltanto ciò
che non muta, ma anche non può assolutamente mutare, solo questo può essere detto
che propriamente è senza attenuazione e in tutta verità».
40
Ma è san Tommaso d'Aquino a portare alle estreme conseguenze quella che
è stata chiamata da Gilson la «metafisica dell'Esodo» e insieme la «metafisica
della Genesi». Proprio sul caso paradigmatico di san Tommaso conviene ora
approfondire, per quanto è possibile, l'analisi.
41
42
«In D i o - dichiara infatti l'Angelico - il suo stesso essere (esse) è la sua essenza (quidditas): perciò il nome, che [Dio] prende dall'essere, lo nomina propriamente, ed è il
suo nome proprio, così come uomo è un nome che si dice appunto per la sua essenza».
43
Non per questo però san Tommaso attenua il suo acutissimo senso della trascedenza divina.
«Nella nostra condizione storica (in stata viae) - aggiunge san Tommaso - di lui [cioè
di Dio] conosciamo che è (quìa est), non che cosa è (quid est), e questo soltanto per
via negativa, e poiché non possiamo nominarlo se non in quanto lo conosciamo, perciò propriissimamente viene da noi nominato "Colui che è"».
44
Confluiscono, a quanto si può intravedere, in san Tommaso due esigenze: da
una parte, egli riconosce che l'essere costituisce l'essenza stessa di Dio; dall'altra,
persistendo l'inconoscibilità dell'essenza divina nella nostra situazione di «viatori», egli ritiene che l'essere divino sia a noi manifesto soltanto in modo indeterminato. In questo quadro san Tommaso precisa pure accuratamente che YEsse
subsistens divino non si identifica per nulla con l'essere degli enti, che egli chiama
Tesse commune e che è invece partecipato cioè creato o, più precisamente, concreato da Dio insieme con gli stessi enti. Questo essere degli enti l'Angelico lo definisce anche esse formale omnium, e ciò perché è Tesse quo formaliter unaquaeque res est, sempre precisando che non est subsistens, sed inhaerens.
45
46
AGOSTINO, De Triti. 5,2, 3; cf. ib., 7, 5,10: PL 42, 912 e 942. Cf. C.J. DE VOGEL, «"Ego sum qui
sum" et sa signification pour une philosophie chrétienne», in Revue des sciences religieuses 35(1961),
337-355.
Cf. É. GILSON, God and PhUosophy, New Haven-London 1941; Io., L'ètre et l'essence, Paris
1962; ID., L'esprit de la philosophie médiévale, Paris 1948 (tr. it., Brescia 1963); ID., Le Thomisme,
Paris 1956. Su questo fondamentale contributo dì Gilson cf. M. Toso, Fede, ragione e civiltà. Saggio
sul pensiero di Étienne Gilson, Roma 1986.
Tra l'enorme bibl. cf, H. LYTTKENS, The Analogy between God and the World. An Investigation of its Background and Interpretation of its Use by Thomas of Aquino, Uppsala 1953; R. MclNERNY, The Logic of Analogy. An Interpretation of saint Thomas, Le Hague 1 9 6 1 ; B. MONTAGNES, La
doctrine de l'analogie de l'ètre d'après S. Thomas, Louvain-Paris 1 9 6 3 ; G . B . MONDIN, Il problema del
linguaggio teologico dalle origini ad oggi, Brescia 1 9 7 1 ; E . N I COLETTI, «L'analogia in S. Tommaso», in
Origini e sviluppo dell'analogia, 1 1 6 - 1 7 5 . A questo proposito non si può non rimandare anche ai lavori di C. FABRO, La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tommaso d'Aquino, Torino
1 9 5 0 ; ID., Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d'Aquino, Torino 1 9 6 0 .
4 0
41
2
2
2
8
42
2
4 3
44
4 5
4 6
TOMMASO D'AQUINO, In I Sem.,
Ivi.
TOMMASO D'AQUINO, C.
ID., Pot., q. 7, a. 2, ad
Geni.,
7.
d. VILI, q. 1, a. 1. C f . Pot., q. 2, a. 1; S. Th., I, q. 13, a. 11.
I, 26,
ed.
C.
Pera, Torino-Roma
1961,
nn,
238-249.
177
In ogni caso, Dio resta sempre per san Tommaso extra totum ordinem universi, aliquid extrinsecum a toto universo, L'essere, infatti, che Dio possiede, io
possiede non in modo limitato o finito, bensì perfetto, secundum totani virtutem
essendi, e solo per questo Dio può parteciparlo al di fuori di sé. È in virtù di
questo essere assoluto, che Dio possiede tanto pienamente, che siamo costretti a
dire che Dio «è» questo stesso Esse subsistens. Sicché, precisa l'Angelico, a parlare formalmente, non possiamo dire che Dio «era», quasi che qualcosa del suo
essere sia diminuito nel passato, né che egli «sarà», quasi che qualcosa di questo
essere sia da attendersi nel futuro, e neppure che questo essere si generi nel passato, nel presente o nel futuro di una temporalità diveniente: l'essere di Dio non
è misurabile in alcun modo, ma è esso stesso mensura omnium dimensionum.
Per san Tommaso, il nome che massimamente nomina Dio è dunque Qui est,
come afferma la stessa rivelazione biblica, poiché questo nome non designa alcun modo d'essere determinato, ma il purissimo, incondizionato, supremo atto
d'essere di quel pelagus substantiae infinitum che è Dio.
Certo va ribadito che sullo sfondo di questa dottrina tomistica di Dio come
Ipsum esse subsistens, prima ancora che una gloriosa catena di auctoritates, che
da sant'Agostino come da Boezio giungono sino a tutto il medioevo, c'è un'interpretazione del dato biblico: sia la creazione del mondo, di cui parla la Genesi,
sia la rivelazione del nome divino attestata dall'Esodo. È il rapporto di Dio col
mondo, fondato dall'atto creativo e illuminato dalla teofania del roveto ardente,
ciò che ispira san Tommaso a distinguere fra Essere sussistente ed ente: distinguere, non separare, mediante un legame sui generis, quello appunto di causalità-partecipazione. In quest'ottica VIpsum esse subsistens, che è Dio, creando,
elargisce se stesso all'ente senza tuttavia risolversi in questo ente o nell'actus essendi di questo ente. Ma, dicendo tutto ciò, san Tommaso mostra pure di rileggere il testo biblico con l'aiuto che gli deriva dal neoplatonismo oltre che
dall'aristotelismo.
In questa linea ha dunque qualche ragione Heidegger a rilevare che, comprendendo come actus ciò che invece i greci dicevano enérgheia, san Tommaso
d'Aquino si procura la base per poter pensare Vagere di Dio come creatio: è in
quanto creatore dell'essere che Dio, il summum ens, può ben comprendersi
come supremo actus essendi e, per conseguenza, come Ipsum esse subsistens
Ha invece meno ragione sempre Heidegger quando aggiunge che san Tommaso
d'Aquino «sopprime proprio in questo modo ogni possibilità di una domanda
sull'essere». È vero piuttosto il contrario e cioè che appunto l'irrompere dell'i47
48
49
50
51
52
53
54
47
,|S
629.
S. Th., I, q. 103, a. 3 sed c. e resp.
TOMMASO D'AQUINO, In Dionysii de Divinis nominibus V, 1, ed. C. Pera, Torino-Roma 1950,n.
Ivi, n. 630.
S. Th., 1, q. 13, a. 11. Chiamando Dio pelagus substantiae infinitum, san Tommaso fa proprio
un celebre testo di Giovanni Damasceno, De fide orth. I, 9: PG 94, 836.
Cf. A . MILANO, «Dio nel pensiero di Boezio», in Sapienza 51(1998), 455-461.
Cf. E. BERTI, «Aristotelismo e neoplatonismo nella dottrina tomistica di Dio come "Ipsum
esse"», in Studi aristotelici, 3 4 7 - 3 5 1 ; NICOLETTI, «L'analogia in S. Tommaso», 162.
M. HEIDEGGER, Seminari ( 1 9 7 7 , 1 9 8 6 ) , a cura di F. VOLPI, Milano 1 9 9 2 , 7 0 - 7 1 (si tratta di un
seminario tenuto a Le Thor in Francia nel 1 9 6 8 ) .
Ivi.
49
50
M
52
53
54
178
dea di creazione provoca, come accade in modo esemplare in san Tommaso, in
tutta la sua radicalità la stessa domanda sull'essere. Che l'intera filosofia moderna sia gravata da un'«impronta ontica» in qualche modo assunta dalla teologia cristiana del medioevo può anche essere riconosciuto. Risulta invece alquanto problematico sostenere che insediare nuovamente la filosofia nella propria essenza «significa sgravarla del suo elemento cristiano». È proprio infatti
questo «elemento cristiano» ciò che storicamente ha motivato la filosofia dell'occidente a un nuovo inizio - e potrebbe nuovamente spingere a farlo. È legittimo, necessario e meritevole rivolgersi a ciò che è greco per reinventare sempre
daccapo il cominciamento della filosofia. È nondimeno arbitrario decidere che il
cristianesimo non racchiuda dentro di sé un originario principio generatore di un
inedito pensiero. Un grande teorico dell'ermeneutica come Heidegger non dovrebbe dimenticare quanto egli stesso ha teorizzato e cioè che la filosofia non comincia mai dal nulla: la comprensione muove sempre da una precomprensione.
Tutto questo dovrebbe valere per lo stesso Heidegger: anch'egli non comincia
dal nulla. Se ha potuto pensare tanto radicalmente l'essere, a parte il valore dei
risultati da lui conseguiti, tutto questo non l'ha fatto direttamente provenendo
dalle origini greche, ma proprio dalla teologia cristiana e, come egli stesso ha
detto, pro-venire può anche voler dire a-venire. Se dunque un pensare radicale
può rivolgersi alla radice greca, resta ancora da dimostrare che sia del tutto improponibile rivolgersi alla radice biblica e cristiana per conquistare una diversa e
non inferiore forma di un pensare radicale intorno all'essere.
In ogni caso, tornando a san Tommaso, andrebbe ancora sottolineato un dettaglio non marginale del suo pensiero: non solo il fatto che Dio è (quia est), ma
anche il fatto che Dio è l'essere stesso (Ipsum esse subsistens) rappresentano, per
il Dottore Angelico, una sublimis veritas, che sarebbe ugualmente di per sé raggiungibile dalla sola ragione umana. Proprio la ragione sarebbe appunto in
grado di riconoscere al nome «essere», tra tutti i nomi desunti dall'esperienza
delle cose create, ciò che conviene formalmente a Dio ed è meno inadeguato e
più degno per nominare Dio. Ma noi, oggi, dopo tanti secoli, soprattutto alla fine
di un'esperienza storica come quella della modernità, che sarebbe ingenuo dichiarare incondizionatamente e totalitariamente amica del cristianesimo (cf. c.
2), possiamo ancora nutrire la stessa limpida e ferma fiducia di san Tommaso nei
confronti della «ragione»?
È nel quadro storico finora abbozzato, in cui cioè si è tentato di elaborare
un'onto-logia che si raccordi con la teo-logia del mistero cristiano fondamentalmente a partire dall'idea di creazione, che si colloca e si articola pure la dottrina
55
56
57
M. HEIDEGGER, In cammino verso il linguaggio ( 1 9 5 9 ) , a cura di A . CARACCIOLO, Milano
Tutto questo lo si vede in modo esplicito particolarmente nel c. 22 («Quod in Deo idem est
esse et essentia») del I libro della Contra Gentiles, interamente elaborato, a giudizio dello stesso Dottore Angelico, insieme con il II e il III, ricorrendo alla ratio naturalis per creaturas. Solo il IV libro
della Contra Gentiles, in cui si tratta di ciò che è supra rationem come la Trinità e l'incarnazione, la risurrezione della carne e così via, verrebbe sviluppato auctoritate sacrae Scripturae.
56
1 9 7 3 , 90.
57
179
tomistica dell'analogia. È in forza di questa dottrina che l'Angelico cerca di comprendere il rapporto di Dio col mondo, tutto distinguendo per unire, ma tutto insieme unendo per distinguere, senza sacrificare, ma senza neppure disgregare le
molteplici forme e i diversi livelli della realtà in un ordo essenzialmente teocentrico (cf. c. 4.7). Resta tuttavia operante in san Tommaso lo schema teoretico
dell'uno e dei molti, caratteristico, come pure s'è accennato, dei pensatori greci,
anche se da lui questo schema viene reinterpretato nell'orizzonte peculiare della
fede cristiana. L'analogia dispiega la sua ragion d'essere nel pensiero tomistico
proprio tessendo la trama dei legami che avvincono l'uno e i molti, dove l'uno è
sia Dio stesso, il creatore che partecipa la propria similitudine alle creature, sia
l'essere anteriore all'ente, alla sostanza e all'accidente.
Si è parlato, a proposito del pensiero tomistico, di una duplice figura di analogia: una analogia «predicamentale», che riguarda il rapporto tra i vari modi categoriali dell'essere degli enti (sostanze e accidenti), e un'analogia «trascendentale», che investe tutto l'ordine della realtà, riferendolo al fondamento ultimo e
assoluto: l'essere. L'analogia «predicamentale» è quella plurium ad unum,
dove l'unum è ciò che è ente a titolo primario ed è perciò la sostanza. L'unificazione del molteplice nella sostanza apre però il problema del rapporto tra le
molteplici sostanze. Tra il pluralismo assoluto e il monismo ontologico san Tommaso si decide nettamente per l'uni-molteplicità analogica delle sostanze. Qual è
però l'unum che fonda il rapporto analogico tra le sostanze? La questione dell'analogia si sposta così dal piano «predicamentale» a quello «trascendentale». Il
fondamento dell'uni-molteplicità degli enti appare così a san Tommaso l'essere
per cui ogni ente è. Nell'ente in quanto ente, nel quale tutte le cose convengono,
si annuncia e si presenta l'essere. L'essere si manifesta moltiplicato e diversificato nelle diverse sostanze, ma insieme uno e comune a tutte le sostanze: è appunto quell'esse commune cui già prima si è fatto riferimento.
Ma san Tommaso scorge pure un rimando dall'analogia predicamentale a
quella trascendentale: nello stesso orizzonte dell'ente in quanto ente egli percepisce l'indicazione di una verità assoluta e intranscendibile, quella delYIpsum
esse subsistens, necessario, immutabile, eterno, causa prima di ogni ente. È Dio,
come già si è intravisto, lo stesso unico Dio della creazione e della rivelazione
questo Ipsum esse subsistens di san Tommaso. Lo si deve però ribadire, il passaggio dall'ente all'Essere sussistente può aversi, secondo l'Angelico, anche mediante la sola ragione, in concreto mediante quelle viae ad probandam existentiam Dei, che la ragione da sola potrebbe anche riuscire a rintracciare e percorrere fin in fondo. Certo il primum movens, il primum necessarium, il primum ordinans in finem, quel principio quod omnes dicunt Deum così raggiunto viene a
corrispondere in concreto allo stesso Dio di Abramo e di Gesù Cristo. Ma verso
di lui, per scoprire an sit, per quanto a fatica, non da parte di tutti e non senza errori, secondo san Tommaso, potrebbe pure protendersi l'uomo da solo, senza la
luce della rivelazione e della fede che le corrisponde.
58
59
5 R
59
180
NICOLETTA
Ivi, 144s.
«L'analogia in S. Tommaso», 119s.
Nondimeno resta la domanda: sarebbe mai possibile chiedersi l'ari sii di
qualcosa senza implicare in certo modo pure il suo quid sit? Si potrebbe cioè mai
cercare di sapere se qualcosa ci sia senza sapere per nulla che cosa si cerchi di sapere se ci sia? Se allora ad probandam existentiam Dei si percorrono delle viae
che muovono dall'esperienza del mondo, è chiaro che non si potrà non giungere
a Dio se non come a qualcosa che abbia a che fare con il mondo e, dunque, a Dio
come principio e fine di questo stesso mondo. Ne consegue che, per coerenza, il
discorso de essentia Dei non sarà se non una continuazione e un approfondimento del tipo di ricerca già avviato con la domanda de existentia Dei. E, viceversa, la via per svolgere il discorso de essentia Dei non potrà che venire a corrispondere alla via affrontata per risolvere il discorso de existentia Dei.
Stando così le cose, una volta che si rinunci a muovere immediatamente dall'autorivelazione storica di Dio «in» Gesù Cristo, il presupposto ontologico del
risalire della ragione dall'effetto alla causa non può che ritrovarsi nel rapporto di
creazione, che intercorre appunto tra mondo e Dio, tra mondo come effetto e
Dio come causa. Si argomenta così che il mondo ha, e non può non avere una habitudo o proportio rispetto a Dio, e questa habitudo o proportio non può alla
fine se non fondarsi su ciò che di più essenziale Dio come causa comunica al
mondo che è il suo effetto: l'essere stesso. Agere sequitur esse: l'influsso della
causa è sempre un influere esse alicuL L'influsso radicale, che consegue all'originario e fondante agire divino, non può che ritrovarsi nell'effusione dell'essere.
Nella dottrina tomistica alla base di tutto c'è dunque l'essere colto come enérgheia, come actus essendi, come energia diffusiva di sé. San Tommaso traccia in
tal modo un cammino che stabilisce la fondazione dell'analogia «predicamentale» nell'analogia «trascendentale», che già in sé preannuncia l'analogia «teologica», mentre trova nella verità dell'essere la sua prima e ultima giustificazione. Ed è così che nel tomismo l'analogia viene a dispiegarsi e legittimarsi in
un'unica, coerente onto-teo-logia.
Il concetto di analogia conquistato da san Tommaso non è certo andato
esente da flessioni e incertezze. Il dissidio interno alla scuola tomistica tra Gaetano, che identificava il pensiero caratteristico dell'Angelico con l'analogia di
proporzionalità, e Suarez, che invece lo rinveniva in quella di attribuzione, trova
in realtà degli appigli nell'ambivalenza dello stesso testo dell'Angelico. D'altra
parte andrebbe anche osservato che l'espressione analogia entis non si trova in
san Tommaso, ma in Gaetano prima e poi in Suarez, il quale parla appunto di
analogia entis creati e pure di analogia entis ad Deum et creaturam. Per parte
sua san Tommaso era ben consapevole di dover obbedire a contrapposte esigenze: quella di rispettare la trascendenza della natura divina, da una parte, e
quella di riconoscere insieme il legame del mondo con Dio, dall'altra, altrimenti
sarebbe risultata impossibile la conoscibilità e la dicibilità di Dio da parte
dell'uomo. Dio deve restare al di là di ogni possibile presa a opera della creatura,
ma, insieme, deve pur sempre risultare in qualche modo afferrabile dalla crea60
61
60
61
Ivi,
Cf.
128.
GERTZ,
Glaubenswelt als Analogie, Dusseldorf
1969, 235-236.
181
tura, se non si vuole lasciar posto all'agnosticismo e, più radicalmente ancora,
all'ateismo. Ecco allora che san Tommaso sostiene che Dio penitus manet ignotiim, proprio mentre afferma che la ragione umana ha pure la capacità di apprendere e dire qualcosa sul mistero della natura divina.
Quando affronta il discorso sull'analogia san Tommaso si sente dunque portato a valorizzare l'analogia di attribuzione, poiché con essa può collegare in un
coerente ordo ad unum tutte le cose riferendole a Dio. Nel Commento alle Sentenze l'Angelico difende infatti il valore dell'analogia di attribuzione (o proporzione) come ordo unius ad alterum anche sul piano trascendentale o teologico.
L'analogia, che così si configura, risulta fondata sulla causalità formale-esemplare di Dio e si determina come rapporto di imitazione secondo la somiglianza
imperfetta della creatura nei riguardi del Creatore.
Tuttavia nel De ventate san Tommaso non menziona più l'analogia di attribuzione e sostiene invece l'analogia di proporzionalità come l'unica forma possibile di analogia tra gli enti creati da Dio. Non viene certo da lui negata la causalità formale-esemplare di Dio, ma solo la rassomiglianza imperfetta diretta. Soltanto l'analogia di proporzionalità sembrerebbe tutelare la distanza infinita tra
Dio e la creatura, in quanto essa non esige un rapporto determinato, ma solo un
rapporto indiretto. Nella proporzionalità infatti il confronto è obliquo: non avviene tra i termini, ma tra i rapporti o proporzioni dei termini. Agli occhi di san
Tommaso l'analogia di attribuzione potrebbe valere soltanto nell'ambito delle
creature, non tra creatura e Creatore, e ciò perché tale analogia, in quanto rapporto «determinato», verrebbe a determinare la stessa perfezione divina. Lo
spostamento dalla forma diretta dell'attribuzione a quella indiretta della proporzionalità sembra un episodio interno al primato della causalità formale esemplificato dal rapporto copia-modello, che san Tommaso difende nei primi scritti e
che gli deriva dal suo maestro Alberto Magno.
In seguito, a partire dalla Contra gentiles in poi, san Tommaso riconfermerà
il primato dell'analogia di attribuzione nella luce sempre più intensa della causalità-partecipazione sul piano dell'essere. Poiché nel Commento alle Sentenze
non contrapponeva proporzione in senso lato (habitudo indeterminata) e proporzionalità (similitudo proportionum), si potrebbe allora rinvenire nel De veritate non tanto una rottura rispetto al Commento alle Sentenze (e anche al resto
dell'opera tommasiana) quanto una formulazione complementare, che ruota attorno alla partecipazione per somiglianza imperfetta, concezione comune a entrambi gli scritti. Dopo il De ventate si nota comunque un graduale mutamento
che porta Tommaso a interpretare sempre più la partecipazione sul piano
62
63
64
65
66
67
68
6 2
63
6 4
65
f>6
H7
LETTA
6 8
182
C. Geni., ILI, 49, n. 2270.
ID., In 1 Seni., d. 35, a. 4.
ID., De ver., q. 2, a. 11.
De ver., q. 23, a. 7, ad 9.
Ivi, q. 8, a. 1, ad 6.
MONTAGNES, La doctrine de l'analogie de l'èire d'après saint Thomas d'Aquin,
L'analogia in S. Tommaso, 145.
TOMMASO D'AQUINO, C. Geni I, cc. 32-35.
TOMMASO D'AQUINO,
73; E . NICO-
dell'essere. Ne consegue la rivalutazione dell'analogia di attribuzione e l'innesto
su questa dell'analogia di proporzionalità. Si tratta dunque di uno sviluppo, che
non comporta certo delle rotture traumatiche o degli abbandoni sostanziali, ma,
si potrebbe dire, soltanto l'emergenza e la messa a fuoco di motivi che già operano, anche se meno vigorosamente, nei primi scritti.
Fin qui la stringata ricostruzione della riflessione tomistica sull'analogia. Ciò
posto, non ci si può non chiedere se l'analogia di attribuzione, colta come rapporto diretto per imitazione esemplare, che nelle intenzioni di san Tommaso dovrebbe pur salvaguardare 1'«infinita differenza qualitativa», garantisca poi sul
serio dal pericolo di supporre la presenza di un aliquid commune tra Dio e la
creatura. Come è possibile infatti pensare il rapporto di imitazione al di fuori di
una forma communi'} analoga? San Tommaso ha cercato in tutti i modi di sfuggire a questo pericolo e lo ha fatto ricorrendo all'analogia di proporzionalità. Ma
questa stessa analogia di proporzionalità, se da una parte salva la distanza infinita, dall'altra affievolisce la relazione diretta di similitudine, slegandola dalla
causalità e dalla partecipazione o quanto meno mettendo queste in ombra. Se si
tiene presente che la causalità esemplare diviene attuale solo in virtù della causalità efficiente, che appunto fa passare dal non-essere all'essere, si può comprendere come Tommaso abbia rivolto sempre più l'attenzione all'essere, fondando di conseguenza il rapporto analogico di Dio col mondo sulla causalità divina come partecipazione dell'essere (nel duplice senso del genitivo soggettivo e
oggettivo). La partecipazione è innanzitutto partecipazione dell'essere, e la causalità efficiente, come donazione di essere da parte dell'Essere sussistente, assurge a fondamento ultimo dell'analogia. Poiché l'essere è V intimissimum rei,
Dio, in virtù é&Wactus essendi partecipato, diviene quanto c'è di più intimo nella
creatura, senza tuttavia risolversi nella creatura, nel suo principio formale. Da
una parte quindi si dà una profonda intimità tra Creatore e creatura sul piano
dell'essere, dall'altra rimane sempre una loro insormontabile «differenza ontologica» sul piano delle loro incomparabili nature.
69
5.4. DE DIVINIS NOMINIBUS.
«DIFFERENZA O N T O L O G I C A » E CRISI DELL A N A L O G I A
La conferma di questa tensione presente nella onto-teo-logia tomistica si ripropone in quell'applicazione dell'analogia che è la quaestio de divinis nominibus. Il rapporto Creatore-creatura, letto come rapporto di causalità-partecipazione, che sta alla base della dottrina tomistica dell'analogia, si traspone coerentemente sul piano linguistico. Se tra il Creatore e la creatura c'è un legame di
causalità-partecipazione, e se la nostra conoscenza dì tale legame va dalle creature al Creatore, non viceversa, anche l'attribuzione di eventuali nomi a Dio partirà dal linguaggio delle cose create, e riferirà a Dio quelle perfezioni e quei cor6 9
NICOLETTI, «L'analogia in S. Tommaso», 129s, 140s.
183
rispondenti nomi che la «differenza ontologica» tra la Causa prima e i suoi effetti creaturali consentono di attribuire. La quaestio de divinis nominibus perciò
non è altro che la determinazione e l'articolazione, a livello esplicitamente linguistico, delia dottrina dell'analogia, che è già di per sé una semantica della
causalità-partecipazione. In breve, per san Tommaso, la creazione e pertanto la
causalità-partecipazione costituiscono il fondamento dell'attribuzione dei
«nomi divini».
L'analogia di proporzionalità, osserva ancora l'Angelico, si può realizzare
sul piano linguistico in due modi: in modo «simbolico» o «metaforico», quando,
per esempio, Dio viene chiamato luce, roccia e così via; in modo «proprio»,
quando, per esempio, Dio viene chiamato essere, bene e così via; nel primo caso
si applicano a Dio delle perfezioni sensibili legate alla materia; nel secondo caso
si applicano a Dio delle perfezioni semplicemente intelligibili slegate dalla materia. Dio in realtà non è propriamente luce o roccia: queste perfezioni sussistono
in lui solo come causa produttrice e perciò virtualmente, e possono essere dette
di lui solo impropriamente, secondo un linguaggio legato all'immaginazione e
alla sensibilità. I nomi divini che designano delle perfezioni intelligibili corrispondono invece davvero a qualcosa di sostanziale in Dio. Di conseguenza l'essere, che prima dell'uno, del vero e del bene, è la suprema perfezione intelligibile, è perciò, come già si è accennato, maxime proprium nomen Dei.
Affermando tutto questo, san Tommaso viene a dichiarare che il discorso
simbolico o metaforico, che riflette a livello di linguaggio la struttura ontologica
dell'analogia di proporzionalità, è nettamente inferiore rispetto al discorso analogico proprio o concettuale. Ecco però una domanda di non poco conto: rivendicandosi, cioè, da parte di san Tommaso, un indiscutibile primato del puramente intelligibile sul simbolico e sul metaforico, non si svaluta drasticamente
quanto costituisce invece gran parte se non la totalità del linguaggio della rivelazione biblica? E se non riesce a render conto in modo adeguato della parola
umana di cui normalmente si appropria la parola di Dio, potrà mai la dottrina di
san Tommaso giustificare adeguatamente il discorso teologico propriamente cristiano? E se non vi riuscisse pienamente, non si mostrerebbe quanto meno l'insufficienza dell'analogia così come viene intesa da san Tommaso?
Già da questa obiezione si comincia forse a intravedere a quali difficoltà, e di
non poco peso, possa andare incontro la dottrina tomistica dell'analogia. Da
quando si è assimilata, da parte dei cristiani, la convinzione tutta greca del primato indiscusso del pensiero astratto e del puramente intelligibile, diventava
ineluttabile che si guardasse con sufficienza, se non con disprezzo, alla testimonianza della Scrittura e comunque ci si sentisse in dovere di trasformarla in idee
70
n
72
Ivi, 1 4 7 .
Cf. sopra nota 43.
V . MELCHIORRE, La vìa analogica, 2 8 9 - 2 9 4 , osserva che almeno in alcuni casi, per es. a proposito di termini come spiritus, verbum, lux ecc., san Tommaso «trasgredisce» i normali limiti impostigli
dal primato del puramente intelligibile, riconoscendo che la Scrittura può ben affidarsi al linguaggio
della metafora, perché da ultimo hic modus est convenientior cognitioni quam de Deo habemus in hac
vita (De humanitate J.C.D.N., a. 14).
70
71
7 2
184
astratte, il più possibile chiare e distinte. Naturalmente non si sospettava neppure che queste stesse idee corressero il rischio di sfumare in misere ombre e
larve fallaci del discorso teologico, che dovrebbe invece legittimarsi a partire
dalla stessa rivelazione biblica. In ogni caso, non si era per nulla sfiorati dall'ipotesi di poter mettere in discussione l'ovvia, incontestabile supremazia del puramente intelligibile o del presunto tale rispetto al sensibile, al metaforico, al
simbolico.
Un'estrema fruttificazione di questo antico e tenace convincimento, che ha
attraversato tutto il medioevo ed è giunto nel cuore dell'età moderna, potrebbe
essere colto fin nella speculazione di Hegel, il quale, pur affermando che la filosofia condivide lo stesso contenuto (der Gehalt ist derselbe/), lo stesso oggetto
della religione assoluta cioè del cristianesimo, affida però alla filosofia il compito
di «pensare» questa stessa verità. Alla religione e pertanto alla teologia spetterebbe «il linguaggio del sentimento (des Gefiihls), della rappresentazione (der
Vorstellung) e anche del pensiero intellettivo (des Verstandigen), la cui dimora è
nelle categorie finite e nelle astrazioni unilaterali», alla filosofia invece «il linguaggio del Concetto concreto (des konkreten Begriffs)».
Ma c'è di più. Una volta che, nell'orizzonte delineato dalla quaestio de analogia, si affermi il primato del puramente intelligibile sul metaforico e sul simbolico, non soltanto diventa problematico adeguarsi compiutamente alle esigenze
della rivelazione biblica, ma a questo punto è pure dallo stesso versante metafisico che si affacciano degli interrogativi inquietanti.
Che cosa infatti è propriamente analogo: l'essere o l'ente? Si equivalgono e
sono perciò interscambiabili fra loro queste due formule: «analogia dell'essere»
e «analogia dell'ente»? L'ente è ciò che è, ed è in quanto ha l'essere, ma l'essere,
in se stesso, può mai paragonarsi, per non dire confondersi, con gli enti? Non si
ha forse, come ha ostinatamente ripetuto Heidegger, una «differenza ontologica», quella appunto fra ente ed essere, che è, e resta intrascendibile? Lo stesso
Heidegger ha accusato, del tutto senza fondamento, la storia del pensiero occidentale di «oblio dell'essere» (Seinsvergessenheit)?
Una volta che l'analogia venga applicata a comprendere il legame che avvince e struttura gli enti, l'essere appare quell'unum rispetto al quale gli enti non
sono che sue determinazioni. Se però l'analogia viene applicata non all'ente,
ma all'essere stesso, che cosa accade? Si potrà mai dire che l'essere è analogo? E
analogo a che cosa? L'analogia può qualificare l'essere solo come una totalità al
cui interno si articolano quelle determinazioni che sono appunto gli enti. Ma se
si prende l'essere nella sua insormontabile differenza rispetto agli enti, a che
cosa d'altro lo si può riferire se non al nulla? L'essere, in quanto tale, non lo si
può che scoprire sciolto da qualsiasi rapporto ad alcunché. L'essere non può
dirsi analogo, poiché al di fuori di sé non ha altro che se stesso oppure il nulla.
Considerando perciò le cose a fondo, si è costretti a dire che l'essere in quanto
73
74
G . W . F . HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1830), Testo tedesco a
fronte, Intr., tr., note e apparati di V. CICERO, Milano 1996, Prefazione alla seconda edizione, 57.
Cf. MOLINARO, «Domande sull'analogia», in 30.
7 3
74
185
tale è univoco. Ma a questo punto che senso avrà parlare di «analogia dell'essere»? Si potrebbe e dovrebbe invece parlare soltanto di «analogia dell'ente», in
quanto l'essere al suo interno si determina secondo la molteplicità degli enti,
rappresentando la totalità unificata dei rapporti reciproci fra gli enti. L'«analogia dell'ente» si costituisce appunto in base aìYordo ad unum di tutte le cose all'essere stesso. «Il più bello di tutti i legami» e cioè l'analogia sembra dunque riguardare l'ente, non l'essere, mentre, in virtù dell'orde» ad unum stabilito dall'essere, l'ente si assoggetta a una gerarchia per la quale l'analogia di proporzionalità deve ricondursi, come al suo fondamento, all'analogia di attribuzione.
Ma tutto ciò neppure basta. L'analogia, si sa, tenta di incunearsi fra l'univocità e l'equivocità. Ebbene non solo l'equivocità, ma pure l'univocità sembra
comportare essa stessa la differenza, al punto che si potrebbe avanzare la tesi
che l'univocità assoluta non si verificherebbe come tale né nel linguaggio né nel
pensiero né nella realtà. L'ordo ad unum, che si ritrova nell'analogia di attribuzione, sembra quasi comunicarsi per contagio alla stessa univocità. Il classico
esempio, di origine aristotelica, della sanità attribuita all'uomo, alla medicina, a
un volto e così via( rappresenta la figura di quell'orde ad unum che viene stabilito dall'analogia dì attribuzione. Si pensi però a un altro esempio: a un termine
come «rosso». Rosso si dice di un fiore, di un tramonto, di un volto e così viaMa, se prestiamo attenzione, questo univoco significato di rosso comincia a mostrare al suo interno delle fratture. Il rosso, in quanto è «il rosso», è tutti i rossi
che si incontrano nella realtà. Infatti quando si dice «il rosso», non si esclude
nessun elemento del rosso, nulla di ciò che gli appartenga: «il rosso» è tutti i
rossi. Ma, quando in riferimento a un individuo concreto come un fiore, un tramonto, un volto, si dice rosso, si dice insieme tutto il rosso, ma si dice anche il
rosso nella sua individuale differenza: il rosso di questo fiore, non è «il rosso»,
ma il rosso di questo fiore come di questo tramonto e così via.
Il linguaggio, dunque, nel suo stesso realizzarsi, non è mai del tutto univoco:
attua sempre una sintesi tra l'unità e la differenza di questa stessa unità. Essere-pensiero-parola stabiliscono così una circolarità o, per meglio dire, una pericoresi. Un'indagine globale sull'analogia non potrebbe configurarsi diversamente che come indagine su questa pericoresi. Ma, da quanto si è finora considerato, emerge pure che l'indagine sull'analogia e sulla compenetrazione di esserepensiero-parola non è mai «neutrale», né può esserlo: risulta sempre storicamente condizionata all'interno di una determinata, presupposta «visione del
mondo», della quale cerca di comprendere l'intima struttura già di per sé data. E
tutto questo vale, a proprio modo, per il pensiero antico e medievale come per
quello moderno e contemporaneo: la riflessione sull'analogia viene sempre
dopo, anch'essa come la civetta di Minerva. Non a caso l'analogia scrutata all'in75
76
77
Ivi, 31.
Ivi, 29s.
Cf. anche a questo proposito le preziose analisi di MELCHIORRE, «La differenza e l'origine: alle
sorgenti dell'analogia», in La differenza e l'orìgine, 3-19; ID., «Linguaggio analogico e linguaggio dell'essere», in Metafore dell'invisìbile, 59-90; ID., Essere e parola. Idee per una antropologia metafisica,
Milano 1990, part. 166-190.
75
76
77
terno dell'onto-teo-logia greca è stata costretta a modifiche e adattamenti una
volta che è stata trapiantata sul suolo dell'onto-teo-logia cristiana. Lo si vede, in
modo paradigmatico, in Tommaso d'Aquino rispetto, per esempio, ad Aristotele. Creazione, partecipazione e analogia si sono così ìntimamente ed essenzialmente legate nel suo pensiero da stare e cadere insieme, senza alcuna possibilità
di perfetta identificazione con quanto aveva a suo modo pensato il filosofo. Non
di meno la pur nobilissima risposta alle domande sull'analogia da parte di san
Tommaso d'Aquino si sottrae a qualsiasi problema.
Se, infatti, si sostiene che tra Dio e il mondo c'è analogia, in che modo si
comprenderà poi questa analogia? Se tra Dio e il mondo si realizzasse una reciproca, perfetta analogia, si verrebbe a sostenere che Dio si troverebbe allo stesso
livello del mondo, entrando in un rapporto determinato con il mondo, impigliandosi così nella rete della finitezza e assoggettandosi a essa. Si dovrebbe piuttosto
precisare, come insinua lo stesso san Tommaso, che è il mondo a essere analogo
a Dio, non viceversa, poiché è il mondo che è necessariamente legato a Dio, non
Dio al mondo. Ma se non è analogo al mondo, Dio in se stesso non è analogo affatto. Il movimento dell'analogia ha dunque una direzione unica e irreversibile:
non da Dio verso il mondo, ma, al contrario, dal mondo verso Dio, svolgendosi
lungo la traiettoria di una relazione, per così dire, ascendente dalla creatura al
Creatore, che non corrisponde per nulla all'altra relazione, quella dal Creatore
alla creatura.
Questa asimmetricità della relazione tra Dio e mondo è stata definita dall'Angelico relatio non ex aequo e nella tradizione scolastica «relazione mista»
(cf. c. 7.3 e 7.6). Essa rappresenta una geniale invenzione, che permette di comprendere il vincolo prodotto dalla creazione e il conseguente rapporto che legittima l'analogia, per un verso, evitando Vaut-aut e, per un altro verso, affermando
Yet-et tra Dio e mondo: la nulla proportio finiti ad infinitum viene nello stesso
tempo coordinata con la connexio finiti ad infinitum. Dio e mondo sono sì in rapporto, ma in modo tale che i due termini di questo rapporto non sono per niente
equiparabili. L'«mfinita differenza qualitativa» li separa e insieme li unisce: Dio
si rapporta al mondo nella libertà, il mondo si rapporta a Dio nella necessità.
Dio può essere senza mondo; il mondo non può essere senza Dio. Quando si dichiara che noi possiamo parlare analogicamente di Dio, si viene perciò a presupporre la creazione del mondo da Dio. L'analogia è possibile e anzi reale soltanto
in virtù di questo rapporto di dipendenza della creatura dal Creatore: unicamente sulla base di questo vincolo onto-logico si dispiega Tana-logico poter dire
Dio nel linguaggio.
Ma pure a questo punto sorgono dei problemi. La relatio non ex aequo tra
Dio e il mondo, se viene stabilita dalla creazione, proprio su questo fondamento
deve riguardare l'essere e, insieme, la totalità delle sue determinazioni. Si dovrebbe cioè sostenere l'istituzione di un rapporto in forza del quale effettivamente l'essere sia l'essere e nella sua totalità possa costituire una totalità di rap78
Cf. A. MILANO, «II "divenire di Dio" in San Tommaso d'Aquino», in Atti del Congresso Internazionale Tomistico, Napoli, 1976, III, 355-365.
78
187
porti molteplici e unificati. Ma l'essere in se stesso, come si è visto, non è analogo. L'analogia come qualificazione strutturante la totalità degli enti va allora
insieme con la qualificazione dell'univocità essenziale dell'essere in quanto tale.
Orbene, in questa situazione paradossale, quella cioè degli enti che sono analoghi e dell'essere che è univoco, dobbiamo chiederci: i termini di analogia e di
univocità riescono a sopportare davvero il peso speculativo che si vuole loro addossare? La «differenza ontologica», con il suo corollario dell'esse commune,
che è irrelato, non analogo, non rende problematica la stessa idea di creazione?
Se il mondo è infatti analogo a Dio, e in esso gli enti sono analoghi tra loro, resta
il problema dell'Essere che è Dio, che pone in essere una molteplicità di enti,
che sono sue partecipazioni e quindi analoghi a lui, mentre lui, in quanto Ipsum
esse subsistens, è irrelato, non è analogo ad alcunché, e neanche può esserlo.
Se dunque l'essere stesso non trova al di fuori di sé niente che possa permettere di dirlo analogo ed è perciò univoco, come si dà origine all'analogia? In altri
termini, in che modo la creazione può rappresentare «l'istituzione stessa dell'analogia», una volta che si spalanchi invalicabile la «differenza ontologica» fra
l'esse commune e l'ente, e, insieme, fra questo esse commune e VIpsum esse subsistens? Bisogna certo farsi molto attenti a non lasciarsi condurre a ipostatizzare
l'essere in quanto tale e a non ragionare sull'Essere che è Dio ritenendolo in nostro dominio: l'immaginativo connesso col linguaggio potrebbe tenderci simili
tranelli. I concetti estremi trapassano nell'ineffabile e la rincorsa per affacciarsi
sul mistero non deve consentirci l'illusione di metterlo a nostra completa disposizione: di Dio e, a suo modo, dell'essere non si dice sempre che si sa più quello
che non è, anziché quello che è?
In ogni caso, come è stato insinuato, si avverte nel tomismo una traccia, neppure tanto lieve, dell'eredità parmenidea. Per san Tommaso infatti l'essere è
ciò che è ultimo e intranscendibile: non solo è ciò che esclude il nulla, ma è anche
ciò che espunge da sé ogni negatività. La verità dell'essere, come fondamento
abissale dell'ente, si identifica con la verità dell'essere come esclusione del negativo. Ma per salvaguardare l'intrinseca esigenza di positività assoluta, che è poi
l'esigenza espressa nel principio dell'atto puro, l'essere deve venir distinto dall'ente, dall'essere dell'ente e insieme dall'Essere sussistente. Il problema che si
apre all'interno della metafisica, e che si riverbera inevitabilmente sulla stessa
dottrina dell'analogia, è che la «differenza ontologica» tra ente ed essere non
sembra facilmente superabile nella differenza metafisica tra ente ed Essere per
sé sussistente.
Il problema dell'invalicabilità della «differenza ontologica», obliato nella
storia del pensiero, quanto meno nel tempo della modernità, viene imposto con
veemenza ai nostri giorni dalla meditazione heideggeriana: non gli si può sfuggire. Ma in tal modo ne viene pure coinvolta la quaestio de analogia. Stando la
«differenza ontologica» fra essere ed ente, a rigore, si dovrebbe lasciar cadere
ogni discorso sull'essere, ogni linguaggio che tenti di dire Vessere in quanto es79
80
79
RI)
188
Cf. MOLINARO, «Domande sull'analogia»,
NICOLETTJ, «L'analogia in S. Tommaso»,
33.
173s.
sere: l'essere infatti si dice di tutto ciò che è, ma dell'essere stesso, con precisione
e adeguatezza, non si può dire nulla, pena trasformarne la verità in una rappresentazione. L'essere è Va quo di ogni pensiero e di ogni linguaggio e, proprio per
questo, non può mai diventare oggetto di attribuzione nemmeno analogica.
Ecco perché Heidegger, proprio martellando insistentemente sulla «differenza
ontologica», non riesce più, da filosofo, a dire qualcosa su Dio, proprio mentre
viene spinto a oscillare continuamente nel suo discorrere sul rapporto tra Dio e
l'essere e pertanto sull'onto-teo-Iogia.
Da una parte infatti Heidegger può sostenere:
81
«Essere e Dio non sono identici e io non tenterei mai di pensare l'essenza di Dio mediante l'essere. [...] La fede non ha bisogno di pensare l'essere. [...] Ho molte riserve a
ritenere che l'essere sia adatto per pensare teologicamente l'essenza di Dio. Con l'essere in questo caso non si può ottenere nulla».
82
D'altra parte però lo stesso Heidegger può anche continuare dicendo che
«tuttavia l'esperienza di Dio e della sua rivelazione (in quanto essa incontra
l'uomo) avviene nella dimensione dell'essere, il che non significa mai che l'essere possa valere come predicato possibile di Dio». «Se Dio è Dio - ha potuto
affermare ancora Heidegger in un'altra circostanza -, avviene a partire dalla costellazione dell'Essere e all'interno di questa» (Ob Gott Gott ist, ereignet sich aus
der Konstellation des Seins und innerhalb ihrer). Insomma, a quanto pare, sulla
via rigorosamente onto-logica, per Heidegger, non è deciso nulla né di negativo,
né di positivo su un possibile essere per Dio, anche se per questa stessa via si
può, anzi si deve porre il problema del rapporto dell'ente e dell'essere con Dio.
Coglie dunque perfettamente nel segno Karl Lowith allorquando dichiara:
83
84
85
«Ma, fondamento sotterraneo di tutto ciò che Heidegger da sempre è venuto enunciando, voce che desta e si fa ascoltare intentamente da molti, è un motivo che resta
non mai enunciato - il motivo religioso, separato dal contesto della fede cristiana, ma
proprio per questa sua indeterminazione rispetto ai legami di qualsiasi formulazione
in dogmi, tanto più consono al sentire di coloro che non sono più cristiani credenti,
ma pure vorrebbero essere religiosi».
86
Rimane però che, in concreto, questa via non è se non un sentiero, che può
anche interrompersi del tutto, lasciando smarriti, oppure può terminare ai bordi
di un fiume, al di là del quale non si può passare senza aver prima lottato con
l'angelo o, meglio, senza essere prima stati vinti da chi solo può aiutare a passare
Ivi, 174.
HEIDEGGER, Seminari, 207 (si tratta di un seminario tenuto a Zurigo nel 1951). Cf. a questo
proposito J.-L. MARION, Dio senza essere (1982), Milano 1984, 60, e nota 26.
Ivi.
M. HEIDEGGER, «Die Kehre», in Die Technik und die Kehre, Pfullingen 1962, 46. Per il pensiero di Heidegger sull'analogia cf. anche J.B. LOTZ, «Identità e differenza in un confronto critico con
Heidegger», in La differenza e l'origine, 280-301.
Cf. M. HEIDEGGER, Dell'essenza del fondamento, Milano 1 9 5 2 , 5 8 , n. 56.
K. LOWITH, Saggi su Heidegger (1960), Torino 1966, 130.
81
8 2
83
84
85
86
189
all'altra riva, quella della rivelazione e della grazia. In ogni caso, la quaestio de
analogia nasce, si sviluppa, si complica ed entra in crisi all'interno della storia
della metafisica come ricerca della verità dell'essere. Una volta che emerga in
tutta la sua drammaticità la «differenza ontologica», non è più concesso pensare
la differenza tra essere ed ente come rapporto analogico. Ma allora si impone
anche un ripensamento della teologia e, in questo quadro, una riconsiderazione
della quaestio de analogia, storicamente configuratasi su quell'onto-teo-logia tenacemente coltivata in regime cristiano, che non ha mai superato del tutto l'eredità greca, in generale, e parmenidea, in particolare, anche se ha cercato di armonizzare questa stessa eredità e di fonderla con la dottrina biblica della creazione. Se la teologia è ineluttabilmente collegata con la riflessione sull'essere,
l'ombra della «differenza ontologica», che mette in crisi il pensiero dell'essere,
non si stenderà forse sulla stessa riflessione intorno a Dio? E se l'essere invita al
silenzio, l'Essere sussistente non imporrebbe anch'esso di tacere e ancora più
imperiosamente?
5.5. «CIÒ C H E È D E G N O DI DIO».
L ' A N A L O G I A GIUDICATA DALLA CRISTOLOGIA
Dove dunque si potrà giungere quando ci si mette in cammino sulla via dell'essere? A quale idea del divino si potrà mai arrivare percorrendola? Se in forza
della «differenza ontologica» già l'essere stesso risulta inoggettivabile e dunque
ineffabile, che ne sarà del divino? Il divino, scrutato percorrendo la via dell'essere, potrà non condividerne lo stesso destino di impensabilità e di indicibilità e
alla fine potrà non esserci lo sbocco apofatico? Come dunque sui sentieri interrotti dell'essere, alla fine di tanta tribolazione, si potrà mai intravedere la luce
del volto del Dio di Abramo e di Gesù Cristo?
Ai greci, che hanno scrutato la verità dell'essere, non è mancato certo il genio e lo zelo per attingere insieme il sublime religioso. Di fatti, proprio muovendosi all'interno di quel loro orizzonte ermeneutico, hanno scoperto la trascendenza del numinoso cosmico e alla fine la sua stessa ineffabilità. Almeno fin da
Senofane essi hanno appreso che c'è «un solo Dio, il più grande tra uomini e
Dèi, né per la figura né per i pensieri simile ai mortali». Fu così che da Senofane venne loro insegnato, come poi riconobbe Aristotele, la singolarità del principio supremo. Ebbene proprio Senofane esprime per la prima volta un motivo
che, mentre rappresenta la vera e propria interiore scaturigine del suo pensiero,
lascia pure intravedere la logica secondo la quale l'intera sapienza greca, centrata sulla verità dell'essere, elaborerà in seguito la sua caratteristica concezione
del divino. A ben vedere, quella di Senofane non è un'argomentazione, anzi
87
88
89
8 7
SENOFANE, D . K . , B 23.
Cf. ARISTOTELE, Metaph. A 5, 986 b ISss.
Per quanto segue, cf. W . JAEGER, La teologia dei primi pensatori greci (1953), Firenze 1971,
80-82. Ma si veda anche A. MILANO, «Senofane o della immobilità di Dio», in Asprenas 21(1974), 4788
89
190
non è neppure un'istanza strettamente filosofica. Senofane nega agli dèi qualsiasi difetto o limite semplicemente in forza di un immediato sentimento religioso che egli avverte dinanzi alla maestà del divino.
Tutto ciò viene da lui espresso con chiarezza ed efficacia quando proclama
che Dio «rimane sempre nello stesso luogo immobile né gli si addice spostarsi di
qua e di là». II verbo usato qui da Senofane per esprimere il convenire o meno
a Dio di qualcosa, epiprépei, non si ripete in nessun altro frammento, ma svela lo
stesso criterio di tutta la sua denuncia dell'antropomorfismo. Le qualità umane,
troppo umane addossate agli dèi omerici o esiodei, come la figura, la parola, la
nascita, per non dire l'immoralità, non sono «convenienti» alla natura del divino.
In questo concetto di «convenienza», che troviamo per la prima volta applicato a
Dio in Senofane, traspare una delle esigenze fondamentali dello spirito greco,
che non si trattiene certo nel solo campo religioso, ma si irradia anche in quello
etico e politico, anzi nell'intera comprensione della realtà.
Da Senofane a Platone e Aristotele fino a Plotino l'istanza della sublimità
del divino non sarà mai abbandonata dal pensiero greco, si affinerà anzi sempre
più. Per la categoria del «Conveniente a Dio» la lingua greca conierà perfino
un'espressione particolare: theoprepés. Dagli stoici, da cui forse deriva, l'espressione passerà ai padri della chiesa presso i quali diventa uno dei criteri decisivi
per l'elaborazione della teologia cristiana. Come appare fin da Senofane e sarà
sempre più rigorosamente ribadito, i greci hanno dunque compreso e insegnato
che la nostra idea di Dio deve concordare in tutto e per tutto con ciò che è appunto «degno di Dio». Se Dio è veramente (orthòs) Dio, non può che essere al di
là dì ogni difetto o limite e dunque al di là di ogni antropomorfismo.
Se però, come diceva Platone, è «al di là di tutto», Dio non è forse pure al di
là della parola che vorrebbe designarlo? Pur con irriducibili, interne diversità e
contrapposizioni, è questa un'eredità del pensiero greco di cui si arricchiranno i
cristiani: un acutissimo senso della trascendenza del divino, che si protende sino
all'apofasia. Una delle testimonianze più significative e anzi emblematica del
trapianto di questa istanza greca nella speculazione cristiana è quella dello
Pseudo-Dionigi: «La Causa buona di tutte le cose - egli afferma - si può esprimere con molte parole e con poche, ma anche con l'assenza assoluta di parole»;
ma l'Areopagita aggiunge pure che «là il discorso [.„], a mano a mano che si innalza, si abbrevia; e, finita l'ascesa, si fa complessivamente muto e si unirà totalmente a Colui che è l'inesprimibile».
Certo i padri fondano primariamente sulla Scrittura la loro idea di Dio. Non
di meno la loro percezione viene stimolata e acuita da quella preparatio evangelii
che al loro sguardo appare la filosofia dei greci. Dai cappadoci a Giovanni Da90
91
92
9 0
SENOFANE, D . K . , B 2 6 , 2.
PLATONE, Rep. II, 3 7 9 a. Per
la precisione bisognerebbe aggiungere che la dialettica negativa
fu istituita propriamente da Piotino e venne sviluppata nella sua estesa problematica da Proclo. Cf. a
questo proposito BEIERWALTES, Proclo, 3 7 2 e nota 5.
PSEUDO-DÌONÌGÌ, Myst. Theol. I, 3: PG 3, 1 0 0 0 . 1 0 3 3 . Sul debito in questo campo dei padri, in
generale, e dell'Areopagita, in particolare, nei riguardi del pensiero antico, soprattutto di quello neoplatonico cf. ancora BEIERWALTES, Proclo, 3 6 2 - 3 9 6 .
1,1
9 2
191
masceno passando appunto per lo Pseudo-Dionigi, si legge la Scrittura, per
esempio i suoi testi chiave: «Io sono colui che sono» (Es 3,14); «Dio nessuno l'ha
mai visto» (Gv 1,18), «né lo può vedere» (lTm 6,16); «Nessuno conosce il Figlio
se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio» (Mt 11,27); e si fa l'ermeneutica di questi e di tanti altri testi biblici, che esaltano l'alterità divina, sensibilizzati dall'ammaestramento dei greci. «Concepire la divinità - aveva detto
Platone - è impresa difficile e a chi l'ha concepita è impossibile enunciarla». Ed
ecco che si pensa di obbedire al dovere di riconoscere e attestare la trascendenza
divina trasferendo l'impulso all'oltrepassamento nel linguaggio sotto forma di
negazione.
Il linguaggio, per essere theoprepés e cioè degno di Dio, deve autolimitarsi. E
così, se non vuole del tutto annichilirsi nel silenzio, il linguaggio deve dire la negazione. La negazione è il silenzio detto nel linguaggio. Dio, poiché è oltre ciò
che è, può esprimersi soprattutto con la negazione di ciò che è. Il discorso negativo o apofasi deve pertanto preferirsi a quello positivo o catafasi: «in riferimento al divino - dichiara sempre lo Pseudo-Dionigi - le negazioni (apophàseis)
sono vere, mentre le affermazioni (kataphàseis) sono insufficienti». A questa
ben radicata e salda tradizione si collega, per esempio, anche Tommaso d'Aquino quando dichiara: de Deo non possumus scire quid est, e pertanto convenientissimus modus significandi divina fit per negationem. In tal modo, dai greci
attraverso i padri, la teologia scolastica e fino a noi, si tenta di «cogliere il Dio irrangiungibile con il linguaggio mediante una autolimitazione del linguaggio».
Ma, accogliendo quel lascito del pensiero greco, l'istanza cioè delPoltrepassamento mediante il linguaggio della negazione, non si trapassa alla fine nella
negazione del linguaggio? Intanto la stessa analogia si è venuta realizzando sul
piano linguistico e concettuale in una dialettica di affermazione-negazioneeminenza. Ma nel modo in cui finora questa dialettica è stata compresa e usata
ci si è adeguati perfettamente al peculiare, originale messaggio della fede cristiana? E, inoltre, che cosa è stato più grave, nella vicenda storica dell'onto-teologia in regime di cristianità, nel cui quadro si colloca la specifica determinazione della quaestio de analogia: che abbia prevalso «l'oblio dell'essere» (Seinsvergessenheit) o, per così dire, «l'oblio di Cristo» (Christusvergessenheit)?
Certo, anche il Dio di Abramo e di Gesù Cristo è di per sé inafferrabile alla
presa dell'uomo. «Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio d'Israele salvatore!» aveva confessato Isaia (45,15). Ma, insieme, di questo Dio, che è come un fuoco
93
94
95
%
97
98
Tim., 28.
Cf. GIOVANNI DAMASCENO, De fide orth. I, 4: PG 9 4 , 8 0 0 .
PSEUDO-DIONIGI, De coel. hier. II, 3: PG 3 , 1 4 1 . A questo proposito, oltre a BRIERWALTES, Proclo, cf. anche A. GHISALBERTI, «Conoscere negando. Immobilità di Dio e fondamento in Dionigi
Areopagita», in La differenza e l'origine, 2 1 - 4 0 .
® TOMMASO D'AQUINO, S. Th., I, q. 1, a. ad 1; In I Seni., d. 34, q. 3, a. 3.
E. JUNGEL, Dio, mistero del mondo, 333.
Si pensi, per esempio, a come nello PSEUDO-DIONIGI, De div. nom., IV, 9: PG 3, 705 (cf. Myst.
Theol. IV-V: PG 3,1040,1045,1048), Paffermazione-negazione-eminenza venga a corrispondere alla
triplice figura del movimento rettilineo, spiraliforme o elicoidale e circolare, e cosi trovi applicazione
nella configurazione e articolazione della teologia, rispettivamente, in simbolica, dialettica e infine
mistica. Cf., a questo proposito, sopra c. 3.2, nota 20.
93
94
9 5
9
97
9R
192
ardente (Dt 5,24) e ha posto le tenebre come proprio nascondiglio (Sai 18,12),
sempre nella Scrittura, si dice che si rivela in molte occasioni e in molti modi, e
soprattutto che alla fine si automanifesta e si autodona «nel» suo proprio Figlio,
Gesù Cristo (Eb l,ls). Dio non è dunque un numinosum, fascinans et tremendum, cui non ci si possa mai accostare senza che arretri e si allontani sempre più
sino a dissolversi, non è un vuoto abisso che si spalanchi e inghiotta chi osa tentare di penetrarvi. Dal punto di vista biblico, in generale, e neotestamentario, in
particolare, Dio è sì un mysterìon, ma lo è in senso positivo, come una ricchezza
immensa (ICor 9,16), cui si può attingere arricchendosi sempre di nuovo. Dio
eccede sì infinitamente il potere dell'uomo, ma l'uomo lo può incontrare e di
fatti lo incontra e ciò perché egli stesso viene e si approssima, parla e si fa udire
senza che l'uomo ne resti sopraffatto e muoia. L'autorivelarsi e l'autodonarsi di
Dio, colui che dice di sé «Io» e si nomina «Io sono colui che sono» (Es 3,14), non
è dunque estrinseco o accessorio: «il fatto di essere reso manifesto appartiene
perciò all'essenza di questo mistero».
L'intelligenza neotestamentaria di Dio è stata certo affrontata dai cristiani
con l'aiuto fecondo dell'eredità dei greci. Il kerygma è diventato dogma e si è
elaborato come teologia attraverso un processo, per così dire, di inculturazione.
L'idea di Dio come mysterion di un «Io» personale, al quale ci si può sempre dischiudere e al quale di fatti si accede perché si autorivela e autocomunica, e dalla
sua «pienezza» (pleròmatos) «in» Gesù Cristo «noi tutti abbiamo ricevuto grazia
su grazia» (Gv 1,16), questa idea di Dio, stata esplorata nella vicenda dell'ontoteo-logia cristiana lasciandosi però contagiare da uno scetticismo ermeneutico o,
nel migliore dei casi, da una concezione dialettica, secondo la quale Dio rimarebbe completamente celato anche dopo essersi rivelato.
E, fatto singolare, tutto questo lo si è confermato da parte dei cristiani anche
a proposito dell'evento Cristo. Infatti, dice quell'autore-destino della teologia
anche dell'occidente che è lo Pseudo-Dionigi,
99
«il Soprasostanziale fattosi uomo è venuto dal suo mistero al nostro cospetto. Però
egli rimane occulto anche dopo la sua manifestazione o, per parlare più divinamente,
nella sua stessa manifestazione siffatto mistero di Gesù rimane nascosto e non può essere spiegato da nessuna ragione e da nessuna intelligenza, ma anche quando se ne
parla, rimane ineffabile, e quando si pensa rimane ignoto».
100
Cristo, per lo Pseudo-Dionigi, è certo veramente uomo, ma non è soltanto
uomo, e perciò «non è meno traboccante di soprasostanzialità, egli che è sempre
soprasostanziale, evidentemente per l'abbondanza della sua natura superiore».
Sicché, guardando le cose «con occhio divino», aggiunge sempre l'Areopagita,
«si conoscerà al di là dell'intelligenza che le affermazioni che riguardano l'amore
di Gesù per gli uomini hanno la stessa virtù di una negazione eccellente». Lo
101
102
9 9
! W )
JÙNGEL, Dio, mistero
PSEUDO-DIONIGI, Ep.
del mondo, 327s.
3: PG 3, 1069 (corsivo nostro). Cf. anche
mondo, 328s.
PSEUDO-DIONIGI, Ep. 4: PG
ID., Ep. 3: PG 3, 1069.
1 0 1
JONGEL,
Dio, mistero del
3, 1072.
1 0 2
193
Scoliaste ci spiega che qui, per l'Areopagita, «negazione eccellente» vuole significare che non si tratta di «negazione secondo privazione»: dicendo cioè che Cristo è uomo, non si vuole affermare che è un uomo come tutti gli altri, ma è sempre al di sopra dell'uomo: non a caso nasce da una madre vergine o compie dei
segni meravigliosi. Cristo, continua da parte sua lo Pseudo-Dionigi, «conseguentemente, non faceva le cose divine in maniera umana, né le umane in maniera umana, ma ha compiuto vivendo fra noi, a titolo di Dio reso uomo, una
nuova azione divina e umana (theandrikén enérgheiarì)».
Che la cristo-logia dello Pseudo-Dionigi sia piuttosto povera rispetto alla sua
sfolgorante teo-logia e faccia così pencolare l'equilibrio calcedonese verso un eccesso apofatico lo si può intravedere anche dalle conseguenze che vengono tirate
dall'affermazione di questa «energia teandrica» del Cristo appunto nel campo
del linguaggio. In generale, nella Scrittura, ci spiega ancora l'Areopagita, si presenterebbe una duplice tradizione: «una segreta e occulta, l'altra chiara e più conoscibile; l'una si serve dei simboli e riguarda i misteri, l'altra è filosofica e dimostrativa. Ciò che non si può dire s'incrocia con ciò che si può dire; l'una persuade
e conferma la verità delle cose dette; l'altra opera e colloca Dio mediante insegnamenti misteriosi e che non si possano insegnare». Non dovrebbe dunque
apparire casuale che la fertile, sontuosa, sfavillante invenzione linguistica dell'Areopagita finisca per soverchiare oltre misura la stessa lettera della Scrittura.
Quanto poi a Gesù Cristo, Egli stesso, secondo lo Pseudo-Dionigi, «parla di Dio
in parabole e ci dà i misteri divini sotto la figura di una cena». Anche dunque
le parole di Cristo, in generale, così come le sue parabole, in particolare, servirebbero, secondo lo Pseudo-Dionigi, a «mantenere incontaminato agli occhi dei
più il Santo dei santi».
A quanto si intravede in modo paradigmatico nello Pseudo-Dionigi, un potente impulso all'oltrepassamento del mondano nel discorso teologico, fuso col
terrore dell'antropomorfismo, si è dunque perpetuato e anzi radicalizzato lungo
tutto il processo di «cristianizzazione dell'ellenismo». E ha fatto scuola nella
teologia cristiana. Purtroppo, si sarebbe tentati di ripetere oggi insieme con
Heidegger: «non c'è chiacchiera peggiore di quella che trae origine dal discorrere e dallo scrivere sul silenzio». Rimane, in ogni caso, inquietante la domanda: nel linguaggio che dice la fede, concludere al benefico compito della
negazione, ma, insieme, alla supremazia del «silenzio divino», alla «bontà del si103
m
105
106
107
108
Cf. PG 4 , 5 3 3 . Gli scolii ci sono giunti e sono stati pubblicati sotto il nome di Massimo il Confessore, ma la maggior parte dì essi sarebbero di Giovanni di Scitopoli secondo H . U . VON BALTHASAR, «Das Scholienwerk das Johannes von Scytopolis», in Scholastìk 1 5 ( 1 9 4 0 ) , 1 6 - 3 8 ; testo riprodotto
in ID., Kosmìsche Liturgìe. Das Weitbild Maximus des Bekenners, Einsiedel 1 9 6 2 , 6 4 4 - 6 7 2 .
103
2
' PSEUDO-DIONIGI, Ep. 4: PG 3 , 1 0 7 2 .
PSEUDO-DIONIGI, Ep. 9, 1: PG 3, 1 1 0 5 .
PSEUDO-DIONIGI, Ep. 9, 1: PG 3, 1 1 0 8 .
1,17
Ivi. È verosimile che l'Areopagita si riferisca
10 ,
1 0 5
1 0 6
qui a Mt 1 3 , 1 3 : «Per questo Io parlo a essi in parabole, perché pur vedendo non vedono e pur udendo non intendono né comprendono». Nondimeno la sua interpretazione fraintende il senso della testimonianza evangelica.
M. HEIDEGGER, In cammino verso il linguaggio ( 1 9 5 9 ) , Milano 1 9 7 3 , 1 2 2 . Sul problema del silenzio nella storia del pensiero cf. in particolare i rimandi forniti da BEIERWALTES, Proclo, 3 7 1 - 3 9 6 e
nota 124.
,nR
194
lenzio», mentre si mortifica l'affermazione o, in breve, concludere alla apofasia e, pertanto, inesorabilmente, alla afasia, tutto questo è davvero un guadagno
per chi crede nell'incarnazione del Logos eterno «in» Gesù Cristo? Non è forse,
lui, Gesù Cristo, «.VAmén, il testimone fedele e verace» (Ap 3,14)? Con tutta
consapevolezza e serietà Paolo ha osato proclamare che «il Figlio di Dio, Gesù
Cristo, non fu "sì" e "no", ma in lui c'è stato il "Sì". E in realtà tutte le promesse
di Dio in lui sono divenute "il Sì" (to naì)\» (cf. 2Cor 1,19-20) (cf. c. 4.8). Affidando l'ultima parola al completo ammutolimento della parola, la teologia cristiana rende perciò davvero piena testimonianza a Colui che è «il Sì» e il Logos,
e cioè tutto Parola affermante? In ogni caso, l'originaria caratterizzazione neotestamentaria risulta condizionata, per non dire deformata. Per coerenza, quando
è stata affrontata la quaestio de analogia, il mistero del Dio cristiano è stato riproposto nello stesso modo in cui esso è stato colto alla luce della sola verità dell'essere, indebolendo cioè, se non annullando, la stupefacente, la scandalosa e
folle pienezza dell'evento Cristo: il suo reale farsi carne.
109
5.6. C O N T R O E PER L'ANALOGIA ENTIS.
BARTH, BONHOEFFER, PRZYWARA
Allorquando Barth, come già sì è accennato (e. 5.1), aveva reagito con veemenza contro l'analogia entis, elevata da Przywara allo statuto di «forma fondamentale di pensiero del cattolicesimo», e nel 1932, nel primo volume della Kirchliche Dogmatik, aveva definito questa impresa nientemeno come ^invenzione dell'Anticristo», non era stato spinto immediatamente da motivazioni cristologiche, bensì dalla sua teologia della rivelazione conseguente all'iniziale
svolta della teologia dialettica. Barth aveva allora riconosciuto sì la grandezza,
ma denunciato pure quella che aveva chiamato la miseria d'una pretesa conoscenza «naturale» di Dio così come aveva tentato di definirla il concilio Vaticano I . Egli rifiutava di comprendere il rapporto fra Creatore e creatura come un
rapporto di tipo «naturale», poiché ciò, ai suoi occhi, avrebbe reso necessario e
universale il rapporto fra Dio e l'uomo, che invece doveva essere affidato soltanto alla libera e gratuita signoria di Dio. La relazione tra l'infinito e il finito, a
suo giudizio, non poteva essere di tipo «ontologico», non poteva cioè comportare un «essere» che accomuni in qualche modo, al di là di qualsiasi dissomiglianza, Dio e uomo. Solo la sovrana condiscendenza della grazia, secondo
Barth, potrebbe porre, e sempre di nuovo, la relazione tra Dio e uomo, mante110
m
1 0 9
PSEUDO-DIONIGI, Div. nom. I V , 2. 22: PG 3, 6 9 6 . 7 2 4 .
Cf. E. PRZYWARA, Analogia entis. Metafisica. La struttura originaria e il ritmo
Intr. e trad. di P. VOLONTÉ, Milano 1995; K. BARTH, Die Kirchliche Dogmatik.
cosmico (1932,
1962),
Die Leher vom
Wort Gottes. Prolegomena zur Kirchlichen Dogmatik, Munchen 1932,1/1, Vili. A proposito del confronto Przywara-Barth si vedano E. MECHELS, Analogie bei Erich Przywara und Karl Barth, Neukirchen-Vluyn 1974; BIJU-DUVAL, Poi chrétienne etphilosophie de la connaissance. ÉUide d'Analogia entis d'Erich Przywara et contribution théologique au débat, Roma 1994; P. VOLONTÉ, Introduzione.
L'analogia ontologica come principio dinamico, in E. PRZYWARA, Analogia entis, XI-XXXVIII.
Denz 3008, 3026.
1,0
195
nendola nella sua trascendenza. L'essere di Dio, spiegava Barth, è perciò da intendersi esclusivamente come atto e anche nell'uomo non può che avvenire
come atto.
Non sarà forse inutile precisare che per atto Barth allora non intendeva certo
Vactus o enérghéia di tipo aristotelico alla maniera del medioevo cristiano e, in
particolare, del tomismo. L'idealismo tedesco aveva interpretato Vactus purus
come libera attività della ragione in contrapposizione all'essere inteso come sostanza necessariamente esistente, alla maniera cioè di Spinoza. In tal modo, a
stare al giudizio di Bonhoeffer, si sarebbero trovate schierate su fronti antitetici
la filosofia trascendentale, di ascendenza kantiana, centrata sull'atto, da una
parte, e un'ontologia centrata invece sull'essere come sostanza, dall'altra. Ed è
a questo orizzonte intellettuale che lo stesso Bonhoeffer faceva riferimento in
Atto ed essere, la sua tesi di abilitazione alla libera docenza (preparata tra il 1929
e il 1930 e pubblicata nel 1931), ed è all'interno di un orizzonte così descritto che
egli svolgeva la sua argomentazione, mentre sistemava non senza artificiosità lo
schieramento in campo delle forze sia filosofiche che teologiche.
In ogni caso, per Bonhoeffer, Barth si situava dalla parte del trascendentalismo. Questi infatti sosteneva che, se è per sua essenza sovratemporale, Dio è anche al di sopra dell'essere e non può dunque che agire come atto. Dio resta sempre il signore, martellava Barth, e colui il quale crede di avere Dio come cosa a
propria disposizione, in realtà non ha a che fare con Dio, bensì con un idolo. Dio
è perciò sempre il Dio veniente, mai il Dio che è qui stabilmente presente. Come
la manna del deserto non si poteva conservarla, ma si doveva raccoglierla e mangiarla giorno per giorno (Es 16,19-21) così anche la parola di Dio non si può presumere di tenerla continuamente in proprio possesso: accade sempre e soltanto
nell'evento della grazia, che avviene di volta in volta proprio mentre resta esclusivamente nelle mani di Dio. La relazione tra Dio e uomo, nella quale la rivelazione si partecipa effettivamente all'uomo, deve essere libera, non statica, continuava Barth, e la sua stessa costanza non rappresenta altro che la costanza di
un'azione che in ogni istante comincia, in senso proprio, dall'inizio. Nessun
istante storico è infatti capax infiniti. Ne consegue che, secondo Barth, la relazione di Dio con l'uomo non può mai essere intesa come vincolata all'essere,
sussistente, nella prospettiva dì una legge naturale o di una funzione naturale,
«ma sempre come attuale, cioè nella totale instabilità di un'azione che avviene
precisamente in questo momento».
A tutto questo Bonhoeffer aveva obiettato che l'attualismo puro di Barth e
la sua esaltazione della contingenza di Dio nella relazione con l'uomo non prendeva in considerazione la «realtà»: il fatto cioè che, rivelandosi, Dio comunque
esce fuori di sé, mette in gioco la sua parola come parola data, fondando un
patto al quale si vincola stabilmente. La libertà di Dio, dichiarava Bonhoeffer,
«trova la più alta dimostrazione proprio nel suo essersi-liberamente-legato al112
113
114
D . BONHOEFFER, Atto ed essere. Filosofia trascendentale e ontologia nella teologia sistematica
(1931), Ed. critica a cura di H . - R . REUTER, tr. di A. Gallas e C. Danna, Brescia 1993.
H . - R . REUTER, Postfazione del curatore, in BONHOEFFER, Atto ed essere, 153-154.
K. BARTH, Die christliche Dogmatik im Entwurf., 1: Die Lehre vom Worte Gottes. Pro legomena zur chrìstlichen Dogmatik, Miinchen 1927, 295.
1 1 2
1 1 4
l'uomo storico e nel suo essersi-messo-a-disposizione di esso. Dio non è libero
dall'uomo, ma è libero per l'uomo». Ma Bonhoeffer non si fermava qui. Come
ha mostrato dall'inizio alla fine della sua esistenza teologica, sempre conseguenzialmente svolgendo il discorso teologico in chiave cristologica per concretizzarlo poi in termini ecclesiologici, Bonhoeffer aggiungeva ancora contro Barth:
«È Cristo la parola della libertà di Dio; Dio è presente, cioè non è nella sua non
oggettività eterna, ma [...] lo si può "avere", lo si può cogliere nella sua parola
nella chiesa». In tal modo Bonhoeffer, da una parte, metteva a nudo la debolezza della barthiana idea attualistica di rivelazione e, dall'altra, affermava in positivo la consistenza dell'autodonarsi di Dio in Cristo e pertanto nella chiesa: «il
vincolo con la chiesa è la libertà di Dio». Quella di Barth, incalzava Bonhoeffer, era un'idea «formale» della libertà di Dio, non «reale», poiché la
«realtà» è che noi effettivamente siamo «in» Cristo in quanto siamo nella comunità di Cristo, dove Cristo si fa reale e dove si ha a che fare con un vero essere.
Con giovanile baldanza e drastica asprezza il ventiquattrenne Bonhoeffer poteva così concludere che, alla resa dei conti, nella concezione di Barth si pensava
la rivelazione come «non rivelazione» e alla fine «Dio non è compreso come
persona».
Oggi sappiamo che Barth non si sarebbe fermato alla «stazione» dove lo coglieva Bonhoeffer. Già a partire dalla sua ricerca sul pensiero di sant'Anselmo
(1931) egli avrebbe precisato le basi gnoseologiche del proprio pensiero, eliminando la «singolare crosta di concetti kantiano-platonici» dai quali era rimasto
irretito dal Commento alla Lettera ai Romani sino alla prima Dogmatica cristiana. Lungo l'incedere trionfale della Dogmatica ecclesiale sarebbe pervenuto appunto a L'umanità di Dio, aggiustando via via il tiro anche a proposito
della questione dell'analogia. D'altra parte, appena qualche tempo dopo Atto
ed essere, nel corso sulla Storia delle teologia sistematica nel XX secolo, tenuto tra
il 1931 e il 1932, lo stesso Bonhoeffer, proprio mentre aveva ribadito che Barth si
serviva del linguaggio filosofico neokantiano, aveva riconosciuto che egli era pur
sempre un teologo che non voleva per niente legare Dio alla sua teologia e ai
suoi concetti. Non sbagliava tuttavia Bonhoeffer a fiutare che l'iniziale teolo115
116
117
118
119
120
121
122
BONHOEFFER, Atto ed essere, 78.
Ivi (corsivo di B.). Cf. a questo proposito A . MILANO, «Chiesa per il mondo. Sulla ecclesiologia di Dietrich Bonhoeffer», in Rileggere Bonhoeffer [=«Hermeneutica», n. s.j, Brescia 1996, 43-102.
" BONHOEFFER, Atto ed essere, 112.
Ivi, 87.
Ivi, 113.
K . BARTH, Credo. Die tìauptprobleme der Dogmatik dargestellt im Anschluss and das Apostolische Glaubensbekenntnis, Miinchen 1935, 159.
Sulla questione dell'analogia in Barth si veda sopra la nota 2. II significativo intervento di
Bonhoeffer nel dibattito sull'analogia non ha finora ricevuto un'adeguata, specifica attenzione, almeno, a quanto pare, se si scorre la Internationale Bibliographie zu Dietrich Bonhoeffer - International Bibliography on Dietrich Bonhoeffer, a cura di E . FEÌL, unter Mitarb.-assist. B.E. FINK, Gutersloh
1998.
D . BONHOEFFER, «Storia della teologia sistematica nel X X secolo», in Scritti (1928-1944),
Brescia 1979, 226-227. È forse opportuno precisare che il testo di questo corso, nonostante sia stato
messo insieme sulla base degli appunti di un ascoltatore, conserva la forte impronta personale del discorso bonhoefferiano.
1 1 5
116
7
1,8
119
1 2 0
121
1 2 2
197
già dialettica corresse il rischio di dissolvere l'effettiva, storica condizione dell'uomo simul iustus et peccator dinanzi a Dio. L'interpretazione attualistica, aggiungeva Bonhoeffer, non rendeva giustizia al pensiero del Nuovo Testamento,
ma neppure a quello di Lutero. Il «sempre di nuovo», con il quale Barth voleva
allora esprimere il concetto della libertà radicale di Dio nella sua grazia, si poneva, a giudizio di Bonhoeffer, piuttosto nella linea della tradizione calvinista.
Ma «è biasimevole - aggiungeva ancora Bonhoeffer - che i luterani di oggi non
sappiano affatto delineare la comprensione luterana della rivelazione, nella duplice delimitazione nei confronti del pensiero sostanzialistico cattolico e dell'attualismo riformato».
Nello stesso momento in cui aveva rivendicato contro il calvinista Barth
un'intelligenza «ontologica» della relazione di Dio con l'uomo, in Atto ed essere
il luterano Bonhoeffer aveva pure reso l'onore delle armi al cattolico Przywara,
il quale, a suo giudizio aveva ricollocato l'analogia entis «con lucida sistematicità
al centro della filosofia della religione e della dogmatica cattoliche». Partendo
dal presupposto antiidealistico dell'assoluta priorità dell'essere nei confronti
della coscienza, la filosofia cattolico-tomistica di Przywara aveva disgregato, secondo Bonhoeffer, «il concetto di essere chiuso per principio per aprirlo alla trascendenza di Dio». Grazie a questa fondazione ontologica sembrava a Bonhoeffer che si fosse in qualche modo riusciti a dimostrare che «Dio non è imprigionato nell'Esserci, né quest'ultimo in Dio; ma come Dio è concepito da una
parte come assolutamente autonomo, così l'uomo, dall'altra, è concepito come
dotato di una propria relativa realtà nei confronti di Dio (causae secundae)\ il
concetto di similitudine richiede due sostanze che stiano l'una di fronte all'altra
e che siano relativamente indipendenti tra di loro». Da questa impostazione,
osservava Bonhoeffer, Przywara derivava, fra l'altro, il corollario della distinzione fra natura e soprannatura e quindi quello della dottrina sulla grazia. In tal
modo con Przywara il tomismo si mostrava in grado di interpretare l'Esserci
nella prospettiva della temporalità, senza però chiuderlo in se stesso».
Nondimeno, a giudizio di Bonhoeffer, restava pur sempre aperta la domanda
se Vanalogia entis fatta valere da Przywara esprimesse adeguatamente la trascendenza di Dio intesa in un senso propriamente cristiano o se, invece, non nascondesse anch'essa una metafisica dell'immanenza. Per parte sua, Bonhoeffer, lasciava chiaramente intendere che voleva tenere ben ferma la validità della classica protesta luterana contro il tradizionale rifiuto cattolico della giustificazione
per la sola fede, per la sola grazia. Se gli premeva sostenere l'implicazione ontologica del discorso teologico cristiano e dunque la congiunzione dell'atto con
l'essere nell'evento della rivelazione, non era però disposto a seguire fin in
fondo l'impostazione di Przywara. Riconosceva che la dottrina tomistica dell'essere considerava l'essere dell'uomo in quanto determinato nella sua essenza
123
524
125
126
137
123
1 2 4
125
126
198
Ivi, 2 3 1 .
BONIIOEFPBK, Atto ed essere,
Ivi, 60.
Ivi, 61.
61.
dalla creaturalità. Ci si doveva però domandare, sempre a giudizio di Bonhoeffer, se si dia un essere dell'uomo in generale, che non sia sempre già determinato storicamente come un essere «in Adamo» o un essere «in Cristo», come
un essere-colpevole o un essere-graziato, e che solo così specificato potrebbe essere compreso nel suo essere. Si potrà mai sostenere, in un orizzonte teologico
cristiano, una continuità tra il modo d'essere in status corruptionis e quello in status gratiaeì Con l'analogia entis di Tommaso-Przywara sembrava invece a Bonhoeffer che venisse garantita all'uomo, assieme alla continuità della condotta del
suo proprio essere, anche la continuità di quella dell'essere di Dio, cosicché l'essere dell'uomo, sia che si trovi «in Adamo» sia che si trovi «in Cristo», potrebbe
essere sempre certo della sua analogia con l'essere di Dio. Affinché la trascendenza di Dio non resti un'affermazione puramente formalistico-metafisica e abbia invece un senso teologico concreto, i modi di essere dell'essere «in Adamo»
o «in Cristo», secondo Bonhoeffer, dovrebbero essere compresi e interpretati
per se stessi, e non nei termini di un sistema aprioristico di comprensione naturale razionale.
In un'ontologia rigorosamente teologica, a giudizio di Bonhoeffer, la
«realtà» di Dio non è, in primo luogo, l'«È» puro e semplice, indifferenziato, ma
il fatto che Dio «è» il giusto, «è» il santo, «è» l'amore. Che l'«È» di Dio sia assolutamente inseparabile dalla sua determinazione concreta dovrebbe restare il
presupposto indiscutibile del concetto di essere valido in un'ontologia teologica
cristiana. Se si ignorasse questo dato di fatto, secondo Bonhoeffer, si distruggerebbe dalle fondamenta l'idea cristiana di rivelazione: la contingenza della rivelazione di Dio nella legge e nell'evangelo verrebbe ridotta, con ulteriori opportune modificazioni, a una dottrina generale dell'essere. Ma in tal modo si bloccherebbe la strada verso un concetto di peccato e di grazia autenticamente teologici. Dal concetto dell'analogia dell'essere si potrebbero di per sé derivare solo
determinazioni generali. Ma su questa linea non si sarebbe più in grado di pensare né colpa né grazia, e tutto dovrebbe essere già sostanzialmente premodellato nel concetto ontologico di similitudine fatto valere da Tommaso-Przywara
per Dio come per l'uomo. L'uomo, che si intravede nelYanalogia entis, sottolinea
Bonhoeffer, esiste nella tensione tra esse ed essentia, ma ritiene di avere in sé, già
come possibilità della sua propria esistenza, la possibilità di una visione dell'«È»,
cioè dell'identità di esse ed essentia propria di Dio. Ma, per questa strada, l'esistenza dell'uomo risulta essere comprensibile a partire da se stessa e Dio si trova
a esserle naturalmente accessibile.
Il tentativo di aprire il concetto di essere al trascendente intrapreso da Przywara condurrebbe perciò, sempre a giudizio di Bonhoeffer, a una trascendenza
solo apparente: «Il concetto ontologico di Dio proprio del tomismo non è in
grado di andare al di là di una metafisica intramondana». Ma, se le cose stanno
davvero così, per il luterano Bonhoeffer conquistato, per questo verso, dalla
,2fi
129
130
1 2 8
1 2 9
13U
Ivi,
Ivi,
Ivi,
61-62.
62-63.
63.
199
svolta della teologia barthiana della parola di Dio, ciò significherebbe che con il
tomismo avremmo a che fare con un pensiero che, nonostante tutto, non è capace di liberare il cor curvum in se con le sue proprie forze così come noi non
siamo capaci di compiere da noi alcun'opera buona senza la grazia. L'uomo, insiste Bonhoeffer, non può porsi da sé nella verità: questo glielo può permettere
solo il dono della rivelazione. L'unica relazionalità a Dio, che risulti valida nella
teologia cristiana, è perciò quella e solo quella che viene compresa sulla base
della rivelazione e cioè sulla base della parola detta da Dio sull'uomo nella legge
e dell'evangelo: «Solo un pensiero che "è" dalla verità, vincolato a Cristo nell'ubbidienza, - proclama Bonhoeffer - può porre nella verità». Nella teologia
cristiana non si può non avere a che fare con l'essere, ma solo a partire dalla rivelazione avvenuta e creduta si può pensare l'analogia dell'essere. La parola di
Dio, che pone l'Io nella verità, è un accadimento contingente: nella sua positività
può essere solo accettata o negata, e deve perciò essere presa come realtà effettiva, che ha il suo fondamento nella libertà di Dio, positivamente come darsi, negativamente come negarsi di Dio, e non può essere derivata da speculazioni che
deducano alcunché da una pretesa metafisica generale puramente razionale.'
Naturalmente dovremmo domandarci non solo se Bonhoeffer abbia contestato efficacemente l'attualismo di Barth, ma pure se egli, insieme con Barth, abbia correttamente interpretato l'analogia entis di Tommaso-Przywara. Intanto
non è inutile ricordare che, in seguito alla pubblicazione nel 1927 della Reli~
gionsphilosophie katholischer Theologie, Erich Przywara aveva ottenuto, fra i
teologi che si raccoglievano intorno alla bandiera della teologia dialettica innalzata da Barth, una clamorosa risonanza. Invitato a un seminario comune nel
1929, Przywara aveva discusso con Barth, lasciandogli la forte impressione di essere «l'unico avversario, ma un avversario realmente pericoloso», che egli
avrebbe dovuto temere, poiché lo costringeva a pensare e a porsi degli interrogativi.' D'altra parte, non è temerario ipotizzare che lo stesso Bonhoeffer abbia
cercato di compiere, in qualche modo, con il suo Atto ed essere all'interno del
protestantesimo un «tentativo ontologico» analogo (!) a quello intrapreso da
Przywara all'interno del cattolicesimo.
«Questo piccolo uomo dalla grande mente», come Barth definiva Przywara,
si era impegnato a trarre tutte le possibili implicazioni teoretiche e più precisamente ontologiche dalla dottrina cattolica espressa dalla celeberrima formula
del Lateranense IV (1215): inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notori, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda. Se intendeva inserirsi nel dibattito teologico a lui contemporaneo, nondimeno Przywara riteneva
131
132
33
m
35
m
Ivi, 66.
Ivi, 67.
Ivi, 70.
Munchen-Berlin 1927.
E . BUSCH, Karl Barth. Biografia ( 1 9 7 5 , 1 9 7 6 ) , Brescia 1 9 7 7 , 1 6 3 - 1 6 4 .
Denz 806, Il Lateranense IV si rifaceva in qualche modo a una espressione dell'agostiniano
De Trìnitate XV, 20, 39: PL 42,1088: «[...] sed potius in qualicumque ista similitudine magnam quoque dissimilitudinem cernat, quantum satis esse videbatur, admonui».
131
132
133
134
1 3 5
136
200
di avanzare la sua interpretazione dell'analogia entis come «forma fondamentale
del cattolicesimo» in risposta non solo al protestantesimo, la cui «forma fondamentale» di pensiero vedeva riproposta da Barth, ma all'intero pensiero dell'epoca moderna da Descartes in poi.
Da un punto di vista storico Przywara ha fatto notare che la definizione dell'analogia implicata nella dottrina del Latenanense IV era stata, a suo tempo,
formulata precisamente in opposizione alla dottrina trinitaria di Gioacchino da
Fiore. A giudizio del concilio, contestando Pietro Lombardo, Gioacchino da
Fiore aveva ridotto l'unità di essenza, sostanza e natura del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo a una unità non veram etproprìam, sed quasi collectivam etsimilìtudinariam, «nello stesso modo cioè in cui molti uomini sono detti un popolo
e molti fedeli una chiesa». L'«unità di Dio» o, meglio, che è Dio Trinità veniva
confusa da Gioacchino con «l'unità con Dio». Per parte sua, il concilio, insieme
con Pietro Lombardo, proclamava che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo costituiscono una quaedam summa res, incomprehensibilis quidem et ineffabilis, e la perfectio della loro unità di natura non è per nulla comparabile con quell'un'io caritatis in gratia che la Trinità stabilisce invece con l'uomo.
Ebbene, sottolinea Przywara, è appunto a proposito del mistero dell'unità
del Dio in-sé tripersonale e dell'unione soprannaturale per-noi donata nell'opera della redenzione che il Lateranense prospetta il discorso sull'infinita distanza che separa il Creatore dalla creatura e, in questo quadro, la dottrina cattolica dell'analogia. Il perché (quia) della presa di posizione del concilio è
espressamente indicato proprio in questa infinita distanza per la quale non potest
similitudo notari, quin Inter eos maior sit dissimilitudo notanda. La piattaforma
iniziale della sentenza conciliare è costituita dunque dal più alto, più profondo e
più intimo tra i misteri della rivelazione, ossia dal mistero di Dio uno e trino
nonché dal connesso mistero della divinizzazione, consistente nella «partecipazione alla natura divina», che ci contraddistingue come figli del Padre, resi conformi al Figlio, per la potenza dello Spirito Santo, un mistero-di-salvezza che
fonda l'unità della Chiesa, per la quale l'intima divina vita si auto-comunica
nella vita dei figli di Dio. Prendendo le mosse dal mistero di Dio Trinità in-sé
così come dal mistero di Dio Trinità per-noi, il Lateranense IV coinvolgeva nel
suo discorso, insieme con la partecipazione soprannaturale alla vita divina, la
stessa incarnazione e la redenzione soprannaturali.
In più, proprio affermando tutto questo, aggiungeva Przywara, il Lateranense IV sosteneva che la relazione «naturale» tra il Creatore e la creatura non
solo non viene mai tolta, ma resta sempre come termine di paragone dell'intera
concezione teologica cattolica. La differenza tra l'unità data da una identità di
natura (che si trova nel Creatore) e l'unione di amore nella grazia (che ha luogo
nella creatura), attestata dal concilio, mostra che la partecipazione a Dio e la re137
138
139
Si veda, per un lucido autosituarsi di Przywara, oltre alla Prefazione alla prima edizione di
Analogia entis, 5-8, anche il saggio del 1940 «La portata dell'analogia come forma fondamentale del
cattolicesimo», ivi, 245-302.
Denz 803.
PRZYWARA, La portata dell'analogia, 2 5 2 .
137
138
1 5 9
201
denzione soprannaturali «sono in sostanza attitudini della "creatura", e che dunque non solo non ne sopprimono la "natura" essenziale, ma, come dirà in seguito
Tommaso, vengono ad aggiungersi al suo "che cosa" (quid agere) come una
"qualità" (qualiter agere), e alla sua "sostanza" {substantiam actus) come un
"modo" (modum agendi)». Grafia non destruit, sed perfidi naturam: l'elevazione soprannaturale non contraddice né sopprime la natura della realtà creaturale, ma, come presuppone in essa una determinata somiglianza con Dio stabilita
dalla creazione (Gen 1,26-27), così porta questa somiglianza alla perfezione.
La sua, sostiene Przywara, è in fondo una «metafisica creaturale». Se parla di
natura della realtà creaturale, non vuole certo attenuare in qualche modo l'infinita
distanza che separa la creatura dal Creatore. La natura della creatura però, secondo Przywara, non è pura potenzialità passiva (come vorrebbe la teologia
greca), né pura antitesi o polarità (come vorrebbe la teologia agostiniana), ma è
potenza attiva (come sostiene invece il tomismo), la cui massima profondità è data
appunto dalla potentia oboedientialis, per la quale la creatura, proprio in quanto
creatura, è e resta totalmente nelle mani del Creatore. Da questo punto di vista
la potentia oboedientialis appare come l'attività della soprannatura nella natura:
140
141
142
«In ogni ambito della vita pratica e teoretica la dimensione soprannaturale della partecipazione a Dio e della redenzione vive e agisce nella sua interezza come una dimensione naturale attiva».
143
Conformemente al rapporto «ontico» che sussiste tra la creatura e il Creatore, continua Przywara, si svolge il rapporto «noetico»: anche cioè la rivelazione si esprime in forma creaturale tramite similitudini delle datità sensibili. La
fede, che aderisce alla rivelazione, viene a implicare di conseguenza la cognizione naturale così come la grazia presuppone la natura. In questa stessa linea,
proprio come la fede non distrugge, ma suppone e perfeziona la ragione, così la
teologia non esclude, ma esige e porta a compimento la filosofia. La natura
perfezionata della creatura sia in senso «ontico» che «noetico» è il punto di vista
supremo e definitivo della teologia cattolica. Da buon neoscolastico Przywara
giunge sino a sostenere che, essendo il rapporto tra Creatore e creatura, un rapporto di causa ed effetto, ne consegue che il «pensiero causale» cioè razionale
corrisponde alla forma logica del sillogismo.
L'analogia entis appare così a Przywara come «la suprema struttura che include e informa ogni cosa».
144
145
146
«La formula dell'analogia contiene - a giudizio di Przywara - i tre elementi costitutivi
dell'unico ordine concreto della salvezza\
la creaturalità naturale, la partecipazione
soprannaturale alla natura divina, la redenzione soprannaturale».
140
, 4 1
142
143
,44
145
146
147
202
Ivi,
267.
PRZYWARA,
Analogia entis, 1 5 - 1 8 , 6 5 .
Io., La portata dell'analogia, 269. Cf. ID., Analogia entis, 118-129.
Ivi, 289.
ID., Analogia entis, 74.
ID., La portata dell'analogia, 271.
LD., Analogia entis, 134.
Ivi, 262 (corsivi dell'A.).
147
Nell'ana-logia tutto si riconduce alla tensione tra le due possibili comprensioni di ana: un «a partire dall'alto e verso l'alto» (ano) e un «intimamente ordinato» (anà). Nei rapporti tra Dio e la creatura, nei rapporti all'interno delle
creature vale l'analogia, e anzi lo stesso rapporto tra l'analogia intracreaturale e
l'analogia tra Dio e il creato non è altro che un'analogia.
Se si parla di analogia entis anche proposito dei rapporti di Dio con la creatura, dichiara Przywara, non si vuole certo attenuare e tanto meno abolire la loro
insormontabile differenza: «il termine entis sta a indicare che tra Dio e la creatura c'è una tale distinzione che essi non hanno in comune nemmeno il genus, e
tuttavia che proprio qui si annuncia la radicale positività di un'unità di fondo».
Verosimilmente non solo un barthiano rimarrebbe più che perplesso e storcerebbe il naso dinanzi a questa affermazione di «un'unità di fondo» così come dinanzi alla «relazione di reciproche alterità» sussistenti tra Dio e la creatura.
Quale «unità di fondo» e quale «relazione di reciproche alterità» potranno mai
avvincere Creatore e creatura? Queste senza dubbio poco felici formulazioni
non dovrebbero comunque nascondere l'esphcita e sempre ribadita intenzione
di Przywara di attestare con forza la dissomiglianza ogni volta più grande nella
somiglianza che in qualche modo pure si dà tra Dio e la creatura. "' La communitas analogiae è, per lui, quella del «nulla» con il «Creatore dal nulla» e perciò il
concetto fondamentale delVanalogia entis è che l'«è» intracreaturale è a tal
punto intimamente (nell'essenza del divenire) un «è nel non» che nel rapporto
tra Dio e il creato esso sta al «Creatore dal nulla» come un «nulla».
Uanalogia entis vale, per Przywara, per l'ordine naturale e analogamente (!)
anche per quello soprannaturale. La teologia, a suo giudizio non ha altro contenuto che la divinizzazione cioè la partecipazione gratuita dell'uomo alla natura
divina e alle tre persone trinitarie sul fondamento della stessa creazione condotta a compimento tramite la redenzione. La legge della divinizzazione nella
sua completezza comporta l'incarnazione, che cioè Cristo, il Figlio di Dio, discenda nella nostra umanità sino a giungere all'infima impotenza della carne
nello scandalo della croce. «La gloria di Dio (che è il centro della divinizzazione)
- dichiara Przywara - sta nello scandalo della croce (che è il centro della redenzione)». Proprio grazie a questa discesa di Dio avviene la nostra ascesa a Dio,
e solo partecipando alla discesa di Dio si può partecipare alla ascesa a Dio. L'autorità teologica è, per essenza, Dio. Se dunque il Dio invisibile si manifesta nel
Cristo visibile, secondo la stessa divina logica la sola figura concreta del Dio in
Cristo è data dalla Chiesa.
La dottrina delVanalogia entis non è altro, agli occhi di Przywara, che la
stessa dottrina del Lateranense IV, filologicamente interpretata e teologicaus
149
150
1
1
152
153
154
Ivi, 137.
Ivi, 1 1 7 - 1 1 8 .
Ivi, 197. Questa osservazione viene fatta per SAN TOMMASO, ma si può applicarla anche al
pensiero dello stesso Przywara.
Ivi, 1 2 9 - 1 3 2 .
Ivi, 135.
ID,, La portata dell'analogia, 267.
Ivi, 2 7 6 .
148
1 4 9
150
151
152
153
154
203
mente elaborata. Alla fine, a giudizio dello stesso Przywara, questa dottrina verrebbe a coincidere con una theologia crucis «caratterizzata dall'in-crociarsi, sul
piano del contenuto, tra il tutto e il nulla di Dio, in un pensiero che in-crocia se
stesso». Grazie ali 'analogia entis la teologia si fa «l'assunzione del mistero inviolato di Dio in un pensiero del mistero, ed è quindi una teologia nel vero Logos e vero Pneuma, cioè in Cristo quale «Logos della croce» (ICor 1,18) e nello
Spirito Santo quale spirito della «sapienza della croce» (2Cor 2,2-16)». Non
che Przywara concepisca l'analogia come un principio o forma in sé e da sé: piuttosto egli la ritiene come «l'autoesplicitazione della posizione della Chiesa nei
confronti di tutte le teologie possibili». Con «discrezione ecclesiale», con «distacco aristocratico e imparziale» il Lateranense IV lascia infatti intendere, secondo Przywara, che la propria dottrina non si identifica con quella di alcuna
teologia particolare. Nondimeno questa stessa dottrina, sempre a giudizio di
Przywara, «rappresenta il momento cruciale in cui nasce la questione dell'intima
forma di ogni teologia in generale», il «principio strutturale», la formula complessiva dell'analogia in quanto tale.
Attestata dal Lateranense IV nel momento del massimo splendore del papato medievale con Innocenzo III, Vanalogia entis viene speculativamente sviluppata da san Tommaso d'Aquino e anzi, per Przywara, la sua problematica si
conclude con lui e viene ascritta al suo nome. L'intero ordo rerum viene strutturato dall'Angelico secundum analogiam e in questa impresa «l'anelito inquieto» di Agostino si tramuta in un «acquietante fulgore», mentre la tensione
deH'«avvolgimento del pensiero» di Aristotele viene liberata in una «quieta sobrietà». Ribadita dalla Chiesa cattolica attraverso il Vaticano I e quindi in occasione della condanna del modernismo, l'analogia entis si contrappone, agli occhi di Przywara, come un baluardo, frontalmente, a qualsiasi affermazione dell'«identità» tra il Creatore e la creatura sia nella versione «teopanistica» (orientale), che eleva il finito al livello dell'infinito, sia nella versione «panteistica» (occidentale), che riduce l'infinito al livello del finito.
Ripensata in virtù di un rigoroso e conseguente tomismo neoscolastico, l'analogia non è certo affermata da Przywara su di un apriorìstico piano razionale
«naturale», come fraintendeva Barth. Non partendo dalla sola idea di creazione,
bensì dal Dio uno e trino e quindi coinvolgendo creazione, incarnazione e redenzione, Przywara dispiega la sua imponente analisi delYanalogia entis come
«"forma ultima" della stessa unità di natura e soprannatura». Per conseguenza, a suo giudizio, non c'è né può esserci un'analogia fidei attuale nell'evento dell'annuncio attuale, come vorrebbe Barth, poiché non c'è alcuna alternativa tra l'analogia entis e l'analogia fidei, ma l'unica e medesima analogia entis
155
156
557
158
159
160
161
155
156
157
158
1 5 9
160
161
204
Ivi, 268-269. Qui Ì ' A . rimanda a TOMMASO
Ivi, 268.
Ivi, 274.
Ivi, 276.
PRZYWARA, Analogìa entis, 198.
ID., La portata dell'analogìa, 169.
Ivi, 300, nota 117.
D'AQUINO,
De ver., q. 24, a. 1, ad 2; a. 13 c.
è essa stessa analogia fidei} Quello di Barth è, secondo Przywara, un tentativo
di fuga in avanti, che conclude a un puro «cristianesimo biblico», che gli si trasforma di fatto in un sistema basato sulla «dissomiglianza ogni volta più grande»
cioè in un sistema messo al bando proprio da quell'analogia da cui egli rifugge.
Non era senza serio fondamento la tesi del giovane Bonhoeffer che nella teologia cristiana non hanno valore categorie ontologiche presuntivamente di pura
ragione, sciolte cioè, come egli diceva, dal peccato e dalla grazia: l'idea di essere
in generale non può offrire di per sé «le fondamenta per la determinazione dell'essere proprio dell'uomo in Cristo». Non è corretto però sostenere che Vanalogia entis elaborata da Przywara prescinda da Cristo, come aveva obiettato
Bonhoeffer: anche questi come Barth fraintendeva le cose. I concetti di Dio,
uomo e mondo caratteristici di Przywara non appartengono a una «metafisica intramondana», ma piuttosto a una onto-teo-logia di schietta ascendenza tomistica, con tutti i pregi, ma anche tutti i limiti che questa tradizione si tira dietro
(cf. cc. 4.7; 5.3-5). Przywara è certo «cattolico», ma il cattolicesimo non è solo
Przywara. In ogni caso, la questione della differenza tra essere (comune) ed
ente, e più ancora tra essere e Dio non è tematizzata da Przywara in modo adeguato. Soprattutto, l'analogia non viene scrutata «in» Cristo e tanto meno essa
viene fatta coincidere con la persona di Cristo nell'effettiva «realtà» della rivelazione e della salvezza. E perché mai non potrebbe essere questa la «forma fondamentale» di pensiero del cattolicesimo o, meglio, dello stesso cristianesimo?
62
163
i64
165
5.7. « N U O V A CREAZIONE».
LA FIGURA CRÌSTOLOGICA D E L L ' A N A L O G I A
Qualora si cerchi di affrontare la quaestio de analogia non immediatamente
nell'orizzonte della verità dell'essere, bensì mettendo a fuoco lo sguardo direttamente sulla verità (a-létheia) che sopraggiunge «in» Gesù Cristo, allora non si
può non scoprire che l'intera ricerca dovrebbe essere reimpostata in modo
nuovo. Se infatti «in» Gesù Cristo viene stabilita una inattesa, inaudita relazione
di Dio col mondo, allora dovrebbe riconoscersi e insieme dichiararsi che non è
più sufficiente il legame primordiale fondato da Dio stesso nella creazione
dell'essere. Dio non può più costituire l'Ignoto assolutamente inaccessibile e
neppure gli può bastare d'essere identificato come il principio e il fine del cosmo
dal momento che oramai s'è fatto YEmmanuele, «Dio-con-noi». Venendo all'uomo, senza nulla sottrarre alla propria divinità, anzi proprio in corrispondenza a essa, Dio non si presenta semplicemente come il Creatore, bensì più radicalmente come il Salvatore e il Trasfiguratore di tutte le cose «in» Gesù Cristo.
«In» Gesù Cristo, infatti, Dio non si dà soltanto a conoscere, rendendo noto
«che» egli è, ma interviene e opera anche, e anzi soprattutto, per donare se
stesso come Colui che appunto è oramai e per sempre il «Dio-con-noi». «In»
162
M
164
165
Ivi
ID., «Metafisica, religione, analogia (1956)», in Analogia entis, 334.
CI BONHOEFFER, Atto ed essere, 2 2 , 1 4 1 .
Ivi, 6 3 .
205
Gesù Cristo Dio non soltanto parla, ma agisce: agisce parlando e parla agendo
verbis gestisque inter se connexis (cf. DV 2). Nell'orizzonte della fede neotestamentaria Dio si autodichiara e autocomunica in ciò che è, ha detto e fatto Gesù
di Nazaret, fino all'estremo della morte e oltre ancora, e cioè fino alla sua risurrezione (cf. c. 1.5). Anche l'onto-teo-logia e con essa l'ana-logia, senza di cui non
ci può essere alcun discorso responsabile sul Dio cristiano, vanno ricondotte in
servitudinem Christi.
La parola umana che parla dell'evento Cristo, l'Evangelo, non annunzia Dio
semplicemente come segno che per significare dovrebbe autonegarsi, bensì efficacemente come «qualcosa che ha potere». Fin negli strati più antichi della
tradizione confluita nei Vangeli Gesù appare come l'uomo della parola così
come l'uomo del gesto simbolico. Attuando e proclamando una nuova relazione di Dio con l'uomo, l'evangelo cristiano viene a esigere perciò una nuova figura di analogia. Se si dà un'analogia implicata in ogni concezione del mondo e
se in ogni riflessione intellettuale degna di questo nome non può mancare un'analogia esplicata, l'impegno di una teologia cristiana conseguente dovrà pur
portare a consapevolezza l'analogia comportata dall'evento Cristo. Se, come
dice lo Pseudo-Dionigi, «bisogna pensare le cose divine in maniera conforme a
Dio», e se Gesù Cristo è stato, ha pensato, detto e fatto tutto «in maniera
conforme a Dio», allora è da lui e non da altri che bisogna apprendere come
pensare e dire «le cose divine». La struttura formale dell'analogia, come condizione di possibilità logica e linguistica del discorso umano intorno a Dio, post
Christum natum non si può dunque derivare dal pensiero dell'essere conquistato nell'onto-teo-logia greca e neppure da quello coltivato nell'onto-teo-logia
rielaborata in un contesto cristiano alla luce dell'essere come essere creato: si
può e anzi si deve portare allo scoperto mediante l'analisi del discorso sul Dio
«già» venuto «in» Gesù di Nazaret e che oramai è il solo discorso davvero corrispondente a Dio. L'onto-teo-logia greca, guardata col massimo della simpatia,
può essere vista solo come un andare a tastoni, un brancolamento sulla via che
dovrebbe condurre al vero Dio. L'onto-teo-logia, che pure in regime cristiano
si è imposta come una necessità, va sottomessa, lasciata giudicare e trasformare
dalla cristo-logia.
Secondo la formula con la quale Paolo riassume il senso e il valore dell'intero evangelo, si potrebbe anzi partire dalla «parola della croce» (ICor 1,18) allo
scopo di riconoscere la legge strutturale formale, alla quale dovrebbe sottostare
ogni discorso teologico cristiano, che voglia essere theoprepés e dunque davvero
degno di Dio. Proprio la «parola della croce», stoltezza per quelli che si perdono,
ma al contrario forza per quelli che si salvano, comunica una dynamis inaudita al
linguaggio che ne parla e così stabilisce la natura e il compito dell'analogia in re166
167
168
Cf. a questo proposito A, MILANO, La Parola nella Eucaristia. Un approccio storico-teologico, Roma 1 9 9 1 , in part. 3 9 - 5 0 .
Cf. R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria, 2 voli., Cinisello Balsamo (Milano) 1 9 9 6 - 1 9 9 9 , I. Gli inizi, 9 2 - 1 0 1 ; II. Gli sviluppi, 3 2 - 3 3 .
166
167
1 6 8
206
PSEUDO-DIONIGI, De div. nom.,
VII, 2, 869 A .
girne cristiano. Non si tratta soltanto di cogliere in qual modo le parole dette da
Gesù mettano in gioco un modello assolutamente nuovo di analogia. È l'intera
intelligenza della parola esibita dal Nuovo Testamento che dovrebbe essere
scrutata, e tutto ciò all'interno della cristologia, che dal principio del Vangelo di
Marco culmina nel prologo di Giovanni, se si vuole ottenere una comprensione
davvero cristiana dell'analogia. La «parola della croce» è in relazione con il linguaggio non solo perché da sempre il linguaggio appartiene all'uomo creato in
virtù della partecipazione dell'essere dal nulla, ma prima e più ancora perché
essa è l'evento definitivo della Parola eterna, che in tal modo porta a compimento il suo farsi carne nella storia per noi e per la nostra salvezza, realizzando
così la «nuova creazione»: «le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di
nuove» (2Cor 5,17). Oramai infatti non è più la prima creazione che conta, bensì
appunto la «nuova creazione» (Gal 6,15).
È vero: «in» Gesù Cristo e dunque nella «parola della croce» si ha una kenosì
di Dio (Fil 2,7), che si adegua al linguaggio umano. Ma proprio nella croce e, in
generale, nel mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo Dio si autoafferma e così si fa accessibile mentre attua quel «legame» e perciò quell'analogia
in cui non le parole umane si avvicinano troppo a lui, bensì lui si avvicina dappresso, intimamente agli uomini, appropriandosi di tutto ciò che è umano e dunque anche del linguaggio. Riprendendo le suggestioni de L'umanità di Dio di
Barth, ma superandone la prospettiva della analogia fidei, Jùngel ha potuto dire
che «Dio è pensabile come uomo che parla perché e nella misura in cui è umano
in se stesso». Secondo l'annuncio evangelico, infatti, «in» Gesù Cristo Dio si
accosta agli uomini tanto che proprio in questo farsi prossimo, mentre concretizza la sua alterità nei confronti dell'umanità, nello stesso tempo realizza l'umanità della sua divinità. L'essere di Gesù Cristo, riconosciuto nella fede come vero
Dio e vero uomo, comporta certo che l'identità con Dio non annulli la differenza, altrimenti non avremmo propriamente il venire di Dio a noi e in tal modo
la salvezza annunciata dal vangelo. Nondimeno l'infinita sproporzione fra Dio e
uomo, che appartiene all'essenza della fede cristiana, «in» Cristo non è la «differenza ontologica» semplicemente di una non affinità sempre maggiore, bensì la
differenza sempre maggiore in un'affinità pur tanto grande.
La possibilità che il linguaggio umano sia theoprepés cioè degno di Dio e corrisponda a Dio ha certo attinenza con una potentia oboedientialis della parola
umana in virtù del primordiale legame creativo dell'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. Diversamente da una posizione come quella di Jungel, che comunque si aggancia a quella di Barth, ancora impacciata da un sospetto tipicamente protestante, si può sostenere con tutta tranquillità che non è per niente
scandalosa una natura creata quodammodo capax gratiae e tale che permetta
pure di parlare di analogia entis. Non è certo blasfemo parafrasare il Lateranense IV, affermando cioè che inter creatorem et creaturam non potest maior dissimilitudo notari, quin inter eos etiam aliqua similitudo sit notanda. Ma tutto que169
170
1 6 9
170
JÙNGEL, Dio,
376.
Ivi,
mistero del mondo,
377.
207
sto, prima che nella creazione originaria, deve essere fondato e dunque compreso nella «nuova creazione» manifestata e attuata «in» Gesù Cristo. Quel Dio
che si mette in una nuova relazione di grazia col mondo per esprimere se stesso
all'uomo come uomo «in» Gesù Cristo, non vuol certo distruggere, bensì sanare
ed elevare quella stessa relazione primordiale stabilita nell'uomo proprio da lui
creato a propria immagine e somiglianza. Corrispondere a Dio è possibile al linguaggio come tale se e nella misura in cui è certo possibile all'uomo come tale
corrispondere a Dio in quanto è creatura di Dio. Ma oramai una nuova possibilità viene da Dio donata al linguaggio, e non certo casualmente proprio al linguaggio in virtù dell'evento della stessa Parola eterna fattasi carne.
Per illustrare l'analogia legittimata cristologicamente è stato suggerito da
parte di Jungel di assumere la parabola come un'espressione linguistica privilegiata. La parabola infatti costituisce una forma altamente rappresentativa dell'evangelo di Gesù: fondamentalmente anzi tutte le forme verbali della fede sembrerebbero partecipare della struttura verbale della parabola. Da questo
punto di vista, in una teologia cristiana della parola, la parabola dovrebbe valere
molto più di una terminologia che rimandi ad astrazioni puramente intelligibili.
Se la parola non è un elemento accessorio e casuale dell'approssimarsi di Dio all'uomo «in» Gesù Cristo, tutto ciò riguarda in modo eminente la parabola: alla
folla Gesù «non parlava se non in parabole» (Mt 13,34).
La parabola infatti può considerarsi una metafora in esteso così come la metafora può essere vista come una parabola abbreviata. Certo la parabola racconta, mentre la metafora condensa il racconto in una sola parola. Se già il linguaggio in generale ci pone in un rapporto significativo con le cose, la parabola e
la metafora costituiscono un particolare momento del linguaggio in quanto scoprono dimensioni sorprendenti della realtà, di solito non colte immediatamente
e trascurate. La parabola e la metafora svelano qualcosa che prima risultava
ignoto e, nello stesso tempo, coinvolgono chi ascolta, lo includono in un nuovo
cerchio, e così lo interpellano. Come accade in Gesù di Nazaret, il parlante viene
a essere implicato personalmente nella parabola che viene raccontata. Si ottiene
un richiamo reciproco, un compenetrarsi, quasi una pericoresi di annunciatore,
parabola, ascoltatore così da realizzare un unico evento.
È stata una pesante perdita nell'intelligenza della fede la svalutazione del
linguaggio simbolico e metaforico che, come s'è visto (c. 5.4), si è verificata nella
vicenda storica dell'onto-teo-logia cristiana centrata sulla pur decisiva verità del171
172
173
JUNGEL, Dio, mistero del mondo, 382.
Cf. G. SÒHNGEN, Analogie und Metapher. Kleine Philosophie
Freiburg-Munchen 1962; E . JUNGEL, Verità metaforica, in P. RICOEUR
171
und Theologie der Sprache,
- E. JONGEL, Dire Dio. Per
un'ermeneutica del linguaggio religioso (1974), ed. di G. Grampa, Brescia 1978,109-180; ID., Paolo e
Gesù. Alle origini della cristologia (1962), Brescia 1978; ID., Dio, mistero del mondo, 378s. Sul tema
della parabola in generale cf. pure V. Fusco, Oltre la parabola. Introduzione alle parabole di Gesù,
Roma 1983; ID., «Parabola/parabole», in Nuovo Dizionario di Teologia biblica, a cura di P. ROSSANO
- G . RAVASI - A. GHIRLANDA, Cinisello Balsamo 1988, 1081-1097. Per una precisa e chiara messa a
punto cf. R . PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria, I. Gli inizi, 97-101.
JONGEL, Dio, mistero del mondo, 379-382s.
172
1 7 3
l'essere e armonizzata con l'aspirazione religiosa e intellettuale dell'uomo greco.
È un grave errore ermeneutico comprendere la parabola come una sorta di velamento, che renda qualcosa più misterioso di quanto questo non sia già di per sé.
Nelle parabole del regno Gesù di Nazaret esibisce infatti il modello ermeneutico
di un linguaggio in cui, raccontandosi del mondo e dell'uomo, si parla di Dio. In
queste parabole il mondo non viene certo messo al posto di Dio. Al contrario, in
esse si impedisce proprio che il mondo e Dio vengano livellati sullo stesso piano.
Si pensi ai personaggi in esse evocati: il re, il padre, il padrone e così via: tutti
sono introdotti per proclamare la divinità di Dio, che manifesta ed esercita la sua
signoria proprio nel suo libero e gratuito rapportarsi all'uomo. Se mai nelle parabole di Gesù si ipotizzasse appena un'assimilazione di Dio al mondo, di fatti il
mondo sarebbe abbandonato a se stesso e resterebbe mondo, un mondo certo
creato, ma sempre in preda del peccato. La parola di Cristo, che si esprime e accade sempre come «qualcosa che ha potere», dall'autopresentazione «Io sono»
alle beatitudini, manifesta la sua peculiarità di annuncio ed evento di salvezza
particolarmente facendosi parabola. E qui Dio resta sempre Dio, anzi, se si potesse dire, la sua divinità vi appare ancora più grande proprio perché nel suo
amore incondizionato egli si rivolge all'uomo, interpellandolo in vista di un abbraccio di misericordia. Le parabole non dicono che Dio «è» un re, un padre, un
padrone, ma è «come» un re, un padre, un padrone. Ed è in tal modo, secondo
un dinamismo che procede sempre dall'alto verso il basso, che mettono in comunicazione, stabiliscono dei legami tra Dio e l'uomo, e perciò strutturano un'analogia, che, raccontata, si fa essa stessa evento di salvezza.
Quanto vale per le parabole dei Sinottici, si ritrova a suo modo pure in Giovanni. È stato infatti notato che nel quarto Vangelo la congiunzione «come» (kathòs) designa tre tipi di legami, l'uno che introduce l'altro: Gesù agisce «come» il
Padre (il Padre detta, Gesù ascolta, in reciproca relazione e immanenza); Gesù
invita i discepoli ad agire «come» egli ha agito con loro e dunque suggerisce di
imitarlo; infine i discepoli devono comportarsi tra loro «come» Gesù li ha invitati a fare e secondo il suo modello. Il primo «come» è fondante ed è il modello
assoluto degli altri; il secondo si partecipa a imitazione del primo; il terzo si configura sul precedente e pertanto sul primo. Orbene questa struttura del
«come» giovanneo non ripropone forse a proprio modo la stessa struttura del
«come» implicata nelle parabole dei Sinottici?
Il «come» dei Vangeli non appiattisce escludendo l'alterità, ma neppure separa impedendo la comunione: non stabilisce un'assoluta univocità e neppure
una drastica equivocità. Sia l'equivocità sia l'univocità vanificherebbero la possibilità dell'interpellazione e dunque la possibilità del coinvolgimento: sarebbero
incapaci di strappare l'uomo a se stesso, al suo peccato, per inserirlo nel dinamismo del «regno di Dio». Nelle parabole come nelle parole di Gesù, in generale,
Dio non viene disumanizzato, ma neanche dissolto nella sua divinità. Di un Dio
del tutto livellato all'uomo o posto del tutto al di là dell'uomo, l'uomo che cosa
174
174
Cf. G.
SEGALLA,
La preghiera sacerdotale di Gesù (Gv. 17), Brescia 1983, 173-175.
209
se ne potrebbe fare? Se Dio non fosse in qualche modo un «Io» cui l'uomo possa
rivolgersi come a un «Tu», se fosse invece un neutro numinosum fascinans et tremendum, assolutamente inconoscibile e ineffabile, Dio non sarebbe più Dio, almeno non sarebbe più un Dio che possa pretendere di essere un Dio
dell'uomo. Se Dio non fosse persona, non potrebbe venire all'uomo e, se non
potesse venire all'uomo, che Dio sarebbe per l'uomo? Una scrollata di spalle, e
se ne farebbe serenamente a meno.
Le parabole dispiegano ed esemplificano la parola di Gesù e in tal modo costituiscono la preparazione ermeneutica dello stesso kerygma pasquale di Gesù
come Cristo, Signore e Figlio di Dio. Ma Gesù di Nazaret si è espresso nelle sue
parole, in generale, nelle sue parabole, in particolare, strettamente connesse e
anzi compenetrate pure con i suoi gesti tanto che questi stessi gesti potrebbero
essere considerati, a loro volta, come parole e parabole. Quanto Gesù dice è gesto fatto parola, quanto Gesù fa è parola fatta gesto. Quello che Gesù dice e fa si
dispiega nel dinamismo di una circolarità talmente compenetrata con ciò che egli
è che a ragione egli stesso può essere proclamato parola-parabola di Dio. Ed è
proprio tutto questo che fa dichiarare a Giovanni, alla luce dell'esperienza pasquale, che Gesù Cristo è lo stesso Logos eterno fatto carne.
Nelle parole, nelle parabole di Gesù non si mostra alcun imbarazzo per un
Dio vicino, alcuna paura di un Dio antropomorfico. Come mai? Si è voluto distinguere un antropomorfismo «dogmatico» da uno «simbolico»: il primo oserebbe parlare di Dio «come» (wie) di un uomo e in questo caso Dio non sarebbe
più Dio; l'altro proibirebbe di parlare di Dio «in quanto» (als) uomo e così permetterebbe a Dio d'essere Dio. Negli Evangeli si attuerebbe il superamento dell'antropomorfismo «dogmatico», che annulla la diversità, parlando di Dio come
di un uomo anche se in forma più elevata. Ma nei Vangeli si realizzerebbe pure il
superamento dell'antropomorfismo meramente «simbolico» che, in una pur
grande affinità fra Dio e uomo, esprimerebbe una non affinità ancora più
grande. La fede cristiana nell'incarnazione della parola di Dio «in» Gesù Cristo
contraddice comunque ambedue quegli antropomorfismi: che cioè si possa parlare di Dio «come» (wie) dell'uomo, mentre contesta la proibizione di parlare di
Dio «in quanto» (als) uomo.
Sic enim est dispositio rerum in ventate sicut in esse: così, e a ragione, sostiene
san Tommaso d'Aquino. Ma dovrebbe valere anche l'opposto, che cioè l'ordine istituito dalla verità deve consentirci di intravedere anche la struttura
dell'essere. Così, se «è» la verità in persona, a questo stesso titolo Gesù Cristo
deve disporre anche l'assetto dell'essere e degli enti. Alla luce della fede, mentre
si apprende che «in» Gesù Cristo ci si mostra ciò che è davvero theoprepés vale a
dire degno di Dio, nello stesso tempo ci si rende noto anche ciò che è pure corri175
176
177
Per il problema della persona Dei, cf. C. ARATA, «La metafisica della prima persona. (Ego
sum qui sum)», in Rivista di filosofia neo-scolasìica 81(1989), 181-200. Ma cf. anche a MILANO, Persona in teologia; ID., La Trinità dei teologi e dei filosofi. L'intelligenza della persona in Dio. Cf. JUNGEL, Dio, mistero del mondo, 386-389.
Cf. JUNGEL, Dio, mistero del mondo, 388.
TOMMASO D'AQUINO, C. Geni. I, 1, n. 5.
175
176
1 7 7
pondente all'umanità dell'uomo. «In» Gesù Cristo infatti Dio ci si presenta
come talmente divino da non apparire diminuito se si appropria pure di ciò che è
realmente umano.
Accettare che Gesù Cristo parli di Dio in modo perfettamente adeguato a
Dio non è dunque un antropomorfismo presuntuoso e pericoloso. Il cristianesimo sta o cade proprio sul fatto che si possa parlare di Dio «in quanto» uomo.
Affermando l'incarnazione, non si proclama certo l'annullamento dell'infinita
differenza qualitativa tra Dio e uomo, si parla anzi dell'uomo proprio pensando
di non confonderlo con Dio. Altrimenti, come lo ha riconosciuto Calcedonia,
non avremmo né Dio né uomo. Nel «mondo dei pensieri» racchiuso nella fede
cristiana, nonostante si veda come mediante uno specchio e nell'enigma, si prospetta pur sempre il paradosso in base al quale si deve dire che proprio quest'uomo, Gesù Cristo, nato da donna e morto sulla croce, è e deve essere chiamato, al tempo stesso, uomo e Dio, così in sé congiungendo cielo e terra. Ed è
anche per questo che lo stesso Gesù Cristo «è» l'analogia concreta. Se dunque
nella luce della fede del Nuovo Testamento viene a esigersi una nuova forma di
analogia, che coincide con Cristo in quanto Verbo fatto carne, ciò è perché questo stesso Cristo è il «mediatore» {mesìtes), colui che sta al centro e tutto conlega nella sua persona (lTm 2,5), davvero come «il più bello di tutti i legami».
In una tale prospettiva, per così dire, «calcedonese», ma andando ancora più
innanzi, e sempre eodemque sensu eademque sententia, si potrebbe anche scorgere la coincidenza in Gesù Cristo dell'analogia di proporzionalità con quella di
attribuzione. Già da un punto di vista strettamente filosofico è stato osservato
che un percorso teoretico mirante a tradurre l'analogia nei soli termini della proporzionalità è insufficiente: comunque dovrebbe presupporsi un rinvio alla tematica dell'uno e dei molti o del diverso parteciparsi all'uno e pertanto un rimando all'analogia di attribuzione. Resta tuttavia che l'analogia di attribuzione, come si ricorderà, stabilisce sì il legame diretto del mondo a Dio, ma
mette a rischio la trascendenza di Dio sul mondo, mentre l'analogia di proporzionalità salva sì la distanza infinita, ma indebolisce a sua volta il legame di Dio
col mondo. È per questa ambiguità della figura dell'analogia che san Tommaso,
come s'è visto (c. 5.3), ha oscillato nel discuterne e nell'applicarla nella sua intelligenza del mistero cristiano. Preoccupati dal rischio di essere costretti ad approdare a una «insolente teologia dell'identità» si è pensato, fra l'altro, di mettere al
riparo la possibilità del dire Dio rifugiandosi nel porto tranquillo della dossologia. Ma quale dosso-logia potrà mai soccorrere l'inconsistenza o rimpiazzare
l'inesistenza di una onto-logia?
In realtà, la costituzione di Cristo, colta alla luce della fede interpretata a
Calcedonia, più e meglio di qualsiasi artificio dialettico, sembra conciliare nel
paradosso quanto disorienta nell'alternativa dell'aporia: nella sua unica «per178
179
analogica, X V .
«Analogia e dossologia» ( 1 9 6 3 ) , in Questioni fondamentali di teologia
sistematica (1967-1972), Brescia 1 9 7 5 , 2 0 5 - 2 2 7 . Rinnova, anche se con una propria, forte originalità,
la stessa proposta I. MANCINI, «Tommaso d'Aquino e le forme attuali della teologia», in Asprenas
2 1 ( 1 9 7 4 ) , 3 4 7 - 3 8 8 . Ma ci sia permesso di rimandare a questo proposito anche ad A. MILANO, «Teologia e ragione in Wolfahrt Pannenberg», in Asprenas 2 9 ( 1 9 8 2 ) , 1 5 7 - 1 6 2 .
1 7 8
179
MELCHIORRE, La via
Cf. W . PANNENBERG,
211
sona» divina Cristo congiunge senza confondere, senza mutare, senza dividere,
senza separare, ie due «nature», l'umana e la divina. In una teologia cristiana la
struttura dell'analogia del linguaggio dovrebbe allora modellarsi su quell'analogia che è Gesù Cristo stesso, poiché in lui la rispettata, insormontabile «differenza ontologica» fra Dio e l'uomo si compone insieme con la relazione diretta
di similitudine e anzi, a essere precisi, con l'identità sia con la divinità sia con
l'umanità. Ma c'è di più. Se in Gesù Cristo la differenza pur così grande tra Dio e
uomo si annoda con una relazione ancora maggiore o, se si vuole, in termini paolini, se a un peccato pur così grave e tragico corrisponde una grazia ancora più
generosa e sovrabbondante (Rm 5,20), ciò significa che di Dio potrebbero ben
darsi dei nomi e dunque, nell'orizzonte della verità dell'essere, anche quello di
Ipsum esse subsistens. E, tuttavia, nella luce dell'evento Cristo e particolarmente
della sua vicenda di morte e di risurrezione, il nome più potente, il più alto rispetto a noi e insieme il più vicino a noi non è se non quello riconosciutogli da
Giovanni: agape (lGv 4,8). Ma se è agape e dunque amore, e l'amore urge per
esprimersi, ciò vuol dire che a Dio come agape appartiene la proclamazione e la
conferma dell'amore.
Certo per esprimersi l'amore deve essere: se non «è», che agape è? Ma, se
non è senza l'essere, non di meno Yagape è più che semplicemente (aplòs) essere. E poiché Dio è tutto ciò che ha, l'essenza dell 'esse che «è» Dio come Ipsum
esse subsistens è appunto Yagape. E se è più che semplicemente essere, Yagape
non è forse più theoprepés e dunque più dell'essere il nome davvero degno di
Dio? La meraviglia di tutte le meraviglie non è allora pensare e dire «che» qualcosa è, come voleva Wittgenstein, e neppure che Dio «è», ed è dunque YIpsum
esse subsistens, come è giunto a dire il grande Tommaso d'Aquino, ma che, scrutato «in» Gesù Cristo, Dio è davvero YAmor ipse subsistens.
L'agape è sul serio id quo maius cogitari potest ed è pertanto il nome più proprio di Dio. E poiché Dio non è solo uno che ama, ma è l'amore stesso, non solo
si può, bensì anche si deve poter parlare di lui: caritas capax verbi.™ Ma se è capace di parola, se anzi la parola è nel potere di Dio, è l'agape che è Dio ciò che
consente a Dio di stabilire il «più bello di tutti i legami» «in» Cristo e così dì istituire l'analogia nell'ordine della «nuova creazione». Così come lo percepisce la
fede cristiana centrata nel mistero pasquale di Cristo, l'essenza radicale di Dio,
vale a dire Dio nella sua più intima, segreta, ultima profondità, prima e più che
Yactus essendi, è la stessa suprema, inesauribile, straripante potenza dell'agape
(cf. c. 7.7).
Svolgendo il discorso in un'ottica trinitaria, si potrebbe anche aggiungere
che, nella sua sorgente primigenia è agape Dio il Padre, ma anche e per questo è
agape Dio il Figlio che da lui è generato, ed è agape lo Spirito che procede dal
Padre mediante il Figlio. È però il Figlio a farsi carne e in questo farsi carne
viene a condividere tutto dell'uomo: il nascere, il vivere, il soffrire e perfino il
0
I8U
Cf.
JONGEL,
Dio, mistero del mondo, 389.
morire. Se è Yagape che rende possibile questa incarnazione del Figlio di Dio e
Dio egli stesso, se Gesù Cristo è la stessa divina agape che si fa carne e così avvince una volta per sempre Dio all'uomo e allo stesso cosmo, allora Gesù Cristo
è l'analogia istituita dall'agape divina. In breve, Gesù Cristo «è» l'analogia reale
in quanto «è» Yagape concreta nell'ordine della «nuova creazione». Nell'orizzonte della teologia cristiana non vale dunque primariamente Vanalogia entis,
bensì Yanalogia Christi o, meglio, Yanalogia Christus.
Giunti a questo punto ci potremmo forse anche spingere più innanzi, sino
cioè a sostenere che la suprema figura cristologica dell'analogia è il Crocifisso.
Se infatti è nel mistero pasquale e, ancora più in particolare, se è nella croce che
Cristo porta a compimento la sua missione di mediatore, quella cioè di farsi centro cui tutto si riporta e da cui tutto si diparte, è allora soprattutto nell'intersecarsi delle due braccia di quel patibolo infame, sul quale si è celebrato l'evento
estremo dell'agape, che bisogna scoprire la coincidenza piena dell'analogia verticale di attribuzione con l'analogia orizzontale di proporzionalità. Se è soprattutto nella croce che si congiunge Dio all'uomo, l'uomo all'uomo, l'uomo al
mondo, allora «il più bello di tutti i legami», che ogni cosa connette e ordina
come in cielo così in terra, potrebbe ulteriormente così precisarsi: analogia Christus crucifixus.
Il primo, forse, a essere folgorato da una intuizione come questa è stato uno
dei maggiori pensatori del nostro secolo, che probabilmente non avremmo mai
sospettato capace di tanto: Edmund Husserl. Sospinto dal colloquio con una sua
discepola, che appunto gli aveva dichiarato: «Sì, Gesù è diventato l'analogia tra
Dio e noi uomini. Questo significa il venerdì santo, la redenzione e allo stesso
tempo la pasqua», il vecchio filosofo ebreo, rivolgendole uno sguardo profondo,
le aveva sussurrato: «Sì, è così».
181
Schwester A. JAEGERSCHMID, «Die Letzen Jahre Edmund Husserls ( 1 9 3 6 - 1 9 3 8 ) » , in Stimmen
1 0 6 ( 1 9 8 1 ) , Bd. 1 9 9 , Heft 2 , 1 2 9 - 1 3 8 , qui 138. Cf. E AD, «Gesprache mit Edmund Husserl
( 1 9 3 1 - 1 9 3 6 ) » , ivi, Heft 1, 4 8 - 5 8 .
181
der Zeit
213