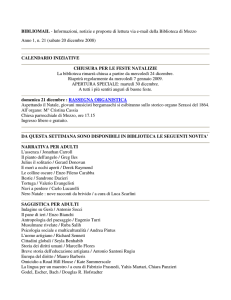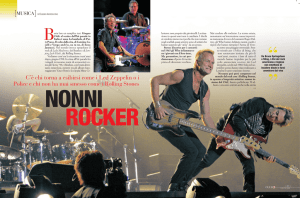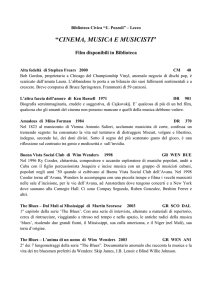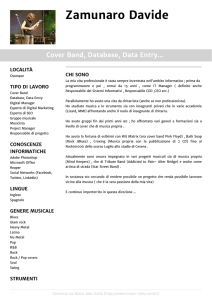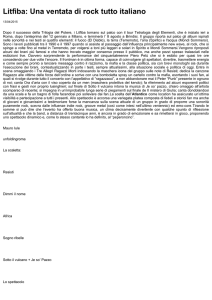SHINE A LIGHT
Rock’n’Roll Circus
Fabio Pezzetti Tonion
Music is a language that doesn’t speak in particular words. It
speaks in emotions, and if it’s in the bones, it’s in the bones.
Keith Richards
Is it only rock’n’roll?
Di indizi per capire quale sia il segreto dei Rolling Stones, che a più di quarant’anni
dall’esordio infiammano ancora la scena rock
internazionale, il film di Scorsese ne fornisce a
sufficienza e alla fine ci si domanda
se sia
davvero necessario cercare la formula di uno
spettacolo di cui la cinepresa restituisce con
scintillante evidenza l’intima e vibrante potenza.
Di queste tracce di un percorso ininterrotto ci
piace
però
elencarne
tre,
quelle
che
maggiormente ci hanno colpito e che più di altre
rappresentano un momento di riflessione all’interno di un film-concerto pirotecnico che sembra
voler mettere al bando ogni riflessione sul gruppo e la sua musica1 ed entrare prepotentemente nella
carne e nel sangue degli spettatori per trasmettere il sacro verbo di quel rock di cui i Rolling Stones
sono (nel bene come nel male) gli indiscussi sacerdoti e custodi.
Keith Richards, rispondendo a chi gli chiede chi sia il chitarrista migliore tra lui e Ronnie
Wood, proclama che presi singolarmente sono entrambi abbastanza scarsi, ma quando suonano
insieme valgono quanto dieci chitarristi. Qui c’è il senso del gruppo, la magica unione alchemica di
personalità tanto diverse che vibrano all’unisono dello stesso diapason, quello del blues e del rock.
Va bene lo spettacolo, ma alla fine quello che interessa davvero è la musica.
1
Sul fatto che la band prima agisca e poi si fermi a pensare è interessante la dichiarazione di Ron Wood, secondo cui «i
Rolling Stones avrebbero potuto implodere molte volte, date le diverse personalità dei suoi membri. Ma il motivo per
cui la band non è mai andata in pezzi è che non passiamo tantissimo tempo seduti a farci domande o esaminare e
analizzare la scaletta dopo lo show». Cfr. Dora Loewenstein e Philip Dodd (a cura di), According to The Rolling
Stones, tr. it., Milano, Mondadori, 2003, pp. 330-331.
www.turindamsreview.unito.it
1
E ancora, in un film che concentra l’attenzione sulla coppia Jagger-Richards, è bello vedere
come la cinepresa indugi sul batterista Charlie Watts, aprendo allo spettatore una dimensione più
riflessiva e pacata sulle dinamiche del gruppo e sul suo ruolo di macchina spettacolare. Se Jagger,
Richards (e in misura minore Wood) sono la facciata degli Stones e in quanto tali sono
maggiormente sottoposti alla pressione del cliché e delle aspettative del pubblico, Watts è il solido
professionista conscio del proprio ruolo, capace di rapportarsi alle situazioni in modo analitico e
“distaccato”. Guarda in faccia la realtà, sorride e continua indefesso a tenere il tempo sull’hit-hat,
anche se ha volte si legge sul suo volto una fatica e una stanchezza che lo riportano (e con lui tutto
il gruppo) ad una dimensione umana e concreta della musica.
È evidente: da una parte c’è lo
spettacolo e dall’altra ci sono gli uomini, con
la loro forza e le loro debolezze. I fans forse
vogliono solo vedere e godere del primo, ma
Scorsese riesce – seppure a tratti – a regalarci
uno sguardo sull’uomo che si trova dietro ad
ogni musicista. La bellezza e il segreto di un
film come questo, che a una visione distratta
può apparire come una semplice (seppur
tecnicamente formidabile) registrazione di
una performance musicale, si trova proprio in
questa ricerca dei tratti di umana semplicità dei musicisti, in questo scrutare e indagare con affetto i
volti sudati e sfatti, i corpi che combattono contro il peso degli anni, in questo mettere in primo
piano la generosa fatica di chi ha fatto della musica e dello spettacolo un mestiere, ma che ha
ancora la capacità – magari per brevi eppure intensissimi momenti che ripagano la loro attesa – di
donare emozioni perpetuando un rito che si ripete da quattro decenni e che ha portato
all’edificazione della leggenda della “più grande band di rock’n’roll del mondo”2.
Da questo punto di vista, non si può che concordare con Scorsese, che si avvicina al
fenomeno Stones né da musicista né da esperto, ma da semplice appassionato. All’inizio di Shine a
Light, nelle convulse sequenze che mostrano la preparazione delle riprese dei concerti che la band
inglese ha tenuto al Beacon Theatre di New York il 29 ottobre e 1° novembre 2006, parlando con
2
Il paragone più appropriato che ci viene alla mente è Neil Young: Heart of Gold (2006) di Jonathan Demme, in cui la
dimensione concertistica si presta ad essere un trampolino di lancio per un ritratto affettuoso e partecipe di un Neil
Young invecchiato e malato ma ancora totalmente percorso e fatto vibrare dalla passione per la musica. Anche in
questo caso siamo lontani dal tono asettico (o peggio, volutamente celebrativo) che simili operazioni hanno come
corollario: se l’oggetto del film è il concerto, il suo soggetto è la ricerca dell’uomo, al di là della facile retorica dello
sguardo sul musicista.
www.turindamsreview.unito.it
2
uno dei suoi collaboratori che gli fa presente che data l’alta temperatura sviluppata dai riflettori
Mick Jagger non può stare fermo davanti agli stessi per più di una decina di secondi, Scorsese
sottolinea che «no, non possiamo dar fuoco a Mick Jagger». Non si può incendiare una leggenda. E
i Rolling Stones sono ancora una leggenda. Sarà perché non hanno mai voluto crescere e dunque
non si sono mai dovuti confrontare con il destino che Pete Townshend dei The Who prospettava in
My Generation, quel «I hope I die before I get old» che, sebbene abbia segnato il ribellismo
giovanile degli anni Sessanta, gli Stones hanno sempre irriso (o meglio ignorato) impegnati
com’erano a vivere. Anche per questo, nonostante tutto e tutti, le Pietre Rotolanti sono per il regista
italo-americano la migliore sintesi possibile di musica e spettacolo attualmente sulla piazza. E a
Scorsese (che ha fatto della riflessione e della pratica del cinema in quanto spettacolo bigger than
life uno dei capisaldi del suo essere cineasta) questa sintesi non poteva passare inosservata, tanto da
ricercare l’occasione propizia per trasformarla in uno spettacolo che abbandona i soliti venues per
essere offerto agli spettatori delle sale cinematografiche. L’esperienza offerta al pubblico
cinematografico e ai fans del gruppo va oltre la dimensione concertistica e puramente musicale: in
effetti l’operazione scorsesiana sancisce – certificandola con il suo imprinting autoriale – quello
che potremmo definire lo statuto ontologico stonesiano, quello che ha permesso al gruppo di Mick
Jagger di incarnare la musica nell’immagine e ha creato lo stereotipo della rock band e della
rock’n’roll way of life.
Still got the blues: shelter from the storm
L’amore di Martin Scorsese per la musica è risaputo e i suoi film trasudano letteralmente di
questa passione: è vero che l’utilizzo di determinate canzoni è funzionale alla creazione di
un’atmosfera o dello spirito di un periodo della storia della società americana che il regista ha
indagato nei suoi film ma è altrettanto evidente come Scorsese lavori sul lato emozionale di
musiche che sente vicine da un punto di vista biografico. Per questo non stupisce che abbia deciso
di realizzare un film sui Rolling Stones (anagraficamente sui coetanei) aggiungendo un altro
tassello a quel mosaico della propria filmografia dedicata a documentare generi, stili e musicisti che
hanno nutrito il suo immaginario. Quando lavora a film incentrati sulla musica, il compito che
Scorsese si propone è quello di essere un testimone sincero e emotivamente coinvolto per poter
diffondere il soggetto della sua indagine (e del suo amore) ad un pubblico formato non solo da
appassionati.
www.turindamsreview.unito.it
3
Nel documentario Feel Like Going Home (2003) è evidente la volontà di andare oltre lo
statuto spesso “leggendario” che il blues e le sue origini assumono, per indagare con scrupolo
storico e quasi etnomusicologico la formazione di uno stile che ha percorso trasversalmente la
cultura e le forme musicali americane fino a
diventare un linguaggio universale, capace
di mettere in relazione musicisti provenienti
dalle aree geografiche più diverse. A
differenza di Wim Wenders, che con Soul of
a Man (L’anima di un uomo, 2003) “legge”
il blues attraverso le vite esemplari di alcuni
suoi protagonisti non riuscendo però a
liberarsi da un approccio quasi mitopoietico,
Scorsese è interessato all’essenza (e all’essenzialità) dello stile, quella in cui vede davvero «l’anima
dell’uomo». Nel rapporto scorsesiano cinema-musica, il blues – con il suo mettere al centro la
singolarità di una situazione umana capace però di sollecitare le intime corde di ognuno – è il
codice genetico che dona vitalità, passione, rabbia e dolore ad una filmografia che ha come
soggetto privilegiato la crisi del singolo. È allora ovvio che Scorsese abbia ricercato, nei suoi film
musicali, di confrontarsi con artisti che nella propria formazione abbiano esperito il blues,
definendo il proprio linguaggio a partire dal confronto con questo stilistico e morale.
In No Direction Home: Bob Dylan (2005) a venire proposto è un ritratto dell’evoluzione
musicale e personale del menestrello di Duluth, con al centro la svolta elettrica e il “tradimento di
Newport”, con il passaggio dallo status di guida morale di una nazione (ancorato all’hic et nunc
dell’attualità politica e sociale) a quello di poeta in apparenza lontano dalle istanze più urgenti della
società. Un passaggio che, al di là della facile accusa del “tradimento” rivolta dalle fasce più
tradizionaliste del suo pubblico, ha ridefinito le forme della cultura musicale popolare incidendo in
maniera radicale anche nella carne viva di una quotidianità che veniva aperta a nuove visioni.
Dylan ha reso tangibile la presenza della poesia nella vita di tutti i giorni, attraverso una musica di
immediata presa e forza seduttiva, obliqua e viscerale, capace di parlare sia al cuore che al cervello.
In Dylan, Scorsese trova non tanto il poeta o l’autore di canzoni che hanno segnato la storia della
musica americana degli anni Sessanta, quanto un personale Virgilio che lo (ri)accompagna in un
viaggio nella memoria della propria giovinezza e della propria formazione. Un viaggio personale –
come personali sono sempre i viaggi intrapresi da Scorsese – in un tempo perduto di cui va
preservato il ricordo, perché si ha la coscienza che quella stagione è irrimediabilmente terminata.
www.turindamsreview.unito.it
4
È quello che accade anche con L’ultimo valzer (The Last Waltz, 1978) che, già nel titolo
crepuscolare e velato di tristezza elegiaca, rende perfettamente l’idea del congedo che il gruppo di
Robbie Robertson prende da un’epoca
che non tornerà più. È per questo che
Shine a Light, seppur simile da un punto
di
vista
strutturale
(ovvero
la
registrazione filmata di un’esibizione
live), è profondamente diverso dal film
che documenta l’ultimo concerto della
Band. Quello dei Rolling Stones non è
un concerto di commiato, ma solo
l’ennesima tappa di un neverendig tour
che li porta, sera dopo sera, a celebrare i
fasti del rock in una dimensione in cui il
tempo cronologico ha smesso di scorrere. Come in un rito, non esiste passato o futuro, ma un eterno
e immutabile presente. Per questo Scorsese non ha realizzato un documentario sui Rolling Stones
sulla falsariga di quello dedicato a Dylan: l’autore di Idiot Wind è già storia e il suo percorso può
essere analizzato con uno sguardo retrospettivo, mentre Jagger & co. non accettano il peso del
tempo e ripropongono costantemente uno show che li pone al di fuori del tempo, delle mode, dei
cambiamenti musicali e sociali3. Anche i materiali d’archivio utilizzati lavorano a definire lo statuto
di una band che sembra consustanziale alla storia stessa del rock e il tenore di tutte le interviste è
quello di chi ha sempre saputo che avrebbe continuato a calcare i palchi accettando
consapevolmente il rischio di trasformarsi nella propria caricatura. Scorsese ne è forse consapevole,
ma da uomo di spettacolo qual è accetta la sfida e riesce a (ri)creare un evento che non ha il sapore
spesso amaro della nostalgia, ma la gioia di una festa ininterrotta.
Benché scontato, è proprio il clima di gioia e di festa che pervade tutto il film (anche la
scelta dei materiali di repertorio esclude volutamente le fasi più “oscure” e difficili per la band4) a
lasciare a tutta prima interdetti, viziati come si è dalla relazione virtuale Scorsese-Rolling Stones
posta in essere dall’uso delle canzoni del gruppo nelle colonne sonore dei film del regista italo3
Va comunque sottolineato come i precedenti documentari musicali di Scorsese hanno come soggetto forme musicali e
musicisti americani, che diventano la lente attraverso la quale non solo osservare l’evoluzione della musica, ma anche
la società e la cultura americana. Per questo nell’opinione di chi scrive il regista ha preferito confrontarsi con un film
che documenta una performance, piuttosto che realizzare un documentario nello stile di No Direction Home dedicato a
un gruppo inglese.
4
Per esempio non ci sono accenni a Brian Jones, Mick Taylor e Bill Wyman, che pure hanno avuto un posto di rileivo
all’interno delle dinamiche della band. Ciò non fa che ribadire l’assoluta coscienza che il “tempo stonesiano” è il
presente, quel presente che viene attualizzato nella performance musicale.
www.turindamsreview.unito.it
5
americano. Facciamo un esempio piuttosto emblematico di questo rapporto: «Oh, a storm is
threat'ning/My very life today/If I don't get some shelter/Oh yeah, I'm gonna fade away». Si tratta
della prima strofa di Gimme Shelter, brano che apre l’album Let It Bleed (1969) e che Scorsese ha
utilizzato in Goodfellas (Quei bravi ragazzi, 1990), Casinò (1995) e The Departed (The Departed –
Il bene e il male, 2006). Come sottolinea Jagger, «that's a kind of end-of-the-world song, really. It's
apocalypse; the whole record's like that»5. E il tono apocalittico del brano è ben colto dal regista,
che lo utilizza per definire da un punto di vista sonoro ed evocativo lo stato terminale dei mondi e
dei personaggi che descrive, quei personaggi che non trovano (o non vogliono trovare) rifugio e
sono spazzati via dalla tempesta che si abbatte sulle loro vite: il vitalismo stonesiano, la volontà di
potenza del rock trova in questo brano – e nell’uso che il regista ne fa – la propria contropartita
dolorosa, il proprio lato oscuro. Da un regista che specchia la propria vita nel cinema non ci si può
che aspettare l’amore e il rispetto per una band che riflette se stessa nel rock e che della vita e del
rock sa evocare i demoni.
Lascia forse un po’ deluso lo
spettatore
scorsesiano
il
mancato
inserimento in scaletta di un trade-mark
del suo cinema come Gimme Shelter, ma
il concerto documentato da Scorsese si
muove in una direzione diametralmente
opposta a quella in cui procedono i film
in cui il brano è parte integrante di un
preciso disegno tematico e morale. Messi
dunque da parte i toni crepuscolari e apocalittici, ciò che interessa al regista e al gruppo (che ci
sentiamo di poter definire co-autore in tutto e per tutto), è lasciare il segno tangibile di una
performance organicamente, musicalmente e tecnicamente perfetta. Se è testimonianza di un
congegno ad orologeria che non perde un colpo, il regista – come abbiamo già sottolineato – si
lascia andare ad improvvise svisate che documentano il lato più tangibilmente umano della band:
fatica, sudore, coscienza di interpretare un ruolo. È la vita che scorre con il peso del tempo quella
che impressiona la pellicola, quella che si può scorgere se ci si distrae e se per un attimo non si
presta attenzione alle corse di Jagger, alle pose studiate di Richards, al turbinoso intreccio dei riffs
delle chitarre.
Scorsese asseconda come può il progetto stonesiano, realizzando con la sua equipe un filmconcerto che non lesina certo sui mezzi o sulla generosità dell’approccio, ma che ha il difetto di
5
Cfr. Jann Wenner, "Jagger Remembers", in « Rolling Stone», 14 dicembre 1995.
www.turindamsreview.unito.it
6
tutti i film di questo genere: quello di essere una testimonianza visiva e sonora di un evento
performativo che necessita di un coinvolgimento fisico diretto per poter essere apprezzato e goduto
al meglio. A parte questo appunto, i fans dei Rolling Stones hanno materiale di primissima qualità
sul quale esercitare una fine esegesi critica, di quella che sanno fare solo i grandi appassionati di
musica rock (come ci insegna Nick Horby in Alta fedeltà), discutendo la scelta della scaletta, dei
suoni e degli arrangiamenti dei brani e lustrandosi gli occhi con riprese di sfavillante perfezione
tecnica unite ad un montaggio implacabile e metronomico. E, a parte alcune discutibili e scusabili
concessioni al music business fatte per accontentare un po’ tutte le tipologie di pubblico
(l’esibizione con Buddy Guy per gli appassionati del blues, quella con Jack White per il pubblico
alternativo ma à la page e quella con Christina Aguilera per soddisfare i gusti più pop), la partenza
al fulmicotone con Jumping Jack Flash, il rituale di Sympathy for the Devil, la tranquillità con cui
Charlie Watts (con Richards forse il vero mastermind dietro il sound stonesiano) sostiene
ritmicamente l’intera esibizione dimostrandosi al contempo il componente del gruppo più
distaccato dal clima celebrativo della serata, il rock rapace di Brown Sugar, le smorfie e le corse di
Jagger, sono momenti di grande spettacolo di una band che vive all’ombra ingombrante di un
passato portato sul palco sera dopo sera.
Per Scorsese forse si è trattato solo di togliersi una soddisfazione e rendere un affettuoso
omaggio ad uno dei gruppi i cui brani sono maggiormente presenti nelle colonne sonore dei propri
film e che hanno segnato la sua giovinezza, ma è comunque divertissement di classe che pochi
registi possono permettersi, se si considera che la distribuzione nelle sale di un film-concerto è una
pratica quasi del tutto abbandonata dalle politiche distributive delle majors cinematografiche e
discografiche. Per noi del pubblico si tratta pur sempre di due ore di rock suonato ai massimi livelli.
E di questi tempi non è poco.
www.turindamsreview.unito.it
7