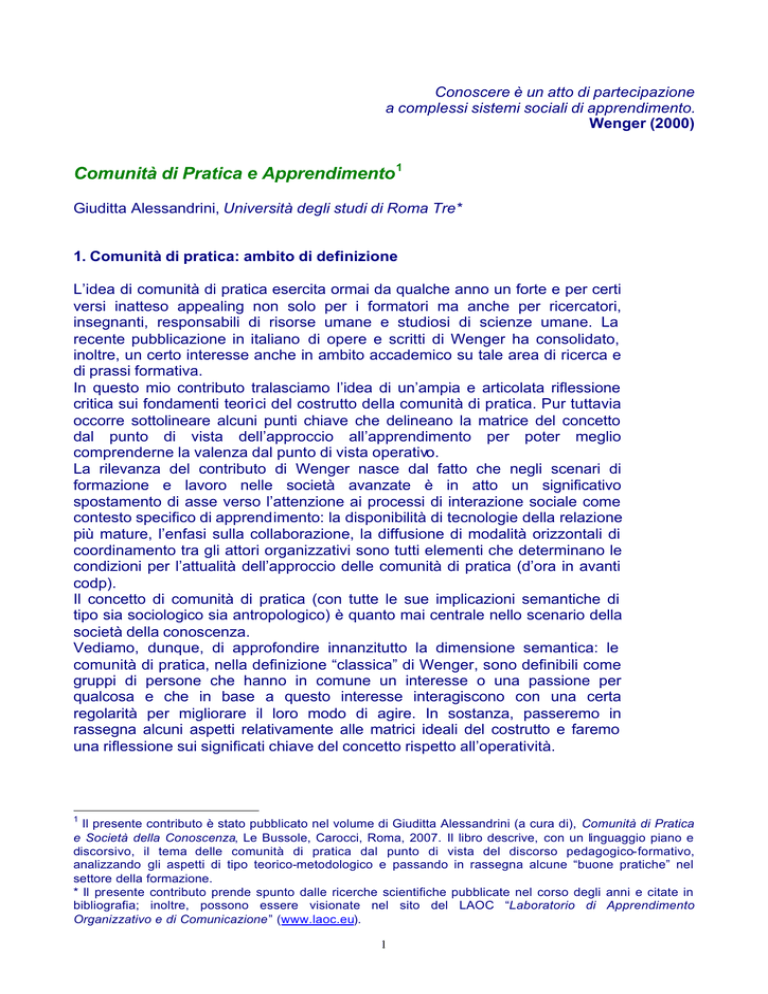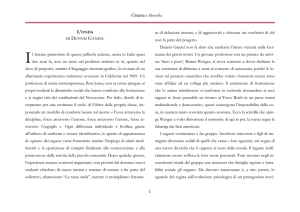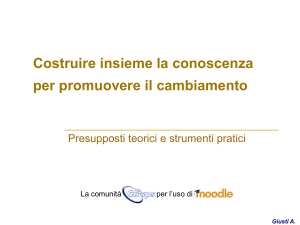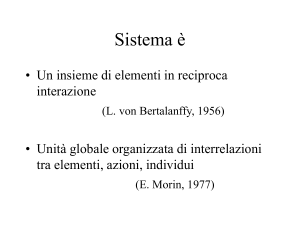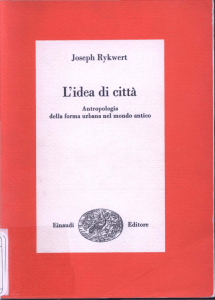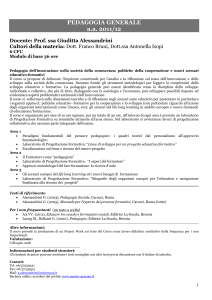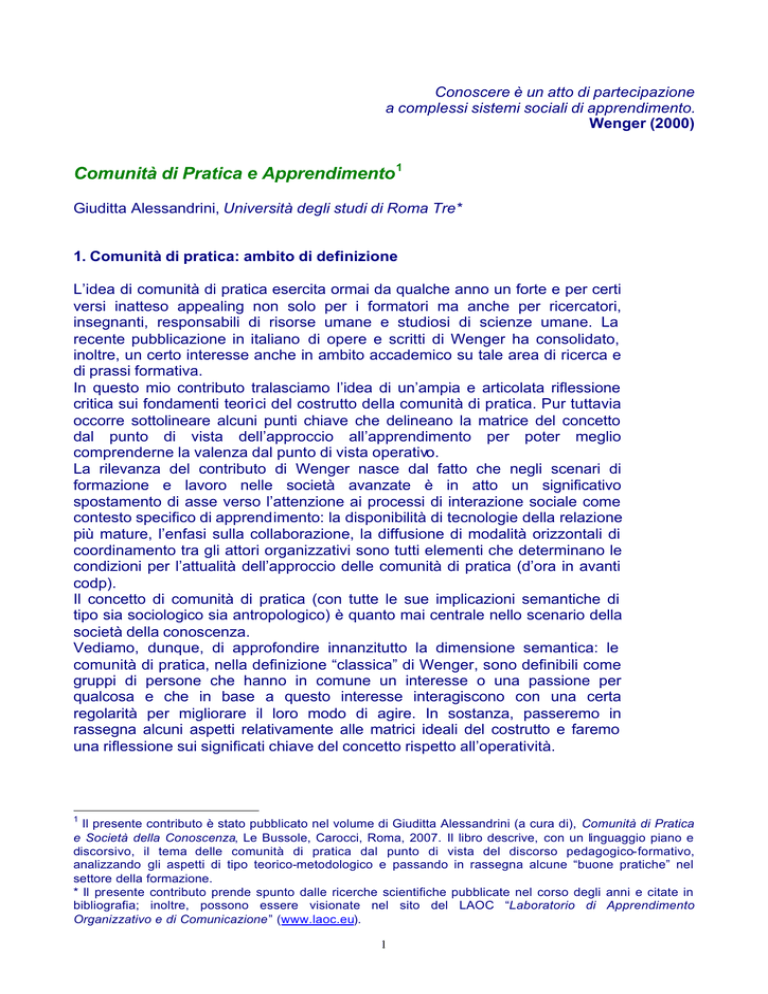
Conoscere è un atto di partecipazione
a complessi sistemi sociali di apprendimento.
Wenger (2000)
Comunità di Pratica e Apprendimento 1
Giuditta Alessandrini, Università degli studi di Roma Tre*
1. Comunità di pratica: ambito di definizione
L’idea di comunità di pratica esercita ormai da qualche anno un forte e per certi
versi inatteso appealing non solo per i formatori ma anche per ricercatori,
insegnanti, responsabili di risorse umane e studiosi di scienze umane. La
recente pubblicazione in italiano di opere e scritti di Wenger ha consolidato,
inoltre, un certo interesse anche in ambito accademico su tale area di ricerca e
di prassi formativa.
In questo mio contributo tralasciamo l’idea di un’ampia e articolata riflessione
critica sui fondamenti teorici del costrutto della comunità di pratica. Pur tuttavia
occorre sottolineare alcuni punti chiave che delineano la matrice del concetto
dal punto di vista dell’approccio all’apprendimento per poter meglio
comprenderne la valenza dal punto di vista operativo.
La rilevanza del contributo di Wenger nasce dal fatto che negli scenari di
formazione e lavoro nelle società avanzate è in atto un significativo
spostamento di asse verso l’attenzione ai processi di interazione sociale come
contesto specifico di apprendimento: la disponibilità di tecnologie della relazione
più mature, l’enfasi sulla collaborazione, la diffusione di modalità orizzontali di
coordinamento tra gli attori organizzativi sono tutti elementi che determinano le
condizioni per l’attualità dell’approccio delle comunità di pratica (d’ora in avanti
codp).
Il concetto di comunità di pratica (con tutte le sue implicazioni semantiche di
tipo sia sociologico sia antropologico) è quanto mai centrale nello scenario della
società della conoscenza.
Vediamo, dunque, di approfondire innanzitutto la dimensione semantica: le
comunità di pratica, nella definizione “classica” di Wenger, sono definibili come
gruppi di persone che hanno in comune un interesse o una passione per
qualcosa e che in base a questo interesse interagiscono con una certa
regolarità per migliorare il loro modo di agire. In sostanza, passeremo in
rassegna alcuni aspetti relativamente alle matrici ideali del costrutto e faremo
una riflessione sui significati chiave del concetto rispetto all’operatività.
1
Il presente contributo è stato pubblicato nel volume di Giuditta Alessandrini (a cura di), Comunità di Pratica
e Società della Conoscenza, Le Bussole, Carocci, Roma, 2007. Il libro descrive, con un linguaggio piano e
discorsivo, il tema delle comunità di pratica dal punto di vista del discorso pedagogico-formativo,
analizzando gli aspetti di tipo teorico-metodologico e passando in rassegna alcune “buone pratiche” nel
settore della formazione.
* Il presente contributo prende spunto dalle ricerche scientifiche pubblicate nel corso degli anni e citate in
bibliografia; inoltre, possono essere visionate nel sito del LAOC “Laboratorio di Apprendimento
Organizzativo e di Comunicazione” (www.laoc.eu).
1
2. La genesi del concetto
Come sono giunti, dunque, Wenger e Lave a elaborare questo concetto che così tanta
fortuna sta acquisendo ormai già da qualche anno nei contesti della formazione
professionale e degli adulti?
In un testo di Wenger del 1998 – tradotto in italiano nel 2006 – è possibile trovare una vera
e propria sistematizzazione dei concetti che inquadrano il tema della comunità di pratica
nell’ambito di una teoria sociale dell’apprendimento.
I primi studi sulle comunità di pratica, che risalgono alla fine degli anni ottanta, erano rivolti
ad approfondire il concetto di apprendimento situato (Lave, Wenger, 2006; Pontecorvo,
Ajello, Zucchermaglio, 1995; Striano, 2000), definizione emersa come esito di alcuni studi
in ambito psicologico e antropologico. Questi studi in particolare erano scaturiti da una
riflessione sul fenomeno specifico dell’apprendistato: le ricerche prendevano in esame
l’interazione tra gli apprendisti, i loro istruttori e gli altri lavoratori, anche saltuari,
dell’azienda, in situazioni locali, in cui ancora l’influenza delle tecnologie di rete era
assente o estremamente limitata. Una prima attenzione al tema si deve alle ricerche sui
comportamenti dei dipendenti della Xerox negli anni ottanta; già allora le comunità erano
descritte come «piccoli gruppi di persone che lavorano insieme per un certo tempo e
collaborano allo sviluppo di un lavoro comune, operano alla pari e li lega la percezione
condivisa che ciascuno ha la necessità di sapere quello che conoscono gli altri» (Orr,
1995).
Wenger e Lave riflettono, viceversa, sul fatto che nell’apprendistato è fondamentale non
solo il rapporto tra esperto e novizio, ma anche quello tra i membri della comunità che
partecipano all’esperienza di apprendimento. La relazione fondamentale nell’apprendistato
è dunque una relazione di “partecipazione evolutiva” e di trasformazione dell’identità
all’interno di un approccio che possiamo definire comunitario. Da questa riflessione
emerge negli autori l’idea di elaborare il concetto di partecipazione periferica legittimata
(legittimate peripheral partecipation, lpp) per far riferimento ai processi specifici di
apprendimento chiamati in causa. Gli elementi cardine che emergono all’interno del
costrutto della codp sono i due “poli”, comunità e pratica, che si innestano su un altro
concetto chiave, quello di apprendimento situato.
Quest’ultimo termine rimanda a un approccio teorico all’apprendimento caratterizzato in
senso sociale che sarà oggetto di analisi nel prossimo paragrafo. A Wenger e Lave si
deve il merito di aver codificato
una realtà sotto gli occhi di tutti e già in qualche modo presente sotto altre “etichette”
definitorie.
Le comunità di pratica sono dappertutto e sono «i mattoni costitutivi di un sistema sociale
di apprendimento poiché sono i contenitori sociali delle competenze che costituiscono
questi sistemi», sostiene Wenger in uno scritto recentemente riproposto in lingua italiana
in una miscellanea (Wenger, in Zucchermaglio, Alby, 2006). La fortuna del concetto è
stata enorme negli ultimi anni, anche se il costrutto viene spesso applicato a uno spettro
ben più ampio di quello originario come i project teams (cioè gruppi formalmente definiti) e
a gruppi di persone che lavorano on line (come i progettisti di software).
Un ulteriore aspetto di rilievo, è che si evidenziano due accezioni di significato, la prima
orientata a una dimensione teorica e descrittiva (che si inserisce in un quadro teorico più
ampio) e la seconda a una di tipo prestazionale che vede le codp come una soluzione
consulenziale orientata a migliorare l’organizzazione. È chiaro che, se ci si accosta al
tema dal punto di vista di un approccio strumentale, possono emergere numerose riserve
anche rispetto al contesto d’uso (non sempre legittimo e pertinente) del costrutto. Se,
viceversa – come intendo esporre in questo contributo - il costrutto è “letto” nelle sue
2
implicazioni teoriche e metodologiche, è più facile comprenderne la consistenza e la
possibilità di sviluppo.
3. L’apprendimento come pratica sociale
Il costrutto della codp si correla a una visione ben determinata di apprendimento che è in
linea, peraltro, con una parte della letteratura classica. L’apprendimento viene considerato,
dunque, come parte integrante della vita quotidiana. In modo più specifico, gli assunti da
cui parte la teoria dell’apprendimento di Wenger sono i seguenti:
• la natura “sociale” degli individui;
• la conoscenza (knowledge) intesa come competenza in attività socialmente apprezzate;
• il conoscere (knowing) inteso come partecipazione ad attività socialmente apprezzate.
Sulla base dei tre assunti viene proposta una teoria dell’apprendimento come
partecipazione sociale.
Il termine “partecipazione” significa per Wenger essere “partecipanti attivi” nelle pratiche di
comunità sociali e nella costruzione di identità in relazione a queste comunità. Quando
partecipiamo a processi di interazione, secondo questa visione, costruiamo la nostra
identità. Il che significa che partecipare influenza ciò che facciamo ma anche ciò che
siamo.
Le componenti di particolare rilievo di questo schema concettuale sono quattro:
• il significato: sta a indicare la nostra capacità di sperimentare la vita e il mondo come
qualcosa di significativo (Wenger, 2006, ed. or. 1998);
• la pratica: è in sostanza l’insieme degli schemi di riferimento che sostengono il
coinvolgimento nell’azione;
• la comunità: rinvia alla configurazione sociale nella quale la nostra partecipazione è
considerata competente;
• l’identità: si determinano processi in divenire nell’ambito delle nostre comunità.
L’apprendimento è quindi visto come appartenenza, come esperienza, come azione e
come divenire.
L’ambito concettuale a cui si riferisce il nostro autore nel suo volume più sistematico (ivi,
2006) fa riferimento in realtà non tanto a una teoria specifica dell’apprendimento, ma a una
teoria sociale dai confini e dalle connotazioni disciplinari molto ampie: dalle tesi
“platoniche” alla sociologia di Émile Durkheim e Max Weber, fino a Anthony Giddens, con
riferimenti ad altre discipline come la linguistica e la psicologia. È fortemente influenzato,
inoltre, da alcuni assiomi dello strutturalismo, secondo cui è più rilevante la struttura che
l’individuo e le sue singole azioni.
La focalizzazione sul contesto situazionale, cioè l’attenzione all’ambiente reale e
fenomenico che l’individuo vive nella sua esperienza di apprendimento, rimanda ad alcune
scuole di pensiero che negli ultimi vent’anni hanno creato un solco nell’interpretazione dei
processi di cognizione: la teoria fenomenologica di Martin Heidegger fino agli approcci
“ecologici” di Humberto Maturana e Francisco Varela, l’interazionismo simbolico in
sociologia e etnometodologia. Non ultimo il riferimento a studi in ambito linguistico sull’idea
dell’identità come narrazione.
La conoscenza – in estrema sintesi – emerge da questi riferimenti come un processo
mediato dalle caratteristiche strutturanti dei contesti sociali.
Anche rispetto al concetto di pratica i debiti riconosciuti da Wenger sono molti: dal
riferimento all’idea di praxis di origine marxiana a Jürgen Habermas, fino agli studi dei
sociologi Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron e ad alcuni approcci di sociologia della
scienza.
3
Questa costellazione multidisciplinare è sottolineata come quadro di riferimento implicito
che giustifica la teoria sociale dell’apprendimento del nostro autore. Si tratta di un tentativo
di sistematizzazione pur encomiabile; non sfugge il rischio di “sfondamento” delle radici
teoriche della codp in un insieme troppo vasto di idee e concetti che appartengono a tutta
la storia del pensiero del xx secolo.
Wenger sintetizza molto efficacemente gli assiomi della sua teoria con particolare riguardo
all’apprendimento (cfr: figura 1); vediamo nel riquadro di approfondimento i principi che
enumera.
Ognuno degli aspetti riportati nel riquadro di approfondimento richiederebbe un
approfondimento, ma preferiamo sviluppare solo alcune considerazioni di sintesi.
Figura 1 - Le declinazioni dell’apprendimento
L’apprendimento:
• è soprattutto capacità di negoziare nuovi significati;
• crea strutture emergenti;
• è esperienziale e fondamentalmente sociale;
• trasforma le nostre identità;
• costituisce delle traiettorie di partecipazione;
• implica la gestione dei confini;
• concerne l’energia sociale e il potere;
• presuppone l’impegno;
• implica l’immaginazione ;
• è un fatto di allineamento;
• implica un’interazione tra locale e globale;
considerazioni di sintesi.
4. Caratteristiche di una codp
Una comunità non è di per sé una comunità di pratica se non sono presenti alcune
caratteristiche: la pratica infatti diventa un elemento per così dire “aggregante” della
comunità; in questo orizzonte occorre chiedersi come si articola, dunque, la pratica e quali
sono le sue specificità. Scorgiamo soprattutto tre dimensioni nello schema concettuale del
nostro autore.
• Impegno reciproco: un’interazione all’interno della comunità che si esplichi in discussioni,
attività in comune, aiuto reciproco. La condivisione di interessi è una condizione
necessaria ma non sufficiente per l’esistenza di una comunità di pratica: è cruciale
l’aspetto interattivo e un impegno nell’attività comune, che dev’essere condiviso anche se
può essere discontinuo. L’appartenenza a una codp è dunque un patto di impegno
reciproco ed è ciò che definisce la comunità. Se ci sono intense relazioni intorno ai compiti
da svolgere, allora possiamo parlare di comunità di pratica e non semplicemente di team o
di network. Sottolinea, infatti, Wenger che la pratica non esiste in astratto e che l’impegno
reciproco richiede interazioni continue.
• Impresa comune: un’identità che deriva dalla condivisione di interessi e soprattutto dalla
dedizione e lealtà dei suoi aderenti (commitment) nei confronti della comunità; in queste
condizioni la comunità acquisisce una competenza collettiva e i suoi membri imparano gli
uni dagli altri. Un’impresa comune è un “processo collettivo di negoziazione” che
indubbiamente fa comprendere il significato della complessità di un impegno reciproco. La
responsabilizzazione diventa parte integrante della pratica: da ciò deriva il fatto che il
processo sia “generativo” ma anche “vincolante”.
4
• Prassi condivisa o repertorio comune: la presenza di un insieme di risorse e di pratiche
condivise che sono il risultato del continuo confronto informale e dialettico delle esperienze
personali messe al servizio della comunità. Il processo di sviluppo di queste risorse può
anche non essere svolto in modo conscio e intenzionale, ma semplicemente attivarsi in
maniera spontanea in conseguenza dei rapporti sociali che si instaurano con gli altri
membri della comunità. Il repertorio di una comunità di pratica include routine, parole,
strumenti, modi di operare che in parte hanno aspetti di reificazione (cioè di “costruzione di
realtà”) e partecipazione. È interessante, ad esempio, la definizione che Wenger fornisce
del termine “repertorio” in quanto «set di risorse condivise dalla comunità per enfatizzare il
carattere sperimentato e la disponibilità per un ulteriore coinvolgimento nella pratica»
(Wenger, 2000).
Le comunità di pratica sono dunque, per il nostro autore, gruppi di persone che
condividono un interesse per qualsiasi cosa fanno e che interagiscono con regolarità per
imparare a farlo meglio, gruppi di individui, cioè, che condividono esperienze e, attraverso
questo processo di interazione, apprendono sia come soggetti sia come parte di gruppi
sociali.
Quando dunque una comunità può essere considerata “vitale”? È indubbio che le
comunità non vivono per sempre ma hanno un proprio ciclo di vita: è importante, allora, in
questa direzione trovare modalità che consentano ai partecipanti di sentirsi professionisti
che comunicano intensamente costruendo identità e repertori condivisi. È rilevante
osservare che non si tratta tanto di vicinanza fisica ma di vicinanza di pratiche per dar
luogo a una comunità. È più significativa la condivisione che la vicinanza-distanza. Infatti, il
costrutto della comunità di pratica ha trovato un grande interesse nell’area delle virtual
community. Ambienti virtuali che consentono lo scambio di messaggi – come forum, wiki e
blog o sistemi di videoconferenze – a basso costo, nella misura in cui creano le condizioni
per mantenere viva l’identità degli attori organizzativi, determinano incentivi per i processi
di condivisione necessari a coltivare la comunità.
5. Le codp come campo di costruzione dell’identità
Nel quadro di riferimento complessivo che stiamo descrivendo in queste pagine, il tema
dell’identità è parte integrante di una teoria sociale dell’apprendimento. Da qui deriva che il
tema dell’identità è quindi strettamente connesso alla comunità. Il focus sulla comunità fa
risaltare il problema della non partecipazione e partecipazione, dell’esclusione e dell’
inclusione degli attori di una comunità.
Che cosa significa, dunque, “costruire un’identità”? È chiaro che il tema dell’identità ha
svariate connotazioni e interpretazioni sul piano disciplinare. Le scienze sociali si sono
focalizzate sul carattere
relazionale e intersoggettivo dell’identità e hanno studiato nel tempo le caratteristiche e le
dinamiche che contraddistinguono la sua genesi e il suo sviluppo.
La visione dell’identità come “costruzione sociale” e prodotto storico emerge in particolare
dalla letteratura di taglio antropologico. Si deve indubbiamente però a Erik H. Erikson –
che a sua volta sviluppava un’idea freudiana – l’aver per la prima volta richiamato
l’attenzione in modo sistematico al tema dell’identità, in particolare l’idea che lo sviluppo
del senso soggettivo di continuità personale dipenda dall’opportunità per l’individuo di
trovare il riconoscimento della propria identità in gruppi e comunità più estesi. Altre correnti
come l’interazionismo simbolico, la teoria dei ruoli sociali di Robert Merton, l’approccio
parsoniano hanno fornito importanti contributi allo studio di processi identitari.
5
Anche se non sono sempre esplicitati i legami di cui si avvale Wenger, è indubbio che egli
si ricollega a un consistente filone di ricerche centrate sulla visione dell’identità come
risultato dinamico dei processi
di mediazione sociale. Secondo Wenger, la costruzione dell’identità consiste nel negoziare
i significati del nostro agire in quanto membri di una comunità (Wenger, 2006, ed. or.
1998).
Che cosa significa questa espressione, dunque? Possiamo sostenere che l’identità è una
sorta di “cerniera” tra il sociale e l’individuale: in altri termini, se è vero che la nostra
visione del mondo, i nostri linguaggi manifestano la ricchezza e la complessità delle nostre
relazioni sociali, la nostra identità come individui non può dissociarsi dalla nostra identità
come membri di una comunità. È importante a questo proposito evitare di cadere nel
pregiudizio secondo cui tutto ciò che è individuale traspira libertà, mentre il sociale è fonte
di vincoli e di limitazioni, così come l’ipotesi inversa. In sostanza non si può vedere come
ineliminabile il conflitto tra individuale e sociale.
Ma la formazione di una comunità di pratica è anche un processo di negoziazione
dell’identità. Possiamo individuare, seguendo questo ragionamento, diverse modalità di
estrinsecazione dell’identità:
identità come esperienza negoziata, come appartenenza alla comunità, come traiettoria di
apprendimento, come nesso di multiappartenenza, ma anche come relazione tra il globale
e il locale.
È interessante dedicare qualche riflessione al fatto che per Wenger l’identità è una sorta di
stratificazione di eventi, di partecipazione e di reificazione attraverso cui si trasformano sia
la nostra esperienza che la sua interpretazione sociale. L’identità è il risultato di un
intreccio di esperienze partecipative e di proiezioni che viene continuamente elaborato
nella pratica. Le dimensioni dell’identità sono correlate a quelle della competenza e si
declinano come reciprocità dell’impegno, responsabilità nei confronti di un’impresa,
negoziazione di un repertorio. Come dice Wenger (2006, ed. or. 1998): «Sappiamo chi
siamo in base a ciò che è familiare, comprensibile, usabile, negoziabile, sappiamo chi non
siamo in base a ciò che è estraneo, opaco, disagevole, improduttivo».
L’identità è vissuta e negoziata, ha carattere sociale e si configura nel tempo come una
“traiettoria” che incorpora sia passato che futuro in quanto essa stessa (l’identità) è
oggetto di apprendimento.
È possibile, dunque, nella costruzione teorica che sostiene le comunità di pratica,
individuare un parallelismo tra pratica e identità.
L’identità può essere colta, infatti, come:
• esperienza negoziata di sé (in quanto partecipazione e reificazione);
• appartenenza;
• traiettoria di apprendimento;
• nesso di multiappartenenza;
• appartenenza definita globalmente ma vissuta localmente.
Alla stessa stregua, la pratica:
• è negoziazione di significato;
• comunità;
• storia comune di apprendimento;
• confine e paesaggio;
• costellazioni.
L’identità è assimilata a una stratificazione di eventi finalizzati alla partecipazione e alla
reificazione attraverso cui l’esperienza e la sua interpretazione sociale si “informano” a
vicenda. Wenger costruisce, dunque, un quadro complesso e articolato che identifica
come ecologia sociale dell’identità.
6
Il parallelismo tra pratica e identità è suggestivo ma conduce anche ad avanzare un
approccio critico dal punto di vista della pedagogia della persona; l’elemento che
potenzialmente caratterizza l’identità – in una visione antropologica di taglio umanistico, ad
esempio –, la specificità della dimensione individuale in quanto soggettualità (cioè
centralità del soggetto in quanto essere responsabile), sembra essere totalmente
assorbita dalla dimensione dell’interazione sociale.
“Appartenenza” e “reificazione” sono i due simulacri ai quali nella teoria di Wenger si
sacrifica inesorabilmente il soggetto (così tendenzialmente enfatizzato nell’approccio
pedagogico tout court).
Siamo convinti che la persona non sia altro che un partecipante a pratiche (practitioner)?
Che la dimensione individuale possa essere assorbita senza problemi e senza tracce
ineliminabili dai vettori che spingono le comunità, quali l’impegno reciproco, l’impresa
comune e il repertorio condiviso?
E’ sufficiente ricordare che l’impianto complessivo della costruzione ecologica (come viene
definita) è coerente e ben costruito, anche se i presupposti sui quali si poggia sono
ipotizzati più come postulati che come risultati emergenti da logiche empiriche.
L’identità necessita anche di confini: il riferimento a questo concetto occupa addirittura un
capitolo nel volume sistematico del 1998.
È opportuno qui approfondire meglio tale concetto anche in riferimento all’idea di
traiettoria, perché è strettamente correlato all’idea di identità.
Il quadro che ci descrive Wenger presenta sostanzialmente le nostre identità come
dimensioni che creano traiettorie sia all’interno che tra le comunità di pratica.
L’accezione di traiettoria è quella di un percorso che implica un movimento continuo e no n
un tragitto previsto o disegnato. Il sé è oggetto di approcci e tecniche di autosviluppo e
quindi implica processi trasformativi che per certi versi si possono identificare essi stessi
con processi di apprendimento che si innestano nella pratica (Mezirow, 1991).
Nel contesto della comunità di pratica sono identificati diversi tipi di traiettorie:
• periferiche (sono quelle che non portano a una piena partecipazione);
• dirette verso l’interno (sono quelle dei neofiti che entrano nella comunità con la
prospettiva di diventare “partecipanti” a pieno titolo);
• interne (si tratta di direzioni tendenti a rinegoziare la propria identità);
• di confine (sono movimenti che tendono al superamento dei confini e al collegamento tra
le comunità di pratica);
• dirette verso l’esterno (si tratta di processi di spostamento verso nuove relazioni).
Una comunità di pratica può anche essere descritta, dunque, come un campo di traiettorie
possibili, quasi un’arena di possibili futuri e possibili passati. La nozione di traiettoria –
nella misura in cui enfatizza la dimensione temporale – caratterizza l’identità come
“divenire” e come sostanzialmente influenzata dallo sforzo di creare un processo di
coerenza nel tempo.
È chiaro, infine, che il concetto di identità è anche connesso a quello di multiappartenenza.
Ogni attore sociale è membro e practitioner di più comunità: in questo senso l’identità è
vista come “nesso di multiappartenenze”. Per rifarci a un’espressione suggestiva di
Wenger, «la multiappartenenza è l’espressione vivente dei confini» (Wenger, 2006).
Ognuno di noi può far parte di diverse comunità di pratica e quindi avere diverse
esperienze dei confini. Ma come fanno le comunità di pratica a organizzare le proprie
interconnessioni?
Secondo Wenger, esistono alcuni oggetti di confine che facilitano il compito o, viceversa,
si possono venire a determinare alcuni sostanziali fattori di intermediazione. I primi sono
“artefatti”, documenti, forme di reificazione intorno alle quali le comunità creano le loro
interconnessioni. I secondi sono “connessioni” messe a disposizione da persone che
possono introdurre fattori ed elementi di una pratica
7
in un’altra pratica.
I processi di standardizzazione delle informazioni (ad esempio la modulistica) possono
fungere da “oggetto di confine”: ad esempio, la partecipazione ai bandi europei attraverso
l’imposizione di framework per il lavoro cooperativo crea artefatti che delineano confini
entro i quali si determina lo spazio di ammissibilità delle azioni dei membri di una
comunità.
Il discorso sugli oggetti di confine è particolarmente interessante perché chiama in causa
la progettazione degli artefatti. Quando una persona utilizza un artefatto diventa a tutti gli
effetti anche un membro di una comunità di pratica. Basti pensare, ad esempio, alla
cosiddetta “metafora della scrivania” introdotta da Windows come standard: è un artefatto
che ha creato la possibilità di dialogo nell’ambito di una popolazione di utenti
completamente diversi tra loro e appartenenti a comunità molto differenti.
Ognuno di noi attraversa i confini di diverse comunità e contribuisce alla negoziazione di
significato all’interno delle diverse pratiche.
È indubbio che abbiano una notevole importanza anche le pratiche di confine. Il compito
della pratica di confine – come suggerisce il nostro autore in una delle sue opere tradotte
in italiano (Wenger, 2006, ed. or. 1998) – è quello di gestire i confini riconciliando le
posizioni e trovando soluzioni. Anche i corsi di formazione potrebbero essere identificati
come pratiche di confine; il corso, infatti, è un luogo dove le comunità operanti in ambiti
diversi cercano di comunicare tra di loro al di là dei confini specifici che caratterizzano il
loro ambito di attività. Un discorso a parte riguarda il tema dei confini istituzionali e della
pratica: i confini della pratica non coincidono infatti con i confini istituzionali. Un’unità
organizzativa può non percepirsi come codp, ma diverse codp possono convivere in un
ambito organizzativo. Tali ambiti possono coincidere con una o varie comunità di pratica o
addirittura nessuna comunità; queste possono anche gettare ponti tra confini istituzionali e
intrattenere relazioni di reciprocità che tendono ad attenuare i confini (Wenger, 2000). Ad
esempio, i progettisti di un software formativo interagiscono con i creatori dei contenuti di
apprendimento del corso (che possono afferire alle discipline più svariate) scambiando
pareri e idee nella misura in cui di fatto diminuiscono i confini.
Un’ultima interessante osservazione è che confini e periferie tendono a sovrapporsi: ad
esempio – come riporta lo stesso Wenger – il fatto che i liquidatori delle pratiche sanitarie
conoscano il gergo dei medici fa sì che si creino “intrecci” tra la comunità dei medici e
quella dei liquidatori.
6. Note conclusive
Il carattere fortemente suggestivo del tema della comunità di pratica scaturisce da alcuni
fattori: la crescente tendenza nei paesi avanzati verso forme “orizzontali” di
comunicazione, la crescita di spinte verso l’autoapprendimento, la presenza di forme
“meticciate” di apprendimento e di lavoro e, infine, il valore di intermediazione giocato
sempre più nello scenario futuro delle tecnologie di rete. Da qui il grande interesse tra i
formatori sul tema, anche considerando le prospettive applicative possibili, ad esempio,
nella formazione professionale e universitaria. Per valutare le effettive “promesse” che
scaturiscono dall’approccio e dal costrutto della codp, è opportuno approfondire le
dimensioni teoriche che caratterizzano il tema, correlate, naturalmente, alla teoria
dell’apprendimento come pratica sociale elaborato in seno alle opere di Wenger.
Tra le domande chiave, ad esempio, possiamo considerare le seguenti: in che misura si
differenziano le comunità di pratica dalle comunità di apprendimento? È chiaro che non si
tratta di sinonimi ma che esistono elementi di differenziazione significativi.
8
NOTA BIBLIOGRAFICA
Alessandrini, G.(1994), La formazione continua nelle organizzazioni, Tecnodid, Napoli.
Alessandrini, G. (1995), Apprendimento organizzativo, Unicopli, Milano.
Alessandrini, G. (1998), Manuale per l'esperto dei processi formativi, Carocci, Roma
Alessandrini, G. (a cura di) (2000), Formazione e organizzazione nella scuola dell’autonomia, Guerini e
Associati, Milano.
Alessandrini, G. (a cura di) (2002), Pedagogia e formazione nella società della conoscenza, Franco Angeli,
Milano.
Alessandrini, G. (a cura di) (2004), Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni, Guerini, Milano.
Alessandrini, G. (a cura di) (2005), Manuale per l’esperto dei processi formativi, Carocci, Roma.
Alessandrini, G. (a cura di) (2005), Formazione e sviluppo organizzativo, Carocci, Roma.
Alessandrini, G. (a cura di) (2007), Comunità di pratica e società della conoscenza, Le Bussole, Carocci,
Roma.
Mezirow, J. (1991), Transformative Dimensions of Adult Learning, Jossey-Bass, San Francisco.
Orr, J. (1995), Condividere le conoscenze, celebrare l’identità. La memoria di comunità in una cultura di
servizio, in Pontecorvo, Ajello, Zucchermaglio (1995).
Pontecorvo C., Ajello A.M., Zucchermaglio C. (1995), I contesti sociali dell’apprendimento, Led, Milano.
Striano, M.P. (2000), I tempi e i luoghi dell’apprendere. Processi di apprendimento e contesti di formazione,
Liguori, Napoli.
Wenger, E. (2000), Comunità di pratica e sistemi sociali di apprendimento, in “Studi Organizzativi”, 1, pp. 1134.
Wenger, E. (2006), Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Raffaello Cortina, Milano (ed.
or. 1998).
Zucchermaglio C., Alby F. (2006), Psicologia culturale delle organizzazioni, Carocci, Roma.
L’AUTORE
Giuditta Alessandrini è professore ordinario (Raggruppamento MPED 01) titolare
dell'insegnamento di Pedagogia Sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi di Roma TRE, ove insegna anche Pedagogia del Lavoro e
Pedagogia delle risorse umane nel corso di Laurea Magistrale. È direttore del Master
Universitario di I livello a distanza GESCOM “Gestione e sviluppo della conoscenza
nell’area delle risorse umane ” (www.master-gescom.it). E’ delegato per l’Orientamento in
uscita ed il placement nell’ambito del GLOA (Gruppo di lavoro per l’orientamento in
Ateneo, e delegato per i Rapporti con Almalaurea).
Svolge attività di servizio, consulenza e docenza per numerose facoltà, società ed Enti.
9