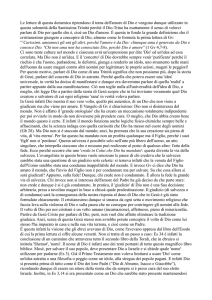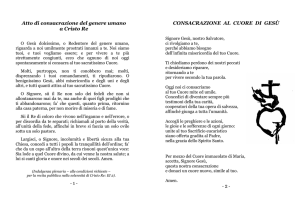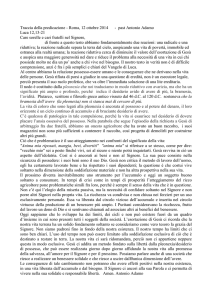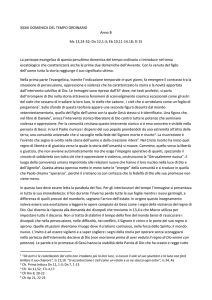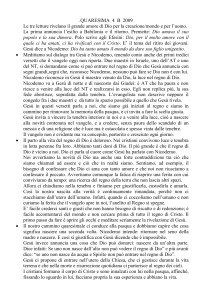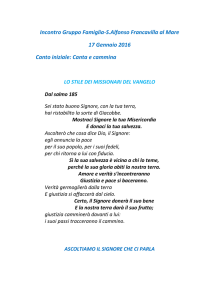IV DOMENICA DI QUARESIMA
2 Cr 36,14-16.19-23
Siamo alla conclusione di una vasta opera storiografica, che l’esegesi attribuisce ad una
scuola sacerdotale del postesilio, opera che comprende i due libri di Cronache e forse anche
Esdra e Neemia. Il cronista vede la storia d’Israele come una storia di abomini, che
attentano al cuore stesso della vita religiosa del popolo, ossia alla purezza del tempio.
L’intera vicenda d’Israele e di Giuda è quindi quella di una serie di richiami premurosi che
Dio ha attuato nei confronti del suo popolo, inviando dei profeti, i suoi messaggeri. Tutti
questi invii di profeti sono dovuti all’amore compassionevole del Signore per il suo popolo
e per la sua dimora in mezzo a loro. A questa compassione del Signore corrisponde, da parte
del popolo, non l’accoglienza ma il rifiuto e il disprezzo verso i profeti, divenuti oggetto di
scherno. La risposta negativa suscita in Dio un’ira che giunge al suo culmine, presentandosi
come ormai senza rimedio. Tale valutazione della storia delle relazioni tra Dio e il popolo
intende spiegare la ragione della caduta di Gerusalemme, della sua distruzione e dell’esilio
in Babilonia di coloro che erano scampati alla strage. L’autore, però, ha ben chiaro un
fondamentale principio teologico: il Signore della storia è soltanto Yhweh e non le varie
potenze politico-militari che si succedono. Anzi, esse sono misteriosamente al servizio del
compiersi della parola del Signore.
L’autore del secondo Libro delle Cronache, cita Ger 29 per quanto riguarda la durata
dell’esilio che serve, secondo la corrente sacerdotale, per la purificazione dei sabati non
osservati da Israele. In definitiva, il principio teologico con cui egli legge la storia, è quello
della ‘retribuzione’, per cui al peccato corrisponde il castigo, alla fedeltà nel bene il premio.
L’intento che Dio persegue non è dunque il castigo del peccato, ma la conversione e la vita
del peccatore. E’ quanto il popolo sperimenta nella sua storia con il ritorno nella terra dopo
la deportazione in Babilonia. Ecco perché l’autore insiste sul fatto che la parola di Dio
attraverso Geremia (29,10) si compie interamente. Affinché tale parola si adempia, il
Signore desta lo spirito di Ciro, re di Persia e questo suo intervento misterioso sfocia
nell’editto regale del 538 a.C. Ciò che è più interessante, è che l’autore fa diventare questo
editto imperiale una sorta di proclamazione di fede nel Dio d’Israele da parte del persiano
Ciro:«Yhwh, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di
costruirgli un tempio a Gerusalemme» (2 Cr 36,23). Nella riedificazione del tempio l’autore
vede il primo e fondamentale intervento di Dio per essere con il suo popolo, per avere
letteralmente ‘casa’ in mezzo a loro. Inoltre l’editto presenta anche la sollecitazione del re
persiano ai giudei deportati, perché tornino alla loro terra. Anche qui si presenta un Ciro
teologo della storia, che riconosce in Giuda/Israele il popolo di Dio e come esso sia
accompagnato e sostenuto, nel cammino dal suo Dio:«Il Signore, suo Dio, sia con lui e
salga».
1
Gv 3,14-21: Dio è fedele alla sua Alleanza
Il contesto della pericope liturgica è il più ampio dialogo con Nicodemo, nel corso del quale
Gesù ha l’occasione di annunziare la possibilità di un nuova nascita, non frutto di risorse
umane, ma del dono divino dello Spirito e dell’acqua, cioè la rivelazione cristologica.
Il v. 14 introduce il tema dell’innalzamento del Figlio dell’Uomo: tale titolo cristologico ha
certamente un’ascendenza danielica e si riferisce alla visione notturna di Dn 7. Nel vangelo
di Giovanni il titolo di ‘Figlio dell’Uomo’ viene usato da Gesù in riferimento alla propria
azione redentrice, al compimento della propria missione. L’espressione ‘Figlio dell’Uomo’,
che Giovanni cita 13 volte, è una figura dinamica depositaria della rivelazione e soprattutto
oggetto di esaltazione perché congiunge l’umile umanità alla sua gloria divina.
L’innalzamento di cui si parla al v. 14, fa pensare subito all’innalzamento sulla croce che
nella logica umana sembra il colmo dell’umiliazione e dell’abbassamento, ma che nella
prospettiva pasquale assunta da Giovanni diventa la rivelazione della sua condizione regale
perché è una morte per dedizione assoluta, per amare fino alla fine; l’innalzamento sul trono
della croce diventa cioè un innalzamento a segno rivelatore di salvezza. Colui che è
innalzato sulla croce diventa oggetto di contemplazione, come appare dalla tipologia
istituita con il serpente di bronzo innalzato da Mosè nel deserto (Nm 21,9).
Quanto precedentemente era stato affermato sulla missione del Figlio dell’Uomo, innalzato
sulla croce, per donare la vita eterna a chi crede in lui, trova ora la sua fondazione teologica
in una cristologia del Figlio in modo assoluto. Difatti il v. 16 inizia con una particella che
talora ha un valore comparativo, ma quando è usata in modo assoluto assume una valenza
esclamativa:«Fino a tal punto!». Inoltre la sua collocazione all’inizio della frase gli dà un
valore assai enfatico. Si vuole così introdurre un’affermazione radicalmente unica e
incomparabile, per dire il mistero di un amore di Dio assolutamente smisurato e che ha per
oggetto il mondo. Il dialogo con Nicodemo si addentra poi in una serie di riflessioni di
natura escatologica, tipicamente giovannea, che al contrario dei Sinottici anticipa il giudizio
fin da ora, per cui esso si dà quando, invece della decisione di fede, si dà quella
dell’incredulità. Chi crede ha già la vita eterna e con essa la promessa della risurrezione,
mentre chi non crede è già condannato (Gv 3,18). In definitiva per Giovanni la decisione di
incredulità pone la persona in un permanente stato di giudizio che si manifesterà nell’ultimo
giorno. Nel prosieguo delle parole rivolte a Nicodemo, Gesù esplicita che il giudizio di
condanna non è formulato da Dio, ma da chi si chiude alla luce divina venuta nel mondo e
perciò risulta essere un’autocondanna. All’Amore incomprensibile di Dio, che giunge a dare
il Figlio per il mondo, si contrappone il fatto che gli uomini hanno amato più le tenebre che
la luce. L’antitesi con cui si conclude il dialogo con Nicodemo vede l’opposizione tra chi fa
il male e non viene alla luce e colui che fa la verità e viene alla luce. Fare la verità, nel
vangelo di Giovanni, significa aprirsi al mistero di Cristo rivelatore, accogliendolo perciò
come ‘luce’. La contrapposizione non è quindi tra un agire eticamente negativo e uno
positivo, ma tra un agire ispirato all’incredulità e uno radicato nella fede cristologica. Infatti
per Giovanni l’unica vera opera di Dio che l’uomo possa realizzare è la fede: «Questa è
l’opera di Dio: credere in colui che Egli ha mandato» (Gv 6,29).
Nicodemo ha accolto ciò che Gesù gli ha detto? Ha accettato di venire alla luce?
La risposta la troviamo in Gv7,50, quando difende Gesù davanti al Sinedrio e poi quando,
onora Gesù, in modo regale con le cento libbre di mirra e aloe (Gv 19,39).
2