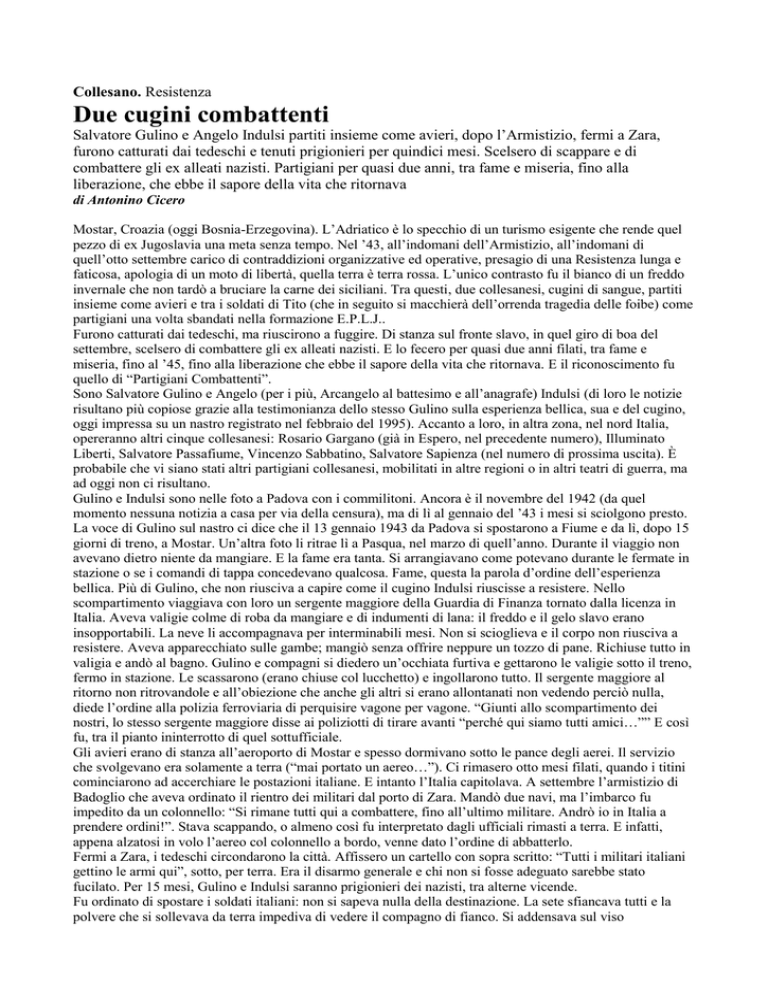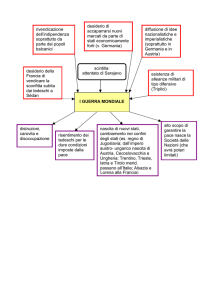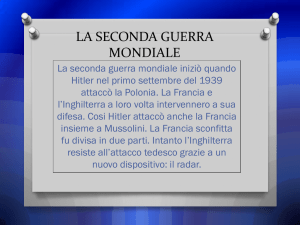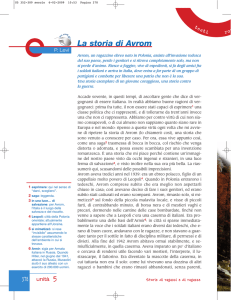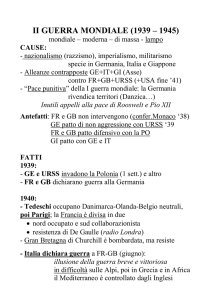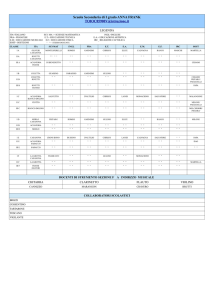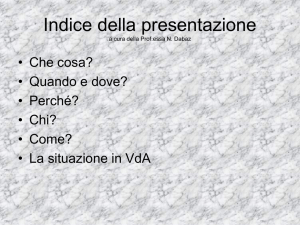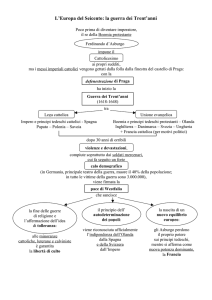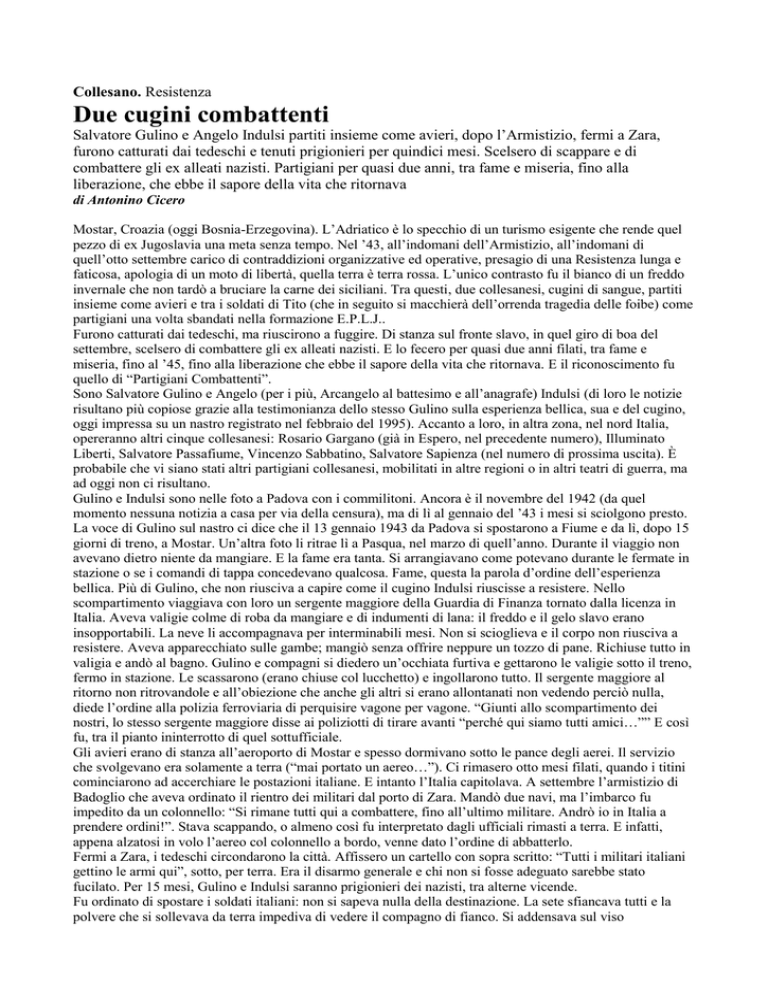
Collesano. Resistenza
Due cugini combattenti
Salvatore Gulino e Angelo Indulsi partiti insieme come avieri, dopo l’Armistizio, fermi a Zara,
furono catturati dai tedeschi e tenuti prigionieri per quindici mesi. Scelsero di scappare e di
combattere gli ex alleati nazisti. Partigiani per quasi due anni, tra fame e miseria, fino alla
liberazione, che ebbe il sapore della vita che ritornava
di Antonino Cicero
Mostar, Croazia (oggi Bosnia-Erzegovina). L’Adriatico è lo specchio di un turismo esigente che rende quel
pezzo di ex Jugoslavia una meta senza tempo. Nel ’43, all’indomani dell’Armistizio, all’indomani di
quell’otto settembre carico di contraddizioni organizzative ed operative, presagio di una Resistenza lunga e
faticosa, apologia di un moto di libertà, quella terra è terra rossa. L’unico contrasto fu il bianco di un freddo
invernale che non tardò a bruciare la carne dei siciliani. Tra questi, due collesanesi, cugini di sangue, partiti
insieme come avieri e tra i soldati di Tito (che in seguito si macchierà dell’orrenda tragedia delle foibe) come
partigiani una volta sbandati nella formazione E.P.L.J..
Furono catturati dai tedeschi, ma riuscirono a fuggire. Di stanza sul fronte slavo, in quel giro di boa del
settembre, scelsero di combattere gli ex alleati nazisti. E lo fecero per quasi due anni filati, tra fame e
miseria, fino al ’45, fino alla liberazione che ebbe il sapore della vita che ritornava. E il riconoscimento fu
quello di “Partigiani Combattenti”.
Sono Salvatore Gulino e Angelo (per i più, Arcangelo al battesimo e all’anagrafe) Indulsi (di loro le notizie
risultano più copiose grazie alla testimonianza dello stesso Gulino sulla esperienza bellica, sua e del cugino,
oggi impressa su un nastro registrato nel febbraio del 1995). Accanto a loro, in altra zona, nel nord Italia,
opereranno altri cinque collesanesi: Rosario Gargano (già in Espero, nel precedente numero), Illuminato
Liberti, Salvatore Passafiume, Vincenzo Sabbatino, Salvatore Sapienza (nel numero di prossima uscita). È
probabile che vi siano stati altri partigiani collesanesi, mobilitati in altre regioni o in altri teatri di guerra, ma
ad oggi non ci risultano.
Gulino e Indulsi sono nelle foto a Padova con i commilitoni. Ancora è il novembre del 1942 (da quel
momento nessuna notizia a casa per via della censura), ma di lì al gennaio del ’43 i mesi si sciolgono presto.
La voce di Gulino sul nastro ci dice che il 13 gennaio 1943 da Padova si spostarono a Fiume e da lì, dopo 15
giorni di treno, a Mostar. Un’altra foto li ritrae lì a Pasqua, nel marzo di quell’anno. Durante il viaggio non
avevano dietro niente da mangiare. E la fame era tanta. Si arrangiavano come potevano durante le fermate in
stazione o se i comandi di tappa concedevano qualcosa. Fame, questa la parola d’ordine dell’esperienza
bellica. Più di Gulino, che non riusciva a capire come il cugino Indulsi riuscisse a resistere. Nello
scompartimento viaggiava con loro un sergente maggiore della Guardia di Finanza tornato dalla licenza in
Italia. Aveva valigie colme di roba da mangiare e di indumenti di lana: il freddo e il gelo slavo erano
insopportabili. La neve li accompagnava per interminabili mesi. Non si scioglieva e il corpo non riusciva a
resistere. Aveva apparecchiato sulle gambe; mangiò senza offrire neppure un tozzo di pane. Richiuse tutto in
valigia e andò al bagno. Gulino e compagni si diedero un’occhiata furtiva e gettarono le valigie sotto il treno,
fermo in stazione. Le scassarono (erano chiuse col lucchetto) e ingollarono tutto. Il sergente maggiore al
ritorno non ritrovandole e all’obiezione che anche gli altri si erano allontanati non vedendo perciò nulla,
diede l’ordine alla polizia ferroviaria di perquisire vagone per vagone. “Giunti allo scompartimento dei
nostri, lo stesso sergente maggiore disse ai poliziotti di tirare avanti “perché qui siamo tutti amici…”” E così
fu, tra il pianto ininterrotto di quel sottufficiale.
Gli avieri erano di stanza all’aeroporto di Mostar e spesso dormivano sotto le pance degli aerei. Il servizio
che svolgevano era solamente a terra (“mai portato un aereo…”). Ci rimasero otto mesi filati, quando i titini
cominciarono ad accerchiare le postazioni italiane. E intanto l’Italia capitolava. A settembre l’armistizio di
Badoglio che aveva ordinato il rientro dei militari dal porto di Zara. Mandò due navi, ma l’imbarco fu
impedito da un colonnello: “Si rimane tutti qui a combattere, fino all’ultimo militare. Andrò io in Italia a
prendere ordini!”. Stava scappando, o almeno così fu interpretato dagli ufficiali rimasti a terra. E infatti,
appena alzatosi in volo l’aereo col colonnello a bordo, venne dato l’ordine di abbatterlo.
Fermi a Zara, i tedeschi circondarono la città. Affissero un cartello con sopra scritto: “Tutti i militari italiani
gettino le armi qui”, sotto, per terra. Era il disarmo generale e chi non si fosse adeguato sarebbe stato
fucilato. Per 15 mesi, Gulino e Indulsi saranno prigionieri dei nazisti, tra alterne vicende.
Fu ordinato di spostare i soldati italiani: non si sapeva nulla della destinazione. La sete sfiancava tutti e la
polvere che si sollevava da terra impediva di vedere il compagno di fianco. Si addensava sul viso
irriconoscibile e a passarvi un dito ne rimaneva impresso un solco profondo. Quella accozzaglia di cenci
militari vide un pozzo lungo il tragitto: tante piccole mosche si piombarono lì e molti provarono a calarsi giù
con la corda. I tedeschi li falciarono con i mitragliatori. Ne caddero dentro cadaveri, altri si accasciarono
esangui al suolo. “La sete” dice Gulino “ci passò”. D’un colpo. Ad ogni falciata, la paura in gola.
La destinazione fu Bihac. Depositati in uno spiazzale, cominciò la conta. Venti dovevano andare via col
tenente tedesco: destinazione ignota. Non si sapeva bene a chi la sorte arridesse: a quanti sarebbero rimasti o
a quanti sarebbero andati. Gulino è tra i venti, ma non il cugino. Chiede ad un compagno lì vicino se vuole
andare al posto di Indulsi. Così fu (quel tale aveva un suo di cugino fuori dalla rosa dei venti). Lo scambio
avvenne e fu la vita. Quanti rimasero, seppero poi, furono trasferiti parte in Germania e parte in Russia…
I venti furono destinati alla pulizia di una scuderia, tra la fame (solo poche patate bollite, a volte con qualche
rapa) e gli stenti. I prigionieri, tuttavia, avevano acquisito lo status di internato civile, diverso da quello di
IMI. Una condizione migliore che permetteva loro di rifiutare la collaborazione armata. Eppure i tedeschi
cominciarono a pressare perché combattessero al loro fianco. Il rifiuto fu risoluto: un sì avrebbe significato il
passaggio al fronte… Inizia lo sfiancamento degli italiani per far cambiare loro idea. Dopo il lavoro in
scuderia, venivano costretti a camminare in tondo per due ore sotto la neve con il freddo sferzante, limando
sempre più il cibo. Il no dei venti permase. Vennero allora chiusi in una camera, tutti insieme. Niente cibo e
niente gabinetto: i bisogni corporali li avrebbero fatti alla vista di tutti quanti. Rimasero attoniti, ma il no non
fu decisione mutata. Resistettero.
Le punizioni erano all’ordine del giorno, come quella inflitta a Gulino i cui cavalli, ad un controllo,
risultarono sporchi. Gli fu vietato di andare a mangiare, ma il bisogno della pancia non sentiva ragioni.
Rientrati i compagni, partì da solo, con un tedesco ad intimargli dietro di fermarsi. La pistola era spianata,
ma Gulino continuò la marcia. Lui avanti ed il tedesco dietro. L’intimazione fu perentoria e Gulino,
voltatosi, aprì la giacca e disse: “Spara allora!” riprendendo a camminare. Il tedesco riposizionò la pistola
nella fondina. Alla fine mangiò. “Credevo fosse giusto così” e non ebbe paura. Era la fame la loro bestia
nera. A volte scappavano attraverso buchi improvvisati nella scuderia. Il rischio era la fucilazione immediata,
ma i civili slavi delle vicinanze comprendevano e qualcosa riuscivano a mettere in pancia. Come quando la
donna anziana andò sul retro a prendere un po’ di farina mentre i pezzi di carne cuocevano in pentola e
Gulino se li ritrovò in tasca: affossò la mano e riempì, per sé e per Angelo rimasto in scuderia sotto il tiro dei
tedeschi. “Non sentivo l’acqua calda…”. La stessa che un commilitone, prima dell’Armistizio, volle farsi
buttare di sopra: la guerra è incubo e si sopportano pure ustioni gravi. Fu rimandato a casa.
Nel 1944 gli americani presero a bombardare Bihac con maggiore frequenza. Colpirono un deposito di
carburante, ma lasciarono intatte le chiese presenti. Dopo il primo passaggio, i civili a migliaia si
ammassarono in una di queste. La notizia trapelò e fu la seconda ricognizione. Brutta cosa, ricorda Gulino.
Cessato il bombardamento, fra le macerie della chiesa fu un groviglio di corpi sbranati. Ogni bomba era un
cratere.
I venti furono spostati nella zona di Zagabria. Salirono in montagna con l’ordine di scavare trincee. In otto
caricavano sulle spalle i tronchi abbattuti e su a scavare. Erano stati depositati in una piccola baracca, tra il
freddo pungente e la fame. Ancora quella. A Gulino venne chiesto chi conoscesse come calzolaio tra i suoi.
Lui non lo era mai stato, ma in quel momento la sopravvivenza lo fece ciabattino. E respirò per qualche
giorno in più. Erano sorvegliati lì da cinque tedeschi, che stanziavano a circa 200 metri dalla baracca italiana.
Questo permetteva uscite notturne, in cerca di cibo. Gulino e Indulsi si avventuravano. E in una di quelle
sere, bussarono e gli fu aperto. Gulino conosceva lo slavo (per questo, ad un certo punto, verrà separato dal
cugino perché richiesto come interprete presso un’altra formazione slava). Gli proposero di immergersi nelle
fila dei partigiani di Tito: loro due e tutti gli altri. Se avessero accettato, sarebbero dovuti ritornare la sera
dopo: li avrebbe attesi una donna. Così fu. L’accordo era semplice: la sera avanti, verso la mezzanotte e
mezza, alla baracca avrebbero bussato due partigiani e loro, gli italiani, avrebbero dovuto farsi trovare pronti.
L’indomani spuntarono i due, con mitragliatrice, cartucciera e bombe a mano. Due dei venti, due romani,
non riuscirono ad infilare gli scarponi per via dei piedi congelati. Piansero perché sarebbero rimasti lì da
soli… Alle cinque del mattino, seppero poi, i tedeschi in allarme presero a seguire le tracce lasciate sulla
neve. Il gruppo si smembrò, distanziati per dieci metri l’uno dall’altro. Furono ingoiati da un bosco dove si
erano inabissati e lì si ricongiunsero alle altre squadre partigiane. Erano un piccolo esercito di donne e
uomini “con accette, tridenti, fucili, mitraglie”. I tedeschi, intanto, si erano ritirati.
Camminarono tutto il giorno e pernottarono lungo la strada. A Gulino toccò la casa di due anziani coniugi.
Gentili, gli diedero da mangiare e un posto sul pavimento per dormire (non avevano un altro letto). Gli
diedero due lenzuola (uno sotto ed uno sopra) e due coperte. Che gli portarono prurito. Erano i pidocchi (gli
stessi che, durante la prigionia tedesca, immergevano in acqua bollente: la biancheria intima però l’indomani
tornava tale e quale). Accesa la candela, le lenzuola da bianche erano diventate tutte nere… L’ordine,
intanto, fu di riprendere la marcia e via con i pidocchi addosso. Camminarono per un giorno intero alla volta
delle linee tedesche. Il cuore era stretto in gola, ma erano volontari e avevano deciso di combattere l’esercito
di Hitler.
Circondati dai tedeschi, l’ordine fu di disperdersi. La squadra dei collesanesi si ridusse a 13 unità e ancora su
per le montagne, fino al paese in lontananza pieno zeppo di partigiani: 12.000 tra donne e uomini. E
l’indomani di nuovo in marcia contro le linee tedesche. L’obiettivo: postazione di 800 nazisti e 2.000 fascisti
slavi. Che si squagliarono al primo attacco. Sul campo rimasero solo gli 800, di cui 690 uccisi e 110 fatti
prigionieri dopo 3 giorni di assedio al fortino e alla fine incolonnati e legati ai polsi col fil di ferro dietro la
schiena. Furono schiaffeggiati e portati dentro ad un recinto. “Da fuori sputavamo e lanciavamo sassi”
continua Gulino. E furono denudati. “Anche noi, in 3 giorni di scontri, abbiamo avuto dei feriti” e ai 110
tedeschi, 4 per ogni barella, fu ordinato di portare i feriti a spalla, tra le montagne. “Io dovevo sorvegliare
quattro tedeschi. Di tanto in tanto gli davo calci per non farli fermare e per evitare” che facessero cadere il
ferito. “E loro piangevano ed io: “Non piangete! Ricambio solo quello che avete fatto a me””. Ad un certo
punto sostarono e il ferito fu messo per terra. “Io inizio a mangiare quel po’ che avevo e i quattro mi
indicavano la spalla: non avevano più né camicia, né maglia, né maglione. E neanche più pelle. Si vedevano
le ossa di fuori”. E piangevano, mentre Gulino gli intimava di fare silenzio. “Mi chiedevano qualcosa da
mangiare e in risposta tirai un colpo di moschetto. Ero stato loro prigioniero…”. La vendetta dei poveri
cristi. E ricorda un episodio d’effetto: “Quando ero prigioniero dei tedeschi e la fame era insopportabile,
stavano a mangiare tutti in un piazzale. Mangiavano da signori e a noi nulla. Mi faccio coraggio, lascio mio
cugino Angelo e mi presento ad un gruppo di loro. Io ero sempre affamato mentre mio cugino, non so come
facesse, riusciva a resistere di più. Vado da questi tedeschi e chiedo un pezzettino di pane. Uno di loro
prende il pane di un chilo, nero come un tizzone e lo butta nel fiume lì vicino: “Nel fiume sì, ma non
all’italiano! Via da qui!” e scappai”…
E racconta pure un altro episodio che rende la guerra incolore, insapore, bestia armata di brutalità. “I
partigiani slavi ci diedero l’ordine di rompere il fronte davanti e bloccare un treno tedesco con migliaia fra
donne, uomini e bambini” che tentavano la fuga in madrepatria. “Era una questione d’onore: i partigiani
sapevano lottare”. Il gruppo si avvicinò alla ferrovia e si intimò l’alt al treno. “Il treno fischiava e voleva
andare avanti… Spianammo le mitraglie e l’ordine fu di sistemare e dividere uomini con uomini, donne con
donne e bambini con bambini. Li hanno divisi tutti. I vestiti buoni erano presi. I tedeschi spogliati e i vestiti li
prendevamo noi. I tedeschi gridavano” e furono inghiottiti dai partigiani. “Li trattammo come trattarono loro
a noi. Gridavano: “Marito mio, figlio mio!” in tedesco e in slavo. “Adesso non ci vedremo più!”… A
commento Gulino sottolinea il dispiacere nel dire questo. E aggiunge: “Ma come si faceva diversamente?”
Sospira. Non c’era niente da fare. Aggiunge: “Mi dovete perdonare se parlo così, ma ho fatto quello che
avevano fatto a me. Non gli avevamo fatto niente a loro: perché [i tedeschi] ci dovevano trattare così?”.
Si riprese la marcia e i tedeschi, intanto, cadevano a terra e sopra il tenente partigiano a freddarli con un
colpo di pistola. “I feriti li caricavamo noi perché mancavano gli uomini…”. Continua così la storia per altri
mesi, fino all’agosto del 1945.
Da Zagabria a Belgrado e da lì rimpatrio in Italia. Il rientro è per il 12 (ricorda così il partigiano, sebbene
dalla copia rilasciata dalla Commissione Riconoscimento Qualifica Partigiani il rimpatrio sia datato al 5
agosto). Direzione Spalato e, via mare, approdo a Bari. Il primo tratto in treno (15 giorni pieni) per chi non
avesse più scarpe (fu così per Indulsi); a piedi per gli altri (così per Gulino che, rotte le scarpe, riuscì a salirci
sul vagone). A piedi sarebbe stato un tiro al piattello: per la strada ancora i cecchini nemici. Alle stazioni si
cercava da mangiare, ma niente. Con un bolognese, Gulino stavolta si diresse in un’abitazione un po’ lontana
dalla ferrovia. Ad aprire una donna, che li fa entrare e sedere. Non mancava niente (stava bene). Un boccone
e l’orecchio teso al fischio del treno. I due erano scalzi, senza più scarpe. “Al fischio, di scatto, la donna ci
riempì le tasche e cominciammo a correre dietro il treno. I piedi erano scalzi, senza neppure calzette e
affossavano nel terriccio”. Erano sassi puntuti e saltellando con le dita, a volte col tacco, “correvo verso il
treno senza fermarmi, neppure per lamentarmi”. Il bolognese, invece, rallentò e si fermò toccandosi i piedi
sanguinanti. Perse il treno “e non lo vidi più”.
Lungo la strada ferrata, alle stazioni, ci stavano i tedeschi prigionieri che lavoravano ai binari per
ripristinarli. Erano a pezzi, grovigli di lordura: barba, capelli lunghi, sporchi ancora. Come lo erano stati gli
italiani… Gioco di specchi, perché la guerra cambia i nomi, ma la sostanza è la stessa.
Finalmente il rientro. “Partimmo da Spalato alle 5. Sulla nave un capitano disse che quello era l’ultimo
viaggio per tentare di andare in Italia” ricorda ancora Gulino. “Dobbiamo attraversare tutta la notte
l’Adriatico che è tutto minato e pieno di sottomarini” diceva il capitano. Pianse disperato e noi con lui. La
nave era strapiena”. L’ordine era di costeggiare: in caso di affondamento forse ci sarebbe stata la possibilità
di approdare con più facilità. Imbottiti del salvagente alla fine giunsero a Bari e lì tutti giù dalla nave, prima
ancora che la nave attraccasse: “Chi saltava di qua, chi saltava di là”.
“Dopo 46 mesi di guerra siamo arrivati in Italia”. Quasi 4 anni filati. Da Bari a Terlizzi, in attesa di rientrare
a casa. “Ci diedero la libera uscita e la liquidazione: 11 mila lire per tutto il periodo di guerra”. Giunti a
Messina “lì eravamo ancora scalzi e allora abbiamo comprato un paio di scarpe io ed Angelo… 3.500 lire a
testa… Poi dritti fino a Campofelice di Roccella e poi a Collesano a piedi. Era notte. Alla mattina, all’alba,
arriviamo a Collesano, a S. Maria di Gesù per correre in contrada Mondoletto. Eravamo a casa”. I due cugini
partigiani saranno richiamati a Palermo nell’ottobre del 1945. Di nuovo a Bari, per smettere la divisa,
definitivamente, il 6 marzo 1946 (il foglio di congedo illimitato di Indulsi, invece, segna l’8 giugno).
Queste le storie brevi di due combattenti. Di più: di due partigiani collesanesi.
Antonino Cicero
(Il racconto degli altri partigiani collesanesi continuerà nella terza parte che sarà pubblicata nel successivo
numero della rivista. Lì si parlerà anche del gruppo di partigiani originari degli altri comuni madoniti)
Il presente articolo è stato pubblicato su:
Espero – Rivista del Comprensorio Termini – Cefalù – Madonie
Anno VI, n. 68-70, Novembre-Dicembre 2012 - Gennaio 2013, p. 5