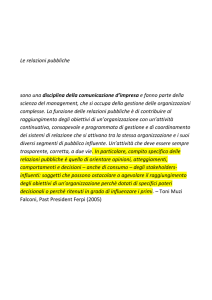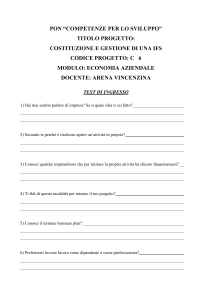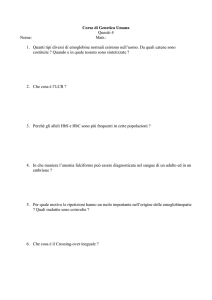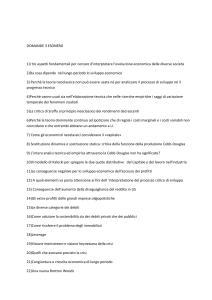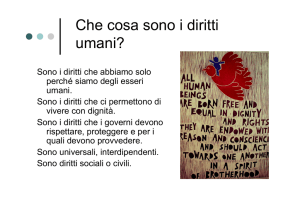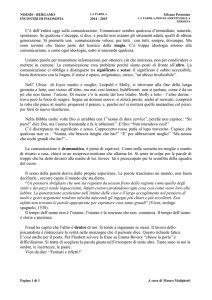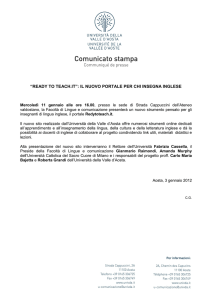1014
I FIUMI, I VIAGGI
E TUTTI GLI UOMINI DI RE ARDUINO
LA BIBLIOTECA DI ESTEBAN ESORDISCE
CON UN CONTRIBUTO
DI GUIDO GIACOMONE,
CURATORE DELLA RUBRICA TERRITORIO
MAPPE ED ILLUSTRAZIONI
SONO STATE ELABORATE
DA BOILER DUE, DA SEMPRE
COLLABORATORI DELLA RIVISTA
I FIUMI
Tre sono i modi che conosco, differenti, di raccontare le vicende dei fiumi.
Il fiume scava, deposita, si espande, il fiume arretra, straripa, s'impaluda,
il fiume si sposta in continuazione, il fiume è soggetto.
Il fiume si è spostato.
Mai che abbia una collocazione precisa, i suoi vecchi alvei sono occupati da
altri fiumi,
tutto è valle, tutto è golena.
Che sarà mai il fiume?
Nient’altro che la risultante dei suoi affluenti.
Che a loro volta null'altro sono che le risultanti ciascuno dei propri affluenti,
e così via a ritroso, sino al più insignificante rigagnolo, sino al rivolo più
minuto,
sino alla goccia che scivola lungo il sasso sfuggendo al fiato rovente del sole:
il fiume non esiste.
I VIAGGI
Partimmo per Amsterdam, e vi giuro che il nostro unico intento era quello di
trascorrere una settimana fumando dalla mattina sino a notte inoltrata tutto
quello che fosse umanamente possibile fumare. Poi, però, visitando il Museo
Reale mi capitò di notare che un posto d’onore era riservato ad una tela del
Seicento che raffigurava un palmipede incavolato, e per la prima volta – forse
- nella mia vita mi resi conto che a questo mondo c’è una quantità
inimmaginabile di cose da capire. Eravamo in ottobre, faceva buio presto e
il tempo era quello che era. Avete presente i marciapiedi di Amsterdam ?
Sono fatti di mattoni; a destra e a sinistra ci sono due gobbette e in mezzo c’è
come una cunetta, e questa cunetta ti sembra che sia lunga milioni di
chilometri, ce l’hai sempre davanti agli occhi dappertutto dove vai. E infatti
noi camminavamo e camminavamo, veniva buio e noi camminavamo, e ci
lavava la faccia un qualcosa di umido e gelido che sembrava pioggia ma mica
lo era; la pioggia viene giù dall’alto e quella roba invece galleggiava a
mezz’aria, e arrivava ad ondate a schiaffeggiarci, ed è stato lì che ho capito
che un punto preciso dove la terra finisce e comincia il mare, e dove finisce il
mare e comincia l’atmosfera, quel punto lì, insomma, proprio non esiste.
Dopodichè ce ne andammo a Siena; la piazza tanto celebre che chiamano il
Campo, dove un paio di volte all’anno corrono i cavalli montati a pelo, è tutta
in discesa e di forma somiglia ad un lavabo, e questo lo si sa in tutto il
mondo, poiché da tutto il mondo vengono a frotte a veder la piazza. Noi, per
fortuna nostra, ci capitammo nella brutta stagione e di turisti, se ce n’erano,
non se ne vedevano. La mattina c’era un po’ di nebbia ma si dissolveva al
primo chiacchierio che si udiva nelle strade. Dalla piazza una via sale in
direzione del punto più alto della città; in prossimità della cima si incontra il
Battistero, che è una chiesa a tre navate, e quindi piuttosto grossa, incassata
come una lavastoviglie sotto un’ala del Duomo, il quale sorge sulla spianata
in cima alla collina, una dozzina di metri più su. Il Duomo è incompiuto; si
sono fatte una navata laterale e la facciata, ma c’è solo la muratura, senza
rifiniture. Di completo, per il momento, c’è soltanto il transetto, che visto in
pianta sarebbe il braccio più corto della croce. In effetti il transetto è già di
suo una chiesa fatta e finita, e per giunta enorme, e la si usa come Cattedrale
fintantochè non sia terminata la costruzione del Duomo. Quando questo
potrà avvenire, però, non si sa, dato che i lavori sono interrotti da qualche
secolo e non pare che al momento ci sia l’intenzione di riprenderli.
TUTTI GLI UOMINI DI RE ARDUINO
Nel mese di gennaio dell’anno 1002, mentre fugge da Roma che gli si è
rivoltata contro, muore - forse di veleno - l’Imperatore di Germania Ottone, il
terzo a portare questo nome. Il sovrano defunto non ha che ventidue anni, di
cui diciannove trascorsi con la corona imperiale sul capo e non lascia eredi.
Dimenticavo di dire, ma immagino che lo si sarà già capito, che l’Imperatore
di Germania lo è anche dell’Italia, e se viene a mancare l’Imperatore di
Germania anche l’Italia si ritrova senza un sovrano. Trascorso a malapena
un mese (un tempo da record per i ritmi forzatamente lenti dell’alto
medioevo, e particolarmente nel cuore dell’inverno) il Marchese di Ivrea, di
nome Arduino, si fa incoronare Re d’Italia nella basilica di San Michele in
Pavia, vale a dire proprio nella cappella del palazzo italiano degli Imperatori
di Germania. Arduino ha il consenso dei grandi Signori d’Italia e l’appoggio
dei piccoli; tutti si augurano che il suo colpo di mano serva a ridimensionare
il potere dei Vescovi, che erano particolarmente legati alla casata imperiale
degli Ottoni appena estintasi, e che si ritrovano momentaneamente senza un
protettore. In altre parole, Arduino è stato mandato avanti a fare il lavoro
sporco, e questo ruolo se lo è guadagnato qualche anno prima attaccando,
sconfiggendo e bruciando vivo dentro la sua chiesa il Vescovo di Vercelli.
Per fare questo, Arduino si era dovuto comprare la complicità dei piccoli e
piccolissimi Signori sottoposti al Vescovo, ma non ci aveva rimesso del suo
giacchè si era limitato a farli padroni di quegli stessi beni vescovili dei cui
frutti sino ad allora, in quanto vassalli della Chiesa, essi avevano goduto solo
in minima parte : tutta la torta, insomma, e non più soltanto le briciole. Il
seguito della vicenda di Arduino ci interessa relativamente poco : il nuovo
Imperatore Arrigo II (detto il Santo dagli amici e lo Zoppo dai nemici) non
riconoscerà l’incoronazione di Arduino e lo combatterà come usurpatore;
dopo alcuni insuccessi iniziali lo batterà ripetute volte ma il declino del
Marchese di Ivrea sarà lentissimo e la sua sconfitta non sarà mai definitiva.
Nel 1014, malato, Arduino getta la spugna, si ritira in convento e poco dopo
muore. In quello stesso anno 1014 – ed è questo, finalmente, il punto a cui
volevo arrivare - l’Imperatore Arrigo si premura di sancire il ritorno all’ordine
restituendo in forma ufficiale ai Vescovi del Piemonte settentrionale quei beni
che erano stati loro sottratti da Arduino per elargirli ai suoi sostenitori.
I FIUMI
I VIAGGI
TUTTI GLI UOMINI DI RE ARDUINO
IL MONDO ERA TUTTA CAMPAGNA
SICURAMENTE QUALCUNO SI ERA SEGNATO TUTTO
TERREMOTUS MAGNUS FACTUS EST
UNA PORTA, UNA VIA, UN CASTELLO
NEGUCIANS ED ASINARIUS
LA RAGNATELA
I
II
I FIUMI
I _ NOSTRA SIGNORA DELLA PALUDE
II _ SOTTO LA PIANURA
III _ DEMONI DELL’ACQUA
IV _ IL CONO D’OMBRA
I VIAGGI
I _ LA CAPPELLA DEL SACRO PALAZZO
II _ L'ISOLA DI FRANCIONE
III _ L’ABBAZIA
IV _ A CASA DI SANT’ALESSIO
IL PIANO REGOLATORE
I _ CASE FATTE DI NIENTE
II _ MERLI, TORRI, TORRETTE E BANDIERINE
I _IL PIANO REGOLATORE
II _ NOTA AL CAPITOLO PRECEDENTE
III _ VENIR VIA DAL CONDOMINIO
DOVEROSE PRECISAZIONI
In un paese antico come il nostro non c’è località, per insignificante che possa apparire a prima vista,
che poi non si scopra essere carica, stracarica e incrostata di Storia. La Geografia è la traduzione della
Storia in territorio. Ma non è detto che la traduzione sia sempre comprensibile. Talora si direbbe che
il territorio e i libri di Storia non raccontino la stessa storia. Questo libro è una raccolta di vite
immaginarie di luoghi reali. Di quel che contiene, tutto ciò che ricade sotto il dominio della Geografia
è vero e facilmente accertabile; quello che è Storia me lo sono inventato ma è verosimile. Potrebbe
persino essere vero.
IL MONDO ERA TUTTA CAMPAGNA
Nel 1014 l’Imperatore Arrigo II restituiva alla Chiesa di Vercelli - città del Piemonte posta a nord del Po
- beni e benefici che le erano stati sottratti, armi alla mano, da Arduino marchese di Ivrea. L’autorità
non solo religiosa ma anche temporale del Vescovo di Vercelli si estendeva su di una vasta porzione del
Piemonte centrale e settentrionale, compresa parte delle colline del Basso Monferrato situate a sud del
Po e parte della Lomellina, che è il pezzo di Bassa Padana compreso tra i fiumi Sesia e Ticino. Nelle
restituzioni del 1014 vengono menzionate per la prima volta numerose località tuttora esistenti che
fanno in questo modo il loro debutto sul palcoscenico della storia.
Queste carte elencano
esplicitamente i fedeli di Arduino, e non si tratta di pure e semplici liste di nomi senza volto : nel
documento in cui è citata per la prima volta Mortara, ad esempio, sono segnalati tra gli altri un Curtius
ed un Gualone, e Curti e Gualla sono cognomi tuttora diffusi in quella zona. Oggi Mortara è la
maggiore città della Lomellina settentrionale ma nel 1014 era solamente un un locus, vale a dire un
qualunque pezzetto di campagna. Non era una città ma non era neppure ancora un paese come lo
intendiamo noi, con le sue vie e la piazza su cui si affaccia la chiesa. I Curti, i Gualla e i loro sodali
vivevano quasi sicuramente all’interno di un castello, che era sostanzialmente una grossa azienda
agricola munita di opere difensive : di certo c'era un fossato e forse anche una palizzata (di muri per il
momento non se ne parlava proprio). Ma cosa rappresentavano questi uomini di Arduino? Erano
uomini liberi, erano possidenti, ed erano armati, tre condizioni che erano strettamente legate. Come
uomini liberi avevano il pieno diritto di possedere beni e di portare armi; come armati avevano la
responsabilità di tutelare il territorio in cui vivevano, in nome e per conto del Signore del luogo, che da
qualche decennio era il Vescovo di Vercelli (in nome e per conto dell'Imperatore). Come ricompensa
per tale servizio veniva loro concesso l'usufrutto di una quota delle terre che la Chiesa di Vercelli
possedeva sul posto. Era pochino; prima che gli Imperatori di Germania riprendessero in mano la
situazione mobilitando i Vescovi, il potere centrale (quando esisteva) aveva ben scarse capacità di
controllo, ed è molto probabile che i liberi uomini di Mortara - come quelli di qualunque altro luogo,
del resto - avessero fatto per lungo tempo i loro porci comodi come se fossero loro i padroni di tutto e al
di sopra di loro non ci fosse nessuno. L'appello alla rivolta di Arduino era suonato alle loro orecchie
come l'annuncio che la pacchia era tornata. Gli uomini di Arduino provenivano dagli strati più infimi
dell'aristocrazia militare, comandavano su dei buchi dimenticati da Dio ma erano tutti di stirpe
guerriera. Di questa avevano ereditato la prepotenza e la rapacità, che si erano mescolate con la
cupidigia e la spilorceria dei contadini. L’impresa di Arduino pose per un attimo questi figuri sotto i
riflettori della Storia, giusto il tempo per una foto segnaletica, poi la sconfitta del loro leader li ricacciò
nel buio, disperdendo sul nascere quella che poteva diventare una classe dirigente radicata nel
territorio. La Lomellina fu condannata ad una marginalità sempre crescente e la regione mantenne
sino a tempi recentissimi un carattere profondamente rurale. Attenzione a questo aggettivo, perchè
dobbiamo intenderci sulla sua effettiva portata. Quando parliamo di mondo rurale pensando ai secoli
più vicini a noi non possiamo prescindere dal contraltare urbano : c’era la campagna e c’era la città, ma
il rapporto non era alla pari, perchè la campagna era subalterna sotto tutti i punti di vista alla città. Dire
che la Lomellina era rimasta profondamente rurale è lo stesso come dire che politicamente non ha mai
più contato nulla; tutte le decisioni venivano prese altrove. Facciamo un bel po' di passi indietro :
anche ai tempi dell’Impero Romano la campagna era sottomessa alla città, e in forma più drastica
ancora, perchè tutte quelle magnificenze che allietavano la vita in città si fondavano sul lavoro delle
moltitudini di schiavi nelle campagne. L’Impero di Roma era sostanzialmente una federazione di città
tutelata da un’efficacissima macchina militare, ma gran parte di quelle città erano state fondate dagli
stessi Romani in terre ancora ferme alla preistoria, dove il massimo dell’urbanizzazione era
rappresentato dalle fortezze fondate dai capi militari più potenti, più antiquate della Troia dei poemi di
Omero. Quando la macchina militare non fu più così efficace, avvenne qualcosa di più radicale di un
semplice ribaltamento delle parti : si dissolse addirittura il dualismo tra città e campagna. Nel mezzo
millennio che è intercorso tra il declino di Roma e la velleitaria campagna di Arduino contro i Vescovi il
mondo è stato rurale, punto è basta. L’Europa occidentale dell’alto medioevo era un pianeta sul quale
si faceva tranquillamente a meno delle città; le città erano un di più, il mondo era tutta campagna. La
quasi totalità della popolazione che lavorava era impegnata nei campi, ed anche di quei pochi che non
erano contadini a tempo pieno la maggior parte operava al diretto servizio dell'attività agricola. L'aria
era frizzante, le foreste sconfinate; di notte il mondo dormiva profondamente e il rumore del vento che
scompigliava le chiome degli alberi assomigliava all'incessante brontolìo del mare. La gente viveva
nelle campagne : una casa qua, una capanna là, una chiesa, una torre, campi, prati e poi ancora foresta.
Le sedi del potere erano le residenze signorili seminascoste tra i boschi o arroccate sulle alture, i
patrimoni più ingenti appartenevano alle abbazie che sorgevano nel cuore delle campagne più fertili, i
mercati e le fiere si tenevano dove incrociavano le strade più battute. Lungo le strade che portavano
più lontano, quelle percorse dagli eserciti e dai pellegrini, ogni venti o trenta miglia (ma sovente erano
molte di più) si potevano incontrare modesti gruppetti di case appoggiate ad avanzi di antiche
fortificazioni e strette attorno ad una chiesa. Era quanto rimaneva di città fondate secoli prima dai
Romani e sopravvissute in qualche maniera ai disastri dell'età barbarica. Esteriormente le si poteva
scambiare per abbazie o castelli di media grandezza; in fondo si trattava sempre di qualche casa coi
rustici annessi, una chiesa, un minimo di opere difensive e basta. Erano degli insediamenti agricoli; le
città erano rimaste tali solo di nome, e solo per il motivo che ci risiedevano i Vescovi. In realtà erano quasi tutte - poco più che paesucoli, e in ognuno di questi paesucoli il padrone di quasi tutto era la
Chiesa, forma allegorica per dire che era tutto dei preti e del Vescovo. Capitava, occasionalmente, che
qualche Vescovo sapesse anche essere un'autorità morale per il clero ed i fedeli disseminati nelle
campagne ma sostanzialmente un Vescovo era un grosso proprietario terriero, più ricco di tanti privati
ma più povero di tanti conventi. Questo era stato il Medioevo profondo, ma quando Arduino aveva
scatenato la sua ferocia contro i Vescovi quel mondo era già alla fine : la vittoria dei Vescovi era
inevitabile ed avrebbe spalancato le porte ad una nuova – e questa volta definitiva – affermazione delle
città sulla campagna. Negli ultimi cent'anni le città erano cambiate parecchio, anche perchè erano
cambiati i loro Vescovi. La Chiesa si era imposta una scrollata moralizzatrice ed erano arrivati Vescovi
capaci di dare una formazione spirituale ma anche civile alle loro comunità. Avevano cominciato col
rimettere in circolo le ricchezze che i loro predecessori avevano accumulato sotto forma di terra;
costruendo e restaurando edifici sacri avevano creato occupazione, e le città avevano ricominciato a
crescere. Poi si erano impegnati nelle opere pubbliche : il grande business del X secolo erano state le
fortificazioni urbane, allestite o ripristinate in tutta fretta sull'onda emotiva suscitata dall'irruzione nella
Val Padana di orde di Ungari razziatori. E infine i Sovrani della dinastia degli Ottoni avevano
promosso i Vescovi a funzionari imperiali investendoli dell'autorità civile prima sulle città e poi sulle
campagne che le circondavano. Sotto la guida di pastori così determinati le cittadinanze si erano
arricchite ed erano maturate politicamente. Presto avrebbero deciso per se stesse, avrebbero innalzato
splendide cattedrali ma soprattutto si sarebbero fatte militarmente temibili.
E notevolmente
aggressive. Cosa siano state le città del basso medioevo ce lo abbiamo ancora sotto agli occhi, cosa
fossero le città dei Romani lo abbiamo piuttosto chiaro; che aspetto avessero le città tra la fine di Roma
imperiale e l’età di Arduino non lo sappiamo proprio. In quei cinquecento anni le città non sono più
state città, perlomeno non sono state più quel che erano prima, nè quel che sarebbero state in seguito,
ma cosa fossero esattamente non è ben chiaro. Di quei secoli non è rimasto un solo edificio profano, i
documenti scritti sono rari, le cronache sono avare di dettagli, le raffigurazioni pittoriche non avevano
alcuna pretesa di essere realistiche. In compenso, questo mezzo millennio invisibile ha lasciato
abbondanti tracce di sè sul suolo, nella topografia. Ma sono tracce antiche, calpestate e ricalpestate
infinite volte, sciupate dagli elementi. Raggiunti strati così bassi, la lettura delle mappe comincia ad
assomigliare all’evocazione degli spiriti.
SICURAMENTE QUALCUNO SI ERA SEGNATO TUTTO
Se c’è una città che per tutti gli Italiani rappresenta lo stereotipo della vita cittadina, esasperato sino alla
caricatura, questa è Milano, che non da oggi è la maggiore città della Val Padana. Milano era già
grande ai tempi dell’Impero di Roma, di cui fu, per più di un secolo, la capitale. Nel 539 Milano venne
rasa al suolo dagli Ostrogoti, e perchè rinascesse ci volle un bel po’, probabilmente un paio di secoli, o
comunque un lasso di tempo sufficiente a che sulla superficie un tempo urbanizzata venissero tracciate
serpeggianti strade di campagna. Di questi fatti i cronisti antichi non ci hanno detto molto : Procopio
di Cesarea, che visse in prima persona buona parte della guerra combattuta tra l'Impero Romano di
Bisanzio e gli Ostrogoti, riferisce che le mura della città furono abbattute e che nel disastro perirono
trecentomila persone. Gli studiosi moderni reputano che la cifra sia eccessiva ma è comunque lecito
pensare che sul posto e sul momento di Milanesi vivi ce ne fossero rimasti ben pochi Come sia morta
Milano lo sappiamo per certo; su come sia poi risuscitata non abbiamo informazioni altrettanto
esplicite, però non è difficile leggere i segni di questa vicenda nella topografia della città. Il nuovo
abitato si formò alla convergenza di alcune strade che immagino fossero piuttosto battute; era un
esiguo recinto che copriva una porzione minima dello spazio che aveva occupato la capitale imperiale.
Che la fine di quest'ultima fosse stato un evento di intensità apocalittica lo conferma il fatto che
l'impianto urbanistico del nuovo borgo non aveva il benchè minimo legame con quello della città
romana, il che è come dire che s'era fatta tabula rasa. Erano rimasti in piedi soltanto gli edifici più
monumentali e di conseguenza più resistenti, come il Palazzo Imperiale e, accanto a questo, il Circo,
che era stato il più grande dell’Impero. Nonostante che della città restasse poco o nulla, le cronache ci
dicono che trent'anni più tardi Milano aveva un Arcivescovo e una Chiesa, cioè un Clero. La cosa non
deve stupire. Prima della distruzione della città i gruppi sociali preminenti in Milano erano tre : i
grandi proprietari terrieri, i militari ed i funzionari, ed infine il Clero. I primi venivano a Milano per far
vita di società ma avevano ville e tenute sparse per ogni dove, i secondi erano per così dire di passaggio,
e solo il Clero aveva piantato solide radici nell'agglomerato urbano, dove era padrone di ingenti
patrimoni immobiliari. Nel momento della catastrofe i proprietari terrieri erano scappati in campagna,
i militari e i funzionari si erano riposizionati altrove, ma il Clero non aveva mollato la presa e appena
possibile era tornato a prendersi cura dei suoi beni. Nel 569, però, alla notizia che i Longobardi
invasori si stavano avvicinando, Arcivescovo e Clero avevano fatto armi e bagagli ed erano fuggiti a
Genova, dove non erano certo andati a stare presso amici o parenti ma disponevano in quanto cosa loro
di una chiesa intitolata a Sant’Ambrogio, che sarebbe stata sede della Cattedra Arcivescovile di Milano
sino al 642. Il che, per contorto che possa sembrare, è un po’ come dire che per settant’anni non solo la
Chiesa di Milano si era ritrovata altrove, ma con essa la città stessa di Milano. Ne era senz’altro
convinto il clero milanese che poteva paragonare se stesso ad Israele, rimasto Israele anche in Egitto o
a Babilonia, però la cosa ha un senso anche per noi, giacchè quando finalmente quel Clero milanese,
ormai totalmente rinnovato nei suoi ranghi, fece ritorno con tutti gli onori in patria, Milano in quanto
città non aveva ancora ricominciato ad esistere. I Signori della Guerra longobardi - il Re e i Duchi - si
erano infatti limitati ad impadronirsi di quel che era rimasto del quartiere monumentale per farne una
vasta reggia, sicuramente di aspetto un po’ rustico (il giovane Principe Cuniperto si divertiva a sollevare
a braccio teso i montoni che vi circolavano) ma non per questo meno prestigiosa, giacchè ospitò più
volte grandi eventi che coinvolgevano l’intera nazione longobarda. Per un periodo senz'altro lungo
anche se difficile da quantificare Milano non fu una città ma soltanto il Palazzo di Campagna del Re dei
Longobardi, alternativo al Palazzo Reale di Pavia, così come la futura città di Monza era il Palazzo di
Campagna della Regina.
I Longobardi erano totalmente estranei alla dimensione urbana : poveri, arretrati e a quanto pare anche
piuttosto scarsi come combattenti, quando erano arrivati in Italia dopo esser stati presi a calci da mezza
Europa avevano trovato un paese a pezzi, stremato dalla lunga e sanguinosa guerra combattuta tra i
Greci e gli Ostrogoti, ma per loro era stato come raggiungere l’Eldorado. Se i loro condottieri – i Duchi
– erano attirati dalle città (o da quel che ne rimaneva) era perché in esse, anche quando erano ridotte a
mucchi di macerie, vedevano sostanzialmente delle fortezze; è probabile che neppure si rendessero
esattamente conto di cosa potesse rappresentare una città al di là delle sue potenzialità militari. Va
detto, però, che se per gli occupanti la città era una cosa mai vista e mai conosciuta, anche per gli
occupati la dimensione urbana stava diventando un ricordo sempre più vago : al pari di Milano,
numerose città della Val Padana occidentale erano state ridotte ai minimi termini ed avevano rischiato
di scomparire. Nella topografia di Ivrea, di Vercelli, di Acqui e di Tortona, per esempio, le tracce
dell’impianto originario di età romana sono limitatissime e molto frammentarie; della città di Pollenzo
rimasero soltanto le fondamenta dell’anfiteatro, sulle quali furono edificate le casette dell’attuale
villaggio che si presenta come una vasta aia ellittica attorniata dalle facciate di modeste dimore
contadine. Pollenzo si trova nella media valle del fiume Tanaro, nel Piemonte meridionale che tra il V
e il VI secolo era stato teatro di eventi bellici molto travagliati. Non lontano da Pollenzo sorgeva e
sorge tuttora la città di Asti, che nel 402 aveva offerto riparo tra solide mura all’Imperatore Onorio,
impegnato contro i Visigoti. Sappiamo che nel 451 il Vescovo di Asti si chiamava Pastore e che nel 465
era Vescovo Maiorano; dopo d'allora non si hanno più notizie di Vescovi per ben quattro secoli, e la
città sparisce dalle cronache e dai documenti per quasi altrettanto tempo; questo potrebbe voler dire
che sul finire del V secolo Asti era tracollata, probabilmente in seguito al disastroso passaggio di bande
di Burgundi. Sta di fatto che se la città romana occupava una superficie sicuramente non minore di
ventotto ettari e non superiore a trentacinque (sono dimensioni standard, l'urbanistica romana era
modulare), ad un certo punto l'abitato si era ritrovato a non superare i sei o sette ettari, praticamente le
dimensioni di un paesetto di campagna dei nostri giorni. Sappiamo che ad Asti aveva la sua corte un
Duca longobardo coi suoi uomini, ma si erano sistemati in un gruppo di ruderi facili a difendersi un po'
distanziato dal paesetto di cui sopra. Ho due buoni motivi per raccontarvi le vicende di Asti come
esempio di quelle che sono state le peripezie della Forma Urbana. Il primo è che ad Asti ci ho vissuto
a lungo quand'ero ragazzo e conosco la città di persona. Conosco bene anche il Monferrato (ma solo
quello Basso) per esser nato in una casa posta ai piedi della chiesa dove è sepolto il primo Marchese di
Monferrato.
Conosco abbastanza bene anche la Lomellina (ma solo quella Alta) perchè ci sto
trascorrendo la mia vecchiaia e dalla finestra di casa vedo l'ultimo pezzetto che è rimasto dei vecchi
prati di Mortara.
Il secondo motivo è che la storia di Asti funziona molto bene come caso
rappresentativo perchè è assolutamente e persino esageratamente nella media, tutta secondo copione.
I documenti più antichi che si son conservati risalgono alla fine dell'VIII secolo e fanno intravedere un
mondo di floridi proprietari terrieri - principalmente religiosi e aristocratici - che davano da lavorare a
intermediari e trasportatori. E che non dovessero passarsela male neppure questi lo dimostra il fatto
che anch'essi compravano, vendevano e affittavano terra. Le prime carte rimaste che tornino a
nominare dei Vescovi sono della seconda metà del IX secolo, ma a parte questa novità la principale
occupazione della Chiesa locale era ancora quella di comprare, vendere ed affittare terra. Alcuni
contratti citano nuove chiese alla periferia dell'abitato, segno che un po' un sordina e probabilmente
senza neppure rendersene conto la città era ricominciata a crescere. In quei tempi l’autorità civile era
esercitata da Conti o Viceconti che però non avevano un gran rapporto con la città, preferendo risiedere
in qualche località della campagna, meglio se boscosa e ricca di selvaggina grande e minuta. Nei
decenni successivi le prerogative dei Conti vennero smontate pezzo per pezzo e trasferite gradatamente
ai Vescovi, decreto imperiale dopo decreto imperiale. Alla fine, e per la precisione nel 962, il Vescovo
di Asti divenne il vero Signore della sua città e dell’immediato circondario. Quarant’anni più tardi,
quando Arduino d’Ivrea si pose in capo la corona di Re d’Italia, le città della Val Padana e gran parte
delle campagne che le circondavano erano saldamente nelle mani dei loro Vescovi.
E' opinione corrente che nella storia delle nostre città la continuità non si sia mai spezzata, neppure nei
lunghi secoli di buio che separano la fine dell'Impero Romano dalla ripresa dell'XI secolo. E' vero, ma
solo in un senso molto particolare. In effetti, quella che ha saputo attraversare mantenendosi viva e
vitale anche i momenti più catastrofici del medioevo profondo non è - lo abbiamo visto - la città, ma è la
nozione di Civitas. Che vuol dire città, ma in quanto cittadinanza, cioè l'insieme dei cittadini. E non
era più la civitas come la intendevano i Romani antichi, qualcosa che non poteva prescindere dall'
esistenza di una Urbs, cioè di una concreta entità urbanistica accessoriata di foro, terme, teatro ed
anfiteatro, di fatto l’unico luogo in cui un cives, cioè un cittadino, poteva condurre una vita a tutti gli
effetti civile. Nell’alto medioevo la Civitas era diventata la Città di Dio, e questa non è soltanto una
bella immagine. Allorchè erano entrati in Friuli senza incontrare resistenza da parte dei Greci che
teoricamente erano i padroni dell’Italia, i Longobardi si erano astenuti dalle consuete devastazioni e
ruberie solo quando avevano incontrano cittadinanze solidamente tenute in riga da Vescovi molto
energici, con i quali i nuovi arrivati erano venuti a patti. La Civitas era dunque la comunità che si
stringeva attorno al suo Vescovo. Va detto, però, che di Vescovi sufficientemente tosti ce n'erano
pochini, e i primi anni della dominazione longobarda assestarono dei colpi micidiali all’organizzazione
ecclesiastica. Gli invasori erano in maggioranza ancora pagani, e quei pochi che erano già cristiani
seguivano l’eresia di Ario; se non era accompagnata da convincenti dimostrazioni di forza, l’autorità dei
Vescovi non significava nulla per loro. Molti Vescovi persero la vita, lasciando le loro Cattedre vacanti
per decenni, e quando finalmente i Re Longobardi si accostarono al cristianesimo di Roma, lo fecero
per ingraziarsi i sovrani dei Bavari, un popolo confinante - cristiano e cattolico - che non bisognava
inimicarsi perchè era più forte (e alle spalle dei Bavari c'erano, ancora più temibili, i Franchi, cattolici
pure loro). Questo significa che tra l’aristocrazia longobarda e i pochi Vescovi della Val Padana rimasti
operativi non c’era stato dialogo; i Longobardi si erano avvicinati a Roma passando per la Baviera. Tra
l'altro, numerosi Duchi invece di convertirsi al cattolicesimo si erano fatti Ariani, e non perchè ci
credessero ma perchè si vedesse che non erano contenti che i Bavari si allargassero troppo a casa degli
altri. Ad ogni modo, quando la rete delle Chiese Episcopali riuscì finalmente a rinsaldare le sue
maglie, curiosamente si ritrovò strutturata esattamente come lo era prima del disastro : una Città, un
Vescovo, una Chiesa. E questo sebbene le città si fossero in gran parte volatilizzate e molte comunità
fossero state disperse. D'altra parte è normale che la Chiesa di Roma riposizionasse i suoi uomini dove
aveva già beni, terreni e abituri. E se questi erano precisamente là dove si trovavano prima della
devastazione, vuol dire che se li era fatti restituire uno per uno. Sicuramente qualcuno si era segnato
tutto. Questo era il potere magico della scrittura : un tipo mai visto prima srotola una pezza coperta di
segni neri, ci guarda dentro, poi ti fissa negli occhi e ti dice che tu detieni ingiustificatamente un
terreno della tale chiesa o del tal monastero, e tu - che eri convinto che dopo cent'anni se ne fossero
dimenticati tutti - improvvisamente senti il diavolo che ti acchiappa da sotto. In quei secoli la Chiesa
era avanti in qualsiasi cosa; aveva il monopolio di quella straordinaria risorsa che era la scrittura ed era
l’unico soggetto sufficientemente organizzato per gestire dei cambiamenti su larga scala. E' merito dei
Vescovi se le città della Val Padana, che avevano rischiato di scomparire, ad un certo punto
ricominciarono a crescere. E da allora non si sono più fermate.
TERREMOTUS MAGNUS FACTUS EST
Nell’alto medioevo l’autorità era concepita come esercitata sugli uomini e non su di un territorio. I re e
i duchi erano capi di eserciti costantemente sul piede di guerra; i vescovi erano pastori di un gregge che
transitava in questo mondo ma solo per raggiungere quell’altro. Belle idee, buone per i tempi eroici.
Ma quando l’età della conquista e quella del martirio finirono, le aristocrazie militari si faecero
sedentarie e cominciarono a finalizzare l’esercizio del loro potere all’incremento del proprio privato
possesso (che a quei tempi era sostanzialmente possesso di terra, di terra e ancora di terra), mentre i
vescovi si premuravano di assicurarsi il districtus, vale a dire l’autorità civile su di un territorio
precisamente circoscritto entro il raggio di tot miglia dalla cattedra episcopale. Ovviamente, di queste
spinte verso una concezione del potere su base territoriale ce ne accorgiamo adesso, col senno del poi,
ma all’epoca nessuno poteva avere ben chiaro quale fosse la tendenza. Ancora a metà del XII secolo,
quando decise di dare una sistemata alle cose d’Italia, l’Imperatore Federico Barbarossa non intervenne
su questioni di confini o, peggio ancora, su pretese di indipendenza (nessuno avrebbe osato anche solo
pensare di potersi ritrovare al di fuori dell’Impero), ma se la dovette vedere con problemi relativi a diritti
e doveri all’interno di un universo che era tenuto insieme da una rete di rapporti vassallatici, e cioè
fondati sulla reciproca fedeltà personale.
E’ pur vero, d’altronde, che nel momento in cui
puntualizzava gli ambiti delle competenze dei soggetti sottoposti al suo imperio, Barbarossa tracciava consapevolmente o meno - dei confini anche geografici. Solamente dopo l’intervento dell’Imperatore,
ad esempio, il Marchesato di Monferrato, che pure esisteva già da due secoli, cessò di essere soltanto
una nebulosa di rapporti di fedeltà che legavano al Marchese un’infinità di soggetti nobili e plebei
disseminati a casaccio tra Piemonte e Liguria, e cominciò ad assumere l’aspetto di un qualcosa che era
già molto simile ad uno stato così come lo intendiamo noi. Il carattere non territoriale delle origini
lasciò però il segno sui confini del Marchesato ed essi ebbero sempre un tracciato bislacco (che tra
l’altro coincideva solo in piccola parte con il perimetro dell’area collinare compresa tra Po ed
Appennino che oggi chiamiamo Monferrato). Per dirne una, il fiume Tanaro segava le terre del
Marchese in due blocchi ben distinti il cui unico punto di contatto era rappresentato dal traghetto che si
trovava presso la località di Felizzano. Il guaio era che il Marchese possedeva solo il cinquanta per
cento di Felizzano; l’altra metà aveva dovuto cederla agli Astigiani, che poi l’avevano passata a quelli
della vicina Alessandria, e i rapporti tra i Monferrato e le due città non furono mai dei migliori. Ai
nostri occhi una situazione del genere può apparire francamente assurda : nei momenti di crisi, per
andare da un capo all’altro dei suoi possedimenti, il Marchese si vedeva costretto a chiedere il permesso
di passare sulle terre di terzi amici o neutrali e questi - signori o città che fossero – non solo davano
graziosamente il loro consenso ma spesso si sentivano in dovere di accogliere ed ospitare con tutti gli
onori l’illustre passeggero ed il suo seguito. Tutto questo sapeva ancora di Medioevo profondo, ma in
realtà il mondo stava mutando molto velocemente. Il dopo Barbarossa vide ad esempio esplodere un
fenomeno destinato a cambiare in maniera irreversibile la nostra geografia : sulla superficie della Val
Padana spuntarono come i funghi centinaia di città in miniatura nelle quali, con le buone o con le
cattive, venivano radunate le popolazioni che prima se ne vivevano sparpagliate nelle campagne.
Stiamo parlando, lo avete capito, della moltitudine di paesi e cittadine che tuttora punteggiano
fittamente il nostro territorio formandone il compatto tessuto connettivo, tutta roba che prima del XII
secolo non c’era, non esisteva proprio.
Questo dilagare per ogni dove della forma urbana fu
effettivamente un fenomeno nuovissimo. Nell’antichità le città dei Greci si riproducevano oltremare e
Roma segnava il progredire delle proprie conquiste fondando città, ma non s’era mai visto che le città
clonassero se stesse nel proprio contado, ed è assolutamente degno di nota che anche i signori feudali,
(che pure erano geneticamente refrattari alla dimensione urbana, in quanto di stirpe germanica,
errabonda per definizione) si buttassero entusiasticamente a seguire la tendenza, al punto che i nuovi
agglomerati formatisi in aree soggette al dominio dei Signori superano ampiamente per numero e per
densità le nuove fondazioni operate dalle città, che di norma costruivano i nuovi insediamenti piuttosto
ben distanziati l’uno dall’altro. Un esempio da manuale di queste nuove città in scala ridotta è San
Damiano d’Asti, la cui nascita, avvenuta nel 1275, ci è narrata in maniera tanto sintetica quanto
esauriente dal cronista Guglielmo Ventura : edificata fuit villa Sancti Damiani et ibi positi fuerunt (e vi
furono posti, manco fossero stati degli scatoloni) homines de Gorzano, de Castronovo, de Lavezolis et
de Marcellengo, cioè gli abitanti delle località rurali circostanti. Ed aggiunge, perchè si sappia che
questi fatti li ha visti coi suoi occhi mentre avvenivano: et ibi hora coenae (cioè all’ora di cena,
quand’era a tavola bello tranquillo) terremotus magnus factus est (ahimè, il terremoto gli ha rovinato la
cena), et scio (e io lo so), quia ibi eram (perchè c’ero). A fondare San Damiano furono gli Astigiani,
che - per inciso - da quasi due secoli si erano affrancati dalla signoria del loro Vescovo e quindi agivano
politicamente e militarmente a nome di se stessi come repubblica. In certe faccende gli Astigiani non
andavano tanto per il sottile : sovente gli abitanti delle campagne venivano convinti a calci nel sedere a
trasferirsi nei centri di nuova fondazione, e per evitare che ci ripensassero si davano alle fiamme le loro
vecchie abitazioni. Il ripetersi di episodi del genere mi induce a supporre che la prospettiva del
trasloco non dovesse apparire molto allettante alle popolazioni rurali, e in effetti non possiamo dare loro
tutti i torti : oggi sappiamo che si trattava di una cosa grossa, che si metteva una pietra sopra
all’antichità e si entrava nell’età moderna senza nessuna possibilità di tornare indietro, ma ai tempi la
faccenda doveva presentarsi come un grosso salto nel buio, e mi immagino che una delle cose che i
villici facessero più fatica a digerire fosse il doversi andare a rinchiudere dentro un recinto. Almeno
sino al XVIII secolo, infatti, una delle componenti immancabili della forma urbis fu la presenza di una
cinta difensiva - artificiale o naturale che fosse - che racchiudeva un agglomerato compatto di abitazioni
private interconnesse dallo spazio comune di una o più strade. Negli ultimi trecento anni la più gran
parte delle città è stata privata delle sue mura mentre i fossati che circondavano i centri minori sono
stati interrati. Un po' perchè l'evoluzione della tecnologia militare rendeva superflue difese così
elementari, un po' perchè l'eliminazione delle barriere apriva orizzonti sconfinati a investimenti e
speculazioni, il che è come dire che spalancava le porte al predominio assoluto della città sulla totalità
del territorio. La cerchia difensiva non è mai stata un elemento specifico ed esclusivo della forma
urbana (come sono invece il tessuto compatto, la prevalenza della funzione residenziale e la rete viaria)
ma senza un guscio protettivo efficace in certi periodi non si scampava.
Per convenzione
unanimemente accettata si fa cominciare il Medioevo con la deposizione dell'ultimo insignificante
Imperatore Romano d'Occidente, ma per un altro mezzo secolo nella nostra penisola si continuò a
vivere alla romana. Per noi il Medioevo comincia quando gli Ostrogoti, in guerra con i Romani di
Bisanzio, distruggono sistematicamente le mura delle città di cui si impadroniscono dopo averne
decimato le popolazioni con l'assedio e con la fame. Private del guscio, le città stremate vengono
inghiottite dalla campagna e per più di trecento anni ci si dimentica perfino di cosa siano. Trecento
anni sono tanti, sono minimo dodici generazioni che si danno il cambio, e la maggior parte di questa
moltitudine di persone non ebbe mai modo di vedere qualcosa che assomigliasse ad una città; è
normale che già alla terza generazione fosse andata persa la nozione stessa di cosa potesse essere una
città. Nel X secolo le scorrerie dei predoni Ungari nella Val Padana provocarono una pioggia di
diplomi imperiali che autorizzavano i Vescovi a circondare di mura le loro città. E' probabile che in
larga misura si trattasse di quello che oggi definiremmo un condono : si fa fatica a credere che i vescovi
più accorti non avessero già provveduto a scavare fossi e a tirare su terrapieni e muraglie. Riformatosi
il guscio, le città crebbero. E si moltiplicarono.
.
UNA PORTA, UNA VIA, UN CASTELLO
Qualche anno fa mi è capitato di soggiornare a Villafranca in Lunigiana. Il nome della cittadina è
significativo : le ville franche erano nuovi insediamenti la cui fondazione era promossa da signori
feudali e il cui popolamento era incoraggiato garantendo franchigie (vale a dire esenzioni da tributi e
prestazioni) a chi avesse lasciato la campagna per trasferirsi nel nuovo borgo. La nostra Villafranca ci
aiuta a capire cosa potesse spingere i Signori (nel nostro caso i Malaspina, tostissima stirpe guerriera)
ad adottare una politica del genere : il borgo era coerente ad una fortezza edificata sul fondovalle della
Val Magra, in un punto in cui questa si restringe sino a presentarsi come una profonda gola. Posta
all’imbocco della strettoia, la fortezza dava a chi ne era padrone la facoltà di bloccare una direttrice di
traffico di importanza continentale, trovandosi la Val Magra sul tracciato del più battuto itinerario di
terra che collegava a Roma l’Europa occidentale. Concentrando le popolazioni della campagna presso
la fortezza era possibile in caso di conflitti tutelarle meglio e più facilmente, e al contempo le si
cointeressava alla difesa di un’opera di primaria importanza strategica. Sebbene il centro storico di
Villafranca abbia subito negli ultimi decenni pesanti alterazioni, soprattutto a causa dei bombardamenti
alleati durante l’ultima guerra, la sua struttura originaria è ancora perfettamente riconoscibile al primo
colpo d’occhio perchè è un’unica strada tendenzialmente rettilinea che corre tra due lunghe file di case.
Ad una estremità della via c’era la fortezza, di cui oggi restano pochi ruderi; all’altro capo c’era - e c’è
ancora - la porta civica a cui si accede da un ponte che scavalca la Magra. La cittadina non aveva una
vera cinta muraria : a proteggerla bastava l’imponente barriera formata su entrambi i lati dell’abitato dai
muri posteriori delle case, solidi muri di pietra che si susseguono senza la benchè minima soluzione di
continuità affacciandosi da una parte sulla Magra e dall’altra su di un fossato che molto probabilmente
era in origine un alveo abbandonato dal fiume. A pochi chilometri da Villafranca si trova Virgoletta,
frazione ingiustamente dimenticata dalle guide turistiche ed ignorata perfino dalla più parte delle carte
geografiche. Conservatasi quasi perfettamente inalterata, la struttura di Virgoletta è esattamente la
stessa di Villafranca : una porta, una via con due file di case, un castello al fondo della via. Come
Villafranca, anche Virgoletta non ha una cerchia di mura : il borgo sorge sulla sommità di un lungo
scoglio di sasso e le pareti posteriori delle case si affacciano direttamente su alti e ripidissimi
strapiombi.
Una struttura analoga a quella di Virgoletta e di Villafranca presenta l’abitato di
Montechiaro, in provincia di Asti. Anche in questo caso abbiamo una via, due file di abitazioni e ripide
scarpate su entrambi i lati della cresta collinare su cui si allunga il paese. Non c’è una fortezza ma in
compenso c’è un massiccio torrione il cui caratteristico profilo, simile a quello di un paracarro, si fa
immediatamente riconoscere anche da grande distanza.
Montechiaro fu fondato nel 1200 dagli
Astigiani sul confine tra la repubblica di Asti e il marchesato di Monferrato, nel bel mezzo di un lungo
conflitto che opponeva i due stati, e credo che se Montechiaro, Virgoletta e Villafranca si assomigliano
tanto (e visti dal di dentro tutti e tre invariabilmente fanno venire in mente una trincea) è perchè
all’origine delle loro fondazioni ci sono analoghe considerazioni di ordine militare.
IL MEDIOEVO NEGATO :
MILANO
l centro storico di Milano come
appare in una mappa del 1808. In
giallo sono evidenziate le tracce
dell'urbanizzazione di età romana,
in rosso la città medioevale. Come
tutte le città romane della Val
Padana, Milano era organizzata
sulla base di una scacchiera
ripartita in quadrati di ottanta metri
per ottanta; la Milano medioevale
su di una griglia a settori
rettangolari. L'orientamento
complessivo dell'abitato medioevale
era condizionato dalla preesistenza
di alcune importanti direttrici di
traffico, la scacchiera romana
rispettava uno standard prefissato,
con assi viari che tendevano
approssimativamente verso i
quattro punti cardinali. Che tra le
due strutture non vi sia alcun
rapporto diretto è lì da vedere, così
come è palese che una delle due ha
patito più dell'altra l'usura del
tempo e le offese degli uomini.
Ciononostante, è opinione
pressochè unanime che i due
impianti urbanistici risalgano
entrambi ai tempi di Roma, ed anzi
si reputa addirittura che il più
antico tra i due sia quello che in
realtà è molto più recente.
L'equivoco si spiega col fatto che i
segni della Milano romana si
lasciano riconoscere soltanto
nell'area in cui sorgevano il Palazzo
Imperiale ed il Circo (di cui nella
nostra mappa risulta ancora ben
leggibile la cosiddetta Spina, che da
nord a sud divideva la pista nel
senso della lunghezza). Senza
pensarci troppo su, se ne trasse la
conseguenza che questa zona fosse
stata urbanizzata in un secondo
tempo rispetto all'abitato vero e
proprio, e questo venne ancora più
sbrigativamente identificato con
l'insediamento sviluppatosi nell'alto
medioevo (il cui assetto ortogonale,
a non voler guardare troppo per il
sottile, può effettivamente far
pensare alla scacchiera romana).
Poi, ovviamente, ci si è dovuti
arrampicare sugli specchi per
spiegare come diavolo potessero
collegarsi ed integrarsi le due
formazioni. Come si sa, il maggior
punto di forza del modello
urbanistico romano stava nella
possibilità di un accrescimento
modulare teoricamente illimitato,
ed era quantomeno pensabile che i
moduli occupati dal Palazzo e dal
Circo rappresentassero quel che
rimaneva di un impianto omogeneo
molto più vasto che per qualche
motivo si era quasi del tutto
volatilizzato. E' chiaro che se si
fosse prestato ascolto a quegli
autori antichi che parlavano di una
Milano che i Goti avevano ridotto ai
minimi termini (il Palazzo e il
Circo, per l'appunto, e poco di più)
tutto sarebbe diventato
immediatamente più chiaro. Però
questo avrebbe significato mettere
in discussione quella continuità
della dimensione urbana nell'Italia
dell'alto medioevo che per molti è
ancora un vero e proprio dogma.
.
NEGUCIANS ED ASINARIUS
Montechiaro sorge su di un versante dell’alta valle del torrente Versa, che si può considerare la chiave di
volta della complessa morfologia del Basso Monferrato. Per Basso Monferrato oggi si intende l’area
collinare compresa tra il Po a settentrione e il fiume Tanaro a sud, ma il territorio del marchesato di
Monferrato comprendeva soltanto la parte nord di questa zona; quella più a sud apparteneva alla città di
Asti, che si trova presso la sponda di Tanaro, su di un terrazzo alluvionale situato alla confluenza di due
lunghe valli che hanno origine nel cuore della catena collinare, ed una di queste è proprio la valle
scavata dal torrente Versa. Poco più a nord di Montechiaro si trova Montiglio, località per il controllo
della quale nel 1191 gli Astigiani avevano mosso guerra al Marchese di Monferrato. Il conflitto si era
protratto per ben quindici anni e si era concluso con un successo solo parziale degli Astigiani che
avevano ottenuto dal Marchese il possesso di alcune località, situate però da tutt’altra parte mentre
Montiglio restava dei Monferrini. La faccenda era però ben lontana dall’essersi conclusa: ancora
cent’anni più tardi, tra il 1305 e il 1306, gli Astigiani attaccarono e devastarono Montiglio e fondarono
nelle immediate vicinanze un nuovo ma effimero insediamento che tentarono di popolare rastrellando
gli abitanti delle località circostanti. Ma a che si doveva tanto accanimento da parte degli Astigiani ?
Tra le numerose valli che solcano la parte meridionale del Basso Monferrato, la Valle Versa è quella che
risale maggiormente verso nord; il suo tratto iniziale si incunea tra due imponenti massicci collinari
posti uno a levante e l’altro a ponente, differenti per morfologia ma anche per storia. Nel 1164 Federico
Barbarossa Imperatore li aveva accorpati giurisdizionalmente sottoponendo all’autorità del Marchese di
Monferrato - che già poteva contare nella parte più orientale su ampi possessi propri e su vassalli di
provata fede - anche gli innumerevoli Signori del massiccio occidentale, che a dire il vero non pare
fossero tutti quanti entusiasti della novità. Le due offensive astigiane di cui si diceva avvennero
entrambe in momenti caratterizzati da significativi vuoti di potere. Nel 1191, infatti, era da poco
defunto Barbarossa, mentre nel 1305 era lo stesso trono di Monferrato ad essere vacante : il Marchese
Giovanni era morto senza eredi diretti, lasciando i suoi vassalli incerti e non concordi sul da farsi, e si
dovette aspettare l’autunno del 1306 perchè arrivasse - addirittura da Bisanzio - un nuovo sovrano, nella
persona di Teodoro Paleologo, figlio dell’Imperatore dei Greci e della sorella del defunto Marchese (i
Monferrato erano imparentati con tutte le case regnanti d’Europa). E’ probabile che le iniziative
militari degli Astigiani mirassero non soltanto ad occupare località di indubbia importanza strategica
ma anche a scardinare una costruzione politica e una struttura territoriale che erano avvertite come
sostanzialmente fragili. Ci sarebbe però anche una terza ipotesi che vi vorrei illustrare. Un paio di
chilometri a nord di Asti si trova la chiesa della Madonna di Viatosto, un edificio trecentesco di
rispettabili proporzioni e di pregevole fattura. La chiesa sorge all’inizio di una lunghissima cresta
collinare che risale sino a Montechiaro passando in vista di Montiglio e va infine a congiungersi alle alte
colline che si affacciano sulla piana del Po, al di là della quale, ad una trentina di chilometri di distanza,
si scorgono la città di Ivrea e l’imbocco della Valle d’Aosta. L’interno della chiesa di Viatosto è
ripartito in tre navate; i pilastri su cui poggiano le volte a crociera hanno capitelli gradevolmente
decorati a bassorilievo.
Accanto allo stemma del Comune di Asti compaiono emblemi e figure
araldiche che ricordano alcune delle famiglie più ricche e potenti della città : c’è ad esempio il sole dei
Solari, oppure le ruote dei Roero, i ricci di castagna dei Ricci e certi animaletti stilizzati che taluni
interpretano come gli asinelli degli Asinari. Come era d’abitudine in quei tempi queste famiglie si
raggruppavano in fazioni avverse tra le quali scoppiavano di frequente conflitti violentissimi che
avevano talvolta i caratteri di vere e proprie guerre in campo aperto. Sui capitelli di Viatosto, però,
questi conflitti non pare abbiano lasciato tracce : ci sono i simboli di famiglie appartenute all’uno come
all’altro partito, e alcuni emblemi sono ripetuti su più di un capitello, in ordine apparentemente casuale.
Alla base della potenza economica, politica e militare delle grandi famiglie di Asti c’era la pratica del
prestito ad usura, esercitato perlomeno dagli inizi del Duecento; ma come avevano fatto costoro a
mettere insieme quantità di denaro tali da poterne fare commercio ?
Già alla fine dell’VIII secolo i più antichi documenti astigiani citano personaggi che si qualificano col
termine negucians, che non è latino ma è il piemontese negusiant, tuttora in uso, che indica persona
che compra e vende beni prodotti da altri. Contemporaneamente al negucians fa la sua comparsa nelle
carte l’asinarius, cioè il trasportatore, figura complementare alla prima nell’esercizio di attività
commerciali itineranti che probabilmente già allora coprivano un ambito territoriale piuttosto ampio
(per inciso, se tornate indietro di qualche riga noterete come una tra le maggiori famiglie astigiane del
Trecento portasse nel suo cognome la qualifica professionale che era stata all’origine delle sue fortune).
Nei due secoli successivi i negucians (un ipotetico plurale neguciantes non è attestato) spariscono dalle
carte; ricompaiono nel 992, qualificati come negociatores, termine collettivo che fa pensare ad un ceto
pienamente cosciente di sè e quindi - si presume - piuttosto solido dal punto di vista economico. Nel
1037 si garantisce ai mercanti astigiani il libero transito attraverso la valle alpina di Susa in direzione
della Francia; a metà del secolo successivo essi sono presenti in gran numero nei porti della Liguria, e
in seguito li ritroveremo un po’ dappertutto : in Francia, in Borgogna, nelle Fiandre, in Germania, in
Inghilterra, nei Paesi Bassi... La fortuna delle famiglie astigiane si era dunque concretizzata seguendo
le carovane di muli carichi di balle di mercanzia lungo sentieri simili a quello che ancora oggi sale da
Viatostofino a Montechiaro ed anche più in là seguendo il crinale della collina (solo in tempi molto
recenti le strade hanno abbandonano i percorsi d’altura conquistando i fondovalle). Il sagrato della
chiesa di Viatosto è l’ultimo punto da cui si può godere la vista dei campanili e delle torri di Asti; più
oltre la strada sale e scende seguendo le irregolarità del crinale e la città non si lascia più vedere. Per
quanto tempo ? Se, come penso, questo sentiero era una strada che conduceva alla Valle d’Aosta ed ai
suoi valichi che rappresentavano la porta dell’Europa nordoccidentale, potevano trascorrere anche
diversi anni prima che si tornasse a vedere il tetto di casa. Sono convinto che gli stemmi e le figure
simboliche scolpiti sui capitelli di Viatosto servissero, come le ben più modeste targhette in plastica
avvitate sui moderni banchi delle chiese, a perpetuare la memoria di chi aveva tirato fuori i soldi (e
questo potrebbe anche spiegare perchè alcuni emblemi compaiano più volte). La chiesa, situata in un
punto che più significativo non si potrebbe, sarebbe dunque un tempio votivo eretto dalle grosse
famiglie mercantili per ringraziare la Madonna della protezione accordata lungo le strade di mezza
Europa.
E credo sia lecito ipotizzare che le ripetute offensive astigiane nell’alta Valle Versa
rappresentassero altrettanti tentativi di impedire che la ricomposizione territoriale del Monferrato
operata da Barbarossa complicasse la vita alle carovane astigiane lungo la pista diretta ai valichi della
Val d’Aosta o - all’opposto - che si trattasse di tentativi di agevolare la libera circolazione delle stesse
approfittando delle debolezze congenite dello stato monferrino.
La viabilità antica è un universo ancora largamente inesplorato, ed un motivo
c'è: fra i tanti elementi che tutti insieme costituiscono il territorio, la strada è
indiscutibilmente uno dei più fragili ed effimeri. Nel momento in cui cessa il
suo utilizzo, essa si volatilizza molto rapidamente, e questo vale tanto per i
sentieri di campagna come per le grandi direttrici di traffico. Nell'alto
medioevo la più prestigiosa tra le strade della Val Padana occidentale era il
prolungamento della Via Emilia che da Piacenza raggiungeva il valico del
Gran San Bernardo toccando Pavia, Vercelli, Ivrea e Aosta e garantendo il
collegamento tra Roma e l'Europa nordoccidentale sino alle Isole
Britanniche. Era quella che oggi va moda chiamare Via Francigena, una
definizione che non so quanta fondatezza storica possa avere. Quand'ero
ragazzo, infatti, si usava l'espressione Strada Francesca, che probabilmente
era anch'essa di fantasia ma che almeno non aveva un suono così straziante.
In seguito, attorno a questa benedetta strada si è messo in piedi un business
mica da ridere (principalmente turistico, ma non solo) e siccome i
consumatori, come i bambini, vanno matti per le parole più sgradevoli ed
astruse, il prodotto è stato ribattezzato con quell'aggettivo che fa accapponare
la pelle ma evidentemente funziona, visto che nel nome della Via Francigena
si son dette e fatte le cose più impensabili. Ovviamente la strada non esiste
più se non come assieme di tanti brandelli scollegati, e non esiste più
neanche come direttrice: per portarsi da Piacenza ad Aosta in autostrada si va
sino ad Alessandria per poi piegare verso Vercelli, dove ci si immette
finalmente sull'antico tracciato. L'importanza di questo era enorme a livello
continentale ma molto minore per quel che riguardava gli spostamenti a
medio raggio; in tempi in cui si viaggiava a piedi o in groppa ad asini e
cavalli, tutte le strade si somigliavano e non esisteva la distinzione tra viabilità
principale e secondaria: a determinare quale fosse l'itinerario più battuto era
la minor quantità di miglia che si dovevano percorrere, e questo valeva da
ogni dove per ogni dove. Nelle illustrazioni che seguono ho provato ad
esemplificare in maniera molto schematica vari modi in cui la grande
direttrice si trovava ad interagire con l’intricata ragnatela della viabilità di
portata locale o regionale. Questa volta non sarà la geografia che ci aiuterà a
decifrare la storia, ma l’inverso, giacchè, come s’è detto, le tracce lasciate
dalle antiche strade sono sovente esigue ed incerte, e sono piuttosto gli eventi
storici a suggerire preziose indicazioni su come si muovessero uomini e cose
LA RAGNATELA
E’ probabile, ad esempio, che i
ripetuti attacchi sferrati dal Comune
di Asti contro il Marchese di
Monferrato per il possesso della
località di Montiglio tra il 1160 e il
1306 mirassero ad assicurare ai
mercanti della città un transito
agevole ed indisturbato lungo il
tracciato che permetteva loro di
immettersi nel minor tempo
possibile sulla grande strada dei
valichi, che correva poche decine di
chilometri al di là del Po. Nella
mappa è evidenziato il territorio dei
Monferrato; il colore più scuro
indica le zone in cui il Marchese
esercitava direttamente la sua
sovranità o poteva contare su
vassalli di provata fede; quella più
in chiaro è l’area accorpata al
Marchesato per volontà
dell’Imperatore Federico
Barbarossa nel 1164. La presenza
dei mercanti astigiani è attestata
inizialmente nella Francia
meridionale (nell’XI secolo) e in
Liguria (nel XII), e solo più tardi
nel nord della Francia e nelle
Fiandre; ammesso che la nostra
ipotesi di partenza sia vera, ci si può
chiedere se le inziative militari degli
Astigiani rappresentassero una
reazione ad intralci ed impedimenti
alla libera circolazione provocati
dalla decisione di Barbarossa, o se
si puntasse ad aprire con le buone o
con le cattive una direttrice di
traffico tutta nuova. All’inizio del
percorso di crinale che da Asti
conduceva a Montiglio sorge la
chiesa della Madonna di Viatosto,
quasi certamente un santuario
votivo voluto dalle maggiori
famiglie mercantili astigiane, e
questo induce a supporre che –
guerre o non guerre – il
collegamento diretto tra Asti ed
Ivrea abbia funzionato
efficacemente per un lungo periodo
di tempo.
La terza mappa evidenzia come i valichi delle montagne biellesi
rappresentassero una valida alternativa alla direttrice principale per chi dal
Vercellese doveva raggiungere la piana d’Aosta o (meglio ancora) le vallate
laterali situate a sinistra della Dora. Il percorso lungo il tratto più basso della
valle della Dora non era infatti dei più agevoli, giacchè nei punti in cui questa
si restringe la strada si riduceva di fatto ad una mulattiera, ed altrettanto
difficoltosa era la salita verso gli avvallamenti secondari, che si affacciano su
quello centrale con alti e ripidi strapiombi. Alla fin fine i disagi che si
potevano incontrare lungo le vie della montagna non erano molto maggiori di
quelli del tragitto di fondovalle, e a fare la differenza era il numero delle
miglia che si dovevano percorrere.
Nell’ultima mappa è evidenziata in
giallo la Strada delle Gallie che in
età romana risaliva la valle della
Dora Baltea sino ad Aosta per poi
biforcarsi e raggiungere i due
valichi che in seguito furono
intitolati a San Bernardo. La
viabilità attuale della Valle d’Aosta è
ancora incentrata su questa vetusta
direttrice, e non soltanto sulle
lunghe distanze ma anche in
ambito locale : salvo poche
eccezioni, infatti, per spostarsi da
una valle laterale a quella contigua
l’automobilista è costretto a
scendere sino alla valle centrale per
poi risalire sino a destinazione.
Ovviamente la continuità tra l’età di
Roma imperiale e i nostri giorni è
del tutto illusoria; nel medioevo,
quando il traffico su ruota era
praticamente inesistente (i carri
servivano per i lavori agricoli e non
per viaggiare) il tracciato che
seguiva il fondovalle della Dora
rappresentava una scelta obbligata
solo per le rotte commerciali che
univano la Val Padana con l’Europa
nordoccidentale attraverso il Gran
San Bernardo, ma per il resto la
viabilità sia locale che a vasto
raggio sfruttava una rete di percorsi
per lo più d’altura che permettevano
di ridurre quanto più possibile le
distanze, ovviamente entro i limiti
della praticabilità. La storia della
Valle d’Aosta è strettamente
intrecciata con quella delle sue
strade, e con l’aiuto della nostra
mappa proveremo a ripercorrerne i
passaggi più significativi. Attorno
all’anno Mille divennero signori
della Valle i Conti di Savoia, il cui
dominio si estendeva dalla Francia
sudorientale sino all’attuale Svizzera
Francese. A quei tempi la Valle
d’Aosta rappresentava per i Savoia
poco più che una scorciatoia : per
recarsi nei suoi possedimenti del
Vallese e del Lago di Ginevra il
Conte valicava il Piccolo San
Bernardo, toccava Morgex, e di qui
raggiungeva il Gran San Bernardo
tagliando per la montagna
(tracciato Verde) ed evitando così di
scendere sino ad Aosta per poi
risalire le valli dei torrenti Buthier
ed Artavanaz. I Savoia
cominciarono ad interessarsi ad
Aosta tra il XII e il XIII secolo,
quando decisero di assumerne il
diretto controllo sottraendolo alle
famiglie signorili che fino ad allora
vi avevano spadroneggiato
standosene annidate nei piccoli
castelli edificati sulla cerchia antica
delle mura romane. Il cambio della
guardia fu sostanzialmente indolore
e i Signori di Aosta non ci
rimetterono. I Signori della Porta
di Sant’Orso, che avevano dominato
sulla Porta Pretoria e sulla parte
nordorientale delle mura divennero
Signori di Quart, mentre i De
l’Archet, che avevano trasformato in
castello l’Arco di Augusto, furono
fatti Signori di Morgex e ad essi fu
affidata la giurisdizione sulla
Valdigne, cioè il tratto superiore
della valle della Dora. L’incarico
era prestigioso, giacchè era ad essi
che toccava l’onore di ricevere il
Conte quando giungeva nella
regione, ma un destino ancora più
luminoso attendeva i Visconti di
Aosta, che da vicedomini del
Vescovo divennero i vicari dei Conti
di Savoia, nonchè Signori di
Challand, il che li portò
gradatamente ad essere i signori di
tutto il tratto inferiore della Valle
d’Aosta. Challand era ben
collegato con la piana d’Aosta
mediante valichi relativamente
agevoli (tracciato verde) e sempre
per la via dei monti comunicava
abbastanza facilmente con la
Pianura Padana, ma quel che più
conta è che la sua posizione
permetteva di controllare la catena
di castelli posti a guardia delle
strettoie della bassa valle della
Dora, lungo la quale continuarono a
circolare nei due sensi uomini, muli
e mercanzie mentre armi ed eserciti
si trovavano di fronte ad una
barriera insuperabile.
LA RAGNATELA
La viabilità antica è materia molto più intricata di quel che si possa pensare. A confondere le idee
sull'argomento è la Via Emilia, l’interminabile rettilineo che da più di duemila anni unisce Rimini a
Piacenza. In questa sfilza di secoli la Via Emilia non ha mai smesso di funzionare egregiamente;
questo però non significa che tutto il sistema viabilistico della Val Padana sia ancora quello di duemila
anni fa, come paiono credere in tanti. Piacenza era il terminale nord della Via Emilia : da qui si
diramavano i tracciati diretti verso i principali passi delle Alpi centrali e occidentali. Tra gli ultimi
secoli dell'Impero Romano e quelli immediatamente successivi all'anno Mille la strada che collegava
Piacenza coi valichi della Valle d'Aosta toccava Pavia, Vercelli e Ivrea costituendo il prolungamento
quasi esattamente in asse della Via Emilia. Era una arteria importantissima, il collegamento più
diretto tra Roma e l'Europa nordoccidentale, eppure ad un certo punto questo smisurato nastro di terra
battuta si è spezzato e nessuno si è presa la briga di riannodarlo. Vedendo su di una carta stradale i
due tronconi che sono rimasti si fa fatica a capire che una volta erano uniti, anche perchè quello tra
Vercelli e Ivrea è colorato in rosso, avendo mantenuto una certa importanza a livello regionale, mentre
quello tra Pavia e Mortara è giallo, trattandosi di viabilità di ambito locale.
Stiamo parlando ricordiamolo - di quella che era una direttrice di portata continentale. Il punto in cui la sua continuità
risulta interrotta coincide con l'attraversamento del torrente Agogna, a metà strada tra le cittadine di
Robbio e Mortara. L'Agogna è un corso d'acqua dal carattere già piuttosto vispo di suo, e poco più a
monte vi si scaricano alcuni minuscoli ma vivacissimi affluenti dai nomi buffi (la Roggia Strona, il Cavo
Orialone) che sono alimentati da abbondanti acque sorgive e rendono ancora più imprevedibile il
regime del torrente. La zona in cui l'antica strada attraversava l'Agogna era (ed è ancora adesso)
investita di frequente da piene gagliarde che dirottavano in continuazione gli alvei e spostavano i punti
in cui era più comodo passare a guado o attraversare con una barca.
Nella rete dei sentieri che si
avvicinano alla golena del torrente si legge chiaramente che il tracciato della strada è stato modificato
più volte per tener dietro al va e vieni del guado; a un certo punto, però, ci si deve essere stufati di
giocare a rimpiattino col fiume, segno evidente che la vecchia strada era caduta definitivamente in
disuso. Ed infatti sono già diversi secoli che per portarsi da Mortara a Robbio si va per vie traverse
seguendo l'una o l'altra di due diverse strade che fanno come si suol dire il giro dell'oca toccando
paesini e paesetti e superando l'Agogna su ponti che sono situati parecchio più a monte o più a valle del
guado antico. E' chiaro, però, che non potevano bastare le piene di un torrente per ammazzare una
strada così importante. In effetti la strada è rimasta viva finchè è durata l'importanza di Pavia, che era
stata la capitale del Regno dei Longobardi ed era poi rimasta la sede di rappresentanza degli Imperatori
in Italia sino ai tempi di Barbarossa, nel XII secolo.
In seguito l'affermazione di Milano e il
conseguente declino di Pavia spostarono parecchio più a nord l'asse principale delle comunicazioni tra
la Lombardia ed il Piemonte, ed è stato questo a far morire lentamente la vecchia strada. Il peso che
fiumi e torrenti hanno avuto nella sua esistenza non va comunque sottovalutato; coi loro incessanti ed
irrefrenabili mutamenti di percorso essi rappresentavano un fattore di rischio che andava tenuto
costantemente sotto controllo, e non dev'essere un caso che le città che i Romani avevano fondato
lungo il tracciato si trovino sempre in prossimità del punto di attraversamento dei corsi d'acqua
principali che si incontravano lungo il percorso : Piacenza sorge a due passi da Po, Pavia sulla riva del
Ticino, Vercelli non lontano da Sesia, Ivrea presso la Dora Baltea. Da Ivrea la strada si addentrava tra
le montagne piegando quasi a gomito per imboccare la valle della Dora, quella che oggi è conosciuta
come Valle d’Aosta. Dall’XI secolo la Valle fu sottoposta ai Conti di Savoia, che però risiedevano
oltralpe e solo di tanto in tanto scendevano a verificare che tutto funzionasse a dovere. In loro assenza
l’amministrazione e il controllo del territorio erano demandati a funzionari e a vassalli fidati, e tra questi
i più importanti erano i Signori di Challant, a cui era affidata in particolare la tutela del tratto inferiore
della Valle, quello più esposto alla minaccia delle potenti e aggressive città della Pianura Padana. I
Signori di Challant si fregiavano del titolo di Visconti, erano cioè i vice conti, ma rispetto ai Conti di
Savoia lo erano, per così dire, solo in seconda istanza giacchè a quella importante funzione ci erano già
pervenuti in precedenza in quanto fedeli del Vescovo di Aosta, Conte e Signore della Città. Questa è
una storia molto interessante e per certi versi persino sorprendente ma ve la racconterò più oltre; per il
momento vi basti sapere che il territorio di Challand (con la d finale) che avrebbe dato il nome al casato,
non ne era la patria; i Vice Conti di Aosta ne erano infatti divenuti titolari solo verso gli inizi del
Duecento, quando i Conti di Savoia, intenzionati a rendere più efficace il proprio dominio sulla regione,
avevano preso il diretto controllo della città di Aosta ed avevano gradatamente esautorato quelle
famiglie che fino ad allora vi avevano esercitato qualche potere. A titolo di compensazione le famiglie
della vecchia aristocrazia aostana avevano assunto la signoria di aree più periferiche ma non per questo
poco prestigiose. Il territorio di Challand, ad esempio, è collocato in una posizione che a quei tempi
risultava particolarmente importante sotto il profilo logistico e strategico : infatti, se da un lato (quello
meridionale) esso si affaccia come una balconata sopra la bassa valle della Dora (un susseguirsi di aspre
strettoie alternate a esigue spianate di fondovalle), dall’altro (quello di ponente) Challand è collegato
mediante alcuni bassi ed agevoli valichi con la media valle della Dora, una piana relativamente ampia e
costellata da una moltitudine di abitati, al centro della quale c’è Aosta. Questi valichi sono tracce di
antichi percorsi della Dora. Ai giorni nostri per uscire dalla conca di Aosta il fiume sterza bruscamente
a destra (e cioè verso sud) ma molte e molte migliaia di anni fa, prima che il processo di sollevamento
della catena alpina incominciasse a sconvolgere questo angolo di mondo, la Dora tirava dritto, e i segni
dei suoi vecchi tracciati si lasciano leggere (sempre sotto forma di selle e valichi) anche più a levante,
nel paio di crinali che separano la Val d’Ayas - dove si trova Challand - dalle alture del Biellese al piede
delle quali si allarga la pianura del Piemonte nordorientale. Se a questo si aggiunge che la Val d’Ayas è
una valle pensile, vale a dire che il suo sbocco nella bassa Valle della Dora è parecchio sopraelevato
rispetto al fondovalle di quest’ultima, e che Challand si trova poco a monte del baratro che separa più
che collegare la valle tributaria e la valle principale, apparirà evidente come gli antichi Vice Conti di
Aosta fossero stati fatti signori di una straordinaria fortezza naturale, validamente munita sulla possibile
linea del fronte e ottimamente organizzata verso le retrovie. Era una sorta di inespugnabile centrale
operativa che coordinava la catena di fortilizi posti a presidiare gli angusti varchi della bassa Valle della
Dora, attraverso i quali transitava l’antica strada romana delle Gallie, che per tutto il medioevo garantì il
collegamento tra la Pianura Padana e il valico del Gran San Bernardo, porta dell’Europa
nordoccidentale. I Signori di Challant seppero ben meritare la fiducia accordata loro dai Conti di
Savoia, e videro accrescere costantemente il loro prestigio e la loro fortuna. Sul finire del XIII secolo
Aimone di Challant era vescovo di Vercelli, e in questa sede lo dobbiamo ricordare per esser stato il
primo importante benefattore di quello che sarebbe poi divenuto il Santuario d’Oropa.
Importantissimo luogo di culto che attrae folle di pellegrini da ogni dove, il santuario sorge a mezza
costa sul versante di mezzodì della catena montuosa che separa la pianura del Vercellese dall’intrico di
monti e vallate della Val d’Aosta; chi lo visita resta ammirato dalla superba veduta della Pianura Padana
che dilaga a perdita d’occhio un buon ottocento metri più in basso. Il santuario è cresciuto attorno ad
una minuscola chiesetta dedicata alla Madonna di cui abbiamo notizie sin dal 1207. Tra la fine del
Duecento e i primi anni del Trecento il vescovo Aimone restaurò ed ampliò la chiesetta, dotandola di
beni adeguati a mantenere dignitosamente i frati eremiti che la custodivano, e fu probabilmente lo
stesso Aimone a porvi la statua della Madonna che ancora vi si trova, una pregevole scultura in legno
realizzata nei modi del gotico d’oltralpe. La tradizione religiosa, elaborata molto più tardi, vorrebbe
invece che la statua sia stata scolpita da San Luca, evangelista ma anche artista, e che a portarla ad
Oropa sia stato, nel IV secolo, Sant’Eusebio, riparato tra le montagne per sfuggire alle persecuzioni
degli eretici Ariani. Eusebio non è un santo qualunque : primo vescovo di Vercelli (alla cui diocesi
appartenne sino al tardo Settecento la chiesa di Oropa), Eusebio fu il principale promotore
dell’organizzazione ecclesiale nella Val Padana occidentale; nel monastero da lui fondato in Vercelli uno dei primissimi in Europa - si formò, a detta del Padre della Chiesa Sant’Ambrogio, la maggior parte
dei vescovi del nord Italia. Attribuire a Sant’Eusebio la fondazione del santuario non era soltanto una
devota licenza poetica, ma era una mossa che potremmo definire politica, giacchè significava stabilire
tra la cattedra vescovile di Vercelli e la chiesa di Oropa un rapporto molto stretto che però in qualche
misura relegava in secondo piano quelli che erano i titolari diretti del Santuario e i legittimi intermediari
tra questo ed il vescovo. Stiamo parlando dei preti della chiesa di Santo Stefano di Biella, la cittadina
ricca ed operosa per definizione che sorge ai piedi della montagna di Oropa e che di Oropa è capoluogo
comunale. Quando e come sia nata la leggenda di Sant’Eusebio e della Madonna di Oropa non lo
saprei dire; a darle forma compiuta e definitiva fu, nei primi anni del XVII secolo, il vescovo di Vercelli
Giovanni Stefano Ferrero che scrisse una vita del Santo. Ferrero non era vercellese, ma era nato a
Biella da una delle famiglie più importanti della città, i cui diversi rami avevano generato personaggi
assurti a cariche prestigiose e non soltanto in ambito locale. Il giovane Giovanni Stefano, per dirne
una, aveva studiato a Bologna nel periodo in cui ne era cardinale lo zio Guido. Un altro Giovanni
Stefano Ferrero, cardinale, era amministratore apostolico nel 1507, mentre Cesare Camillo Ferrero era
vescovo di Ivrea nel 1585; discenderanno dai Ferrero Della Marmora i quattro fratelli La Marmora,
generali dell’esercito sabaudo che tanta parte avranno nelle vicende del Risorgimento. In un certo
senso Oropa rappresentava per i Ferrero una spina nel fianco, e da lunga data.
Sul finire del
Quattrocento Sebastiano Ferrero, che era stato chiavaro (come dire il sindaco) di Biella ed era in
seguito diventato consigliere di stato e tesoriere generale prima del Ducato di Savoia e poi del Ducato
di Milano, aveva mosso mari e monti perchè il Capitolo, (cioè il collegio dei sacerdoti) di Santo Stefano
cedesse la chiesa della Madonna di Oropa ai Canonici Regolari Lateranensi, un importante ordine
religioso che da poco tempo si era insediato in città. Va detto che a promuovere a proprie spese la
venuta dei Lateranensi a Biella era stato proprio lo stesso Sebastiano Ferrero, e che a dirigere per primo
il monastero con la carica di Preposto fu Bartolomeo Ferrero, che di Sebastiano era fratello. Il clero di
Santo Stefano, però, non aveva la benchè minima intenzione di rinunciare al Santuario e probabilmente
disponeva di appoggi più solidi di quelli su cui potevano contare i Ferrero; fatto sta che nel 1501 Papa
Alessandro VI riconfermava la chiesa di Oropa al Capitolo di Santo Stefano, e morta lì. La chiesa di
Santo Stefano, che da un centinaio di anni non esiste più, sorgeva nel Piano, a un tiro di schioppo dal
piede della fascia collinare prealpina. Essa aveva una lunga tradizione di orgogliosa difesa delle
proprie prerogative : pur essendo sottoposta al vescovo di Vercelli, essa era abituata a comportarsi con
l’autorità di una autentica Chiesa Cattedrale. Matrice della maggior parte delle chiese del Biellese,
Santo Stefano esisteva già nel V o nel VI secolo; sulle trasformazioni subite dall’edificio durante la sua
lunga esistenza ci forniscono vaghi indizi alcuni episodici reperti di scavo e i due cospicui avanzi della
chiesa conservatisi fino ai nostri giorni : un elegante campanile romanico che a occhio e croce dovrebbe
risalire al Millecento e un delizioso e fiabesco battistero costruito con ciottoli di fiume e rifinito in
mattoni, realizzato probabilmente attorno al Mille. Pur potendo vantare edifici di tanto pregio, a quei
tempi Biella era ancora lontana dal diventare qualcosa di simile ad una città. Nel IX secolo Biella, anzi
Bugella, è definita villa o curtis; nel X e nell’XI secolo è citata la presenza di un castrum, cioè un
castello, che probabilmente occupava un’area di ridottissime dimensioni coincidente con l’isolato in cui
adesso sorgono il duomo e il municipio, duecento metri per duecento, o anche meno. Sono forme di
insediamento e strutture caratteristiche delle aree rurali, come dire che Santo Stefano sorgeva in aperta
campagna. Nel 1160, però, sulla collina immediatamente prospiciente viene fondato, per iniziativa di
Uguccione vescovo di Vercelli, il borgo del Piazzo in cui si insedia parte della popolazione di Bugella e
che assumerà ben presto i caratteri di un autentico insediamento urbano a pianta compatta. Per un
centinaio di anni gli abitanti del Piazzo saranno vassalli del vescovo di Vercelli, il che insinua il sospetto
che la nuova fondazione avesse proprio lo scopo di ridimensionare l’autorità di Santo Stefano. Oggi il
centro città di Biella è tornato a coincidere col Piano, e il Piazzo è un pittoresco quartiere che richiama
numerosi turisti, ma fino al Settecento le parti erano invertite e il Piazzo, dove risiedevano le maggiori
famiglie della città, guardava dall’alto in basso anche metaforicamente il Piano, che aveva l’aspetto di
un paese di campagna, con le sue casette allineate sui lati delle strade, tra le quali si estendevano
campi, orti e frutteti. Al centro del Piano c’era Santo Stefano col suo bel campanile; la famiglia Ferrero,
invece, aveva un palazzone al Piazzo. Sebbene il tentativo di sottrarre Oropa a Santo Stefano fosse
andato a vuoto, i Ferrero non mollarono la presa sul Santuario. Furono loro, ad esempio, a lanciare la
moda di costruirsi una casa presso la chiesa di Oropa (che era ancora quella piccolina risistemata dal
vescovo Aimone alla fine del Duecento) e presto furono imitati da tutte le famiglie benestanti di Biella
che in questo modo potevano seguire con tutto comodo feste e solennità, facendo pure la giusta dose di
buone azioni giacchè una parte degli immobili era destinata al ricovero dei pellegrini. Bisognerà però
attendere sino all’anno 1600 perchè un Ferrero riesca finalmente a mettere le mani (in senso buono, si
intende) su di Oropa; ce le metterà materialmente ristrutturando ed ampliando a sue spese la chiesa, e
ce le metterà soprattutto culturalmente, dedicando il suo impegno ad accreditare la leggenda che vuole
Sant’Eusebio fondatore del santuario. Il Ferrero di cui stiamo parlando è ovviamente il già citato
Giovanni Stefano, vescovo di Vercelli e autore di una Vita di Sant’Eusebio edita nel 1600 e ristampata
nel 1609. La leggenda di Sant’Eusebio ad Oropa aveva una forte valenza propagandistica, rivolta su
due fronti : da un lato si trattava di affermare il valore delle tradizioni religiose locali di fronte alla
minaccia delle eresie protestanti che avevano preso il sopravvento appena al di là dei valichi alpini;
dall’altro occorreva però temperare gli eccessi di superstizione connessi al culto popolare. Promuovere
la devozione verso Sant’Eusebio cercando di sovrapporla a quella per la Madonna rappresentava un
tentativo di esorcizzare la componente di idolatria legata alla venerazione della statua della Vergine, e
difatti all’interno della chiesa alcune lapidi, un paio delle quali dettate dallo stesso Giovanni Stefano
Ferrero, ribadiscono che la statua, lungi dall’essere un oggetto magico piovuto da un altro mondo, altro
non è che un simulacro qui collocato da un uomo, sia pur eccezionalmente santo. Un poco a monte
della chiesa di Oropa si trova un masso di considerevoli dimensioni sul quale le pellegrine popolane
andavano a sbattere il deretano, convinte che quel gesto propiziasse la maternità. Immaginando che
questa innocua superstizione perpetuasse chissà quale remoto culto pagano, si pensò bene di
ingabbiare il macigno dentro una cappella, all’interno della quale fu posto un gruppo statuario dedicato
ad un episodio della leggenda di Sant’Eusebio che si sarebbe verificato - guarda caso - proprio in quel
luogo. La leggenda aveva dunque anche un preciso scopo pratico, e cioè quello di bonificare ogni
angolo del Santuario da possibili contaminazioni idolatre educando (o rieducando) i fedeli attraverso la
proposta di episodi edificanti. Date siffatte premesse, è chiaro che dalla tradizione devota non si può
pretendere una veridicità storica che non rientrava di certo negli intenti di chi l’aveva elaborata : se la
storia è verosimile ce n’è d’avanzo. Nel caso specifico, la leggenda di Sant’Eusebio, che rifugge da
miracoli, prodigi ed altri effetti speciali, parrebbe particolarmente plausibile, ma a ben guardare essa
contiene un anacronismo di fondo che ne smaschera la natura di racconto di fantasia : perseguitato
dagli eretici, Sant’Eusebio si rifugia ad Oropa come se si trattasse di un posto isolato e sicuro, lontano
da tutto e da tutti. E’ il tipo di idea che può venire in mente a un uomo moderno, nato e cresciuto in
un contesto urbanizzato e che guarda alla montagna come a un luogo romanticamente selvaggio.
Nella nostra concezione del mondo la montagna sta ai margini, e fa più danno che profitto; a scuola ci
hanno insegnato, ad esempio, che le Alpi ci dividono dall’Europa, e che per farci passare treni ed
autotreni si son dovute scavare gallerie e costruire viadotti, con immane dispendio di soldi e di fatica.
Ovviamente, ai tempi in cui si andava a dorso di mulo le cose stavano diversamente. Nello specifico, il
Santuario di Oropa si trova proprio sul margine della fascia degli alpeggi, dove la ripidezza della parte
bassa della montagna lascia il posto al più dolce declinare di un lungo avvallamento sospeso. Lungi
dall'essere un deserto, gli alpeggi richiamavano per tutta la durata della bella stagione una parte
considerevole della popolazione dei fondovalle e rappresentavano per l'economia di queste zone un
ambito di rilevanza fondamentale. Prova ne sia che l'importante fiera di Biella era in origine la fiera del
bestiame che si teneva presso una chiesetta dedicata a San Bartolomeo, situata a poca distanza da
quella della Madonna d'Oropa. Uomini e bestie vi convergevano numerosi dagli alpeggi circostanti e a
quanto pare si davano alla pazza gioia, tanto che ad un certo punto la fiera fu trasferita d'imperio in
città per meglio prevenire i disordini e le gazzarre che vi si verificavano, segno incontrovertibile che la
festa era un successone. Al di sopra degli alpeggi, poi, c'erano i valichi che garantivano, finchè le
condizioni metereologiche lo permettevano, la comunicazione diretta tra valli adiacenti. Tra l'altro, gli
specialisti che indagano il passato attraverso lo studio dei pollini e degli anelli di accrescimento del
legno ci assicurano che al tempo in cui visse Sant'Eusebio ci si trovava in una fase climatica
decisamente calda che si protraeva da alcuni secoli e rendeva agibili alpeggi e valichi per una lunga
parte dell'anno. Il complesso monumentale di Oropa si è sviluppato sul tracciato di una vecchia strada
che attraverso il valico della Barma metteva in comunicazione il Biellese, cioè l’estremo angolo
nordoccidentale della pianura piemontese e lombarda, con il tratto inferiore della Valle del Lys, che è la
prima vallata laterale della Val d’Aosta che si incontra risalendo la sponda orientale della Dora. Dalla
Valle del Lys, superando ancora la cresta montagnosa che si innalza sull’altra sponda del torrente, ci si
ritrovava in bassa Val d’Ayas; ad esempio attraverso il valico del Col Dondeuil si poteva raggiungere
Challand Saint Victor, e da qui, come s'era detto, si arrivava ad Aosta senza particolari difficoltà. Ai
giorni nostri il Passo della Barma rappresenta sotto il profilo viabilistico un’entità del tutto
insignificante, ma le attenzioni di Aimone di Challant vescovo di Vercelli nei confronti della primitiva
chiesetta di Oropa mi fanno pensare che egli reputasse la strada dei valichi una valida alternativa al
tracciato di fondovalle per spostarsi tra la magione avita e il posto di lavoro. O addirittura che fosse il
percorso utilizzato di preferenza, e questo in virtù del principio per cui la lunghezza dell’ipotenusa è
minore della somma delle lunghezze dei cateti : tagliando per la montagna le distanze si accorciavano,
e in un’epoca in cui o poco o tanto le strade erano tutte disagevoli la cosa poteva avere la sua
importanza. Ai giorni nostri è difficilissimo (oserei quasi dire che è una sofferenza) ragionare di
viabilità prescindendo da quello che potremmo chiamare il modello autostradale, vale a dire grandi
direttrici che vanno da metropoli a metropoli, sulle quali si innestano svincoli che smistano veicoli e
passeggeri verso bacini di traffico secondari. Fino a tempi piuttosto recenti, invece, una intricatissima
ed infinita ragnatela di tracciati si allargava a raggiera da ogni dove verso ogni dove. Cercherò di
spiegarmi meglio con un esempio molto schematico.
Se nel territorio compreso tra due città
(mettiamo che siano Mortara e Novara, distanti una quindicina di miglia) ci sono tre paesetti disposti
grosso modo in fila indiana ma non perfettamente in asse, l’unico modo sensato per collegare le cinque
località parrebbe essere un’unica strada che vada da Mortara a Novara facendo qui e là qualche mezza
curva che le permetta di toccare anche tutti e tre i paesini (ed è quello che avviene effettivamente ai
giorni nostri). Ad una soluzione del genere, però, si è arrivati soltanto da un paio di secoli; ancora nel
Seicento si ragionava (e si viaggiava) in una maniera completamente diversa, e infatti da Mortara
partiva non soltanto una strada per Novara, ma anche una distinta strada per ognuno dei paesini
intermedi. Da ciascun paesino partivano a loro volta diverse altre strade, una per ognuno dei paesi
circostanti, più – ovviamente - una per Novara e una per Mortara, e così via.
A complicare
ulteriormente le cose ci poteva anche essere (anzi, c’era proprio) un’ennesima strada che da una terza
città – ad esempio Pavia - raggiungeva Novara passando vicino a Mortara ma senza toccarla, più altre
strade ancora che arrivavano da chissà dove e andavano chissà dove, come le cosiddette Strade degli
Asini che erano utilizzate principalmente dal traffico commerciale ad ampio raggio e che percorrevano
lunghe distanze tenendosi alla larga dai centri abitati. Se nelle belle storie del passato i protagonisti
smarrivano la strada ogni volta che attraversavano un bosco un motivo ci doveva pur essere.
II
Qualche pagina addietro ho promesso che avrei detto qualcosa di più in merito alle vicende dei Visconti
di Aosta e degli altri Signori della città, e adesso che mi accingo a farlo mi rendo conto che quella che
sto per raccontare è una parte affascinante e poco conosciuta della vita della città di Aosta, qualcosa di
paragonabile al passaggio da un’adolescenza priva di regole alla maturità con i suoi doveri e le sue
responsabilità. A ben guardare, in questa similitudine è implicito un apprezzamento moralistico non
proprio lusinghiero, e in effetti se di questa delicata fase della storia della città – che pure ha lasciato
vistose testimonianze architettoniche ed urbanistiche – il grosso pubblico non sa molto, è perchè si è
preferito attirare la sua attenzione sull’infanzia di Aosta, che al contrario della giovinezza è stata
virtuosa e squadrata, e non poteva essere altrimenti giacchè è coincisa con l’età di Roma e del suo
Impero. Sull’eredità romana di Aosta si è molto insistito ai tempi del Risorgimento e del Fascismo, e la
cosa è comprensibile; peccato però che non ci si sia limitati alle parole ma si sia posta mano al piccone
e per riportare alla luce i resti di Aosta romana si sia fatta sparire una discreta porzione di Aosta
medioevale. Chi arriva ad Aosta col treno, appena uscito dalla stazione ferroviaria è accolto da una
statua di Ottaviano Augusto, da un lungo tratto della cinta muraria romana e da un massiccio torrione
quadrato, su ogni lato del quale si aprono due file regolarmente scandite di quei lunghi e caratteristici
finestroni centinati a tutto tondo che nell’intero bacino del Mediterraneo e in buona parte dell’Europa
continentale rappresentano il marchio di fabbrica dell’edilizia dell’Impero Romano. Sembra quasi di
essere in uno di quei quartieri della Roma popolare dove si ammucchiano ricordi di tutte le epoche; poi,
però, si va a leggere il cartello posto alla base del torrione, si scopre che i vecchi Aostani lo chiamavano
Pailleron, cioè il fienile, e si capisce che fino a tempi piuttosto recenti qua si era in aperta campagna, si
scopre che le ampie vie rettilinee che si incrociano a novanta gradi all’interno della cerchia romana sono
state tracciate appena qualche decennio fa e si realizza che la romanità di Aosta è stata reinventata di
sana pianta nell’ultimo paio di secoli, dopo che per un’infinità di tempo la città ed i suoi abitanti
l’avevano completamente rimossa. Anche perchè l’Aosta romana, che pure era disseminata di edifici
grandiosi, era quasi del tutto sparita sotto un profondo strato di macerie. Per rendersi conto che non
sto esagerando basta una visita all'immenso porticato che si è conservato in ottime condizioni nella
parte settentrionale della città. La colossale struttura circondava una piazza al cui centro sorgevano
due templi gemelli, e non è chiaro se si trattasse di un santuario o di un mercato o di tutte e due le cose
insieme. Sia come sia, il porticato è perfettamente agibile ma per accedervi bisogna scendere una scala
abbastanza lunga giacchè il monumento si trova un bel po' di metri sotto terra. A differenza di tante
altre testimonianze di Aosta romana, questa non si è potuta - fortunatamente - riportarla alla luce del
sole (ed esporla alle intemperie) perchè al di sopra di essa nell'alto medioevo si era costruita la
Cattedrale. Basta lo spessore dello strato di detriti che ha seppellito il porticato a far capire che razza di
cataclisma avesse posto fine all'infanzia della città. Curiosamente, però, l'evento non ha lasciato
alcuna traccia di sè nelle cronache dell'epoca e a tutt'oggi non c'è modo di sapere chi o che cosa abbia
distrutto Aosta. Ed è ancora più curioso che la cerchia delle mura sia rimasta in piedi sostanzialmente
intatta, anche se all'interno di essa non c'era praticamente più niente. L’Atlante degli Stati di Sua
Altezza Reale il Duca di Savoia, stampato ad Amsterdam nel 1682, dedica ad Aosta una bella veduta di
sapore già romantico che rende bene l’idea di cosa fosse la città alla fine del medioevo e ci aiuta a
capire come potesse presentarsi nei secoli ancora precedenti. Diciamo subito che nell’incisione
seicentesca le mura romane si vedono benissimo, ma se uno non sapesse cosa sono le potrebbe
tranquillamente scambiare per un lungo muretto che recinga un’ortaglia. Anche perchè al loro interno
i prati, i campi ed i frutteti dilagavano; in particolare la porzione orientale dello spazio che esse
racchiudevano era quasi completamente deserta, e quel poco di edificato che vi si trovava si raccoglieva
nei pressi dell'angolo di nordest delle mura; più giù era tutta campagna. La cosa più singolare che la
vecchia stampa ci mostra è però questa : fuori della città, lungo l’antica strada romana che giungeva alla
porta orientale si era sviluppato un popoloso quartiere suburbano, ma all’interno delle mura il
prolungamento di questo tracciato – che pure al tempo di Roma costituiva la principale arteria cittadina
– si era completamente volatizzato e per andare dalla porta orientale sino al centro dell'abitato, che era
tutto spostato verso ponente, non si poteva tirare dritto ma si doveva fare un giro bello largo
costeggiando la parte nordorientale delle mura. Nel medioevo più profondo quel poco di Aosta che
allora esisteva si stringeva attorno al Duomo, nelle immediate vicinanze della porta nord, che era un
tantino decentrata verso occidente. A partire dall’esiguo nucleo altomedioevale l’abitato avrebbe poi
ricominciato a crescere lungo l’asse formato dall’altra via principale della città romana, quella che ai
tempi aveva collegato la porta settentrionale alla meridionale. In una cartografia moderna questa
direttrice di sviluppo si lascia leggere abbastanza facilmente, ma nella veduta seicentesca (che era a
tutti gli effetti una mappa, e pure precisa, ma realizzata prima che la topografia diventasse una scienza
esatta) la strada di cui stiamo parlando si riconosce benissimo, lunga e dritta, ma è una via come tutte
le altre, affondata in un guazzabuglio urbanistico fatto di isolati dal perimetro irregolare, giustapposti
come capitava. Verso la fine del XVIII secolo, dunque, questo paesone dalla fisionomia ancora
spiccatamente medioevale occupava (senza peraltro riempirla) la parte occidentale del recinto romano,
mentre quella orientale, come s’è detto, era quasi spopolata. L’esagerata disparità nella distribuzione
delle superfici urbanizzate aveva radici antiche. Nell’alto medioevo tutto lo spazio compreso entro le
mura romane era sottoposto all’autorità del Vescovo, Conte della Città, ma al di sotto del Vescovo c’era
la piramide degli uomini a lui fedeli, e di quelli fedeli ai suoi fedeli, ed ognuno di questi personaggi
esercitava un pezzo di potere che gli era stato concesso come premio per la sua fedeltà. Così, se il
Vescovo aveva il potere su tutto il quadrilatero circoscritto dalle mura, nella porzione di levante in effetti
ne aveva un po’ di meno, poichè la difesa militare di quella che era la parte più esposta a possibili
attacchi era stata per così dire appaltata a famiglie dell’aristocrazia guerriera che a loro volta
subappaltavano tratti delle antiche fortificazioni ad altre famiglie a cui erano legate. A cavallo del
lungo muraglione era spuntata una serie di piccoli castelli, qui un po’ più fitti e là un po’ più rarefatti a
seconda di quanto fossero stretti i vincoli tra le famiglie che li avevano costruiti e li possedevano.
Persino l’arco trionfale eretto dai Romani un mezzo chilometro fuori dalla porta orientale era stato
trasformato in un fortilizio.
L’aspetto di Aosta mille anni fa doveva essere affascinante quanto
singolare : la minuscola capitale del Vescovo (poco più che un villaggio raccolto attorno alla Cattedrale)
era circondata da un regno in miniatura sui cui confini correva ininterrotta una piccola Grande
Muraglia irta di torri, e se l’immagine vi sembra artificiosamente suggestiva provate a calarvi nei panni
delle persone di allora - per le quali il mondo era infinitamente più vasto di quel che è per noi - ed anche
la quarantina di ettari compresa entro le mura di Aosta assumerà le proporzioni e i caratteri di una
regione dotata di una sua peculiare fisionomia. E se per caso vi domandate cosa potesse esserci di
tanto prezioso in quella superficie quasi vuota da giustificare un apparato difensivo così
impressionante, la risposta è semplicissima : c'era della terra, e doveva anche essere terra buona, perchè
se è vero che quel suolo era formato quasi interamente da detriti, è anche vero che la maggior parte
degli edifici dell'Aosta romana doveva essere stata realizzata con materiali di origine prevalentemente
vegetale, presto ritornati allo stato di fertile humus. E in più c'erano i ruderi delle costruzioni
monumentali in pietra, praticamente delle cave di eccellente materiale edilizio con cui erano state
realizzate le torri disseminate lungo il bastione. Le mura di Aosta custodivano dunque la base stessa
del benessere e della sicurezza del Vescovo, dei suoi preti, degli uomini che direttamente o
indirettamente erano al loro servizio e dei guerrieri a cui era affidata la salvaguardia della comunità.
Tra le famiglie che vigilavano sulla parte orientale delle mura, la più potente era quella dei Signori della
Porta di Sant'Orso, i quali avevano eretto una torre a ridosso della massiccia Porta Pretoria, che era
stata l'ingresso principale della città in età romana e che aveva già di suo i caratteri di una fortezza vera
e propria. Poco più a nord c'era la torre della famiglia De Fromage, vassalli dei Porta Sant'Orso, e più
su ancora, sull'angolo di nordest della cinta muraria, avevano la loro torre i De Palacio, così chiamati
per la dimora che si erano costruiti recuperando parte dell'antico anfiteatro che si trovava proprio lì
vicino, all'interno delle mura. A ponente della torre dei De Palacio c'era poi quella dei De Pertuis, che
vigilava su di un varco secondario della cerchia. A sud della Porta Pretoria si innalzava sulle mura la
torre dei Plouves, legati anch'essi ai Signori di Porta Sant'Orso, mentre più avanti lungo la strada che
usciva dalla Porta Pretoria c'era la piccola fortezza dei Signori De l'Archet, vale a dire l'Arco di Augusto
riattato a mo' di castelletto. A differenza di quella orientale, la parte occidentale delle mura non
conobbe mai una simile concentrazione di opere difensive, forse perchè la si riteneva meno esposta al
rischio di attacchi dall'esterno. Sulla porta occidentale della città c'era la torre della famiglia Friours
che possedeva pure, situata un poco più a sud, quella che oggi è conosciuta come Torre del Lebbroso;
di un paio di altre torri (probabilmente strutture effimere od estemporanee) rimangono soltanto
sporadiche menzioni nei documenti antichi, mentre la cosiddetta Tourneuve merita qui appena un
cenno in quanto eretta, come dice il suo nome, più tardi delle altre torri. Decisamente più importanti,
almeno a giudicare dalle ricorrenti controversie scoppiate per assicurarsene il possesso, dovevano essere
le fortificazioni che fiancheggiavano la porta settentrionale della città. Affidata in origine alle cure dei
Signori De Porta, questa rappresentava il punto di inizio della strada per il Gran San Bernardo, ed è
probabile che la sua rilevanza, più ancora che di ordine militare fosse di carattere schiettamente
economico, per la quantità di interessi che ruotavano attorno ad una direttrice di traffico di tale
importanza. Diametralmente opposto alla porta nord c'era infine (e c'è ancora) il castello dei Visconti
della città, meglio conosciuto come Torre di Bramafam ed eretto in corrispondenza dell'antica porta
meridionale. In teoria la famiglia dei Vice Conti avrebbe dovuto essere la più potente fra tutte, giacchè
l'autorità che essa esercitava non era soltanto una fetta di potere concessa dal Vescovo Signore della
Città ma era - tutto intero - il potere stesso del Vescovo, di cui i Visconti erano funzionari prima ancora
che vassalli. Se essere vassalli significava aver stretto un legame di reciproca fedeltà tra privati
gentiluomini, essere funzionari del Vescovo voleva dire esser parte di un'Autorità (o di un Potere, se
preferite) a cui si doveva inchinare qualsiasi persona, piccola o grande che fosse, perchè quel potere
proveniva direttamente da Dio e si esercitava attraverso l'Imperatore e gli uomini che questi aveva
posto a controllare ed amministrare le tante regioni dell'Impero. Ovviamente, un ragionamento del
genere (con tutte le conseguenze pratiche che poteva comportare) funzionava soltanto in quei rari
momenti in cui si avvertiva l'esistenza di un potere centrale efficace; diversamente, a stabilire le
gerarchie era la forza pura e semplice, ed è probabile - per tornare nello specifico - che la supremazia
dei Vice Conti sia sempre rimasta circoscritta alla sola parte occidentale della città. Sicuramente non
provavano alcuna soggezione nei loro confronti i Porta Sant'Orso, signori di innumerevoli fortezze. Le
due famiglie rivaleggiarono per il controllo della porta settentrionale della città e giunsero talvolta allo
scontro militare : nel 1253, ad esempio, fu assaltato e devastato il castello di Bramafam. Queste cose
però succedevano quando i Porta Sant'Orso avevano già assunto il titolo di Signori di Quart (un antico
possesso vescovile situato un sei chilometri a levante di Aosta) ed i Visconti erano diventati, come
sappiamo, i Signori di Challant. Erano gli anni in cui i Conti di Savoia rafforzavano gradatamente il
loro controllo su Aosta, ed è probabile che le famiglie maggiori si dessero da fare per arraffare quanto
più potevano prima che fosse troppo tardi. E' innegabile, ad esempio, che i Signori di Quart, che già
erano si erano impadroniti della torre che era stata dei De Pertuis, tentassero di estendere ulteriormente
la già rispettabilissima catena di castelli che i loro avi di Porta Sant'Orso possedevano o controllavano
lungo le mura orientali; dal canto loro gli Challant eressero la Tourneuve sull'angolo di nordovest della
cinta - praticamente agli antipodi del loro castello di Bramafam - quasi volessero marcare gli estremi del
loro antico territorio, ma la disparità tra gli apparati bellici messi in piedi e controllati dall'una e
dall'altra famiglia doveva essere abbastanza vistosa. A quel tempo l'agglomerato urbano di Aosta era
già ricresciuto parecchio, ma era ricresciuto, come s'è detto, solo nella parte occidentale dell'antico
recinto, e forse in questo aveva influito proprio la meno accentuata militarizzazione, chiamiamola così,
del tratto di mura relativo a quell'area. Sappiamo che nell'alto medioevo la terra era fondamento del
potere, ed era con la terra che si ricompensava chi esercitava il potere in nome di un'autorità superiore.
Nel caso specifico, una minore dispersione del potere del Vescovo si sarebbe tradotta in una minore
dispersione del suo patrimonio fondiario, e questo potrebbe spiegare perchè nei secoli successivi la
metà di Aosta che era rimasta più saldamente nelle mani della Chiesa sarebbe tornata ad essere una
città, mentre la metà che era stata affidata all'aristocrazia guerriera sarebbe rimasta campagna per così
tanto tempo ancora.
In questa vecchia piantina di Aosta
contenuta in uno stradario del 1956
l'area archeologica del teatro e
dell'anfiteatro romani risulta ancora
parzialmente edificata ed esiste
ancora la strada che nel medioevo
costeggiava le mura di nordest
collegando la Porta Pretoria - vale a
dire l'accesso orientale della città con la zona del Duomo, cuore
dell'abitato. Cancellando questa
vecchia direttrice, le campagne di
scavo degli anni successivi hanno
portato a compimento il processo di
rimozione dell'identità urbanistica
di Aosta condotto lungo tutto il XX
secolo nel nome di Roma Imperiale.
Prima c'era stata l'urbanizzazione
della parte meridionale del
quadrilatero compreso entro le
mura : fasci di strade parallele che si
incrociano ad angolo retto e che
nelle intenzioni dei progettisti
avrebbero dovuto ridisegnare
l'originaria scacchiera romana. Un
obiettivo probabilmente mancato,
giacchè ne è venuta fuori una
griglia a settori rettangolari che non
corrisponde allo standard consueto
nelle città romane della Val Padana
e che è forse il frutto di una
ricostruzione congetturale un po'
frettolosa, basata su ritrovamenti
archeologici contestualizzati
malamente. Assediata da una
caricatura di scacchiera romana ed
abbondantemente sventrata per
riportare alla luce qualche
malinconico basamento di colonna,
con la soppressione del
collegamento tra il Duomo e la
Porta Pretoria, la vecchia Aosta si è
vista privare dell'elemento più
caratteristico e singolare della sua
struttura urbanistica, la cui ossatura
era costituita proprio dalle strade
che dalla Cattedrale conducevano ai
quattro accessi principali della
cerchia muraria. Tre di questi (a
settentrione, a ponente ed a levante)
coincidevano con le porte di età
romana; il quarto, quello
meridionale, si apriva in
corrispondenza della torre del
Pailleron, di fronte all'attuale
stazione ferroviaria.
Nell'illustrazione successiva questi
tracciati sono evidenziati in giallo,
mentre in bruno è indicata molto
schematicamente la superficie che
risultava urbanizzata sul finire del
medioevo. Sono inoltre segnalate
in rosso le principali fortificazioni
che si susseguivano lungo la cerchia
delle mura.
IL MEDIOEVO RIMOSSO : AOSTA
I FIUMI
NOSTRA SIGNORA DELLA PALUDE
Nessuno più ricordava quel nome, Nostra Signora della Palude : la chiesetta campestre era già diruta
settecento anni fa, quando i monaci eressero una chiesa nuova e un convento su fondi che immagino
già appartenessero loro e che essi stessi dovevano aver sottratto alla palude bonificandola.
Prosciugare una palude non è così complicato; faticoso si, ma non complicato : si traccia un solco che
abbia la giusta pendenza, largo il giusto e profondo quel che basta, e l'acqua che prima ristagnava
riprende il suo cammino abbandonando un tesoro, una putredine vecchia di secoli che farà ricchi i
raccolti.
Sovente, ed anzi quasi sempre, il solco già esiste ma è fuori uso : un ruscello intasatosi, un'ansa di
fiume rimasta isolata; sarà sufficiente allora ridare loro sfogo, perchè l'acqua non chiede di meglio che
riprendere il suo viaggio, ed è difficile credere, quando ci si trova di fronte all'instancabile scuotimento
del mare a cui tutte le acque vogliono far ritorno, che quell'elemento mai quieto possa giacere
intorpidito abbracciato alla melma.
Da pensionato Pier Antonio Gabba vide realizzarsi il suo sogno più bello : fu pubblicato il libro a cui
aveva lavorato per tanti anni dedicando ogni momento del suo tempo libero a pazienti ricerche
d'archivio. Era la storia del suo rione, e per quel che mi risulta il dilettante Gabba, ex operaio del
comune, è il solo autore ad essersi mai accorto di come Eraldo Mussa cronista del Seicento citasse una
sentenza che citava a sua volta un istrumento ove si nominava Nostra Signora della Palude, non
altrimenti nota. E per quel che mi consta, dei pochi lettori di Gabba uno soltanto (io) si rese conto di
come sotto quel nome si celasse qualcosa di ancora temibile.
Ho vissuto anch'io, per quasi vent'anni, nel rione di Gabba e ho percorso infinite volte la strada ove
sorgeva il convento, ormai scomparso anch'esso, come pure la chiesa, da due secoli quasi.
A
cancellarli insieme agli orti e ai coltivi annessi era stata la fame crescente di spazi edificabili : case ed
officine, fabbriche e magazzini si erano moltiplicati al piede del terrazzo alluvionale su cui sorgeva la
città più antica con le sue torri, i palazzi e i campanili. La strada del convento divenne una via chiusa
tra condomìni e capannoni, e tutti i giorni ci passavo per recarmi in centro; al fondo della via una breve
ma ripida salita stretta tra i muri bruniti di palazzi antichi affrontava con vigore il dislivello che separava
la città vecchia dalla nuova.
Ed ecco, pochi anni or sono, che ai piedi di quell'erta si avventano minacciose le acque brune di fango :
ingigantitosi sotto la sferza di piogge violente ed interminabili, il fiume che scorre qualche cento metri
più in là era dilagato irrefrenabile fuori dal proprio letto distruggendo vite e beni. Io che già da
qualche tempo me ne vivevo altrove vidi in televisione che sotto la casa dove avevo abitato ci si spostava
in barca; l'acqua superava i due metri e sudai freddo pensando a che cosa la sorte mi aveva risparmiato,
però non ne fui sorpreso. Cinquant'anni prima (lo raccontavano i vecchi, io non c'ero ancora) era già
successo, tutto uguale. Perchè l'acqua non ha fantasia : nessuno può dire quando arriverà, ma si sa
benissimo per quale strada.
La via che conduce al fiume e al ponte che lo scavalca corre su un lungo terrapieno, quasi una diga che
nei giorni del disastro era sfondata in un sol punto, proprio là dove tempo addietro transitava la vecchia
roggia molinara ripercorrendo un alveo abbandonato. L'acqua non improvvisa, e per questo gli antichi
non edificavano in golena.
Se attraversando la pianura vi capita di vedere un pioppeto decimato dall’uragano, e le piante
rovesciate, con la chioma per terra e le radici a mezz’aria che si tirano dietro un pezzetto di campo,
allora potete star certi che lì sotto, a portata di badile, c’è l’acqua. Quando incontra l’acqua, la radice
del pioppo cessa di trivellare il suolo e si accontenta di estendersi in larghezza, il che va benissimo per
nutrirsi, ma non basta a garantire alla pianta la necessaria stabilità.
SOTTO LA PIANURA
Dove vivo io il pioppo coltivato viene chiamato Canadese, e per per parlare di un pioppeto si dice i
Canadesi, al plurale; sono quanti anni che abito qua e non ho mai sentito un agricoltore usare la parola
pioppeto. Se avete messo piede qualche volta in un pioppeto probabilmente sarete stati colpiti dalla
sua somiglianza con un enorme capannone industriale, e in effetti si tratta di un ambiente
esageratamente artificiale, grandioso ma vuoto; ci sono questi altissimi pilastri – vivi – e nient’altro,
neppure l’erba per terra. Salvo trovarci, inaspettatamente, qualcuna di quelle anticaglie – un manufatto
irriguo in disuso, un filare di salici – che è facile incontrare sparse per la campagna ma che qui dentro
(perchè l’impressione è proprio quella di trovarsi al chiuso) assumono l’aspetto un po’ sconcertante
delle installazioni museali. Mi è capitato per esempio di dover visitare una testa di fontanile situata
proprio all’interno di un grande pioppeto. I fontanili, lo spiego velocemente per chi non è della zona,
sono le canalizzazioni scavate nei secoli scorsi per recuperare dal suolo acqua da destinare
all’irrigazione; la testa è il punto dove comincia il fontanile. Le teste dei fontanili possono essere di
vario tipo e questa apparteneva al più comune, un cospicuo scavo profondo un due metri e mezzo e
largo quattro o cinque, dal quale aveva inizio una lunga canalizzazione rettilinea della stessa profondità
e larghezza. Di fontanili ne avevo già passati in rassegna parecchi; quanto ai pioppeti, visto uno visti
tutti, insomma non ero per nulla preparato alle singolari impressioni che mi attendevano questa volta.
Nella leggera penombra di quell’ambiente tanto vasto quanto neutro l’ampio scavo scuro spezzava la
continuità del suolo grigiastro e uniformemente dissestato dalle ripetute discature. Era un accesso
della metropolitana, pari pari, però con le spallette coperte di rovi, e da esso sgomitavano per uscire
certe vigorose figure nere e scarmigliate che viste più da vicino si rivelarono essere sei o sette giovani
ontani che effettivamente facevano a spallate per alzare la testa quanto più possibile al di sopra del
suolo, intendo dire il mio suolo, perchè il loro stava due o tre metri più giù, sul fondo dello scavo. Era
davvero l’accesso ad un livello infero, al quale dovetti scendere per rilevare temperatura e acidità
dell’acqua che sgorgava copiosa e scorreva spigliata, limpida e buia come il fondo melmoso sottostante,
sul quale però non mi capitò quasi mai di poggiare il piede giacchè l’invaso era ingombro delle carcasse
dei vecchi ontani caduti. L’aggettivo ingombro rende bene l’idea : tanto era vuoto il livello soprastante,
tanto era affollato quello di sotto, e affollato esclusivamente di forme di vita vegetale. Alle
erbacce solitarie e ai radi rovi che mestamente strisciavano sul suolo del pioppeto faceva riscontro al
livello più basso un ricco assortimento di muffe, di funghi del legno, di piante acquatiche fluttuanti o
galleggianti, di piante erbacee - dalle minuscole alle più allampanate; più, inevitabili, i rovi e le robinie,
più – ovviamente - loro, i signori del luogo, gli ontani. Credo sia il caso di spiegare cosa significasse
tutto quel rottame di ontani caduti. Gli ontani hanno questa abitudine, che quando arrivano ad una
certa età si lasciano crollare tutti insieme e fanno spazio ad una nuova generazione. Gli ontani
abbandonano i loro semi all’acqua, e questi germogliano solo se si arenano su di un suolo che sia
esattamente di loro gradimento. Se a questo si aggiunge che gli agricoltori non li amano, è facile
capire perchè gli ontani si vadano facendo rari, tanto che li si incontra ormai quasi esclusivamente negli
angoli più fuori mano, come quella testa di fontana nascosta nel pioppeto. Stando sul fondo della
quale, intrappolato in un groviglio di piante vive e legna morta, mi veniva quasi da credere che la
sdegnosa stirpe degli ontani avesse scelto di rifugiarsi in una dimensione diversa dalla nostra, situata
qualche metro più in basso. Una fantasia che conteneva una mezza verità e una bugia tutta intera. E’
vero infatti che la rete di teste e canalizzazioni sviluppatasi nei secoli scorsi per recuperare acqua dal
suolo è qualcosa di molto simile a quel fantomatico piano di sotto della pianura di cui mi piaceva
favoleggiare tra me e me; grandiosa per estensione e molto ramificata, essa ha un proprio microclima e
caratteri biologici notevolmente diversi da quelli di superficie. E’ falso, invece, che questa realtà
parallela sia al riparo dalle devastazioni che la specie umana sa provocare : se gli ontani della testa
erano scampati sino ad allora, con tutto il loro corteggio di vegetali sudditi, non era perchè si trovassero
in un’altra dimensione ma soltanto perchè il pioppeto e il fontanile erano di proprietari diversi, e
siccome di questi tempi i cavi fontanili sono apprezzati più come collettori di acque di varia
provenienza da rimettere in circolo che non come produttori in proprio di acqua, erano ormai vari anni
che nessuno più si prendeva la briga di dare una pulita alla testa, il punto di scaturigine primario.
I DEMONI DELL’ACQUA
I
Racconta mia madre che io all’asilo ci sono andato un giorno solamente, e questo perchè quando venne
a riprendermi, verso sera, mi trovò zuppo d’acqua dalla testa ai piedi mentre giocavo tutto solo nella
piccola fontana del giardino. Il giorno successivo non mi ci portò più, ma non so fino a che punto
questo sia bastato a preservarmi dai demoni dell’acqua.
Un’altra cosa che mi raccontano di quel
periodo è che più d’una volta mi è capitato di piazzarmi sotto il davanzale della finestra del piano terra a
farmi colare addosso lo sgocciolìo dei vasi appena annaffiati. La spiegazione corrente è che fossi
convinto di lavarmi; francamente io queste cose non le ricordo ma siccome mi ficcavo sotto l’acqua
tutto vestito, il sospetto che ci fosse qualcosa che non funzionava mi è rimasto.
II
Avrò avuto una dozzina d’anni e ogni settimana si andava a far visita ai nonni materni che vivevano in
un cascinino in collina. Essendo di indole un po’ malmostosa e solitaria, una volta baciati e salutati i
parenti ero ben contento di prendere su e di andarmene a spasso per la campagna lì attorno. Non che
ci fosse quel granchè da vedere : la casa dei nonni sorgeva sul fianco di una collinetta che digradava
molto dolcemente verso la valle, e a perdita d’occhio non si scorgeva praticamente altro che vigne e
campi. Ad attirarmi era soprattutto un minuscolo ponte di bei mattoni vecchi gettato sopra un fossetto
di scolo che scendeva molto gradatamente tagliando di sbieco il versante. A meno che non fosse
piovuto di brutto, il tratto di fosso a monte del ponticello era sempre asciutto; allo sbocco del condotto,
invece, si potevano scorgere qua e là tra le coriacee e rade erbacce sul fondo del fosso alcune
microscopiche pozzanghere d’acqua e fanghiglia, tanto piccole che ci si poteva a malapena bagnare la
punta di due dita. Ce n’erano altre un poco più giù, e poi ancora, distribuite senza un apparente
criterio, quindi si iniziava ad incontrare un pochetto di pantano e dell’acqua ferma, che a un certo punto
- difficile da definire con esattezza - si increspava un filino e prendeva a scivolare verso valle. Non so
dire cosa ci trovassi in quello spettacolo, ma se me ne ricordo ancora così bene è evidente che ne rimasi
folgorato. Quel che invece non ricordo è per quanto tempo fossero continuati i miei pellegrinaggi alla
sorgente, se fosse stato per una sola stagione o più d’una; in ogni caso c’è sempre un anno dopo, e
l’anno dopo la sorgente non c’era più.
III
All’incirca in quel periodo aveva fatto la sua apparizione su di un tratto di strada che percorrevamo di
frequente una piccolissima sorgente che si era scavata nell’asfalto un invaso della capacità di una
tazzina da caffè, colmo d’acqua sino all’orlo e non di più. La sorgente restò attiva alcuni anni, durante i
quali almeno una volta fu otturata per il rifacimento del manto stradale. Ricomparve pochi mesi dopo
e continuò imperterrita a farsi gli affari suoi finchè si esaurì, all’improvviso.
IV
Piccola e soprattutto molto breve, la Vallescura si insinua tra le colline nei pressi del mio paese e basta
una sola occhiata per esaminarla da cima a fondo. In ogni stagione e soprattutto in primavera il
fondovalle è piuttosto ricco di acque che filtrano o colano dalle ripide alture circostanti e vanno
disciplinatamente ad incanalarsi nei tanti fossetti rettilinei e paralleli che solcano l’esigua spianata, o
almeno così pare.
Aspettate che un’abbondante nevicata ricopra di bianco ogni cosa e vedrete
disegnarsi sul fondo della vallata una lunga traccia grigiastra di neve più umida che serpeggia qua è la
infischiandosene dei fossi che se la dormono convinti di avere fatto il loro dovere.
IL CONO D’OMBRA
A metà del XVII secolo la parte più orientale del territorio di Mortara - così come abbondanti porzioni
del territorio dei comuni limitrofi - era ancora coperta da una vasta selva che si allungava da nord verso
sud per una ventina di chilometri, coincidendo sostanzialmente con l’estensione di un grande banco
sabbioso che è l’elemento geologico più notevole di questa parte della Lomellina. Vi raccomando di
tenere a mente questo banco di sabbia, perchè il vero protagonista della storia è proprio lui. Orbene,
l’aspetto di questa grande massa boscosa non doveva essere particolarmente gradevole nè tantomeno
rassicurante : alle aride superfici rilevate su cui dominava la quercia si susseguivano depressioni
paludose invase da ontaneti impenetrabili, e in più c’erano i ladri, che vi agivano numerosi e
indisturbati.
La distruzione di questa selva fu accompagnata da un modesto ma significativo
movimento migratorio, che fu probabilmente incoraggiato dalle amministrazioni di alcuni dei comuni
circostanti mediante la lottizzazione e la cessione di incolti di proprietà pubblica, prati e boscaglia che
in precedenza venivano usati collettivamente per pascolare le bestie e per raccogliere legna da ardere.
In prossimità dei terreni più umidi e più fertili si svilupparono alcuni insediamenti - le frazioni costituiti da un piccolo numero di abitazioni di proprietà delle famiglie contadine che si erano
impegnate nella valorizzazione di quei suoli che venivano man mano sottratti dapprima alla palude e in
seguito al bosco. Questi insediamenti possono essere correttamente definiti colonie, anche se la cosa
ci può far sorridere, essendo noi abituati ad usare questo termine per indicare fenomeni di ben altra
consistenza, come le nuove fondazioni delle antiche città greche o i possedimenti delle grandi potenze
dell’età moderna. Sostanzialmente, però, una colonia è un insediamento funzionale alla colonizzazione
di nuovi territori, indipendentemente dal fatto che questi si trovino al di là del mare oppure a due passi
dalla madrepatria, come nel nostro caso. E comunque la distanza non è necessariamente soltanto una
questione di chilometri : se vi capiterà un giorno di percorrere a piedi una delle numerose stradine che
dalle frazioni orientali di Mortara conducono al capoluogo sarete quasi certamente colti da un senso di
grande lontananza e distacco. A colpire non sono tanto la solitudine e il silenzio, emozioni così
comuni nella campagna lomellina che alla fine ci si fa il callo, ma è piuttosto l’impressione che la strada
non sia quella giusta; non è proprio la sensazione di essersi persi ma quasi, ed è una sensazione tanto
più bizzarra sapendo che in quel pezzo di campagna non si incontrano sentieri che conducano a vicoli
ciechi ed è impossibile perdersi : tutte le strade portano sicuramente a Mortara. Questo singolare stato
d’animo nasce probabilmente dal fatto di non avere la percezione visiva della meta verso cui si è diretti,
il che è veramente inconsueto da queste parti. Nel piatto paesaggio delle risaie le caratteristiche
sagome dei campanili rendono infatti immediatamente localizzabile da grande distanza questo o quel
centro abitato. Invece Mortara che è lì a due passi, sempre più vicina, chissà perchè si ostina a non
apparire. Il trucco c’è ma non si vede : le frazioni sono sparpagliate lungo un modesto avvallamento
che si trova ad un’altitudine leggermente inferiore rispetto al capoluogo, per raggiungere il quale
occorre risalire un paio di terrazzamenti piuttosto sfumati e quasi impercettibili alla vista ma sufficienti
a rialzare la linea dell’orizzonte quel tanto che basta per occultare il profilo della città, che infatti si
palesa all’improvviso quando si giunge sull’orlo del terrazzamento superiore. Se a questo si aggiunge
che i campanili e i casamenti del capoluogo dominano una sconfinata distesa di risaie, mentre le sue
frazioni se ne stanno annidate tra i pioppeti, giacchè sul grande banco sabbioso che le ospita la risaia è
ancora minoritaria, credo concorderete con me sul fatto che bastino anche pochi chilometri per
separare due mondi.
Le frazioni sono una forma di insediamento rurale decisamente rara in
Lomellina, dove la norma era rappresentata dalle grosse cascine isolate, vale a dire stuoli di lavoranti
alloggiati attorno ad un’aia e impegnati su terra altrui (e pochi grandi proprietari che risiedevano
volentieri altrove). Una frazione è una città in miniatura, è forma urbana; la grande cascina no, e
questo non dipende tanto dalla distribuzione degli edifici, e meno ancora dalla consistenza demografica
(una cascina poteva essere più vasta ed articolata e molto più popolosa di certe minuscole frazioni di
impianto quasi inconsistente); a fare la differenza erano i rapporti che intercorrevano tra gli abitanti, e
tra di essi e il territorio su cui agivano : la grande cascina conteneva i dipendenti del padrone della terra,
la frazione era abitata da privati cittadini coltivatori della propria terra, quelli che il dialetto locale
qualifica con la colorita espressione Perdapè. Delle pochissime frazioni esistenti in Lomellina ben otto
si concentrano in un fazzoletto di terra vasto si e no quattro chilometri quadrati : quattro frazioni si
trovano nel territorio del comune di Mortara, due in quello del comune di Gambolò, una è divisa a metà
tra Gambolò e Mortara; l’ottava è in territorio di Vigevano. Cinque di questi paesetti sorgono - tre di
qua e due di là - sulle due sponde di una valletta così poco profonda che praticamente non la si nota, e
sono situati tutti e cinque proprio sul confine tra la dorsale asciutta e la depressione umida, segno,
questo, che chi aveva fondato i paesetti la valletta l’aveva notata benissimo.
Nella mappa sono evidenziati i
principali corsi d'acqua naturali ed
artificiali che solcano la pianura
novarese e lomellina, limitata ad est
da Ticino, a sud da Po e ad ovest da
Sesia. Sesia è il principale
responsabile della modellazione del
territorio di questa regione : tutti i
torrente e tutti gli antichi cavi
irrigui sfruttano lunghi tratti di
alveo già occupati dal fiume e poi
abbandonati da esso nel suo
implacabile retrocedere verso
ponente. Quale sia la potenza di
Sesia lo dimostra il fatto che esso
trascini le acque di Po per decine di
chilometri verso sud, tanto che
viene da chiedersi chi sia l'affluente
di chi. Sono evidenziati anche gli
affluenti di destra di Sesia che
occupano alvei abbandonati da Po
nel suo spostamento verso
meridione; tutta la Lomellina
sudoccidentale è segnata dalle
infinite tracce dello scontro tra i due
fiumi. Sesia è un livellatore
spietato : dove i suoi spostamenti
sono stati graduali e la sua brutalità
ha avuto modo di esprimersi
pienamente, il paesaggio si è
appiattito in maniera uniforme e
solo là dove Sesia ha subìto
diversioni improvvise di ampie
proporzioni si sono conservate le
testimonianze di una morfologia
che anticamente si presentava più
vivace ed accidentata. Da Novara
si allunga verso mezzogiorno il
cosiddetto Pianalto (evidenziato più
in chiaro), un modesto rilievo
formato da detriti morenici la cui
sopravvivenza è dovuta al
dirottamento verso ponente delle
acque che lo stavano erodendo da
nord. Questo strappo nella
continuità dell'azione livellatrice di
Sesia e dei corsi d'acqua suoi
satelliti ha avuto ripercussioni su
tutta la fascia di territorio posta a
valle del Pianalto (e cioè a sudest di
questo, giacchè tale è la direzione
generale delle colature). Si è infatti
formata una sorta di cono d'ombra
all'interno del quale la piallatura dei
suoli è stata più episodica e meno
intensa : si sono conservate ampie
distese sabbiose (probabili residui
di depositi risalenti alla penultima
glaciazione) e nelle vicinanze di
Gambolò permangono consistenti
avanzi delle scarpate (anch'esse
evidenziate in chiaro) che
chiudevano ad occidente la valle ora
occupata dal torrente Terdoppio. I
piccoli pallini rossi disseminati tra
Gambolò, Vigevano e Mortara
rappresentano le otto frazioni che si
sono sviluppate su di un
terrazzamento intermedio tra la
valle del Terdoppio e la spianata di
Mortara e che costituiscono
senz’altro l'elemento più
caratteristico di quella porzione di
territorio.
SABBIA E ACQUA
IL CONO D’OMBRA
Più a monte, due frazioni sorgono in margine ad un’altra leggerissima depressione che va a confluire
nella prima; l’ottava frazione è separata dalle precedenti da una dorsale di altezza molto modesta ma
piuttosto faticosa a valicarsi trattandosi nè più nè meno di uno spropositato cumulo di sabbia
mimetizzato nella boscaglia. Anche quest’ultima frazione di cui vi dicevo si trova sull’orlo di un
terrazzamento, ma in questo caso la faccenda è completamente diversa, trattandosi delle scarpate che
per un tratto di quasi dieci chilometri chiudono a ponente la valle solcata dal torrente chiamato
Terdoppio, scarpate che in certi punti raggiungono l’altezza davvero considerevole di sette-otto metri,
che per una zona piatta come questa sono un’enormità. A percorrere gli avvallamenti minori a cui
abbiamo accennato in precedenza sono invece rogge e cavi irrigui, giacchè in Lomellina ormai da lungo
tempo non esiste più un’idrografia naturale. La regione è stretta tra due fiumi importanti ed è solcata
da tre rispettabilissimi torrenti, ma per il resto non ha un rio, un ruscello od un rigagnolo : tutti i colatori
naturali sono stati rimpiazzati da canalizzazioni artificiali o sono stati incorporati in esse. Va detto, a
onor del vero, che questi colatori non funzionavano più di tanto, trattandosi generalmente di alvei
abbandonati dai corsi d’acqua maggiori nei loro incessanti spostamenti, e i ristagni e le paludi
abbondavano ovunque; intervenendo su di essi si rimisero in movimento le acque ferme rendendole
disponibili per l’irrigazione delle aree più rilevate, generalmente molto aride. La storia umana della
Lomellina sta tutta nella risoluzione del problema dell’acqua disegualmente distribuita, troppa qua e
troppo poca là. La storia naturale, invece, sta tutta nel come si sia creato quel problema, ed un
colpevole c’è : si tratta di Sesia, il fiume pazzo, teso ossessivamente a raddrizzare il suo corso verso il
sud. Soggetto a piene improvvise dagli effetti disastrosi, le sue intemperanze hanno sovvertito più volte
il quadro complessivo delle colature di una regione molto ampia, rivoluzionandone ripetutamente
l’idrografia. Direttamente o indirettamente, Sesia è il responsabile della modellazione del suolo della
Lomellina e di buona parte della provincia di Novara, che è situata immediatamente a monte della
Lomellina. La parte vecchia della città di Novara sorge, come su di un promontorio che guardi la
pianura, all’estremità di un modesto rilievo – il cosiddetto Pianalto di Novara – che si allunga per una
decina di chilometri ed è formato da materiali di minuta consistenza derivati dal millenario degrado dei
detriti dei ghiacciai alpini.
Detto così, ci si attenderebbe che Novara si trovasse all’estremità
meridionale del suo bel Pianalto e guardasse in direzione di Po dando le spalle alle Alpi. Si tratta
invece dell’estremità nord, e Novara si affaccia, si, su di una pianura ma in faccia ha le montagne. Tra
il Pianalto di Novara che sta isolato nel bel mezzo dell’alta Val Padana e la primissima fascia collinare
pedemontana (a cui un tempo il pianalto era collegato) ci sono infatti più di dieci chilometri di pianura
accuratamente livellata dal lavorìo dei corsi d’acqua. L’aspetto più curioso di tutta questa storia sta
proprio nel fatto che il Pianalto sia ancora lì mentre tutto quel rilievo che esisteva immediatamente a
nord di esso è stato spazzolato via dall’azione distruttiva dei fiumi. Evidentemente, ad un certo punto
è arrivato qualcuno che ha preso per la collottola i corsi d’acqua che stavano erodendo da nord il
Pianalto e li ha costretti ad istradarsi su altri tracciati, collocati un poco più ad occidente. Quel
qualcuno è Sesia, spietato catturatore di fiumi, e la stessa diversione che ha graziato il Pianalto di
Novara ha evitato che venisse gradualmente smantellato, un pochettino più a sudest, il grande banco di
sabbia su cui sorgono le frazioni di Mortara e di Gambolò. Il vistoso avvallamento che il Terdoppio
percorre costeggiando il grande banco sabbioso è un’eredità lasciata al torrente da un fiume scomparso
di ben maggiore consistenza (ennesima vittima di Sesia) e deve anch’esso la propria sopravvivenza a
quella provvidenziale diversione, che ha creato una sorta di cono d’ombra a cui sono state risparmiate le
forme più brutali della rimodellazione fluviale. Queste anticaglie geologiche inopinatamente scampate
alla distruzione non sono solamente delle curiosità scientifiche, ma hanno anche il merito di
movimentare e di rendere più bello un paesaggio che altrimenti si sarebbe ridotto alla consueta desolata
piattura.
In più esse hanno costituito e costituiscono tuttora dei fattori di un certo peso nelle
dinamiche sociali ed economiche della zona. Proprio per via dei suoi caratteri geologici e morfologici
poco allettanti il grande banco sabbioso ha scoraggiato a lungo i tentativi di valorizzazione agraria; a
colonizzarlo sono stati infine non i soggetti economicamente più forti - che già si erano accaparrati i
bocconi migliori altrove - ma modeste famiglie di agricoltori, che hanno dato vita al peculiarissimo
fenomeno urbanistico delle frazioni. E siccome a questo si lega una forte frammentazione fondiaria
(tipica delle zone in cui ancora prevale la piccola proprietà) e di conseguenza un buon livello di
diversificazione delle colture, la presenza delle frazioni si sta rivelando un efficace antidoto contro il
degrado della campagna circostante. Capoluogo di un terzo di quest’area, la cittadina di Gambolò è
situata a poca distanza dalla riva del Terdoppio; le sue frazioni si chiamano Remondò e Garbana, anzi
la Garbana, con l’articolo.
Sono nomi che molto probabilmente rinviano alle prime fasi della
colonizzazione : la parola Remondò si riferirebbe alle operazioni preparatorie eseguite sui terreni da
mettere a coltura, Garbana ricorderebbe i gerbidi un tempo ivi esistenti.
Gambolò si trova sul
fondovalle, in sponda sinistra (che da questa parte del Po corrisponde alla riva orientale), le sue frazioni
sorgono invece dall’altra parte del torrente, al di sopra dei terrazzamenti che chiudono il vallone in
sponda destra. Al contrario delle frazioni di Mortara, le frazioni di Gambolò si trovano dunque in
posizione rilevata, più in su rispetto al capoluogo. Per recarsi da Gambolò alla Garbana occorre
superare un dislivello di circa otto metri; percorrendo la moderna carrozzabile si tratta di una lunga e
graduale salitella, ma se si prende la vecchia strada sterrata che supera il torrente un po’ più a monte del
ponte nuovo, ci si para davanti un imponente e ripido bastione ammantato di boscaglia che mette
persino un po’ di inquietudine : cosa ci capiterà di incontrare quando saremo arrivati lassù ? In effetti,
ai nostri giorni, con il fondovalle assoggettato alla più ferrea monocoltura risicola, una volta che si sia
raggiunto l’orlo superiore della scarpata si gode la vista di un piccolo e inaspettato paradiso :
appezzamenti di limitate dimensioni orlati di filari, varietà delle colture e soprattutto una rispettabile
copertura arborea, composta in egual misura da pioppeti e da incolti in cui il bosco si va riformando
spontaneamente. Sono questi i benefici effetti della frammentazione fondiaria legata, come si diceva,
alla persistenza della piccola proprietà agricola attorno alle frazioni ed è, in definitiva, l’ennesima
generosa eredità lasciata da quella diversione fluviale che ha risparmiato il grande banco sabbioso.
Cinque o seicento anni fa, però, là in cima alla scarpata c’era la foresta, c’erano i lupi, c’erano i banditi,
e a separare ulteriormente il fondovalle dall’altura c’erano le frequenti piene del torrente. Nella
seconda metà del Quattrocento sono attestate le chiesette campestri di Remondò e della Garbana, ma
per la celebrazione di battesimi, matrimoni e funerali gli abitanti delle due località dovevano recarsi
presso la chiesa madre, che era l’antica chiesa dedicata a Sant’Eusebio Vescovo di Vercelli posta in riva
al Terdoppio, appena fuori la porta di Gambolò. Ancora a inizio Settecento gli abitanti delle due
frazioni adducevano a scusante della scarsa frequentazione della parrocchiale la paura di essere
aggrediti dai ladri dei boschi. Nel 1776 finalmente Remondò ebbe una bella chiesona nuova dedicata a
Santa Margherita, e a quell’epoca la foresta era già definitivamente sconfitta. Nell’area delle frazioni ne
rimanevano ormai solo abbondanti frammenti aggrediti su tutti i lati, ma un poco più giù, nella parte
più meridionale e più deserta del grande banco sabbioso la copertura arborea originaria doveva resistere
ancora per un secolo abbondante, e il nome della strada dei Boschi Bruciati, che passa da quelle parti,
mi fa pensare che il disboscamento avesse conosciuto dei momenti piuttosto brutali.
I VIAGGI
LA CAPPELLA DEL SACRO PALAZZO
La facciata dell’Abbazia di Vezzolano, edificata sul fianco di una delle più alte colline del Monferrato è
concepita come una esposizione visiva della cosmologia cristiana. La dimensione ultraterrena è
simboleggiata da tre ordini sovrapposti di gallerie cieche e al vertice della facciata fa capolino il volto
del Creatore; scendendo, tre coppie di statue rappresentano le schiere angeliche e tra due arcangeli c’è
il Redentore che benedice tutto quanto il sottostante. Molto più in basso, una lunetta posta sopra
l’uscio della chiesa rappresenta il momento chiave della Storia per i Cristiani : lo Spirito Santo sotto
forma di colomba si avvicina al capo di Maria Vergine che con la sua maternità redimerà il mondo, le
brutture del quale si manifestano sui capitelli che reggono il portale assumendo l’aspetto di demoni
fitomorfi. Nel vastissimo campionario della demonologia romanica questi mascheroni che eruttano
fogliame dalle orecchie e dalle narici sono piuttosto insoliti. Un tempo credevo (ingenuamente) che
essi fossero la testimonianza del perdurare del culto degli alberi tra la popolazione rurale; in realtà
questo è quel che gli uomini di chiesa - parecchio schematici nelle loro convinzioni - credevano che il
popolo credesse. Un luogo comune ormai antico ma la cui fortuna non accenna a diminuire, ed anzi si
rinnovella ogniqualvolta ritornino di moda le scienze occulte ed altre stupidate del genere, vorrebbe che
nelle architetture religiose del medioevo - e massimamente nelle facciate delle chiese - si tramandasse
ogni sorta di insegnamento recondito ed astruso.
La lezione di scienza sacra limpidamente ed
esaurientemente esposta nella facciata dell’Abbazia parrebbe dare ragione al signor Luogo Comune,
però io credo che il capolavoro di Vezzolano rappresentasse l’eccezione, e che la regola fosse invece
quella di accumulare indiscriminatamente sulle pareti degli edifici sacri tutta la decorazione che il
budget del committente permetteva di realizzare, senza curarsi più di tanto del senso e della coerenza
del messaggio che veniva trasmesso da quel groviglio inestricabile di diavoli e martiri, eroi e mostri e
creature fantastiche di ogni genere intrappolati dentro ghirlande e festoni.
Proprio la composta
sobrietà della decorazione di Vezzolano - poche figure di cospicue dimensioni e sapientemente
distanziate, una lunetta perfettamente decifrabile posta al disopra della porta d’ingresso alla chiesa e
per ornamentazione nient’altro che tre o quattro testine di demoni con relativi fronzoli - mi conforta
nella mia convinzione che ci troviamo di fronte ad un esemplare molto raro, e volendo persuadere anche
voi che la prassi corrente era ben altra cito due monumenti coevi all’Abbazia e che mi paiono assai
rappresentativi. Il primo è la chiesa di San Secondo che sorge nella campagna del paese di Cortazzone,
nell’Astigiano, parecchio lontano dall’abitato.
La chiesa ha tre navate; la navata centrale è
notevolmente più alta delle laterali e questa particolarità, unitamente alle ragguardevoli dimensioni,
dona all’edificio un’eleganza maestosa che pare francamente sprecata giacchè attorno alla chiesa non vi
sono che prati, vigneti e campi. La cosa non ci sorprende, avendo noi già incontrato altri edifici sacri
di grande pregio artistico e di cospicue proporzioni abbandonati in mezzo alla campagna : quando fu
eretta, la chiesa di San Secondo provvedeva alla cura della moltitudine di anime che lavorava sui campi
di una delle tante Curtes (vale a dire le corti, le aie, e cioè le aziende agricole) che appartenevano alle
chiese astigiane. In questa zona i centri abitati il cui nome comincia per Cort- sono abbastanza
numerosi e distribuiti con una certa continuità : le proprietà degli enti ecclesiastici costituivano dei veri
e propri distretti produttivi. A quei tempi - è una storia che conosciamo già - i paesi ancora non
esistevano : Cortazzone - e con lui Cortanze e Cortandone - si sarebbero formati solo più tardi sulla
sommità delle colline che dominano l’ampia e lunga valle nel bel mezzo della quale sorge la chiesa di
San Secondo. All’interno di questa i pilastri che separano le navate portano dei capitelli di dimensioni
balorde che sembrano recuperati da qualche altra chiesa più antica, decorati piuttosto rozzamente con
animali e mostruosità varie . La decorazione esterna riserva invece non poche sorprese : nei blocchi di
arenaria della facciata, della parete meridionale e dell’abside sono state scolpite innumerevoli bizzarrìe
distribuite senza alcun ordine o criterio. Ci sono alcuni autentici saggi di bravura e tra essi spicca un
omino che se ne sta a pancia all’aria aggrappato ad un archetto pensile alla sommità di un’abside,
delizioso (e mi immagino che la gente venisse fino alla chiesa apposta per vederlo). E ci sono anche
dei pasticci inenarrabili : c’è un uccellaccio tutto sghembo che vorrebbe forse significare un’aquila, ci
sono fregi intrecciati in maniera caotica, c’è un paio di belle mammelle rotonde. C’è persino la
raffigurazione - demenziale - di un coito, con due pupazzetti, maschio e femmina, distesi uno davanti
all’altro, palma del piede contro palma del piede. Una posizione che scoraggerebbe qualsiasi rapporto;
fortunatamente per lui, l’omino è dotato di un pene lunghissimo che si insinua come un serpente tra le
gambette dei due personaggi puntando dritto sull’obbiettivo. E poi uccellini, fioroni, fogliame ed
intrecci, visibilmente realizzati da tante mani diverse e non tutte abili in ugual misura. L’impressione
generale non è certo quella di un programma decorativo intenzionalmente elaborato, ma si direbbe
piuttosto che si sia fatto buono tutto quel che si riusciva a rimediare, basta che ce ne fosse. E questo
nonostante che San Secondo fosse tutt’altro che una modesta chiesetta, ma una signora chiesa voluta da
una committenza di discreto livello, in grado di esigere un lavoro di notevole pregio architettonico.
Però di bocca buona in fatto di decorazione, senza pretese per quel che riguardava la forma e
sostanzialmente indifferente ai contenuti. Vediamo cosa avveniva invece ad un ben più alto livello
della gerarchia sociale e culturale, e precisamente nella maestosa basilica di San Michele Maggiore a
Pavia. Diciamo subito che le sequenze di rilievi che adornavano riccamente la parte mediana ed
inferiore della facciata risultano oggi leggibili a fatica, essendo state realizzate in un’arenaria molto
tenera sulla quale i secoli e le intemperie si sono accaniti senza pietà.
E’ ancora pienamente
apprezzabile, al contrario, la decorazione dei tre portali, scolpita in una pietra di meno effimera
consistenza. E se, come pare, essa era omogenea per stile e contenuti al resto dell’ornamentazione,
allora credo si possa dire che l’emozione che la facciata della basilica doveva comunicare a chi le si
avvicinava era - senza mezzi termini - l’angoscia. Rari gli episodi che si possono identificare con
sicurezza come tratti dalla Bibbia, tanti gli animali, reali o fantastici, senza numero i combattimenti :
uomini a piedi o a cavallo contro altri uomini; uomini contro animali; uomini contro mostri; animali o
mostri contro altri animali e mostri; animali e mostri che assaltano e sbranano esseri umani e per
condimento, qui e là qualche testa mozza. La violenza insita nell’uomo e nella natura è esemplificata
in mille modi; uno dei rilievi più impressionanti presenta una fila interminabile di mostriciattoli che si
inseguono, e ciascuno di essi azzanna ferocemente la coda di quello che gli sta davanti. L’eccellente
fattura accentua il realismo e la crudeltà della raffigurazione. E’ poi presente un certo numero di
soggetti bizzarri ed enigmatici che forse si ispirano ad una tradizione narrativa di cui si è perso ogni
ricordo o forse sono prodotti di pura invenzione; in tutti i casi anche qui non mancano esempi di
prevaricazione e violenza : un uomo cavalca una donna usando i capelli di questa come redini; un altro
afferra per i capelli una donna che impugna un bastone, e via di questo passo, tra cacciatori che tornano
dalla battuta portando prede spropositate e guerrieri che tornano dalla battaglia reggendo trofei di teste
tagliate. Come ho già accennato, tutto questo bailamme non ricopre completamente la facciata della
basilica ma si arrampica sino ai due terzi di essa, dove un gruppo di finestre variamente sagomate
disegna una raffigurazione molto stilizzata del Calvario. Al di sopra dell’apertura centrale in forma di
croce c’è solo più la liscia parete di pietra nuda e alla sommità della facciata c’è una superba galleria di
finestre cieche che pare irraggiungibile tanto è posta in alto. La lezione impartita dalla facciata di San
Michele è chiarissima : quaggiù ci sono tutte le cattiverie e le assurdità del mondo, lassù c’è la città di
Dio; al centro c’è il Crocefisso, unico tramite tra le due dimensioni. E siccome la chiesa funge da
succursale terrena della città di Dio, San Michele Arcangelo e due santi vescovi - raffigurati ciascuno al
di sopra di uno dei tre portali della facciata - mostrano ai fedeli la strada per accedere all’edificio sacro
passando indenni tra le atrocità terrene. Come si vede il messaggio non è poi così lontano da quello
trasmessoci dalla facciata dell’Abbazia di Vezzolano, ma se in quest’ultimo caso l’esposizione avveniva
molto sinteticamente attraverso la giustapposizione di poche figure altamente simboliche, sulla facciata
di San Michele si ammucchia sino alla saturazione una moltitudine di scene di forte impatto
emozionale ma povere di significati e molto probabilmente accostate in maniera del tutto arbitraria.
Alla straboccante ricchezza della decorazione non corrispondeva dunque un’adeguata profondità di
contenuti. E questo accadeva non in una chiesa qualunque ma nella cappella del Sacro Palazzo, vale a
dire l’edificio di culto annesso alla residenza dell’Imperatore in Italia. In San Michele Maggiore furono
incoronati diversi Re d’Italia, e tra di essi, come s’era detto tante pagine fa, anche Arduino d’Ivrea. La
basilica fu ricostruita e riattata più di una volta; offese del tempo a parte, l’aspetto con cui essa si offre a
noi oggigiorno è lo stesso che presentava nel 1155 quando vi ricevette la corona del Regno d’Italia
l’Imperatore Federico Barbarossa. Una considerazione prima di chiudere : credo concorderete con me
che si ha l’abitudine di considerare la facciata di una chiesa come se essa fosse il volto dell’edificio
sacro, l’elemento che maggiormente contribuisce alla sua identificazione, e riesce difficile immaginare
che è soltanto tra l’XI e il XII secolo che le chiese cominciano ad essere caratterizzate da facciate
appariscenti ed architettonicamente complesse. Prima d’allora la chiesa era concepita essenzialmente
in quanto contenitore, e al modo con cui essa si presentava all’esterno non veniva data quella grande
importanza. Semplificando al massimo, possiamo dire che quando ancora non avevano un volto le
chiese potevano essere sostanzialmente di tre tipi. C’erano innanzitutto le chiese a pianta radiale
(rotonda, ottagonale, dodecagonale e così via), di cui però non parleremo perchè questo genere di
edifici non ha mai avuto delle autentiche facciate; al massimo gli si appiccicava un porticato in
corrispondenza dell’ingresso principale, e buonanotte. Il secondo modello è quello tipico delle antiche
basiliche romane a pianta rettangolare; anche in questo caso veniva anteposto all’ingresso un porticato,
però questa volta esisteva una parete di facciata la cui parte superiore, incombente sul porticato, poteva
essere decorata con mosaici o pitture restando comunque una qualsiasi mezza parete liscia.
Aggiungiamo che il porticato poteva prolungarsi su quattro lati racchiudendo un cortile antistante la
chiesa, destinato ad accogliere i fedeli che ancora non avevano ricevuto il battesimo (mentre l’accesso
alla chiesa era riservato ai battezzati). Il terzo modello, un tantino più recente, è quello delle grandi
chiese abbaziali dell’epoca carolingia (tra IX e X secolo, per capirci). Da noi è poco considerato,
essendo diffuso principalmente nell’Europa centrale e settentrionale, ma è molto importante perchè è a
partire da esso che le facciate delle chiese cominciano ad assumere una loro fisionomia specifica ed un
ruolo protagonista. La cosa potrebbe sembrare strana giacchè queste chiese non avevano, all’inizio,
assolutamente nulla che potesse anche solo somigliare ad una facciata : esse erano infatti chiuse da
absidi tanto all’estremità orientale che a quella occidentale. Raddoppiando le absidi, raddoppiavano
anche i transetti, e siccome sull’incrocio tra navata centrale e transetto si usava edificare una massiccia
torre che fungeva da lucernario, mentre ai lati della parte absidale si innalzavano di norma due snelle
torrette che contenevano scale a chiocciola, anche le torri raddoppiavano, e queste chiese di maestose
proporzioni finivano per apparire come superbe ed inespugnabili fortezze, una versione marziale di
quella Città di Dio di cui rappresentavano le filiali in un’area geografica ancora scarsamente popolata e
relativamente insicura. Tenete presente che ai piedi di queste chiese sorgevano degli importanti
complessi conventuali che rappresentavano degli avamposti della fede e della cultura ma soprattutto
della colonizzazione agraria; se la case di Dio erano fatte in modo che il loro aspetto incutesse rispetto e
timore alle orde di pagani morti di fame che ancora vagavano per il continente in cerca di facili prede,
qualche buon motivo c’era. Combinando ed accorpando variamente gli elementi che componevano
l’estremità occidentale dell’edificio - torre, torrette, transetto ed absidi - queste chiese iniziarono, tra
l’Ottocento e il Mille, a caratterizzarsi individualmente; non si trattava ancora di vere e proprie facciate,
dato che i poderosi ed altissimi avancorpi non davano accesso immediato all’interno del tempio, ma
ogni chiesa presentava ora a chi vi giungesse un sembiante inconfondibile, a volte severo torrione, a
volte fiabesco castello. Da noi questa tipologia è praticamente assente : era forse dotata di un
massiccio corpo occidentale la basilica di Santa Maria Maggiore a Lomello, nel cuore della bassa
Lomellina, eretta attorno al Mille; però nel 1155 tale struttura fu pesantemente danneggiata dalle armate
pavesi, e il maestoso rudere che ne rimane non permette di trarre conclusioni inequivocabili sulla sua
fisionomia originaria. Altri esempi del genere io non ne conosco, ma questo non vuol dire che non ne
esistessero, giacchè dalle nostre parti gli edifici di grandi dimensioni anteriori al XII secolo giunti sani e
salvi fino a noi sono molto rari. Prima dell’affermazione economica e politica delle città marinare e
mercantili, l’Italia, lontana dai centri del potere, costituiva un’area periferica piuttosto arretrata :
l’edilizia era per lo più scadente e le grandi chiese edificate in quel periodo offrivano scarse garanzie di
stabilità, ragion per cui non appena l’economia ricominciò a tirare si provvide a ricostruirle più
solidamente e sovente non fu neppure necessario abbattere i vecchi fabbricati perchè erano già crollati
per conto loro.
Relativamente più numerose sono le chiese preromaniche di piccole e medie
dimensioni, e queste presentano sovente dei modesti avancorpi porticati che a seconda della forma e
delle dimensioni possono volta a volta ricordare - ma sempre piuttosto alla lontana - i porticati tipici
delle chiese romane oppure i corpi occidentali delle chiese abbaziali del nord. E’ certo invece che da
noi godette di una qualche fortuna la formula della torre campanaria addossata alla parete di facciata e
dotata alla base di un portale che dava accesso alla chiesa, un modello che molto probabilmente traeva
ispirazione dalle chiese nordiche. L’esempio più bello è quello della chiesa di Santa Maria del Tiglio di
Gravedona, in provincia di Como, che risale però al Millecento, un’epoca in cui si era ormai affermata
una nuova concezione dell’edificio sacro, che non era più chiuso su se stesso in posizione difensiva
rispetto agli assalti di un mondo signoreggiato dal Male, ma si apriva - anzi, si spalancava - alle folle dei
fedeli, a cui si rivolgevano ora come un invito le vaste facciate delle chiese, con le loro ricche
decorazioni. Cosa avesse determinato un simile e radicale cambiamento è facile da capire : le città
stavano prendendo il sopravvento sulla campagna, la visione del mondo gerarchica e paranoica tipica
delle vecchie aristocrazie militari iniziava a sgretolarsi ed emergevano i valori nuovi di comunità
fondate sulla libera associazione di individui che si sentivano tutti uguali di fronte a Dio.
L'ISOLA DI FRANCIONE
I
Nel territorio del comune di Confienza, al confine tra Lomellina, Vercellese e Basso Novarese, scorre
un piccolo corso d'acqua di origine naturale chiamato Strona. A pochi chilometri di distanza, nel
comune di Robbio, esiste una Roggia Strona. La parola roggia implica un certo grado di artificialità
perchè viene usata per indicare corpi d'acqua in movimento che vengono incanalati ed indirizzati qua o
là dall'uomo a seconda delle proprie esigenze. Nel caso specifico, però, la tortuosità del tracciato rivela
che l'alveo entro cui scorre la roggia è in massima parte di origine naturale.
Di origine
indiscutibilmente naturale sono i due torrenti Strona che una sessantina di chilometri più a nord
scorrono tra Alpi e Prealpi, l’uno nella provincia di Vercelli e l'altro in quella di Verbania.
Verosimilmente vetusta, la voce Strona è un termine generico che designa per l'appunto in modo
generico un corso d'acqua. Torrenti e fiumi, anche importanti, privi di un autentico nome proprio
sono numerosi nell’area padana occidentale; basti pensare alle Dore (il termine è diffuso anche al di là
delle Alpi in area francofona), alle Bormide (a cui si accompagnano Borbore, Borbera e Taborba), alle
Nizze, alle Verse, alle Sture. Presumo che prima dell’arrivo dei Romani e della latinizzazione, da
queste parti non si sentisse particolarmente la necessità di individuare le entità geografiche con nomi
propri differenziati e ci si limitasse a designarle con i nomi comuni più appropriati. Del resto nelle
campagne questo vale ancora oggi: un ambito rurale circoscritto che abbia una precisa percezione dei
propri confini definisce di preferenza nel modo più generico possibile le proprie componenti : "nella
valle", "sul piano", "il rio", "i boschi", "i prati", "la piazza", "in fondo al paese", "le case nuove".
Credo anche che si possa dire che l'esigenza di dare dei nomi propri ai luoghi si avverta solo o
principalmente quando vi è una consapevole volontà di trasformazione del territorio : guerre e
conquiste ma anche interventi di colonizzazione agraria. Nel Basso Monferrato, in un’area di circa
cinquanta chilometri quadri (ma il continuo saliscendi tra ripide colline e valli tortuose la fa apparire, a
chi la percorre, molto più vasta di quel che essa sia realmente) si raggruppa una dozzina di località dalla
fisionomia molto differenziata che portano nomi ispirati a specie vegetali o a forme di coltura o ad
attività connesse all’agricoltura. Ci sono grossi paesi come Vignale, Rosignano ed Ottiglio, ed altri
meno consistenti, come Cereseto e Frassinello; c’è Olivola, che fa comune ma come paese è veramente
piccolino, ci sono i castelli di Uviglie e di Lignano e c’è anche il paese di Ozzano, citato nelle fonti
medioevali come Orzianum. Gli altri centri abitati che si ritrovano ad intercalare questo singolare
repertorio agrario portano anch’essi nomi significativi ma di altro genere, rinviando a particolari forme
di insediamento rurale : Sala, Treville e Cella (o Cellamonte). E c’è anche Camagna, la Casa Grande.
Insomma, in tutta la zona non c’è un solo paese che abbia uno di quei nomi scemi che non si riesce a
capire cosa significhino. Ora, di località che portano nomi di piante ce ne sono dappertutto, ma
sparpagliate e lontane l’una dall’altra; qui invece stanno tutte insieme come le vie dai nomi di fiori che
formano interi quartieri alla periferia delle grandi città. Difficile che si tratti di una pura e semplice
combinazione e le fonti storiche ci suggeriscono come possa essere andata. Nel 1014 (ma guarda che
combinazione) l’imperatore Arrigo restituiva alla Chiesa di Vercelli il castello e la terra di Cereseto,
usurpati da Braseverto, fedele del mancato re Arduino. Quindici anni prima un diploma di Ottone III
imperatore attestava l’autorità della Chiesa di Vercelli sul luogo di Ozzano. Un secolo più tardi i signori
di Frassinello, Rosignano e Cellamonte risultavano legati da rapporto di fedeltà al Vescovo di Vercelli a
cui ricorrevano per ottenere dall’imperatore Arrigo V la conferma delle proprie prerogative, e tale fedeltà
era ribadita ancora nel 1218 dai signori di Cella, sebbene essi fossero sottoposti ormai da settant’anni al
Marchese di Monferrato.
L’origine di queste località risalirebbe dunque alla sistematica
colonizzazione da parte della Chiesa di Vercelli di un’area che per la sua morfologia particolarmente
accidentata si era sottratta sino ad allora allo sfruttamento agricolo; quel che purtroppo non sapremo
mai è chi fosse il chierico dall’animo gentile che volle battezzare le cime di queste aspre colline con
nomi di piante e di fiori.
II
Più o meno consciamente tutti vorremmo che il nostro paesello natale avesse origini antiche e se
possibile illustri e questo spiega, ad esempio, perchè si siano promossi ad antichi Romani con elmo e
pennacchio tanti modesti toponimi di origine indiscutibilmente latina ma formatisi palesemente
nell’alto medioevo, in mezzo ai boschi e ai branchi di maiali. Pensate, per dirne una, a tutte quelle
località che hanno per nome dei numerali ordinali (i vari Terzo, Quarto, Quinto, Sesto, Settimo, per
capirci) che ci si ostina a voler credere risalgano al tempo di Roma Imperiale e delle sue strade che
miglio dopo miglio legavano un capo all’altro del continente. Un miglio corrisponde grosso modo a un
chilometro e mezzo, e a quattro miglia dalla veneranda città di Asti, fondata dai Romani e antica sede
vescovile, sorge il villaggio di Quarto; quattro chilometri al di là di Quarto c’è Annone, che è l’antico Ad
Nonum (sottinteso miliarum), cioè la nona pietra miliare.
Ora, nove meno quattro fa cinque, e
trattandosi di miglia son circa otto chilometri, e non quattro. Se i conti non tornano è perchè le nove
miglia di Annone sono state conteggiate da autentici Romani antichi a partire da dio sa dove (e questo
lo possiamo affermare con sicurezza perchè esattamente cinque miglia più in là c'è un altro paese che si
chiama Quattordio). Le quattro miglia di Quarto, invece, indicano la distanza del luogo dalla Cattedra
del suo Vescovo (che proprio a Quarto possedeva vigne, campi, boschi, cascine, armenti e quant'altro)
e sono state calcolate molto più tardi, nel medioevo. Del resto, che i toponimini non fossero coetanei
ce lo doveva già far supporre lo stato di avanzata decomposizione dialettale del nome Annone, in cui
l’origine latina si è fatta a malapena riconoscibile, quasi fosse uno di quei consunti rilievi che delle
antiche raffigurazioni conservano solo gli incerti profili.
III
Quand'ero più giovane (e più facilmente suggestionabile) mi capitava, di tanto in tanto, di ritrovarmi
ingenuamente ad almanaccare su quelle fungaie fitte fitte di toponimi accomunati da una stessa buffa
desinenza che spuntano qua e là sulla superficie delle mappe degli atlanti. Mi domandavo che razza di
dialetto si potesse parlare da quelle parti, o addirittura mi immaginavo che quei nomi strampalati
rappresentassero le sole testimonianze rimasteci di idiomi antichissimi parlati da popoli di cui si era
perduto ogni altro ricordo. In queste mie fantasie c'era innegabilmente qualcosa di vero, ma era il
ragionamento nel suo insieme ad essere farlocco, giacchè ero convinto - come molti, del resto - che a
tramandare per secoli e per millenni i nomi dei luoghi fossero state la voce e la memoria delle persone
che generazione dopo generazione vi avevano abitato. Purtroppo, questa è poco più che una bella
favoletta : quello di cui non tenevo conto (e che invece era necessario sapere) era che tutti i toponimi
antichi che erano sopravvissuti sino ai giorni nostri erano passati attraverso una serie più o meno lunga
di scritturazioni che ne avevano fissato la forma apportando inevitabilmente delle alterazioni più o
meno consistenti dell'originale. A monte di ognuno dei gruppetti di toponimi strani che avevano
suscitato la mia curiosità, in un punto situato tra i mille e i milletrecento anni fa, c'era un amanuense
che era stato incaricato di stendere in bella calligrafia la lista dei beni appartenenti al vescovo o al
monastero che all'epoca era il maggiore (se non l'unico) proprietario terriero della zona. E dovendo
dare l'impressione che l'elenco fosse redatto in latino, il buon amanuense aveva pensato bene di
storpiare in una maniera che suonasse convincente alle sue orecchie tutti i nomi di località rurali che
andava pazientemente trascrivendo. E' chiaro che la sto buttando un po' in barzelletta per alleggerire
l'esposizione, ma l'argomento è abbastanza serio : per secoli, salvo rarissime eccezioni, l'unica lingua
scritta è stata il latino, e dovendo riportare per iscritto una serie di parole per lo più prive di senso, mere
sonorità quali sono in genere i toponimi, gli scrivani si sentivano in dovere di sottoporle ad una sorta di
formattazione che le rendesse omogenee alla latinità del testo che andavano redigendo. Il sistema più
semplice consisteva nel subordinare il toponimo al termine locus, e bastava appiccicargli una desinenza
sulla coda per farne un aggettivo come Cesanus, Gallianus, Alzanus (sottinteso locus) o un genitivo
come Cesatis, Galliatis, Alzatis (sempre sottinteso locus); poi, a forza di darlo per sottinteso, del
sostantivo locus ci si è dimenticati e son rimasti i nomi Cesano, Galliano, Alzano, e Cesate, Galliate ed
Alzate. Il fatto che da toponimi di partenza che dovevano essere molto simili se non addirittura
identici si sia arrivati a forme nettamente distinte ci dice come non esistesse una regola prestabilita ed
ogni trascrittore risolvesse il problema a modo suo. Nei casi che vi ho proposto la latinizzazione
forzata si era mantenuta entro i limiti della ragionevolezza e del buon gusto, producendo risultati
decisamente plausibili, tant'è vero che molti sono convinti che toponimi come Cesano e Galliano
risalgano immancabilmente ai tempi di Roma antica. Non sempre però gli esiti erano così lineari ed
eleganti, e questo poteva dipendere dalla più o meno grande disinvoltura con cui lo scrivente
maneggiava il latino, o dalle sue personalissime perversioni estetiche, ma anche dalle difficoltà
oggettive che poteva comportare la trascrizione di certi toponimi che erano già di per sè ingombranti ed
imbarazzanti e costringevano il povero amanuense ai proverbiali salti mortali. Soprattutto quando
contenevano suoni non riducibili ai segni alfabetici di cui si faceva uso, che funzionavano benissimo
per fissare sul foglio le parole latine ma risultavano molto meno efficaci se si dovevano registrare e
riprodurre voci provenienti da quegli idiomi che erano in uso prima che arrivassero i Romani. Perchè
se è vero - e siamo così ritornati all'inizio del discorso - che esiste un gran numero di nomi di luogo che
hanno effettivamente uno spiccato carattere etnico, nel senso che sono riconducibili a questo o a quel
popolo dell'antichità, è anche vero che la forma appariscente e curiosa con cui questi toponimi possono
presentarsi è quasi sempre da addebitarsi all'estro di chi per primo si era trovato a doverli ridurre a
parole scritte (e che a seconda di come gli girava quella mattina poteva decidere di esaltarne i caratteri
più schiettamente barbarici o, all'opposto, di attenuarli sino a renderli irriconoscibili). Tra Alpi e
Prealpi sono comunissimi, per dirne una, i toponimi che contengono nella sillaba finale il gruppo
consonantico -gn- variamente combinato con tutte e cinque le vocali del nostro alfabeto. Sicuramente
riconducibili a strati linguistici prelatini, questi nomi raggiungono in certe zone una densità
impressionante. A monte di Novara, per esempio, nelle valli che gravitano su Sesia e su Ticino, si
incontrano Vegno, Pogno e Druogno, ma anche Vagna, Cravegna ed Alagna, e poi Germagno, Vocogno
ed Albogno, Cicogna, Vogogna ed Antrogna, Folsogno, Cossogno e Luzzogno, Carcegna, Intragna ed
Omegna, e via di questo passo, senza dimenticarci dei torrenti Vogna, Bogna, Agogna ed Artogna...
Un'analoga concentrazione di toponimi dello stesso tipo la si incontra, a dire il vero, anche in quella
fascia della Pianura Padana che è compresa tra Brescia, Cremona, Pavia e Milano, però non la si nota
per niente perchè è ben mimetizzata al di sotto di una latinizzazione piuttosto spinta. Basta infatti
mozzare la coda ai vari Brignano, Incugnate e Sergnano, Pognano, Antegnate e Cumignano, Trognano,
Calignano eccetra eccetra per vedere saltar fuori nomi che ricordano da vicino quelli che affollano le
valli dell'Ossola e la Valsesia. Non dobbiamo però commettere l'errore di pensare che questi ultimi
rappresentino delle forme genuine ed originarie, giacchè conosciamo almeno altri tre diversi metodi di
trascrizione a cui si è fatto ricorso per convertire in parole scritte i toponimi di questo tipo. Oggi che
le forme italianizzate si sono cristallizzate in maniera definitiva ed ufficiale (non dimentichiamo che i
nomi dei comuni sono fissati per legge) il legame tra questi diversi tipi di scritturazione non è così
evidente, ma sino a quando i documenti sono stati redatti in latinorum c'è stata una certa
interscambiabilità e poteva avvenire che lo stesso toponimo fosse trattato in maniera diversa da
scriventi diversi. Questo può significare solamente una cosa, e cioè che la gn e le forme alternative ad
essa che ora passeremo in rassegna erano solamente degli espedienti escogitati per ridurre a scrittura
un suono per il quale non esisteva un segno alfabetico appropriato. Vediamo la prima variante : un
ridotto numero di toponimi presenta al posto della gn il gruppo ni; a voler esser pignoli son due cose
piuttosto diverse, ma all'atto pratico Nonio e Gemonio suonano pari pari come Pogno e Cologno. La
seconda alternativa è esemplificata dal nome del torrente Olona; che facesse parte della stessa famiglia
dell'Agogna e dell'Imagna lo si capisce intuitivamente, ma più ad occhio, vedendolo scritto, che ad
orecchio. E' bastata infatti una normalissima enne per cancellare senza lasciare tracce l'impronta
atavica che caratterizzava così vistosamente il toponimo, e la stessa sorte deve essere toccata a parecchi
altri toponimi dello stesso gruppo, resi irriconoscibili dopo il trattamento. E' stata una specie di
pulizia etnica condotta a suon di enne ma senza che ce ne fosse l'intenzione; semplicemente questo era
il metodo più sbrigativo per togliersi dall'impaccio. La terza ed ultima alternativa è rappresentata dalla
doppia enne che caratterizza i nomi di un certo numero di località della Lombardia settentrionale.
Questa forma di trascrizione è sicuramente molto antica : Chiavenna è già segnalata come Clavenna nel
grande atlante stradale del IV secolo conosciuto col nome di Tabula Peutingeriana, una
rappresentazione molto stilizzata ma straordinariamente efficace dei collegamenti che permettevano di
spostarsi celermente da un capo all'altro dell'Impero Romano. Non foss'altro che per il rispetto che si
deve all'età, c'è da credere che la doppia enne fosse il grafismo che maggiormente si avvicinava al
suono che intendeva registrare e riprodurre, forse la tremenda enne faucata che si pronuncia lasciando
la mandibola allentata, come se si tenesse in bocca un sorcio vivo e non lo si volesse lasciar scappare
(una cosa per noi priva di senso ma che in una società primitiva di raccoglitori che cercavano di
integrare una dieta di vegetali selvatici catturando tutto quel che si lasciava prendere poteva essere
un'evenienza da contemplare).
I toponimi che portano la doppia enne nel finale hanno una
distribuzione geografica molto particolare. A parte qualche sporadica presenza nell'alto Piemonte ed
in Trentino, questi nomi sono peculiari della Lombardia e si incontrano da un estremo all'altro della
regione, anche se soltanto a monte di Brescia, di Bergamo e di Milano. L'area complessiva in cui essi
sono diffusi è dunque vastissima, però i pochi ambiti circoscritti in cui essi sono effettivamente presenti
ne coprono una percentuale davvero minima, giacchè si tratta quasi sempre di allineamenti più o meno
lunghi e più o meno fitti, formazioni singolari che non possono certo essere frutto di casualità. Se li
riportiamo su di una mappa è facile infatti constatare come una parte di essi ricalchi sicuramente
direttrici di traffico che hanno mantenuto la loro importanza dall'antichità sino ad oggi, ed è
quantomeno verosimile che la parte rimanente evidenzi anch'essa vecchie direttrici di portata più
locale.
Caronno e Saronno si trovano sul tracciato che univa Como a Milano; Crenna, Caronno
Varesino, Castronno, Ganna e Manno sulla direttrice che da Gallarate portava a Bellinzona toccando
Varese; Ardenno, Berbenno e Andevenno si susseguono nella bassa Valtellina, Chiavenna sta sul bivio
che istrada da un lato verso lo Spluga e dall'altro verso l'Engadina; Erbanno, Bienno, Malonno, Monno
e Zoanno risalgono la Val Camonica sino al passo del Tonale. Alcuni allineamenti seguono tratti delle
sponde del Lago di Como; un altro taglia di sbieco il massiccio che separa i due rami meridionali del
lago e toccando Crevenna, Scarenna e Cranno punta in direzione di Onno, sulla riva del braccio
lecchese; un altro ancora, che ha un andamento più incerto e comprende Schianno, Vogonno e
Capronno, pare suggerire un collegamento tra Como e l'imbarcadero di Angera, sulla sponda del Lago
Maggiore. Sulla riva opposta - in Piemonte - c'è Arona, e subito a monte di questa c'è Talonno. Un
allineamento parte da Como e pare dirigersi verso Bergamo ma si esaurisce a mezza via dopo aver
incontrato Senna, Brenna e Nibionno. Consonno e Carenno, sulle sponde opposte del piccolo Lago di
Olginate da cui ha inizio il tratto di pianura dell'Adda, evidenziano forse la posizione di un significativo
punto di guado. Tutti insieme, i nomi di queste località ricompongono dunque un disegno coerente e
vediamo riaffiorare ampie porzioni di una complessa rete di strade e vie d'acqua, probabilmente molto
antica.
Praticamente è un fossile, anche se di un genere molto particolare, essendosi formato
all'interno di una paccata di strati di pergamena che ne hanno conservato l'impronta. Mettiamoci per
un attimo nei panni di chi mille o millecento anni fa teneva sotto controllo l'una o l'altra di quelle strade
o rotte lacuali; ogni volta che una nuova dinastia assurgeva al trono oppure quando un pretendente
contestato aveva ragione dei suoi rivali, ci si preoccupava di farsi immediatamente riconfermare per
iscritto dal nuovo sovrano le prerogative ed i benefici legati al ruolo che si esercitava. Ed ogni volta
l'immancabile elenco di località che accompagnava l'enunciazione delle volontà del Sire veniva copiato
pari pari da quello della volta precedente, che era uguale identico a quello della volta prima, e così via a
ritroso sino all'epoca in cui la doppia enne era la forma consueta di trascrizione dei nostri toponimi,
vale a dire - ce lo insegna la precoce citazione di Clavenna - fino ai giorni della dominazione romana.
Questo era un puro gioco d'immaginazione, ma d'altra parte è il solo modo in cui riesco a spiegarmi
perchè tra le miriadi di toponimi appartenenti alla famiglia soltanto quei pochi (e solamente lì dove si
trovano) hanno conservato nella sillaba finale la doppia enne. In questa ipotesi non ci sarebbe
comunque nulla di particolarmente fantasioso giacchè una parte ragguardevole dei beni della Corona
dei sovrani medioevali era costituita proprio da quel che rimaneva del demanio romano : avanzi delle
immense proprietà imperiali e beni pubblici veri e propri, tra i quali infrastrutture come strade, ponti,
traghetti, imbarcaderi e così via. Non essendoci più uno stato vero e proprio che potesse assicurarne il
funzionamento, il monarca avveduto ne concedeva la gestione a soggetti degni di fiducia (in primis
naturalmente i Vescovi) e a questi andavano dazi, pedaggi, noli e quant'altro era dovuto da chi ne
usufruiva. In realtà la concessione del sovrano era quasi sempre un pro forma : di fatto si confermava
la facoltà di esercitare una funzione di pubblica utilità a chi già la esercitava ed aveva dimostrato in
concreto di saperlo fare bene, anche perchè lo faceva da parecchio, e talvolta poteva attestarlo
producendo una documentazione che tanto più rimontava indietro nel tempo tanto più faceva fede.
Immaginare però - come abbiamo fatto noi - che la catena dei documenti potesse risalire senza
spezzarsi sino all'origine, quando a garantire che strade e battelli funzionassero era Roma stessa
(oppure, detto con altre parole, supporre una continuità dell'attività amministrativa anche nei momenti
più bui del primo medioevo) può sembrare un tantino romanzesco ma non è fantascientifico. E'
innegabile che vi sia stato nella storia e nella geografia dell'Italia padana uno sbrago tremendo apertosi
tra il 535 e il 553, nei diciotto anni che durò la guerra tra gli Ostrogoti ed i Greci. I Goti avevano retto
validamente l'Italia per quasi mezzo secolo in nome e per conto dei Greci, e adesso i Greci volevano
riportare l'Italia sotto il loro diretto controllo; da sessant'anni non esisteva più un Imperatore
d'Occidente, eppure la macchina dello stato non aveva cessato di funzionare e lo standard di vita
romano era rimasto elevatissimo anche sotto i Goti. Con la guerra e con la terribile pestilenza che ad
essa fece seguito, tutto questo ebbe fine. I Greci ebbero la meglio ma ormai l'Italia era solo più una
postazione da tenere; quindici anni dopo la loro vittoria, l'effettivo controllo militare che i Greci
esercitavano sulla Pianura Padana si riduceva ad una fascia di sicurezza posta a tutela di Ravenna e che
comprendeva il basso Veneto e l'Emilia orientale; tutti gli altri si dovevano arrangiare. E difatti
quando i Longobardi penetrarono in Italia non trovarono neppure una parodia di esercito che facesse
finta di contrastarli.
Occupato il Friuli, però, la loro avanzata si incanalò forzatamente entro un
corridoio limitato a sud dalla linea difensiva dei Greci e a nord dalla catena delle Alpi e dai solidi reami
barbarici che Burgundi, Alamanni e Bavari vi avevano creato; se provavano ad avvicinarsi a Ravenna o
se tentavano di risalire le valli alpine, le bande armate dei Longobardi rimbalzavano indietro come le
bocce sulle sponde del biliardo.
L'impressione che se ne trae è che fossero lasciate libere di
scorrazzare entro un'area ormai talmente disastrata che era impossibile provocarvi danni ulteriori. E'
difficile spiegare in un altro modo la velocità con cui i Longobardi si impadroniscono della Pianura
Padana : una dopo l'altra le città cadono senza che ci sia bisogno di combattere, e i Signori della Guerra
- i Duchi - vi si asserragliano come se fossero recinti murati entro cui non abita più nessuno. Solo in
qualche rarissimo caso si percepisce la presenza di comunità ancora sufficientemente ricche ed
organizzate da riuscire a patteggiare una ragionevole convivenza con gli occupanti : il Vescovo di
Treviso affronta a viso aperto i nuovi arrivati ed ottiene il rispetto dei beni della sua Chiesa; Pavia resiste
per tre anni e tre mesi all'assedio e quando finalmente spalanca le porte le viene risparmiato il
saccheggio. In seguito se ne attribuirà il merito al Padreterno che avrebbe frenato l'ira di Re Alboino
azzoppandogli il cavallo mentre stava entrando in città, ma è più verosimile che in quei tre anni i
Longobardi avessero avuto modo di fare le loro considerazioni sui vantaggi che presentava lo stile di
vita dei Romani. C'è poi il caso del Generale Francione, che si era arreso ai Longobardi solo durante il
regno di Autari, più di quindici anni dopo l'inizio dell'invasione. Francione era stato un comandante
delle forze armate greche, ma da vent'anni si era messo in proprio alla guida di un esercito personale
con il quale si presume - anche se le fonti non lo dicono espressamente - che avesse continuato a fare la
guardia ad una qualche importante fetta di territorio. Più che una sconfitta vera e propria, la resa di
Francione pareva un passaggio di consegne laboriosamente concordato : il Generale era rimasto
asserragliato per sei mesi nell'imprendibile Isola Amacina ed alla fine gli era stato concesso di riparare
a Ravenna insieme con la moglie e con il suo patrimonio personale. Lo storico Paolo Diacono che ha
raccontato l'episodio riferisce anche che dopo la sua partenza i Longobardi avevano ritrovato nell'isola
ingenti tesori che vi erano stati riposti da numerose civitates. Questo particolare confermerebbe che
Francione aveva tenuto sotto controllo un territorio ampio e piuttosto ben organizzato : l'isola sarebbe
stata infatti la cassaforte delle comunità poste sotto la sua tutela. Che si trattasse dell'Isola Comacina,
posta all'imboccatura superiore del braccio di ponente del Lago di Como, è opinione diffusa, ma il testo
di Paolo Diacono lo conferma solo indirettamente, nel senso che lo è lo stesso Paolo a dirci come nei
decenni seguenti l'Isola Comacina fosse stata di sicuro e più di una volta teatro di episodi analoghi.
Sotto il regno di Agilulfo successore di Autari, per esempio, il Duca di Bergamo Gaidulfo si ribellò al
suo sovrano e andò a rifugiarsi nell'isola, ma il Re non faticò eccessivamente a sbarcarvi ed a
sconfiggerlo .
La parte più interessante della storia però viene dopo : cacciato Gaidulfo, anche
Agilulfo scopre nell'isola grandi ricchezze che vi erano state nascoste dai Romani (testuali parole di
Paolo). Potrebbe trattarsi dello stesso tesoro della volta prima (Paolo non dice che i Longobardi se lo
fossero portato via) come pure di roba fresca accumulata nei pochi anni intercorsi tra l'uno e l'altro
assedio; sia come sia, Agilulfo non ci pensa due volte e se ne impadronisce, e dopo d'allora dei tesori
dell'Isola Comacina non se ne parla più, anche se l'isola sarà ancora toccata per un paio di volte da
vicende guerresche. Vi si rifugerà dapprima il buon Re Cunimondo per sfuggire alle insidie dell'infido
Duca Alachi, e poi l'illustre gentiluomo Ansprando - destinato a divenire re qualche anno più tardi braccato dal feroce usurpatore Ariberto. L'impressione che si trae da tutto questo via vai è che l'isola
non appartenesse a nessuno in particolare, nè a qualche Duca, nè tantomeno al Re : chi arrivava per
primo vi si trincerava, e se ne aveva la forza se la teneva. In effetti è molto probabile - ce lo suggerisce
la faccenda dei tesori - che l'isola fosse proprietà delle cittadinanze della regione del lago, così come è
probabile che Longobardi non esercitassero sul lago un controllo molto stretto, e preferissero
impicciarsi il meno possibile della gestione di una realtà troppo complessa ed evoluta per loro.
Pensiamoci un attimo : se un generale delle armate imperiali si era preso la briga di difendere la regione
per vent'anni, quando la maggior parte della Pianura Padana era stata abbandonata a se stessa, c'è da
credere che ne valesse la pena. Può darsi che il lago e il suo territorio fossero usciti in buone
condizioni dal disastroso periodo della guerra tra i Greci e i Goti : il fatto che i protagonisti degli episodi
che abbiamo citato scorrazzassero in nave su e giù per il lago potrebbe ad esempio significare che un
attività cantieristica di buon livello non si era mai interrotta, ma comunque fossero andate le cose è
fuori di dubbio che la posizione strategica lungo gli itinerari che conducevano fin nel cuore dell'Europa
doveva stimolare un'economia piuttosto vivace, incentrata su quella che oggi definiremmo la logistica.
E persino i Longobardi erano in grado di capire che taglieggiare (senza esagerare) una comunità
prospera e laboriosa era più vantaggioso che infierire su popolazioni ridotte allo stremo, e che di
conseguenza era meglio non andare a guastare un meccanismo ben collaudato che continuava a
funzionare a puntino per conto suo producendo benessere. Supporre che sul Lago di Como e nelle valli
circostanti il lungo periodo di buio compreso tra la fine dell'Impero Romano e la nascita del Sacro
Romano Impero di Carlo Magno se ne sia trascorso senza patire strappi particolarmente drammatici
non sarebbe dunque così azzardato. Sotto l'ala protettiva del valente Francione un'oasi di civiltà
romana era riuscita a sopravvivere sin quasi alle soglie del VII secolo. Ne conosciamo l'estensione
perchè corrispondeva all'area in cui sono diffusi i toponimi con la doppia enne; la controprova è nel
fatto che il limite meridionale di quest'area coincide esattamente con i confini del territorio che i
Longobardi avevano conquistato nella prima fase dell'occupazione : poco a monte di Brescia, di
Bergamo e di Milano i nomi di luogo con la doppia enne finiscono di colpo. Di qua c'erano i Duchi
longobardi arroccati entro le mura delle città; di là, tra le montagne, c'era Francione. Quando il
Generale consegna la sua regione agli occupanti, però, qualcosa sta cambiando : la parte più influente
dell'aristocrazia longobarda - presto seguita dalla maggioranza del suo popolo - si sta convertendo al
cattolicesimo, il che è come dire che anche i Longobardi, attraverso la mediazione degli uomini di
Chiesa, stanno entrando a far parte di un mondo organizzato e gestito principalmente per mezzo della
scrittura, e dunque non ci sarebbe nulla di così insensato nell'immaginare che sulle sponde del Lago di
Como non si fosse mai smesso, neppure nei momenti più travagliati, di formalizzare per iscritto ogni
atto che avesse una qualche rilevanza, e che non si fosse mai persa la lodevole abitudine di tenere in
buon ordine gli archivi, conservando col dovuto rispetto anche i documenti più vetusti.
IV
Fra tutti i toponimi più ridicoli e più sgraziati che esistano, un posto d'onore spetta senza dubbio a
quelli che hanno avuto la sfortuna di terminare con la desinenza -engo. Nella Val Padana centrale ed
occidentale se ne incontra un buon numero, quasi sempre raggruppati all'interno di aree circoscritte più
o meno vaste. Ve ne sono tra Verona e la costa del Lago di Garda (Bussolengo e Pozzolengo, per
citarne due soltanto), nella Bassa Bergamasca (Vidalengo e Pumenengo), nel Cremasco(Pianengo ed
Offanengo), nel basso Bresciano (Ovanengo e Farfengo), nel Cremonese (Ossalengo e Marzalengo), nel
Canavese (Barengo e Tonengo), nel Basso Monferrato (Aramengo ed Odalengo), nel basso Novarese
(Fisrengo e Pisnengo) e in quello alto (Morghengo e Sillavengo), nel Vercellese (Busonengo ed
Olcenengo) e nel Biellese (Vallanzengo e Mortigliengo). E' opinione diffusissima che le località che
portano nomi di questo tipo fossero - all'epoca - importanti insediamenti del popolo longobardo. E'
solo un luogo comune, però del tipo più insidioso, di quelli difficili da smascherare. E' indubbio infatti
che la forma con cui questi toponimi sono giunti fino a noi risalga all'epoca del dominio longobardo, ed
è anzi certo che siano stati proprio i Longobardi a battezzare in modo siffatto queste località (o a
ribattezzarle, essendo probabile che parecchi di questi toponimi già esistessero, sebbene privi della
desinenza che adesso si ritrovano appiccicata sul sedere). Però il problema non sta nel carattere etnico
di questi nomi, che è acclarato. Il problema sono gli insediamenti longobardi - specificamente
longobardi - che non sono mai esistiti. I Longobardi erano predoni e lo rimasero sempre; se volevano
diventare più ricchi non si mettevano a colonizzare della nuova terra ma si impadronivano di terra altrui
già coltivata. Perchè dovevano formare nuovi insediamenti quando si faceva la bella vita alle spalle di
quelli che esistevano già ? Il diritto del più forte permetteva loro di scorrazzare per la penisola
prendendosi tutta la terra che volevano ed andando a occupare le città fortificate, le proprietà private
più prestigiose, i beni di chiese e di conventi e quelli del Demanio Imperiale. In effetti questo fu quel
che fecero i Longobardi nei primi tempi dell'invasione. Poi, rimasti senza un Re, i maggiori capi
militari - i Duchi - trascorsero dieci anni facendosi la guerra tra di loro per portarsi via l'un l'altro quel
che prima avevano depredato ai Romani. Infine, resisi conto che il protrarsi dell'anarchia non avrebbe
portato a nulla di buono, si diedero nuovamente un Re - il battagliero Autari - e lo dotarono di un
Demanio privandosi ciascuno di metà dei propri possessi.
Tra i Beni della Corona a cui i Re dei
Longobardi erano più affezionati c'era la grande Selva Urbe, dove i sovrani si scatenavano in faticose
battute di caccia quando non ci si poteva sfogare con qualche bella guerra. Tra l'altro c'era anche il
vantaggio della comodità : dal Palazzo di Pavia si arrivava alla selva in poche ore senza stancare il
cavallo; la foresta si stendeva vastissima sull'una e sull'altra sponda del torrente Orba, nella pianura che
si stende tra Novi Ligure, Tortona ed Alessandria. E nel cuore della selva si trovava il bosco di
Marengo. Con ogni probabilità le zone in cui si concentrano i nomi che finiscono in - engo erano, ai
tempi, porzioni del Demanio dei Re longobardi. Almeno per una di esse - quella che si annida tra le
colline più elevate del Basso Monferrato - ne abbiamo la certezza perchè sappiamo che in antico era
sottoposta ad un Iudex, titolo che si dava ai funzionari che badavano ai regi patrimoni. Quella era la
terra del Re, un parco a tema molto esclusivo (ci si ammazzava per guadagnarsi il diritto di accedervi).
I suoi confini erano talmente ampi che il Sovrano poteva illudersi di galoppare nelle vastità senza limiti
da cui erano venuti i suoi antenati; le ricchissime partite di caccia che vi avevano luogo erano un
assaggio degli svaghi del paradiso dei guerrieri. Quindici anni dopo che erano arrivati in Italia i
Longobardi ragionavano ancora in tedesco; la donazione dei beni dei Duchi alla Corona era stata
senz'altro accompagnata da chilometriche elencazioni delle terre cedute al Re, e ad ogni nome veniva
aggiunto un suffisso che doveva essere il corrispettivo germanico del latino locus. Immagino fosse la
parola land, in posizione da genitivo sassone o quel che è; c'è da capire come abbia fatto a diventare un
risibile -engo. Che sia merito della parlata popolare è difficile crederlo; gran parte della terra del Re era
ammantata di fitte selve e sarebbe rimasta spopolata ancora per qualche secolo. E' più probabile che
la storpiatura sia da addebitarsi agli scrivani che avevano dovuto inventarsi un sistema per ridurre a
scrittura delle parole tedesche in un epoca in cui in tedesco non ci scriveva praticamente nessuno.
Questi toponimi debbono essere passati attraverso numerose trascrizioni, giacchè il demanio regio
longobardo era poi confluito in quello di Carlo Magno Re dei Franchi dei Romani e dei Longobardi, e
poi ancora, dopo varie traversie, nei beni della Corona degli Imperatori di Germania (e d'Italia), ma è
probabile che una volta inseriti nel database questi nomi non siano più stati modificati. La storpiatura
doveva essersi verificata all'origine, però non è detto che la primissima trascrizione fosse avvenuta in
diretta, mentre l'assemblea dei guerrieri acclamava Autari suo Re. In quel periodo i Longobardi erano
tutti analfabeti (e questo è normale) ma erano anche pagani ed avevano pessimi rapporti con quel che
restava del clero locale. Il che è come dire che non avevano alcun accesso all'universo della scrittura
con tutti i suoi portenti, dato che preti e monaci erano gli unici che ancora fossero in grado di
servirsene. Non che ai Longobardi glie ne fregasse molto; c'è da credere che all'incoronazione di
Autari non fosse presente neppure una persona capace di tenere in mano un calamo o una penna, e non
ci sarebbe da stupirsi se uomini degni di fiducia fossero stati incaricati di imparare a memoria la lista
delle terre che i Duchi - uno per uno - donavano al Re, per poi tramandarla nei tempi a venire, sempre e
rigorosamente a voce. E' possibile che il trasferimento dei dati su di un supporto meno volatile sia
avvenuto molto più tardi; i testimoni che sfilavano davanti allo scrivano avevano dimenticato quel poco
di tedesco che i nonni avevano insegnato loro, e quando venivano interpellati snocciolavano certe
filastrocche cadenzate nelle quali si susseguiva una quantità di toponimi ormai irrimediabilmente
conciati che facevano rima tutti quanti con balengo.
L’ABBAZIA
La casa dove sono nato si trova nella parte più alta del paese, quasi sulla sommità della collina, proprio
ai piedi dell’antichissima Abbazia. Se accidentalmente la frase che avete appena letto avesse evocato
sullo schermo della vostra mente qualche immagine particolarmente suggestiva, siete pregati di
cancellare tutto e di sostituire con questo : l’abbazia è un voluminoso scatolone le cui brutte pareti non
intonacate incombono con malgarbo sulle case sottostanti. Camminando per una qualunque delle
quattro viuzze che compongono il paese alto si ha come l’impressione di essere tenuti d’occhio
dall’ingombrante sagoma dell’edificio, onnipresente; basta alzare gli occhi ed è lì che spia, fra un tetto e
l’altro.
Bene, avete appena incrociato lo sguardo col volto del potere, ovviamente come lo
sperimentavano, all’epoca, gli abitanti di qui. Fino al Settecento, infatti, Signore del paese era l’Abate,
e anche quando l’abbazia fu soppressa le cose sostanzialmente non mutarono; ancora ai tempi che mio
padre era ragazzo spadroneggiavano certi parroci autoritari e ficcanaso, talora disonesti e schiettamente
prepotenti. In genere da queste parti a dominare un paese è un castello; salendo verso di esso è facile
incontrare un bel cancello che lascia intravedere un piccolo parco ombroso, e al di sopra di muretti e
muraglioni spuntano palme o allungano i rami superbi cedri del libano. Frivolezze che non avrebbe
senso attendersi da un clero che era proverbiale per la sua avarizia, e se è vero che il buon esempio o il
cattivo vengono dall’alto, ecco che si spiega perchè il mio paese visto dal di dentro è così brutto.
Spostiamoci all’esterno di esso e arretriamo di qualche centinaio di metri per poterci fare un’idea
dell’insieme : l’abbazia e il paese alto sorgono su di un cocuzzolo che si drizza nel punto in cui
convergono tre lunghe creste collinari e sui crinali di queste si allineano le case del paese basso. Che
non è tanto bello neppure lui : lunghi stradoni fiancheggiati su entrambi i lati da facciate anonime;
rozzi portoni che danno accesso a vaste aie (quando invece nel paese alto le case hanno cortili
microscopici, se li hanno). Arretriamo ancora, diciamo di un paio di chilometri. Allontanandosi dal
paese le creste collinari si diramano e il leggero saliscendi che caratterizza il loro profilo si appiattisce
illusoriamente sino ad un’orizzontalità uniforme che però è interrotta qua e là da certe protuberanze a
panettoncino le cui sagome replicano, molto più in piccolo, la gobba a cui si abbarbica la parte alta del
mio paese con la sua abbazia. Sono scherzetti della morfologia dovuti alle alterne vicende della
modellazione fluviale, e ognuna di queste ridicole montagnole è imbruttita da una disordinata chioma
di robinie entro cui si nasconde un oratorio, cioè una chiesetta, piccola o piccolissima. Ai piedi della
montagnola, immancabilmente, si trova un gruppetto di cascine.
Le chiesette sono intitolate
rispettivamente a Santa Maria, San Pietro, Sant’Anna, San Vittore e Santa Cristina, la stessa schiera di
Intercessori al cospetto dell’Altissimo in onore dei quali era stata istituita l’abbazia. Destinati alla cura
delle anime dei contadini dipendenti del monastero, gli oratori marcavano vistosamente le terre su cui
questi vivevano e lavoravano. Le cascine che si vedono adesso son cosa recente, sono state edificate
dopo la soppressione dell’abbazia e la vendita dei suoi beni, ma prima d’allora, oltre ad esserne il
signore e il pastore, l’Abate era anche il padrone della più gran parte di queste colline. Non è un
commento malevolo come potrebbe sembrare, non necessariamente. Più d’una volta nel cuore del
medioevo più profondo il clero rimase l’unico soggetto economico significativo esistente sulla piazza e
gli toccò – tra le altre cose - di dover reinventare l’agricoltura. D’altra parte in quegli stessi frangenti
era anche l’unico soggetto che fosse dotato di valide forme organizzative e il solo capace di tenere in
vita qualcosa che somigliasse ad una cultura. La realtà in cui io che scrivo e voi che leggete ci
muoviamo poggia in larghissima misura su fondamenta che sono state gettate dalla Chiesa nel cuore
del medioevo. Tra di esse va annoverata, ovviamente, l’organizzazione del territorio. Se mettiamo
leggermente fuori fuoco la veduta che si allarga davanti ai nostri occhi e dedichiamo la nostra
attenzione soltanto al profilo delle colline ignorando i dettagli più minuti, vedremo disegnarsi una
mappa molto schematica ma chiarissima, come usava prima che la topografia diventasse una scienza
esatta.
La gobba più voluminosa indica la posizione dell’abbazia, le gobbette più piccole
rappresentano la galassia degli oratori che attirano la benevolenza celeste sulle proprietà terriere
dell’abbazia; le direttrici attorno a cui si è strutturato questo paesaggio furono tracciate, mille anni fa,
tenendo conto delle esigenze della cura delle anime, e il fatto che queste coincidessero con le esigenze
di una valida gestione patrimoniale non ci deve sorprendere : rifocillare gli atleti di Dio che pregavano
anche nel cuore della notte perchè il mondo non andasse in pezzi e il Nemico non prendesse il
sopravvento era la priorità logistica assoluta. Riaccostiamoci al paese ma questa volta portandoci alle
sue spalle. Quando sono molto ripidi ed eccessivamente ombreggiati – il che è abbastanza consueto –
i versanti settentrionali di queste colline sono lasciati incolti e si ammantano di una fitta macchia. Da
dove ci troviamo ora il paese non si vede e il massiccio parallelepipedo dell’abbazia appare fatto su nel
fogliame degli alberi; solo il robusto campanile si sottrae orgoglioso all’abbraccio della vegetazione.
Non è che un’illusione ottica, ma a vederla di qua, almeno per un attimo l’abbazia sembra essere
l’unico segno di presenza umana fra i boschi che avvolgono ogni cosa, e non si fatica a capire come in
un’epoca in cui il territorio non era ancora stato soggiogato dall’uomo essa potesse essere scambiata
per una succursale del paradiso : solide mura, preghiere e canti, dipinti, mosaici e soprattutto una
dispensa sempre ricolma di ogni ben di dio.
Si dice che la notte precedente la battaglia di Ponte Milvio l'imperatore Costantino sognasse una croce,
e che nel sogno una voce gli dicesse : “ In questo segno vincerai ”, cosa che il giorno successivo si
sarebbe puntualmente avverata, avendo l'imperatore provveduto a far marciare alla testa delle sue
truppe l'insegna della croce. E' noto che Costantino non fu un ingrato : lui, che cristiano non era, pose
fine alle persecuzioni contro i cristiani, e nel 313 riconobbe loro il pieno diritto di esprimere
pubblicamente la propria fede (che pochi decenni più tardi - ma guarda un po' che combinazione sarebbe diventata religione di stato ed avrebbe a sua volta soffocato tutte le altre fedi).
Per tutto il
Medioevo si credette che la riconoscenza di Costantino si fosse spinta al punto di donare al vescovo di
Roma tutto quel pezzo d'Italia che va da Ravenna a Latina, il che significava per il Papa una vera e
propria nomina a re di tutte quelle terre, certificata da tanto di pergamena e sigilli. Si trattava di una
patacca ben confezionata ma era comunque una patacca e si dovette attendere sino al XV secolo perchè
fosse riconosciuta come tale. Anche la visione notturna di Costantino è palesemente una leggenda ma
sbaglieremmo se la considerassimo soltanto un innocente svolazzo della fantasia : intenzionalmente o
meno, la leggenda maschera dietro a un prodigio una realtà molto più prosaica, e cioè che la
maggioranza degli ufficiali dell'esercito di Costantino era ormai convertita al cristianesimo. Le legioni
di Roma furono sempre uno straordinario veicolo di diffusione delle religioni : spedite ai quattro angoli
del mondo, ne tornavano stracariche di cultura aliena sotto forma di oggetti depredati ma anche di
costumi e di credenze. Fra le tecnologie belliche sviluppate dai Romani per assoggettare città e
nazioni una delle più sconcertanti era il rito che si celebrava per indurre gli dei del nemico a disertare e
passare dalla parte di Roma; noi possiamo riderci su, però i Romani vincevano quasi sempre ed erano
convinti che il rito funzionasse per davvero.
Le divinità dei popoli che entravano a far parte
dell'Impero trovavano in Roma una seconda patria e diventavano romane anch'esse. Tutto questo fu
vero sinchè durò quel sano politeismo che riconosceva la stessa dignità ad un numero tendenzialmente
infinito di entità sovrumane, alle quali Agrippa, genero di Augusto, dedicò il tempio del Pantheon, la
casa di tutti gli dei.
Cent’anni più tardi l’imperatore Adriano rinnovò l’edificio e lo dotò della
stupefacente cupola che simboleggiava la volta celeste. Ai tempi di Adriano, però, le cose erano già
cambiate, e il fatto che i credenti alzassero lo sguardo e lo spirito verso il cielo lo dimostra : gli Dei si
erano fatti gelosi e pretendevano dai loro fedeli una devozione intima ed esclusiva, prove di iniziazione
e riti segreti. Tutte cose che ben si addicevano alla condizione del soldato, sbattuto oltre i confini
dell’immaginabile. La comunanza di una fede molto coinvolgente rafforzava il cameratismo e aiutava
a tirare avanti in mezzo ad insidie ed imboscate, e tra gli ufficiali e la truppa dilagavano le credenze più
astruse. Straordinario fu il successo riscosso tra i militari dal virile culto di Mitra, il Dio orientale che
aveva dato origine a tutte le cose sgozzando un immane toro. La religione di Mitra si diffuse in tutta
l'Europa romana ma al suo trionfo si opponeva un limite intrinseco ed insormontabile: era vietata alle
donne. A decretare il successo del cristianesimo in Roma furono invece proprio le donne, nella
fattispecie le mamme e le sorelle degli ufficiali : mamme benestanti, spesso vedove, con un sacco di
tempo libero ed ansiose di dare un senso alle proprie giornate. E sorelle zitelle, che riscattavano la loro
sia pur dorata emarginazione andando spose al Cristo.
A CASA DI SANT’ALESSIO
Qualche tempo fa, trovandomi a Roma con degli amici mi capitò di entrare nella chiesa dei Santi
Bonifacio e Alessio, sull'Aventino. Una signora della comitiva ci stava costringendo a visitare tutti gli
edifici sacri che incontravamo nella nostra passeggiata, e la seguimmo per l'ennesima volta senza
troppo entusiasmo. La facciata seicentesca della chiesa non lasciava presagire nulla di buono e difatti
come fummo entrati ci trovammo di fronte al solito sciupìo di decorazioni barocche che alla lunga
provoca un moto di ripulsa non soltanto estetico e ti spinge irresistibilmente a simpatizzare coi luterani.
Una cappella ospitava la statua tanto bella quanto svenevole di un santo agonizzante, al di sopra della
quale era sospesa, ingabbiata in una grande teca di forma strana, un'ingombrante reliquia tutta nera
che un po' a fatica capii essere quel che restava di un'antica scala di legno. Improvvisamente mi si
accese nel cervello la proverbiale lampadina : il Sant'Alessio a cui era dedicata la chiesa non era un
Sant'Alessio qualsiasi ma era proprio quel Sant'Alessio che fu protagonista di una delle leggende più
popolari del nostro Medioevo. La storia è semplice ma funziona, e merita il successo che ha avuto :
siamo alla fine del IV secolo e Alessio, figlio del senatore Eufemiano, disdegna i lussi e gli ozi della casa
paterna, disdegna pure la giovane e bella sposa e parte per un lungo pellegrinaggio. Torna che sembra
un barbone; a casa sua nessuno lo riconosce e lui si sistema in un sottoscala e si adatta a campare di
avanzi. Dopo diciasette anni muore e solo allora la sua identità viene rivelata da uno scritto che il
poveretto si portava indosso: sorpresa generale, fiumi di lacrime, alleluia alleluia, la storia finisce qui.
Confesso di aver sempre creduto che si trattasse di una di quelle vicende talmente esemplari da essere
diffuse fin dalla più remota antichità in tutti i continenti sotto forma di mito o di favola; miti e favole
che poi tutte le letterature hanno rielaborato nei modi più disparati. In effetti è una storia che un poco
fa pensare a quella di Cenerentola, ma ricorda anche l’episodio di Ulisse che ritorna alla sua reggia e
soltanto il cane lo riconosce. Narrativa allo stato puro, insomma, ed io mi ero fatta l'idea che il povero
Sant’Alessio fosse uno di quei santi di fantasia - come San Giorgio o come San Cristoforo - che avevano
vissuto le loro prodezze e i loro drammi in un mondo di fiaba tutto inventato. Adesso invece mi
ritrovavo proprio a casa sua, a casa di Sant'Alessio in persona. La chiesa dei Santi Bonifacio e Alessio
fu edificata infatti dove sorgeva la dimora di Eufemiano e si trova, come ho accennato, sull'Aventino,
vale a dire quell'altura che s'innalza sulla sponda orientale di Tevere poco a valle dell'isola Tiberina.
Siamo dunque in pieno centro, ma il colle è una delle zone meno popolate della città, pur senza essere
un'area archeologica come il vicino Palatino. Sull'Aventino si vedono solo delle chiese, una dietro
l'altra e intervallate da ville che grandi giardini alberati nascondono all'occhio del passante. Immagino
che fosse così anche duemila anni fa : belle ville, bei giardini, e qua e là alcuni templi. Pochi residenti,
tutti benestanti (più, ovviamente, le numerose persone di servizio), tutti che si conoscono, poco
passaggio di estranei, salvo quando si celebrava una festa in qualche tempio (e se ben ricordo ce n'era
persino uno che ospitava l'associazione degli attori). Un po' di casino ma solo di tanto in tanto, il
giusto per non annoiarsi e fare un po' di folclore. Era come stare in riviera, anche se due passi più giù
c'era il porto, c'erano i mercati e c'era ogni ben di Dio da comprare, più che in qualsiasi altro posto del
mondo. Del resto, un poco più in là si alzava, ben in vista, la mole del Campidoglio con i suoi templi,
vale a dire il cuore di Roma e – conseguentemente - il cuore del mondo. Con l'affermarsi del
cristianesimo i templi caddero gradualmente in abbandono e alla fine si ridussero a cave per
l'estrazione di materiale edilizio di pregio. Le belle dimore invece rimasero, ma piano piano la
maggior parte di esse si tramutò in conventi e chiese. Già sul finire del IV secolo la nobile vedova
Marcella aveva fatto della sua casa sull'Aventino il primo monastero femminile di Roma. Marcella
morì nel 410, probabilmente in seguito ai maltrattamenti subiti durante il saccheggio di Roma da parte
dei Goti; per aver tentato di difendere la discepola prediletta Principia, la nobildonna era stata
malmenata brutalmente e non si era più ripresa dallo choc. In effetti il sacco di Roma fu uno
schiaffone di portata epocale : da signora del mondo qual'era, la città si era ritenuta sino ad allora
inviolabile e adesso scopriva che in realtà la sorte non le concedeva alcun privilegio. A differenza di
Marcella, Roma seppe comunque reagire bene e già nel 422 l'Aventino vide la costruzione della superba
basilica di Santa Sabina, eretta sul sedime prima occupato da una casa di abitazione e da due piccoli
templi. A paragone della maggior parte delle chiese romane, Santa Sabina appare piuttosto disadorna
ma conserva della sua decorazione originaria due elementi assolutamente strepitosi : una grandiosa ed
elegantissima iscrizione celebrativa realizzata a mosaico e la maestosa porta di ingresso abbellita da
raffinati bassorilievi.
I manufatti in legno così antichi sono molto rari, e rarissimi quelli così
ottimamente conservati. Le eccezionali condizioni in cui si trova la porta sono senz’altro dovute al
materiale di cui è fatta (che le guide turistiche dicono essere legno di cipresso) ma mi piace credere che
almeno in parte sia anche merito dell'aria dell'Aventino, che da sempre è considerata particolarmente
salubre. Nel cuore del Medioevo il poter godere del microclima di questa altura era diventato, più
ancora che in passato, un privilegio quanto mai esclusivo. Tutto il colle era occupato da conventi di
grande prestigio, ed i rarissimi laici che vi avevano casa appartenevano alla casta dei potentissimi. Nel
939 Alberico Principe di Roma donava il palazzo di famiglia sull'Aventino (in cui peraltro soggiornava
di rado) all'Abate Oddone di Cluny - uno degli ecclesiastici più influenti di tutta Europa - perchè vi
creasse il convento dedicato a Santa Maria, che è l'attuale priorato dei Cavalieri di Malta. Nel 977 papa
Benedetto VII insediava in quella che era stata la casa di Sant'Alessio il vescovo in esilio Sergio di
Damasco, che vi fondava il monastero di San Bonifacio presto diventato importantissimo come quartier
generale delle missioni per i paesi slavi (che rappresentavano in quell'epoca la nuova frontiera
dell'evangelizzazione). Nel 999 l'Imperatore di Germania e d'Italia Ottone III stabilì la sua reggia
sull'Aventino, proprio nei fabbricati del monastero di San Bonifacio. Ottone III, lo ricorderete, era
l'imperatore ragazzino alla cui morte Arduino marchese di Ivrea si proclamò re d'Italia. Ora possiamo
aggiungere che Ottone era un fanatico, tanto fanatico quanto la sua età, la sua corona e l'epoca
violentissima in cui viveva gli permettevano di essere, e anche un po' di più. Probabilmente l'aria
miracolosa dell'Aventino gli arrostì definitivamente il cervello, e i Romani che mal sopportavano
disciplina e autoritarismo gli si rivoltarono contro e lo cacciarono. A poca distanza da quella di
Sant'Alessio c'era la casa che la tradizione vuole fosse appartenuta ad Aquila e Prisca (o Priscilla) che
diedero ospitalità all'apostolo Pietro.
La loro dimora fu dunque uno dei primissimi focolai di
diffusione del cristianesimo in Roma, e anch'essa divenne una chiesa che esiste tuttora, intitolata a
Santa Prisca. In effetti non pochi tra i più antichi edifici di culto di Roma si reggono sulle fondamenta
di ricche residenze nelle quali veniva celebrata l'eucaristia durante il periodo di clandestinità, quando il
cristianesimo era ancora illegale. Queste chiese domestiche erano sparpagliate un po' dappertutto per
la città; senza entrare troppo nel dettaglio e limitandoci a sfogliare una buona guida turistica possiamo
citare le due case di Lucina nel Campo Marzio divenute poi le chiese di San Lorenzo in Lucina e di San
Marcello in Via Lata; la casa di Equitus, sul colle Oppio, dove ora sorge la chiesa di San Martino ai
Monti; l'abitazione dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, che sottostà alla chiesa omonima. Anche la
basilica di Santa Maria in Trastevere pare tragga origine da una chiesa domestica di cui si ignora il
titolare, mentre Santa Croce in Gerusalemme, presso l’Anfiteatro Castrense, occuperebbe il sito della
casa di Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino. La chiesa di Santa Susanna sul Quirinale sorge
dove erano le case di Gabino, padre della santa, e dello zio Caio, vescovo; la chiesa di Santa Cecilia in
Trastevere corrisponde alla casa della santa; quella di Santa Bibiana sull'Esquilino alla casa del prefetto
Flavio, genitore di Bibiana; quella di Santa Pudenziana, sul Viminale, alla dimora del padre Pudente,
senatore, che ospitò - lui pure - l'Apostolo Pietro.
Ovviamente buona parte di queste attribuzioni è
puramente leggendaria; il fenomeno delle chiese domestiche fu reale e determinante per l'affermazione
del Cristianesimo, ma le personalità esemplari a cui per tradizione esse sono intitolate sono in larga
misura inventate. L'Aquila e la Priscilla di Santa Prisca che accolsero San Pietro sono sicuramente una
replica del senatore Pudente, ma allo stesso tempo sono anche il doppione di una coppia omonima che
aiutò San Paolo e che è ricordata negli Atti degli Apostoli. La stessa venuta di San Pietro a Roma è
stata lungamente messa in dubbio dagli storici protestanti giacchè non vi è alcuna fonte antica, né sacra
né profana, che ne parli. Quanto al buon Sant'Alessio, è per davvero una creatura tutta letteraria,
protagonista di uno dei tanti racconti di origine orientale che una volta arrivati qui da noi erano costretti
a presentarsi come la vita di questo o quel santo, giacchè una narrativa profana noi non ce l'avevamo
ancora, immersi come eravamo nel più abissale integralismo religioso.
E' significativo che la
dedicazione a Sant'Alessio della chiesa sull'Aventino risalga soltanto agli inizi dell’XI secolo; alla sua
fondazione l'edificio era intitolato al solo San Bonifacio, e questo mi fa pensare che ad un certo punto la
Chiesa di Roma si sia data da fare a reinventare la propria storia (o la propria mitologia) cucendo
insieme leggende recuperate dalla tradizione locale o pescate dove e come capitava. Sicuramente
leggendaria è Santa Pudenziana; ad inventarla fu la fantasia popolare equivocando sulla definizione
Ecclesia Pudentiana, dove Pudentiana non è un nome ma un aggettivo che stava ad indicare che la
chiesa era sorta sopra la casa di Pudente. Ci tengo a precisare che se ho scritto che la chiesa è sorta
sulla casa non mi sono servito di un modo di dire ma ho descritto fedelmente come stanno le cose:
Santa Pudenziana esiste come chiesa dal IV secolo, ma le sue strutture murarie sono più antiche di ben
duecento anni, essendo prima appartenute ad un bagno pubblico costruito all'epoca dell'imperatore
Adriano.
Orbene, il pavimento di Santa Pudenziana, che si appoggia sulle piscine del piccolo
stabilimento termale, sta nove metri più in alto di quello che era il livello del suolo nel I secolo, vale a
dire ai tempi di Nerone, di Pudente e di San Pietro, e sotto alla chiesa c'è una casa proprio di
quell'epoca, con le strutture murarie pressochè intatte, pavimenti e soffitti compresi. Questi locali
furono scoperti nel 1870 e furono resi perfettamente agibili grazie all'asportazione di migliaia di metri
cubi di macerie con le quali erano stati colmati. Nulla ci vieta ci credere che si tratti veramente della
casa di Pudente ma non dobbiamo dimenticare che le terme che nel II secolo avevano seppellito la casa
si tramutarono in chiesa solo alla fine del IV secolo, quando Roma era ormai cristiana. Tra la chiesa
domestica di Pudente – ammesso che di questa veramente si tratti - e la soprastante chiesa di Santa
Pudenziana c'è dunque contiguità spaziale ma non c'è una diretta continuità storica : per duecento
anni - che sono tantissimi - in questo luogo non si badò più alla salute delle anime ma solo al benessere
dei corpi. D'altra parte è del tutto verosimile che durante il lungo periodo della clandestinità il popolo
cristiano di Roma avesse serbato con la massima cura una precisa memoria delle proprie vicende più
antiche. el nostro caso, ad esempio, il ricordo di dove si trovasse la casa di Pudente si sarebbe
conservato esattamente anche se la casa si era eclissata inabissandosi nel suolo (e nessuno sapeva che
essa esistesse ancora, seppure colma di rottame). E' anche vero, però, che a Roma sotto a qualcosa c'è
sempre qualcos'altro (in nessun altro posto al mondo la storia si apparenta così strettamente alla
geologia) e la coincidenza tra la chiesa e la casa su cui si regge potrebbe anche essere del tutto fortuita;
vedete voi quale ipotesi vi sembra più plausibile. Riguardo alle vicende urbanistiche ed edilizie di
Santa Pudenziana resta da dire che da allora ad oggi la città si è ulteriormente alzata e ai nostri giorni
l’ingresso della chiesa si trova un tre o quattro metri più in basso rispetto alla strada che le transita
davanti, e per accedere al cortiletto prospiciente l’edificio sacro occorre scendere un paio di rampe di
scale. Per quanto concerne invece gli aspetti storici dobbiamo osservare che Santa Pudenziana è in
assoluto una delle chiese più antiche di Roma e se la tradizione relativa a Pudente avesse qualche
fondamento storico, quasi sicuramente la chiesa domestica del senatore sarebbe da considerarsi il più
antico luogo di culto cristiano della città. Eppure, a dispetto di tante benemerenze, Santa Pudenziana
è tra le chiese meno conosciute della capitale e confesso che anch'io non mi sarei mai sognato di
andarla a cercare e di visitarla se non avessi letto del suo mosaico absidale, che in effetti merita di essere
visto perchè è molto antico ed è anche molto particolare, essendo ancora legato a quel naturalismo che
era tipico della grande pittura romana dei primi tempi dell'impero.
Gli splendidi mosaici che
abbelliscono tante chiese di Roma non sono conosciuti come meriterebbero ed il motivo è molto
semplice e quasi banale : in città c'è troppa roba da vedere e gli itinerari turistici alla fine privilegiano,
sensatamente, quel che è più facile da presentare, anzi quel che si presenta da sé, nel senso che è
maggiormente capace di imporsi all'attenzione del visitatore : la Roma Imperiale, la Roma
Rinascimentale e la Roma Barocca. La Roma Medioevale - che pure è dappertutto - si vede poco,
anche perchè l'hanno ridotta a brandelli : prima la Roma Barocca l’ha seppellita sotto colate di marmi,
poi la Roma Imperiale (non quella degli antichi Romani ma quella di Mussolini) si è abbattuta su di
essa a colpi di piccone, e il Duce medesimo si fece fotografare mentre assestava la prima botta alle
vecchie case di non ricordo quale rione. Un giro turistico della Roma medioevale non è la cosa più
comoda del mondo, e per affrontarlo ci vogliono dei validi motivi. Ad esempio visitare Roma durante
la settimana di Pasqua. Più di un chilometro di coda per entrare in San Pietro, tre o quattro per i Musei
Vaticani, Fontana di Trevi inavvicinabile a qualsiasi ora del giorno e della notte; davanti al Pantheon
una moltitudine di turisti, tutti in piedi, attende che finisca la messa per poter entrare. Non c'è
scampo, bisogna ripiegare su itinerari alternativi. A complicare le cose c'è pure la Maratona, la città è
segata in due dalle transenne; i varchi sono pochi e la folla vi si accalca disordinatamente. Uno di essi
si apre ai piedi della vertiginosa scalinata dell'Aracoeli, sui cui gradini si accasciano nugoli di turisti
sfiniti. Salire all'Aracoeli - l'Altare del Cielo - dà l'impressione di arrampicarsi su di una piramide
cerimoniale di qualche remota civiltà, ma il paragone in effetti è riduttivo, giacchè stiamo scalando il
Campidoglio, che è un'autentica montagna sacra. Ovviamente, in cima alla scalinata non c'è un altare
pagano ma una bella chiesa dedicata alla Madonna e costruita nei primissimi secoli del Medioevo. La
chiesa è vasta, dentro ci sarà si e no una quindicina di persone, quasi invisibili nella penombra delle
navate laterali : un paio di gruppetti che bisbigliano, qualche coppia che sussurra, alcuni visitatori
solitari. Più o meno lo stesso numero di persone - quindici, venti, massimo venticinque - lo abbiamo
incontrato in quei giorni tutte le volte che abbiamo messo piede in una delle principali chiese
medioevali di Roma : così in Santa Sabina, così in Santa Prassede, così persino in San Giovanni in
Laterano; in Santa Maria Maggiore c'era senz'altro più gente ma la chiesa è talmente enorme che
sembrava quasi deserta. Era come muoversi attraverso una Roma parallela, scarsamente comunicante
con quell'altra Roma in cui ogni tanto ci capitava improvvisamente di riemergere : a San Pietro in
Vincoli, ad esempio (che pure non è una delle massime attrazioni della città), i turisti arrivavano
incessantemente, a vagonate; schiamazzavano un po' davanti alla celebre statua di Mosè e poi cedevano
il posto ad altre comitive. Forse in nessun luogo la lontananza tra queste due Rome si lascia misurare
così bene come a Santa Maria in Cosmedin : dentro la chiesa la solita quindicina di visitatori col naso in
su a guardare i bellissimi affreschi; fuori, sotto il portico, una fiumana di turisti asiatici in coda per farsi
fotografare con la mano nella Bocca della Verità; due o tre alla volta, se no a quest'ora sarebbero ancora
là.
Quindici o venti persone in ogni chiesa che visitavamo fanno comunque una media non
disprezzabile; noi, però, ci spingemmo ancora oltre, fino a quelle chiese in cui di turisti ne entrano
davvero pochi, vuoi perchè non gli avanza il tempo, vuoi perchè non sanno neppure che esistano. In
San Giorgio in Velabro, la malinconica chiesetta che nel 1993 fu vittima di un incomprensibile attentato
dinamitardo, una coppietta tubava sotto lo sguardo benevolo di non ricordo quali Entità Paradisiache
raffigurate nel catino absidale, e ci ritraemmo in punta di piedi per non guastare quel loro momento di
tenerezza. In Santa Pudenziana non c'era nessuno; per acquistare la guida della chiesa dovetti, con
molto rincrescimento, andare a rompere le scatole al custode che si godeva un po' di sole seduto nel
cortiletto antistante. Anche ai Santi Giovanni e Paolo non incontrammo nessuno, ma forse era colpa
dell'ora tarda. Ai Santi Quattro Coronati, al contrario, di turisti ce n'erano, e non erano visitatori
casuali, perchè i Quattro Coronati è fuori mano e non ci si arriva per sbaglio; chi ci va è certamente
mosso da un qualche suo demone bizzarro. L'incontro con questi viaggiatori provenienti da galassie
mentali remote ci confermò che avevamo raggiunto per davvero un punto limite, una postazione di
frontiera. Ma procediamo con ordine : tanto per cominciare, quando arrivate ai Quattro Coronati vi
dimenticate di essere a Roma e vi pare di trovarvi in un qualsiasi paese di collina di una qualunque
regione d'Italia, e neppure un paese dei più belli, giacchè c'è un'aria di trascuratezza che non invoglia.
Più che un monastero, i Quattro Coronati sembra un castello, ma di quelli brutti, fatti a scatolone. Se
però, come noi, siete arrivati da dietro arrampicandovi per la salita, già avete potuto rendervi conto
dell'imponenza minacciosa del fabbricato e siete pienamente convinti che come castello esso meriti il
massimo rispetto. Così come lo si vede adesso, i Quattro Coronati è il risultato di lavori protrattisi per
un centocinquant'anni, dagli inizi del Millecento alla metà del Duecento. Per la verità, una chiesa
esisteva in questo luogo già dal V secolo e fors'anche da prima, e pian piano era diventata una delle più
prestigiose di Roma.
Nel 1084, però, era andata distrutta per opera delle armate di Roberto il
Guiscardo. Il condottiero normanno, venuto in soccorso del papa che i Romani in rivolta tenevano
assediato nel Palazzo Laterano, e per fare un lavoro ben fatto aveva fatto radere al suolo tutto quello che
esisteva tra il Laterano e il Colosseo, qualche chilometro più giù. La catastrofe ebbe tre conseguenze
significative : quest'area tornò per vari secoli allo stato di aperta campagna; l'altura su cui si trovavano i
Quattro Coronati venne ad assumere una certa rilevanza dal punto di vista militare; i Quattro Coronati
fu riedificato come convento e si pensò bene di strutturarlo come se fosse una fortezza, destinata a dare
rifugio al papa qualora il palazzo del Laterano, sua residenza abituale, si fosse reso poco sicuro. Non
so se il monastero sia mai stato effettivamente coinvolto in avvenimenti bellici ma sono certo che
nell'evenienza l'edificio se la sarebbe cavata egregiamente. Tutto questo per dire che i Quattro
Coronati è un monumento tanto complesso quanto la sua storia, e infatti quando varcate il portone
d'ingresso e penetrate nel cortile stretto tra alte pareti, avete ben chiaro che di cose da vedere ce ne sono
parecchie : c'è la chiesa, c'è l'oratorio di San Silvestro, c'è il chiostro con la cappella di Santa Barbara, e
c'è la cripta. Prima, però, c'è da capire dove bisogna andare. Al primo cortile, infatti, ne segue un
altro, e su entrambi grava la stessa sconsolante impressione di sciatteria; per un istante vien fin da
chiedersi se per caso non abbiamo sbagliato portone. Ci sono dei cartelli indicatori ma per rintracciarli
sarebbero utili degli altri cartelli indicatori. Comunque, una volta trovati i cartelli il problema diventa
cosa si deve fare, perchè il complesso monumentale è inserito in un convento di suore di clausura, e per
visitare chiostro, oratorio e cripta bisogna chiedere ogni volta il permesso alle monache (che essendo
monache di clausura non si lasciano vedere). Il concetto è chiarissimo : stiamo rompendo le scatole.
Per visitare l'oratorio di San Silvestro, che è una cappella separata dalla chiesa, bisogna prima entrare in
una stanza demenziale sulle cui pareti, in bei caratteri gotici rossi e neri, è dipinto tutto il calendario
liturgico, come se l'ambiente fosse stato tappezzato con quattro enormi paginoni miniati. Qui bisogna
avvicinarsi ad uno sportello chiuso e suonare un campanello elettrico (la cosa più moderna che ci sia
qua dentro). Lo sportello si apre, si posa l'offerta e la mano di una suora la raccatta; l'altra mano della
suora schiaccia qualche pulsante e nella parete opposta si apre la porta dell'oratorio. La cappella,
bisogna dirlo, è molto bella : c'è un ciclo di affreschi del Duecento che è citato in ogni libro di storia
dell'arte, e ci sono anche delle pitture rinascimentali, meno note ma fin più belle. Dentro ci sono già
due ragazze; di che nazionalità possano essere non avremo modo di saperlo, giacchè non diranno una
parola ma continueranno per tutto il tempo a saltellare di qua e di là scattando fotografie e
contorcendosi nelle maniere più astruse per riuscire a cogliere qualche angolazione bizzarra. Noi
usciamo e le tipe restano lì ad agitarsi, saltano sulle panche, si aggrappano ai pilastri, se potessero si
arrampicherebbero sui muri. Ripassando per il cortile entriamo nella chiesa, che è buia ma ha un
pavimento tanto lucido che rapisce lo sguardo e impedisce di notare che l'ambiente è opprimente e le
pitture bruttine. Sono peccati veniali quando si possiede un pavimento così straordinario, nel quale si
trova incastonata un'infinità di frammenti di lapidi funerarie, tantissime delle quali incise : ci sono
accenni di decorazione, brandelli di iscrizioni, i nomi dei defunti, la loro età, chi resta a piangerli.
All'improvviso entra, rumorosamente, una piccola comitiva e pensiamo bene di accodarci, giusto per
avanzarci la pena di chiedere alle monache di aprirci il chiostro e la cripta. Il chiostro sarebbe bello ma
è maltenuto e triste; anche la comitiva è tetra, son tutte persone di mezza età vestite ammodo, a fare da
guida è la più anziana tra di loro, palesemente autonominatasi capobranco; quello che dice si capisce
poco, ma siccome ha una voce molto alta, i suoi latrati ne segnalano efficacemente la posizione e
ricompattano il gruppo quando tende a disperdersi. La scala che scende alla cripta è strettina, la voce
della vecchia riecheggia lugubre come il corno di Orlando a Roncisvalle; è lei che per chissà quale
inconcepibile motivo ha trascinato sino a questo angusto budello gli infelici compagni, e nessuno glielo
perdonerà mai.
Adesso, però, la sola preoccupazione è riguadagnare l'uscita : uno alla volta ci si
ferma per una frazione di secondo davanti al cancello che chiude il sepolcreto, poi si fa dietro front e si
risale sgomitando con quelli che ancora stanno scendendo. Io e mia moglie siamo tra gli ultimissimi e
abbiamo modo di dare un'occhiata con un po' più di agio. La cripta è minuscola, dentro ci stanno
quattro sarcofaghi disadorni, stipati uno contro l'altro senza che avanzi un centimetro. Praticamente
non c'è niente da vedere, però non è una patacca. Per chi ci crede, lì dentro c'è un quadruplice
amuleto, uno dei più potenti tra i tanti che Roma custodisce, una vera e propria batteria di missili
puntati contro l'Anticristo. Una volta a queste cose ci credevano tutti, persino i papi e i cardinali;
adesso non lo so, ma ho il sospetto che siano ancora in parecchi a pensare che l'arsenale di sante
reliquie che si conserva qua sotto rappresenti una valida garanzia contro le oscure manovre di Satanasso
principe di questo mondo. Questo, ve l'ho detto, è un posto di frontiera; di qua c’è il nostro presente e
dall'altra parte ci sono tutti i medioevi, quelli già trascorsi ma anche quelli a venire in cui potremmo
ritrovarci sprofondati da un giorno all'altro. Nel 499 la chiesa che sorgeva in questo luogo era
qualificata come Titolus Aemilianae, cioè col nome di chi l'aveva fondata o donata; cent'anni più tardi,
invece, era intitolata ai Quattro Santi Coronati (dove la corona era quella simbolica del martirio). Non
è chiaro se già a quell'epoca la chiesa conservasse i resti dei santi a cui era dedicata, ma la cosa è poco
probabile, se è vero che nei cent'anni successivi ben due diversi cimiteri si vantavano di ospitare le loro
spoglie. Nei due secoli che seguirono, la devozione verso i Santi Quattro si fece ancora più forte, così
come il prestigio della chiesa intitolata ad essi. Nell'847 salì al trono pontificio Leone, Cardinale dei
Santi Quattro Coronati.
Papa Leone IV, a cui si debbono importanti realizzazioni in campo
architettonico ed urbanistico, ebbe molti riguardi nei confronti di quella che era stata la sua chiesa : la
ampliò, la abbellì e come supremo ornamento dell'edificio fece costruire la cripta, nella quale radunò
tutte le reliquie attribuite ai Quattro Coronati, riesumate dai due cimiteri rivali. Fate attenzione alle
date : bastano pochi decenni perchè da una fede limpida e semplice basata su di un rapporto diretto tra
credenti e Divinità si passi ad un culto già intriso di superstizione che necessita della mediazione di una
moltitudine di intercessori dotati di aureola. Dopo di che si scivola inesorabilmente - ed è una deriva
senza rimedio che si protrae per secoli - verso una religione che è sostanzialmente magia, nella quale
acquistano rilevanza primaria le sante reliquie, oggetti che si reputano dotati di poteri soprannaturali :
ossa, chiodi, tessuti, capelli, denti, gioielli, dipinti, arredi liturgici, oggetti di uso quotidiano, qualsiasi
cosa. Voler credere che i resti raccolti da papa Leone nella cripta siano proprio quelli dei Quattro
Coronati è davvero un atto di fede cieca. La storia è complicata e ve la racconto come l'ho capita io;
non è detto che le cose siano andate veramente così, però è una versione che sta in piedi. I Quattro
Coronati sarebbero (il condizionale è d'obbligo) altrettanti pretoriani martirizzati a Roma nel 311 e
sepolti nel cimitero dei Due Lauri sulla Via Labicana. Di loro non si conoscono i nomi. Verso il 600,
come s'è detto, viene loro dedicata una chiesa già esistente, però il culto dei martiri, che non è il
massimo dello spirituale, pretende un supporto materiale - le reliquie - come oggetto di venerazione.
Si ricercano dunque i resti dei Quattro Santi nel cimitero dei Due Lauri, dove si tramanda siano stati
deposti. Il fatto che non si conoscano i loro nomi non rappresenta certo un problema per gli uomini di
quell'epoca così ricca di immaginazione. Il cimitero ospita infatti il sepolcro dei martiri Claudio,
Nicostrato, Castorio, Sinforiano e Simplicio; sono cinque ma va bene lo stesso : si tratta certamente dei
Quattro Coronati più un amico. C'è però chi contesta questa identificazione : i cinque corpi dei Due
Lauri, si dice, appartengono ad un gruppo di scalpellini serbi giustiziati al tempo di Diocleziano; i veri
Quattro Coronati erano soldati e sono sepolti ad Albano. Si chiamavano Severo, Vittorino, Carpoforo e
Severiano, ed erano quattro fratelli, cristiani, martiri e militari. Che si trovino nel cimitero sbagliato
poco importa; questi son tempi di miracoli e prodigi e le leggi della logica valgono ancora meno di
quelle della fisica.
Finalmente Leone IV recupera le reliquie dall'uno e dall'altro cimitero e le
trasferisce nella chiesa dei Quattro Coronati sistemandole nella nuova cripta. In altre parole, dentro i
quattro sarcofaghi dei Quattro Coronati ci sarebbero in realtà nove corpi, nessuno dei quali
apparterrebbe però agli autentici Quattro Coronati. Alcuni autori ritengono tuttavia che la chiesa già
accogliesse da tempo immemorabile i resti dei quattro soldati giustiziati in Roma nel 311; in questo
caso i Quattro Coronati sarebbero addirittura tredici. Fossimo stati in India ci si sarebbe inventata una
qualche divinità con tredici teste e ventisei braccia; da noi non si era avvezzi a simili arditezze
iconografiche, ma la sostanza della credenza popolare era altrettanto assurda. Nel cuore del Medioevo
più profondo la principale fonte energetica era indubbiamente la fede, e la fede cieca, in particolare, era
per quell'epoca quello che per noi è l'energia nucleare, tanto potente quanto pericolosa. Per la Chiesa
le reliquie rappresentavano qualcosa di paragonabile alle bombe atomiche dell'ex Unione Sovietica :
efficace deterrente contro il nemico finchè stavano in buon ordine al loro posto, si tramutavano in un
incubo quando se ne perdeva il controllo. Altissimo era ad esempio il rischio che cadessero nelle mani
di mistici, profeti o taumaturghi, pazzoidi o ciarlatani che a quell'epoca proliferavano. Neutralizzare le
ricorrenti eruzioni di misticismo misto a magia era un'esigenza prioritaria che giustificava l'uso di
qualsiasi strumento : le benedizioni, l'acqua santa, gli esorcismi, il carcere e le catene o, nei casi
estremi, il fuoco e la spada. A volte però si rivelava sufficiente un buon contenitore in pietra, un
sarcofago ad esempio, anzi quattro, come nel nostro caso. Immagino che allorchè si prese la briga di
rastrellare le reliquie dai vari cimiteri per riporle acconciamente nella cripta della sua chiesa, Papa
Leone volesse prima di ogni altra cosa farla finita con le superstizioni che erano legate al culto popolare
dei Quattro Coronati, probabilmente esagerate persino per quell'epoca così credulona. Immagino
anche che di tanto in tanto i devoti dell'uno e dell'altro cimitero se le suonassero di santa ragione, dato
che a quei tempi la religione (o quel che era) suscitava un tifo da stadio e la gente era manesca, molto
peggio che adesso. Papa Leone ci mise letteralmente una pietra sopra, anzi quattro : i Quattro
Coronati sono qua e sono questi, punto e basta. Ammesso che tutto questo sia vero, non si deve però
pensare che Papa Leone si sia mosso per stroncare le superstizioni più disdicevoli in nome della
razionalità. La chiesa dei Quattro Coronati da lui ristrutturata era più vasta e molto più luminosa di
quella attuale (riedificata al risparmio dopo il disastroso passaggio del Guiscardo, e buia come il limbo)
ma la luce che allora la pervadeva non era ancora quella metafora della ragione divina ed umana che
quattrocento anni più tardi riempirà di sé le chiese gotiche. Nel IX secolo gli edifici sacri di Roma
risplendono di luci e di colori sfolgoranti che vogliono rappresentare un modestissimo riflesso del
bagliore accecante di Dio.
Attorno all’820, pochi decenni prima del pontificato di Leone, Papa
Pasquale I aveva edificato o risistemato diverse chiese foderandole, letteralmente, di mosaici
straordinariamente belli. Il capolavoro di Papa Pasquale è indubbiamente la cappella di San Zenone,
che si trova nella basilica di Santa Prassede. E' un piccolo ambiente dalle pareti d'oro, sulle quali una
ristretta ma sceltissima rappresentanza del creato rende lode al Signore : ci sono santi e sante, ma anche
fiori coloratissimi, animali simbolici e oggetti carichi di sacralità come il trono e la croce. Dagli angoli
della volta, poggiando i piedi su quattro belle colonne antiche, altrettante figure angeliche, longilinee ed
elegantissime, si slanciano a sorreggere con le braccia levate una finestra circolare che buca proprio al
centro il cielo tutto d'oro. Da essa si affaccia Cristo Pantocratore, cioè Signore di Tutto, che pare
ritratto mentre dà una controllatina al mondo di sotto; in realtà la sua funzione è piuttosto quella di
celare ai nostri occhi quel che sta ancora al di sopra di lui, e cioè Dio Padre, che i nostri sensi e la nostra
mente non sono in grado di percepire e comprendere. E difatti alle spalle di Cristo si intravede a
malapena un po' di sfondo scuro che contrasta con il diluvio di luce e colore che ci piove addosso dalle
pareti della cappella. Questo spiraglio d'ombra rappresenta qualcosa di più che una sottigliezza
teologica : negli anni in cui a Roma Papa Pasquale ricopriva di santi i muri delle sue chiese, a Bisanzio
si distruggevano le immagini sacre, la cui venerazione era giudicata una perniciosa forma di idolatria.
A quei tempi Bisanzio era ancora capitale di un impero; Roma invece non lo era più da un bel pezzo,
però ci pativa e lo dimostra il fatto che sul finire del secolo precedente la Chiesa di Roma aveva
coinvolto Carlo Magno Re dei Franchi e dei Longobardi nel tentativo di dare vita ad un Impero
dell'Europa Occidentale, un esperimento destinato ad esaurirsi nell'840 con la morte di Ludovico, figlio
di Carlo. All'epoca di papa Pasquale, però, ci si poteva ancora illudere che la cosa funzionasse, e Roma
cercava in tutti i modi di dimostrare di non essere inferiore a Bisanzio né dal punto di vista politico né
sotto il profilo culturale. Quel buco nel soffitto presidiato da Gesù Cristo (che è dio ma è anche uomo)
e al di là del quale si estendono le immensità del Padre Suo (che è puro spirito) vietate alla nostra
percezione, vuole affermare che a Roma non si era barbari idolatri; nessuno a Roma si sarebbe mai
sognato di raffigurare quel che va al di là dei nostri sensi e della nostra immaginazione. Però perchè
privarci della gioia che suscita in noi la raffigurazione del creato, ivi compreso - ovviamente - l'essere
umano, che della creazione è il compimento? E a maggior ragione ivi compreso Gesù Cristo che è Dio
ma è anche l'essere umano più perfetto. La pittura serve a lodare l'operato del Signore; forme, colori e
luce muovono all'esultanza e mettono voglia di guadagnarsi il Paradiso perchè sono un assaggio - una
briciola appena - dello splendore che ci attende con la resurrezione dei morti e la vita nel mondo che
verrà. A quei tempi la comunicazione per immagini aveva un'importanza paragonabile a quella che ha
oggi per noi, e non soltanto perchè a leggere e a scrivere erano rimasti in pochi : la vista era più che mai
la regina tra i cinque sensi, costituiva il tramite privilegiato con la realtà terrena e indicava la via per
quella ultraterrena. Non per nulla, nei regolamenti di conti tra potenti la prima preoccupazione del
vincitore era quella di far cavare gli occhi al perdente. Anche Papa Pasquale fu accusato, non si sa se a
torto o a ragione, di aver fatto accecare e poi decapitare alcuni funzionari sospettati di infedeltà e
tradimento. Chiamato dall'Imperatore Ludovico a giustificarsi, Pasquale non si scaldò nemmeno un
poco : dichiarò che le vittime se l'erano senz'altro meritata, che chi li aveva fatti fuori - chiunque fosse
stato - aveva fatto bene, e la cosa finì lì.
Papa Pasquale è una delle pochissime persone della sua
epoca di cui conosciamo con precisione le sembianze, giacchè si fece raffigurare per ben tre volte sulle
pareti delle sue chiese in compagnia di Gesù, della Madonna e di vari santi. Sebbene stilizzati al limite
della caricatura o della grafica da fumetto, i ritratti di Pasquale - che era tutto fuorchè un bell'uomo sono assolutamente veritieri e la sua figura poco aggraziata stona al confronto di tutti quei santi e quelle
sante bellissimi come da copione. Bello o no, Papa Pasquale era comunque un uomo di gusto, un
amante dell'arte e un grande mecenate. Prima di tutto, però, era un uomo dei suoi tempi e a quanto
pare aveva pelo sullo stomaco da vendere. Ciononostante egli era sicurissimo di avere il posto
prenotato in Paradiso, e in prima fila. D'altronde, all'epoca per andare in Paradiso non c'era quel
granchè da fare o da pensare: l'importante era stare in riga, ovviamente dalla parte giusta, cioè quella
dei vincitori.
IL PIANO REGOLATORE
CASE FATTE DI NIENTE
Chi come me ha già una certa età sa bene quanto sia cambiato il nostro vissuto da quando il legno è
diventato un dato marginale della nostra esperienza quotidiana (sto parlando del legno vero,
ovviamente, e non dei suoi inverosimili succedanei). L’inesorabile ticchettìo del tarlo che nelle notti
silenziose della mia infanzia scavava le sue gallerie nella mobilia è uno dei pochissimi tra i miei ricordi
che sappia suscitare in me un briciolo di sincera nostalgia. A dire il vero era già da un pezzo che il
nostro rapporto con il legnoare sino ai confini della preistoria, quando l’avvento della metallurgia
permise di rimpiazzare molto validamente la pietra, l’osso e il legno nella realizzazione di moltissimi
prodotti, vorrei almeno ricordare come tra il XII e il XIII secolo nella Val Padana si cominciassero a
costruire in muratura non più soltanto le chiese e le fortificazioni ma anche le case d’abitazione, che in
precedenza erano fatte nel migliore dei casi con materiale di recupero tenuto assieme dalla carpenteria,
o più comunemente col cento per cento di materiale vegetale.
C’era stata, è vero, la parentesi
dell’Impero Romano, che aveva portato l’edilizia in muratura in ogni angolo dell’Europa occidentale,
ma non dobbiamo pensare che le nuove tecniche di costruzione fossero penetrate in modo ugualmente
profondo in ogni dove. Qualche decina di anni fa sono stati dissepolti in località Fontana Gregotti, non
lontano da Mortara, in aperta campagna, i resti di una dimora rurale risalente alla tarda romanità. Si
tratta di una scoperta abbastanza eccezionale; sebbene la zona fosse discretamente popolata, come
dimostrano le numerose sepolture che si continuano a rinvenire tutt’intorno, quella della Fontana
Gregotti è l’unica abitazione che abbia lasciato tracce della propria esistenza. Tracce che si riducono
comunque a ben poca cosa : coppi e chiodi. Tutto il resto era sparito, evidentemente perchè realizzato
in materiale vegetale molto deperibile, e se di tutte le altre case che dovevano esistere nei paraggi non
s’è trovato nulla, probabilmente è perchè i loro abitanti non si potevano permettere neppure un tetto in
cotto e una carpenteria tenuta insieme con i chiodi. Come dire che erano dei poveracci, però potrei
anche sbagliarmi. Il fatto è che per noi italiani moderni il mattone è un autentico blocco mentale, e
all’idea di vivere in una casa di legno o - peggio ancora - di canne e di paglia associamo
automaticamente immagini di miseria e desolazione, quando invece i paesi nordici e il Giappone ci
insegnano che l’edilizia in legno poteva raggiungere livelli di lusso e raffinatezza elevatissimi, per non
parlare poi dei mari del sud dove si viveva come gli dei dentro case fatte di niente (ma forse anche
questo è un luogo comune). I materiali danno forma e carattere ad una civiltà; il medioevo, che per
forza di cose era tendenzialmente autarchico, vide svilupparsi un gran numero di culture
geograficamente circoscritte che erano fortemente caratterizzate dai materiali localmente più
abbondanti o più facilmente reperibili. Cito soltanto, a mo’ di esempio i borghi costruiti coi sassi di
fiume sulle due sponde di Sesia al confine tra i territori di Vercelli e di Novara, oppure le superbe
architetture sacre decorate a fasce alternate di pietra candida e pietra più scura che presidiano l’alto
Tirreno, da Genova a Pisa alla Sardegna penetrando in profondità nell’entroterra toscano, da Lucca a
Pistoia fino a Siena. Un’inattesa e suggestiva parafrasi dello stile pisano e lucchese la si incontra sul
fianco di una delle più alte colline del Monferrato, nella facciata dell’Abbazia di Vezzolano. Tre ordini
sovrapposti di gallerie cieche imitano in tono un po’ dimesso quelle ben più spettacolari che
abbelliscono le facciate delle chiese di Lucca, e non manca neppure l’ornamentazione muraria a fasce
orizzontali bicolori, ma anzichè il candore del marmo c’è il bianco sporco dell’arenaria, e la pietra scura
è sostituita dal bel rosso del mattone. Argilla ed arenaria, questa stratificata al di sopra di quella, sono
quanto il suolo sa offrire nelle colline poste tra i fiumi Tanaro e Po, e i capomastri locali hanno saputo
farne uso con perizia e con gusto. Il monumento che meglio rappresenta l’accoppiata tra i due
materiali è probabilmente la cosiddetta Torre Rossa che fa da campanile alla chiesa di Santa Caterina in
Asti. Si tratta di una snella torre a sedici lati costruita in età romana utilizzando uno strepitoso mattone
di color rosso cupo, alla quale fu aggiunta nel XII secolo una sopraelevazione che si presenta come un
aggraziato tempietto a due piani. Il piano sottostante è tutto in mattone ed ha otto finestre a tutto
sesto regolarmente cadenzate, un lato si e un lato no; il piano superiore, a fasce orizzontali bianche e
rosse, ha anch’esso otto finestre che si aprono sui lati alterni rispetto a quelle del piano inferiore. I lati
privi di finestre del piano di sopra sono abbelliti da esili colonnine in arenaria di grande eleganza.
Volendo fare gli intellettuali si potrebbe dire che questo piccolo gioiello esemplifica come meglio non si
potrebbe la convinzione diffusa tra le menti migliori del medioevo di essere dei nanetti lungimiranti
appollaiati sulle spalle dei giganti dell’età classica. Restando più terra terra noteremo come la nostra
bella torre esemplifichi altrettanto validamente quella sorta di staffetta che si è storicamente verificata
nell’uso dei due materiali con cui la torre è stata realizzata. Facciamo un bel salto all’indietro nel
tempo : chiusasi con la fine dell’Impero Romano la prima grande stagione del cotto, l’attività edilizia
nel Monferrato tornò ad esercitarsi a livelli apprezzabili solo nel XII secolo grazie all’utilizzo
dell’arenaria, che divenne strumento attivo di evangelizzazione, giacchè è con essa che si costruirono le
innumerevoli chiesette rurali sparse per ogni dove tra le colline. Nel frattempo riprese quota anche
l’arte del cotto, ma sino al XIII secolo il mattone fu usato quasi esclusivamente per intercalare in misura
più o meno consistente l’arenaria, e fu soltanto nel Milletrecento che i committenti di maggior
prestigio - religiosi ma anche laici, giacchè erano ormai numerosi i privati stracarichi di soldi –
cominciarono ad usare il cotto dalle fondamenta al tetto per edificare chiese, castelli, abbazie, torri,
palazzi e case mentre l’arenaria, nelle sue diverse gradazioni di consistenza e pregio, passava a
soddisfare le ambizioni dei ceti medi e medio-bassi : chi poteva permetterselo si faceva la casa in solida
pietra da cantoni; chi non poteva si accontentava di usare il cosiddetto sabbione, che a vederlo
assomiglia alla pietra da cantoni ma dopo un po’ incomincia a sfragugliarsi. Questa rincorsa che aveva
assunto i caratteri della competizione di classe
si protrasse per diversi secoli, conobbe un
momento
altamente
emozionante
nel
Settecento con l’erezione di stupende chiese
barocche dalle facciate in mattone a vista che
nobilitano paesi e paesetti, e si concluse nei
primi decenni del Novecento quando anche il
coltivatore diretto intraprendente e fortunato
si costruiva la sua bella cascinetta di mattoni
rosso scuro.
MERLI, TORRI, TORRETTE E
BANDIERINE
Grazie alla sua versalità il mattone si è
imposto quasi dovunque come succedaneo di
qualsivoglia materiale edilizio. Ho accennato
altrove ai borghi costruiti con pietre di fiume
fra il XIII e il XIV secolo lungo le sponde di
Sesia e degli altri corsi d’acqua del Vercellese
e del Biellese.
Sebbene i ciottoli fossero
reperibili in loco in abbondanza e non
richiedessero alcuna lavorazione, i successivi
interventi di miglioria risultano effettuati di
preferenza utilizzando il cotto; in alcuni casi,
addirittura, l’originaria cinta muraria in pietra
è stata rivestita esternamente con un nuovo
strato in mattoni. Il più famoso tra questi
particolarissimi insediamenti è il Ricetto di
Candelo nel Biellese, situato a poca distanza
dalla riva del Torrente Cervo ed attestato come esistente sin dalla metà del Trecento. Il termine ricetto
(o recetto, o recinto, o rinchiuso) è utilizzato a partire dal tardo medioevo per indicare varie tipologie
urbanistiche di dimensioni generalmente contenute accomunate dal fatto di essere circoscritte da una
efficace cinta difensiva. Il ricetto di Candelo è situato sull’orlo di un terrazzamento fluviale; le sue
casette a due piani, fitte fitte, sono allineate sui lati di cinque strade parallele e sono chiuse entro una
cerchia di mura dotata di torrette alla quale dà accesso un’unica porta sormontata da un robusto
torrione. Belle e ben tenute come autentiche case, le costruzioni interne al ricetto non servivano da
abitazione ma venivano usate per conservare le scorte di derrate, e solo in caso di eventi bellici che
minacciassero il circondario esse ospitavano temporaneamente i cittadini di Candelo, che del ricetto
erano i proprietari.
Il paese - quello vero dove abitava la gente - se ne stava al di fuori, separato dal
ricetto da mura, fossato, torrione, portone e ponte levatoio. Oggi il paese circonda il ricetto su tre lati e
se andiamo a dare un’occhiata alla pianta dell’abitato salta immediatamente all’occhio il contrasto tra
due impostazioni urbanistiche diametralmente opposte. All’interno del ricetto vige da secoli, senza
che mai nessuno (o quasi) si sia sognato di metterla in discussione, la ferrea pianificazione originaria; al
contrario gli spazi compresi tra le strade serpeggianti del paese sono stati occupati in maniera
disordinata ed apparentemente casuale. L’unico edificio fuori scala del ricetto è la cosiddetta casa del
principe, più alta di un piano rispetto alle altre costruzioni. La prosopopea di quel piano in più
rispecchia bene la megalomania di chi l’ha voluto, che è un personaggio che già conosciamo, vale a dire
Sebastiano Ferrero, chiavaro di Biella, generale delle finanze di Savoia, tesoriere del Ducato di Milano e
chissà quante altre cose.
Acquistato nel 1496 dal Duca di Savoia il feudo di Candelo, Ferrero
pretendeva di estendere le prerogative che esercitava sul paese - diritti, tributi e giurisdizione - anche
sul ricetto, che era, come si è detto, proprietà esclusiva della comunità. Richiesto l’arbitrato, i giudici
dichiararono infondate le richieste del feudatario, il quale ottenne solamente di poter detenere una
chiave del ricetto, alla pari degli altri uomini del paese. Sebastiano Ferrero era uno che ci provava
sempre e comunque. Fortunatamente qualche volta gli andava buca. Per quel che risulta dalla
documentazione che si è conservata, la maggior parte dei borghi di pietra di fiume eretti nella pianura
tra Biella, Novara e Vercelli sarebbe stata adibita sin dalla fondazione ad uso residenziale stabile e
continuativo, e ancora adesso questi borghi sussistono come centri storici dei paesi cresciuti loro
attorno. Per quanto riguarda invece i ricetti di cui si sa che costituivano un’entità distinta dal paese,
l’unico conservatosi in condizioni apprezzabili è quello di Candelo, mentre degli altri rimangono ruderi
o tracce frammentarie.
Verrebbe spontaneo pensare che il recinto murato non abitato
continuativamente rappresentasse un esperimento un tantino bizzarro e sostanzialmente fallimentare,
laddove la norma era costituita da nuovi insediamenti utilizzati stabilmente a fine abitativo. E tuttavia
tra gli studiosi di Storia si è dibattuto e ancora si dibatte su quale delle due forme debba considerarsi la
primogenita, e la questione non è futile come potrebbe sembrare a prima vista. Schematizzando il più
possibile, proverò a sintetizzarne i termini, ma prima vi devo chiedere di non dimenticare che stiamo
ragionando di un fenomeno che aveva alla base, sostanzialmente, delle esigenze di ordine militare, reali
o pretestuose che fossero. E’ innegabile che in quel periodo le guerre fossero all’ordine del giorno,
guerre incessanti, guerre di tutti contro tutti. Guerre il cui momento più rappresentativo non era la
battaglia ma il cosiddetto guasto, il saccheggio a danni dei civili, vale a dire un momento festoso e
liberatorio in cui si poteva finalmente fare alla luce del sole quello che a casa si doveva fare di nascosto
e con grave rischio : rubare. Orbene, la domanda che ci si pone è se all’origine (siamo nel Millecento
avanzato) queste benedette nuove fondazioni fossero concepite fin da subito come strumenti di
organizzazione della vita sociale, oppure se si badasse essenzialmente a salvaguardare le scorte
alimentari, perdute le quali qualsiasi cosa che potesse somigliare ad una vita sociale se ne sarebbe
andata a farsi benedire. A ben guardare, è ancora una volta il contrasto tra dimensione urbana e
mondo rurale. Oggi sappiamo che alla fine fu la città a prevalere, ma all’epoca nessuno poteva
prevedere quale sarebbe stato l’esito della partita e le due culture cercavano l’affermazione sul territorio
procedendo per tentativi ed esperimenti. Ci terrei a sottolineare la parola esperimenti : il medioevo fu
caratterizzato da lunghi periodi di assenza di forti poteri centralizzati, e di conseguenza in ogni dove e
ad ogni livello della scala sociale ci si dovette arrabattare ad inventare forme e modi di convivenza
sociale, ivi comprese adeguate formule urbanistiche. Come è lecito attendersi, questi esperimenti
tendevano a rifarsi a tradizioni consolidate e ad esperienze già maturate. Le città, lo si è detto,
presidiavano il territorio replicando se stesse su scala ridotta, ma i signori feudali e le comunità rurali
avevano sott’occhio un diverso modello, che era il castello. Negli ultimi secoli questo aveva assunto la
forma prevalente di residenza fortificata di un Signore unico proprietario, ma alle origini, tra il 900 e il
1100, il castello aveva conosciuto una grande diffusione come struttura difensiva realizzata e fruita – non
necessariamente ad uso abitativo - da famiglie dell'aristocrazia guerriera sovente consorziate tra loro.
Il modello urbano è incentrato sull’utilizzo residenziale individuale : lo spazio è trattato come pura
estensione ed è suddiviso in lotti abitativi sostanzialmente equivalenti connessi da una rete di strade
che deve permettere la massima mobilità; all’interno di un castello, invece, lo spazio non rappresenta
un’entità neutra ma si caratterizza in funzione delle attività che vi vengono espletate giacchè ad
articolarlo sono i cortili attorno a cui si distribuiscono gli edifici. Nel modello urbano lo spazio
comune è la via; nel modello rurale è l’aia.
Ad esempio di come queste diverse concezioni si
traducessero concretamente in insediamenti vorrei citare due casi che credo si possano definire estremi.
Il primo è Bagnasco, un minuscolo centro dell’Astigiano situato sulla sommità di una collina circondata
da strette valli molto boscose. Il nucleo centrale del paese è costituito da una piazza a pianta
grossolanamente circolare sul cui perimetro sono disposte, senza continuità e senza un ordine
particolare, alcune casette al di là delle quali vi sono ripide scarpate che scendono verso valle. Per
accedere alla piazza si passa sotto un modestissimo portale che rappresenta l’unica traccia superstite di
opere difensive e la cui aria ben poco marziale non risolleva certo il tono quanto mai rustico e dimesso
dell’abitato. Poco più giù, nel cimitero del paese che si trova a metà collina, sorge una chiesa romanica
a tre navate che non può certo dirsi grandiosa ma che in tutti i casi appare indiscutibilmente
sovradimensionata rispetto all’inconsistente insediamento soprastante. A metà del XII secolo, epoca in
cui fu costruita, questa era la chiesa di Bagnasco, ed essendo chiesa pievana da essa dipendevano le
chiese di alcune località circostanti, tra cui è il caso di citare almeno Montafìa. Che la chiesa si
trovasse così fuori mano rispetto al paese attuale non è cosa che possa sorprendere il lettore attento, che
ormai sa che a quei tempi di paesi non ce n’erano e la popolazione rurale risiedeva qua e là per la
campagna; tutto questo per dire che quando ancora non era un paese, Bagnasco era una località di una
certa importanza. In seguito, il processo di accentramento degli insediamenti portò ad un maggior
incremento delle località vicine (come Montafìa, che adesso è capoluogo comunale) mentre a Bagnasco
(che adesso è frazione di Montafìa) rimase nè più nè meno quel che già c’era : a mezza costa una
chiesona che ormai non serviva più a niente e in cima alla collina una struttura difensiva che più tardi
sarebbe stata convertita all’uso residenziale privato diventando l’attuale paesetto.
Se ho parlato
genericamente di struttura difensiva e non ho usato espressioni più precise come castello o ricetto è
perchè non ho la benchè minima idea dell’epoca a cui tale struttura possa risalire. Se il recinto
circolare di Bagnasco rimontasse al X secolo dovremmo parlare di un castello, se fosse del XIII sarebbe
un ricetto, anche se è vero che non pochi ricetti sono nati sul sedime di vecchi castelli, e questo
potrebbe essere uno di quei casi. Sia come sia, Bagnasco non offre a chi lo guarda nessun elemento
che possa aiutare a capire la sua età. A dire il vero non c'è proprio niente da vedere, a parte una
spianata circolare in cima a una collina, una forma talmente elementare che la si riscontra anche in un
gran numero di siti preistorici come i cosiddetti castellieri posti sulla sommità delle alture da un capo
all’altro del Mediterraneo. Nella sua impressionante semplicità Bagnasco ci aiuta a capire cosa fosse
sostanzialmente un castello, e cioè un’aia protetta, punto e basta. In seguito, come s’è detto, i castelli
si fanno residenze signorili fortificate, cominciano a metter su merli, torri, torrette e bandierine e alla
fine diventano quei cosi pittoreschi che si vedono nelle illustrazioni dei libri di fiabe. Un imponente
castello signorile domina l’abitato di Montemagno, che è il secondo caso esemplare che volevo proporre
alla vostra attenzione. Montemagno è un grosso centro situato sul confine tra Astigiano e Basso
Monferrato, in una zona tradizionalmente caratterizzata da un intenso sfruttamento agricolo. Il paese
si estende sul versante di mezzogiorno di una collina ed è sistemato, diciamo così, in pendenza.
Normalmente, in casi del genere l’abitato è organizzato attorno ad assi viari situati a varie altezze e
paralleli alla cresta della collina. Il centro storico di Montemagno, invece, è tagliato da una decina di
ripide strade parallele che scendono in linea retta dalla sommità della collina sino a mezza costa, dove
transita una via di raccordo a cui corrisponde, in cima, proprio ai piedi del muraglione del castello, un
lungo spazio pianeggiante che definire strada non è giusto perchè e troppo largo, e chiamare piazza
non si può perchè è troppo stretto. Questa sistemazione, che dovrebbe risalire alla fine del Duecento,
quando il paese fu distrutto e ricostruito durante uno dei frequenti conflitti tra Asti e Monferrato, credo
la si possa considerare come un’applicazione demente e malsana di quello che abbiamo definito
modello urbano. A parte la crudeltà di costringere i paesani a faticose scarpinate in salita (che
all’inverso diventavano discese piuttosto disagevoli), immagino che ad ogni acquazzone le vie
diventassero fiumane di fango, giacchè i suoli di queste colline sono ben poco consistenti. Forse mi
sbaglio ma credo che il particolarissimo assetto urbanistico di Montemagno trovasse la sua ragion
d’essere nella volontà di tener sotto controllo tutto quanto l’abitato dall’alto del castello; nel qual caso il
democraticissimo modello di una rete viaria capillare che mette in comunicazione tutte le residenze
individuali si sarebbe ribaltato in uno strumento biecamente totalitario.
IL PIANO REGOLATORE
Chi ama visitare paesi e cittadine apprezza la personalità tutta sua che ogni piccolo centro sa esprimere
: le chiese, i palazzi, i portici e la veduta sullo sfondo hanno il loro peso, ma a fare il carattere
dell’abitato è qualcosa che non si coglie a colpo d’occhio, è l’organizzazione degli spazi concepita dagli
ignoti urbanisti del basso medioevo, è il piano regolatore originario. Non giudicate un anacronismo
l’aver parlato di piani regolatori; sebbene la narrativa e il cinema facciano a gara nel dipingere un
medioevo dominato dall’approssimazione e dall’arbitrio, gli uomini di quelle epoche, a tutti i livelli
della scala sociale, erano di una pignoleria quasi maniacale e non è neppure pensabile che in una
faccenda seria come l’organizzazione di un insediamento qualcosa potesse essere lasciata al caso. Che
poi sovente le cose degenerassero, e laddove ai nostri giorni ce la caveremmo con una crisi di giunta si
finisse a mazzate, è un altro discorso. Il grosso problema del medioevo, lo si è detto, erano le ricorrenti
vacanze del potere centrale che scatenavano, a valanga, dei parapiglia generali in cui regole e patti
andavano a farsi benedire, ma questa era l’eccezione e non la regola. Tutto questo vale anche riferito ai
cosiddetti secoli bui, che sono tali principalmente per la scarsità della documentazione che ci è
pervenuta. A riprova vorrei citare il caso di Asti, di cui il lettore già conosce le fortunose vicende.
Fondata un cent’anni prima dell’inizio della nostra era, Asti era fatta come la maggior parte delle città
nuove dei Romani nella Val Padana occidentale : la superficie urbana era uniformemente ripartita in
isolati di ottanta metri per ottanta, un impianto che è ancora chiaramente leggibile nella struttura del
centro storico di Piacenza, Pavia, Novara e Torino. Asti si estendeva per nove isolati da ovest ad est
contro almeno cinque in senso nord-sud; come fossero occupati questi spazi non lo saprei dire, ma la
sopravvivenza di tracce significative dell’urbanizzazione originaria nella parte nordoccidentale
dell’abitato e in quella sudorientale mi porta a credere che almeno in queste aree esistessero edifici
piuttosto importanti capaci di offrire una maggiore resistenza agli eventi distruttivi. Nella parte di
nordovest sorgevano probabilmente dei templi di una certa maestosità; nella cattedrale, che è situata
proprio ai piedi della cresta collinare che chiude a settentrione la città vecchia, si possono ancora
osservare due grandi ed eleganti capitelli corinzi che fanno da basamento a massicce acquasantiere
medioevali e che hanno tutta l’aria di non essersi spostati di molto dal posto in cui facevano bella
mostra di sè originariamente.
Nella mappa catastale di epoca
napoleonica Asti appare come una
città ancora sostanzialmente
medioevale e vi si possono leggere i
segni di tre differenti piani
regolatori risalenti ad epoche anche
lontane tra loro ma accomunati
dalla fedeltà al modello urbanistico
romano. Il più antico - in giallo - è
ovviamente quello originario,
mentre in arancio è evidenziata la
prima espansione medioevale,
databile tra il IX e l'XI secolo, e in
fucsia l'ampliamento risalente al
XII secolo. Nel XIII secolo (in
rosso) l'espansione continua, ma
con caratteri completamente
diversi. L'omogeneità di impianto
tra la città romana, quella di età
vescovile e la prima urbanizzazione
comunale rende abbastanza
difficoltoso il loro riconoscimento :
la scacchiera romana e quella
medioevale si lasciano distinguere
solamente perchè gli assi nord - sud
di quella più recente risultano più
arretrati verso ponente di circa venti
metri rispetto a quelli della
formazione più antica. E' un caso
di mimetismo quasi perfetto e
questo spiega perchè agli storici
locali sia sfuggita l'effettiva portata
delle devastazioni subite alla fine
del V secolo dalla città romana.
Come si può notare, le tracce che
questa ha lasciato si concentrano ai
due estremi della superficie che
essa occupava, e questo lascia
supporre che in tali aree sorgessero
edifici particolarmente solidi,
mentre tutto il resto sarebbe stato
spazzato via. Nella zona di sudest
doveva trovarsi il comando militare,
in quella di nordovest spazi pubblici
di carattere monumentale; nell'alto
medioevo la prima divenne sede di
un Duca longobardo, nell'altra si
trovavano importanti proprietà
ecclesiastiche, sia monastiche che
vescovili. Qui sorse poi la
Cattedrale, mentre l'area di sudest
divenne il cuore amministrativo
della città (ancora adesso vi si trova
il palazzo comunale) e per diversi
secoli ospitò il mercato principale.
Lo spazio compreso tra queste due
zone, urbanizzato ai tempi di Roma
imperiale e poi tornato allo stato di
campagna aperta, fu dunque
rioccupato soltanto nei secoli posti
a cavallo dell'anno Mille; per
almeno trecento anni Asti era stata
una località rurale che non aveva
più nessuno di quei caratteri che
sono propri delle entità urbane sia
pure di minime proporzioni
.
IL MEDIOEVO INAVVERTITO
ASTI
Nella mappa sono evidenziate in giallo
le testimonianze dell'antica viabilità
rurale che si lasciano riconoscere nella
topografia del centro storico di Asti.
Sono le tracce lasciate da numerose
strade formatesi in epoche differenti,
ed è probabile che alcune di queste
esistessero già prima dell'occupazione
romana; l'edificazione della città ne
avrebbe momentaneamente spezzato la
continuità,
poi
ripristinatasi
spontaneamente dopo il tracollo
dell'agglomerato urbano nel V secolo.
Altre risalgono sicuramente al periodo
durante il quale la superficie già
occupata dalla città romana era tornata
campagna; altre ancora sono state forse
tracciate molto più tardi, quando ormai
la città era ricresciuta (e si sarebbero
sovrapposte ad aree che già erano state
riurbanizzate ma avevano poi subito
gravi danneggiamenti durante i
conflitti che coinvolsero Asti tra XI e
XII secolo). In tutti i casi, queste
tracce sono quasi sempre mutile e
frammentarie, e quando presentano
una continuità apprezzabile vi si
possono riconoscere delle direttrici di
traffico di una certa importanza; delle
altre, sebbene siano ridotte in
frantumi, non è comunque difficile
farsi una mezza idea di dove
andassero a parare. Nel XII secolo
l'area dove un tempo aveva la sua
corte il Duca longobardo (cerchio
verde) era diventata il cuore della città,
sebbene si trovasse ancora al di fuori delle mura : c'era la chiesa del santo
patrono, c'era il mercato, vi si amministrava la giustizia e vi si prendevano
tutte le decisioni più importanti per la vita della comunità. Nei decenni
successivi l'attività edilizia attorno alla piazza del Mercato del Santo si fece
frenetica, e la lottizzazione dei terreni vicini cancellò i tratti terminali
(evidenziati in arancio) delle strade che in precedenza convergevano dalla
campagna verso la porta che si apriva alle spalle della spianata dove si teneva
il mercato. Se la ricostruzione grafica che ho azzardato è plausibile, queste
strade andavano ad attestarsi all'altezza della Casa dei Gardini, che non a
caso rappresentò per alcuni secoli il limite geografico ma anche sociale tra la
vecchia città alta (cerchio azzurro) e la nuova città bassa. Nelle illustrazioni
più piccole possiamo osservare tre diverse raffigurazioni della piazza dove era
ubicata la dimora dei Gardini, risalenti la prima al 1671, la seconda al 1818 e
l'ultima al 1972. In tutte e tre ho evidenziato la posizione del vicoletto (oggi
rimpiazzato da una breve gradinata) che a mio avviso coincide con un varco
della cinta difensiva realizzata tra il X e l'XI secolo.
MEDIOEVO FOSSILE
LA CASA DEI
GARDINI
Nella parte di sudest, invece, nelle adiacenze della porta orientale della città, c’era forse il comando
militare o comunque degli edifici dotati di strutture murarie abbastanza solide da superare bene
qualsiasi disastro, tant’è vero che nel VI secolo, evidentemente giudicando il sito sufficientemente
sicuro, vi pose la sua sede il duca dei Longobardi, il cui arrivo segnò la momentanea conclusione di una
lunga sequenza di eventi bellici. All’epoca questa zona era diventata aperta campagna, giacchè la città
si era ridotta alla sua parte nordoccidentale, che tra l’altro era situata in posizione un tantino rilevata e
quindi più facilmente difendibile. Il poco che rimaneva della città alta risultava ancora strutturato sulla
scacchiera romana ma stentava a coprire la superficie di nove isolati; attorno all’anno Mille, invece,
l’estensione della città era grosso modo raddoppiata, e la cosa interessante sta nel fatto che la rinnovata
espansione era stata pianificata ispirandosi con assoluta fedeltà al modello originario romano, con
strade che si incrociavano ad angolo retto formando isolati di ottanta metri per ottanta : le due aree,
l’antica e la nuova, si lasciano riconoscere e distinguere soltanto per una leggera sfasatura (venti metri
circa) degli assi viari orientati in senso nord-sud. In mancanza di espliciti riscontri documentali è
impossibile sapere con precisione quando fosse stato elaborato questo che possiamo legittimamente
definire un piano regolatore, ma
se si tiene conto delle primissime attestazioni di alcuni edifici che possono servire da fossili-guida (alla
stregua di quelle povere bestie calcificate che permettono di datare gli strati geologici) non si può
escludere che esso risalisse addirittura al IX secolo, alla faccia dei cosiddetti secoli bui. Le fasi di
sviluppo successive sembrano organizzate in maniera molto più estemporanea ed approssimativa, quasi
si stentasse a tenere il passo con una realtà che l’incremento della popolazione e delle attività
economiche sottoponeva a costante accelerazione.
Il passaggio dal dominio del Vescovo
all’autodeterminazione dei cittadini fu segnato da fasi conflittuali che portarono a ripetute devastazioni
seguite da ricostruzioni frettolose e piuttosto caotiche (nel 1155 persino l’Imperatore Federico
Barbarossa in persona si prese la briga di appiccare il fuoco alla città). Nel XII secolo Asti dilaga sulla
spianata sottostante al terrazzamento che ospita la città vecchia del Vescovo; una prima espansione è
ripartita molto sbrigativamente tracciando due strade che si incrociano ad angolo retto; l’ulteriore
sviluppo dell’abitato procede ancora più semplicisticamente per addizione di fasce concentriche che
verranno racchiuse a fine Duecento in una robusta cerchia di mura, scavalcata la quale la città
continuerà a crescere limitandosi ad allineare case lungo le strade che dalle porte si dirigono verso la
campagna.
NOTA AL CAPITOLO PRECEDENTE
Una città che si espandeva spostava in continuazione i suoi ingressi, e non sempre sono rimasti dei
segni espliciti che ricordino che nel tal posto si apriva un varco negli antichi recinti. Tuttavia è raro
che un punto notevole di un organismo urbano non lasci una qualche testimonianza di sè; il difficile è
capire a che cosa l’abbia affidata. Il luogo indiscutibilmente più enigmatico di tutta Asti era per me
ragazzo una breve scalinata che collega una viuzza tutta in salita con una vasta piazza posta di lato
rispetto alla viuzza e un poco più in su di questa. La piazza è pretenziosa (c’è un monumento
ingombrantissimo e un palazzone ridicolo che sembra il castello del teatro dei burattini) però è così
soltanto da poco più di cent’anni. Ancora agli inizi del XIX secolo al posto della piazza c’era una
specie di cortile stretto, lungo e tortuoso che ospitava il mercato della frutta e delle uova e che si
intrufolava tra le case fino a terminare in un vicoletto che passava dove adesso c’è la nostra scalinata.
Doveva essere uno degli angoli più disordinati e fatiscenti della città e per risanarlo si procedette ad una
serie di demolizioni che alla fine lasciarono un grande spazio vuoto sostanzialmente inutilizzato e
puramente di rappresentanza, prova ne sia che la spropositata aiuola sistemata attorno al monumento si
mangia lei da sola quasi tutta la superficie della piazza. Rispetto a tutto questo gran lavoro la
scalinatella laterale rappresenta un po’ il tocco finale , e in effetti è proprio carina; da un lato ha un
casamento antico, dall’altro una palazzina di fine Ottocento, e vista da sott’in su sembra che debba
condurre al cospetto di chissà quali meraviglie. Peccato però che fatti quei pochi scalini non si scopra
niente di così entusiasmante. Quand’ero ragazzo, ai piedi della scalinata c’erano da una parte uno di
quei vespasiani in metallo che adesso credo che non esistano proprio più, e dall’altra una bancarella che
per quel che ricordo vendeva esclusivamente acciughe sotto sale, che per la cucina del posto sono un
ingrediente molto importante. Non sono abbastanza bravo da sapervi descrivere l’odore delle acciughe
che si sprigionava dai tolloni aperti sul banchetto. Era grossolano ma non spiacevole, stuzzicava la
salivazione e soprattutto era potentissimo : invadeva tutta la via ma ristagnava basso e a fatica strisciava
sino ai gradini superiori della scalinata. In qualche maniera quell’odore sfacciato riusciva a tenere
assieme tutti gli articoli male assortiti che si ammucchiavano in quel luogo : i piani stradali sfalsati che
lasciavano trasparire sotto gli edifici un accidentato paesaggio collinare, le nefandezze architettoniche e
scultoree della piazza che si intravedevano al di sopra della scalinata, l’imbarazzante vespasiano zincato
che, poveraccio, era lì solo per fare il suo dovere, e infine l’eleganza francamente sprecata della
scalinatella. Eppure questa specie di ripostiglio delle scope un tempo era stato un luogo importante : il
vicoletto sepolto sotto la scalinata conduceva alla casa della famiglia Gardini, che dava sulla piazzetta
vecchia. E per qualche secolo, nel basso medioevo, la casa dei Gardini aveva segnato ufficialmente il
confine tra città alta e città bassa. Il perchè è facile da capire, dato che la piazza sta proprio sulla punta
estrema del pianoro su cui si trova la parte più antica della città, e di qua e di là è tutta discesa. E’
facile capire, però, che la casa dei Gardini marcava anche un discrimine sociale : stare sopra i Gardini
voleva dire abitare nella città vecchia del Vescovo e degli aristocratici; sotto i Gardini c’era la città nuova
dei bottegai e degli artigiani. Forse mi inganno, ma sono convinto che un limite del genere avesse un
senso solo se si fosse trovato nel principale punto di passaggio tra città vecchia e città nuova, o
addirittura in un passaggio obbligato. Ad esempio una porta. Spieghiamo sul tavolo la mappa della
città; senza troppa fatica vi leggeremo le tracce di alcune grosse strade campestri che convergevano da
più parti sull’abitato. L’urbanizzazione frenetica del basso medioevo ne ha abbondantemente mutilato
i tratti terminali, ma a giudicare da quel che ne rimane si direbbe che esse dovessero alla fine
congiungersi proprio ai piedi della nostra scalinata. Bene, forse abbiamo appena scoperto dov’era
l’ingresso della città nell’anno Mille, o forse ci siamo fatti ingannare da quattro scarabocchi che
abbiamo scambiato per una mappa del tesoro, vedete voi a cosa preferite credere.
VENIR VIA DAL CONDOMINIO
Tra le forme di insediamento che furono escogitate nel medioevo ce n’è una che suscita in modo
particolare la mia ammirazione per un’apparenza di modernità che nasceva invece dall’incapacità di
staccarsi del tutto da un modo di abitare e di vivere ancora profondamente arcaico. E’ un modello che
si può incontrare in alcuni paesi del Basso Monferrato ed è di una semplicità disarmante : una fila
continua di case posta in fregio ad una strada che dal lato opposto si affaccia su di una scarpata
verticale rinforzata da un rivestimento in muratura (che in genere rimpiazza un più antico sostegno
realizzato con pali e fascine). Tanto elementare che ci si aspetterebbe che esso fosse molto più diffuso
di quel che non sia in realtà, e si sarebbe tentati di interpretarlo come una forma di sviluppo spontaneo
se non fosse per un elemento - il rinforzo della scarpata - la cui realizzazione deve aver richiesto un
intervento pubblico o quanto meno un accordo preventivo tra i privati che ne avrebbero beneficiato e
dunque un sia pur minimo livello di pianificazione.
Un insediamento di questo tipo lo si può
incontrare sul versante soleggiato di una collina, diciamo a un tre quarti della sua altezza, sensibilmente
più in basso della sommità (dove di norma c’è o c’era un castello) ma più in alto dei crinali che
collegano l’altura a quelle vicine. Attualmente questi minuscoli borghi si ritrovano inglobati all’interno
dei paesi che sono cresciuti loro attorno e questo ne rende un po’ difficoltoso il riconoscimento. I
pochi esemplari sufficientemente leggibili che sono riuscito ad individuare si trovano tutti quanti in
centri che al tempo della loro nascita erano sottoposti all’autorità diretta dei Marchesi di Monferrato e
non a loro vassalli; potrebbe essere soltanto un caso ma io non escluderei che fossero i sovrani stessi a
promuovere la diffusione di questo particolare modello di insediamento. L’esemplare più significativo
è sicuramente quello di Mombello, fondato ai piedi di un castello oggi scomparso che era tra le
residenze preferite dai Marchesi. I Monferrato, che rimasero sempre fedeli alle tradizioni e alla cultura
dell’alta aristocrazia germanica, non sentirono mai l’esigenza di avere una reggia stabile, ed anche
quando la morte senza eredi del Marchese Giovanni portò sul trono i Paleologi, membri della famiglia
imperiale di Bisanzio, ci volle del tempo perchè il piccolo stato si desse una capitale, che fu stabilita
nella cittadina di Casale. Si deve forse alla predilezione dei Marchesi per questo luogo se il vecchio
borgo di Mombello si presenta un po’ meglio dei suoi simili (che hanno tutti un aspetto decisamente
più rustico); sul muraglione di mattoni a cui si appoggia la strada, ad esempio, si alza una torretta
quadrangolare merlata, in cotto, che sul vasto paesaggio collinare che fa da sfondo fa veramente la sua
bella figura. Peccato che il colpo d’occhio sia guastato dalle numerose macchine in sosta e dal grigiore
dell’asfalto; com’era inevitabile la funzione viabilistica alla fine ha prevalso e si è presa tutto, ma
immagino che originariamente e sino a tempi non lontani la strada su cui si affacciano le casette del
borgo - e che a sua volta si affaccia sulla vallata sottostante - si presentasse come una successione di
piccole aie interessate da una servitù di passaggio, praticamente via e cortile allo stesso tempo. Questo
tipo di insediamento permetteva dunque di concentrare gli abitanti della campagna offrendo loro
un’adeguata protezione (garantita a monte dal castello e a valle dal muraglione) senza doverli
necessariamente rinchiudere dentro un recinto : gli usci delle case allineate lungo la strada si
spalancavano sul cielo e sulle colline e davano libero accesso a sole ed aria pulita. E’ una concezione
dell’abitare che ci può sembrare molto moderna, ma in effetti è il nostro gusto che si è riavvicinato
all’antico dopo che per secoli il massimo della vita ci era sembrato lo stare in città, dentro case che si
prendevano a gomitate per rubarsi l’un l’altra l’aria e la luce. Va detto che in un epoca come la nostra
(e voglia il cielo benigno pensarci due volte prima di darcene un’altra eguale) un mutamento di gusti
può avere conseguenze catastrofiche, e sapete meglio di me come al sogno coltivato da tante persone di
lasciare la città (o quanto meno di venir via dal condominio) si sia risposto senza criterio nè scrupolo
alcuno costruendo ville villette e case a schiera dovunque e dappertutto finchè ce ne stavano. Una
superficie urbana estesa all’infinito ma senza forma urbana : i servizi sono localizzati dove capita (tanto
con l’automobile si va dappertutto); gli spazi comuni sono monopolizzati dalle automobili e sottratti a
qualsiasi utilizzo che non sia la viabilità. Per quanto di proporzioni apocalittiche, sicuramente anche
questa ondata avrà fine, ma il mio timore è che prima che si esaurisca essa riesca a snaturare
irrimediabilmente tanti piccoli centri che zitti zitti, senza quasi che nessuno se ne accorgesse erano
stati capaci di superare gli ultimi sette o otto secoli mantenendo intatto il loro carattere originario di
insediamento rurale sparso e non accentrato. Un esempio solo, ma illustre : il paese di Callianetto, che
in un diploma del 1159 l’Imperatore Federico Barbarossa elencava tra le località sottoposte all’autorità
della vicina città di Asti. Dopo una lunga e tranquilla esistenza lontana da ogni clamore, Callianetto
ebbe un momento di fama inaspettata nel XIX secolo come patria dichiarata di Gianduja, personaggio
del teatro delle marionette che rappresentava la più profonda e genuina ruralità messa a confronto con
l’artificiosità e la malizia dei cittadini. Una sorta di buon selvaggio giunto fresco fresco da un eden
incontaminato e a cui era permesso, tra gaffes e strafalcioni, di dire quel che realmente gli passava per
la testa. In seguito Gianduia fu scelto come maschera carnevalesca ufficiale del Piemonte ed assunse
un carattere più paternalistico ed artefatto.
Ho dei precisi ricordi di come era Callianetto una
cinquantina di anni fa; i suoi civilissimi abitanti non potevano certo essere paragonati a Gianduja, però
qualcosa del paradiso incontaminato il luogo lo aveva indiscutibilmente mantenuto : una lunga valle
disseminata di cascinini disposti uno qua e uno là senza un ordine preciso, qualcuno a fondo valle,
qualcuno a mezza costa sul versante soleggiato, qualcuno sulla sponda del rio. E in più una quantità
sorprendente di pozzi artesiani che zampillavano allegramente tra vigne, campi ed orti : era tutto
talmente bello che sembrava finto. Di tanto in tanto mi capita di ripassare da quelle parti ed ogni volta
noto che si è aggiunto un pezzo : una volta è un garage, un’altra è un condominio, un’altra ancora è un
capannone, e immagino che si andrà avanti così, riempiendo un buchetto alla volta, finchè anche
questo piccolo paradiso perduto per sempre sarà diventato irrimediabilmente un’area urbana senza
peraltro esser mai stato Forma Urbana.
DOVEROSE PRECISAZIONI
Come ho accennato da qualche parte nelle primissime pagine, questo libro non è un lavoro di pura
immaginazione : vi si narrano storie inventate che hanno per protagonisti dei luoghi che esistono
per davvero. Le descrizioni che ho dato di questi si basano sovente su ricordi lontani e potrebbero
risultare imprecise; fate conto che siano descrizioni inventate di posti che esistono per davvero.
Quando un luogo non è nominato in modo esplicito è perchè nel ritratto che ne ho fatto ho
deliberatamente forzato quei caratteri che mi tornava comodo evidenziare. Ad esempio, la città di
cui si parla in Nostra Signora della Palude è Asti, anche se un po’ stilizzata. Nel racconto faccio
congiungere delle strade che in realtà stanno a qualche isolato di distanza e ovviamente Pier
Antonio Gabba non è mai esistito; è vero però che a informarmi dell’esistenza della altrimenti
dimenticatissima Madonna della Palude è stato proprio un opuscolo pubblicato qualche decennio fa
da un dilettante di Storia locale. Non è vero che le due alluvioni citate nel brano (quella del 1948 e
l’altra del 1994) abbiano avuto un’identica dinamica, giacchè a provocare la prima fu il torrente
Borbore e la seconda il fiume Tanaro, ma all’atto pratico il risultato fu lo stesso giacchè le aree
inondate erano sempre quelle, ed è sconfortante che nei cinquant’anni trascorsi tra i due disastri si
sia continuato a costruirvi, come se niente fosse capitato. Un paio d’anni dopo la catastrofica
alluvione del 1994 sono passato da Ceva, situata anch’essa sul Tanaro, ma molto più a monte di Asti.
Ceva ha una rimarchevole via centrale fiancheggiata da vecchi portici, bassi ma parecchio larghi,
molto particolari. Sui muri del quartiere moderno in cui avevamo parcheggiato si vedeva ancora
benissimo la fascia scura lasciata dall’acqua, alta quasi quanto me; poi, man mano che ci si
avvicinava al centro storico il piano stradale si innalzava gradatamente e la striscia nera si
assottigliava di conseguenza, fino ad azzerarsi ad un passo dal primo portone della città vecchia.